

arcipelagomilano.org, 3 aprile 2018. Il terribile "anno di moratoria", inserito in una leggie che voleva difendere territorio e paesaggio dalla cementificazione, ma permise di concentrare in un anno decenni di schifezze. Ricordare in futuro
La legge 765 reca la data per così dire ingannevole del 6 agosto 1967 poiché il «ponte» doveva agganciare l’altra riva un anno dopo; infatti, l’applicazione della legge sarebbe iniziata il 6 agosto 1968. Il decreto n.1444 lo denominavamo in quel modo mentre l’incipit del testo dice «limiti inderogabili di altezza, di distanza fra i fabbricati…» e seguono le note indicazioni. Al primo significato del termine «ponte» se ne abbinava però un secondo: esprime il periodo pontiere, creduto quanto mai breve, fino all’approvazione di una nuova legge urbanistica generale sostitutiva della legge 1150 del 1942. Mezzo secolo è passato come attraverso una lunga guerra, vissuta dal paese attraverso immani distruzioni del proprio retaggio storico (patrimonio materiale e spirituale). L’esistenza di leggi regionali le più svariate, magari illegali per postulato e in linea col più smaccato liberismo, basta per giustificare la rinuncia a un unitario provvedimento generale.
La prima definizione della 765 divenne presto testimonianza allibita di fatti gravissimi, di avvenimenti urbanistici e edilizi di segno uguale a quelli che l’articolo 17 della legge intendeva bloccare, ovvero un’edificazione rovinosa nei comuni privi di piano regolatore o piano di fabbricazione ma anche, per certi aspetti diversi, nei comuni dotati di tali strumenti. L’anno «vuoto» dal 6 agosto 1967 al corrispondente giorno del 1968, dunque oltre il decreto degli standard, è stampato nella memoria degli anziani, anzi dei vecchi, e forse solo in loro sfortunatamente. In quei dodici mesi bastava gettare un pilastro di calcestruzzo o alzare pochi metri di muratura a caso in un fondo, persino alla vigilia della scadenza, per assicurarsi la costruzione di un edificio, nel caso migliore progettato falsamente. Nel paese imperversava una specie di banditismo edilizio autorizzato; un bislacco comportamento delle amministrazioni pubbliche sguarniva le città e le campagne d’ogni possibile difesa.
Altro che «limiti inderogabili» a venire. I provvedimenti legislativi, indipendentemente dal rinvio dell’obbligo, furono comunque facilmente aggirabili a causa della loro gracilità. La decantata fantasia italiana potette scatenarsi nelle forme più ardite, né mancò l’intensa partecipazione dei tecnici campioni di opportunismo e servilismo (funzionari pubblici, professionisti architetti, ingegneri, geometri e periti edili). Gli speculatori d’altronde proseguivano tranquillamente nella loro azione cominciata prima che la guerra fosse terminata. In quell’anno caddero un diluvio di metri cubi, come un’enorme frana da sotto in su, all’incontrario e centomila volte più vasta di quella di Agrigento del 19 agosto 1966; a dicembre la dura relazione-denuncia dell’ingegner Michele Martuscelli (1918/2003) sul n. 48 di Urbanistica. Fu il disastro agrigentino la causa creduta preminente della legge 765. Da un lato tentativo di tamponare in qualche maniera la perenne libertà concessa agli imprenditori di ricavare dal territorio e dalle città il massimo di rendita, dall’altro dimostrazione della impossibilità politica di volerlo fare davvero.
La costituzione ambientale storica del paese era già in buona parte sovvertita. Antonio Cederna aveva cominciato a scrivere nel 1949 gli articoli su il Mondo in seguito confluiti nel libro I vandali in casa (Laterza, 1956) allorché quei devastatori che avevano già scorrazzato in lungo e in largo; Leonardo Borgese aveva scritto sul Corriere della Sera i primi articoli della sua campagna in difesa del Bel Paese nel 1946 e proseguirà per 25 anni (oggi possediamo una raccolta di oltre 60 testi nel libro dal titolo-verità L’Italia rovinata dagli italiani, Rizzoli 2005); Cesare Brandi denunciava senza tregua la distruzione del paesaggio naturale e del patrimonio artistico dal 1956, anch’egli insisterà per un quarto di secolo sul Corriere e altri mezzi di informazione (saranno gli Editori Riuniti a pubblicare nel 2001 un bellissimo volume di quasi 500 pagine per 116 testi, dal titolo Il patrimonio insidiato). Il destino di una Napoli come rappresentata nel film di Francesco Rosi Le mani sulla città, 1963, appariva segnato in maniera irrimediabile. Secondo Pasolini, poi, l’Italia era già deturpata in buona parte alla fine degli anni Cinquanta.
Riscriviamo la conclusione della commissione Martuscelli (con Ambrosetti, Astengo, Di Paola, Guarino, Molajoli, Russo e Valle): «la commissione sente il dovere di segnalare la gravità della situazione urbanistico-edilizia dell’intero paese, che ha trovato in Agrigento la sua espressione limite […]. E non può non auspicare che da quest’analisi concreta parta un serio stimolo nel porre un arresto – deciso e irreversibile – al processo di disgregazione e di saccheggio urbanistico». Eppure, dopo una breve sosta attonita, gli stessi girgentini, forse anche ammirati da alloctoni di molle carattere, ripresero la lena e posero mano anche alla dirimpettaia Valle dei Templi, l’antica e da loro malvoluta Akragàs, reclamandola come proprietà ereditaria e dunque atta a essere meglio impiegata, invece che mediante il «classico» statico, mediante il «moderno» dinamico, vale a dire la costruzione di conveniente edilizia, benché bassa e scadente, compensativa dell’ingiusta perdita. E vennero man mano le 700 costruzioni di vario genere nella Valle, vere o false provvisorie a ridefinire il paesaggio, il secondo nuovo dopo il primo dominato dallo spaventoso prospetto dell’insensata espansione urbana destinata al crollo.
Chi potette visitare l’eccezionale ambiente storico e archeologico di Agrigento fino alla metà degli anni Cinquanta non si trovò nella medesima situazione di Alexis de Tocqueville e di suo fratello Eduard che videro nel 1827, «là giunti, l’immensa cerchia delle mura di Girgenti [… e] quasi tutto quel che resta dei monumenti antichi schierato sul bastione naturale che dà sul mare». Tuttavia non vide quasi niente di spaventoso. Il paesaggio giustapponeva la ricca città greca morta e la povera città storica viva in uno scenario nel quale le due realtà parevano ignorarsi ma, a saper ascoltare, potevano dialogare. Quando ritornò ai templi negli anni Sessanta prima della frana, cercò di procurarsi ad arte un qualche godimento dando le spalle all’orrida immanenza della città e osservando la residua Akragàs da sud. Se non avesse resistito e, come Orfeo, avesse girato la testa, la nuova città non sarebbe sprofondata al fondo dell’Ade come Euridice e lui avrebbe vomitato.
Quale nuova esperienza visiva e percettiva per chi vorrebbe trovarsi lì oggi? Altro ambiente altro paesaggio? La Valle piena di robaccia? Girgenti più brutta di prima? Mettiamo che il visitatore abbia cinquant’anni, l’età della legge influenzata dal disastro dimenticato. Sarebbe talmente abituato ad aggirarsi nello schifo medio del territorio nazionale che troverebbe naturale la condizione agrigentina. Perché insistere sul caso siciliano? Perché voler ricordare la determinazione del bravo direttore dell’Urbanistica al Ministero dei lavori pubblici? Perché l’auspicio suo e della commissione fu tradito, la disgregazione e il saccheggio urbanistico, esaltati nell’annata dell’assurdo o del surreale concesso dal legislatore, continuarono come e più di prima, vissero trionfali gli anni, i lustri e i decenni. Ora, più che maratoneti, tagliano il traguardo del 2018 e si fanno ammirare pronti per future avanzate benché sconcertati dinanzi alla sorprendente scarsità di materia disponibile.
Sull'argomento vedi in eddyburg l'articolo di Mauro Baioni, Gli standard urbanistici compiono cinquant'anni. In realtà la legge avrebbe dovuto essere un "ponte" verso una più completa riforma urbanistica, che tutti ritenevano necessari dopo i catastrofici eventi del 1966 (crollo di un intero pezzo di città ad Agrigento, alluvioni a Firenze e Venezia, crolli diffusi a Napoli).
Articolo ripreso dalla pagina qui raggiungibile
il manifesto, 15 marzo 2018. Ricordo di un evento straordinario, che aprì un ventennio nel quale l'inizio della costruzione di un'Italia migliore fu sconfitto dall'avanzata del neoliberismo. Con postilla
Il 19 novembre 1969 si svolse in tutta Italia per iniziativa delle tre confederazioni sindacali nazionali lo sciopero generale per la casa. Uno sciopero imponente, con adesioni e partecipazione altissime. La piattaforma elaborata da Cgil, Cisl e Uil poneva per la prima volta la questione degli alloggi pubblici e delle città al centro dell’iniziativa sindacale. La piattaforma interpretava il clima di quei tempi attraversati da potenti spinte sociali, dal bisogno di case di chi viveva ancora in baracca, da tante occupazioni. La spinta feconda che aveva fatto nascere prima a Milano e poi in tutta Italia, l’Unione Inquilini.
Sono passati 50 anni e converrà ragionare sulle cause strutturali sull’esaurirsi della spinta riformatrice e dell’affermazione della controriforma guidata dalla grande proprietà immobiliare, la cui cifra scandalosa sta nell’esenzione dal pagamento dell’Imu per le società proprietarie di appartamenti di recente realizzazione e in vendita. Calcolando che sono almeno 300 mila gli alloggi nuovi invenduti, ogni anno la potente lobby risparmia 300 milioni. I sostenitori del «libero mercato» hanno stabilito che chi costruisce case e non le vende è esentato dalle tasse che tutti gli altri cittadini pagano.
L’azione degli anni ’70 aveva l’obiettivo di strappare provvedimenti legislativi a favore delle classi deboli. Nel 1971 venne approvata dal Parlamento la legge sulla Casa (n. 865). Nel 1977 la legge «Bucalossi» (n.10) che facilita il governo pubblico delle città. Nel 1978 il piano decennale sulla casa. Nell’agosto di quello stesso anno la legge sull’equo canone.
Pezzo dopo pezzo, tutta l’architettura che dava una risposta ai bisogni delle fasce popolari è stata demolita. Nel 1998 viene chiuso il capitolo dei contributi Gescal che avevano consentito di finanziare l’edilizia pubblica mentre negli anni ’80 due sentenze della Corte Costituzionale limitarono le possibilità dei comuni a costruire nuovi quartieri popolari.
Nel 2008 la legislazione nazionale ratifica il capovolgimento culturale: nasce l’housing sociale invece delle case pubbliche, e inizia la contesa tra istituti di credito e fondazioni bancarie per inserirsi nel mercato. L’offensiva neoliberista si appropria del mercato dell’edilizia per le famiglie a basso reddito. Per alimentare il fondo sull’housing sociale, oltre a Cassa Depositi e Prestiti, si inseriscono i colossi del credito, dalle Assicurazioni Generali a Unicredit, da Allianz a Intesa San Paolo.
La macchina della privatizzazione del comparto delle case popolari sembra destinata al trionfo. Poi arriva la crisi immobiliare del 2008 e il castello di carte crolla. L’impoverimento del ceto medio e la precarietà del lavoro dei giovani rende pressoché impossibile acquistare casa.
Il tragico bilancio della privatizzazione della città è un numero sempre più grande di famiglie in stato di disagio abitativo, della ricomparsa delle baracche, delle tante occupazioni. Un dato ci dice molto di quanto accaduto. Fino al 1990 venivano costruiti in media 18 mila case popolari all’anno. Negli anni ’90 il valore scende a 10 mila. Nel decennio 2000 – 2010 si è arrivati a poco più di 5 mila. È su questo nodo che dobbiamo ragionare se vogliamo risolvere i problemi della casa. Il fronte progressista si è molto indebolito perché molti hanno creduto alla sirena del “privato” ed oggi faticano ad aggiornare analisi e obiettivi. Sindacati di base e i gruppi di difesa delle fasce deboli hanno avuto il grande merito di resistere alla cultura dominante, ma non hanno avuto la forza di imporre un nuova agenda politica e sociale.
Tre sembrano le strade da seguire per ripartire. Ricostruire pezzo dopo pezzo la legislazione in grado di dare risposte alla società impoverita e all’immigrazione. La seconda è quella della certezza dei finanziamenti. Occorre tornare a finanziamenti certi e duraturi: il segnale potrebbe partire dal far pagare l’Imu alla grande proprietà. Infine, ricostruire il welfare urbano selvaggiamente cancellato. Era una delle più innovative conquiste della piattaforma dello sciopero del 1969 e va ripresa. Il fallimento dell’housing sociale ci offre la grande possibilità di ricostruire una prospettiva sociale. La sinistra deve provarci.
postilla
Il 19 novembre 1969 accadde qualcosa che non era mai avvenuto e non si è mai ripetuto: tutta l'Italia si fermò, con uno sciopero generale nazionale sui temi della casa, l'urbanistica, i trasporti. Così dirompente fu l'impatto di quell'evento, così minacciati si sentirono i poteri forti del capitalismo italiano, che all'indomani (precisamente il 12 dicembre dello stesso anno) esplosero le bombe della reazione, esplose a Milano, piazza Fontana: si aprirono così gli "anni di piombo".
Un piano misconosciuto, ancora vigente e positivamente operante poiché costruito e gestito nei decenni in cui le scelte urbanistiche erano espressione di valori sociali e culturali altrove smarriti o contraddetti nei decenni successivi
Premessa
A rendere tragica la situazione concorse la sordida alleanza fra la camorra ele Brigate rosse che volevano impedire “la deportazione dei napoletani”. Fu rapitol’assessore regionale all’urbanistica Ciro Cirillo e furono uccisi l’autista eun poliziotto. La risposta istituzionale fu un’aggiunta alla legge indiscussione a favore dei comuni terremotati, subito approvata, che dichiarò “dipreminente interesse nazionale” la realizzazione di 20 mila alloggi e dellerelative opere di urbanizzazione nel comune di Napoli, affidando tutti i poterial sindaco della città nominato “opelegis” commissario straordinario del governo e soggetto soltanto alrispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento.
L’approvazione della legge provocò il panico nel comune. Per aiutare Valenzi,la direzione del Pci inviò a Napoli Guido Alborghetti, vice presidente dellacommissione Lavori pubblici della Camera. Ero allora dirigente del ministerodei Lavori Pubblici e nella qualità di commissario di governo Valenzi ottenneil mio comando presso i suoi uffici. Alborghetti condusse subito, mirabilmente,con assoluta trasparenza e puntualità, l’affidamento dei lavori a un centinaiodi imprese raccolte in 12 raggruppamenti, fra lo stupore del mondo dellecostruzioni e della stampa nazionale.
Per l’organizzazione delle strutturetecniche, superando l’ostilità degli apparati burocratici municipali, decidemmodi far capo all’Ufficio studi urbanistici del comune, formato dai giovanitecnici che avevano ideato e progettato il piano delle periferie. Da allorafurono chiamati “i ragazzi del piano”. Li avevo conosciuti a Roma prima delterremoto in incontri di lavoro per la messa a punto del piano delle periferiee con alcuni di loro – Elena Camerlingo, Rosanna Costagliola, Maria Franca deForgellinis, Giovanni Dispoto, Giancarlo Ferulano, Roberto Giannì, MarioMoraca, Giuseppe Pulli, Laura Travaglini – si stabilì un legame che non si èmai interrotto.
Mi limito a citare i tre progetti più importantiampiamente discussi in quegli anni:" IlRegno del possibile", promosso da Confindustria, imprenditori privati edelle Partecipazioni statali, volto allo sventramento del centro storico; "Polis 2000", formato da Banco diNapoli, Iri – Italstat e costruttori interessati alla riorganizzazione dellazona orientale storicamente destinata alle attività industriali, ormai dismesseo in via di dismissione; infine "Neonapoli" – ambiziosa iniziativa patrocinata dal ministro del Bilancio PaoloCirino Pomicino e sottoscritta da altri sette ministri, riguardante l’interaarea metropolitana – assunta a simbolo della filosofia politica e affaristicache in quegli anni governava Napoli. L’unico esile legame con il potere localeera rappresentato dal “preliminare di piano”, una bozza di nuovo Prg che dovevasostituire quello del 1972, con il quale l’amministrazione comunale cercava ditornare in campo in materia urbanistica, al tempo stesso spianando la strada a.Neonapoli.
Ma la nostraimpostazione era che le decisioni in materia urbanistica dovevano essereelaborate dagli uffici comunali, discusse e votate, non solo ratificate, inconsiglio comunale (e poi sottoposte alle osservazioni dei cittadini), senzascorciatoie. Per questo fu deciso di produrre al più presto un’appositavariante per Bagnoli, la prima di altre varianti che, nell’insieme, avrebberoformato il nuovo piano regolatore. In concordanza con un apposito documento di indirizzi approvato dalconsiglio comunale nel 1994 furono elaborate la variante disalvaguardia e quella per Bagnoli e l’area. occidentale. Quindi quella per il centrostorico e le zone orientale e nord occidentale. Tutte poi unificate, conun medesimoimpianto metodologico e normativo,nelnuovo Prg definitivamente approvato dalla regione Campanianel giugno del 2004.
Il nuovo assetto di Bagnoli – luogo di anticae mitica bellezza, sotto le falesie di Posillipo, affacciato su Nisida e sulleisole del Golfo – fu salutato molto favorevolmente dalla stampa nazionale e damolti giornali stranieri. Nel 1999 un circostanziato vincolo di tutela delministero dei Beni culturali (mirabilmente scritto da Antonio Iannello),confermò, consacrandole, se così posso dire, le previsioni urbanistichecomunali. Ma intanto si era messo mano a una confusa operazione di bonificacondotta dal ministero dell’Ambiente e cominciò ad appannarsi la speranza dellanuova Bagnoli. Fra ritardi nei finanziamenti, inettitudini e peggio, labonifica non è mai finita.
Che il comune di Napoli disponga di un progetto urbanisticoregolarmente approvato e vigente il governo lo ignora, accredita anzi ilconvincimento che si sia all’anno zero e si debba cominciare daccapo,determinando così le condizioni per rimettere in campo gli energumeni delcemento armato E infatti le proposte del soggetto attuatore, per quanto sideduce dalle immagini dei soliti power point governativi, sono volte aconcentrare la polpa delle nuove funzioni sull’area Cementir di proprietà delgruppo Caltagirone. Ma a seguito di un ricorso del comune spetta adesso allaCorte costituzionale decidere in merito alla legittimità dello Sblocca Italiaper Bagnoli.
In occasione del quarantesimo anniversario dall'approvazione della legge Bucalossi sul regime dei suoli, pubblichiamo un estratto da Fondamenti di urbanistica. La Storia e la Norma che sintetizza i contenuti della legge e i suoi nodi irrisolti (m.b.)
da Fondamenti di urbanistica. La Storia e la Norma, di Edoardo Salzano, Laterza editori, Roma-Bari 20074,,p 178-200
Spezzoni di riforma
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 55 era stata approvata la “legge-tappo” del novembre 1968, che prorogava per cinque anni la validità delle previsioni degli strumenti urbanistici comportanti vincoli nei confronti dei diritti reali. I cinque anni trascorsero senza che fosse assunta alcuna concreta iniziativa e si fu così costretti, nell’ultimo giorno utile, ad approvare un’altra proroga biennale. Nel novembre 1975 ancora un rinvio di un anno. Questa volta è però accompagnato da un disegno di legge governativo di riforma del regime dei suoli che, finalmente, dopo un’ultima proroga di tre mesi, è approvato nel gennaio 1977. È la legge 28 gennaio 1977, n. 10, più nota come legge Bucalossi, dal nome del Ministro repubblicano per i lavori pubblici che ne fu l’autore.
Alla base della legge c’è la scelta nettamente a favore della separazione dello jus aedificandi dal diritto di proprietà. In verità, sullo “scorporo” del diritto di edificare dal diritto di proprietà la Dc non dà mai un’adesione convinta. L’intesa fra i partiti di governo si realizza soprattutto grazie all’impegno di Pietro Bucalossi che minaccia le dimissioni (e quindi la crisi di governo) in caso di mancata approvazione del disegno di legge. Il principio della separazione viene però affermato in maniera ambigua, cosi da renderla accettabile al partito della proprietà, se è vero che qualche esponente della proprietà edilizia che aveva prima parlato “di una vera confisca (sic), giustificata dal troppo evidente inganno che la proprietà rimane nella titolarità dei proprietari”, dopo l’approvazione del consiglio dei ministri, afferma - peraltro con la medesima superficialità del primo giudizio - che “la legge non esprime più l’adozione di quel principio sovversivo[1].
Il disegno di legge Bucalossi è approvato dal Consiglio dei ministri il 29 novembre 1975 e presentato al Parlamento 1’11 dicembre. Gli elementi portanti della riforma sono l’istituto della concessione onerosa, il convenzionamento dell’edilizia abitativa, il programma di attuazione dei piani urbanistici e la normativa contro gli abusi.
Il regime di concessione onerosa ha come presupposto la riserva pubblica del diritto di edificare. L’ente pubblico assente la concessione di questo diritto al proprietario dell’area, ovvero a chi ne ha la legittima disponibilità, per l’edificazione di opere conformi agli strumenti urbanistici. La concessione non incide sulla proprietà - che resta privata - dell’immobile realizzato. L’onerosità della concessione è parziale, nel senso che il contributo di concessione non costituisce il corrispettivo dell’intero plusvalore dell’area. Il contributo è infatti formato da una quota del costo di costruzione, variabile dal cinque al venti per cento, e da una quota afferente agli oneri di urbanizzazione.
Il convenzionamento dell’edilizia abitativa dovrebbe essere uno dei punti qualificanti della legge. Esonerando l’edilizia convenzionata dagli oneri di concessione si possono favorire gli imprenditori disposti a concordare con il comune i prezzi di vendita ed i canoni di locazione degli alloggi da destinare alle categorie meno abbienti, e quindi esercitare consensualmente un controllo del mercato delle locazioni.
Il programma poliennale di attuazione degli strumenti urbanistici serve ad evitare una delle più macroscopiche distorsioni che hanno accompagnato la crescita delle città, e cioè la contemporanea diffusione dell’attività edilizia in tutte le direzioni possibili e senza alcuna correlazione con gli interventi volti alla realizzazione delle infrastrutture e attrezzature. In tal modo i comuni sono stati costretti ad inseguire la disordinata diffusione delle iniziative private, sostenendo ingenti spese per la costruzione delle reti di urbanizzazione e per assicurare i minimi servizi (si pensi ai trasporti). Il programma poliennale di attuazione consente invece ai comuni di definire quali delle opere previste dal piano regolatore si possono realizzare in un determinato periodo, organizzando per tempo, ed in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie, gli interventi pubblici necessari.
La nuova normativa contro l’abusivismo, fenomeno già allora in forte espansione, prevede, nei casi di maggior gravità, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva. La demolizione resta l’unica sanzione quando l’abuso contrasta con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. Il fatto che l’acquisizione al patrimonio comunale non sia una facoltà ma un atto dovuto per il comune sembra il deterrente decisivo. Ma, come vedremo, l’abusivismo esploderà più violento di prima.
Il dibattito in parlamento rinfocola i contrasti. Il disegno di legge è in parte migliorato. Non vengono invece chiariti i nodi relativi al regime di proprietà delle aree edificabili.
La mancata esplicitazione del principio della separazione costituisce un grave errore - anche politico - perché le riforme non si fanno con le riserve mentali (se c’è separazione, come c’è, non si vede per quale motivo non Si debba dirlo chiaramente), perché non ci può essere confusione su un principio che costituisce il presupposto del regime concessori (senza la separazione, infatti, la concessione si ridurrebbe ad un fatto meramente nominalistico), perché infine si potrebbe rischiare di incorrere in una nuova declaratoria di incostituzionalità (la logica della sentenza n. 55, è bene ricordarlo, è stata ribadita dalla Corte in una recente pronuncia)[2].
Facile profezia. Nel gennaio 1980, a tre anni dalla Bucalossi, la Corte costituzionale si pronuncerà ancora sulla incostituzionalità della legge urbanistica. [Con la sentenza n. 5/1980 la Corte affermò infatti che, nonostante la diversa denominazione data dal legislatore «ildiritto di edificare continua ad inerire alla proprietà» - n.d.r.].
Note
[1] M. Martuscelli, nell’introduzione a: F. Bottino, V. Brunetti, Il nuovo regime dei suoli, Edizioni per le autonomie, Roma 1977, p. 20.
[2] Ivi, p 27.
Riferimenti
Qui potete scaricare il capitolo introduttivo al libro di F. Bottini, V. Brunetti, Il nuovo regime dei suoli, scritto da Michele Martuscelli, allora direttore generale del Ministero dei Lavori Pubblici. E' un saggio di notevole interesse: nella prima parte inquadra i contenuti nella legge nel percorso di riforma urbanistica, tentato e mai portato a compimento. Nella seconda parte, fornisce un primo bilancio dell'attuazione, affidata - con tutte le conseguenze del caso - all'iniziativa delle Regioni.
L'autore guida i lettori attraverso i segreti matematici, geometrici o scientifici meno conosciuti delle mete turistiche. Nella narrazione s'intravedono, dietro la rigida maglia urbanistica, Storia, Natura, Società ed Economia. La Repubblica, 22 agosto 2016, con postilla
La prima testimonianza archeologica di una città a scacchiera risale però a più di quattromila anni fa, ed è Mohenjo-daro nell’attuale Pakistan. La prima testimonianza progettuale è invece quella di Mileto da parte dell’architetto Ippodamo, nel quinto secolo prima della nostra era. Il suo modello divenne la base per la fondazione dapprima delle colonie greche, e in seguito delle città romane. In particolare, il cardo verticale e il decumano orizzontale costituiscono la versione urbanistica di quelli che in seguito sarebbero divenuti gli assi introdotti da Cartesio nella Geometria del 1637.
Le vestigia di questo approccio geometrico si possono osservare nei siti archeologici romani dell’intero Mediterraneo, ma affiorano anche in molte città moderne: dai centri storici di Torino o Città del Messico, al quartiere Ensanche di Barcellona.
Ma nessuna città al mondo incarna l’ideale cartesiano meglio di Manhattan, che estende il proprio sistema di coordinate su una superficie di 87 chilometri quadrati. Evitando l’anacronistica e inefficiente denominazione delle strade con nomi scelti a caso e in maniera disordinata, le Avenue e le Strade di Manhattan sono individuate da coordinate intere riferite a due assi cartesiani: la Prima Strada e la Prima Avenue, situate rispettivamente agli estremi Sud e Est dell’isola.
Il sistema è lungi dall’essere ideale, da un punto di vista matematico. Anzitutto lascia fuori la punta meridionale dell’isola, che essendo il primo insediamento della Nuova Amsterdam olandese dapprima, e della Nuova York inglese poi, crebbe in maniera tanto caotica quanto le altre città europee dell’epoca. Il vero sistema di coordinate inizia con la Quarta Strada, che costeggia il lato settentrionale di Washington Square e separa la parte geometrica di Manhattan dal Greenwich Village e dagli altri quartieri meridionali: Chinatown, Little Italy, Soho, Tribeca, il Civic Centre e il Distretto Finanziario.
Non è un caso che i bohémien, i beat, gli hippie, e più in generale gli artisti e gli artistoidi, ai quali la razionalità e la pianificazione non sono mai risultate congeniali, abbiano sempre preferito questa parte della città. È qui, ad esempio, che si trovano locali storici per la musica folk o jazz, come il Village Vanguard o il Blue Note. Ed è qui che bazzicavano Salvador Dalì e Andy Warhol, Jack Kerouac e Allen Ginsberg, Bob Dylan e Jimi Hendrix.
Ma Downtown Manhattan è anche la sede di istituzioni quali la New York University e la Borsa di Wall Street. E quest’ultima non è stata certamente immune dalle sirene della più folle razionalità: quella dei derivati, che non a caso sono un’invenzione della madre patria olandese.
La prima bolla speculativa, scoppiata miseramente come tutte, fu infatti quella dei bulbi che fiorì agli inizi del Seicento, proprio al momento della fondazione di Nuova Amsterdam, e fu raccontata nel 1850 da Alexandre Dumas padre nel romanzo Il tulipano nero.
Tornando alla Manhattan geometrica, mentre la numerazione delle Strade cresce da Sud a Nord, quella delle Avenue cresce da Est a Ovest: la città si situa dunque tutta, stranamente, nel quadrante cartesiano di Nord-Ovest (il quarto). Per ovviare al problema, la Quinta Avenue svolge surrettiziamente la funzione del cardo romano o dell’asse Y cartesiano, come sottolinea il fatto che inizi all’Arco di Trionfo di Washington Square. La numerazione civica su ciascuna strada avviene con coordinate crescenti in due direzioni opposte a partire dalla Quinta Avenue, verso Est (positive) e verso Ovest (negative): di fatto la Manhattan geometrica si situa dunque nel semipiano cartesiano settentrionale (il primo e il quarto quadrante).
Non ha dunque molta importanza il fatto che le Avenue in realtà siano enumerate in maniera pasticciata. Ad esempio, fra la Terza e la Quinta ce ne sono in realtà tre, invece di una sola: la Quarta era quella che oggi si chiama Park, ed è stata in seguito affiancata da Lexington e Madison.
La Sesta si chiama anche Avenue delle Americhe. La Nona, la Decima e l’Undicesima cambiano nome a partire dalla 59a Strada, diventando Columbus, Amsterdam e West End. E la Dodicesima infine non è parallela alle altre, ma segue la incurvata costa occidentale dell’isola.
Ci sono dunque varie imperfezioni locali, alle quali si aggiunge il fatto che la famosa Broadway taglia la città obliquamente, da Sud-Est a Nord-Ovest, e all’altezza della 75a Strada si inserisce parallelamente tra la Decima e l’Undicesima Avenue, andando ad aumentare ulteriormente il numero delle Avenue.
Ma globalmente il sistema è un’ottima realizzazione pratica di un modello teorico matematico, proposto a tavolino nel 1811 da un’apposita Commissione Urbanistica. E ha addirittura stimolato lo studio di una nuova geometria, ispirata alla flotta di taxi gialli che costituiscono una delle caratteristiche di Manhattan.
L’idea è di misurare le distanze fra i punti della Manhattan geometrica alla maniera del tassametro dei taxi, appunto. Poiché neppure a New York le auto possono passare attraverso le case, ma sono costrette a seguire il percorso stradale,il tassametro non misura le distanze in linea d’aria, bensì quelle ottenute sommando i percorsi a zig zag (orizzontali e verticali) che conducono da un punto all’altro. Nella geometria di Manhattan, dunque, invece di calcolare le distanze mediante il teorema di Pitagora, estraendo cioè la radice quadrata della somma dei quadrati dei percorsi totali (orizzontale uno e verticale l’altro), si sommano direttamente i percorsi stessi.
La geometria di Manhattan è un semplice esempio di geometria non euclidea, perche un triangolo rettangolo che abbia un cateto disposto su una Strada e l’altro cateto su una Avenue ha un’ipotenusa lunga quanto la somma dei due cateti, invece che minore. Quello stesso triangolo rettangolo non soddisfa dunque il teorema di Pitagora, perché la somma di due quadrati (dei cateti) non è uguale al quadrato di una somma (dell’ipotenusa).
La caratteristica più nota di Manhattan è però di essere una città non bidimensionale o quasi, come sono quelle solite, ma sostanzialmente tridimensionale, come sono anche Chicago e Hong Kong, a causa del proliferare dei grattacieli. Edifici di questo genere pongono enormi problemi strutturali, e nel caso di New York sono stati costruiti soprattutto nelle zone di Midtown e Lower Manhattan, dove il substrato roccioso è vicino alla superficie: in Central Park a volte lo si può addirittura veder affiorare direttamente alla superficie.
Dal punto di vista matematico, se un ubriaco vive in una città bidimensionale e cerca di tornare a casa girando a caso a ogni incrocio, prima o poi ci arriva sicuramente. In una città tridimensionale, invece, la complicazione di dover anche salire o scendere a caso da un piano all’altro fa sì che la probabilità di arrivare non solo all’entrata del proprio condominio, ma anche alla porta di casa, scende al 30%.
Se dunque volete andare negli Stati Uniti a ubriacarvi, scegliete come meta la piatta Los Angeles ma non New York, a causa della sua sobria geometria tridimensionale.
postilla
Sotto la lettura "matematica" di Odifreddi si intravedono le smagliature apparentemente eterodosse che Storia e Ambiente hanno introdotto nella rigidità geometrica della maglia edilizia: il percorso obliquo e tortuoso di Broadway, memoria dell'originario percorso degli indigeni Lenapi, originari padroni del sito; il reticolo bizzarro della vecchia New Amsterdam, lascito della cultura europea dei primi colonizzatori; la maggiore verticalità della forma urbana là dove la Natura ha fornito un suolo più solido all'appetito degli speculatori.
A conoscere un poco la storia sociale della città, si può leggere come nella giovane democrazia capitalistico-borghese nordamericana la Società abbia potuto vincere sull'Economia della rendita, strappando a furor di popolo centinaia di isolati destinati all'edificazione per costruire il grandioso Central Park: nessun urbanista aveva inventato allora i "diritti edificatori".
Un secolo fa l’economista inglese John Maynard Keynes ha suggerito che, quando un paese è in crisi economica e di occupazione ... (segue)
Un secolo fa l’economista inglese John Maynard Keynes ha suggerito che, quando un paese è in crisi economica e di occupazione, una soluzione consiste nell’investire denaro pubblico in opere di utilità generale, in quelle che una volta si chiamavano “lavori pubblici” e che in Italia avevano addirittura un apposito ministero: strade, ferrovie, porti, edifici pubblici. I soldi pubblici spesi avrebbero assicurato un salario a lavoratori i quali li avrebbero spesi per acquistare quelle merci che fino allora erano fuori dalla portata delle loro tasche. Per produrre tali merci molte imprese avrebbero assunto altri lavoratori che a loro volta sarebbero diventati consumatori di altre merci e così via. Imprenditori e lavoratori avrebbero pagato, in nuove tasse, più di quello che lo stato aveva speso per avviare le opere pubbliche.
La ricetta funzionò, più o meno come aveva suggerito Keynes, negli Stati Uniti durante la prima grande crisi del Novecento; il governo di Franklin Delano Roosevelt, dal 1933 fino alla seconda guerra mondiale, fece, con i soldi dei contribuenti, opere pubbliche utili, anche dal punto di vista ambientale, come difesa del suolo dall’erosione, rimboschimento, centrali elettriche, addirittura fabbriche di concimi e di prodotti chimici “statali” (un‘eresia per il liberalismo americano).
Qualcosa di questo spirito fu recepito anche in Italia negli anni della ricostruzione, dopo il 1945, soprattutto con l’occhio rivolto al Mezzogiorno arretrato. Ce ne siamo dimenticati, ma se il Mezzogiorno ha accorciato le distanze rispetto all’Italia settentrionale più industrializzata è stato per merito delle fabbriche statali, delle strade, della distribuzione ai contadini delle terre abbandonate, delle case “popolari”, della difesa del suolo con rimboschimenti, della regimazione delle acque; i soldi spesi dallo stato sono rientrati, con gli interessi, attraverso le tasse riscosse a mano a mano che nasceva nuova occupazione nelle fabbriche e nei cantieri sorti, nel Sud e nel Nord, per soddisfare la nuova domanda di abitazioni, frigoriferi, televisori, automobili.
Certo, ci sono stati vistosi errori, dovuti a previsioni e a scelte imprenditoriali sbagliate, a localizzazioni errate, ci sono stati episodi di vistosa corruzione, per cui tanto denaro pubblico ha fatto ricchi e ricchissimi pochi mentre avrebbe potuto togliere dalla miseria tanti nostri concittadini.
Col passare dei decenni le parole “stato” e “pubblico” sono diventate politicamente poco corrette davanti alla nuova ideologia della privatizzazione. L’esito sono state le crisi che hanno caratterizzato la seconda metà del Novecento e l’inizio di questo secolo, al punto che si deve di nuovo invocare l’intervento dello stato per opere pubbliche, oggi le chiamano infrastrutture.
Ci sono opere pubbliche elettoralmente redditizie, che consentono di inaugurare autostrade, ferrovie, ponti, con discorsi ufficiali e tanta televisione. Ma ci sono altri umili lavori di grande utilità pubblica e sociale, che richiederebbero l’impiego di migliaia di lavoratori, che non si possono inaugurare con interventi della televisione ma che salverebbero, di tante persone, i beni e i campi e i soldi (e anche molte vite), portati via dalle continue frane e dagli allagamenti di terre e città.
In seguito al terremoto del 1980, a Napoli si attua un imponente programma di edilizia residenziale pubblica basato sul recupero dei centri storici. Una vicenda straordinaria, assai sottovalutata, che merita di essere raccontata.(m.b)
 |
Le aree interessate dal piano delle periferie, approvato nel 1980, con evidenziati i luoghi visitati durante l’iniziativa Una città un piano. |
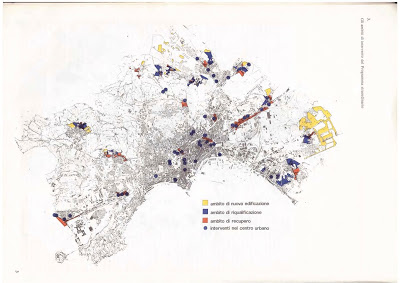 |
| Gli ambiti di intervento del programma straordinario approvato nel 1981 |
Altri documenti interessanti, comprese fotografie e video dell’epoca, sono consultabili nelle pagine web di UrbaNa, curate dal Comune di Napoli.
 In occasione dell'iniziativa Una città un piano sul programma di ricostruzione del post-terremoto di Napoli, recuperiamo un articolo di Antonio Cederna che descrive i risultati raggiunti e le lezioni impartite, la Repubblica, 20 maggio 1987 (m.b.)
In occasione dell'iniziativa Una città un piano sul programma di ricostruzione del post-terremoto di Napoli, recuperiamo un articolo di Antonio Cederna che descrive i risultati raggiunti e le lezioni impartite, la Repubblica, 20 maggio 1987 (m.b.)«Natura di cose altro non che il nascimento di esse»: l'esperienza di riqualificazione urbana e di recupero in corso a Napoli - i risultati raggiunti e i loro limiti - possono appieno apprezzarsi solo se si conosce, sia pure sommariamente, la complessa vicenda della ricostruzione dopo il terremoto del 23 novembre 1980, di cui quell'esperienza è parte.
In primo luogo, sembra perciò utile una cronaca, per quanto possibile oggettiva, dell'origine e dello sviluppo del Programma straordinario. In secondo luogo, questa premessa ha il dovere di intervenire nel dibattito che i metodi e le procedure adottate a Napoli hanno provocato fra i cittadini interessati, nell'opinione pubblica, in ampi settori dell'amministrazione e dei mezzi di informazione e fra gli operatori della materia. In particolare, interessa mettere in evidenza che l'operazione in corso ha senso solo se può proseguire in un' azione ordinaria di lunga durata, indispensabile alla soluzione dei drammatici problemi della città. Non è infatti difficile dimostrare - ed è l'ultimo argomento di queste note che la situazione abitativa dell'area metropolitana di Napoli (che è privo di significato parlare di Napoli isolandola dal suo territorio) raggiunge indici di bisogno e di disagio che non hanno riscontro nel resto del paese.
Infatti, secondo la legge 219, «formano oggetto della concessione tutte le opere necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione e il pagamento delle indennità [...], la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il numero degli alloggi da realizzare, le tipologie degli stessi, le prescrizioni urbanistico-edilizie da osservare e i termini per la realizzazione dell'intervento, la progettazione esecutiva delle opere, la realizzazione delle stesse e quant'altro necessario per rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli assegnatari».
Nei torridi giorni dell'agosto 1981 ha quindi inizio il lavoro dei progettisti incaricati dai consorzi; i tecnici impegnati aumentano con il passare delle settimane: alla fine sono quasi mille. La convenzione prevede tre fasi - schema urbanistico, progetto di massima e progetto esecutivo - ciascuna soggetta all'approvazione del sindaco-commissario. Si organizzano, infatti, gli uffici di questa singolare istituzione, che si avvale anche della consulenza di qualificati esperti e di istituti specializzati, distinti in strutture «orizzontali» e «verticali». Le prime, una per ciascuno dei 12 comparti territoriali, operano in corrispondenza degli altrettanti consorzi concessionari, di cui rappresentano la «controfaccia»: le strutture orizzontali operano invece per materia di competenza (nuova edificazione, recupero, urbanizzazioni, attuazione degli interventi, sicurezza antisismica, ecc.). Il lavoro consiste essenzialmente in incontri a tre -committente, progettisti e impresa - che consentono una rapida soluzione dei problemi. I progetti sono poi sottoposti a una commissione che raccoglie i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate e degli enti erogator i di servizi.
A regime, si riusciranno ad approvare ogni mese progetti per 40 miliardi (lire 1981), importo di tutto rispetto se confrontato con i 100 miliardi all'anno ordinariamente assegnati alla Regione Campania per l'edilizia pubblica e che in parte restano inutilizzati.
I criteri e i vincoli definiti per la progettazione degli interventi di sostituzione e di completamento riconoscono un valore primario alle preesistenti tipologie urbanistiche. Si richiede perciò il rispetto dei lotti che compongono il tessuto insediativo, della scomposizione interna alle corti, delle loro caratteristiche tipologiche, distributive e dimensionali. Questa impostazione rende, di fatto, sostanzialmente indifferente la scelta fra conservazione e sostituzione: prevale l'ultima modalità quando ragioni di costo, o irrimediabili condizioni statiche degli immobili, rendono impraticabile la conservazione. (Questi argomenti sono oggetto del saggio di Carlo Gasparrini, cap. Il, cui si rinvia per ogni approfondimento).
In sostanza, nella situazione data, rischiava di andare in crisi, per gli interventi di recupero, la stessa filosofia del rapporto concessorio. Il progressivo chiarimento che si era raggiunto, a seguito di lunghe, appassionate e faticose discussioni con esperti e operatori, anche estranei al Programma straordinario, in ordine alla metodologia del recupero , pretendeva infatti la piena «disponibilità» della progettazione da parte del committente. E non che non ci fossero progettisti interessati, convinti e disponibili ad approfondire la linea che a mano a mano si metteva a punto negli uffici del commissariato e che aveva il punto di partenza nelle analisi storico-tipologiche di cui tratta l'esemplare saggio di Gianfranco Caniggia pubblicato in questo volume, (nel cap. Il). Anzi, proprio il contributo di più architetti e tecnici professionalmente impegnati nell'iniziativa è stato determinante per verificare la concreta praticabilità dei metodi che si definivano. Il problema era perciò essenzialmente di natura contrattuale in quanto la più precisa definizione della domanda da parte del concedente poteva entrare in conflitto con le «libertà già garantite agli operatori, in particolare attraverso la determinazione a misura del costo degli interventi .
Senza chiamare in causa questioni di storia e di cultura, in sintesi di qualità urbana, è facile calcolare che la rinuncia al capitale infrastrutturale e sociale esistente e le immense spese di sistemazione temporanea degli abitanti e delle attività insediati sono nettamente superiori al costo delle operazioni di «cuci e scuci» urbanistico distribuite nel tempo (Ovvero di manutenzion eurbana) che si stanno sperimentando con il Programma straordinario. AI recupero, allora, non c'è alternativa se non si vuole imboccare il vicolo cieco di un'espansione illimitata degli insediamenti (ma a Napoli, per esempio, dov'è lo spazio?), le cui parti più antiche continuano a marginalizzarsi socialmente ed economicamente.
Sappiamo tutti che sono in corso riflessioni e ricerche su nuove forme di società immobiliari, sulle quali dovrebbe svilupparsi un dibattito più ampio di quanto non ci sia stato finora. Da questo punto di vista, dovrebbero sfruttarsi «in positivo» le stesse caratteristiche negative della situazione napoletana. Per esempio, a una così alta percentuale di alloggi in affitto dovrebbe corrispondere -nel rispetto di determinate condizioni -una più agevole manovra della mobilità abitativa, che è un presupposto essenziale per affrontare rilevanti problemi di riqualificazione urbana.
Ricorrono nel 2012, e precisamente domani,i cinquant’anni della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante «Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare». Ricorrono altresì quest’anno i settant’anni della legge urbanistica, la l. 18 agosto 1942, n. 1150, ma con un significativa differenza. La legge urbanistica, per quanto approvata nel 1942, era il frutto di un’elaborazione risalente a dieci anni prima, come ben risulta dagli studi sulla sua formazione (v. V. De Lucia, La legge urbanistica del 1942); la l. 167 era invece frutto proprio del suo tempo.
Dopo il governo Tambroni del 1960, che aveva avuto l’appoggio determinante del MSI, si era formato il terzo governo Fanfani, un monocolore democristiano di «restaurazione democratica», conosciuto anche come il governo delle «convergenze parallele». La Democrazia cristiana aveva tenuto nel settembre 1961 un convegno di studi a San Pellegrino e poi, alla fine di gennaio 1962, il suo ottavo congresso nazionale a Napoli: erano maturate così le condizioni per un nuovo governo. Fanfani succedeva a sé stesso e nel febbraio 1962 formava il suo quarto governo, un tripartito Dc-Psdi-Pri, con un programma concordato anche con il Psi. Per iniziativa di quel governo venivano approvate nello stesso anno 1962 due importanti riforme. La l. 31 dicembre 1962, n. 1859 istituiva la scuola media unica, realizzando così non solo una riforma scolastica ma una vera riforma sociale: si superava il modello classista della riforma Gentile fondato sulla distinzione tra scuola classica umanistica e scuola di avviamento professionale, senza insegnamento del latino e senza possibilità di accesso agli studi superiori. La l. 6 dicembre 1962, n. 1643 nazionalizzava le imprese esercenti le industrie elettriche, ponendo così le basi per la diffusione della rete elettrica nelle zone rurali, trascurate dalle imprese private, al fine di favorire il loro sviluppo.
Prima ancora di quelle riforme, e giusto nell’anniversario delle elezioni del 18 aprile 1948 per la prima legislatura repubblicana, il Parlamento approvava il disegno di legge sull’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare avviato dal precedente governo nel quale ministro dei lavori pubblici era stato Benigno Zaccagnini, sostituito nel quarto governo Fanfani da Fiorentino Sullo.
L’intervento pubblico per l’edilizia popolare aveva una lunga tradizione, risalente all’inizio del secolo. La l. 31 maggio 1903, n. 254, nota anche come legge Luzzatti, era stata seguita da vari altri provvedimenti legislativi, sistemati nel corso del tempo in testi unici, nel 1908, nel 1919 e, da ultimo, nel 1938 (r.d. 28 aprile 1938, n. 1165). Dopo la guerra, inoltre, proprio Fanfani, ministro del lavoro nel quinto governo De Gasperi, aveva promosso un importante progetto per incrementare l’occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori: la l. 28 febbraio 1949, n. 43 aveva istituito la gestione Ina-casa, rinnovando le forme organizzative e finanziarie dell’intervento pubblico per l’edilizia popolare. La gestione Ina-casa aveva prodotto, nei suoi due piani settennali,risultati imponenti: le case Fanfani, come vennero presto denominate, furono realizzate in gran numero e su tutto il territorio nazionale, anche in centri minori (su quella esperienza v. da ultimo il volume a cura di Paola Di Biagi, La grande ricostruzione. Il piano Ina-casa e l’Italia degli anni ’50 , Donzelli, Roma, 2001).
La l. 167 del 1962 costituiva però un significativo sviluppo poiché affrontava il tema, in precedenza trascurato, della disciplina urbanistica delle aree per l’edilizia economica e popolare, integrando e sviluppando la legge urbanistica del 1942.
I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e quelli capoluogo di Provincia erano tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare (peep); gli altri Comuni ne avevano facoltà, ma potevano anche esservi obbligati dal Ministro per i lavori pubblici, ove ne riconoscesse la necessità. La legge stabiliva un termine stringente per la formazione del piano, 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o dalla comunicazione della decisione ministeriale, e prevedeva anche, in caso di inadempienza, l’intervento sostitutivo mediante un commissario nominato dal prefetto.
Le aree da comprendere nel piano dovevano essere scelte di norma nelle zone destinate a edilizia residenziale nei piani regolatori generali vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell’aggregato urbano. In caso di mancanza del prg era prevista la formazione, insieme al peep, di un programma di fabbricazione. La legge richiedeva dunque sempre una pianificazione urbanistica generale dell’intero territorio comunale entro cui inquadrare la specifica pianificazione urbanistica dell’edilizia economica e popolare, configurata come esecutiva di quella generale. Il sistema della pianificazione a cascata della legge urbanistica del 1942 veniva confermato nella sua impostazione ma anche attenuato nelle modalità operative poiché si consentivano peep in variante dei prg. Con un unico procedimento si poteva variare il prg e approvare un peep che risultasse conforme al prg così come variato. In questo caso il procedimento di formazione del peep era quello del prg: il piano era soggetto ad approvazione del Ministero dei lavori pubblici, mentre i peep conformi al prg (e senza osservazioni da parte delle amministrazioni centrali dello Stato) erano approvati dal provveditore regionale alle opere pubbliche.
La configurazione dei peep quali piani esecutivi di una pianificazione generale si manifestava anche sotto altri aspetti. Ai peep veniva attribuito lo stesso valore dei piani particolareggiati di esecuzione del prg previsti dalla legge urbanistica, compresa l’equivalenza a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste che consentiva l’espropriazione delle aree. La legge, anzi, accelerava le procedure stabilendo che l’approvazione dei peep equivaleva anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti e edifici in esso previsti, in modo da consentire anche l’occupazione d’urgenza in via anticipata rispetto all’espropriazione.
L’espropriazione diventava il modo normale di realizzazione della pianificazione urbanistica, sia pure limitatamente alla parte di pianificazione riguardante l’edilizia economica e popolare. Veniva così ripresa una previsione della legge urbanistica del 1942, quella relativa all’espropriabilità delle aree urbane (art. 18), che è stata largamente trascurata dai Comuni, soprattutto per mancanza delle necessarie risorse finanziarie, ma che, se effettivamente utilizzata, avrebbe consentito uno sviluppo urbanistico qualitativamente ben diverso e migliore di quello concretamente realizzatosi.
I Comuni potevano riservare a sé stessi l’acquisizione fino a un massimo del cinquanta per cento delle aree comprese nel piano, salvo cessione del diritto di superficie o rivendita a enti o privati che si impegnassero a realizzare la costruzione di case economiche e popolari. Le rimanenti aree potevano essere richieste per la costruzione di case popolari da parte di altri soggetti: lo Stato e gli enti pubblici territoriali, l’Incis, l’Ina-casa, le società cooperative, l’Inpgi, altri enti senza fine di lucro operanti nel settore. La legge, dunque, assegnava un ruolo centrale ai Comuni nella definizione degli aspetti urbanistici dell’edilizia economica e popolare, ma lasciava un assetto pluralistico per la realizzazione degli immobili: il ruolo dei Comuni non era esclusivo, ma almeno la metà delle aree doveva essere resa disponibile per la realizzazione degli immobili da parte di soggetti diversi.
Per l’espropriazione delle aree la legge adottava soluzioni riformiste, ma non estremiste. L’indennità di espropriazione era infatti determinata secondo la legge generale sulle espropriazioni (l. 25 giugno 1865, n. 2359) e quindi era commisurata al valore venale; tuttavia la legge si proponeva di contenere la rendita fondiaria e a tal fine stabiliva che il valore venale fosse determinato senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione e attuazione del piano. Il principio non era nuovo, poiché era stato già stabilito dall’art. 38 della legge urbanistica, ma la sua conferma, quanto mai opportuna, era espressione di una precisa volontà politica che continuò ad animare i propositi riformatori del governo. La legge inoltre, sempre per contenere la rendita fondiaria, stabiliva che il valore venale dovesse essere riferito a due anni precedenti alla deliberazione del piano, invece che al momento dell’espropriazione (per questo aspetto, tuttavia, la legge venne dichiarata illegittima da Corte cost., 22/1965, per il lungo intervallo di tempo possibile tra l’approvazione del peep e l’espropriazione nonché per le disparità di trattamento tra proprietari espropriati in momenti diversi).
La legge inoltre conciliava il potere pubblico di pianificazione e di espropriazione col principio liberale del minimo sacrificio dei diritti privati compatibile con il perseguimento dell’interesse pubblico. I proprietari delle aree ricomprese nei peep potevano evitare l’espropriazione impegnandosi direttamente, con la richiesta della licenza edilizia, a costruire sulle aree stesse fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare, sempre che le opere venissero iniziate entro centoventi giorni dal rilascio della licenza e venissero ultimate entro il biennio dall’inizio della costruzione.
La l. 167 ebbe successo, segnando un importante progresso sia per le realizzazioni di edilizia economica e popolare sia per la disciplina urbanistica. Modificata e integrata, soprattutto dalla l. 865 del 1971, essa è ancora formalmente in vigore, anche se di fatto la sua utilizzazione è ormai da tempo marginale. Il problema sociale dell’abitazione ha assunto in mezzo secolo contorni diversi, se è vero che oltre l’ottanta per cento delle famiglie oggi vive in casa di proprietà. Ma rimane sempre una fascia, pur piccola, di popolazione bisognosa, tanto bisognosa da non poter aspirare alla casa di proprietà per impossibilità di ricorso al credito e in difficoltà anche nel sostenere i canoni di locazione del mercato, pienamente liberalizzato dalla fine del 1998. L’edilizia economica e popolare, che con la piena attuazione dell’ordinamento regionale aveva assunto la nuova e corretta denominazione di edilizia residenziale pubblica, si è molto ridotta ed è stata sostituita nel linguaggio corrente delle amministrazioni locali dall’housing sociale, una miserevole espressione entrata, a fini fiscali, persino nella legislazione statale (si veda la rubrica dell’art. 57 del cd decreto Cresci Italia, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27).Una stagione dello Stato socialee del riformismo sembra conclusa, ma non con l’esaurimento del bisogno, bensì con la progressiva riduzione dell’intervento solidaristico a sostegno dei più deboli.
Sul piano strettamente urbanistico la l. 167 ha largamente ispirato la legislazione (statale e regionale) più recente sui piani esecutivi in variante del piano regolatore generale. Ma quel sistema, che poteva avere una giustificazione nel 1962 e limitatamente all’edilizia economica e popolare, è diventata un vero tarlo che ha inficiato un corretto sistema di pianificazione urbanistica. Inoltre la legislazione successiva non ha ripreso il contrasto alla rendita fondiaria, una tassa a favore dei proprietari delle aree che grava molto pesantemente sul settore immobiliare che finora è rimasta immune dalle iniziative intraprese per il contenimento delle rendite e per la promozione dello sviluppo economico.
Vedi anche Il ventennio del cambiamento e della speranza
Dichiarazione finale approvata all’unanimità a conclusione del Convegno Nazionale per la Salvaguardia e il Risanamento dei Centri Storici (Gubbio 17-18-19 settembre 1960).
Il successo dei Convegno di Gubbio promosso da un gruppo di Comuni, affiancato da parlamentari e studiosi[1], consente la formulazione di una dichiarazione di principi sulla salvaguardia ed il risanamento dei Centri Storici.
Le relazioni degli otto Comuni promotori, la presentazione nella mostra di alcuni studi, in parte preparatori ed in parte esecutivi, di operazioni di risanamento conservativo e l’adesione al Convegno di 50 Comuni dimostrano il crescente interesse che il tema sta suscitando presso le Amministrazioni locali e larghi strati di opinione pubblica.
L’estensione a scala nazionale del problema trattato è stata unanimemente riconosciuta, insieme alla necessità di un’urgente ricognizione e classificazione preliminare dei Centri Storici con la individuazione delle zone da salvaguardare e risanare. Si afferma la fondamentale e imprescindibile necessità di considerare tali operazioni come premessa allo stesso sviluppo della città moderna e quindi la necessità che esse facciano parte dei piani regolatori comunali, come una delle fasi essenziali nella programmazione della loro attuazione.
Si invoca una immediata disposizione di vincolo di salvaguardia, atto ad efficacemente sospendere qualsiasi intervento, anche di modesta entitଠin tutti i Centri Storici, dotati o nodi Piano Regolatore, prima che i relativi piani di risanamento conservativo siano stati formulati e resi operanti.
Si riconosce la necessità di fissare per legge i caratteri e la procedura di formazione dei piani di risanamento conservativo, come speciali piani particolareggiati di iniziativa comunale, soggetti ad efficace controllo a scala regionale e nazionale, con snella procedura di approvazione e di attuazione.
Detti piani fisseranno modalità span> e gradualità di tutti gli interventi su suolo pubblico e privato, sulle fronti e nell’interno degli edifici, e si attueranno esclusivamente mediante comparti, ciascuno dei quali rappresenti un’entità di insediamento e di intervento.
Rifiutati i criteri del ripristino e delle aggiunte stilistiche, del rifacimento mimetico, della demolizione di edifici a carattere ambientale anche modesto, di ogni “diradamento” ed “isolamento” di edifici monumentali attuati con demolizioni nel tessuto edilizio, ed evitati in linea di principio i nuovi inserimenti nell’ambiente antico, si afferma che gli interventi di risanamento conservativo, basati su una preliminare profonda valutazione di carattere storico-critico, devono essenzialmente consistere in:
a. consolidamento delle strutture essenziali degli edifici;
b. eliminazione delle recenti sovrastrutture a carattere utilitario dannose al l’ambiente ed all’igiene;
c. ricomposizione delle unità immobiliari per ottenere abitazioni funzionali ed igieniche, dotate di adeguati impianti e servizi igienici, o altre desti nazioni per attività economiche o pubbliche o per attrezzature di mode sta entità compatibili con l’ambiente, conservando al tempo stesso vani ed elementi interni ai quali l’indagine storico-critica abbia attribuito un valore;
d. restituzione, ove possibile, degli spazi liberi a giardino ed orto;
e. istituzione dei vincoli di intangibilità e di non edificazione.
Si ravvisa la necessità che la valutazione storico-critica debba, per omogeneità di giudizi, essere affidata ad una commissione regionale ad alto livello e che la redazione dei piani di risanamento e dei comparti, da affidare a tecnici qualificati, avvenga in stretta connessione con la commissione regionale e con i progettisti dei Piani Regolatori.
Si suggerisce che la pubblicazione dei piani di risanamento conservativo si avvalga di una procedura particolare, in cui siano previste forme di pubblicità estesa, come, ad esempio, la contemporanea esposizione in sede regionale oltre che locale, al fine di consentire osservazioni qualificate e l’esame delle osservazioni con l’intervento di particolari competenze.
Si afferma che nei progetti di risanamento una particolare cura deve essere posta nell’iindividuazione della struttura sociale che caratterizza i quartieri e che, tenuto conto delle necessarie operazioni di sfollamento dei vani sovraffollati, sia garantito agli abitanti di ogni compatto il diritto di optare per la rioccupazione delle abitazioni e delle botteghe risanate, dopo un periodo di alloggiamento temporaneo, al quale dovranno provvedere gli Enti per l’edilizia sovvenzionata; in particolare dovranno essere rispettati, per quanto possibile, i contratti di locazione, le licenze commerciali ed artigianali ecc., preesistenti all’operazione di risanamento.
Per la pratica attuazione di tali principi, si invoca un urgente provvedi mento di legge generale che, assorbendo i due disegni di legge del senatore Zanotti Bianco ed altri e dell’on. Vedovato, risolva in modo organico la complessa materia e stabilisca:
I. le modalità ed il finanziamento per il censimento dei Centri Storici;
2. la programmazione delle operazioni alla scala nazionale;
3. le modalità per la formazione dei piani esecutivi di risanamento conservativo, secondo i principi enunciati, affidando ai Comuni la responsabilità delle operazioni per la loro realizzazione;
4. le procedure per la disponibilità dei locali durante le operazioni di risanamento, ivi comprese le modalità per la formazione dei consorzi obbligatori e per un rapido svolgimento delle pratiche di esproprio o prevedendo anche la sostituzione, da parte del Comune, di Enti o di cooperative, ai proprietari inadempienti o che ne facessero domanda;
5. l’entità e le modalità di finanziamento delle operazioni, preferenzialmente risolto con la concessione di mutui a basso interesse ai Comuni interessati con eventuale garanzia dello Stato e con facoltà del Comune di graduare il tasso di interesse proporzionalmente al grado di utile ricavato dall’operazione, con eventuale contributo a fondo perso nei casi di accertata e notevole diminuzione di valore dell’intero compatto;
6. le modalità per la perequazione dei valori economici delle singole proprietà all’interno di ogni compatto;
7. la possibilità gli Enti dell’edilizia sovvenzionata di partecipare alle operazioni di risanamento.
A conclusione dei propri lavori, il Convegno riafferma la necessità che gli auspicati provvedimenti sulla salvaguardia ed il risanamento dei Centri Storici improntati ai principi enunciati formino un unico corpo di norme legislative facente parte, a sua volta, come capitolo fondamentale, del Codice dell’urbanistica, in corso di elaborazione.
[1] Il convegno è stato promosso da un gruppo di architetti, urbanisti, giuristi, studiosi di restauro, e dai rappresentanti dei comuni di Ascoli Piceno, Bergamo, Erice, Ferrara, Genova, Gubbio, Perugia, Venezia. Le relazioni sono svolte da: G. Samonà, A. Cederna, M. Manieri Elia, G. Badano, D. Rodella, E.R. Trincanato, G. Romano, L. Belgiojoso, E. Caracciolo, P. Bottoni
(per motivi di spazio sono state omesse Note, immagini e Bibliografia, per cui naturalmente si rinvia alla pubblicazione cartacea)
Il piano Milano Verde, elaborato nel 1938 da un gruppo di progettisti legati a Giuseppe Pagano e alla rivista Casabella, rappresenta un singolare caso di scollamento tra immagine e realtà. Come ne La liahison des images di Rene Magritte, che raffigura una pipa seguita dalla dicitura ceci n' est pus une pipe, tra la rappresentazione di un oggetto e la sua realtà vi è la stessa distanza che possiamo trovare tra l‘immagine di questo piano urbanistico e i suoi reali contenuti insediativi. Che il piano Milano Verde abbia affermato e consolidato il proprio ruolo soprattutto in quanto icona è confermato dal fatto che, negli ultimi 40 anni, sono stati presentati esemplari del plastico in diverse esposizioni, senza tuttavia che si entrasse mai compiutamente nel merito qualitativo e quantitativo del progetto. Ed è proprio grazie alla forza della sua immagine 'dimostrativa' che il piano è stato ideologicamente assunto dalla storiografia contemporanea come un vero e proprio quartiere-modello.
Ad esempio, nel 1979 Francesco Dal Co affermava che questo «rigoroso» progetto rappresentava una delle «testimonianze» delle «battaglie degli architetti razionalisti» nel periodo tra le due guerre; secondo Antonino Saggio, Milano Verde «presenta una gerarchizzazione tra i volumi, una calibrazione attenta dei servizi e del verde, un corretto orientamento degli edifici che si richiamano alle esperienze di Gropius e di Oud, che faranno scuola tra i giovani architetti». Anche per Arturo Carlo Quintavalle il rapporto più ovvio di Milano Verde «è ancora con la progettazione di Gropius per i quartieri popolari di Dessau»; mentre per Cesare De Seta il piano divenne addirittura un punto di riferimento per il razionalismo, al punto che «il piano per un quartiere operaio a Rebbio di Terragni e Sartoris può considerarsi un [suo] ideale completamento».
Lo stesso Ignazio Gardella, uno dei progettisti del piano, nel 1986 lo aveva legato alle esperienze tedesche, riconoscendone peraltro i limiti culturali: «il progetto di Milano Verde del gruppo Pagano, di cui anch'io facevo parte, aveva un'evidente parentela con le famose 'Siedlungen' delle città tedesche e un impianto molto rigido, con il costante ossessivo allineamento dei fabbricati secondo un unico, asse di orientamento. Non è certo un modello da riproporre oggi, neanche come modello di riferimento».
Questi giudizi, che accomunano frettolosamente Milano Verde ad altre esperienze del tutto eterogenee tra loro di quartieri popolari, le Siedlungen tedesche, Gropius, Oud, Terragni e Sartoris, ecc.) potrebbero far pensare a un'idea di coesione e di coerenza del razionalismo che non è assolutamente mai esistita ne in Europa ne tantomeno in Italia. Rispetto alle polemiche e alle divisioni culturali del Movimento Moderno in ambito europeo, la vicenda dell'architettura italiana degli anni Venti e Trenta si presentava ancora più sfaccettata e sfrangiata, tra una tradizione accademica molto forte e radicata, tra le esperienze artistiche autoctone del Novecento, dell'arte Metafisica e dell'avanguardia Futurista e tra un codice linguistico 'moderno' d'importazione europea. In quel periodo l'architettura rivestiva un ruolo politico di primaria importanza come strumento di regime per ottenere il consenso popolare. In Italia l'architettura moderna era soprattutto una questione di stile, nel tentativo - quanto mai votato all'insuccesso- di promuoversi come «arte di Stato», secondo la formula coniata da Pietro Maria Bardi.
Non a caso già ne1 1933, in occasione della V Triennale, Edoardo Persico aveva decretato la fine del razionalismo italiano, da lui ritenuto niente più che «un bisogno artificioso di novità» o un'«imitazione dell'estero», per sottolineare come sotto l'ombrello di comodo del razionalismo si radunassero troppi architetti, pochi per reale convinzione e molti per convenienza professionale. L'architettura moderna italiana si riduceva quindi, in molti casi, a un tentativo di autopromozione tramite l'espressione di uno stile d'importazione mescolato ad alcuni equivoci linguistici quali la 'mediterraneità' e la 'romanità', che avrebbero dovuto confermare una presunta tradizione italica della modernità, incrociata con il classicismo quale carattere genetico dell'arte italiana.
|
Lo stesso contesto milanese in quel periodo era tutt'altro che unito, nonostante molti storici abbiano esaltato a più riprese, con toni epici" il luogo comune delle cosiddette «battaglie degli architetti razionalisti». Tra il 1933 e il 1936 i principali riferimenti milanesi erano costituiti dalle redazioni delle riviste: Domus di Gio Ponti, Casabella-Costruzioni diretta da Persico e Pagano (attorno alla quale si riunivano soprattutto Albini, Palanti, Romano e Gardella) e Quadrante, alla quale erano maggiormente legati i Bbpr, Figini e Pollini, Terragni.
Quindi, sotto le etichette dei termini 'razionalismo' e 'moderno' in quegli anni si accavallavano diverse linee culturali e progettuali, all'insegna di una volontà d'innovazione e, soprattutto, di affermazione professionale. Non vi era assolutamente una tendenza predominante, ma una compresenza d'atteggiamenti diversi, accomunati dalla volontà di contribuire a costruire l'espansione di Milano secondo il nuovo Piano Regolatore di Cesare Albertini de1 1934.
Il Piano Milano Verde fu presentato su Casabella-Costruzioni nel 1938, con un saggio introduttivo di Giuseppe Pagano dall'impegnativo titolo L'ordine contro il disordine, nel quale si scomodava perfino il Libro della Genesi per introdurre il tema del reticolo ortogonale come conquista della civiltà. Il disordine rispetto al quale Milano Verde voleva intervenire non era tanto quello della situazione esistente, quanto quello della pianificazione allora in atto, il Piano Albertini, che in quell'area prevedeva la lottizzazione della Fiera e dell'ex-scalo ferroviario lungo via Pallavicino, con un disegno piuttosto complesso di strade diagonali.
Il settore urbano interessato dall'intervento, compreso tra l'area della Fiera e Corso Sempione, aveva un'estensione territoriale di circa un milione e mezzo di metri quadri. Milano Verde nasceva anche come esplicito tentativo di concretizzare una serie di rilevanti trasformazioni urbane che si presentavano a quel tempo, con alcune impressionanti coincidenze con la Milano contemporanea di questo primo decennio del XXI secolo. Ne1 1938, infatti, oltre che della trasformazione dell'area dello scalo ferroviario di smistamento s'iniziava a parlare anche del trasferimento della Fiera e dello spostamento delle caserme tra via Mario Pagano e via Reggimento Savoia di Cavalleria, altri temi d'attualità dopo oltre settant'anni. È soprattutto su queste aree di proprietà pubblica e su quelle private ancora libere che il piano Milano Verde giocava le proprie possibilità di realizzazione. In questo senso, questo progetto aveva senz'altro una valenza culturale ma, privo com'era di una vera e propria committenza, assumeva anche i connotati di un vero e proprio progetto promozionale.
Come già detto, Milano Verde si presentava con la nitida immagine del quartiere fondato sul principio dell'edilizia aperta, nel quale assumeva una certa importanza il corretto distanziamento degli edifici e una caratterizzazione specializzata degli spazi aperti ('verde' pubblico e privato, strade, giardini, parcheggi). Quello che viene proposto è un vero e proprio masterplan ante-litteram, cioè un sistema di lottizzazione di iniziativa privata destinato a un mercato di edilizia borghese di livello medio-alto. A questo proposito, uno delle letture più attente di questo piano urbanistico è stata quella di Guido Canella il quale, pur senza addentrarsi in un'analisi puntuale, ha osservato come Milano Verde risulti «funzionalmente distorto dal paradigma del quartiere razionalista e che è improprio attribuirgli un 'ideologia ed una strategia aderenti al Movimento Moderno internazionale», per la sua destinazione al ceto borghese medio-alto anziché alla classe operaia; per la " dimensione di molto superiore all'unità minima teorizzata dai Ciam (il piano prevede un insediamento di 45.000 abitanti contro quella che è l'unità minima di 6.000-7.000); per la sua stretta dipendenza e complementarietà al centro storico; per non essere un quartiere auto-sufficiente e per la dotazione, la qualità e la gestione dei suoi servizi.
In effetti, saranno ben altri i progetti nei quali gli architetti milanesi affronteranno più compiutamente il tema della residenza popolare e del quartiere autosufficiente. Nel 1940 Giuseppe Pagano, Irenio Diotallevi e Franco Marescotti presentano il ben più radicale Progetto di città orizzontale applicato al caso pratico di Milano tra via Brera e via Legnano19. Nel 1940 L'Istituto Fascista Autonomo Case Popolari (Ifacp) commissiona a un gruppo abbastanza eterogeneo, composto da Albini, Bottoni, Cerutti, Minoletti, Palanti, Pucci e altri il progetto di Quattro città satelliti alla periferia di Milano da realizzarsi in aree esterne rispetto alla città. Questi quattro progetti rappresentano uno dei contributi più significativi al tema del quartiere popolare. Inoltre, verranno realizzati, sempre per l'lfacp, i quartieri Fabio Filzi (1936-1938), Gabriele d’Annunzio (1939), Ettore Ponti (1939) su progetto Franco Albini, Renato Camus e Giancarlo Palanti.
Un montaggio di questi progetti del triennio 1938-1940 su una planimetria di Milano del 1936 mostra l'estensione dimensionale degli interventi rispetto al corpo della città. Da questo collage si nota come l'orientamento principale dei progetti sia prossimo a quello nord-sud, con due significative eccezioni, costituite dai progetti localizzati lungo la strada del Sempione: il quartiere Ifacp Costanzo Ciano in viale Certosa e proprio il piano Milano Verde. Soprattutto in quest'ultimo caso, è evidente come sia stato assunto l'orientamento del tessuto urbano già consolidato del Piano Beruto lungo Corso Sempione.
Milano Verde è un progetto di ricucitura urbana, che riallaccia i fili della maglia berutiana impostata sull'asse del Sempione, assumendone le direttrici principali. La viabilità è risolta secondo un principio di gerarchia funzionale legato al nuovo ordine ortogonale che viene impresso a tutto il settore urbano. Sono cancellate in modo definitivo le diagonali e i tracciati fuori squadra della Fiera e dell'ex-scalo di smistamento. All'interno delle direttrici principali che si legano ai tracciati esistenti si sviluppa una serie di strade secondarie di distribuzione ai lotti residenziali, vere e proprie «strade giardino», come sono definite dagli stessi autori.
Di fatto, Milano Verde tentava di coniugare due modelli urbani tra loro inconciliabili: quello dell'edificazione intensiva e quello della città-giardino. Il tentativo dei progettisti milanesi era quello di dimostrare che l'urbanistica moderna poteva essere conveniente dal punto di vista immobiliare, facendo coesistere in modo realistico e pragmatico la densità urbana con la qualità dell'abitare.
Il tema della densità era legato alla specificità del luogo e rappresentava la volontà di rispondere realisticamente alle opportunità del mercato immobiliare utilizzando i suoi stessi strumenti. Infatti, questa zona della città era già allora considerata di notevole pregio, al punto da essere definita come «il salvadanaio di Milano».
I lotti residenziali si inquadrano in un sistema di isolati di circa 110 x 220 m, che si sviluppa secondo le misure e gli orientamenti del Piano Beruto. Benché sia un concetto improprio in questo caso, è possibile quindi individuare un 'tessuto' prevalente di edifici in linea di 6 piani fuori terra (chiamati dai progettisti «case basse»), che insistono su lotti edificabili con un giardino privato. In totale vi sono 152 lotti di case a sei piani. Questo tessuto di «case basse» è interferito da due elementi principali. Il primo è costituito dalle «case alte», di 20 piani fuori terra, che sono in totale 15 (4 lungo Corso Sempione e 11lungo la Via Trionfale, prolungamento di via Vincenzo Monti) .Coerentemente con i principi dei Ciam, gli edifici sono distanziati in base all'altezza (il rapporto è più o meno 1/1).
L'indice di utilizzazione territoriale è di 1,06 mq/mq. È importante notare il peso che ha la viabilità urbana, pari a 658.719 mq per un totale del 42% del totale, addirittura superiore alle aree edificabili, di 638.685 mq (41 %). Ogni trenta metri era prevista una strada di accesso alle abitazioni, il che non permetteva certo di risolvere al meglio la distribuzione. Se gli isolati fossero stati accorpati a due a due si sarebbero ottenuti giardini più grandi e si sarebbe ridotta quasi della metà la superficie stradale. Un gruppo di 17 ville urbane si dispone lungo la fascia verde, con un peso insediativo del tutto trascurabile. Altre interferenze puntuali inglobate nel disegno sono costituite dalle preesistenze, come il velodromo Vigorelli.
Il secondo tema, quello della dttà-giardino, per sua natura estensivo e quindi antitetico a quello della densità, vuole costituire una critica alla città ottocentesca. Al principio moderno dell'edilizia aperta viene abbinato il tema del verde privato diffuso. In questa combinazione di verde privato e di edificazione in linea (nella relazione di progetto si usa il termine «edifici a .schiera» ) si possono trovare le principali analogie con la città giardino. Ma una città-giardino densa come Milano Verde è un ossimoro urbanistico; gli edifici di sei piani con i giardini privati antistanti sono di fatto inconciliabili con i principi della città-giardino.
Paradossalmente, in Milano Verde il peso insediativo del verde è molto basso. Il verde pubblico è solo il 12% della superficie territoriale, come dichiarato dagli stessi autori. Quello che è chiamato «parco» in realtà è un giardino urbano, più o meno delle stesse dimensioni di quello attuale di via Pallavicino sull'ex- scalo ferroviario. Il verde privato è più del doppio: in totale i giardini condominiali incidono per il 25,5% della superficie. Resisi conto della scarsità di verde, i progettisti hanno sommato le due quantità, dichiarando che il verde totale è il 37,5 % , anche se più di due terzi è privato.
Lo stesso Pagano aveva evidentemente sentito il bisogno di ritoccare le foto del plastico pubblicate su Casabella-Costruzioni per accentuare la percezione del verde. Anche gli spazi per i parcheggi pubblici sono molto ridotti, solo il5 % della superficie territoriale totale. Un confronto con la pianificazione attuale non ha ovviamente alcun valore critico, ma è comunque utile come termine di paragone: se Milano Verde fosse un odierno piano attuativo sarebbe ben al di sotto della dotazione di servizi richiesti. La realizzazione del piano si doveva articolare in tre fasi, anche in relazione alla demolizione degli edifici esistenti .La prima fase prevedeva la lottizzazione delle aree libere, dell'ex scalo ferroviario e degli isolati ancora non lottizzati. La seconda fase prevedeva la demolizione della Fiera e delle caserme di via Mascheroni. La terza e ultima fase rappresentava un completa- mento del disegno urbano.
Nonostante il plastico e le prospettive d'insieme mostrino una totale omogeneità architettonica, questa viene sorprendentemente negata nelle due viste prospettiche ravvicinate, che raffigurano una strada residenziale secondaria e la Via Trionfale. Il piano insegue infatti una notevole flessibilità realizzativa, in quanto i lotti lineari si possono suddividere secondo diverse modalità, come si vede nella tavola degli «schemi delle varie possibilità di suddivisione dei lotti per abitazione». Fatti salvi alcuni parametri fondamentali (il principio dell'edilizia aperta, lo spessore del corpo di fabbrica, l'altezza di gronda) ciascun edificio può quindi essere progettato e realizzato da operatori diversi. A detta degli stessi progettisti, infatti, «il regolamento di lottizzazione offre la possibilità dei più svariati raggruppamenti di volumi, di colori e di forme per ottenere, pur nell 'indispensabile controllo di un ordine generale, una varietà nel particolare e una vivacità nel dettaglio in modo da eliminare quella eventuale 'monotonia' che è l'ossessione del borghese, che pur si compra i vestiti fatti e sogna l'automobile 'di serie'»26. Quindi, pur auspicando una «sorveglianza artistica e tecnica totalitaria» per tutte le opere d'urbanizzazione, il verde, gli edifici pubblici egli spazi di uso pubblico, il piano accetta il tema della varietà architettonica degli edifici privati.
L'immagine urbana che ne consegue è dunque molto lontana da quella uniforme dei quartieri popolari di quegli anni, ma è molto più vicina alla varietà della città ottocentesca. Edifici moderni si accostano l'uno all'altro, accanto a diversi esempi novecentisti. La possibilità di suddivisione degli isolati lineari, peraltro regola- ta nel dettaglio e illustrata in ben tre elaborati grafici, è del tutto simile ai meccanismi di frazionamento immobiliare dell'isolato ottocentesco. E proprio qui nasce una delle più interessanti contraddizioni di questo piano: di fatto, i lotti residenziali con giardino non sono altro che degli isolati ottocenteschi 'stirati' e trasformati in elementi lineari, dove il giardino prende il posto del cortile condominiale. La differenza sta nel passaggio dalla forma chiusa dell'isolato a quella aperta dell'elemento in linea, ma il meccanismo di costruzione della città è lo stesso. Inoltre, gli edifici affacciati sul giardino non fanno altro che riproporre, in forma diversa, i rapporti della città ottocentesca. È difficile pensare che gli affacci sul giardino siano del tutto equivalenti a quelli sulla strada posteriore. Questi apparenti edifici lineari hanno poco in comune con il principio dell'edilizia aperta, sono pezzi di isolato con un fronte verso i giardini e un retro verso la strada posteriore.
Milano Verde non fornisce alcuna idea tipologica degli edifici residenziali. L'unica indicazione è quella relativa allo spessore dei corpi di fabbrica, di 13 metri. Questa vaghezza è dovuta al fatto che non c'era alcun bisogno di ulteriori indicazioni in quanto, essendo un piano fondato sull'iniziativa privata, doveva avere il massimo grado di generalità e di flessibilità. Le piante degli alloggi sarebbero quasi sicuramente risultate del tutto simili a quelle della città ottocentesca, con il tradizionale corpo doppio, il muro (o i pilastri) di spina e il corridoio di distribuzione centrale.. È negli spazi pubblici che Milano Verde esprime i suoi aspetti più interessanti. Anche in questo caso si misura comunque una significativa presa di posizione rispetto al tema della strada. In- fatti la via 1ìionfale, costituita da carreggiate stradali e tramviarie e da un percorso pedonale porticato su due livelli, recupera in pieno il ruolo della strada urbana come «valore di architettura civile» e non solo come arteria di scorrimento veicolare. Il percorso in quota conduce a una piazza sopraelevata situata al centro del progetto, intorno alla quale si trovano gli edifici di uso pubblico: un caffè, un cinema-teatro, una loggia.
Da questo punto una passerella conduce al parco, suddiviso in due parti dal prolungamento di via Domodossola. Il disegno degli spazi pubblici è studiato con molta accuratez- za. Particolarmente interessante è anche l'uso dell'acqua nel disegno urbano.
Il piano Milano Verde non ha avuto seguito, anche per il sopraggiungere della guerra. Tuttavia vi sono state alcune significative ricadute di questa esperienza, soprattutto per la chiarezza dimostrativa, quasi didattica, del suo impianto urbano. Nel 1948 viene presentata una proposta progettuale denominata «Fiume verde» sull'area dell'ex-scalo ferroviario, ad opera di Giulio Minoletti e Gio Ponti. Minoletti, uno dei progettisti di Milano Verde, cita espressamente l'esperienza di dieci anni prima, rispetto alla quale viene ripreso il tema del rapporto con gli spazi aperti, ma con una maggiore libertà compositiva ed una maggiore varietà tipologica. Proprio sulla base di quest'ultima esperienza, che riprende il tema dell'edilizia aperta alternando edifici a torre e palazzine di limitata dimensione, viene redatto negli anni' 50 il Piano Particolareggiato della zona Sempione- Fiera29, come attuazione del Prg del 1953 (fig. 19). La planimetria generale del Piano Particolareggiato ha pochissime congruenze planimetriche con I' analoga porzione di Milano Verde, il cui orientamento sud-est/nord-ovest è alternato con orientamenti ad esso ortogonali.
Di Milano Verde rimane comunque una evidente conseguenza architettonica, che mostra una singolare continuità con il progetto originale: il Palazzo Ina di Piero Bottoni in Corso Sempione a Milano, realizzato nel 1953-1958, che riprende alla lettera la volumetria e la collocazione del quarto degli edifici alti disposti a pettine lungo Corso Sempione.Questo edificio isolato, forse troppo isolato, rappresenta un vero e proprio frammento di quest'esperienza milanese de1 1938, la cui vera natura è rimasta a lungo celata dietro la sua candida immagine.
La vera natura, sfuggente e contraddittoria, di questo progetto contribuisce a mettere in crisi, con la sua ambiguità tra idealismo e realismo, quel quadro semplicistico dell'architettura moderna fatto di fragili catalogazioni e di rassicuranti luoghi comuni. Questa vicenda è la riprova di come il razionalismo a Milano si realizzi nella sua progressiva scomparsa, o se vogliamo nella sua progressiva trasfigurazione in entità espressive difficilmente catalogabili o, peggio ancora, etichettabili. Realismo, sperimentazione, rapporto con la storia, tradizione/tradizioni, compromessi, illusioni: in questa vicenda ci sono tutte le parole-chiave delle diverse vie che caratterizzeranno una parte significativa dell'architettura italiana nel secondo dopoguerra.
Questa rilettura di Milano Verde è basata solo su documenti noti e alla portata di tutti da 73 anni, cioè dalla data della loro pubblicazione. Ritroviamo qui la conferma dell'importanza dello studio delle opere e dei documenti per ricostruire la realtà dei fatti e la storia delle idee. Il fatto che molti studiosi si siano fermati a un livello di lettura quantomeno parziale di questo piano è abbastanza sorprendente, e si può forse spiegare proprio da un punto di vista metodologico.
Tralasciando gli episodi di superficialità, da escludere in quasi tutti i casi citati, le vicende dell'urbanistica e dell'architettura viste attraverso la lente deformante dell'ideologia permettono di cogliere solo aspetti parziali e distorti della realtà, legati a contenuti dimostrativi e propagandistici. Ma forse il ruolo che Milano Verde ha assunto nella storiografia moderna è stato proprio ciò che la cultura architettonica voleva inconsciamente sentirsi raccontare. In fondo, le ambiguità di questo progetto sono talmente inquietanti da essere state rimosse. L'immagine di «ordine contro il disordine» propagandata da Pagano è forse poco veritiera ma certamente rassicurante. I plastici che abbiamo avuto sotto gli occhi, sia quello originale (andato perduto, a quanto risulta), sia quelli realizzati per le varie esposizioni, mettono in scena un'immagine urbana ordinata e convincente, spesso impropriamente imitata da molti progettisti come una sorta di antidoto contro il caos metropolitano contemporaneo.
Società degli Amici di Ronchi e Poveromo 1961-2011, pagine non numerate, riprodotto in proprio in formato 14x21, senza data (ma agosto 2011), senza luogo (ma Ronchi, Massa)
Quel gruppo di persone che, nel settembre del 1961, decise di fondare un’associazione "degli amici" di Ronchi e Poveromo forse non immaginava non solo di dare un'importante testimonianza di impegno civile, ma di scrivere una pagina della lunga storia dei movimenti per la difesa della natura.
Si trattava di persone che da molti anni frequentavano Ronchi e Poveromo --- un rettangolo di poco più di una decina di chilometri quadrati, circa a metà fra Marina di Massa e Forte dei Marmi, nella Toscana nord-occidentale --- e che, di fronte ai segni di un assalto speculativo e becero alle bellezze caratteristiche della zona, si ispirarono alle primissime associazioni, come Italia Nostra, fondata appena sei anni prima, che stavano sorgendo in varie parti d'Italia per arginare i guasti ai beni naturali e ambientali.
Negli anni cinquanta e sessanta del Novecento gli effetti del "miracolo economico" portarono alla distruzione di boschi e macchie e dune, coprirono di cemento le spiagge, alterarono il paesaggio costiero e quello di montagna, attraverso una graduale appropriazione e privatizzazione dei beni e dei valori collettivi che la Costituzione repubblicana, nel suo articolo 9, riconosce come valori da difendere: "La Repubblica ... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione".
Questo scempio non solo non offriva a masse sempre più grandi la giusta possibilità di prendere conoscenza e di godere dei beni e dei valori naturalistici, storici e ambientali che sono di tutti, ma era mosso da un arrogante potere economico che ripeteva, nelle zone ancora utilizzabili per il riposo e la vacanza, i modelli di urbanizzazione che avevano già deturpato le città.
L'articolo 3 dello statuto della nuova associazione, che assumeva il nome di "Società degli Amici di Ronchi e Poveromo", afferma che "l'associazione ha lo scopo di difendere e proteggere le zone di Ronchi e Poveromo --- e più precisamente il comprensorio fra l'agglomerato di Ronchi e l'albergo Doria --- che sono rimaste quasi le ultime a conservare le più rare caratterististiche del paesaggio costiero della Versilia e che uniscono felicemente la veduta delle Alpi Apuane all'incantevole visione della costa, da Viareggio a Porto Venere".
Nel successivo articolo 4 lo statuto afferma: "Onde ottenere lo scopo suddetto l'associazione intende promuovere azioni atte ad evitare che edifici inopportuni vengano a turbare l'armonia del paesaggio sia sull'arenile sia nelle bellissime pinete e nella macchia di retroterra, e a proteggere la tipica vegetazione sia della landa marina --- unica ormai rimasta a ricordare le spiagge cantate dai nostri poeti --- (le agavi, i caratteristici arbusti), sia delle pinete e della macchia del retroterra: i piccoli gigli, l'erica, i lecci, gli ontani, i pioppi. Inoltre l'associazione si adopererà a promuovere la regolamentazione e la bonifica dei canali (Poveromo, eccetera) ad evitare il danno di invasione di insetti e di esalazioni malsane".
La zona di Ronchi e Poveromo era, agli inizi degli anni venti, una macchia quasi selvaggia, sede di poche abitazioni sparse e in armonia con la vegetazione, e tale più o meno è rimasta fino alla seconda guerra mondiale, quando divenne, dal settembre 1944 all'aprile 1945, l'immediato retroterra del fronte di combattimento --- l'estremità occidentale della "Linea Gotica", ferma al Cinquale. I lunghi mesi di guerra portarono alla distruzione di un largo tratto di pineta con i relativi edifici.
Dopo la Liberazione ebbe inizio una lenta ricostruzione della pineta e della vegetazione e si moltiplicarono le abitazioni, in genere senza un programma, spesso all'insegna della bruttezza e del disordine, talvolta della furberia e dell'abusivismo.
In quanto alla spiaggia la crescente pressione della popolazione estiva ne ha ben presto modificato profondamente i caratteri. Già la strada litoranea, costruita intorno al 1925, aveva portato lo spianamento di una delle grandi dune parallele al mare; la diffusione del turismo estivo portò lentamente il livellamento dell'arenile per permettere l'accesso più comodo delle persone e delle automobili fino alle cabine, fino alla riva del mare, con conseguente alterazione e distruzione della vegetazione spontanea della spiaggia, comprendente talvolta specie molto rare.
Chi critica la maniera "moderna" di avvicinarsi alla spiaggia, al verde, alla natura, al mare, è considerato un arretrato conservatore, anzi nemico del popolo, ma l'analisi ecologica dimostra che la protezione della natura è l'unica strada che permette di evitare danni in futuro ed è quindi anche socialmente utile, anzi è la strada per assicurare a tutti i cittadini, “al popolo”, il godimento di beni collettivi necessari per la salute e il benessere.
Non a caso la Francia, un paese industriale, avanzato e moderno più di noi e non certo accusabile di ubbie ecologiste, ha posto dei severi vincoli su tutte le sue coste vietando la privatizzazione, gli insediamenti stabili come strutture balneari, e, a maggior ragione, la costruzione di case.
La legge italiana n. 431 del 1985, ispirata al cosiddetto "decreto Galasso", che pure imponeva di proteggere dall'occupazione e dall'edificazione da parte di strade e abitazioni, le coste e le rive dei fiumi e del mare, non è mai stata applicata proprio dagli organi di quello stato che pure l'aveva emanata.
L’ “impero del disordine”
E non si tratta di capricci o ubbie. Per esempio negli anni settanta, la distruzione dei pini costieri, dovuta all'attacco da parte di agenti chimici presenti nel mare e trasportati in forma nebulizzata dal vento, fu proprio dovuta al fatto che l'aerosol marino non era più fermato dalle dune e dalla vegetazione spontanea della spiaggia.
Il disastro è stato completato dai vari sciagurati decreti di condono edilizio, a cominciare da quelli del 1985 e del 1993, che hanno legalizzato innumerevoli (nel senso letterario, perché nessuno li ha mai contati, tanto meno gli organi che avrebbero dovuto farlo) abusi edilizi, anche quando violavano vincoli naturalistici.
Non solo: nella zona di Ronchi e Poveromo sono stati violati tutti gli altri vincoli, ancora in vigore, ma "dimenticati", relativi al taglio degli alberi solo dopo una specifica autorizzazione delle autorità forestali, le norme sulle recinzioni dei terreni: quanto più gli edifici erano abusivi o furbescamente in violazione della legge (case che avrebbero dovuto essere monofamiliari divenute orribili palazzoni), tanto più sono state circondate e "protette" da altrettanto orrendi muraglioni, portoni a comando elettronico, viali di cemento, con ulteriore alterazione della vegetazione e della circolazione delle acque sotterranee e delle piogge.
Il falso "progresso", l'aumento della densità delle abitazioni, la cementificazione della pineta e della macchia, l'introduzione di specie vegetali estranee e la distruzione della vegetazione originaria, tutte queste azioni hanno compromesso un delicato equilibrio ambientale, idrogeologico e naturalistico. Le conseguenze non hanno tardato a farsi sentire, sotto forma dell'abbassamento della falda sotterranea di acqua dolce e dell'aumento della salinità dell'acqua sotterranea, della scomparsa delle specie vegetali ecologicamente più fragili.
Interessi di chi?
Purtroppo nei molti decenni della sua esistenza la voce della “Società degli Amici di Ronchi e Poveromo” non solo è rimasta scarsamente ascoltata dalle amministrazioni e dalle popolazioni locali, ma è stata per lo più accusata di difendere gli egoistici interessi di pochi "signori" snob, calati dalle grandi città, che volevano impedire ad altri di sfruttare e "valorizzare" --- secondo una ben distorta visione del "valore" --- la zona.
E invece, come l'associazione ha sempre sostenuto ad alta voce, la difesa delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche di Ronchi e Poveromo è non solo difesa di valori assoluti --- quella indicata dall'articolo 9 della Costituzione --- ma è anche nell'interesse della popolazione del luogo, degli agricoltori, dei bagnini, degli operatori turistici e dei turisti che guardano appena un po' più lontano del proprio naso. Un discorso non gradito.
Purtroppo l'esperienza ha mostrato che il graduale degrado, la distruzione della vegetazione spontanea, l'erosione delle spiagge, la mancata manutenzione dei fossi, gli inquinamenti, hanno portato un continuo declino del turismo della riviera apuana, soprattutto se paragonato a quello di altre zone costiere, anche della stessa Toscana.
Si è così verificato quanto si temeva: distruggere le spiagge, il verde, il silenzio, la possibilità di camminare tranquillamente a piedi o in bicicletta, significa compromettere, in breve tempo, una fonte di reddito per la stessa popolazione e per l'economia locale.
Si vede anche dalla rapida diminuzione delle strutture ricettive alberghiere trasformate in condomini: la pensione Betty, la pensione Iinternazionale (divenuta un orribile pacchiano casone), la mitica pensione La Pergola, la Villa Irene, la pensione Doria --- quella ricordata nello statuto dell'associazione --- divenuta casa di suore e ora trasformata in appartamenti.
Va anche detto che la popolazione locale non ha mai amato coloro che, venendo da altre città, nella zona di Ronchi e Poveromo sono vissuti a lungo e tale zona hanno molto amato. Lo dimostra il disinteresse per gli intellettuali e gli artisti che a Ronchi e Poveromo hanno scritto e operato, il fatto che la città di Massa non è stata capace di tutelare e segnalare, almeno con una lapide, la casa di Piero Calamandrei, che a Poveromo ha scritto importanti pagine delle sue opere di giurista e di uomo politico e anche parte della Costituzione repubblicana. Si tratta di quella villa, all'angolo fra Via Siena e il Viale Lungomare di Levante (poi alterata e ingrandita) nella quale Calamandrei ha ospitato tutti gli intellettuali e gli uomini politici che hanno fatto l'Italia moderna; il Comune non è stato neanche capace di dedicare almeno una strada, magari la stessa Via Siena, a Piero Calamandrei.
Lo stesso vale per le strade in cui hanno operato Savinio, Sacchi e tanti altri. Non dico di cambiare i nomi poetici e bellissimi di alcune strade --- via degli ontani, delle macchie, degli olmi, dei fichi, dei fortini --- ma altre strade hanno nomi che potrebbero essere modificati per ricordare poeti, scrittori e artisti che Ronchi e Poveromo hanno abitato e amato.
Il tornado del 1977
Nei molti decenni della sua storia l'associazione è passata attraverso --- ed è stata protagonista di --- vari eventi di importanza non solo locale.
Il tornado del 28 agosto 1977 è stato un evento naturale imprevedibile ed eccezionale, ma i suoi effetti devastanti sono stati ancora più gravi a causa di tutte le alterazioni ecologiche prima ricordate, perché l'intero ecosistema era stato reso più fragile dalla distruzione della vegetazione originaria e delle dune costiere e dall'alterazione delle falde idriche sotterranee. Il disastro sollevò emozione a livello internazionale. La Società degli Amici di Ronchi e Poveromo organizzò, il 29-30 ottobre 1977, insieme ad Italia Nostra, un convegno al quale partecipò, fra gli altri, Antonio Cederna (scomparso nel 1996).
La Comunità Europea, riconoscendo la grande importanza ambientale e naturalistica dell'ecosistema costiero apuano, stanziò ingenti contributi per incentivare la ricostruzione della vegetazione, in gran parte pini, distrutta. Con un commovente atto di solidarietà ogni città grande e piccola dell'Europa volle donare un albero alla zona colpita.
Dove è finito tutto questo ? Purtroppo i contributi comunitari sono stati in gran parte dissipati. Molte piante sono state messe a dimora malamente e sono poi morte, altre sono morte perché erano inadatte all'ambiente; larghi tratti delle pinete distrutte sono stati spianati e trasformati in prati all'inglese, fonti di indescrivibili sprechi di acqua, richiesta per la continua irrigazione. Intorno a molte case, al posto degli alberi, sono state costruite piscine (a pochi metri dal mare !) o stradine e parcheggi asfaltati. Il che fa diminuire la capacità ricettiva, per l'acqua delle piogge, del suolo che originariamente era sabbioso e molto permeabile, con conseguente formazione di pantani e paludi ad ogni pioggia più intensa.
Alla natura si comanda se le si ubbidisce
Ancora oggi un malinteso senso di "pulizia" della macchia o la trasformazione della macchia spontanea in "giardini" ad opera di alcuni proprietari, impedisce la formazione del sottobosco e di quella sequenza di specie vegetali che sole possono assicurare un sistema stabile e la cui difesa è specificamente raccomandata dallo statuto della Società.
In un mondo in cui lo sfoggio della ricchezza e dello spreco sono leggi, che posto possono avere le umili robinie, saggine, e roverelle, i poveri lecci e pini e platani e olmi --- ricordati nel nome di tante strade di Ronchi e Poveromo --- tutte piante che hanno la colpa di non costare niente, di crescere spontanee in gioioso disordine e non "valgono" niente, rispetto alle costose esotiche piante, ai bei giardini con gli alberi allineati, circondati da prati ben ordinati. Solo una profonda ignoranza botanica ed ecologica può non capire che invece la vegetazione sopravvive soltanto se è disordinata (secondo i nostri sciocchi canoni di "ordine"), e che tale disordine invece assicura, secondo ineluttabili leggi della biodiversità, rapporti di collaborazione e cooperazione spontanea e duratura fra tanti diversi esseri viventi vegetali. Proprio per questa la Società degli Amici di Ronchi e Poveromo ha più volte organizzato delle conferenze del prof. Erminio Ferrarini, uno dei profondi conoscitori della flora apuana, per ricavarne indicazioni e suggerimenti.
Adesso non solo della vecchia pineta restano pochi frammenti, intramezzati da larghi tratti privi di vegetazione, ma il turbamento dell'ecosistema ha fatto aumentare la salinità dell’acqua sotterranea, il che contribuisce ulteriormente a far morire piante e alberi. E ad ogni nuova licenza edilizia i proprietari e i costruttori, per prima cosa, distruggono e sradicano qualsiasi vegetazione spontanea, incuranti del fatto che in alcuni fazzoletti di terreno dei Ronchi e di Poveromo esistono ancora rari biotopi.
La spiaggia che scompare
Un altro grave problema che ha impegnato l'associazione riguarda l'assetto della spiaggia di Ronchi e Poveromo. Nel disordine del trasferimento delle competenze sulle concessioni degli arenili dal Ministero della Marina mercantile alle amministrazioni locali sono proliferati stabilimenti balneari spesso orribili, talvolta mascherati sotto l'etichetta di circoli o associazioni, in genere dotati di enormi parcheggi in terra battuta o addirittura in cemento, che occupano abusivamente larghi tratti di spiaggia, a pochi metri dal mare.
Nello stesso tempo la spiaggia di Ronchi e Poveromo lentamente retrocede, erosa dal mare, in conseguenza degli interventi sbagliati di presunta "difesa" della costa a Marina di Carrara e Marina di Massa e della diminuzione, a causa dei prelevamenti di inerti dal greto del fiume e della diga a Bocca di Magra, del trasporto, da parte delle correnti marine verso sud-est, della sabbia del Magra.
Non solo i pennelli e le barriere non consentono la ricostruzione della spiaggia di Marina di Massa, ma l'erosione, dopo avere raggiunto Ronchi, sta rapidamente muovendosi verso Poveromo e il Cinquale. Si fermerà probabilmente fra Forte dei Marmi e Viareggio, grazie all'apporto compensatore della sabbia proveniente dal Serchio, che le correnti marine spingono verso nord-ovest.
Il piano regolatore dell'arenile, approvato dal Comune di Massa nei primi anni novanta, ha peggiorato ancora le cose. Quel po' di spiaggia che ancora sopravvive è ora costellata di orribili edifici, finti bagni, ma in realtà ristoranti e discoteche, che sono riusciti anche qui a togliere la vista del mare a chi percorre il viale litoraneo. Le ultime tracce di ondulazioni, residui delle dune, sono state livellate e fu una gran fatica, per l'associazione, trovare, nel sopralluogo fatto all’inizio degli anni novanta delle decine di stabilimenti balneari, due o tre che ancora avevano alcuni residui della, una volta ricca e rara, vegetazione della rena. A questo proposito si possono ricordare gli incontri che la Società ha organizzato invitando Ferruccio Egori (scomparso nel 1999) a illustrare l’evoluzione della costa che egli aveva immortalato in una collezione di migliaia di diapositive che avrebbero meritato di essere raccolte in un archivio.
La salvezza alla crescente crisi ecologica si può avere soltanto con un salto di cultura, al quale la Società degli Amici di Ronchi e Poveromo, nel mezzo secolo della sua vita, ha dato un contributo organizzando presentazione di libri, incontri e dibattiti pubblici anche in collaborazione con le associazioni ambientaliste locali. Fra tali iniziative va ricordata in particolare la pubblicazione del prezioso volume, “Ronchi-Poveromo. Natura e memoria”, edizioni 1997 e 2007 (alcune copie sono ancora reperibili presso l’associazione), con una raccolta di saggi sulla storia della riviera apuana e una copertina arricchita della riproduzione di un quadro donato da Piero Calamandrei.
Bisognerebbe far crescere la consapevolezza che la zona di Ronchi e Poveromo può sopravvivere soltanto se si riconosce che è parte di un grande ecosistema costiero che va da Bocca di Magra fino a Livorno, e comprende fiumi e torrenti il cui apporto di sabbia al mare governa, lentamente, l'avanzata o la retrocessione della costa. Purtroppo, per strane ragioni storiche, la costa è divisa amministrativamente "sotto" due regioni, Liguria e Toscana, tre province, La Spezia, Massa Carrara e Lucca, e tanti Comuni, ciascuno dei quali, per differenti e talvolta contrastanti interessi, compie --- o omette --- opere che influenzano i caratteri naturalistici delle zone vicine.
Fra acque e mare
I fondatori della Società degli Amici di Ronchi e Poveromo, che nel 1961, nello statuto, parlarono della necessità di mantenere in efficienza il sistema idrico di fossi come il Poveromo, avevano ben presente che la zona di Ronchi e Poveromo faceva parte, ancora all’inizio del Novecento, di un ampio sistema paludoso: la bonifica era stata realizzata, con amore e saggezza, scavando numerosi canali scolmatori delle acque di piena che intersecavano tutta la pianura da Marina di Carrara a Viareggio.
Nel tratto Ronchi-Poveromo si possono ricordare il Magliano, il Poveromo, il Canalmagro Fescione, il Fosso del Sale, il sistema Montignoso-Versilia-Cinquale, ben riconoscibili nelle carte dell'Istituto Geografico Militare della fine del secolo scorso.
La pulizia dei fossi e il loro accesso al mare assicuravano il deflusso delle acque piovane, una forma di autodepurazione assicurata dall'incontro fra l'acqua salina del mare e le acque dolci provenienti dall'interno, che permetteva di evitare l'inquinamento e la salinizzazione delle falde sotterranee.
Un attento osservatore riconosce, nonostante i tentativi di livellamento delle strade asfaltate, le ondulazioni parallele e perpendicolari alla costa che assicuravano il drenaggio delle acque delle paludi e la protezione delle falde di acqua dolce che una volta era facile reperire a pochi metri di profondità e che alimentavano gli alberi della macchia.
Una parte di questo sistema idrico era unito, fino all’inizio del Novecento, dalla grande palude, e vasca di espansione delle acque, del Lago di Porta. Nel corso dei decenni il lago è stato occupato dal Polverificio di Vittoria Apuana (circa 1900-1920), poi dall'aeroporto del Cinquale (dal 1930), poi è diventato deposito di scarichi industriali e di rifiuti urbani, poi è stato occupato abusivamente da edifici, poi è stato occupato da un campo da golf (dal 1990).
Per non disturbare i malintesi miopi interessi dei concessionari delle spiagge è stato chiuso l'accesso al mare dei fossi scolmatori: il Magliano è ridotto a un rigagnolo, sono chiusi il Poveromo, il Fescione, il Fosso del Sale: il Cinquale si è riempito del fango e della marmettola provenienti dal Versilia e viene tenuto aperto quel minimo che fa comodo al passaggio dei motoscafi. Una parte dei fossi sono stati coperti con cemento e sfruttati a fini abitativi; i fossi sono così diventati vere e proprie fogne a cielo aperto, fonti di puzza, di parassiti e di inquinamento delle acque sotterranee ad opera dei prodotti di putrefazione che ristagnano nei fossi stessi e percolano nel sottosuolo.
La mancanza di manutenzione e di periodica pulizia ha fatto sì che i fossi si riempissero di fango, che ne diminuisse la capacità ricettiva delle acque piovane e che queste esondassero sempre più spesso, allagando terreni e strade.
Nel nome di interessi privati, "violenti" contro la natura, si è ridotto lo spazio per il moto delle acque e non a caso dagli anni novanta si sono vetrificate continue alluvioni dovute al fatto che le acque provenienti dai torrenti di montagna non trovano più nella pianura spazi in cui espandersi e allagano e distruggono strade, case, beni materiali e vite umane. Non c'è da meravigliarsi se ad ogni nuova pioggia si sono avute e si avranno alluvioni e allagamenti. Il fatto singolare è che gli errori e le omissioni, sotto gli occhi delle pubbliche amministrazioni, fruttano pochi milioni a chi ne trae vantaggio, costruendo case dove non dovrebbero essere costruite, e costano milioni di euro alla collettività.
Dopo ogni nuova alluvione, infatti, vengono spesi soldi pubblici per risarcire i danni, ma nessun soldo è speso per ripristinare le condizioni che assicurano l'espansione delle acque, cioè per prevenire gli eventi calamitosi. La più ardita proposta consiste nel rialzare gli argini dei fossi, e in questo modo non si fa altro che spostare le zone allagate da un posto all'altro, senza alcun vantaggio per il reale deflusso delle acque.
Nello stesso tempo l'estensione di case, di parcheggi, addirittura piste sportive di asfalto e cemento, alterano la permeabilità dei suoli e la capacità dell'originale terreno sabbioso di assorbire rapidamente le acque piovane. Così si moltiplicano le zone in cui l'acqua ristagna.
Anche questi piccoli episodi, apparentemente locali, ma che riflettono una situazione che si ritrova in tutta Italia, mostrano che l'attenzione per la condizione "naturale" della zona è essenziale per la conservazione di un patrimonio ecologico che appartiene alla collettività e che deve essere difeso nell'interesse della collettività, presente e futura.
Natura e inquinamento industriale
C'è un'altra pagina della storia del territorio di Ronchi e Poveromo in cui l'associazione ha avuto un notevole ruolo. Ad appena pochi chilometri di distanza, nella pianura fra Massa e Carrara, nel 1938 fu insediata una vasta zona industriale con stabilimenti chimici, metallurgici, meccanici, essenzialmente previsti per le esigenze della guerra.
Distrutte in gran parte durante la guerra, dopo la Liberazione le fabbriche sono state ricostruite e trasformate per operazioni produttive sempre più inquinanti: di particolare pericolosità ed effetto negativo sull'ambiente sono state le industrie chimiche, la cokeria, lo stabilimento di pesticidi Rumianca poi Enichem, l'altro stabilimento di pesticidi Montecatini poi Montedison poi Farmoplant, lo stabilimento per la produzione di ferroleghe, quello per manufatti di cemento-amianto, la fabbrica di refrattari. Nello stesso tempo una ripresa, dopo lunga stasi e crisi, dell'attività di segagione del marmo locale e dei graniti di importazione, ha portato un crescente inquinamento del mare, che si aggiungeva a quello delle fogne urbane, per decenni senza alcun depuratore, poi con depuratori sbagliati e insufficienti.
A poco a poco l'inquinamento dell'aria e delle acque ha cominciato a fare sentire i suoi effetti anche nell'apparentemente isolata e lontana zona di Ronchi e Poveromo. L'aria e l'acqua non hanno confini e si spostano secondo le loro leggi naturali e non esistono isole privilegiate.
L'inquinamento ha danneggiato la vegetazione costiera, ma la consapevolezza di convivere con un grande polo industriale e con i relativi pericoli ha raggiunto anche la zona di Ronchi con i due gravi incidenti industriali, quello del 17 agosto 1980 alla Montedison, del 12 marzo 1984 all'Enichem.
Per anni nessuno ha mai misurato lo stato di inquinamento dell'aria e delle acque e la balneabilità del mare: la scoperta delle disastrose condizioni locali si è avuta quando il nostro paese è stato costretto, negli anni ottanta del Novecento, a recepire le normative europee a dotarsi, sia pure lentamente, di una rete di analisi dell'aria e delle acque. Si è così visto che le leggi europee e quelle nazionali (a cominciare dalla storica legge "Merli" contro l'inquinamento delle acque interne) erano violate continuamente e sotto gli occhi di tutti.
A partire dalla metà degli anni ottanta si è formato nella zona un vasto movimento di protesta contro le fabbriche pericolose e inquinanti: davanti all'arroganza delle industrie che si rifiutavano di migliorare le condizioni di sicurezza e di eliminare le produzioni pericolose e inquinanti, gli abitanti di Massa si sono mobilitati chiedendo un referendum per la chiusura della Farmoplant (lo stabilimento Enichem era chiuso dal 1984).
A questo punto la Società degli Amici di Ronchi e Poveromo ha sentito il dovere di affiancare la popolazione in una protesta che era non solo civile, ma anche strettamente legata ai suoi fini istituzionali di difesa della natura e dell'ambiente. Soprattutto i soci che abitavano stabilmente nella zona --- per tutti vorrei ricordare la bravissima socia Doda Dionisi Vici che mise nell'impresa tutto il suo impegno e la sua passione --- parteciparono al comitato promotore del referendum popolare e hanno "marciato" insieme alla popolazione dapprima per ottenere il referendum, poi per sollecitare, nella votazione del 15 ottobre 1987, un "sì" che assicurasse la chiusura dello stabilimento Farmoplant.
Il referendum fu vinto e la fondatezza della protesta fu dimostrata poco dopo da un nuovo incidente, il 18 luglio 1988, sempre alla Farmoplant. Ma la storia della violenza contro l'ecosistema costiero apuano è continuata: dopo la chiusura (nel 1988) della fabbrica di pesticidi la Farmoplant, nonostante le proteste della popolazione, ha fatto funzionare, fino all'estate 1991, un grande inceneritore di rifiuti tossici per distruggere le materie pericolose ancora presenti nello stabilimento, provocando un ulteriore inquinamento.
La protesta della Società degli Amici di Ronchi e Poveromo, insieme alle altre associazioni ambientaliste --- Italia Nostra, WWF, Legambiente --- e alla popolazione contro gli inquinamenti, non è stata una posizione antindustriale, ma una richiesta, doverosa, che le pubbliche amministrazioni facessero rispettare la legge che prescrive, oltre a precise norme urbanistiche e paesaggistiche (violate), anche norme contro gli inquinamenti dell'aria e delle acque (violate anch'esse).
Una richiesta perché il lavoro e l'occupazione siano garantiti da attività compatibili con gli inevitabili vincoli che ogni territorio pone: questa compatibilità è anche premessa perché l'occupazione sia duratura. Si tratta, insomma, di una civile e doverosa domanda di rispetto delle leggi dello Stato, in armonia con quelle altrettanto inviolabili della natura, essenziale per il futuro, anche turistico ed economico della riviera apuana.
Il passato è prologo
E poiché il passato è prologo, ripercorrere la storia della Società degli Amici di Ronchi e Poveromo, a 50 anni dalla sua fondazione, non è solo un'occasione per ricordare il suo contributo culturale e di stimolo civile, ma può anche essere occasione per vedere i principali problemi che l'associazione potrebbe affrontare ... nei prossimi 50 anni.
Un bel ruolo potrebbe avere l'associazione rilanciando la cultura della solidarietà fra l'intera riviera apuana e quella versiliese, proprio partendo dalla posizione centrale di Ronchi e Poveromo, spiegando e cercando di far capire che la zona stessa si salva soltanto se si realizzano dei piani ambientali ed ecologici, in cooperazione e coordinamento fra le diverse unità amministrative in cui è polverizzata la riviera apuo-versiliese.
Un arduo compito perché non ci si può nascondere che esistono antiche e radicate antipatie fra le diverse, pur vicinissime, comunità: a parte l'antica rivalità fra Carrara e Massa, ci sono rivalità fra Massa e Montignoso, irrequieta comunità originariamente appartenente alla Repubblica di Lucca, chiusa (fino alla fine del 1700) fra gli Stati Estensi e l'enclave del Granducato di Toscana; per non parlare poi dell'orgogliosa indipendenza dei cittadini di quella che si considera "Versilia storica" a sud del Cinquale --- comprendente Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema, antica enclave del Granducato di Toscana fra Stati Estensi e Repubblica di Lucca --- molti dei quali ritengono di non avere niente a che spartire con gli abitanti della riviera apuana.
La presenza e la vigilanza dell'associazione sono ancora più necessari in questi anni in cui una mania di privatizzazione di tutti i beni pubblici sta portando alla svendita, da parte dello Stato, del delicato demanio marittimo --- e di quanto resta del demanio fluviale --- con la prevedibile conseguenza di un'accelerazione della distruzione di quanto ancora resta.
Qualcosa si può ancora salvare chiedendo la "protezione" di almeno alcuni piccoli pezzi del territorio. Oasi del WWF sono state create al Cinquale (in Comune di Forte dei Marmi) e una di queste oasi è diventato un piccolo "santuario" delle specie vegetali tipiche della spiaggia. Una piccola zona protetta è stata creato nel residuo delle paludi fra l'abitato di Ronchi e il fosso Magliano. Ma è troppo poco rispetto all'avidità di chi vuole installare nuovi spazi "giochi" o ristoranti o discoteche, contrabbandati come "servizi ricreativi", di fatto con interventi devastanti su quanto resta dell'ecosistema.
La Società degli Amici di Ronchi e Poveromo continua ad essere al fianco del lavoro generoso e benemerito del WWF e di quanti hanno a cuore la difesa dei valori ambientali, paesaggistici e naturalistici la cui difesa chiedevano, con lungimiranza, i fondatori della Società mezzo secolo fa.
Titolo originale del paragrafo: Miss Beecher's Home Church of Jesus Christ– Estratti e traduzione e a cura di Fabrizio Bottini
I numerosi libri di Catharine Beecher erano certamente più letti dei manuali di architettura del paesaggio. Se questi ultimi proponevano la contemplazione di Dio attraverso il culto della bellezza naturale, la Beecher proponeva alle sue lettrici di cercare la salvezza nella perfezione della vita familiare. Autrice di un Trattato di Economia Domestica a Uso delle Giovani Signore e delle Scuole (1842), co-autrice de La Casa della Donna Americana (1869), sollecitava le donne a farsi carico dell’abitazione suburbana e della famiglia, che lei definiva “la casa-chiesa di Gesù Cristo”. Chiedeva loro di restare a casa, a padroneggiare una organizzazione efficiente del progetto dell’abitazione e del giardino, oltre che il sostegno spirituale di grandi famiglie. La Beecher fu la prima scrittrice americana a proporre un manuale di esistenza domestica che comprendeva architettura, arte dei giardini, arredamento, cucina, igiene, allevamento dei figli. I suoi libri erano di prospettiva più ampia di quelli di Andrew Jackson Downing [ il primo “guru” dell’abitazione suburbana e fondatore della moderna landscape architecture , a cui l’Autrice in due paragrafi viene analizzata in parallelo n.d.t.] perché affrontava il tema dell’alimentare la vita familiare oltre che la forma dello spazio domestico. Era un architetto dilettante assai più dotato di quanto non fosse Downing, e progettava contesti per una serie di attività domestiche in modo assai preciso e innovativo. Il suo pubblico potenziale era quello di ogni donna americana, giovane o vecchia. La sua visione del contesto domestico era esplicitamente di genere: erano le donne che dovevano creare il mondo della famiglia, lontano dalle tensioni del lavoro in città, e nonostante così le donne si sarebbero trovate escluse dall’arena pubblica della vita economica e politica, sarebbero poi state ricompensate in paradiso per il proprio sacrificio.
Il nido familiare della Beecher è architettonicamente molto definito. Nel 1869 è decisamente suburbano: “adeguato a desideri e abitudini sia di chi abita in campagna o in quegli ambienti suburbani che consentono salubri spazi per le attività all’aperto al servizio della famiglia”. Consentiva che “le ferrovie, che consentono agli uomini di darsi da fare in città per mantenere la famiglia in campagna, sono da questo punto di vista una fortuna”. C’è un cottage in stile gotico, posto sulla riva di un fiume fra le verzure, circondato da immagini di donne, bambini, animali domestici, e fiori, a decorare la pagina del titolo del volume del 1869, scritto in collaborazione con la sorella Harriet Beecher Stowe. Sul frontespizio, una donna al centro di una famiglia composta da tre generazioni diverse, legge di fronte a un caminetto. Il capitolo intitolato “ Una Casa Cristiana” inizia con un’ampia veduta esterna della casa, che mostra tre croci poste sugli abbaini laterali e sulla porta di ingresso.
A differenza di Downing, che praticava l’orticoltura dall’età di sedici anni, la Beecher arriva più gradualmente al proprio interesse per l’architettura. Figlia maggiore di Lyman Beecher, importante predicatore Congregazionalista, nasce nel 1800 a East Hampton, Long Island, prima di otto figli. Si fa carico di una importante quantità di attività domestiche dopo la morte della madre, all’età di sedici anni. Alla scuola di Miss Pierce a Litchfield, Connecticut, i suoi diari quotidiani si guadagnano lodi per la capacità di descrivere la vita personale per un ampio pubblico. Insieme alla sorella Harriet, assiste tutti i fratellini fino alla partenza per il college e all’inizio dell’attività di predicatori. Catharine Beecher poi diventa maestra di disegno a New London, Connecticut. All’età di ventitre anni fonda una propria scuola per giovani fanciulle a Hartford, Connecticut; a trentadue apre il Western Female Seminary in Ohio. Nel suo primo libro, del 1831, sostiene la superiorità morale delle donne, sulla base della loro dedizione e della capacità di sacrificio. Ha quarantun anni quando pubblica il Trattato, che vende tanto bene da assicurarle l’indipendenza finanziaria.
Per tutta la vita nubile, anche se è stata fidanzata da giovane a un professore di Yale morto durante un viaggio in mare, la Beecher consiglia di sposarsi presto, rinunciare alle attività mondane, avere dieci figli, e gestire la casa senza servitù. Definisce il lavoro di cura e manutenzione della casa “la vera professione della donna” parlandone come di un “ministro”. In parte si tratta di una risposta alla sua contraddittoria esperienza con la religione organizzata. La Beecher non ebbe mai una vera conversione religiosa. E riteneva che restando lontana dalle teorie, una donna potesse meritarsi la salvezza attraverso la dedizione pratica alle necessità degli altri, in una “casa-chiesa” creata con le proprie mani. In parte, la Beecher reagiva ai primi segni del movimento per i diritti delle donne. Lanciava un auspicio assai propositivo riguardo all’autorità femminile nella sfera domestica, ma pensava agli aspetti più conservatori dell’esistenza delle donne, dove se ne sottolineava la competenza in casa, ma la totale passività nella sfera pubblica. Il suo era un “femminismo domestico”, contrario a quello “sociale” delle militanti per la temperanza come Frances Willard, o di quello “materiale” di chi sosteneva il salario al lavoro domestico, come Melusina Fay Peirce.
Impegnatissima come scrittrice e conferenziera, la Beecher non praticò mai il femminismo domestico che predicava. Tutte le sue energie si esercitavano nel dare centinaia di orientamenti pratici. Il suo libro era enciclopedico: come prendersi cura di un invalido, come curare un orto, e soprattutto, come costruire una casa salubre che rendesse più lieve il lavoro della donna. In questo campo era avanti di decenni rispetto a qualunque architetto o arredatore professionista. Dopo aver studiato sui migliori manuali di architettura, ingegneria sanitaria e meccanica, oltre che su libri di medicina ed etichetta, esercitava la sue mente creativa per escogitare decine di piccole soluzioni al “concentrarsi delle comodità”. Nell’arco di alcuni decenni perfezionò gli schizzi originali abbastanza convenzionali delle case in stile revival Greco o Gotico della prima edizione del suo Trattato, e le versioni del libro del 1869 sono molto avanzate. Risolveva problemi architettonici su cui stavano lavorando ancora gli architetti nei primi decenni del ventesimo secolo. Nel farlo, la Beecher cambiava i nomi delle stanze, dove il lavoro domestico diventava una storta di liturgia, con variazioni stagionali: il salotto si trasformava in “stanza della casa” la cucina in “stanza del lavoro” la sala da pranzo diventava “stanza della famiglia”.
Nella sua abitazione del 1869, ogni metro quadrato veniva progettato con la cura di una ex insegnante di disegno. Con una superficie di circa 180 metri quadrati, era un po’ più grande del “ Cottage Suburbano” di Downing, parecchio più comoda, e anche più fluida nella successione degli spazi. La Beecher contrapponeva due salotti all’unico di Downing. Avendo installato un sistema di riscaldamento centrale, con stufe di ghisa Franklin collegate a una caldaia per l’aria calda nel seminterrato, poteva evitare stanze piccole e utilizzare liberamente lo spazio. Uno dei salotti poteva essere diviso con una innovativa parete mobile. Entrambe le sale erano dotate di teche, finestre, verande. Il ricambio d’aria era assicurato da ingegnosi tubi di ventilazione, con altri che portavano via l’aria viziata. In ogni senso, la comoda abitazione della Beecher anticipa l’opera dei progettisti del XX secolo.
Soprattutto, la Beecher redefinisce la cucina, introducendo una superficie di lavoro unica con spazi per strumenti e derrate, schermando il calore della stufa per cucinare con porte scorrevoli in vetro. La “signora arrosto” per cui protestavano le donne negli anni attorno al 1840 non aveva spazio, qui. La Beecher introduce anche un lavello con acqua corrente. Inventa un banco da lavoro particolare per la pasticceria, e un altro per il resto della cucina. Organizza la sistemazione di piatti e pentole. Scaffalature ordinate, e attrezzi appesi a ganci. Molta attenzione agli impianti idraulici moderni. La casa ha due bagni interni, uno nel seminterrato e uno a livello delle camere da letto, in un’epoca in cui molte persone usano ancora le “sistemazioni esterne”, come aveva prescritto Downing nel suo cottage del 1842. Nel seminterrato si organizza anche uno spazio efficiente per il lavoro pesante di lavanderia e stiratura, deposito per il ghiaccio, preparazione di conserve di frutta e verdura.
La casa della Beecher è evidentemente un luogo di lavoro. Tra Bibblie e letti sfatti, scaffali e cestini da cucito, il lavoro per una donna mon finisce mai. E nemmeno per l’uomo. Il suo tono è molto diretto: “Fatevi preparare dai vostri uomini, a partire da tavole grezze non piallate, un telaio da ottomana ... imbottitelo col medesimo materiale usato per il divano, e ricopritelo dello stesso chinz”. Dopo aver finito coi centrini, o le tende di mussolina, la casalinga può iniziare a sistemare la vecchia poltrona sfondata. La Casa della Donna Americana viene pubblicizzato come “Il più economico e desiderabile libro dell’anno” o “un libro che dovrebbe arrivare in ogni famiglia del paese”. La casa editrice, J. B. Ford, indica come “ UNO SOLO DEI CONSIGLI DI QUESTO LIBRO PUO’ VALERE MOLTE VOLTE IL PREZZO DI TUTTO IL LIBRO” che si vende a 2,50 dollari del 1869, “ricco degli ultimi e più avanzati risultati della scienza applicati alla vita domestica”.
Dopo che il suo sistema era stato sviluppato per l’abitazione ideale suburbana, la Beecher notò che si sarebbe potuto adattare ad altre condizioni, in campagna o in città. Schizzò un piccolo appartamento per i quartieri popolari centrali, rimpicciolendo alcuni mobili così che anche colei che abitava in una casa d’affitto urbana potesse esercitare la propria funzione di “ministro della casa”. Progettò anche un incrocio fra una casa, una scuola e una chiesa per le insegnanti missionarie. Erano donne sole che si recavano negli stati del Sud dopo la Guerra Civile, a insegnare in cittadine molto isolate. La scuola poteva essere trasformata in chiesa, se arrivava un predicatore viaggiante per celebrare le funzioni, e le insegnati missionarie abitavano in spazi posti sopra gli spazi ad aula. Un’aula che poteva essere divisa con una parete mobile. La Beecher divenne anche una delle prime sostenitrici del consumo familiare come necessario per l’economia capitalistica, raccomandando l’uso di molti prodotti, anche “superflui” al fine di “promuovere l’attività, la virtù e la religione” mantenendo l’occupazione nei diversi rami produttivi.
PREMESSA
II Piano Regolatore Generale di un comune è uno strumento diretto ad orientare il rapporto fra gli uomini ed il territorio. II suo oggetto specifico è l'organizzazione dello spazio da parte della popolazione che ne usufruisce e degli oggetti che la popolazione stessa dispone in questo spazio: gli insediamenti (la città o il paese, le frazioni, le case sparse); i servizi (dagli uffici alle istituzioni scolastiche e sanitarie, dalle attrezzature sportive a quelle ricreative); le infrastrutture (strade, luce, acqua, fognature). II Piano si presenta anzitutto come un insieme di ricerche dirette ad interpretare e conoscere la realtà di una comunità per capire le direzioni del suo sviluppo e le attese dei suoi cittadini, e dare a queste tendenze i mezzi per realizzarsi. Naturalmente per valutare queste cose non basta studiare la conformazione del paese, i modi di vivere della popolazione, il numero di alloggi o il tipo di scuole di cui essa ha bisogno. Occorre anche conoscere la storia della comunità, le attività produttive che si svolgono localmente (agricoltura, industria, commercio, servizi), i fenomeni che più direttamente interessano la collettività (per tutti, l'emigrazione). E' necessario inoltre prendere in considerazione non soltanto il centro o i centri abitati, ma anche la campagna e l'insieme delle relazioni che uniscono un paese - Tricarico, ad esempio - ad altri paesi - Grassano, allo stesso modo di Matera o Potenza.
La scienza che intende studiare tutti questi fenomeni si chiama urbanistica: scienza della città. II Piano Regolatore è il prodotto della tecnica urbanistica, esso investe - perciò - solo determinati aspetti della vita di una comunità, anche se tende a prenderli in considerazione tutti. La sua funzione è di regolare i modi in cui il rapporto fra società ed economia si manifesta al livello dell'insediamento umano, assunto in tutte le sue forme. In definitiva, pianificare significa prevedere ed organizzare. Si tratta di un'attività che gli uomini hanno sempre svolto: per se stessi, oppure per piccoli gruppi sociali o per classi. Nei tempi moderni è la società nel suo complesso che si è assunta questo compito: per potersi sviluppare, essa ha bisogno di conoscersi e, quindi, di pianificare. Questo principio è valido per uno stato così come per un comune. II Comune dì Tricarico, con il Piano Regolatore, intende regolare il suo sviluppo futuro. Per volontà dell'Amministrazione comunale il Piano Regolatore diverrà poi - attraverso una serie di approvazioni amministrative - vera e propria legge: la legge che regola il rapporto della comunità con il territorio. Di qui l'importanza del Piano Regolatore. Di qui anche questo Quaderno del Piano, che è un modo di far conoscere al maggior numero possibile di persone il lavoro che si sta svolgendo ed i problemi che stanno alla base dell'impostazione definitiva del Piano.
II Quaderno del Piano è composto di due parti: una di fotografie con testo; l'altra di normale carta da quaderno ad uso dello studente o, comunque, di chi utilizza l'opuscolo. La parte fotografica è unitaria, anche se interrotta dai fogli di carta quadrettata, e va quindi vista e letta come un tutto unico.
La parte del testo associa immagini e parole per spiegare dei fatti, dei problemi. In testa ad ogni pagina c'è un titolo che indica l'argomento trattato, con delle didascalie per la lettura delle singole immagini. La parte quadrettata può servire allo studente per compiere delle ricerche da solo e - meglio ancora - in gruppo; a scuola e in famiglia. II Quaderno è, in ogni caso, un oggetto da consumare: su di esso si può scrivere, come disegnare; il suo impiego non è legato necessariamente alle attività scolastiche.
II Quaderno non è indirizzato soltanto agli studenti. L'Amministrazione comunale di Tricarico ha pensato, facendolo compilare e stampare, di fornire a tutte le categorie di cittadini uno strumento di crescita civile. In questo senso, il Quaderno intende essere un atto di vera democrazia: conoscere il proprio paese e i programmi che lo riguardano significa mettersi in grado di operare delle scelte e di partecipare attivamente ai problemi della comunità, facendo della buona politica.
II Quaderno è legato, nella sua sorte, alla funzione che possono svolgere, nel divulgarlo e spiegarlo, gli operatori culturali: in primo luogo gli insegnanti. Molti termini, perfino molte immagini, hanno bisogno della mediazione della cultura. Sono queste, del resto, le responsabilità che gli intellettuali hanno nei confronti della comunità, e soprattutto dei giovani. Così com'è, il Quaderno non è che un seme gettato in un terreno buono. Sta a chi può, far sì che questo seme diventi una pianta.
li Quaderno del Piano continuerà la sua vita non solo attraverso l'uso che ne faranno le persone che lo leggeranno o ci scriveranno sopra. Quando il Piano Regolatore Generale di Tricarico sarà elaborato, verrà data la possibilità di incollare nelle pagine a quadretti le riproduzioni delle tavole definitive del Piano e di trascrivere le conclusioni essenziali alle quali è pervenuto il Gruppo di elaborazione.
Qui un'ampia illustrazione della vicenda del PRG di Tricarico
Il sistema del verde nel “Progetto generale di Piano Intercomunale” del 1967
Con l’approvazione da parte del Ministero, nel 1959, della nuova perimetrazione proposta dal Comune di Milano per la redazione del Piano Intercomunale (35 comuni che diverranno 92 nel 1967) e superate, mediante una formula di coinvolgimento paritetico, le resistenze iniziali delle amministrazioni comunali interessate dal piano, che temevano una forte diminuzione della propria sovranità territoriale, nel novembre del 1961 si riunisce per la prima volta l’Assemblea dei Sindaci che decide di affidare l’elaborazione del piano ad un organismo tecnico appositamente costituito: il Centro Studi per il Piano Intercomunale Milanese.
Dopo una prima fase nella quale l’attenzione sembra rivolgersi prevalentemente all’analisi ed alla interpretazione delle dinamiche insediative (che porterà alla definizione di “schemi di piano” di notevole forza suggestiva: lo schema “a turbina” del 1963 e quello “lineare” del 1965), l’Assemblea dei Sindaci approva nel 1967 il “Progetto generale di Piano e linee di attuazione prioritaria”, affrontando con un taglio più decisamente operativo i problemi di assetto territoriale dell’area.
Già in questo documento, che sconterà nella sua applicazione concreta i limiti della formula volontaristica di adesione alle scelte di piano che caratterizzerà tutta l’attività del PIM, comincia a delinearsi come elemento qualificante delle scelte di politica insediativa ed infrastrutturale proposte per contrastare i processi in atto di dispersione delle edificazioni e di consumo e compromissione delle aree agricole, un disegno di ampio respiro per il sistema del verde: esso si articola in un livello “di interesse metropolitano” (i cui elementi “portanti” sono costituiti da una serie di “parchi attrezzati”: il Parco Nord, il Parco delle Groane e il Parco di Monza) e in un livello “di interesse locale” (basato prevalentemente sul rispetto degli “standard”, introdotti dalla legge “ponte” dell’aprile del 1967 e precisati dal Decreto Ministeriale dell’aprile dell’anno successivo) al quale viene affidata, oltre alla funzione di salvaguardia territoriale, quella di “supporto per la diffusione dei servizi e dei valori urbani”.
Meno avvertita appare, in questa fase, la questione delle aree agricole del sud Milano che, benché interessate da una crescente edificazione lungo i principali tracciati della viabilità, non vedono ancora intaccata la complessiva compattezza dell’insediamento agricolo e, contrariamente alle aree del nord, sembrano offrire, all’interno dello stesso ambito PIM, buone possibilità di collegamento e connessione in un disegno di scala territoriale. […]
Una cintura verde per l’area metropolitana milanese: gli anni ’70 e ‘80
All’inizio degli anni ’80, mentre prosegue un confronto serrato tra le forze politiche e le associazioni ambientaliste per la definitiva approvazione del piano generale delle aree protette regionali, l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino, con la LR n° 33 del 22 marzo 1980, e la pubblicazione dello Schema di Piano Territoriale di Coordinamento Comprensoriale elaborato dal PIM ed approvato dal Consiglio Direttivo il 13 marzo 1980, sembrano aprire una nuova stagione nella pianificazione di “area vasta”, all’interno della quale la “politica del verde” comincia ad assumere una più matura articolazione.
Lo Schema di Piano Comprensoriale, in particolare, contiene la prima proposta organica per la realizzazione di una cintura verde di scala metropolitana.
Nei documenti di piano viene infatti posta con chiarezza, affrontando il tema del verde comprensoriale, l’esigenza di salvaguardare un corretto equilibrio tra aree urbanizzate ed aree verdi (superando la pura logica degli standard urbanistici e considerando invece il rapporto tra il complesso delle aree verdi – agricole e non – ed il complesso delle aree urbanizzate) e, in particolare, di tutelare quelle aree che, per la loro compattezza e continuità, potevano costituire i collegamenti tra il verde metropolitano ed il sistema del verde regionale, ponendo così le premesse per una inversione di tendenza rispetto al progressivo e preoccupante degrado della qualità ambientale delle aree extraurbane.
Si sottolineava inoltre come, rispetto a questi obiettivi, la situazione complessiva fosse ormai prossima al “livello di guardia”, ma risultasse comunque ancora possibile operare per il loro conseguimento sulla base di una volontà politica che individuasse come punto fermo la salvaguardia rigorosa delle aree essenziali al sistema del verde comprensoriale.
Coerentemente con queste premesse, il piano indicava la soglia del 50% come limite quantitativo da non valicare nell’urbanizzazione del territorio comprensoriale e definiva planimetricamente le aree da salvaguardare come “cintura verde metropolitana”, individuando al suo interno le aree agricole produttive, le aree a verde agricolo-ecologico e le aree a parco e verde attrezzato comprensoriale; una particolare attenzione era dedicata al settore sud della cintura metropolitana per il quale veniva riconfermata la proposta, ormai da tempo presente nel dibattito culturale, di un “parco diffuso” integrato alle aree agricole, il Parco Sud.
All’interno del complesso delle aree di cintura individuate, il piano proponeva di “ controllare ogni mutamento significativo dell’uso del suolo e del paesaggio, impedendo a tempo lungo ogni trasformazione difforme da quella a “verde” con la sola eccezione di opere pubbliche per le quali una particolare istruttoria abbia verificato l’impossibilità di collocazione alternativa, abbia esplicitato – in termini di ‘costi-benefici’ – il danno arrecato al sistema del verde comprensoriale dall’opera in rapporto ai benefici connessi alla sua attuazione ed infine abbia verificato che ogni sforzo sia stato compiuto in termini di qualità del progetto per il migliore inserimento dell’opera sotto il profilo ambientale e paesistico”.
Pubblicato nel 1982, quando era ormai stato decretato lo scioglimento degli organismi comprensoriali, il piano costituirà in ogni caso un riferimento importante per la definizione delle politiche territoriali nell’area milanese.
Con la promulgazione della legge-quadro n° 86 (“ Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”), approvata nel novembre 1983, la Regione Lombardia porta a compimento il processo avviato nel decennio precedente: viene individuato un sistema costituito da 23 parchi e vengono istituiti tre nuovi parchi (Adda Nord, Adda Sud e Valle del Lambro), che si aggiungono a quelli istituiti nel corso degli anni ’70 (Ticino, Groane, Nord Milano, Colli di Bergamo e Monte Barro).
La legge inoltre, istituendo le “Commissioni Provinciali per l’ambiente naturale”, affida alle Province nuovi compiti connessi alla individuazione dei particolari valori del territorio e delle misure per la loro tutela.
In questo contesto, ed in assenza di un organismo istituzionale di livello sovracomunale in grado di definire le scelte generali di pianificazione del territorio e di verificare la coerenza delle politiche condotte alla scala locale, la Provincia di Milano, chiamata a completare il quadro territoriale delle aree protette anche adottando misure di controllo ed indirizzo della pianificazione comunale, si fa promotrice di studi, ricerche e momenti di dibattito e confronto che, partendo dal disegno definito nel Piano Comprensoriale, intendono approfondirne le indicazioni e individuare le possibili politiche di intervento.
La ricerca promossa nel 1984 su “Il sistema delle aree verdi nel territorio provinciale”, si proponeva, in particolare, (attraverso una valutazione delle risorse, delle opportunità di valorizzazione e degli strumenti di tutela già attivati per le aree non urbane, la verifica della sensibilità delle comunità locali e l’esame della “politica del verde” in alcune grandi aree metropolitane quali Londra, Parigi e Rotterdam) di individuare uno schema di riferimento generale e di fornire indicazioni per l’iniziativa della Provincia, finalizzata a consolidare la tutela delle “aree di cintura” ed a promuovere e coordinare le iniziative comunali per la loro valorizzazione e fruizione pubblica.
I temi che emergono e i principali settori sui quali si propone, anche alla luce delle esperienze condotte nelle altre aree metropolitane europee, di concentrare l’attenzione e l’iniziativa provinciale sono soprattutto, oltre alla tutela ed alla qualificazione delle attività agricole esistenti, quello dello sviluppo delle attività forestali e, in particolare, quello della costruzione di un sistema di attrezzature che consentano e favoriscano una effettiva fruizione sociale del verde e degli spazi aperti.
L’impegno della Provincia e la forte mobilitazione delle associazioni e dei cittadini su questi temi porteranno all’approvazione della LR 41/85, istitutiva dei “parchi di cintura metropolitana”, e all’inclusione all’interno di questa categoria, su proposta dell’amministrazione provinciale, del Parco Sud Milano.
Con la definitiva istituzione del Parco Sud, che avverrà tuttavia solo nel 1990, l’obiettivo della salvaguardia di tutti i grandi ambiti territoriali individuati nel disegno della “cintura verde metropolitana” proposta dal Piano Comprensoriale del 1980 verrà finalmente raggiunto e inizierà una nuova fase, quella della sua “costruzione” in un rapporto di effettiva collaborazione tra i molteplici soggetti interessati.
Riprendiamo dal “dossier” di Urbanistica informazioni (gennaio-febbraio1985) il saggio di uno dei partecipanti (insieme a Mario Cresci, Ferruccio Orioli, Raffaele Panella e altri) a un’esperienza che è stata rapidamente dimenticata. Eppure, rileggere oggi questo resoconto del lavoro compiuto è di grande interesse.
Perché è una interessante anticipazione dello spirito e dei modi della “pianificazione partecipata”, con il coinvolgimento della popolazione (compresi gli emigranti e i bambini delle scuole) finalizzata alla costruzione di un progetto di città e al suo governo.
Perché è un esempio (e un’anticipazione) di quel passaggio dal piano alla pianificazione che si cominciava allora a rivendicare.
Perché ricorda l’essenzialità della saldatura tra le indispensabili componenti della pianificazione della città e del territorio: quella politica, quella economico-sociale, quella fisica, tutte alimentate e sorrette da una dimensione etica dell’impegno professionale.
Nel file .pdf, scaricabile dal link in calce, oltre alle illustrazioni del saggio, utilissime per comprendere lo spirito e la sostanza del lavoro, sono riprodotte le schede, curate da Ferruccio Orioli, che illustrano le diverse componenti progettuali e attuative della pianificazione avviata con il PRG.
NOTE SUL PRG DI TRICARICO
1. ALCUNI DATI GENERALI
Le operazioni di piano a Tricarico (Matera) vanno dal 1966, anno del conferimento dell’incarico del Prg, al 1972, anno in cui vennero ultimati i Pp di volta in volta collegati all’attuazione della 167, alla costruzione di una nuova casa comunale e, infine, agli interventi nel centro storico.
Il Prg fu affidato dall’Amministrazione comunale di Tricarico al Laboratorio di ricerca e progettazione Polis di Venezia, avente come responsabile A. Musacchio per la sezione socio-economica e R. Panella per la sezione urbanistico-territoriale. Alla Polis parteciparono dagli inizi F. Orioli, che fin dal ‘67 (la Polis era nata nel ‘65) assume un ruolo direttivo nel settore urbanistico-architettonico a fronte di un progressivo distacco del gruppo di R. Panella e M. Cresci, che dopo una collaborazione in veste di grafico avrebbe curato le campagne fotografiche a Tricarico e l’uso della fotografia nei vari atti di piano.
La sigla Polis fu utilizzata per le operazioni di piano comprese fra il ‘66 ed il ‘69. A partire dal ‘70 nella titolarità degli atti di progettazione subentrò, praticamente sulla base delle stesse persone, il gruppo di progettazione “Il politecnico”, che si costituì direttamente a Matera, dove operò fino al 1974. Per la Polis hanno partecipato all’attività urbanistica e socio-economica a Tricarico essenzialmente: Mario Cresci, Aldo Musacchio, Ferruccio Orioli, Raffaele Panella, Luisa Tugnoli, Neri Braulin. Per il Politecnico: Mario Cresci, Amalia D’Adamo, Luciana Fabris, Giuseppe Grassi, Aldo Musacchio, Ferruccio Orioli, M. Silvia Pertempi, Cono Terranova, Pancrazio Toscano.
Fra il 1966 ed il ‘72 il Comune di Tricarico fu retto da una Giunta la cui continuità di governo fu assicurata dalla Dc, sindaco M. Molinari, un laureato in economia e commercio, funzionario del Banco di Napoli. Tutte le delibere relative agli atti di piano furono approvate dal Consiglio comunale all’unanimità. Alla metà dell’83 il Prg risultava realizzato nella misura del 65-70%. Nel corso dello stesso anno l’Amministrazione comunale, ora presieduta da una Giunta socialista-comunista, con sindaco Psi, conferiva l’incarico della revisione del piano a F. Orioli.
2. I fondamenti teorici del lavoro di gruppo
2.1.La Polis si formò sulla scorta delle esperienze comuni di alcuni operatori culturali facenti capo all’Iuav (Istituto universitario di Architettura di Venezia). (In precedenza, Musacchio era stato, a Venezia, Coordinatore del Corso superiore di disegno industriale, di cui era allievo Cresci).
Dall’intensa attività scientifica e dalla stessa effervescenza politica dell’Iuav di quegli anni la Polis eredita almeno due presupposti ideali, legati, soprattutto in Panella, ma in parte anche in Orioli, alla lezione di Giuseppe Samonà:
a) il mito del piano, come strumento di razionalizzazione dei fenomeni territoriali, e come grande fattore di mobilitazione e promozione sociale e d’allargamento della democrazia di base (il “piano partecipato”);
b) il mito dell’interdisciplinarietà quasi come corrispettivo e correttivo dell’univocità ideologica del gruppo di lavoro, di decisa estrazione marxista, ma fortemente interessato a portare avanti un discorso di applicazione e di interazione professionale di determinate discipline scientifiche, dentro una dialettica sperimentazione/ negazione delle scienze sociali derivante pure dalla frequenza - Musacchio, Panella - di ambienti veneti legati ai Quaderni rossi.
2.2. Soprattutto in Musacchio e Panella, d’origine meridionale, gioca la volontà d’invertire la tendenza tradizionale dei “meridionali del Nord”, ridiscendendo al Sud per condurre un esperimento d’avanguardia nel sottosviluppo. Di questa determinazione è parte integrante la scelta di far coincidere, quanto più è possibile, luogo di lavoro e luogo di residenza; coll’avanzare dell’intervento urbanistico su Tricarico, in effetti, il gruppo si radicherà stabilmente in Basilicata (prima a Tricarico, poi a Matera).
3. IPOTESI DI LAVORO E RISCONTRI NELLA REALTÀ
3.1. Il nucleo fondamentale dell’impostazione teorica del lavoro di Tricarico è rappresentato dalla collocazione, al centro dell’attività di conoscenza e di progettazione urbanistica, di una riflessione d’ordine socio-economico; se il territorio - città e campagna - costituisce il luogo del rapporto società/economia, allora l’urbanistica è principalmente capacità di dare forma e razionalità spaziale ai vari stadi storici di tale rapporto.
3.2. L’ipotesi di lavoro per Tricarico discende da alcune valutazioni della congiuntura che il paese attraversa.
Dislocato nell’interno della Basilicata, lungo la strada statale che - all’epoca - unisce Matera a Potenza, Tricarico partecipa politicamente e socialmente di quella che Rocco Scotellaro ha chiamato la zona grigia dei movimenti contadini per la terra. Tra il ‘55 ed il ‘65 la popolazione locale è diminuita, per effetto dell’emigrazione verso il Nord ed il resto d’Europa, di 3 mila unità, passando all’incirca da 10 mila a 7 mila abitanti.
Per il momento il paese è tagliato fuori da qualsiasi programma di sviluppo: soltanto una zona periferica del suo territorio è stata toccata dalla riforma agraria, mentre l’industrializzazione di Val Basento lambisce appena il sistema collinare sottostante il paese, occupando solo poche unità lavorative.
In uno scenario del genere prevalgono, sotto il profilo socio-economico e demografico, le negatività:
- è l’emigrazione che fa vivere, con le proprie rimesse, i superstiti; nel ‘67 l’ammontare dei depositi fra casse postali e sportelli bancari è di circa 5 miliardi (per cinquemila anime);
- una frazione crescente dei ceti intellettuali borghesi si giova dell’impegno pubblico: soprattutto attraverso le istituzioni scolastiche e quelle sanitarie, assistenziali, previdenziali;
- le famiglie che hanno degli emigrati, proprio in questa seconda metà degli anni Sessanta, vanno istituendo una specie di “circolo virtuoso” del reddito, fondato sulla complementarietà di stato e mercato, e composto di una quota di risparmio migratorio e di quote di autoconsumo connesse alle economie naturali ed alla proprietà pressoché generalizzata della casa e di frammenti di latifondo contadino, di spezzoni di lavori collocati nell’agricoltura e nell’edilizia, di quote assistenziali (indennità di disoccupazione, pensioni di vecchiaia e soprattutto di invalidità), di lavoro domestico delle donne.
3.3. In questo contesto:
A) Qualsiasi previsione di sviluppo è aleatoria, in quanto - fra l’altro - non riconducibile ad alcun strumento di piano vigente in Basilicata a livello regionale. L’unico giudizio possibile, al momento, è che quello tricaricese sia un sistema a sviluppo zero, in cui ciò che viene impostato dall’esterno viene consumato parzialmente sul posto, lasciando come residuo una massa di capitali che, a sua volta, viene riportata all’esterno attraverso il sistema postale e bancario.
B) Le previsioni demografiche portano a pensare ad un lento declino della popolazione, soprattutto con effetti di senilizzazione e di femminilizzazione. Nell’incertezza delle dinamiche migratorie, l’obiettivo più realistico appare la stabilizzazione entro un decennio della popolazione su di un contingente di 5.800 - massimo 7 mila unità.
C) Che cos’è, che cosa può fare l’urbanistica nel sottosviluppo? Tricarico è (ha) un centro storico vincolato dalla Soprintendenza. Da secoli è sede di diocesi e, quindi, vanta una struttura nobile, tuttora non alterata da interventi distruttivi. La crisi di identità, prodottasi negli ultimi anni in conseguenza dei processi di mutamento generati dall’esodo fa sì che l’immagine ideale del paese sia decaduta presso la stessa mentalità comune. Ciò non ha provocato ancora l’aggressione del vecchio abitato, in quanto sono mancate le risorse finanziarie per farlo. Ora però l’emigrazione, fornendo tali risorse, mette in moto la macchina dell’edilizia; la quale sempre più si palesa come l’unica fonte d’occupazione e, quindi, di reddito per la forza lavoro (debole) rimasta in paese. Per un verso è lo Stato che attiva e sostiene l’industria delle costruzioni attraverso i finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno in opere pubbliche e attraverso gli interventi nell’edilizia economica e popolare; per un altro verso è l’emigrazione che alimenta un crescente mercato delle abitazioni e delle aree. La massima e più diffusa aspirazione dei tricaricesi è di ristrutturare la casa di proprietà; ma l’eccedenza di risparmio - localmente non impiegabile in altri investimenti, dato che l’acquisto della terra in quanto bene agricolo è condizionato dall’incertezza del rientro degli emigrati e da un distacco dalla terra che, comunque, si avverte come definitiva - alimenta soprattutto l’espansione urbana.
La decisione dell’Amministrazione comunale di Tricarico, allora, di far redigere il Prg non è tanto un atto illuminato di governo, quanto un modo di “superare” il vincolo della Soprintendenza (che - ai sensi della normativa urbanistica del tempo - in ogni caso obbliga Tricarico alla redazione di Piano regolatore), accettando e legittimando il boom dell’edilizia. L’urbanistica, dunque, come “licenza di costruire”. Non solo. L’emigrazione mette a disposizione della società locale una massa monetaria che stimola, oltre che il mercato immobiliare, la rendita fondiaria urbana.
Nel ‘67, a Tricarico, i suoli centrali - i suoli, cioè, che rientrano nell’area percepita come appartenente alla tradizione dell’abitare e del vivere nella comunità - hanno un prezzo che oscilla fra le 70 e le 100 mila lire al metro quadrato. Valori a livello metropolitano, dal momento che a Tricarico lo spazio “urbano” è un bene raro, ritenuto in via di esaurimento. Ciò significa, quali che siano le intenzioni dei progettisti, che il Prg, definendo una nuova forma urbana di Tricarico, finisce, comunque, col definire il mercato fondiario, dal momento che ci si trova davanti ad un eccesso di domanda e che un sovradimensionamento, pur calcolato, delle aree di espansione, da un canto incontrerebbe limiti fisici (oltre che storico-paesistici) insuperabili, dall’altro esporrebbe il Comune al rischio di dover espandere a dismisura la spesa per le infrastrutture e di servizi. Il che, forse, è ciò che accade dappertutto, o quasi. Quel che è proprio del sottosviluppo, invece, è che i capitali disponibili provengono per la massima parte dall’emigrazione, vale a dire dalla fuga dal Mezzogiorno dei più poveri, mentre di contro i suoli, essendo i più prossimi al vecchio abitato, appartengono per la massima parte alla borghesia locale.
Se ne deduce che l’urbanistica (il Prg) di fatto sanziona il passaggio dei capitali da alcune mani ad altre, anzi (di norma) da una classe ad un’altra o, più banalmente, da coloro che per sopravvivere hanno dovuto emigrare e coloro che, per una qualche ragione, sono riusciti a restare in paese.
Due conclusioni di ordine generale: a) in ogni caso gli emigrati si danno carico dei rimasti, sia che costoro appartengano alla categoria dei percettori di rendita, sia che costoro - tuttora appartenenti al proletariato - percepiscano un salario dall’edilizia promossa dal processo migratorio; b) che tutto questo processo trova un qualche corrispettivo programmatorio nell’urbanistica che, nel sottosviluppo, non potendo razionalizzare (appunto) lo sviluppo, si adatta a razionalizzare le forme “opulente” della marginalità e della sussistenza.
3.4. L’analisi della situazione congiunturale e delle contraddizioni di fondo dell’urbanistica nel sottosviluppo prende forma nell’estate del ‘66, in fase di studi propedeutici al piano, e costituirà uno dei leit-motiv del dibattito di gruppo negli anni della operatività in Basilicata. Una delle alternative fondamentali dinanzi alle quali ci si imbatte, a Tricarico, è quella relativa al dimensionamento delle aree da destinare all’urbanizzazione privata. Un’inflazione, contenuta, dei suoli immessi sul mercato calmerebbe probabilmente i costi, determinando tuttavia - va ripetuto - uno stato di disagio e addirittura di rischio delle finanze comunali, senza dire delle barriere che ad una dilatazione del perimetro urbano oppongono le preesistenze paesaggistiche e monumentali ed i condizionamenti geografici. Davanti al male “certo” di un sovradimensionamento che metterebbe in pericolo alcune soluzioni urbanistiche, senza garantire che gli operatori di mercato si comportino in maniera conforme alle previsioni (il mercato fondiario diviene estremamente aleatorio in una situazione in cui il compratore vuole ad ogni costo acquisire un bene di cui per secoli ha agognato l’acquisto e dove l’esborso di una certa somma, da una parte, riflette la sua nuova mentalità di inurbato aggiornatosi ai costi delle aree metropolitane, dall’altra è prova e simbolo, nello stesso tempo, del suo nuovo status, della sua mutata capacità di reddito), in queste condizioni, dunque, il male minore appare quello di attenersi, almeno in via di ipotesi, ad un piano di minima che si rifaccia strettamente ai margini di sviluppo ed alle quantità demografiche realisticamente prevedibili e dia per scontata, pure, una flessione nel tempo della domanda fondiaria ed immobiliare, a mano a mano che l’emigrazione si consolida nei luoghi di destinazione.
Entro tali margini i veri obiettivi di piano, in gran parte coincidenti, possono identificarsi nella salvaguardia del patrimonio storico-monumentale, nella regolamentazione degli interventi di risanamento e conversione, nell’elevazione infine degli standard abitativi e residenziali, attraverso misure e servizi d’ordine vastamente igienico-sanitario, in grado di diffondere quei “modelli urbani” e quella “qualità della vita” che i flussi monetari provenienti dall’esterno finalmente consentono di raggiungere. Senza, tuttavia, incoraggiare “sprechi”: tentando, cioè, di evitare che l’accumulazione di capitale si riversi in surplus edilizio, in opulenza abitativa, in dilatazione abnorme del perimetro cittadino. Tutti fenomeni, che si tradurrebbero in oneri insopportabili per l’ente locale, senza che, peraltro, esista una ragionevole certezza che gli emigrati beneficino effettivamente delle risorse investite, tranne che nei brevi ritorni in paese per le festività tradizionali.
Inserendosi in quello che è il ganglio vitale del nuovo rapporto economica/ società istituito dall’emigrazione, il Prg si colloca fra gli strumenti, ed anzi col tempo si manifesta come il più efficace fra gli strumenti, politico-amministrativi per il governo della transizione di Tricarico da una formazione contadino-artigiana, ad una caratterizzata da un generico e ancora non definito processo di modernizzazione.
A Tricarico, insomma, il Prg coincide con la fine della miseria, come condizione generale della vita collettiva, e con l’introduzione di nuovi costumi, di diversi modelli di consumo, con la conseguente apertura al mercato di aree geografiche finora rimaste praticamente escluse dalle correnti di scambio delle merci; di processi pressoché generalizzati d’istruzione, che negli anni immediatamente a venire convoglieranno massicciamente l’investimento del risparmio migratorio verso l’educazione dei figli.
4. GLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO
4.1. Obiettivi politici
Nel lavoro del gruppo agiva l’ideologia propria dell’Iuav, e tipica di quegli anni, dell’equazione di lavoro professionale e di lavoro politico. In particolare, a Tricarico, la Polis tentò di verificare la possibilità che i processi d’informazione e di coinvolgimento diretto della popolazione nell’ideazione e nel dibattito delle linee di piano divenissero strumenti effettivi di democrazia materiale.
In sostanza la partecipazione della società locale alle varie fasi di piano si articolò secondo quattro modalità:
a) l’intervista a singole persone e, più spesso, a nuclei familiari, con visite e sopralluoghi alle loro case. In queste occasioni il contatto si estendeva, di frequente, al vicinato, ma sempre nelle dimensioni del “piccolo gruppo”, del quale si raccoglievano indicazioni, proteste, denunzie di bisogni, aspirazioni sociali. I dati statistico-sociali per nucleo familiare erano stati prelevati dalle schede censuarie; quelli relativi alla morfologia dell’alloggio venivano, invece, raccolti sul posto;
b) riunioni con gruppi sociali più vasti facenti capo ad un intero rione, per il quale il gruppo poteva proporre, o per il quale potevano essere suggeriti dai presenti, interventi infrastrutturali complessi, organizzazione di servizi collettivi, soluzioni urbanistiche di quartiere;
c) assise per categorie sociali omogenee (artigiani, commercianti, contadini, professionisti) in relazione a problemi come la dislocazione delle attività economiche e commerciali, l’insediamento di nuove strutture istituzionali, la distribuzione del traffico e simili;
d) assemblee anche dell’ordine di 600-700 persone per la discussione dei vari stadi d’avanzamento del Prg, compresa la stesura finale.
Sotto il profilo sociologico è d’un qualche rilievo sottolineare come la maggior quantità di dati e di informazioni a livello di “nuclei familiari” e di “piccoli gruppi” sia stato fornito dalle donne, come detentrici dell’esperienza e del sapere quotidiani e quindi attente ai problemi della casa, dal vicinato, dei servizi collettivi e così via; mentre, nelle riunioni pubbliche, a parlare siano stati soprattutto gli uomini (i quali, del resto, in queste sedi costituivano la massima parte, se non la totalità dei presenti) su argomenti per lo più incentrati su grandezze territoriali ed economiche connesse al lavoro o alla produzione.
In ogni caso è doveroso rilevare come tutta l’esperienza partecipativi di Tricarico sia stata agevolata dalla relativa modestia delle quantità demografiche in gioco, e come lo spirito sperimentale e pionieristico della Polis mettesse in conto tempi di lavoro e strumenti di indagine e d’intervento non propriamente di tipo professionale, dal momento che il gruppo di lavoro traeva da altri lavori (professionali e/o accademici) i mezzi per la propria autonomia economica.
Infine, fra gli obiettivi politici rientrava, come meglio si avrà modo di precisare in seguito, l’instaurazione di un rapporto organico non solo con gli organi elettivi dell’Amministrazione comunale, ma anche (e, in un certo senso, a maggior ragione) con l’Ufficio tecnico comunale, la cui collaborazione era ritenuta essenziale per l’impostazione e la redazione del piano, ma ancor più per la futura attuazione.
4.2. Obiettivi pedagogico formativi
L’iniziativa della Polis conteneva, in matrice, una forte connotazione pedagogica ed educativa riferita al “valore piano”. Questo aspetto del progetto su Tricarico emerse principalmente con la redazione di un Quaderno del piano distribuito in 5 mila copie nelle scuole di ogni ordine e grado per le ricerche di classe. Il formato era di due sedicesimi. Uno, con immagini in bianco e nero commentate da didascalie che, spiegando che cosa fossero la città e il territorio, di che natura gli obiettivi dell’urbanistica, quali le strutture e gli oggetti su cui si esercitava il piano e così via, forniva il corredo di tutta una serie di dati storici e statistici su Tricarico; il secondo di carta bianca, quadrettata, destinato a completare e commentare il testo a stampa attraverso le ricerche di classe. La sceneggiatura ed i testi erano di A. Musacchio, la grafica e le fotografie di M. Cresci, l’impostazione generale del gruppo. Il Quaderno, oltre che nelle aule e nelle case degli studenti, finì nei diversi luoghi di destinazione dell’emigrazione, come raccolta sistematica di immagini e documenti - e quindi di “memorie” - su Tricarico.
Un secondo strumento di avvicinamento della popolazione locale a tematiche culturali fu individuato nelle mostre: una, fotografica, di Mario Cresci che espose, nel ‘67, i ritratti eseguiti nel corso della campagna fotografica dell’anno precedente, suscitando grande interesse, curiosità e a volte risentimenti e rivalità da parte delle persone riprodotte (si calcola che la mostra sia stata visitata da poco meno di 1000 persone); un’altra, di pittura, di un giovane artista locale, Michele Santangelo, vicino al gruppo per la tematica dei suoi quadri, presentati nel catalogo da A. Musacchio (sempre nel 1967).
Un aspetto più propriamente formativo dell’azione del gruppo fu costituito dal progressivo coinvolgimento di un nucleo di giovani locali nel lavoro di rilevazione e di indagine. Battere questa via significò, per il gruppo, soprattutto tentare di far crescere sui temi socio-economici ed urbanistici alcuni “quadri” intellettuali in grado, in seguito, di gestire il piano. Questo disegno formativo, delineatosi con la Polis e il Prg, fu concretato da Il politecnico nel ‘70, quando in fase di pianificazione particolareggiata di Tricarico (ma, più in generale, nell’attività complessiva dello studio) vennero inseriti stabilmente - nel settore delle ricerche socio-economiche - due insegnanti tricaricesi, Giuseppe Grassi e Pancrazio Toscano (quest’ultimo, non a caso, forse, da qualche anno sindaco socialista di Tricarico).
4.3. Obiettivi tecnico-scientifici e culturali
Nel lavoro del gruppo prevalse, in maniera abbastanza netta, la tendenza a privilegiare l’osservazione e la ricerca empirica di campo, secondo una metodologia molto vicina a quella delle scienze sociali e quindi con sopralluoghi, visite, interviste ed un lavoro di rilevazione di dati e di situazioni oggettive (tipologie edilizie, particolari costruttivi, modelli dell’arredamento tradizionale, inventario dei materiali da costruzione ecc. ecc.) che, oltre ad esser puntato sulle strutture architettoniche ed urbanistiche, teneva di continuo sotto osservazione, e probabilmente privilegiava, il contesto storico e socio-culturale in cui i vari fenomeni ed i diversi oggetti si erano prodotti, il tipo di “scienza sociale diffusa” da cui nasceva un certo modo di costruire e di usare il paese, le funzioni economiche e sociali assolte dai vari ambienti e spazi urbani (quelli chiusi e quelli aperti, i privati ed i pubblici, e così via).
Alla luce di queste tematiche la fotografia assunse un ruolo importane, e a volte decisivo, almeno in tre direzioni:
A) Documentazione. La campagna fotografica si compose, alla fine, di circa 2 mila immagini. Più che di un’immediata riduzione della fotografia a strumento di documentazione, di memoria, di conoscenza urbanistica, si trattò - in un primo tempo - di recuperare i segni ed i singoli elementi linguistici del paesaggio urbano e rurale di Tricarico, per estendere poi la ricerca alle varie forme di azione sociale della comunità ed ai modelli antropologici e culturali emergenti (sia a livello di persone che a livello di oggetti). Al termine della campagna fotografica ci si rese conto che la serie delle immagini, nell’assieme, era passibile anche di un’utilizzazione urbanistica, ma che più in generale l’iconografia raccolta permetteva una rappresentazione entro la quale era possibile muoversi in parecchie direzioni: da quella più propriamente urbanistica ad una di tipo sociologico, fino ad una terza a contenuto marcatamente antropologico, e così via.
B) Produzione culturale. Il lavoro di Cresci assunse progressivamente i caratteri di una vera e propria rielaborazione creativa delle immagini prelevate dalla realtà tricaricese. A parte, dopo la mostra fotografica a Tricarico, Cresci assoggettò i materiali raccolti ad una serie di trattamenti d’ordine grafico, che espose - sempre nel ‘67, con una presentazione di Musacchio - al circolo La Scaletta di Matera. Il suo lavoro ebbe anche sviluppi pittorici (alcuni cartoni dipinti ed album di disegni con progetti anche di sculture) e, infine, cinematografici con un abbozzo di documentario a passo ridotto (1969). Il tutto con l’avallo culturale e finanziario del gruppo, che considerava l’attività espressiva di Cresci come uno dei possibili esiti del lavoro collettivo su Tricarico.
C) Applicazione della fotografia in urbanistica. Soprattutto in sede di redazione dei piani particolareggiati il gruppo cominciò a pensare all’adozione della fotografia come “strumento urbanistico”. E ciò in due sensi. Anzitutto proprio dalle riunioni a carattere pubblico era emersa la quasi impossibilità di comunicare a persone per lo più di mestiere e di cultura contadina dati, informazioni e progetti urbanistici concepiti ed espressi dentro la categoria dello spazio cartesiano. La cartografia normalmente usata dagli urbanisti risultava molto spesso incomprensibile al pubblico, specie ai vecchi e alle donne (tuttora in maggioranza analfabeti). Si ricorse, in un primo tempo, a disegni a carattere accentuatamente “figurativo”; poi ci si rese conto che il sistema di segni più agevolmente acquisibile da parte della generalità dei partecipanti alle assemblee era appunto la fotografia, che secondo il senso comune riproduceva con la maggiore fedeltà possibile la realtà. Questa esperienza portò a pensare ad un secondo livello d’impiego della fotografia sia per la rappresentazione dello stato di fatto, sia per le indicazioni progettuali da riportare sulle tavole di piano. Dopo una rigorosa ricerca di omogenei criteri matematici e geometrici in grado di garantire il rispetto delle dimensioni, dei volumi, delle distanze, della scala ecc. ecc., la fotografia fu usata direttamente per la redazione delle tavole di piano, in particolare nei piani particolareggiati. In questa operazione furono impiegati tanto metodi grafici (le immagini vennero retinate, disegnate e, in genere, trattate come si sarebbe fatto con qualsiasi altro materiale cartografico) quanto metodi fotografici (a cominciare dal montaggio).
Un’altra occasione di approfondimento e di trasferimento all’esterno di nozioni e problematiche tecnici scientifiche fu offerta dal Piano di zona della 167, alle cui tavole ed alla cui normativa fu allegata una guida all’edificazione. L’obiettivo era quello di comunicare una metodologia della progettazione e dell’edificazione ad una comunità che, con l’emigrazione e con la graduale scomparsa dei capimastri, aveva perduto gran parte della propria (spontanea) scienza delle costruzioni.
La zona d’insediamento della 167, come quasi sempre a Tricarico, era molto scoscesa: si trattava, pertanto, di intervenirvi facendo ricorso non soltanto ai moderni criteri urbanistici in tema di tipologie, di allineamenti, di rispetto degli standard e così via, ma anche ai vecchi criteri d’insediamento sul terreno, di sfruttamento delle pendenze a fini costruttivi, di consolidamento a monte delle abitazioni, di prevenzione dell’umidità ecc. ecc.
Il piano di zona fu concepito come una sorta di quotizzazione, cioè di ripartizione del terreno in quote, che, assemblate, davano luogo ad un lotto. Ogni lotto corrispondeva alla quantità minima di suolo necessaria per dar luogo ad un intervento edilizio rispondente alla normativa della 167: essendo i lotti di varia ampiezza, ad ogni tipo di lotto corrispondeva un preciso volume edificabile (naturalmente nel rispetto di tutti gli standard previsti dalla legge). In questo modo - fra l’altro - ogni cittadino era in grado di valutare autonomamente quanto suolo gli servisse per poter costruire secondo i propri bisogni. Sulla scorta della giacitura e della inclinazione dei terreni, inoltre, la guida proponeva una serie di possibili piante (componibili sulla scorta delle specifiche soluzioni derivanti dalle combinazioni superficie/volume) in relazione - ovviamente - alle tipologie edilizie previste dallo strumento urbanistico. Benché rivolta all’insieme della cittadinanza, quest’operazione, in definitiva, intendeva fornire una nuova strumentalizzazione metodologica e tecnica soprattutto ai professionisti locali, in primo luogo ai geometri, avendo cura di non sostituirsi ad essi ma di fatto suggerendo un ventaglio di soluzioni progettuali, che aggiornavano le tecniche d’aggressione dei terreni, le scelte tipologiche, i principi di distribuzione degli ambienti ecc.
5. LE SCELTE URBANISTICHE
5.1. L’operazione tentata a Tricarico va collocata nel contesto storico e socio-culturale locale. Nel ‘66 - ‘67 Tricarico era come immerso in una prospettiva di possibile scomparsa materiale. L’emigrazione aveva drammaticamente suggellato una riflessione collettiva di più ampio periodo intorno alla decadenza del paese e ad una sua più o meno inevitabile fine. Il paese sembrava ai suoi abitanti medesimi tagliato fuori dalla storia, né gli stessi movimenti contadini dei primi anni di questo dopoguerra avevano dato la sensazione alla collettività locale d’un recupero pieno di attualità.
L’emigrazione, perciò, non era stata solo una necessità, ma anche un atto consapevole di rinunzia, tant’è vero che - attorno al ‘55 - i primi ad abbandonare Tricarico erano stati i leader politici e sindacali delle lotte per la terra della seconda metà degli anni Quaranta.
Di questa regressione dell’identità storico-sociale di Tricarico era espressione non secondaria un sentimento di ambivalenza nei confronti del paese: pur dichiarando di amarlo, alcuni affermavano apertamente che l’unica soluzione fosse di abbatterlo e ricostruirlo, magari sullo stesso posto. Ma il sentimento più frequente, come si è accennato in precedenza, era di esaurimento dello spazio storico di Tricarico. Avendo vissuto il centro storico come scena primaria e unità di luogo della loro vicenda collettiva, i tricaricesi non riuscivano a concepire un altro teatro praticabile.
Un intervento di edilizia economica e popolare dei primi anni del dopoguerra, insediato in posizione speculare a quella del centro storico e ad una distanza di poche centinaia di metri, veniva sprezzatamente chiamato “il villaggio” (“villaggio” come modello urbano e antropologico-culturale in contrapposizione a “paese”).
Esaurito il ristretto sito collinare sul quale Tricarico era stato per secoli confinato, la capacità progettuale della collettività s’era come paralizzata, nell’incapacità di rivedere i meccanismi che per secoli avevano governato le dinamiche centripete del sistema. Oltrepassare i limiti della periferia tradizionale, dilatare le dimensioni del vissuto collettivo e dalla rete di relazioni, fruire dei mezzi di locomozione moderni (del resto già ampiamente diffusi) per spostarsi entro un ambito riconoscibile ancora come “conforme” allo spirito comunitario: tutto ciò sembrava fuori della portata della mentalità e perfino dell’immaginazione della società locale.
5.2. Uno dei compiti principali degli operatori urbanistici era, dunque, quello di riproporre uno spazio storicamente reale alla collettività: di progettare, in altri termini, una dimensione del vivere sociale che restituisse a Tricarico la forma della contemporaneità (o per meglio aderire alle categorie mentali e culturali della collettività locale) della modernità.
Un simile stato delle cose richiedeva al gruppo di lavoro di espungere ogni residuo estetizzante o sentimentalista della concezione dell’operazione da compiere. Si trattava, in un certo senso, di liberarsi dal mito del Sud, trattando finalmente la forma urbana di un paese come Tricarico al di fuori di qualsiasi nostalgia della civiltà contadina (anche se nella consapevolezza e nel rispetto dei suoi valori). Occorreva, a ben vedere, che ciascuno dei fatti territoriali fosse sottratto al deficit di significato che l’aveva colpito e ricollocato entro un nuovo orizzonte di senso: senza essere manomesso, ma semplicemente predisposto a nuove potenzialità d’uso.
Specie la campagna fotografica aiutò il gruppo a leggere la pluralità dei fenomeni urbanistici, economici e sociali di Tricarico come un complesso di relazioni, che potevano essere riconnesse fra loro entro mutati codici di regolamentazione spaziale. In altri termini, la fotografia rese evidente come i vari componenti del “sistema Tricarico” potessero essere riassorbiti in un nuovo quadro di riferimento.
5.3. Fin dal principio fu chiaro, sia ai progettisti che agli amministratori comunali, che l’attività di pianificazione non si sarebbe esaurita col Prg, ma sarebbe divenuta un work in progress da realizzare attraverso una successione coerente di atti urbanistici distribuiti lungo l’arco di alcuni anni, così da aggiornare di continuo il rapporto fra il piano ed i processi di cambiamento in atto, che già mostravano i caratteri di una accelerata, “grande trasformazione”.
5.4. Il Prg si sforzò di intervenire su Tricarico senza enfatizzare a priori alcuna valenza a danno di altre: la stessa vitalità del centro storico doveva essere misurata, più che sui suoi intrinseci valori estetici e documentari, sull’attitudine a partecipare ad un nuovo discorso urbanistico. In breve i perni del nuovo sistema urbano e territoriale di Tricarico possono essere riportati ai seguenti punti:
A) Conservazione attiva del centro storico, con riqualificazione ed esaltazione così della sua qualità residenziale complessiva, come delle sue funzioni di rappresentanza e dei suoi giacimenti monumentali. Con due linee maestre di orientamento: 1) conservazione a Tricarico di alcune funzioni direzionali, legate ad un secolare ruolo (protrattosi fino ai nostri giorni) di centro dispensatore di servizi a livello comprensoriale (Vescovado, ospedale, scuole pubbliche e private di grado superiore, pretura, ufficio del registro, centro dell’Ente riforma ecc. ecc.); 2) miglioramento del livello della residenza e, contemporaneamente, strategia d’espansione del demanio comunale della casa in vista sia di interventi pilota connessi ai programmi d’edilizia economica e popolare, sia di eventuali iniziative a favore degli anziani (case-albergo a carico degli enti locali), sia infine, di una possibile valorizzazione turistica.
B) Concezione unitaria del centro storico e degli immediati dintorni a partire da una vasta area inedificata a verde, detta Conca di S. Antonio, a valle del percorso della S.S. n. 7, Appia, tuttora improntata solo dalla presenza di due antichi conventi.
C) Dentro il nuovo disegno urbano, in parte prefigurato dai processi d’urbanizzazione spontanea in corso, definizione di un perimetro a ferro di cavallo, a monte del quale sono dislocate le nuove zone d’espansione urbana e produttiva, ed a valle del quale (appunto nella Conca di S. Antonio vista come un tutt’uno col centro storico, in quanto paesaggio storicamente sedimentato entro una concezione unitaria di città murata - natura) andrà a collocarsi (F. Orioli, 1973), nell’ambito di un apposito piano particolareggiato, la nuova Casa comunale con funzioni (anche) simboliche di centro della rinnovata forma urbana di Tricarico. In pratica, il discorso urbanistico muove, ora, al centro storico per dipanarsi lungo l’Appia fino a toccare il cosiddetto “villaggio”, recuperandolo alla coscienza sociale ed alla vita di relazione della collettività tricaricese.
D) Rafforzamento della rete dei servizi e delle infrastrutture sia con riguardo alla funzionalità ed agibilità del corpo urbano con le sue articolazioni, sia con riguardo ai rapporti di Tricarico col mondo esterno (in seguito, nel pieno degli anni Settanta, Tricarico diverrà sede di Comunità montana). Nelle strategie di raccordo fra espansione urbana e dotazione d’infrastrutture e servizi collettivi il Prg persegue l’obiettivo di “agganciarsi” agli insediamenti di edilizia pubblica già costruiti o in programma assumendoli come “volani” per le urbanizzazioni private. E ciò, al fine sia di accrescere la capacità di tenuta dell’ente locale di fronte alle esigenze poste dalla fin troppo rapida espansione del centro abitato, sia di proporre come modello al settore privato i principi d’ordine e di regolamentazione edilizia ed urbanistica generalmente propri degli interventi pubblici.
Rispetto ai rapporti col territorio circostante il Prg indica:
a) la costruzione di un collegamento viario veloce con la Val Basento che è, nello stesso tempo, la sede degli impianti chimici dislocati nel nucleo d’industrializzazione, della superstrada Basentana (in quel tempo, nella prima fase di costruzione), della tratta della ferrovia Taranto-Potenza-Napoli (e/o Roma);
b) il miglioramento delle reti viarie di penetrazione nelle aree produttive delle campagne tricaricesi, con particolare riferimento al centro della Riforma agraria di Calle, ormai consolidatosi come autonomo insediamento, umano e produttivo;
c) il piano, che allarga e precisa il campo delle funzioni urbane senza tuttavia inflazionarne il significato, immette due valenze nuove nella vita economica e sociale di Tricarico. La prima è costituita dall’individuazione di due aree per attività produttive: una è situata all’interno del perimetro urbano, ed è prevalentemente di servizio ad attività artigianali e commerciali; l’altra è esterna, dislocata in una località di campagna, alla confluenza di alcune strade a carattere intercomunale e quindi di scambio di merci e di persone con Irsina, Grassano, lo scalo ferroviario di Val Basento ecc. Queste scelte predispongono Tricarico a poter ospitare, in qualsiasi momento, eventuali iniziative industriali. La seconda valenza consiste nella proposta di valorizzazione turistica del bosco comunale di Fonti-Tre Cancelli, posto a 900 m. d’altezza, a monte di Tricarico lungo la statale per Potenza; d) tutta l’esperienza urbanistica di Tricarico ha confluito verso il coinvolgimento diretto del gruppo di lavoro nella “gestione dell’urbanistica”. Uno dei punti chiave della filosofia del gruppo è stato che i fondamenti astratti della scienza urbanistica non dovessero - per principio - prevalere sulle “ragioni” dell’Ente locale, e che fosse buona regola di comportamento politico-civile e “d’igiene mentale” tentare di divenire (per quanto possibile) amministratori, contribuendo ad amministrare appunto l’urbanistica assieme al personale politico e burocratico dell’ente locale prima, durante e dopo il processo di piano, verificando che ciascun progetto avesse una copertura finanziaria o attraverso le entrate del bilancio comunale, o attraverso il ricorso ad una qualche legge che consentisse l’accensione di un mutuo garantito dai cespiti ancora delegabili da parte di un’Amministrazione comunale oberata da pesantissimi debiti; assumendo responsabilità in prima persona sulla conduzione dell’Ufficio tecnico comunale (interinato di F. Orioli, nel ‘69), rappresentando o fungendo da consulente del comune in tutte le sedi politico-amministrative in cui si decidessero in parte o in tutto le sorti del piano. E così via.
La vicenda della sovracomunalità nell'area milanese è piuttosto lunga, complessa, articolata. Come già messo in evidenza in altri articoli e cartelle di eddyburg, l'emergere della dimensione metropolitana nella "capitale morale" italiana è più o meno parallelo alle prime esperienze di pianificazione internazionale a scala regionale. Già nel bando di concorso per il piano regolatore del 1926, si richiede ai partecipanti di tener conto della dimensione metropolitana, e il coordinatore dell'ufficio urbanistico del comune, Cesare Albertini, interverrà ripetutamente nel corso degli anni '30 sul tema del piano regionale.
E' comunque soltanto col dopoguerra e gli strumenti messi a disposizione dalla legge urbanistica del 1942, che il dibattito sul piano sovracomunale per l'area milanese inizia ad uscire dalle pagine delle riviste e dalle aule dei convegni, per diventare oggetto di dibattito politico, tecnico, amministrativo.
Tra gli elementi più interessanti, oltre quelli strettamente legati a modi e forme della pianificazione, ci sono la perimetrazione e le forme decisionali del nuovo organismo. Proprio questi sono i temi al centro della breve antologia proposta, per il loro riflettere oltre le contingenze locali aspirazioni e contraddizioni di carattere nazionale, sul tema della modernità, dell'idea di democrazia e partecipazione, sviluppo, equità.
Marco Romano, nell'estratto dall'articolo introduttivo al PIM di Urbanistica 50-51, 1967, ricostruisce da un lato il contesto entro cui matura storicamente il piano, e dall'altro ne traccia (col senno di poi, a quasi vent'anni dall'inizio) l'arco delle vicende politico-amministrative.
Amos Edallo, nel breve testo allegato su Urbanistica 18-19, 1956, al Piano Regolatore Generale comunale di Milano, chiarisce il senso originario dello schema intercomunale, proprio a partire dalle questioni irrisolte del capoluogo.
L'introduzione generale di Adriano Olivetti al Congresso nazionale INU del 1956 di Torino, convocato proprio sul tema della pianificazione intercomunale, contestualizza in senso culturale "alto" le aspirazioni dei piani di dimensione vasta, chiarendo se necessario come soprattutto a questa scala al centro siano gli obiettivi sociali, ben oltre quelli spaziali e di generica efficienza.
L'intervento di Ezio Cerutti ancora al Congresso INU del 1956, sottolinea alcune tendenze già evidenziate ad esempio da Astengo e Bianco nel loro primo Piano piemontese del 1946: la pianificazione territoriale come utopia anche politica, attraverso una profonda riorganizzazione territoriale e amministrativa dello stato e degli enti locali.
Ma la razionalità solo spaziale dell'urbanistica non basta da sola a contenere la complessità del reale, come chiarisce l'articolo di Domenico Rodella da Città di Milano marzo 1957, totalmente orientato a rispondere sostanzialmente ad una sola domanda: esiste un bisogno, e se sì anche un diffuso consenso, a forme complesse di riorganizzazione come quelle che sottendono una pianificaizone metropolitana?
Se la caratteristica principale del PIM del dopoguerra è il suo auspicare un percorso "ascendente", la Provincia Ambrosiana proposta dal progetto di legge del Partito Liberale torna, pur nel quadro democratico delle autonomie elettive, a un sistema più simile a quello centralizzato di cui si dibatteva negli anni '30. Sono sostanzialmente gli obiettivi di carattere politico, espressi nella relazione di Giovanni Malagodi al convegno di presentazione della legge (1956), e efficienza economica sottolineati da Mario Golanel suo articolo dalla Rivista di Politica Economica marzo 1956.
L'intervento di Rossana Rossanda, da Rinascita, n. 10, 1960, spiega come attorno al dibattito sulla pianificazione metropolitana si sia dispiegato un intero catalogo delle ambizioni di potere della classe dirigente italiana. Ben oltre, quindi, una semplice idea di spazio, ambiente, efficienza, servizi.
Su Mall/Antologia il resoconto del seminario internazionale ILSES di Stresa del 1962 sul tema, essenziale per la cultura del PIM, della "Città-Regione", di Umberto Toschi, dalla Rivista Geografica Italiana.
La Premessa al Secondo Schema PIM di Giancarlo De Carlo precisa sia in senso socioeconomico generale che nei termini più disciplinari della pianificazione territoriale gli obiettivi e gli strumenti decisionali dello schema metropolitano, con particolare attenzione al suo processo formativo ed evolutivo (da "La pianificazione territoriale e urbanistica nell'area milanese", Marsilio 1967)
Il racconto di Giampiero Spinelli, estratto da uno studio del PIM, di come si sia sviluppata nel tempo una delle grandi idee portanti del piano ovvero la greenbelt metropolitana del Parco agricolo Sud Milano (da Il Paesaggio, La Natura, la Città, 205)
I pochi allegati, sono nell'ordine: l'intervento di Ezio Cerutti completo della tabella di dati statistici (impossibile da inserire nella pagina) senza la quale non si coglie il senso della sua proposta di riorganizzazione circoscrizionale; lo schema del sistema intercomunale allegato all'articolo di Amos Edallo (curiosamente sbilanciato verso lo scalo aeroportuale di Malpensa); una carta della zona del piano nel 1967; la versione integrale della Premessa al Secondo Schema di De Carlo, 1963; due powerpoint che riassumono per immagini alcuni dei temi spaziali degli articoli, con l'aggiunta di alcuni degli schizzi di Giancarlo De Carlo che descrivono le modalità di sviluppo metropolitano milanese.
Fiorentino Sullo è una figura tragica ed emblematica della vicenda urbanistica italiana che ha determinato anche la sua biografia personale e politica. Nato a Paternopoli (Avellino) il 29 marzo 1921 è morto a Salerno il 3 luglio del 2000. Laureato in giurisprudenza e in lettere. Deputato per 41 anni, dalla I alla XI legislatura. È stato il più giovane deputato all’Assemblea costituente. Uno dei capi storici della Democrazia cristiana, fondatore della corrente di Base. Più volte sottosegretario, ministro dei Trasporti nel governo Tambroni del 1960, si dimise quando quel governo ottenne la fiducia con i voti determinanti del Movimento sociale italiano. Il suo nome resta però legato alla proposta di riforma urbanistica, basata sull’esproprio preventivo delle aree fabbricabili, presentata quando era ministro dei Lavori pubblici nel quarto governo Fanfani (1962-1963) e nel successivo governo Leone (1963). Sconfessato dal suo partito, fu ancora ministro per la Pubblica istruzione (1968-1969), per la Ricerca scientifica (1972) e per l’Attuazione delle regioni (1972-1973), ma lentamente e progressivamente emarginato dalla vita politica che abbandonò definitivamente nel 1987.
La proposta di riforma urbanistica che porta il nome di Fiorentino Sullo e la cronaca della sua clamorosa bocciatura sono illustrate nei documenti che seguono. Qui interessa soprattutto mettere in luce la “lunga durata” della sua dannazione. Ancora oggi non mancano politici e amministratori che di fronte a scelte urbanistiche coraggiose si tirano indietro sostenendo che non intendono fare la fine del ministro Sullo. Tant’è che penso di poter motivatamente sostenere che nel 1963 fu compromessa per sempre la possibilità di dotare il nostro paese di una legislazione moderna in materia di urbanistica.
La prima inquietante dimostrazione della forza di chi si opponeva alla riforma fu il tentato colpo di stato da parte di esponenti delle forze armate nell’estate del 1964 al tempo della formazione del secondo governo Moro (1964-1966). Nel dicembre dell’anno prima, nelle dichiarazioni programmatiche alla Camera del dicembre 1963, in occasione del primo governo Moro (1963-1964), lo statista dedicò molto spazio alla nuova legislazione sui suoli, che riprendeva in larga misura le linee della proposta Sullo. Moro dichiarò infatti, tra l’altro, che tra gli obiettivi da perseguire era compresa:
l’avocazione alla collettività nella misura massima possibile delle plusvalenze comunque determinatesi e la creazione di un meccanismo che eviti la formazione di nuove rendite per il futuro. Il governo ritiene che la strumentazione atta al raggiungimento dei fini della politica economica e sociale che coinvolgano l’utilizzazione del territorio debba trovare il suo fondamento nel regime pubblicistico del mercato della aree fabbricabili.
Nel programma del secondo governo Moro (luglio 1964), la riforma urbanistica è invece del tutto cancellata. Che era successo? Quarant’anni dopo, all’inizio del 2004, polemizzando con Paolo Mieli che riteneva infondata l’ipotesi del colpo di stato del luglio 1964, Eugenio Scalfari scrisse che il complotto c’era stato: “Il business italiano, già colpito dalla nazionalizzazione dell’industria elettrica, tremava al pensiero che i socialisti volessero attuare la nazionalizzazione dei suoli edificabili, che avrebbe spezzato la speculazione sulle aree ed avrebbe impresso un corso diverso allo sviluppo delle città, delle coste, insomma del Paese”. L’analisi di Scalfari non è una novità. Nella Storia e cronaca del centro-sinistra di Giuseppe Tamburrano si legge che “la nazionalizzazione dell’industria elettrica non suscitò le ostilità degli ambienti economici che incontrò invece la riforma urbanistica”. Lo stesso Tamburrano ricorda quanto scrisse Pietro Nenni nel suo diario a proposito degli interminabili incontri con la Dc nel luglio 1964: “La bomba scoppiò quando Moro disse, col suo solito tono distaccato, che il presidente della repubblica non avrebbe mai firmato una legge la quale comportasse l’esproprio generalizzato dei suoli urbani”. Nenni intravide un “balenar di sciabole” e indusse i socialisti a ripiegare.
Un altro episodio, ancor più tragico e tenebroso, addebitabile agli oppositori della riforma furono le bombe di Milano e Roma del 12 dicembre1969 che misero in moto la strategia della tensione. Attenti osservatori (per primo Antonio Cederna) videro in essa il tentativo di ostacolare, innanzi tutto, le ipotesi di riforma urbanistica e dell’intervento pubblico in edilizia che erano state imposte dalla possente manifestazione sindacale che si svolse in occasione dello sciopero nazionale del 19 novembre del 1969.
La nuova legge urbanistica sembrò realizzata nel 1977, per merito di un altro importante ministro riformatore, il repubblicano Pietro Bucalossi. Ma tre anni dopo, all’inizio del 1980, la prima di una serie di sentenze della Corte costituzionale obliterò non solo i contenuti innovativi della legge Bucalossi ma anche le norme che agevolavano il ricorso all’esproprio per pubblica utilità del 1971. Comincia così, con gli anni Ottanta, la lunga stagione della controriforma urbanistica, che non finisce mai. I portatori degli interessi fondiari e speculativi hanno ormai vinto, le intimidazioni e le trame eversive non sono state inutili.
I nostri lettori sanno che nel 2005, alla fine della XIV legislatura, quella del secondo governo Berlusconi, la Camera dei deputati ha approvato (con il voto favorevole di 32 deputati del centro sinistra) il cosiddetto disegno di legge Lupi, dal nome del deputato di Forza Italia Maurizio Lupi, che intendeva sancire definitivamente la privatizzazione dell’urbanistica, rendendo addirittura obbligatoria l’intesa con la proprietà per qualsivoglia trasformazione urbanistica. Siamo esattamente agli antipodi della proposta Sullo. L’approvazione del testo Lupi da parte del Senato, che era data per scontata, fu scongiurata anche (e forse soprattutto) grazie alla mobilitazione organizzata da eddyburg.
I testi proposti dall’antologia in questa Pagina di Storia
Il Discorso al Senato con cui il ministro dei Lavori pubblici sottolinea come la riforma urbanistica sarà nelle sue intenzioni uno dei pilastri: dell’azione ministeriale e di quella complessiva del governo. Da Edilizia Popolare , maggio-giugno 1962.
Tre diversi articoli, tutti estratti da Urbanistica n. 36-37, 1962, a partire dall’ampia introduzione al progetto di legge di Giovanni Astengo dal titolo Urbanistica in Parlamento, poi la Relazione illustrativa della proposta di legge, così come elaborata dalla Commissione presieduta da Sullo, e infine l’articolato del Progetto di Legge urbanistica, così come elaborato nel giugno 1962 e proposto all’attenzione del CNEL.
Un piccolo gruppo di note, dalla stampa di partito dell’aprile 1963, che documentano come la Democrazia Cristiana si dissocia dal suo ministro, iniziando a ufficializzarne l’emarginazione, prima politica e poi, gradualmente, anche personale (estratti dal volume di documenti a cura dello stesso Sullo, Lo scandalo Urbanistico , Vallecchi 1964).
Un altro estratto da Lo Scandalo Urbanistico, in cui Sullo argomenta (presumibilmente col senno di poi) la sua idea di Interesse pubblico e privato nei piani regolatori.
Due articoli dal periodico “ideologico” del PCI, Rinascita. Uno di Lucio Magri, del 24 agosto 1963, intitolato Una legge per le Città, in cui si confrontano le intenzioni di Sullo, gli equilibri nel suo partito, le posizioni della sinistra e gli interessi reali del paese. Uno di Aldo Natoli, del 25 aprile 1964, Parabola di Sullo, in cui la recensione dell’appena pubblicato Lo Scandalo Urbanistico diventa occasione per riflettere sulla contingenza politica italiana che ha determinato la radicalizzazione dello scontro e il naufragio della legge urbanistica.
Un estratto da Fondamenti di Urbanistica , di Edoardo Salzano, Laterza 2003 (2° ed. accresciuta) in cui si riassumono in una prospettiva storica La proposta di Fiorentino Sullo e la sua sconfitta.
L’on. Fiorentino Sullo, ministro dei Lavori pubblici nel primo governo di centro-sinistra, diretto dall’on. Fanfani, ha raccolto nel volume Lo Scandalo Urbanistico (Firenze, Vallecchi 1964) la documentazione del sorgere e del tramontare in seno alla DC delle illusioni riformatrici nel campo dell’urbanistica. È una parabola che inizia dal congresso di Napoli e dalla successiva formazione del governo Fanfani, che ha il suo corso più rapido e ascendente durante l’estate del 1962, raggiunge il punto più elevato alla fine di settembre, al Congresso ideologico della Democrazia cristiana a San Pellegrino e, subito dopo, inverte la propria direzione e precipita miseramente insieme, del resto, a tutto il castello programmatico del primo governo di centrosinistra.
Il 30 settembre 1962 l’on. Sullo, parlando a San Pellegrino non lesinava l’audacia delle sue affermazioni: “La legge urbanistica sarebbe più rivoluzionaria, non dirò della legge di nazionalizzazione dell’industria elettrica, che è proprio nulla rispetto a una seria legge urbanistica, ma persino della legge di riforma agraria”, ed individuando possibile una prossima soluzione aggiungeva: “Sarebbe veramente una grande vittoria per la Democrazia cristiana se non aspettasse altre legislature per porre a fuoco questo problema sotto la pressione di altre forze politiche”.
Non sappiamo fino a che punto l’on. Sullo, pronunciando queste parole, si cullasse nelle sue generose illusioni, ovvero intendesse, così, di esercitare una pressione sulle potenti forze che già si erano messe in movimento (e lui lo sapeva) per insabbiare lo schema di una nuova legge urbanistica che, durante l’estate, era stato approntato dalla Commissione di studio da lui stesso nominata. Questo schema costituiva allora, senza dubbio, il punto più avanzato cui era giunta l’elaborazione della cultura urbanistica, partita alla fine del ’60, dalla impostazione del “Codice dell’Urbanistica” del X Congresso dell’INU. Nel quadro dell’ordinamento regionale e integrata con la programmazione economica, la nuova disciplina dello sviluppo urbano era fondata su tre punti essenziali, annunziatori di una vera e propria riforma dell’assetto proprietario del suolo urbano: l’esproprio generalizzato, l’agganciamento delle indennità di espropriazione al prezzo dei terreni agricoli, l’introduzione del diritto di superficie. Sembra probabile che Sullo – le sue parole di San Pellegrino lo indicano – pensasse di giungere attraverso l’instaurazione del regime pubblicistico del suolo urbano e di un titolo di possesso precario di esso, ad una sorta di nazionalizzazione del settore. Dalla lettura attenta della sua prefazione e dal riscontro dei documenti raccolti nel volume risulta però in modo inoppugnabile che, mentre egli pronunciava le parole che abbiamo sopra riportate, aveva già rinunciato a parte del suo programma ed aveva avuto anche numerose occasioni di registrare segni non equivoci di resistenza ed opposizioni insuperabili. Anzitutto Moro, allora segretario della DC, si era opposto all’introduzione del diritto di superficie. Sullo, sia pure riluttante, aveva accettato di rinunziarvi. Ma ciò non era bastato. Come si sa, lo schema di legge non fu mai discusso dal Consiglio dei ministri: Fanfani si diceva d’accordo con il testo studiato e infatti le osservazioni tecniche della presidenza del Consiglio, riportate nel volume, non riguardano che minori questioni di dettaglio, senza toccare la struttura dello schema. Fanfani, a quel che dice Sullo, fece sempre riferimento ad una opposizione più generale di Moro, che funzionò come un vero e proprio veto e che colse come risultato il dirottamento dello schema di legge al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, dove esso doveva rimanere definitivamente insabbiato.
“ Invero – scrive Sullo a p. 15 della prefazione – nell’ottobre 1962 avevo ancora qualche illusione sull’iter della legge. Mi sembrava che convenisse al governo Fanfani almeno approvare in Consiglio dei ministri il disegno di legge. Certo, il Parlamento non avrebbe avuto il tempo per discutere il testo. E la legge sarebbe stata rinviata alla ventura legislatura. Nondimeno in sede governativa, si sarebbe potuto precisare sul piano politico il punto di vista del governo”.
Curiosa e patetica confessione. Dunque erano bastati pochi giorni dal convegno di San Pellegrino (30 settembre) perché Sullo fosse costretto ad abbandonare l’illusione che “ la Democrazia cristiana non aspettasse altre legislature per porre a fuoco il problema”. Ciò malgrado, egli si illudeva ancora che lo schema innovatore di legge urbanistica potesse diventare elemento qualificante del programma del governo e della politica di centro-sinistra, anche, è evidente, in viste delle elezioni ormai prossime.
Al Consiglio nazionale della DC, il 12 novembre 1962, Sullo aveva cercato di contrastare l’attacco doroteo condotto da Rumor, Colombo e Piccoli, diretto a bloccare il programma del governo relativo all’approvazione delle leggi per l’ordinamento regionale. Non mancò anche di fare un cenno alla legge urbanistica: “ Vi è sul tappeto una proposta di legge urbanistica. La DC la accetta? La rigetta? La emenda? Se manca la nostra iniziativa, gli altri colmeranno il vuoto” (dal resoconto del Popolo, 12 dicembre 1962).
Nessuna risposta ebbero questi angosciosi interrogativi. L’anno e mezzo trascorso da allora ci permette, stando nella favorevole posizione di chi non ha che da ricapitolare avvenimenti recenti, di constatare come le speranze dell’on. Sullo fossero completamente ingiustificate e potessero essere formulate solo perché egli non si rendeva conto di essere del tutto isolato all’interno del suo partito.
Egli non aveva ancora avvertito che il colpo d’arresto alla politica e “avanzata” del centro-sinistra, era stato già deciso e veniva solo consacrato in quel Consiglio nazionale per condurre alla liquidazione del programma del governo nel gennaio 1963 e ad una campagna elettorale nella quale la politica del centro-sinistra era ormai ridotta ad un nome vano. Era dunque fatale che, durante quella campagna elettorale, la DC nella fretta di sbarazzarsi di zavorra progressista, per ritrovare la grande massa dei suoi elettori di destra, gettasse a mare il ministro dei Lavori pubblici, per darlo in pasto agli squali della speculazione edilizia, schierati con il partito liberale. Raramente è capitato di vedere un caso come questo, di spregiudicato, meglio sarebbe dire cinico linciaggio di un uomo politico. Obbediente alle direttive di Moro, Sullo, nella seduta della Camera dei deputati del 23 ottobre 1962, aveva pur chiarito che il diritto di superficie “ poteva essere omesso” dalla legge. Ma ciò non bastò, perché la DC e il suo segretario Moro sentissero se non il dovere, almeno il bisogno di difendere e sostenere il ministro dei Lavori pubblici del governo in carica di fronte all’attacco furioso e demagogico della speculazione. Al contrario, egli fu pubblicamente sconfessato. Non si può fare a meno di fare un confronto con la condotta seguita dalla DC nei confronti di altri suoi esponenti, da Togni a Colombo a Jervolino, coinvolti e corresponsabili in gravissimi episodi di disordine amministrativo e tuttavia strenuamente difesi, e mantenuti a galla, costi quel che costi.
Ma Sullo, nel 1962, agli occhi del segretario dc, era colpevole di ben altro: leader di una corrente della sinistra dc, aveva avuto il torto di credere ingenuamente al contenuto rinnovatore del Congresso di Napoli e del programma del governo Fanfani; aveva voluto realizzare nel settore urbanistico una riforma al cui confronto, la stessa nazionalizzazione dell’energia elettrica sarebbe apparsa “proprio nulla” e ciò proprio nel momento in cui le forze moderate, neocentriste della DC, erano già passate al contrattacco, lanciando lo slogan “mai più nazionalizzazioni”. Sullo, sorpreso in contropiede, non poteva che finire in fuorigioco. Ciò era inevitabile, soprattutto per il modo con cui egli era giunto a farsi assertore della riforma urbanistica. La DC, come partito di governo del paese e della maggioranza dei comuni, aveva sempre dimostrato la più completa e opaca sordità di fronte ai problemi dello sviluppo urbano. Al contrario, più volte era apparsa direttamente compromessa, o addirittura protagonista degli scandali clamorosi della speculazione. Esemplare, il caso del comune di Roma. Tutta l’azione per la riforma urbanistica era stata condotta, per un decennio, dalle sinistre, comunisti in prima fila. Fu soltanto nel 1961 che l’on. Zaccagnini, ministro dei Lavori pubblici nel governo Fanfani “delle convergenze”, iniziò per la prima volta lo studio della riforma urbanistica. Ma tale studio si concluse con la redazione di un progetto di legge che era un passo indietro rispetto allo schema presentato alla fine del 1960 al congresso dell’INU. Esso fu seppellito senza cerimonie nella primavera del 1962, quando l’on. Fanfani presentò al Parlamento il programma del governo di centro-sinistra. A questo punto entrava in scena Sullo, neofita ed entusiasta di fronte ai problemi urbanistici. L’errore, il vero, grave errore di Sullo consisté, e consiste, nell’aver creduto di poter varare la riforma solo grazie all’aiuto di una commissione di saggi, di tecnici, di illuminati. Abbiamo già dato un giudizio positivo sul lavoro di quella commissione. Ma come poteva sperare Sullo che una riforma così complessa, che investiva il rinnovamento della struttura statale attraverso l’attuazione delle regioni; che presupponeva il varo della programmazione; che colpiva frontalmente gli interessi parassitari della proprietà fondiaria urbana – così intimamente collegata con certi gruppi dirigenti del partito dc e, soprattutto, con l’amministrazione di potenti istituti religiosi e della stessa S. Sede - , come poteva Sullo illudersi che una riforma simile sarebbe passata senza una dura lotta politica nel seno stesso del suo partito e del governo; senza una inevitabile scelta delle forze politiche capaci di sostenerla, prima ancora che nel Parlamento, nel pese!
Nelle 500 pagine del volume si cercherebbe invano un solo indizio che un barlume di tale consapevolezza abbia mai fugacemente illuminato i ragionamenti e l’azione politica dell’on. Sullo. Per questo, nell’autunno del 1962, egli non riusciva a capire le “ obiezioni teoretiche” di Moro e le esitazioni di Fanfani: per questo, nella campagna elettorale del 1963, lo sfrenato attacco scatenato contro di lui dalle “ grandi immobiliari” gli appare come una “ allucinazione generale”, che gli fa vivere la vita di ogni giorno in un “ tragico clima pirandelliano”.
In realtà egli, ingenuo apprenti sorcier, non poteva che divenire il capro espiatorio nel momento del riflusso centrista che scuoteva la DC. Con gelido cinismo, Moro, che pure aveva già ottenuto da lui la rinuncia al famigerato diritto di superficie, disponeva la pubblica dissociazione delle responsabilità della DC da quelle del suo ministro dei Lavori pubblici. Dopo il 26 aprile, a conclusione della vicenda, lo stesso Moro, nel compromesso della Camilluccia, proponeva a Nenni (che accettava) l’abbandono delle velleità riformatrici di Sullo e la rinuncia ad ogni azione innovatrice nel settore urbanistico.
La vicenda che risulta dalla documentazione raccolta da Sullo e dalla prefazione che la precede, in quanto espressione degli orientamenti politici prevalenti del gruppo dirigente della DC, alla luce degli avvenimenti che hanno portato alla costituzione del governo Moro-Nenni e all’esperienza dei cinque mesi, da allora trascorsi, non può che portare a preoccupanti considerazioni circa gli sbocchi della crisi attualmente in corso. Sintomatico e sconcertante in vista del Congresso della DC deve essere considerato l’ingresso dello stesso Sullo nella corrente unificata moro-dorotea, dove sono raccolti tutti i più convinti avversari della riforma urbanistica, cui si sono contemporaneamente associati uomini come Pella e Andreotti. Con questo passo si direbbe che Sullo abbia tratto dalla amara esperienza degli anni 1962-1963 la lezione peggiore, quella che toglie valore di protesta morale e politica alla sua denuncia e tende a ridurla a un mero espediente tattico nella lotta per il potere all’interno della DC.
Ciò segna anche l’inizio del suo tramonto come capo politico, forte di un certo margine di autonoma determinazione, e lo incammina sulla melanconica strada di quei notabili, di cui è così ricca la provincia democristiana.
La proposta del ministro Sullo
Autore della proposta che risolve alla radice il problema della rendita fondiaria urbana è Fiorentino Sullo ministro democristiano dei Lavori pubblici dal febbraio del 1962. Preso atto che “la stragrande maggioranza degli urbanisti non si dichiarava d’accordo” con lo schema elaborato dalla commissione insediata da Zaccagnini, ricostituisce la stessa commissione, integrandola con giuristi, economisti, sociologi[1].
Il disegno di legge Sullo è pronto nel giugno 1962. La riforma è impostata su basi completamente nuove ed originali. Per quanto riguarda i rapporti tra programmazione economica e pianificazione urbanistica, il progetto stabilisce che l’indirizzo e il coordinamento della pianificazione urbanistica debbono attuarsi nel quadro della programmazione economica nazionale ed in riferimento agli obiettivi fissati da questa. In attesa della costituzione degli organi che saranno preposti all’attuazione del piano economico è prevista l’istituzione di uno speciale comitato di ministri che provvede ad impartire le direttive.
La pianificazione urbanistica si articola, sia nella fase regionale che statale, agli stessi livelli e con gli stessi dispositivi previsti dal progetto Zaccagnini: piano regionale, piano comprensoriale, piano regolatore comunale e piano particolareggiato.
Il piano regolatore generale e quello comprensoriale - quando questo ha valore di piano generale - sono obbligatoriamente attuati per mezzo di piani particolareggiati, le cui prescrizioni hanno valore a tempo indeterminato e nel cui ambito il comune promuove l’espropriazione di tutte le aree inedificate (fatta eccezione per quelle demaniali) e delle aree già utilizzate per costruzioni se l’utilizzazione in atto sia sensibilmente difforme rispetto a quella prevista dal piano particolareggiato, nonché delle aree che successivamente all’approvazione del piano particolareggiato vengano a rendersi edificabili per qualsiasi causa.
Acquisite le aree, il comune provvede alle opere di urbanizzazione primaria e cede, con il mezzo dell’asta pubblica, il diritto di superficie sulle aree destinate ad edilizia residenziale, che restano di proprietà del comune. A base d’asta viene assunto un prezzo pari all’indennità di esproprio maggiorata del costo delle opere di urbanizzazione e di una quota per spese generali. Quando si tratta di aree richieste da enti pubblici operanti nel settore edilizio, da società cooperative aventi gli stessi fini, ovvero nel caso in cui le aree siano adibite ad utilizzazioni industriali, la cessione avviene a trattativa privata.
L’indennità di espropriazione è determinata, per i terreni non edificati e non aventi destinazione urbana prima dell’approvazione del piano, in base al prezzo agricolo; per i terreni non edificati, ma aventi già destinazione urbana, in base al prezzo dei più vicini terreni di nuova urbanizzazione, aumentato della rendita differenziale di posizione in misura non superiore ad un coefficiente massimo fissato dal comitato dei ministri, e infine, per i terreni edificati, in base al valore di mercato della costruzione.
In sintesi, lo schema Sullo modifica profondamente il regime proprietario delle aree: di proprietà privata resta soltanto una parte delle aree edificate, le altre aree - edificate o edificabili - passano gradualmente in proprietà dei comuni, che cedono ai privati il diritto di superficie per le utilizzazioni previste dai piani.
Il 14 luglio del 1962, la presidenza del Consiglio dei ministri - a cui Sullo aveva trasmesso il disegno di legge - comunica di “condividere in linea di massima i criteri informatori della nuova disciplina urbanistica” e muove solo osservazioni di natura tecnica. Del suo disegno di legge Sullo parla pubblicamente in più occasioni: al convegno ideologico della DC a San Pellegrino, nel settembre. a chiusura del dibattito parlamentare sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, in ottobre; ed al IX congresso dell’Inu, a Milano, nel novembre. Nessuna particolare reazione viene suscitata dalla pubblicità che gli urbanisti, e lo stesso Sullo, organizzano intorno alla proposta di riforma.
In attesa di un parere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), il Consiglio dei ministri, però, rinvia l’esame del provvedimento[2]. Ci si avvicina così alla scadenza della legislatura ed alle elezioni politiche della primavera del 1963.
È nell’aprile del 1963 (le elezioni sono fissate per il 28 aprile) che si scatena “lo scandalo urbanistico”: una furibonda campagna di stampa (in primo luogo“Il Tempo”, di Roma) contro il Ministro dei lavori pubblici accusato di voler togliere la casa agli italiani. È lo stesso Sullo che racconta:
“A casa mia, con un senso di sgomento e di smarrimento più che di curiosità, miei parenti stretti mi chiesero, anche essi, se volessi togliere loro davvero la casa. […] Ed io, confesso, non sapevo più come difendermi da una allucinazione generale: non bastava a difendermi il tentativo di spiegare gli errori giuridici degli oppositori, né il rammentare che in Parlamento, nell’ottobre 1962, avevo dichiarato che del diritto di superficie. Si sarebbe potuto fare a meno. Non c’era che una strada: spiegare al video a milioni di telespettatori la realtà e la fantasia. Ma questo non mi fu permesso. Invece, senza affatto consultarmi, mentre ero assente dalla capitale e con una comunicazione postuma alla mia segreteria di Roma, venne una doccia fredda; la dissociazione delle responsabilità del mio partito dalle mie. Fui sbalordito per l’oggettiva ingiustizia morale verso di me”[3].
Con una “dolorosa nota” del 13 aprile “Il Popolo” comunica che la DC dissocia la propria responsabilità dall’operato del ministro Sullo. “Se i lavoratori - commenta Sullo - non erano sufficientemente mobilitati a favore della legge, la mobilitazione dei proprietari di case era invece massiccia”
“Le grandi immobiliari trovarono terreno fertile nella primavera del 1963. E lo trovano ancora. La sociologia ci aiuta a individuare i loro alleati, che non sono immaginari. L’invenzione del pericolo della proprietà della casa fu l’arma più forte, ma non la sola. A parte l’allucinazione sulla pretesa rivoluzione del diritto di proprietà, bisogna riconoscere che il clima del “miracolo economico” aveva (ed ha) creato aspettative in tutti i proprietari potenziali di aree, anche periferiche e suburbane, soprattutto i più piccoli. E questi hanno reagito. Ora non c’è nulla di peggio che un sogno infranto. Ho ricevuto lettere, in questi mesi, che sono rivelatrici di un diffuso stato d’animo. Dalla Romagna, un cittadino si lagnava perché la legge urbanistica gli avrebbe “confiscato” un ettaro di terreno sul quale aveva sperato di costruire la dote delle figliole! Non ci si rende conto che il moltiplicarsi di questi “sogni ad occhi aperti” dei piccoli proprietari terrieri suburbani è incompatibile con altre richieste che gli stessi proprietari fanno allo Stato democratico, in quanto cittadini che aspirano, ad esempio, al diffondersi della scuola ed ad un più razionale sistema di sicurezza sociale. I “sognatori ad occhi aperti” sono tuttavia lottatori furibondi per la realizzazione del sogno, mentre i lavoratori che hanno bisogno dell’area a basso prezzo sembrano rassegnati all’attesa. E lottano debolmente per la legge urbanistica”[4].
Sullo resta ministro dei Lavori pubblici nel “governo ponte” presieduto da Leone nell’estate del 1963, ma alla costituzione del primo governo organico di centro sinistra viene sostituito dal socialista Pieraccini[5]. Negli accordi tra i partiti per la formazione del governo Moro, viene concordato che la riforma urbanistica deve assicurare la preminenza dell’interesse pubblico, attraverso l’acquisizione alla collettività delle plusvalenze fondiarie e la posizione di “indifferenza” dei proprietari rispetto alle scelte di piano. Su queste basi viene elaborato il disegno di legge Pieraccini: si conserva il principio dell’esproprio generalizzato, l’indennizzo però non è pari al prezzo agricolo ma è rapportato al valore di mercato del 1958. Il diritto di superficie è abolito e sono esonerati dall’esproprio le aree interessate da progetti presentati prima del 12 dicembre 1963. Mentre la proposta di legge cadeva insieme al governo, in tutta Italia vengono rilasciate una valanga di licenze edilizie.
Nella vicenda della riforma urbanistica aveva vinto in definitiva quello che Valentino Parlato, qualche anno dopo, definirà “il blocco edilizio”: un blocco sociale ed economico nel quale, attorno agli stati maggiori della proprietà fondiaria urbana, della grande proprietà immobiliare e del capitale imprenditoriale e finanziario (volta a volta alleati alle forze della rendita o in timido conflitto con loro), si aggregano le “fanterie” dei piccoli proprietari di case o aspiranti tali, dei risparmiatori, degli artigiani e dei lavoratori legati alla produzione edilizia[6].
[1] La commissione, presieduta dall’on. Sullo è costituita dal presidente di sezione del Consiglio di stato Roehrssen (vice presidente), dai giuristi Benvenuti, Giannini, Savarese e Rubino, dagli urbanisti Astengo, Piccinato e Samonà, dai sociologi Ardigò e Compagna, dai funzionari ministeriali Valle e Spanò. Segretari sono Mario D’Erme e Aurelio Prestianni. Cfr. F. Sullo, Lo scandalo urbanistico, Firenze, 1964, p. 287.
[2] “Sa Iddio come avvenne, invece, che in Consiglio dei ministri il testo del disegno di legge non giungesse mai. Io posso attestare che, in numerosi colloqui con me, Fanfani si dichiarò sempre personalmente favorevole al testo studiato, ma ogni volta concludeva esortandomi a convincere Moro, segretario politico del partito di maggioranza relativa, a fare opera di persuasione su Moro! Ed io rispondevo che avevo già accolto da Moro l’invito a rinunciare al diritto di superficie. E che altre obiezioni di fondo (prima del 28 aprile 1963) non c’erano state, da parte di Moro. Vincendo le mie esitazioni, Fanfani dispose l’invio del progetto al Cnel. Molti oppositori vollero vedere in questa disposizione un tentativo di affossamento. Espressi, nell’ambito parlamentare, opinioni opposte: si voleva spianare la strada al progetto evitando errori tecnici e soprattutto rassicurando implicitamente l’opinione pubblica che non si sarebbe ripetuto il dibattito-lampo (o dibattito-fulmine) della nazionalizzazione dell’energia elettrica. Rimase in me il dubbio sui “lunghi tempi” che furono consentiti al Cnel, me nolente, e sulla decisione (che neppure fu mia) di non discutere (anche a fine gennaio) il disegno di legge in Consiglio dei ministri con che si sarebbe lasciato, come Campilli suggeriva, al Cnel di fornire direttamente, come fu fatto per i disegni di legge agricoli, il parere alle Camere” (F. Sullo, cit., pp. 15-16). Il parere del Cnel, successivamente predisposto da Petrilli e Senin, è favorevole ai princìpi della proposta Sullo. Ivi, pp. 383-439.
[3] Ivi, pp. 17-18.
[4] Ivi, p. 21.
[5] “Avevo desiderio di rimanere ministro dei lavori pubblici per fare la legge urbanistica e per provare che le paure della primavera del 1963 erano grossolane: che si viveva in un clima rovente di passioni e di allucinazioni. Credevo di aver diritto a dimostrare non solo la buona fede, ma il mio realismo. E tuttavia, avrei cercato di non affossare i princìpi fondamentali della riforma. Altri non ha apprezzato sufficientemente gli aspetti morali di questa mia richiesta e le cose sono andate diversamente!” (Ivi, p. 24).
[6] Valentino Parlato, Il blocco edilizio, in “il manifesto”, nn.3-4, 1970. Ripubblicato in: “Lo spreco edilizio”, a cura di F. Indovina, Marsilio, Padova 1972.
La legge urbanistica
La legge più importante sarà la legge urbanistica, sulla quale vi sono tante attese nel Paese, e che, a mio avviso, vale quanto una riforma di struttura. Abbiamo avuto un rigoglio imprevisto di alcune nostre città; abbiamo un trasferimento continuo di gente che dalla campagna si addensa in grandi metropoli. La legge urbanistica del 1942 è giunta a vecchiezza senza essere giunta a giovinezza. Ha cominciato ad essere applicata negli anni 1953-1955 ed allora era già come un abito stretto per la struttura demografica del Paese. La legge urbanistica è studiata prima da una Commissione nominata dal mio predecessore onorevole Zaccagnini. Ho dovuto però, utilizzando in parte gli elementi di quella Commissione ed in parte immettendone i nuovi, far studiare di bel nuovo il problema alla luce di criteri nuovi da una nuova Commissione. Debbo ringraziare da questo banco tutti i valorosi docenti universitari, gli uomini pratici del diritto, della tecnica e dell'economia che hanno partecipato con tanta passione ai lavori della Commissione: in particolare i tre architetti che già facevano parte della precedente Commissione, Astengo, Piccinato e Samonà; l'economista Lombardini; i sociologi Compagna e Ardigò; i giuristi Giannini e Guarino. A tutti debbo rivolgere il più vivo ringraziamento, senza escludere naturalmente i valorosissimi funzionari e ausiliari dell' Amministrazione, come il Consigliere di Stato Roehrssen, l'avvocato dello Stato Savarese, il Presidente di Sezione Valle. Come il senatore D'Albora ha ricordato, la legge urbanistica in primo luogo deve essere configurata come una legge quadro nei confronti delle Regioni. É una necessità. Se è giusto che le Regioni abbiano il compito di definire la politica urbanistica, non si può consentire che tale compito . possa snaturarsi con lo stabilire un sistema di espropriazioni e di vincoli terrieri diverso dalla Sicilia alla Toscana e alla Lombardia. Il costituente, decentrando l'urbanistica, non ha inteso attribuire poteri che riguardano diritti costituzionali che non possono che essere uguali per tutti i cittadini italiani. Questi aspetti debbono essere chiariti nell'ambito di una legge-quadro a carattere unitario. Ma noi, senatore D'Albora - dico noi perchè come Presidente della Commissione, anche se l'ho presieduta soltanto all'inizio e alla fine, credo di avere avuto una parte nei lavori della Commissione - non abbiamo lavorato intorno a una legge la quale badi soltanto al futuro. Vi è una parte della legge che verrà attuata immediatamente a prescindere dalla istituzione delle Regioni. La legge dovrà funzionare dal momento in cui sarà approvata dal Parlamento: sia prima che le Regioni abbiano deliberato in materia, sia successivamente, quando le Regioni abbiano finalmente deliberato. Vi è una parte che ha carattere transitorio. Bisognerà fare in modo che si eviti la speculazione terriera e nello stesso tempo attenui la sperequazione tra i proprietari. Oggi un proprietario vincolato deve pagare le imposte e un proprietario non vincolato tende a costruire fino a livelli impossibili per ottenere la massima valorizzazione del suolo. Questo è elemento di perturbazione ai fini di un'articolazione razionale della città. Fino a quando ci sarà la corsa di chi vuole utilizzare il suolo per ottenere il massimo in contrasto con chi invece si trova ad essere sfortunato perchè vincolato, la città non si potrà costruire organicamente. O si adotta il sistema del comparto, che però occupa determinati aspetti negativi, o si adotta il sistema proposto dalla Commissione per cui i Comuni comprano, lottizzano, urbanizzano e poi vendono all'asta anche a privati.
Non voglio anticipare una discussione. Desidero soltanto assicurare che la legge è stata studiata con accuratezza, e non con intenti oppressivi nei confronti di questa o quella classe, di questa o quella categoria, ma con la visione realistica di chi vuole che le città si accrescano in maniera organica e la corsa alla speculazione cessi. Una armonica crescita delle città veramente tutti desideriamo. Il Parlamento italiano voglia favorirla con una politica urbanistica coerente.
Lo schema predisposto consta di 87 articoli suddivisi in 5 titoli.
Alcune norme, quelle di carattere generale, stabiliscono i rapporti tra la programmazione economica nazionale e la pianificazione urbanistica, affermando il principio della preminenza della programmazione economica nazionale e della necessità che la pianificazione e l'attività urbanistica si adeguino a tutto ciò che forma oggetto del programma economico. Fino a quando non sarà stato costituito apposito organo di programmazione, le direttive saranno formulale da un Comitato di Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio.
La pianificazione urbanistica viene distinta in 4 gradi dipendenti l'uno dall'altro e cioè: piani regionali, piani comprensori, piani regolatori generali comunali e piani particolareggiati.
Tale suddivisione, pur non discostandosi gran che dalla ripartizione attuale, si differenzia sostanzialmente da essa sia perchè il contenuto e l'efficacia dei vari piani sono profondamente aggiornati, sia perché, per taluni di essi, l'adozione diventa obbligatoria.
Naturalmente, diversi sono gli organi preposti all'attuazione ed all'approvazione dei quattro tipi di piano a seconda che essi vengano adottati prima o dopo l'attuazione delle regioni e la emanazione, da parte di queste, delle relative leggi urbanistiche.
Si è previsto, in ogni caso, che i piani regionali, i quali hanno indubbiamente un contenuto che supera quello meramente urbanistico e si permea di notevoli addentellati economici, vengano approvati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Per la disciplina delle aree fabbricabili nelle zone di espansione urbana e della conseguente attività edilizia, lo schema prevede nell'ambito di ciascun piano particolareggiato, obbligatorio per i Comuni espressamente individuati in sede di piano comprensoriale, l'espropriazione di tutte le aree edificabili da parte del Comune, il quale è tenuto ad attuare sulle stesse, prima di devolverle all'utilizzazione edilizia, le opere di urbanizzazione primaria. Successivamente il Comune procede alla vendita all'asta dello ius ad aedificandum sulle aree urbanizzate: con possibilità, peraltro, di cessione diretta di tale diritto ad Enti che operano nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Il problema finanziario connesso a tale disciplina è risolto col sistema del pagamento dell'indennità di espropriazione, che, al pari della materiale apprensione dei beni, può essere differito entro un anno; tale termine appare sufficiente per mettere in moto un meccanismo di rotazione delle somme occorrenti ai Comuni.
L’attuazione del sistema è altresì garantita da una speciale gestione urbanistica prevista per i Comuni, i quali dovranno farvi affluire ed attingervi, rispettivamente, i prezzi di vendita ed i prezzi di acquisto dei suoli.
Infine, altre norme fondamentali previste nel progetto riguardano l'esclusione di qualsiasi deroga in materia edilizia rispetto ai piani approvati ed ai regolamenti edilizi comunali; nonché una più drastica normativa sanzionatoria per l'ipotesi di violazione alle concesse autorizzazioni a costruire, la quale può arrivare sino alla confisca delle parti costruite in difformità. Il disegno di legge dovrà essere discusso con i competenti Ministeri e portato allo esame del Consiglio dei Ministri. In questa fase ogni suggerimento ed ogni critica, anche della stampa e degli organismi specializzati e delle associazioni interessati, saranno attentamente vagliati.
Il secondo semestre del ‘62 è caratterizzato, per quanto riguarda l’urbanistica nel nostro Paese, da due fatti fondamentali: l’entrata in vigore della legge 18 aprile 1962, n. 167, e la ultimazione del progetto per la nuova legge urbanistica.. compilato dalla commissione nominata e presieduta dal Ministro Sullo.. e sottoposto in questi mesi al parere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.
La legge 167 sull’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare rappresenta 10 sbocco, in vero assai tardivo.. di un disegno di legge che, presentato dapprima dal Ministro Romita, quindi riportato in Parlamento dal Ministro Togni, ha impiegato sette anni per superare il vaglio di due legislature e di varie commissioni parlamentari. Confrontando il testo finale con quello iniziale c’è da domandarsi se gli emendamenti apportati durante il lungo iter costituiscano effettivi e sostanziali benefici per il pubblico interesse, tali da giustificare la lentissima gestazione, o se non sarebbe stato assai più efficace, per la finalità stessa della legge, approvare celermente il testo primitivo.
Non si deve infatti dimenticare che la proposta di legge è uscita originariamente dal Ministero dei Lavori Pubblici quando i Comuni già si trovavano in difficoltà per il reperimento di aree a basso costo, in quantità ed ubicazione adeguata, per l’edilizia statale promossa, a getti discontinui e sovrapposti, dalle numerose leggi allora operanti, quando l’INA-Casa, esaurito il programma del primo settennio, stava ormai impostando quello per il secondo periodo settennale, quando l’esigenza del coordinamento operativo dell’edilizia statale e sovvenzionata aveva già trovato una sua embrionale espressione con la formazione del CEP (1954), quando, cioè, era facilmente constatabile che la legge stessa, anche se resa immediatamente operante, sarebbe giunta in ritardo, tenuto conto dei tempi tecnici di attuazione, rispetto al momento di massima piena degli stanziamenti statali.
La stessa durata ristretta del piano e la procedura d’urgenza, istituita per la sua redazione, pubblicazione ed approvazione, erano misure eccezionali, rispondenti a questa esigenza di bruciare le tappe, di ricuperare il tempo perso, di stimolare indirettamente la formazione dei piani comunali generali, per garantire ai vari stanziamenti statali, sia pure nella loro fase discendente e finale, una possibilità di corretto impianto urbanistico a costi ragionevoli.
L’appoggio dell’INU al disegno di legge Romita volle allora significare il consenso ad uno strumento semplificativo delle procedure normali, adeguato a situazioni contingenti, e che, se pure imperfetto (basti ricordare la clausola della variante automatica dei piani regolatori per mezzo del piano settoriale dell’edilizia popolare, fin dall’inizio denunciata come inaccettabile) poteva tuttavia servire di innesco per la redazione dei primi piani particolareggiati, facilitandoli con la riduzione del temuto piano finanziario ad una semplice previsione di spesa, e per la formazione di una prima rata di demanio comunale, con procedura abbreviata rispetto all’art. 18 della legge urbanistica.
Queste prospettive sono cadute nel nulla a causa, come è noto, dell’infausto abbinamento, in sede parlamentare, fra una legge elementare, come quella a favore dell’acquisizione delle aree fabbricabili per l’edilizia popolare, ed una complessa e controversa come quella per l’imposta sulle aree fabbricali, abbinamento che, anziché a favore, si è in definitiva risolto tutto a danno della prima.
L’aver richiamato le situazioni di partenza e d’arrivo della legge 167, che nasce, come era del resto prevedibile, scompagnata dalla sua gemella adottiva, ci è parso utile non tanto come motivo di rimpianto, quanto per cercare di capire quale possa essere oggi la funzione di questa legge nel quadro della mutata situazione odierna: ad esaurimento di quegli stessi fondi, per il più razionale e spedito utilizzo dei quali era stata predisposta, ma anche alla vigilia di un nuovo programma decennale, ancora in elaborazione, di investimenti statali nel settore dell’edilizia).
Si può cosi amaramente constatare che la 167 giunge talmente in ritardo rispetto ai programmi di edilizia statale e sovvenzionata degli anni ‘50, da essere per lo meno in anticipo rispetto a quelli degli anni ‘60.
A parziale compenso del tempo e delle occasioni perdute abbiamo oggi una formulazione indubbiamente più estensiva di quella originaria, nella finalità e nei mezzi della legge. Due sono le innovazioni sostanziali: la estensione della applicazione alla edilizia economica, sia sovvenzionata che di libera iniziativa, ed il riferimento, per l’indennità di espropriazione, al valore che / i terreni avevano due anni prima del piano, con la stabilizzazione dodecennale di tale valore.
Sull’utilità sociale della prima non vi possono essere dubbi: che a fruire dell’acquisto a prezzo di costo delle aree espropriate, pianificate ed urbanizzate, siano non solo gli Enti statali e parastatali, ma anche cooperative ed Enti statutariamente privi di scopo di lucro e che, inoltre, agli stessi benefici possano accedere, entro certe condizioni e misure, anche i privati è certo un fatto positivo, che apre e sviluppa te finalità stesse della legge ed incita le Amministrazioni locali a darsi un programma edilizio decennale.
Non si possono tuttavia tacere alcune perplessità sul blocco dodecennale del prezzo dei terreni ricadenti nel piano. Originato dal lodevole proposito di frenare l’ascesa dei prezzi delle aree edificabili, particolarmente acuta negli ultimi anni, e di garantire all’edilizia economica e popolare l’acquisto di aree scevre da rialzi speculativi, stabilizzando al tempo stesso i prezzi in modo da consentire una più tranquilla attuazione degli investimenti, il congegno escogitato appare tuttavia non immune da difetti e tale da creare situazioni di grave sperequazione. Basta infatti considerare che, quando il piano blocca terreni esterni non ancora rivalutati da operazioni speculative o da lottizzazioni, si determina all’istante una situazione di sperequazione fra terreni bloccati e terreni liberi, sperequazione che diventa particolarmente acuta ed evidente nel caso di proprietà contigue, l’una inserita nel piano (con utilizzazione rinviata magari agli ultimi elenchi annuali), e l’altra di libera utilizzazione, che fruirà, nel frattempo, degli incrementi di valore per le opere di urbanizzazione che il Comune è obbligato a provvedere a servizio dell’ area vicina.
Ne è da escludere, infine, il caso in cui il blocco dei prezzi giochi a sfavore della collettività, premiando paradossalmente gli alacri lottizzatori col garantir loro una stabilità di alti prezzi artificiosamente raggiunti; situazione, questa, tutt’altro che improbabile per i terreni siti nelle frangie semi-urbanizzate delle città, dove il gioco speculativo di questi ultimi anni ha ottenuto i massimi incrementi.
Infine, non sono da poco anche i motivi di perplessità di ordine strettamente operativo. Nei Comuni obbligati a redigere il piano per l’edilizia economica e popolare, e cioè in tutte le grandi città, la presentazione obbligatoria e simultanea, in limiti di tempo eccezionalmente brevi, di tutti i piani particolareggiati, relativi alle aree prescelte per una previsione decennale, non solo comporta comprensibili difficoltà redazionali, con tutti gli inconvenienti di una elaborazione affrettata ed eseguita per parti, ma anche il rischio di condizionare e di cristallizzare per un decennio le direttrici di espansione per l’intera città a mezzo di un piano settoriale troppo precipitosamente formato.
I prossimi mesi ci diranno se e quanto erano giustificate queste apprensioni: per intanto segnaliamo che al 15 di novembre, data di scadenza dei 180 giorni fissati dalla legge per la redazione dei piani ai Comuni con oltre 50.000 abitanti 0 capoluoghi di provincia, e che interessano in complesso circa 20 milioni di cittadini italiani, un numero limitatissimo di piani sembra giunto a compimento poiché la maggior parte dei Comuni ha chiesto la proroga.
Il fatto è che la 167, perso il primitivo carattere di legge congiunturale a tempi brevi in funzione di precisi stanziamenti per l’edilizia statale e sovvenzionata, ha oggi assunto una ben più impegnativa funzione di obbligatoria formazione di piani particolareggiati per una rilevante aliquota dell’espansione residenziale; senonché a questa nuova dimensione, mentre si pone come elemento di rottura dell’immobilismo amministrativo, essa rivela al tempo stesso una intima fragilità, ne si dimostra in grado di risolvere i problemi e le contraddizioni che essa stessa suscita.
In definitiva, la 167 fornisce una ulteriore testimonianza sulla insufficienza delle soluzioni settoriali ed un’altra prova della improrogabile esigenza di una visione globale, quale solo la nuova legge generale urbanistica è in grado di prospettare.
La presentazione ai Ministeri interessati ed al CNEL della proposta di legge urbanistica che porta la firma del Ministro Sullo ha dato esca ad accese discussioni, sollevando opposizioni e consensi: in articoli di giornali e di riviste [1] si è giunti a tacciare la proposta di inefficienza e di incostituzionalità., accusandola di condurre alla paralisi edilizia assoluta, di favorire la corruzione e la persecuzione politica e di mirare all’annientamento della proprietà. Privata.
Quanto queste accuse siano fondate e legittime, e se siano mosse da una effettiva e disinteressata preoccupazione del bene pubblico o non piuttosto dalla trasparente difesa di ben precisi interessi di parte, non è difficile constatare purché si esamini con il dovuto distacco il testo della proposta che pubblichiamo nella sua versione integrale [2].
Per comprendere il disegno nella sua interezza occorre intanto tener presente che la proposta costituisce, essa stessa, una revisione del testo elaborato dalla Commissione interministeriale insediata dal Ministro Zaccagnini [3], revisione resasi necessaria per gli impegni assunti dal Governo di centro-sinistra in relazione alla programmazione economica ed alla istituzione delle Regioni. Orientamento, questo, destinato ovviamente ad incidere fortemente ed in modo definitivo sul contenuto dei piani, sulle procedure di formazione e di attuazione e sugli organi ad esse preposti e che le recenti decisioni governative in materia regionale [4], fanno ormai ritenere di imminente attuazione, rendendo pertanto inattuali quelle soluzioni a carattere unicamente interlocutorio e compromissorio in materia regionale che avevano informato il testo della Commissione Zaccagnini.
La proposta della nuova legge urbanistica, conformata per espressa direttiva del Ministro Sullo come “legge cornice”, appare oggi, non solo perfettamente aderente ai più recenti sviluppi del programma del governo, ma anche cosi tempestiva da poter offrire immediatamente un primo e basilare contenuto per l’attività normativa ed amministrativa delle istituende Regioni. Anche la stretta correlazione fra pianificazione urbanistica e programmazione economica, esplicitamente affermata dalla proposta di legge e chiaramente individuata negli scopi e negli organi, non sotto specie di subordinazione dell’una all’altra forma di pianificazione, ma come atto continuo di intesa fra i responsabili della vita pubblica nazionale e regionale, pone il disegno di nuova legge urbanistica come uno degli strumenti più attuali e più espansivi dell’attività economica e dell’intervento pubblico. Cosicché i piani urbanistici ai vari livelli e, di conseguenza, i procedimenti per la loro formazione, approvazione ed attuazione assumono nel processo di ammodernamento dell’ordinamento statale, sempre più il carattere di strumento fondamentale per la scelta democratica degli interventi pubblici e privati e per la loro corretta e razionale organizzazione spazio-temporale, e si rivelano sempre più indispensabili, quanto più accelerato e complesso diventa il ritmo di sviluppo economico e quanto più si estende il decentramento responsabile sul terreno delle autonomie locali.
Su questo punto di partenza non dovrebbero ormai esservi dubbi, ma giova tenerlo ben presente, per comprendere le varie dosature del contenuto dei piani. In sede nazionale il contenuto economico è preminente, in sede regionale l’economico e l’urbanistico si equilibrano, in sede comprensoriale il contenuto urbanistico prevale su quello economico, pur ancora ben presente, in sede comunale l’urbanistico è decisamente dominante. Il contenuto economico prevale per sua natura al vertice, s’interseca a metà strada con l’urbanistico e si affievolisce alla base, perché le scelte economiche reclamano una ampiezza di prospettiva ed una visione globale che sfuoca e svanisce man mano che si scende alla localizzazione territoriale, dove le scelte economiche ammettono spesso ampi gradi di libertà, mentre le scelte urbanistiche traggono la loro ragione d’essere proprio dalle particolarità territoriali: sono acutamente a fuoco alla base, sul terreno, ma diventano via via più sfumate ed approssimate man mano che i territori considerati si ampliano, ammettendo alla scala regionale e nazionale un maggior numero di alternative. La esatta compenetrazione dei due contenuti ai vari livelli si presenta dunque come elemento innovatore della legislazione e come fattore chiarezza e di propulsione nel processo deliberato delle varie Amministrazioni pubbliche.
Passando ora alla materia più strettamente urbanistica e non potendo ovviamente toccare tutti gli aspetti, ci limiteremo a coglierne alcuni essenziali, sia di carattere procedimentale, sia di carattere sostanziale.
Tra i primi è da illustrare brevemente la portata dei piani comprensoriali, cosi come configurati dal disegno di legge.
L’organo per la pianificazione comprensoriale è definitivamente il Consorzio dei Comuni interessati, i quali possono demandare al Consorzio stesso alcune loro funzioni urbanistiche. Il piano comprensoriale, che è essenzialmente un piano territoriale, funge anche da piano regolatore generale nei territori dei Comuni non tenuti alla sua formazione: da esso è quindi possibile discendere direttamente alla formazione dei piani particolareggiati, anche in Comuni non dotati di P.R.G. Con questo accorgimento si potranno conseguire notevoli risultati di snellimento procedurale e di rapido intervento localizzato, particolarmente utili nei piccoli Comuni privi di attrezzatura tecnica; inoltre lo stesso esercizio collegiale dei poteri di pianificazione, garantendo il reciproco controllo, dovrebbe agire da stimolo per l’espansione delle responsabilità e per la rottura delle visioni campanilistiche.
Alla tendenza spontanea, centripeta e congestionatrice, delle aree metropolitane potrebbero, in questo clima di rinnovamento, contrapporsi, con concreta possibilità di successo, le nuove tendenze di proiezione dell’urbanizzazione in una campagna organizzata.
Venendo ora all’esame delle norme relative alle limitazioni dell’uso della proprietà del suolo urbano, che costituisce il problema di fondo di ogni legislazione urbanistica, occorre rilevare che la proposta di legge è orientata ad eliminare, ed in ogni caso attenuare, nel limite del possibile, il processo delle multiple e successive sperequazioni che ogni forma di piano, che definisca e prescriva destinazioni d’uso del suolo, necessariamente determina nei confronti delle singole proprietà.
Com’è noto, il processo avviene, concettualmente, per gradi: alla prima scelta delle determinazioni d’uso per grandi classi, che discrimina sostanzialmente aree cui sono attribuite, o no, utilizzazioni urbane, ne subentra una seconda, in cui le grandi classi si suddividono in sottoclassi: le zone residenziali si articolano per differente indice di edificabilità ( spesso con un ventaglio di valori estremamente ampio) , quelle infrastrutturali in una serie, assai varia, di usi, determinando situazioni di accentuata sperequazione non solo nei valori, ma anche nella disponibilità stessa delle aree.
A questa seconda serie di sperequazioni se ne aggiunge una terza, spesso trascurata ma non meno reale, che riguarda il computo dell’indennità per le aree destinate a scopi o servizi di utilità pubblica e per le quali è ammesso, dalle leggi operanti in materia, il procedimento di espropriazione con differenti criteri di determinazione e con procedure più o meno lunghe, faticose e farraginose, che creano difficoltà non indifferenti agli Enti esproprianti, e disparità di trattamento nei confronti degli espropriati: buon’ultima la 167.
La legge urbanistica vigente, in tema di sperequazioni si limita ad affermare genericamente la non indennizzabilità dei vincoli di zona. Il principio, se applicato alla prima operazione di classamento fra suolo urbano e non urbano, è evidentemente accettabile, perché tale discriminazione dovrebbe sempre rispondere ad esigenze e scelte di esclusivo carattere superindividuale; il terreno agricolo, non modificando in perdita la sua destinazione d’uso attuale (salvo i casi, ben rari, di una limitazione anche di tale uso), non è quindi suscettibile di indennizzo. Il principio è in definitiva pacifico e lo si ritrova in tutte le legislazioni estere.
Senonché se si ammette che l’uso’urbano sia fonte di lucro, con valori proporzionali all’uso e commisurabili con i parametri della destinazione dell’intensità di fabbricazione e della giacitura, è inevitabile che ai margini della città, sulla linea di demarcazione urbano-non urbano, si scatenino le lotte e che, secondo gli elementari e secolari principi di tattica, la lotta tenda a spostarsi dalla linea di demarcazione per esser portata il più estesamente e profondamente possibile nelle retrovie: le lottizzazioni extraurbane confermano ampiamente questo stato di cose. All’interno della linea di demarcazione urbana non sono da meno le lotte intestine per l’ aggiudicazione di una redditizia destinazione d’uso o per l’elevazione degli indici di edificabilità. È una situazione ben nota, che intorbida la redazione dei piani, esplode nelle osservazioni in sede di pubblicazione, e sfocia in pressioni di ogni genere. Contro queste aggressioni dall’esterno e dall’interno, le Amministrazioni pubbliche sono oggi impotenti per carenza di legge.
Si è più volte affermato nei congressi, che si sarebbe usciti da questa situazione solo quando si . fossero resi i proprietari indifferenti al piano; ma non facile si presentava la soluzione.
Le proposte avanzate in questo campo, alla ricerca di sistemi riequilibratori, basati a volte su imposizioni fiscali proporzionate agli incrementi conseguiti o contemplanti compensazioni monetarie fra plus e minus valori creati dal piano, o, ancora, impostati sulla perequazione dei volumi edificabili, quale quello proposto dal nostro Istituto [5] e che la Commissione Zaccagnini aveva accettato, hanno rivelato, ad un esame più approfondito, difficoltà pratiche che ne hanno consigliato l’ applicazione generalizzata.
Infatti, come ha recentemente detto il Ministro Sullo alla Camera parlando della proposta di legge in sede di approvazione del bilancio dei LL.PP., “ l’introduzione di una imposta sulle aree fabbricabili ha la caratteristica di ridurre le diversità, senza eliminarle, perché è intrinseco allo stesso concetto di imposta di non costituire una confisca” [6]. La compensazione monetaria è applicata in paesi ( come nella Germania federale) in cui vige la denuncia annuale del valore delle aree e dove l’Amministrazione pubblica si riserva il diritto di prelazione delle aree al prezzo denunciato. La ‘perequazione dei volumi sarebbe un istituto nuovo applicabile solo in sede di piano particolareggiato, necessariamente planovolumetrico, che non risolverebbe quindi le situazioni di saldatura o di conflitto tra piano e piano e che richiederebbe inoltre la istituzione di complessi e costosi servizi amministrativi. Infine, nessuno di questi sistemi è in grado di risolvere anche e contemporaneamente il problema dell’acquisizione delle aree per i pubblici servizi, secondo un criterio equo ed unificato.
La soluzione prospettata tende a risolvere contemporaneamente tutti questi problemi. “I criteri ai quali si ispira il progetto di legge predisposto sotto la mia presidenza - ha dichiarato il Ministro - si possono cosi riassumere:
a)procurare la certezza che i compilatori dei piani urbanistici nell’assolvere questo delicatissimo compito abbiano di mira esclusivamente gli interessi pubblici; liberare le autorità amministrative ed i tecnici urbanistici dalle pressioni degli interessi privati settoriali; rendere possibile una pianificazione rapida, efficiente, che sia adeguatamente elastica e possa essere coordinata con le esigenze di sviluppo economico dell’intera collettività;
b)consentire che i Comuni ed i soggetti pubblici interessati acquisiscano ad un prezzo equo le aree che siano indispensabili per i servizi pubblici e sociali; liberare cioè i Comuni dalla schiavitù rappresentata dagli insostenibili oneri finanziari attuali;
c)porre tutti i proprietari, in relazione agli effetti della legislazione urbanistica, su un medesimo piano di parità; impedire che la costruzione della città si traduca per gli uni in un danno, per altri in un enorme vantaggio;
d)semplificare al massimo i servizi urbanistici e contenerne il costo di gestione”.
Il sistema adottato dall’acquisizione preventiva delle aree e della loro urbanizzazione è, d’altra parte, quello stesso dell’art. 18 della legge urbanistica, e quello della 167, entrambi generalizzati e migliorati per ciò che concerne il criterio di valutazione dell’indennità di esproprio.
Con la generalizzazione cadono le sperequazioni residue tra aree di piano ed aree marginali e con il criterio di valutazione unificato scompaiono le sperequazioni derivanti dagli scopi della espropriazione, oggi esistenti per la pluralità di leggi al riguardo e che costituiscono una vera distorsione giuridica; diventa superfluo il criterio del blocco dodecennale istituito dalla 167 e cade infine ogni discriminazione di trattamento a seconda della dimensione dei Comuni.
Se si riflette poi alla estensione che l’applicazione della I67 sta assumendo nelle periferie delle grandi città ci si rende conto che l’urgenza di ristabilire un criterio unico ed equitativo è ormai indilazionabile.
L’accettazione del principio generalizzato dell’ acquisizione ed urbanizzazione preventiva delle aree di espansione porta alla conseguenza fondamentale ed innovatrice di conferire al Comune il compito e la responsabilità diretta e democraticamente controllata del processo di urbanizzazione.
Con tale attribuzione di poteri ed oneri la espansione urbanistica non sarebbe più, come oggi accade, subita passivamente dai Comuni che, anche quando sono dotati di piano generale approvato, sono costretti a consentire l’edificazione ovunque sia proposta ed a correre quindi dietro a voleri, capricci ed artifici dei singoli, per dotare qua e là le varie aree con strade e servizi, con uno sparpagliamento di mezzi che rende sempre insufficiente l’intervento comunale. Cesserebbe quindi nelle grandi città ogni manovra, oggi impudentemente giocata, per attirare i servizi in questa o in quella zona, per ampliare o restringere l’offerta di aree, a seconda del maggior lucro che si può trarre dall’operazione: cesserebbe una impari lotta, in cui il Comune non può che essere soccombente di fronte all’astuzia dei singoli.
Cadrebbero pure, di conseguenza, le varie iniziative di lottizzazione, sia effettive, sia fittizie o di comodo, che compromettono ormai ogni razionale utilizzazione di suolo periferico o esterno alle città grandi e piccole. E cadrebbe anche definitivamente il sistema delle convenzioni, che noi stessi anni addietro, in carenza di norme di legge, abbiamo illustrato e caldeggiato, ma che all’atto pratico si è dimostrato uno strumento discontinuo e insufficiente e, in definitiva, inadatto ad una generalizzazione.
Discontinuo e insufficiente perché, in assenza di norme sulla dotazione di opere di urbanizzazione primaria, non vi è stata unicità di indirizzo nella attribuzione degli oneri e nella consistenza delle opere stesse, con pochi casi di esemplare adempimento contro una maggioranza di palesi inadempienze. È ben vero che la materia potrebbe essere disciplinata con norme che stabiliscano rigidamente la consistenza e i tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione, come avviene, ad esempio, in Francia [7]; ma gli abusi che di questo istituto stanno oggi compiendosi in vari Comuni.. con la richiesta di contropartite in natura o addirittura in denaro, sconsigliano di proseguire oltre su questa via. La lottizzazione convenzionata, anche se regolata da norme generali, resterebbe pur sempre un’operazione privatistica, tendente a dilagare sul territorio ed a contrastare le scelte razionali dettate da considerazioni sopraindividuali, scoprendosi come una nuova, se pur intelligentemente mimetizzata, forma di pressione che verrebbe ad influenzare negativamente la distribuzione territoriale e l’entità delle opere di urbanizzazione generale.
La forma di acquisizione e di urbanizzazione preventiva, infine, si pone come l’unica seria garanzia che si possa avere sia nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni, che solo con questo strumento saranno in grado di calibrare effettivamente le aree occorrenti per i vari usi residenziali.. infrastrutturali e di lavoro, istituendo una gestione autonoma ed in partita di giro, sia nei riguardi degli utenti che dai difensori ad oltranza degli interessi precostituiti vengono sistematicamente ignorati.
Né i sistemi vigenti di libero mercato delle aree edificabili dentro o fuori dei P.R., né il sistema, sia pure razionalizzato e codificato, della lottizzazione convenzionata sono infatti in grado di fornire una adeguata garanzia agli utenti, obbligati oggi ad accettare aree lottizzate, ma non servite, o servite tardi e male.
E poiché le città si dovrebbero costruire non per il lucro dei proprietari di aree, ma per essere usate dagli abitanti, parrebbe che, anche a parità di sacrifici e di vantaggi, sia pubblici che privati, dovrebbe pur sempre prevalere quel sistema che offra serie garanzie di efficienza per gli abitanti.
Non è possibile evidentemente illustrare ora tutti gli aspetti della proposta di legge, su cui avremo ancora occasione di tornare più d’una volta, seguendone le vicende parlamentari.
Ma non possiamo non segnalare all’attenzione dei lettori almeno quel gruppo di norme che riguarda le opere di risanamento.. che per la prima volta vengono sistematicamente proposte e che interessano una gran parte del patrimonio edilizio ed urbanistico nazionale; sarà sufficiente notare che per le operazioni di rinnovamento urbano e per quelle di risanamento conservativo dei centri storico-artistici ed ambientali è richiesta, in prima istanza.. l’azione diretta dei proprietari degli immobili.
La legge non si propone cioè una compressione o un annientamento della proprietà privata, ma.. al contrario, una espansione dell’intervento privato. Sgombrato il campo dagli ostacoli e dai freni dell’urbanizzazione, innalzati oggi dalle proprietà frantumate e dalle lottizzazioni estensive, inserito il Comune come interr1zediario fra i primitivi proprietari ed i cessionari, il terreno urbanizzato si presenta libero e predisposto per l’impresa edilizia e per l’accesso di chi aspira ad edificarsi la casa o ad erigere un impianto di lavoro.
Si apre cioè la possibilità per tutti, privati ed enti pubblici, di realizzare ordinatamente l’espansione ed il rinnovamento urbano e l’organizzazione civile della campagna.. in forme razionali e seno sibili, non più condizionate e compresse da moventi extraurbanistici.
Non è una prospettiva da poco ed il prossimo futuro ci dirà se il Paese è maturo per questasvolta decisiva.
[1]Fra i vari sono da citare: Giornale dei Costruttori, n. 37, 20 settembre 1962; Rivista Giuridica dell'Edilizia, luglio-agosto 1962.
[2]Il testo, pubblicato per la prima volta e senza autorizzazione, su Documentazione Italiana, conteneva infatti errori ed ommissioni.
[3]La prima commissione interministeriale per la riforma della legge urbanistica, nominata dal Ministro Togni ed insediata dal Ministro Zaccagnini il l0/12/1960, aveva ultimato i propri lavori nell'agosto del 1961 e formalmente consegnato il testo definitivo il 26 settembre 1961.
La seconda commissione per la riforma delle legge urbanistica, nominata e presieduta dal Ministro Sullo è stata insediata il 28 marzo 1962 ed ha presentato ufficialmente il testo finale il 12 giugno scorso.
Di entrambe hanno fatto parte, come membri dell'INU, i professori Giovanni Astengo, Luigi Piccinato e Giuseppe Samonà.
[4]Approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, di quattro disegni di legge concernenti la costituzione delle Regioni a statuto ordinario: Roma, 16 novembre 1962.
[5]Art. 55 della “Proposta di legge generale per la pianificazione urbanistica”.
[6]Dal testo del discorso del Ministro Sullo stralciamo il seguente passo di importanza basilare perla comprensione della proposta di legge: “Nei confronti di istituti quali la perequazione dei volumi o la imposizione sulle aree fabbricabili sono poi da aggiungersi due critiche di fondo, che ne dimostrano la limitata utilità.
La prima è che gli istituti stessi, pur riducendola, lasciano tuttavia che continuino a sussistere in una sensibile misura la disparità di trattamento e, con essa, il conflitto di interessi. La perequazione, come si è detto, non elimina le differenze tra l'una e l'altra zona; l'imposta sui fabbricati assorbe solo una parte del plusvalore provocato dalle misure urbanistiche. Ancora più rilevante è il considerare che questi istituti operano non nel momento stesso in cui le determinazioni urbanistiche sono adottate, ma in un momento successivo; esse cioè intervengono solo quando queste determinazioni devono essere applicate, e si propongono, per l'appunto, di attenuarne gli effetti.
Questo significa che, nella fase della adozione dei piani che; come già si è visto, è la più importante dal punto di vista urbanistico, gli istituti in esame lasciano che sopravviva il conflitto di interessi con tutta la sua incidenza negativa sulla adozione delle norme. Anche se gli istituti in esame eguagliassero in modo completo le posizioni (il che non è ne può essere), essendo tale livellamento rinviato al futuro, la tendenza dei proprietari sarebbe non di disinteressarsi del contenuto del piano, ma al contrario di procurarsi vantaggi urbanistici e a capitalizzarsi subito, prima cioè dell'entrata in funzione del meccanismo perequatore. Non è da escludere che perequazioni dei compensi ed imposte sulle aree accrescano la tensione al momento della deliberazione del piano, anziché diminuirla. Il che conferma che questi istituti rispondono, sia pure in modo imperfetto, alla finalità di attenuare le disuguaglianze, ma non eliminano gli ostacoli che si presentano da un punto di vista propriamente urbanistico.
La soluzione rappresentata da compensi nei volumi e nella imposizione fiscale sulle aree e in secondo luogo contrastata dalla esigenza di acquisire al minor prezzo possibile le molte aree che sono indispensabili per i servizi pubblici e sociali. Si presentano al riguardo due possibilità: la prima è che i Comuni acquistino le aree agli stessi .prezzi ai quali le aree sarebbero cedute dai proprietari ai privati. Questa soluzione è però ingiusta ed inopportuna. Sembra infatti assurdo che il Comune debba pagare al proprietario il plusvalore che è determinato non dall'abilità o dall'attività dello stesso proprietario, ma esclusivamente dagli atti amministrativi adottati dal Comune. Se poi le aree dovessero essere acquisite a prezzo di mercato, non resterebbe al Comune altra possibilità fuor di quella di rinunciare a tutte le aree non strettamente indispensabili, e ciò per mancanza di mezzi finanziari. La situazione attuale che è rappresentata dalla assoluta insufficienza di aree aventi finalità sociali (parchi, palestre, scuole ed asili, circoli ricreativi per bambini) è da attribuirsi principalmente a queste difficoltà; e questa situazione si riprodurrebbe inevitabilmente anche in futuro se restasse in vigore il sistema vigente.
La seconda possibilità è che i Comuni siano autorizzati ad acquisire singole aree destinate a finalità pubbliche e sociali, a prezzo inferiore a quello di mercato. Il legislatore ha avvertito questa necessità fin dal 1885 prevedendo un metodo di determinazione dell'indennizzo che dà risultati inferiori a quelli comuni. Provocata originariamente da una esigenza di carattere territoriale (legge per Napoli), il metodo è stato poi di volta in volta applicato a fattispecie sempre più numerose (v. le leggi sui piani regolatori di Bologna, Catania, Palermo, Ancona; sulla istruzione elementare, sulla gestione INA-Casa; sulla edilizia popolare ed economica; sull'incremento delle costruzioni edilizie; sulla costruzione dei campi sportivi, sulla eliminazione di abitazioni malsane; sulle Ferrovie dello Stato etc.).
Da ultimo si è affermata una tendenza più radicale, consistente nello stabilire in modo più esplicito che l'indennizzo deve essere ragguagliato ai valori agricoli (art. 4, L. 4 febbraio 1958, n. 158).
Questi orientamenti suscitano tre osservazioni. La prima è che tutti i casi qui contemplati sfuggono ad ogni disciplina egualizzante e realizzano quindi delle ipotesi di disparità di trattamento che, applicando i principi oggi in vigore, restano ineliminabili. Il secondo rilievo è che queste normative speciali, che una volta avevano un carattere eccezionale, sono andate generalizzandosi e occupano oggi un posto molto importante nella disciplina delle espropriazioni. La terza ed ultima osservazione è che questi istituti aggravano la disparità di trattamento in quanto, mentre obbligano i proprietari di singole aree o zone a cedere i loro terreni al Comune e ad enti pubblici ai prezzi fissati con riferimento a date anteriori al piano regolatore, consentono che i proprietari circonvicini possano trarre un immediato vantaggio dalla urbanizzazione della zona contigua e raccogliere a suo tempo gli incrementi di valore progettati dal piano. Le decisioni amministrative in questa materia acquistano, per i proprietari colpiti, il carattere sostanziale di una sanzione e non è da escludere, purtroppo, in periodi elettorali o preelettorali, che l'esercizio dei relativi poteri venga influenzato dal desiderio di favorire amici e colpire i nemici.
L'analisi compiuta conferma che una legislazione urbanistica, per essere efficiente, deve non solo perfezionare gli strumenti normativi, ma anche rimuovere le cause alle quali soprattutto è da imputarsi il rendimento insoddisfacente degli ordinamenti in vigore, cause che qualora fossero lasciate sussistere pregiudicherebbero allo stesso modo l'applicazione dei nuovi istituti”.
[7]V. Urbanistica n. 31, pagg. 87-88 e n. 35, pag. 86.
La Commissione ha ricevuto la direttiva di elaborare un disegno di legge che attui il precetto costituzionale dell'art. 117, per quella parte in cui attribuisce alle Regioni potestà normativa in materia di “urbanistica”.
Pertanto la Commissione si è dovuta porre in primo luogo il problema di come formulare una di quelle che ormai anche nell'uso corrente si denominano “leggi cornice”, tenendo presenti i comuni insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza della Corte costituzionale circa i limiti e il contenuto di tali leggi-cornice.
Il compito si è presentato di attuazione non facile. Va tenuto presente che la materia dell'urbanistica non è di quelle nelle quali predomina un profilo che potrebbe dirsi sostanziale, ma piuttosto predomina un profilo procedimentale. Nell’attività urbanistica infatti l’aspetto sostanziale, che può essere costituito dalla concezione della proprietà urbana, con tutto l’ordine delle limitazioni che ad essa si riferiscano o che da essa derivino, non si presta a delle enunciazioni di principio, come è dimostrato dal fatto che ne nella nostra tradizione legislativa, né nelle legislazioni straniere, anche le più progredite, è stato mai proceduto a siffatte enunciazioni. Esse invece si presentano piuttosto come il frutto di opere dell’interprete, e, sul piano normativo, sono soprattutto una conseguenza di un ordinamento di procedimenti amministrativi disposto dal legislatore. Nella misura in cui i procedimenti medesimi si presentino come più accurati, è possibile raggiungere il risultato di un contemperamento giusto dei molteplici interessi concorrenti nell’urbanistica, che sono gli interessi delle generazioni presenti e future, della comunità generale e delle singole comunità territoriali, delle sin. gole branche amministrative dello Stato e degli enti pubblici territoriali o nazionali, dei gruppi settoriali privati; quali quelli dei proprietari di immobili, degli imprenditori, degli agricoltori e degli industriali, non sempre convergenti e anzi molto spesso tra loro confliggenti.
Data questa realtà, al disegno di legge è stata applicata un’organizzazione che può apparire complessa, ma che è stata ritenuta la più rispondente agli scopi che si volevano raggiungere.
Le maggiori difficoltà da risolvere sono state incontrate proprio in ordine all’elaborazione di questa legge cornice. Ad una prima lettura essa può dare l’impressione di essere sovrabbondante. Ma ove ben si consideri la realtà che si doveva disciplinare, e si tenga presente soprattutto quanto si avvertiva dianzi circa la prevalenza del profilo procedimentale nella disciplina di questa materia, la prima impressione è destinata a mutarsi. Si è voluto, nella legge cornice, rappresentare alle regioni soprattutto il fatto che per ottenere un risultato giusto, occorre disciplinare i procedimenti di formazione dei piani regolatori, di adozione dei medesimi, nonché quelli di attuazione e di esecuzione, in termini di particolare accuratezza, si da permettere congiuntamente la presenza di tutti gli interessi, generali, collettivi e particolari, ai fini di una loro adeguata valutazione e da permettere altresì una pluralità di istanze tali da consentire la correzione di errori nei quali si possa incorrere.
Da un lato ci si è preoccupati che un eventuale carattere eccessivamente autoritativo che le leggi regionali potrebbero imprimere ai procedimenti amministrativi in materia urbanistica potrebbe conseguire risultati lesivi di diritti e interessi collettivi e particolari; ma dall’altro ci si è non meno vivamente preoccupati del possibile eccesso opposto, ossia che leggi regionali, con l’adozione di provvedimenti poco accurati o eccessivamente larghi, possano recare incentivi ad interessi settoriali, impersonati ormai in gruppi di pressione organizzati, i quali possano far sortire effetti diametralmente opposti, e quindi portino gli interessi pubblici generali a soccombere di fronte ad interessi di gruppo particolare.
... Notevolmente innovative sono, invece, le disposizioni contenute negli articoli 23 e seguenti, che hanno ad oggetto i mezzi per la attuazione del piani particolareggiati.
L’art. 23 fissa un principio di carattere generale e cioè: la espropriazione di tutte le zone inedificate comprese nell’ambito del piano particolareggiato nonché di quelle aree già utilizzate per costruzioni se la utilizzazione stessa sia sensibilmente difforme da quella prevista dal piano particolareggiato. É sembrato alla Commissione che in tal modo si possano risolvere adeguatamente ed anche con criteri di equità le non facili situazioni che possono verificarsi a seguito della adozione del piano particolareggiato, evitando altresì la possibilità di interventi e di pressioni estranee sulla esplicazione dell’attività delle Amministrazioni comunali, le quali devono, in. vece, avere di mira soltanto la possibilità di realizzare, legittimamente e convenientemente, le direttive e le prescrizioni urbanistiche del piano.
D’altro canto l’acquisizione al Comune delle aree edificabili dei piani regolatori particolareggiati vale anche a rendere più agevole e più semplice la successiva utilizzazione delle aree stesse, come a momenti si vedrà.
Ecco perché si è ritenuto che il sistema di trasferire in proprietà al Comune tutte le aree suddette sia la misura più opportuna anche se più radicale: ovviamente il diritto dei proprietari viene salvaguardato attraverso la cor. responsione del relativo indennizzo, a norma dell’art. 42 della carta costituzionale.
Va messo in luce che il primo comma dell’art. 23 consente al Comune di ripartire, proprio ai fini dell’espropriazione, tutto il territorio del piano particolareggiato in più zone e ciò allo scopo di evitare la possibilità per il Comune di accollarsi oneri finanziari eccessivi: il Comune ha, invece, la facoltà di graduare nel tempo le espropriazioni appunto attraverso la ripartizione del detto territorio in più zone.
La disciplina per il calcolo dell’indennità di espropriazione è contemplata dall’art. 24. In esso viene posta la fondamentale distinzione tra le aree che precedentemente al piano regolatore generale non avessero destinazione urbana e quelle già comprese in zone urbanizzate.
Per le prime, l’indennità ragguagliata al valore agricolo delle aree, dato che ogni eventuale ulteriore incremento di valore è legato esclusivamente al piano e non valutabile secondo il principio generale fissato dal quarto comma.
Per le altre, viene introdotto un criterio di valutazione comparativo coi terreni di nuova urbanizzazione, corretto con un parametro, stabilito dal Comitato dei Ministri, inerente alla diversa rendita differenziale di posizione.
Qualora tali aree siano coperte da costruzioni, la Commissione ha fissato il criterio di valutare il solo valore venale della costruzione che vi insiste. Infatti, l’utile effettivo del proprietario - e quindi il sacrificio operato dalla espropriazione - è dato solo dalla costruzione, non dalla redditività astratta dall’area sottostante. Potrebbe avvenire, peraltro, che il valore della sola area, calcolato col criterio comparativo e corretto col parametro dianzi menzionato, sia più alto; è disposto allora che, in tale ipotesi, l’indennità va determinata secondo il ricordato criterio comparativo.
I successivi commi dell’att. 24 introducono una notevole semplificazione nella procedura di esproprio. In sostanza, si è stabilito in conformità di quanto disposto da recenti leggi (L. 4 febbraio 1958 n. 158) che l’indennità è offerta dall’espropriante ed è pagata direttamente all’espropriato, in caso di accettazione, ovvero depositata, in caso di contestazione, entro termini che saranno stabiliti dalla legge regionale. Si elimina così la macchinosa e dispendiosa procedura peritale prevista dalla vigente legge sulle espropriazioni. Il decreto di espropriazione precede il pagamento o il deposito. Tale disposizione, che è conforme ad altri precedenti legislativi speciali (R.D.L. 16 settembre 1926 n. 1606 e D.L.L. 14 settembre 1944 n. 242 riguardanti le espropriazioni a favore dell’Opera Nazionale Combattenti) è da ritenere perfettamente costituzionale, perchè - come ritenuto dalla Cotte Suprema di Cassazione a proposito delle leggi richiamate (Sent. 15 marzo 1957 n. 903) - l’art. 42 della Costituzione prescrive solo la corresponsione di un indennizzo a favore del proprietario espropriato, ma non esige che esso sia pagato preventivamente o contestualmente al provvedimento di esproprio.
È appena il caso di osservare, poi, che è sempre salvo il diritto dell’espropriato di impugnare la misura dell’indennità offerta e non accettata nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 51 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, richiamata dall’ultimo comma.
Notevole infine la disposizione secondo cui per il periodo intercorrente fra la consegna del bene ed il pagamento o il deposito dell’indennità di espropriazione, l’espropriante è tenuto al pagamento degli interessi al tasso legale...Senza indugiare su troppi dettagli, si pongono in luce talune modifiche essenziali introdotte nel progetto allegato:
1) allo scopo di stimolare i Comuni ad adottare i loro provvedimenti in un tempo ragionevole, evitando cos! i gravi inconvenienti cui dà sempre luogo la inerzia della pubblica Amministrazione, il secondo comma dall’art. 30 (richiamato dal successivo att. 31) stabilisce che il Comune, qualora provveda oltre i termini che saranno stabiliti dalle leggi regionali, è obbligato al risarcimento dei danni nella misura degli interessi legali. Sembra evidente la funzione stimolatrice di questa disposizione, soprattutto ove si tenga conto che il Comune potrà poi riversare l’onere i finanziario sul dipendente che sia in colpa;
2) il quinto comma dell’att. 30 (richiamato anche dall’art. 31) tende a risolvere un altro grave problema che di frequente si verifica, quello cioè che, a causa del mancato coordinamento delle leggi e delle operazioni amministrative, il cittadino il quale costruisca in base a licenza di costruzione rilasciata dal Comune può trovarsi esposto durante il corso della costruzione. ad interventi di altre autorità che ordinano la sospensione se non addirittura la demolizione delle opere già eseguite. È evidente la situazione di estremo disagio che in tal modo viene a crearsi e perciò il ripetuto 5° comma stabilisce chiaramente che una volta intervenuta la licenza di costruzione o l’approvazione del progetto, nessun’altra autorità amministrativa può in nessun modo intervenire in ordine alla costruzione;
3) il sesto ed il settimo comma dello stesso articolo 30 (anch’essi richiamati dall’art. 31) si sono preoccupati dei problemi che possono sorgere dai provvedimenti comunali che autorizzano la costruzione. Nel caso che il Comune rifiuti la costruzione, il cittadino che si senta leso può senz’altro adire i competenti organi costituzionali, ma nel caso di provvedimento favorevole al richiedente, le eventuali illegittimità anche gravi del provvedimento stesso possono essere fatte valere soltanto dai proprietari confinanti i quali, ovviamente, tenderanno a prospettare soltanto quelle illegittimità che possano arrecare danno alle loro proprietà ed ai loro interessi. In tal modo possono rimanere, e di regola rimangono, non tutelate quelle violazioni, spesso gravi, ai più importanti interessi pubblici. Ecco perché i citati commi hanno stabilito da un lato che copia dei provvedimenti autorizzativi deve essere affissa nell’albo comunale e che contro il provvedimento di autorizzazione o di approvazione del progetto è ammessa l’azione popolare dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
L’art. 32 introduce, poi, il nuovo istituto della licenza di uso, attraverso il quale si vuole assicurare che non vengano utilizzate costruzioni le quali non rispondano a quei requisiti minimi indispensabili per un civile svolgimento della vita.