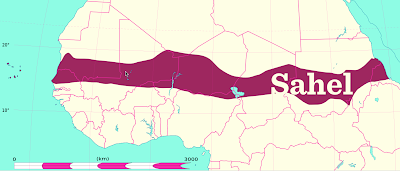la Nuova Venezia, 6 aprile 2018. Il racconto altisonante di come un'archistar trasforma un territorio in un immaginario fatto di lusso, bon ton e tanta ricchezza. Nei dettagli l'amara verità. La ex colonia trasformata in un enclave ad uso esclusivo dei ricchi. (m.p.r.)
STELLA DEL MAR
MAXI RESIDENCE A JESOLO
PROGETTO DA 75 MILIONI
Jesolo. Un progetto da 75 milioni di euro, nasce allido "The Summer Houses - Design District", residence con 99 appartamenti e albergo in via Levantina, fronte mare. Le costruzioni ad uso turistico non si fermano e Jesolo prosegue nella sua lenta opera di rinnovamento con la costruzione di un complesso che diventerà uno dei più grandi sul litorale. Ancora una ricettività destinata a un target molto alto, che ormai ha preso il sopravvento nella Jesolo del futuro. I turisti con disponibilità economiche che scelgono la località per la sua posizione strategica, la spiaggia, l'intrattenimento ad ampio raggio, la vicinanza a Venezia.
Con queste premesse, gli investimenti non mancano perché chi ha soldi da spendere non ci pensa troppo quando si tratta di soggiornare in strutture di altissimi livello o di acquistare ville e appartamenti lussuosi. La Massimo Frontoni Avvocati, con un team formato dal fondatore Massimo Frontoni e da Andrea Mattioli, ha ricevuto l'incarico di assistere la società Ponente Italia srl e Stella del Mar srl, con gli sponsor Kronberg International - Berlin e RIV Group Sas - Jesolo. Seguirà tutta la parte contrattualistica che è alla base della realizzazione del complesso urbanistico "The Summer Houses - Design District". Contratti di direzione lavori, contratti con gli appaltatori e tutto quanto attiene al progetto. Sorgerà sulle aree di proprietà di Stella del Mar Srl, in corrispondenza del numero civico 241 di via Levantina, poco distante dal complesso Jesolo Lido Village.
La ex colonia è stata rasa al suolo, aprendo questa ulteriori finestra sul mare tra la zona dell'ospedale e piazza Milano che sta diventando davvero il tratto di litorale più prestigioso dopo gli anni delle piazze e dei grattacieli che hanno deluso le aspettative del mercato turistico e immobiliare.La concessione edilizia è stata rilasciata il 16 marzo 2018 dal Comune. Il totale degli investimenti previsti è di 50 milioni di euro per la parte residenziale e altri 25 milioni per l'albergo che completerà il quadro delle strutture ricettive "stellate" al lido. Progetto dell'archistar Richard Meier di New York che a Jesolo ha già sperimentato il suo genio allo Jesolo Lido Village. Novantanove saranno le unità residenziali oltre a una struttura ricettiva residence e hotel cinque stelle con garage interrato. Il lotto è una delle ultime aree edificabili sul fronte mare in questa location di lusso e si estende su una superficie di complessivi 11.500 mq con forma rettangolare di circa 100m x 110m.
 |
Ecco un famoso scempio di Richard Meier
nel delicato centro storico di Ulm |
Una zona tranquilla e un po' fuori dalle rotte del turismo degli eccessi, spostatosi ormai verso il cuore del lido. Da piazza Milano verso il lido est Kronberg International e RIV Group saranno gli sponsor di riferimento. Massimo Frontoni Avvocati è uno studio specializzato nel settore edilizio e immobiliare, delle grandi infrastrutture e dei servizi di pubblica utilità. Ha fornito la consulenza legale. Il gruppo Kronberg è conosciuto a livello europeo, in particolare nel mercato tedesco, austriaco e italiano, nel settore immobiliare da oltre 25 anni. RIV Group è invece uno dei leader del mercato Jesolano con 20 anni di esperienza che ha realizzato 1.000 appartamenti. Due partner importanti per una delle operazioni immobiliari di maggior peso al lido, destinata a far parlare anche perché si inserisce in un tratto di litorale contraddistinto da molteplici strutture ricettive di altissimo livello per una clientela selezionata proveniente da tutta Europa
PISCINE, SAUNE E DISCREZIONE
COSÌ IL LIDO HA CAMBIATO VOLTO
«Questa nuova opera va a occupare la zona compresa tra l'ospedale e piazza Milano
Un quadrilatero d'oro sempre fronte mare per una clientela che non bada a spese»
JESOLO. In principio è stato lo "Jesolo Lido Village". L'architetto newyorkese Richard Meier era uno degli archistar di fama internazionale che mai ci si sarebbe aspettato di vedere al lido per nuovi disegnare nuovi progetti, concepire spazi e forme avveniristiche per il turismo internazionale.Nei primi anni del 2000 quel suo progetto sembrava atterrare direttamente da Miami, bianco candido, sottili ringhiere a vista. E fu subito un modello da imitare. Gli investimenti arrivavano dall'Alto Adige e facevano capo alla ricca e dinamica famiglia Reichegger, così come i primi ospiti di una lunga schiera disposta a spendere per questi villaggi avulsi dalla normale realtà jesolana.
L'architetto di fama mondiale Richard Meier aveva presentato davvero un'offerta residenziale che non aveva precedenti nel litorale veneziano. Lui stesso disse a proposito del progetto: «Sto creando un nuovo concetto di spazio, dove trascorrere le vacanze e il tempo libero, utilizzando come unità di misura le dimensioni umane». Sono sorti così tre elementi integrati tra loro, The Pool Houses, The Beach Houses e The Hotel & Spa. Tutto bianco per catturare la luce naturale e lussuosi appartamenti per vacanze andati a ruba quasi subito, chiusi nella loro impenetrabile area che quasi non pare avere rapporti con l'altra Jesolo.
Qui si vedono famiglie numerose dai tratti "kennedyani" con patriarchi carismatici, eleganti figli devoti ed emancipati, nuore bellissime, nipotini educati e ben vestiti. Quelle famiglie che discendono dai monti o arrivano dalle plaghe europee in cerca dello sbocco sul mare di Venezia.Era solo l'inizio di un lungo cammino dorato. Di lì a pochi anni è arrivato il primo hotel a cinque stelle di Jesolo, il gigantesco hotel Almar, tutto jesolano nella proprietà che fa riferimento alla famiglia Boccato, oggi riferimento per l'alta cucina e gli eventi internazionali, seguito a breve distanza, di metri e anni, da un altro grande hotel della catena altoatesina Falkensteiner, anche questo molto richiesto da una clientela europee dal palato fine e il contante sempre disponibile. Hanno offerto aperture destagionalizzate, saune e centri Spa.Il polo del lusso tra la zona ospedale e piazza Milano si completa ora lungo via Levantina con questa nuova opera di Meier che stupirà ancora lasciando il segno della sua mano nuovamente al lido.

perUnaltracittà, newsletter 4 aprile2018. Firenze. Come distruggere insieme urbs e polis. L'insegnamento della città guida del renzismo urbanistico. Ma contrastare si può passando dalla denuncia all'azione.
Proprio in nome della “rigenerazione urbana”, una Variante al Regolamento Urbanistico sottopone a trattamento degenerativo il corpo esangue della città storica e lo predispone a nuova speculazione immobiliare. La Variante al RU, approvata dalla Giunta e a breve in discussione consiliare, aggredisce il patrimonio edilizio storico e abolisce l’obbligatorietà del restauro sui monumenti architettonici: la loro tutela viene demandata alla libera discrezionalità della Soprintendenza, ridotta allo stremo dalla riforma Franceschini.
Nel feudo del declinante potere renziano
All’ultimo anno di mandato, la Giunta Nardella si esprime con questo pericoloso provvedimento che apre la strada agli appetiti sulle architetture monumentali del centro città e delle colline, che agevola la sciagurata vendita di edifici storici di proprietà pubblica e che, infine, legittima vecchie speculazioni bloccate dal sistema giudiziario. È l’estrema torsione amministrativa, liberista e servile, un regalo agli “investitori”, agli immobiliaristi, ai parassiti della rendita.Ma è principalmente un atto di selezione sociale.
L’accelerazione impressa dalla Variante rafforza infatti il processo di esclusione della vita civile e delle funzioni sociali dai luoghi rappresentativi della comunità cittadina, prodromo dello spossessamento degli spazi pubblici e comuni. Corrobora ulteriormente la già avviata sostituzione dei residenti con «utenti» che, dotati di notevole disponibilità economica, influiscono sull’assetto urbano senza tuttavia partecipare alla vita politica[1]. Tutta urbs niente polis, verrebbe da dire. La popolazione ideale da governare.
Tutto il contrario di quanto sarebbe auspicabile per ridar vita alla città storica. La soluzione è da ricercare semmai in politiche cariche di valenza sociale, che tutelino l’ambiente di vita urbana tutelando la vita ivi condotta, secondo l’esempio originario di Bologna (anni Sessanta-Settanta), certo da rinnovare, perfezionare e rendere applicabile nei giorni presenti.
Carico di tali connotati sociali, il restauro è stato consacrato dalla cultura e dalle pratiche urbanistiche come il metodo di intervento più indicato sulle città storiche. Mai era stato messo in crisi, formalmente, il principio della tutela dell’edificato storico. Ci prova ora – sotto le insegne dell’innovazione urbana, ma da solida posizione di retroguardia culturale – il Comune di Firenze.
Ristrutturazione “alla fiorentina”
La proposta Variante all’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico agisce sulla disciplina delle trasformazioni del patrimonio immobiliare storico introducendo un’inedita “ristrutturazione edilizia limitata” su quasi metà dell’edificato del territorio comunale[2](sono esclusi i beni culturali, ma su di essi torneremo subito).
La “ristrutturazione edilizia limitata” pur preservando la sagoma, le facciate – ancorché “sostanzialmente” – e alcuni elementi distributori (scale, androni), non tutela la configurazione interna degli edifici ed espone il patrimonio edilizio a ulteriori frazionamenti finalizzati agli affitti turistici. Del rischio di “façadisme” abbiamo scritto su queste pagine nell’articolo Dietro la facciata niente, a cui rimandiamo.
Se già appariva surreale l’invenzione di una ristrutturazione “alla fiorentina”, appare fuor di ragione la normativa che il Comune ha delineato per i monumenti architettonici: i pezzi più pregiati, dagli Uffizi a Forte Belvedere, dalla Villa di Rusciano alla Manifattura Tabacchi, saranno suscettibili di “ristrutturazione edilizia” tout court (“senza limitazioni” si precisa nella delibera). Non è un caso che molti di essi corrispondano alle “Aree di Trasformazione” del RU e alcuni siano anche presenti nei Piani di alienazione.
La sostituzione del restauro con la “ristrutturazione” contravviene alla prescrizione di tutela del Bene culturale espressa nell’art. 29 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La ristrutturazione edilizia è infatti la classe di intervento che consente la maggior libertà nelle opere di trasformazione, persino la demolizione dell’edificio e la sua ricostruzione in forme diverse da quelle originali. Quanto a previsioni urbanistiche dunque, sui monumenti si potrà agire con la stessa libertà con cui si opera su un capannone industriale.
La tutela sarà demandata totalmente alla Soprintendenza, che finora ha lavorato a fianco del Comune autorizzando le trasformazioni consentite dal RU (poiché sono due i dispositivi che rispondono al precetto di tutela del Bene Culturale: il permesso di costruire, in capo al Comune, e l’autorizzazione del soprintendente). Ma come ognun sa, la Soprintendenza non è il Comune, non è un organo rappresentativo della cittadinanza, ha funzioni di diversa natura, non tratta di pianificazione, non è suo compito occuparsi della disciplina in materia di attività edilizia ed urbanistica. In altre parole: il Soprintendente non può sopperire alla mancata pianificazione comunale.
Degenerazione amministrativa
Rimettendo alla Soprintendenza il destino degli edifici monumentali, il Comune recede da un obbligo costituzionale. Elude le funzioni attribuitegli dalla Legge urbanistica (L 1150/1942), dall’art. 118 della Costituzione, definite dal “Testo unico degli enti locali” che specifica:
«Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori […] dell’assetto ed utilizzazione del territorio» (DLgs 267/2000, art. 13, co. 1).
L’urbanistica, quale funzione primaria ed essenziale, rientra tra tali compiti amministrativi: attraverso il Piano Regolatore (nelle sue varie denominazioni regionali) il Comune ha l’obbligo di dettare la disciplina delle trasformazioni e dell’uso di ogni immobile ricadente nel territorio comunale, nell’interesse generale. Nessuno escluso.
[L’articolo è la trascrizione del contributo dell’autrice all’incontro All’assalto della città pubblica! Firenze elimina il restauro e spiana la strada ai grandi capitali organizzato da Spazio InKiostro, tenutosi a Firenze il 28 marzo 2018. In apertura: Santo Stefano al Ponte Vecchio, aprile 2018,
Note al testo
[1] Si veda su questo argomento il sintetico: Alessandro Barile, Utenti contro residenti. La nuova dialettica metropolitana tra cittadini e fruitori, “Alias”, supplemento a “il manifesto”, 17 marzo 2018.
[2] Ossia, sulle «emergenze di valore storico architettonico» non vincolate; sugli «edifici di interesse documentale» e sugli «edifici storici o storicizzati» (ricadono in questa voce le case popolari di via dei Pepi poste in vendita nel piano comunale delle alienazioni).

Privatizzare ogni spazio pubblico, sostituire lo spettacolo alla libera fruizione degli spazi aperti, rendere merce ogni patrimonio comune. E intanto spendere soldi pubblici per le guerre e gli armamenti: questa è la legge dei dominatori
in calce le firme e il link per le adesioni
Chiediamo che, a tempi brevissimi, gli assessori capitolini alloSport e all’Ambiente chiariscano ai cittadini come stanno realmente le cose inrelazione alla notizia – pubblicata da tutta la stampa romana – di un accordocon il CONI e con la Federazione Sport Equestri (FISE) col quale si affiderebbeai due enti di gestire Piazza di Siena e il Galoppatoio di Villa Borghese perle gare ippiche che vorranno, con contratti rinnovabili e per ben otto anninelle intenzioni della FISE, utilizzando la Casina dell’Orologio per“ricevimenti”, trasformando anche il Galoppatoio in un impianto sportivopermanente, e rendendo stabili le tribune e gli altri impianti: in pratica, unasostanziale, continuata “privatizzazione” di Piazza di Siena e del Galoppatoio,escludendo dal suo pieno godimento i cittadini romani ai quali lo Stato invecela destinò acquistandola nel 1901.
Chiediamo che, al contrario, entro l’estate, si concretizzi l’impegnoa trasferire, dal prossimo 2019, il Concorso Ippico in altra sede. Da qualcheanno – e con una impressionante progressione – il Concorso Ippico di Piazza diSiena si è trasformato in un pretesto per occupare per circa due mesi (frapreparazione, concorso e ripristino della zona) tutta l’area circostante, finoalla cancellata del Giardino del Lago: una marea di bancarelle e di rumoroseinstallazioni che rendono inaccessibile una vasta area di Villa Borghese e nefanno un indecoroso suk. A questo s’aggiungono i continui danni, irreparabili,alla vegetazione dei giardini storici, e il via vai di mezzi pesanti il cuiingresso è vietato dalle leggi di tutela.
Nel contempo suggeriamo come nuova sede del Concorso stesso loStadio dei Marmi, dove si svolge già con successo il prestigioso Concorsoippico internazionale del Longines Global Champions Tour. Una locationperfetta perché non necessita di lavori di allestimento, si inserisce nelquadro di un Foro Italico destinato alla pratica di tutti gli sport e disponedi ampi parcheggi. Lo stesso vale per l’ippodromo di Tor di Quinto, prestigiosasede del centro ippico dei Lancieri di Montebello, ai piedi della collinaFleming.
Chiediamo che, essendo già la "città storica di Roma"qualificata Sito Unesco Patrimonio dell'Umanità e la stessa Villa Borgheseinserita nella apposita Carta Unesco, essa venga tutelata con ben altraattenzione ed energia stornando definitivamente la minaccia di una"privatizzazione" come quella contenuta nella convenzione fra Comune,Coni e Fise per Piazza di Siena e per il Galoppatoio, ed eliminando per semprelo sconcio, intollerabile parcheggio di pullman turistici dall'ingresso delValadier da piazzale Flaminio verso l'interno. Oltre tutto, la Carta mondialedi Firenze del 1981 prevede che nei luoghi storici dalla stessa protetti glieventi possano essere soltanto eccezionali e non invece continui. Non siamo fraquanti vorrebbero conservare questi beni come in una teca, ma riteniamo chenelle Ville Storiche siano possibili soltanto attività e strutture discrete,compatibili con l'assetto antico e con la funzione pubblica delle Villemedesime, come, ad esempio, la Casa del Cinema e la Ludoteca della Casina diRaffaello.
Da ultimo ci chiediamo: ma cosa stanno facendo o si propongono difare, davanti a tanti stravolgimenti di un bene storico, artistico epaesaggistico di valore planetario quale Villa Borghese, la SovrintendenzaCapitolina e la Soprintendenza statale? Rimanere a guardare?
.
Vittorio Emiliani Comitatoper la Bellezza Carlo TroiloOsservatorio Roma
aderiscono
Desideria Pasolini dall'Onda, fondatrice di Italia Nostra
Licia Vlad Borrelli, archeologa, specialista del restauro
Fulco Pratesi, presidente onorario WWF
Dacia Maraini, scrittrice
Valerio Magrelli, poeta, scrittore, docente universitario
Alberto Asor Rosa, saggista, Università La Sapienza
Adriano La Regina, presidente Istituto Naz. Archeologia eArte, accademico dei Lincei
Vezio De Lucia, urbanista e saggista
Alix Van Buren, presidente Amici di Villa Borghese
Luigi Manconi, sociologo e scrittore
Antonello Falomi, presidente Associazione ex parlamentari
Paolo Berdini, urbanista e saggista
Massimo Teodori, storiografo
Gianni Mattioli, fisico, fondatore di Legambiente
Nicola Spinosa, storico dell'arte, già soprintendente PoloMuseale di Napoli
Andrea Emiliani, storico dell'arte, accademico dei Lincei
Bruno Toscano, storico dell'arte, professore emerito RomaTre
Jadra Bentini, presidente Italia Nostra Bologna, giàsoprintendente
Guido Pollice presidente Verdi Ambienti Società (VAS) conl'intero esecutivo
Giuseppe Cederna, attore e scrittore
Silvia Danesi Squarzina, storica dell'arte
Luigi Piccioni, storico dei Parchi Nazionali, Università diReggio Calabria
Maria Pia Guermandi, coordinatrice Emergenza Cultura,archeologa
Comitato per la Difesa di Villa Borghese
Associazione Amici di Villa Strohl Fern
Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio
Pietro Giovanni Guzzo, Ist. Naz. Archeologia e Arte,accademico dei Lincei
Ruggero Martines, già soprintendente Roma e Puglia
Fausto Zevi, archeologo, docente alla Sapienza
Alberto Benzoni, presidente Roma Nuovo Secolo
Chiara Frugoni, storica dell'arte, medievista
Andrea Manzella, costituzionalista
Francesco Pardi, paesaggista, Università di Firenze
Giorgio Nebbia, pioniere dell'ambientalismo, professoreemerito Bari
Paolo Maddalena, vice-pres, emerito Corte Costituzionale
Alberto Abruzzese, sociologo e saggista
Umberto Croppi, Associazione "Una città"
Mario Morcellini, consigliere Comunicazione della Sapienza,Roma
Giorgio Boscagli, biologo, Gruppo dei 30, già direttore diParchi Nazionali
Francesco Mezzatesta, fondatore della LIPU
Carlo Pavolini, già docente archeologia classica
Lorenzo Lavia, attore e regista
Gabriele Simongini, critico, docente all'Accademia di BelleArti di Roma
Celestino Spada, Economia della Cultura
Vincenzo Scolamiero, docente Accademia di Belle Arti Roma,pittore
Cristiana Mancinelli Scotti, Forum Salviamo il PaesaggioRoma e Lazio
Massimo Livadiotti, Respiro Verde
Gaia Pallottino, Coordinamento Residenti Città Storica
Annalisa Cipriani, Italia Nostra Roma
Mirella Belvisi, Italia Nostra Roma
Maria Teresa Filieri, storica dell'arte, già direttore MuseiNaz. di Lucca
Nicola Scalzini, Italia Nostra
Nathalie Naim, consigliere I Municipio
Giorgio Treves, regista cinema e tv
Renata Rampazzi, pittrice
Mina Welby
Luciano Manuzzi, regista cinema e tv
Andrea Camilli, archeologo, Assotecnici
Stefano Sylos Labini, ricercatore
Paola Paesano direttore Biblioteca Naz. Vallicelliana
Pio Baldi, architetto, già soprintendente Lazio
Bernardino Osio, ambasciatore
Franco Monteleone, storico radio e tv, Roma Tre
Sergio Guidi, presidente Ass. Nazionale Patriarchi dellaNatura
con l'intero esecutivo
Vittorio Roidi, giornalista
Maria Grazia Cianci, Dipartimento di Architettura, Roma Tre
Giancarlo Santalmassi, giornalista
Giorgio Panizzi, Circoli Fratelli Rosselli
Gianandrea Piccioli, consulente editoriale
Guido Melis, storico dell'Amministrazione, Sapienza, Roma
Ugo Leone, professore emerito Scienze Ambientali, Napoli
Carlo Clericetti, giornalista
Maurizio Fiasco, sociologo
Pino Coscetta, giornalista scrittore
Giuseppe Lo Mastro, avvocato
Emilio Drudi, giornalista scrittore
Renato Parascandolo, già responsabile Rai Educational
Montse Manzella
Andrea Costa, Ass. Roma Nuovo Secolo
Stefano Sepe, docente Storia dell'Amministrazione
Annarita Bartolomei
Ferdinando Zucconi Fonseca, già presidente di Cassazione
Raffaella Prandi, giornalista
Vittorio Sartogo, Ass. Insieme Roma
Daniele Protti, giornalista
Giuseppe Sfligiotti, dirigente industriale
Dina Nascetti, per il comitato Vivere Trastevere
Paola De Vecchi, per il Comitato Trionfalmente
Pino Galeota, coordinatore Corviale Domani
Giuseppe Morabito, Giustizia e Libertà
Federico Sandrone, urbanista
Domenico Finiguerra, Stop a consumo di suolo
Riccardo Picciafuoco, Salviamo il Paesaggio Marche
Michele Boato, Ecoistituto Veneto
Oreste Magni, Ecoistituto Valle del Ticino
Gabriella Lalìa, pres. Ass. Oltrelasiepe Arcevia
Fiorenza Rossetto,Salviamo Bracciano
Antonio Tomei, Salviamo il Paesaggio Latina
Luigi Scarsi, Stop al consumo di suolo
Edoardo Salzano, urbanista, presidente di APS eddyburg
Per aderire indirizzare a Vittorio Emiliani
Avvenire, 28 marzo 2018. Nuove conferme del profondo degrado del pianeta Terra. Un recente studio dell'Onu ribadisce la gravità della situazione, ma nessun governo riesce ad arrestare lo "sviluppo" saccheggiatore edenergivoro che ci conduce al disastro
«Gli scienziati incaricati dall'Onu di studiare l'impatto dell'azione umana sugli ecosistemi producono uno studio allarmante. "Rischiamo la sesta estinzione di massa delle specie“»
Il primo rapporto mondiale sul degrado del suolo ha prodotto risultati allarmanti. In molte aree del pianeta la situazione dei terreni ha raggiunto livelli «critici», la rapida espansione di terre agricoli e pascoli gestiti in maniera non sostenibile sono il problema principale e stanno provocando significative perdite di biodiversità e di “servizi ecosistemici”, cioè dei benefici che la varietà dell’ecosistema offre agli esseri umani.
«Con un impatto negativo sul benessere di almeno 3,2 miliardi di persone, il degrado del suolo sulla superficie terrestre a causa delle attività umane sta spingendo il pianeta verso la sesta estinzione di massa delle specie» ha avvertito il sudafricano Robert Scholes, scienziato dell’ecologia dei sistemi che ha coordinato lo studio assieme all’italiano Luca Montanarella, ingegnere agronomo dal 2003 alla guida del centro di ricerca della Commissione europea sui dati del suolo.
Il report è il primo di questo genere realizzato dall’Ipbes, la “piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici” avviata nel 2012 dall’Unep, il programma delle nazioni unite per l’ambiente. L’Ipbes è stata creata per condurre un lavoro di ricerca internazionale, autorevole e indipendente sugli effetti che l’attività umana ha sugli ecosistemi sul modello di quanto il più famoso Ipcc ha fatto per il clima.
Alla realizzazione di questo studio, prodotto dopo tre anni di lavoro, hanno partecipato più di cento esperti da quarantacinque nazioni, sulla base di oltre tremila ricerche scientifiche pubblicate. Il risultato è stato rivisto da oltre duecento studiosi indipendenti, inclusi funzionari governativi, e quindi approvato, lunedì scorso, durante la sesta sessione plenaria dell’Ipbes, a Medellìn, in Colombia. Ieri ne è stata pubblicata un’anticipazione, presto arriverà il documento completo.
Il degrado del suolo si manifesta in modi diversi: l’abbandono di terreni, il declino della popolazione e delle specie selvatiche, la deforestazione, la perdita e il peggioramento della salubrità del terreno, dei pascoli e dell’acqua. Dal 2014 sono stati convertiti in terre agricole oltre 1,5 miliardi di ettari di ecosistemi naturali. Solo il 25% della superficie terrestre ha evitato di essere significativamente modificato dall’attività umana, quota che entro il 2050 si ridurrà al solo 10%.
Nelle proiezioni al 2050, gli studiosi prevedono 4 miliardi di persone costrette a vivere in terre arride tra i 50 e i 700 milioni di esseri umani che non avranno alternativa a migrare. Il calo della resa dei terreni provocherà anche tensioni sociali. «Soprattutto nelle terre aride, dove anni di piovosità estremamente bassa sono stati associati a un aumento del 45% dei conflitti violenti» nota Scholes. Montanarella aggiunge che le aree più a rischio di un peggioramento del degrado del suolo sono l’America centrale e il Sudamerica, l’Agrica sub-Sahariana e e l’Asia.
C’è un legame evidente tra le conclusioni dell’Ipbes e quelle dell’Ipcc. «Il degrado del suolo, la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico sono tre facce differenti della stessa sfida: l’impatto sempre più pericoloso delle nostre scelte sulla salute del nostro ambiente naturale» ha commentato Robert Watson, presidente dell’Ipbes. Questo significa che per evitare il peggioramento della situazione occorre cambiare i comportamenti. Per esempio, suggerisce l’Ipbes, si può evitare l’ulteriore espansione dei terreni agricoli migliorando la resa delle terre già coltivate, spostandosi verso diete che prevedono più frutta e vegetali e meno proteine animali da fonti non sostenibili, e poi ridurre lo spreco di cibo.
Ci sono poi una serie di azioni che possono dare un contributo: dalla gestione attenta dei sistemi forestali e degli allevamenti al controllo dell’inquinamento nelle zone umide fino agli interventi urbani, come lo sviluppo delle vie fluviali, l’espansione dei parchi, il ripiantamento di alberi e piante autoctone.Tocca ai governi darsi da fare. Badando più ai vantaggi a lungo termine che ai costi immediati, avverte l’Ipbes: in media, stimano gli scienziati, i benefici del ripristino di un ecosistema sono dieci volte superiori ai costi, che comprendono anche la perdita dei posti di lavoro legati ad attività non sostenibili.
Articolo tratto dalla pagina qui raggiungibile

La Stampa 23 marzo 2018 . un tentativo di dare una risposta al significato dei colori della mappa post-elettorale dell'Ilalia. Ma forse quei colori sono troppo pochi per rappresentare alcunchè di significativo
Me la sono appesa quasi sopra la scrivania dove per lo più leggo, lavoro, scrivo. La mappa dell’Italia dopo le elezioni. Coloratissima. Il blu del centro destra, il giallo del Movimento 5 Stelle, il rosso del centro sinistra. La guardo e mi dico: Adesso è arrivato il momento di studiare. Che qualcuno studi. Che non abbia fretta.
Che cos’è quest’Italia? Che cosa hanno in testa gli italiani? Se quello fosse veramente il nostro ritratto, non potremmo davvero arrivare a una identificazione veritiera. Sono opinioni politiche? Sono scelte fatte da cittadini consapevoli del bene comune? E quei colori hanno a che fare con una sorta di guerra civile interna?
Io non credo. E non perché sia particolarmente ottimista. Semmai il contrario. Sono convinto che siamo, questo sì, davvero al centro di una battaglia culturale perduta, o forse mai realmente combattuta. Quando vedo il puntino rosso di Milano e di Torino, e forse solo di Milano centro e di Torino centro, in mezzo al blu, mi vengono in mente New York e San Francisco (sapevano a New York e a San Francisco che cosa avevano in testa i cittadini di Rock Springs dove ha stravinto Rex Rammell, il Trump del Wyoming? Avevano letto i racconti di Richard Ford ambientati in quella città alla fine degli anni ottanta del Novecento?), e poi mi viene in mente Londra centro del pre-Brexit (anche lì c’era qualcuno che aveva un’idea non contrastiva della città del Nord, di Preston, Lancashire o della stessa Birmingham di cui racconta Jonathan Coe?).
Milano è come New York e come San Francisco, da quel punto di vista: qui accade ciò che altrove non accade, qui si discute di diritti umani, qui c’è un intelligente assessore alle politiche sociali , qui ci sono gli archistar, la moda, l’editoria, qui siamo nella “città creativa Unesco per la letteratura”, qui ci sono la Casa della Carità, le Associazioni, il Volontariato, la Fondazione Feltrinelli, la Fondazione Prada, la Fondazione Mondadori, la collaborazione fra pubblico e privato nell’accoglienza di primo livello, per cui senti che l’inclusione è possibile - sia pur con tutte le contraddizioni del caso - come a New York e come a Londra.
E quel che accade altrove, a Rock Springs, Wyoming, a Preston, Lancashire, a Novi Ligure, a Castelfranco Veneto, Romano di Lombardia, non importa. L’Italia è una sterminata provincia, spesso si tratta di provincia ricca, ancora più spesso questa provincia coincide anche con l’Italia della cultura storica, dei monumenti, delle famiglie aristocratiche e delle tradizioni popolari.
A pensarci bene, la provincia del fascismo. Ma qui il fascismo del ventennio non c’entra. C’entrano invece le trasformazioni sociali, “antropologiche”, nonché (anche qui come nelle città) architettoniche, che hanno creato l’Italia “della villetta” (mono o bifamigliare): quel sublime concentrato di isolamento sociale, di trionfo del particulare, di asfissia ideale, di delirio psicologico e di assuefazione al cattivo gusto , quel diffuso monumento alla paranoia e all’orgoglio cellulare che è stato da una parte un simbolo di prosperità e autonomia ma dall’altra anche terreno di coltura di devianze e delitti interfamigliari.
Paradossalmente, nell’uno e nell’altro caso, siamo ignoranti. La politica di quelli che ci piace chiamare “valori” è ignorante. Non lo è ovviamente la Lega, non lo è il centro destra e non lo è neppure il Movimento 5 Stelle. Io non so se Salvini ha studiato l’humanitas della villetta, ma certamente ha ereditato quel che la Lega storica ha sempre saputo di quel mondo. Che cosa conosca o abbia intenzione di conoscere Di Maio, non saprei.
Nei primissimi anni sessanta Truman Capote andò a Holcomb, Kansas, e mise a fuoco un mondo immenso e immensamente ignoto – a partire da un delitto, è vero, ma venne fuori un ritratto sociale delle High Wheat Plains, del Kansas rurale, ricchissimo di umanità e di sfumature (i democratici si contavano sulle dita di una mano). L’opposizione metropoli/periferie è in realtà opposizione metropoli/provincia, quella provincia lì, sempre meno ricca, sempre più inquieta, sempre più diffusa. Non vuole altra cultura che non sia quella analgesica e televisiva dei tronisti e degli chef, quella virtualmente urlata dei social, quella squisitamente razzista del “fuori il diverso” (nero o non nero non importa) che bivacca davanti alle stazioni – non certo quello che i capomastri bresciani vanno a raccogliere nei luoghi convenuti, quello che si prende cura di nonni e di disabili, quello umiliabile in termini salariali.
Ebbene mi prende la sana curiosità che si possa sapere che cosa hanno in testa quelli che non riconoscono il tratto epocale della deriva dei continenti, la necessità di assumere la povertà del mondo come tema comune, la convivenza come un destino ricco di conseguenze. Sono certissimo che di quella che chiamiamo cultura, le aree blu e gialle della mappa temono una cosa sola: la complessità. Cosa c’è mai da apprendere che non sia già saputo altrove? La tecnologia non è esposta a nessuna forma di critica che non sia quella se funziona o non funziona.
Perfino la scuola è guardata con sospetto. La cultura umanistica contemplata nei programmi del centro destra rientra nella “potenzialità del turismo”. Detto questo, la spocchia di chi ritiene di saperla lunga è finita. Per “capire” è ancora presto. È necessario uscire dalle città per cominciare a guardare. Prendere appunti. Accelerare verifiche. Meglio se in comune. Fra i nemici non ci sono solo nemici e spesso, come diceva il poeta, fra quelli dei nemici c’è anche il nostro nome.
la Nuova Venezia, 25 marzo 2018. Dagli atti sembra che non ci sia altro destino. La giustizia formale rende possibile una trasformazione non voluta dalla comunità attuale né dallo strumento urbanistico del 1999. (m.p.r.) con riferimenti
La Vida di campo San Giacomo da l'Orio potrà diventare un ristorante, senza dover passare dal voto (incerto) del Consiglio comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Lo rivela l'accesso agli atti richiesto dai consiglieri comunali Maurizio Crovato (Lista Brugnaro) e Rocco Fiano (Lista Casson): «La dirigente del Commercio Stefania Battaggia e l'architetto Emanuele Ferronato, responsabile della pratica, ci hanno confermato che la Vida può aprire come ristorante, senza bisogno del nullaosta del Consiglio», commenta Crovato.
L'esperienza spontanea, stimolante e vivacissima che l'ex Vida è stata per cinque mesi - "liberata" da comitati e associazioni di cittadini, che ne hanno fatto un animato centro civico - pare così segnata, anche se dopo lo sgombero dei locali è ancora attivo un presidio, sventola lo striscione «No ste cavarne ea Vida», ci si ritrova per le "colazioni condivise in campo" si annuncia un nuovo calendario di appuntamenti cultural-ricreativi. Non tutto è ancora autorizzato, ma la porta al nuovo ristorante è spalancata. Il 6 marzo l'avvocato Bartolomeo Suppiej, per conto dell'imprenditore Alberto Bastianello - che ha comprato l'immobile dalla Regione per 911 mila euro - ha protocollato allo Sportello unico per l'edilizia l'atto con il quale «ritiene che possano essere autorizzate opere di manutenzione straordinaria volte alla riapertura della storica trattoria alla Vida, compatibilmente con la destinazione d'uso C1 commerciale risultante dall'atto di acquisto».
Ma come è possibile, stante il vincolo contenuto nella scheda 20 della variante urbanistica al piano regolatore per la città antica - che per la Vida prevede come «destinazione d'uso compatibili: musei, sedi espositive, biblioteche, archivi, attrezzature associative, teatri, attrezzature religiose»? La risposta ufficiale è che in un secolo l'ex trattoria non ha mai perso i requisiti igienico-sanitari concessi dal Comune sin dal 1914 per farne un locale pubblico, tanto che quando la Regione Veneto l'acquistò ottenne l'autorizzazione sanitaria a farne sede della mensa aziendale. L'asso giocato dalla nuova proprietà sta nella missiva del gennaio 2005, con la quale il Comune - rispondendo a una richiesta di chiarimenti avanzata dalla Regione, per sapere quali fossero le destinazioni d'uso compatibili per la Vida - citava l'art. 21.2 della norma per la città storica, che per gli immobili preottocenteschi di tipo "Su" prevede sì le destinazioni cultural-artistico-religiose delle quali si sa, specificando (però) che «ove la destinazione d'uso in atto (prima del 31 maggio 1996, ndr) non sia tra quelle consentite o prescritte, nessun intervento, eccedente la manutenzione ordinaria e straordinaria, può essere realizzato se non volto ad attivare una destinazione d'uso consentita».
Proprio quella manutenzione straordinaria che chiede ora la proprietà. E qui sta il punto, perché se è vero che la trattoria a la Vida aveva aperto i battenti nel 1914 - sostiene la nuova proprietà, atti alla mano - una volta passata in mano pubblica, la Regione ha ottenuto nel 1978 e nel 1980 l'autorizzazione sanitaria a "esercizio di tipo A (mensa aziendale) per i soli dipendenti regionali. Sono passati 37 anni, la Vida è stata più volte occupata, poi è diventata un archivio, ma tanto basta all'attuale proprietà per rivendicare come tuttora vigente la secolare destinazione commerciale scritta nell'atto notarile di compravendita dei 200 metri quadrati con affaccio su campo San Giacomo da l'Orio, chiedendone, perciò, la semplice manutenzione per riaprire l'antica trattoria. «La dirigente Battaggia mi ha confermato che le cose stanno così», chiosa Crovato. Intanto, pende ancora il sequestro preventivo deciso dal giudice di pace, per far sgomberare l'immobile dopo l'occupazione. Nuovo ristorante, ma senza pergola. Nel "pianino" del campo non sono previsti tavoli, né sedie, né vigne davanti alla Vida. Se ne riparlerà tra 5 anni: un atto al voto del Consiglio comunale.
L'articolo originale lo trovate qui.
riferimenti
Sulla vicenda del bene pubblico ex Teatro dell'anatomia chiamato Vida si vedano su eddybur Giù le mani dai luoghi pubblici di Vera Mantegoli, A Venezia la Vida torna in strada di Giacomo Maria Salerno.

Città Nuova, 24 Marzo 2018. Intervista al portavoce del Forum italiano dei movimenti per l’acqua, che si riunisce a Roma dopo un viaggio di mobilitazione per difendere il diritto all'acqua e l'esito del referendum, ignorato dalle forze politiche, che per la maggior parte hanno continuato a privatizzare. (i.b).
È cosa nota. In Italia, di fatto, non è stato applicato finora l’esito del referendum sull’acqua del 2011 che chiedeva di riconsegnare la gestione del ciclo idrico alla mano pubblica. Di questa battaglia si è fatto paladino, a suo tempo, il M5S mentre nel Pd, soprattutto tra i giovani, il dibattito dopo la sconfitta elettorale del 4 marzo ha toccato anche la contraddizione del mancato rispetto della volontà popolare.
Cerchiamo di capire lo stato delle cose con questa intervista a Paolo Carsetti, segretario e portavoce del Forum italiano dei movimenti per l’acqua. Cioè la realtà eterogenea che non ha mai cessato di portare avanti le istanze per l’applicazione del referendum popolare e che, sabato 24 marzo, si radunerà a Roma al termine di un viaggio di mobilitazione in giro per l’Italia per promuovere “Il diritto all’acqua, per il diritto al futuro”. Secondo Carsetti, «l’acqua e i beni comuni possono essere un nuovo orizzonte di senso in grado di connettere terreni e conflitti diversi, di parlare potenzialmente a tutti ben al di là dei recinti angusti della politica di palazzo e ricostruire alle radici una diversa cultura collettiva».
Per chi non ha seguito da vicino in questi anni ci puoi dire che effetto ha prodotto il referendum vinto sull’acqua pubblica?
Abbiamo assistito ad una reazione decisa, quasi feroce, delle lobby economico-finanziarie. L’attacco all’esito referendario non si è fatto attendere e il mantra delle privatizzazioni è tornato ad essere il faro delle élite politiche che governano il nostro Paese. Dal pronunciamento popolare del referendum l’emersione della crisi economico-finanziaria a livello globale ha costretto prima a sterilizzare l’esito referendario per poi riprendere il cammino delle privatizzazioni. Oggi si utilizza una strategia ben più subdola di quella sconfitta dal referendum, ovvero non si obbliga più alla privatizzazione ma si favoriscono i processi che puntano a raggiungere il medesimo obiettivo attraverso la promozione di operazioni di fusione e aggregazione tra aziende.
In che modo agisce questa tattica?
La strategia si incentra sulla creazione di alcune grandi aziende multiservizio quotate in Borsa, che gestiscono i fondamentali servizi pubblici a rete (acqua, rifiuti, luce e gas) e hanno un ruolo monopolistico in dimensioni territoriali significativamente ampie. Allo stato attuale s’intende far avanzare un processo di progressivo allargamento verso i territori limitrofi delle “4 grandi sorelle”: Iren proiettata in Piemonte, Liguria e la parte occidentale dell’Emilia-Romagna; A2A che tende a diventare l’unico soggetto gestore in Lombardia; Hera che occupa la parte dell’Emilia-Romagna che va da Bologna a Rimini e guarda a tutto il Triveneto e alle Marche; Acea che si espande dal Lazio all’Umbria, alla Toscana e parte della Campania. In questo quadro, s’inizia a delineare anche ciò che si muove nel Mezzogiorno, dall’accaparramento delle fonti alla creazione di un potenziale “gestore del Sud Italia” così come indicato nell’ultima legge di stabilità.
Questo ostracismo del sistema giustifica la mancanza di fiducia nelle forze politiche?
Certamente il mancato rispetto della volontà popolare e il sostanziale aggiramento dell’esito referendario ha contribuito ad approfondire la distanza tra la società civile e le forze politiche. A mio avviso ciò non può e non deve costituire un alibi per non proseguire un percorso di mobilitazione, sensibilizzazione e formazione volto all’azione.
Ad ogni modo cosa ha prodotto l’impegno dei movimenti per l’acqua pubblica?
A quasi 7 anni dal referendum possiamo dire di aver contenuto la spinta privatizzatrice, di aver contribuito non poco alla rottura socio-culturale sul tema della liberalizzazione dei servizi pubblici. Abbiamo costruito con testardaggine un fronte europeo, prima inesistente, senza il quale oggi saremmo sicuramente più deboli. Siamo riusciti ad analizzare approfonditamente i meccanismi del calcolo della tariffa e del reinserimento della remunerazione del capitale da parte dell’Aeegsi (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico), oggi Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e abbiamo avuto la capacità di strutturare un calcolo per l’autoriduzione delle bollette lanciando la campagna di “Obbedienza civile”.
Un cammino irto di ostacoli, dunque, ma con quali risultati?
Abbiamo pervicacemente lavorato alla promozione della nostra legge per la gestione pubblica del servizio idrico, anche contribuendo alla nascita dell’integruppo parlamentare per “L’acqua bene comune”, e l’abbiamo difesa con forza dall’ennesimo attacco del Pd e della maggioranza che alla Camera hanno stravolto la legge approvandone un testo che, a partire dalla soppressione dell’articolo 6 che disciplinava i processi di ripubblicizzazione, ne ha ribaltato il senso. Abbiamo costruito una campagna nazionale, anche attraverso la raccolta di 230.000 firme consegnate alla Presidente della Camera, contro l’approvazione dei “decreti Madia” sulle società partecipate e sui servizi pubblici tramite i quali il Governo si poneva l’obiettivo di rilanciare i processi di privatizzazione di tutti i servizi a rete, dall’acqua all’energia, dai rifiuti al trasporto pubblico locale, espropriando gli Enti Locali e le comunità territoriali di ogni facoltà nel determinare l’articolazione territoriale dei servizi e le politiche tariffarie. Anche grazie alla nostra mobilitazione il Governo è stato costretto a ritirare il decreto sui servizi pubblici locali. Una vittoria della mobilitazione e dell’applicazione della Costituzione!
Cosa avete da dire sull’esperienza dell’azienda ABC (acqua bene comune) promossa dal comune di Napoli?
Se facciamo riferimento alle grandi metropoli, ABC Napoli è un’esperienza unica in Italia. D’altra parte va ricordato che esistono molti altri comuni, di piccole dimensioni, che hanno ripubblicizzato il servizio idrico. L’amministrazione napoletana avviò la trasformazione della società per azioni (Arin S.p.A.) in azienda speciale subito all’indomani del referendum proprio a volerne recepire immediatamente l’esito. Il percorso è proseguito in maniera decisa e oggi ABC Napoli costituisce la prova che la ripubblicizzazione dell’acqua è possibile e s’inserisce a pieno nella tendenza internazionale che vede centinaia di municipalità in giro per il mondo riprendersi la gestione diretta del servizio idrico dopo anni di mala-gestione privata. Si tratta di un percorso molto complesso che abbisogna ancora di un passaggio fondamentale, la definizione compiuta della gestione partecipativa. La partecipazione alla gestione della comunità locale, intesa come comunità di lavoratori e utenti, è l’unico antidoto rispetto al rischio di replicare errori del passato, ossia una gestione pubblica poco attenta ai reali bisogni del territorio. La proprietà pubblica del bene è una condizione necessaria ma non sufficiente. Per questo il nostro auspicio è che a Napoli e in ABC si arrivi quanto prima a definire strumenti di partecipazione concreti e reali.
Quale è la vostra aspettativa verso un eventuale esecutivo a guida M5S?
Per il momento la stella dell’acqua pubblica non ha brillato particolarmente nelle amministrazioni pentastellate, a meno che non si portino a conclusione alcuni percorsi, che guardano alla gestione pubblica dell’acqua, faticosamente avviati a Roma e Torino. L’auspicio è che si tratti realmente di una stella e non di una meteora che svanisce alla prova del governo delle istituzioni.
Gli enti locali hanno tuttavia molto limiti nel loro operare…
I diritti vengono sempre più logorati anche mettendo sotto attacco gli Enti Locali e la democrazia di prossimità, senza la quale ogni legame sociale diviene contratto privatistico e la solitudine competitiva l’unico orizzonte individuale. Si restringono, così, i parametri del patto di stabilità interno facendo diventare gli Enti Locali i luoghi sui quali far precipitare la crisi. Si costruiscono meccanismi predatori attraverso l’imposizione di piani di rientro dal debito. Si realizza, così, la cosiddetta “trappola” del debito. Un debito per gran parte illegittimo creato dalla progressiva finanziarizzazione dell’economia e della società. Ciò che era socialmente inaccettabile, ovvero privatizzazioni dei servizi, vendita del patrimonio pubblico, restringimento degli spazi di democrazia, diviene politicamente inevitabile anche perchè interiorizzato da gran parte delle forze politiche che governano sia a livello nazionale che locale.
Quindi cosa resta da fare?
Di fatto non sussiste un impedimento concreto alla possibilità degli Enti Locali di riprendersi la gestione diretta del servizio idrico e quindi ripubblicizzare. Purtroppo, l’unico impedimento è l’assenza di volontà politica di una gran parte degli amministratori locali perché, di fatto, subalterni alla logica delle privatizzazioni e intimoriti da una serie di norme che rendono maggiormente complicata la strada della gestione pubblica, ma non impossibile. Le politiche monetariste e di austerità sono diventate lo strumento mediante il quale scaricare gli effetti sui cittadini. I vincoli di bilancio diventano prioritari rispetto alla garanzia dei diritti fondamentali. Di fatto siamo alla cinica attuazione dell’aforisma di Friedman secondo cui «lo shock serve a far diventare politicamente inevitabile ciò che è socialmente inaccettabile». Purtroppo la crisi sistemica nel nostro Paese si innesta dentro un profondo degrado delle istituzioni e della democrazia e dentro un’altrettanto profonda frammentazione delle relazioni sociali. L’aspettativa è che chi si candida a governare il nostro Paese abbia ben chiari quali siano i reali ostacoli per poterli affrontare e rimuovere.
Ripreso dal sito di Città Nuova, qui raggiungibile.
la Stampa online, 23 marzo 2018. i limiti dello "sviluppo" forsennato si sono superati da tempo, nonostante le prediche dei pochi capaci di guardare al di là del loro naso. Per ora il prezzo lo pagano gli sfrattati dallo sviluppo, ma domani...
«Nel 2050 143 milioni di persone saranno “migranti climatici” l rapporto della Banca mondiale sulle migrazioni climatiche chiarisce le enormi dimensioni un fenomeno potenzialmente devastante, con cui dovranno confrontarsi i Paesi nell’epoca del climate change»
“Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration”. Il titolo del rapporto della Banca mondiale sulle migrazioni climatiche, pubblicato lunedì 19 marzo, ha il merito della chiarezza. Perché tratta di un fenomeno di dimensioni enormi e dalle conseguenze potenzialmente devastanti, con le quali dovranno confrontarsi i Paesi nell’epoca del climate change.
Il rapporto concentra l’attenzione su tre regioni, l’Africa subsahariana, l’Asia del Sud e l’America latina, che rappresentano il 55% della popolazione dei Paesi in via di sviluppo. Gli esperti interpellati dall’istituto internazionale, stimano infatti che questa area geografica potrebbe subire degli spostamenti interni, al di là dei conflitti armati, di un’ampiezza pari a 143 milioni di persone entro il 2050.
L’istituto di Washington, tuttavia, non si accontenta di interpretare il ruolo della Cassandra, ma fornisce anche alcuni spunti di riflessione. “Il cambiamento climatico sta già avendo un impatto sugli spostamenti della popolazione e il fenomeno potrebbe intensificarsi”, afferma John Roome, responsabile dei cambiamenti climatici presso la Banca Mondiale. Ma se riusciamo a limitare le emissioni di gas serra e incoraggiare lo sviluppo attraverso azioni nel campo dell’istruzione, della formazione, dell’uso del territorio ... ci saranno “solo” 40 milioni di migranti climatici, e non 143 milioni, a cui queste tre regioni dovranno far fronte. La differenza è enorme”, sostiene il funzionario, convinto che una crisi migratoria su vasta scala possa evitarsi, purché si prevengano questi massicci spostamenti interni.
La Banca Mondiale basa le sue analisi su tre casi studio rappresentati da alcuni paesi in via di sviluppo: Etiopia, Bangladesh e Messico. Per ottenere le informazioni più accurate possibili, i ricercatori dell’Earth Institute della Columbia University, dell’Istituto di ricerca demografica della New York University e del Potsdam Institute per la ricerca sull’impatto del clima, hanno costruito un modello che incrocia diversi indicatori, come l’aumento della temperatura, i cambiamenti nelle precipitazioni, l’innalzamento del livello del mare, con dati demografici e socio-economici.
Seguendo la logica adottata dal gruppo di esperti del Panel delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (IPCC), i ricercatori hanno organizzato le loro proiezioni intorno a tre scenari: uno pessimista, in cui le emissioni di gas serra rimangono elevate e lo sviluppo economico diseguale; uno intermedio, dove l’economia migliora e le emissioni si arrestano; infine, uno scenario con un’evoluzione “compatibile con il clima”, che associa una riduzione delle emissioni a dei progressi nello sviluppo sociale.
Nello scenario “pessimista” esplorato dagli esperti, l’Africa subsahariana potrebbe doversi confrontare, alla fine del secolo, con uno spostamento interno di 86 milioni di persone. Mentre l’Asia meridionale e l’America latina, entro il medesimo orizzonte temporale, potrebbero registrare rispettivamente 40 e 17 milioni di migranti climatici.
Il rapporto evidenzia anche la molteplicità dei fattori che costringono le persone a lasciare i loro paesi d’origine, distinguendo delle caratteristiche specifiche proprie di ciascuna regione. In Etiopia, un paese prevalentemente agricolo e caratterizzato da una forte crescita demografica (fino all’85% entro il 2050), è il crollo dei raccolti che costituisce la prima causa di migrazione. Il Bangladesh è indebolito in particolare dall’erosione delle sue zone costiere e dalle difficoltà di accesso all’acqua potabile. Il Messico, invece, vede il dilagare nei centri urbani delle popolazioni che vivono nelle aree rurali colpite dagli effetti del riscaldamento globale.
Il campo di applicazione dello studio fa discutere. Gli autori del rapporto, decidendo di esaminare solo gli spostamenti superiori ai 14 chilometri, non hanno considerato le realtà dei piccoli stati insulari, che sono già oggi le prime vittime dei cambiamenti climatici. Il documento non fa neanche menzione delle discussioni in corso sulla definizione dello status giuridico di questi migranti climatici. Di fronte a questo vuoto giuridico, l’Assemblea generale delle Nazioni unite dovrebbe adottare il prossimo settembre, un Patto mondiale sulle migrazioni. Un’iniziativa che però è già stata indebolita da una decisione di Donald Trump. All’inizio di dicembre 2017, il presidente repubblicano ha annunciato infatti il ritiro degli Stati Uniti da questo progetto, perché giudicato incompatibile con la politica migratoria americana.
Articolo ripreso dalla pagina qui raggiungibile


la Stampa, 22 marzo 2018.Non sembra che l'attuale presodente del Brasile sia un ambientalista a 18 carati, ma l'iniziativa che sponsorizza, ospita e illustra in questo scritto è indubbiamente interessante
L’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici di base - tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e condizione per la vita umana - è un diritto. Oppure 2 miliardi di persone nel mondo sono prive di una fonte d’acqua sicura in casa; circa 260 milioni, più dell’intera popolazione brasiliana, devono camminare più di mezz’ora per raggiungerla e 2,3 miliardi hanno carenza di servizi igienici. Garantire l’accesso a questo bene è una delle principali sfide del nostro tempo.
In Brasile si concentra il 12% dell’acqua dolce del pianeta, eppure non siamo immuni dai problemi relativi all’acqua. Le grandi città hanno affrontato la mancanza di approvvigionamento, ma persiste l’inaccettabile carenza di servizi igienico-sanitari. È nota la sofferenza che le siccità causano nel Nordest brasiliano.
Per rispondere a tali pressanti domande ospitiamo in questi giorni a Brasilia l’
ottavo Forum Mondiale dell’Acqua, con più di 40 mila partecipanti provenienti da oltre 160 Paesi. Sono presenti capi di Stato e di governo, governatori e sindaci, parlamentari e magistrati, rappresentanti di organizzazioni internazionali e del mondo accademico, del settore privato e della società civile. Una diversità di attori che arricchisce il Forum.
La scelta del Brasile come Paese ospitante del più importante evento globale sulle risorse idriche non stupisce. Abbiamo già ospitato Rio 92 e Rio +20, in cui si è sottolineato lo stretto rapporto tra sostenibilità idrica e sviluppo. Più di recente, siamo stati tra i primi a ratificare l’Accordo di Parigi su una delle principali minacce al diritto all’acqua: il cambiamento climatico.
Questo tradizionale protagonismo estero è ancorato a misure concrete sul piano interno. Il Brasile è consapevole che acqua e servizi igienico-sanitari sono sinonimi di preservazione ambientale e noi abbiamo fatto della sicurezza idrica il pilastro delle nostre politiche per l’ambiente. Per preservare i corsi d’acqua, abbiamo implementato il programma «Piantatori di fiumi», con l’impiego di strumenti digitali nella difesa delle sorgenti e delle aree di preservazione permanente.
Abbiamo fatto grandi progressi anche nella protezione delle foreste, ampliando le aree di conservazione e invertendo la curva della deforestazione in Amazzonia, in precedenza in ascesa. E stiamo per creare due vaste aree di tutela della biodiversità marina. È così, proteggendo gli ecosistemi, che proteggeremo le nostre fonti d’acqua. Avere acqua è essenziale, ma non sufficiente. È necessario che essa raggiunga chi ne ha bisogno.
Proprio di questo tratta un antico progetto, la trasposizione del fiume São Francisco, che stiamo ultimando a beneficio di 12 milioni di abitanti del Nordest. Già concluso l’asse che porta acqua in Pernambuco e Paraíba, siamo ora nella fase finale del tratto che raggiungerà il Ceará. Nel contempo, non trascuriamo la sostenibilità: abbiamo lanciato il progetto «Novo Chico», teso alla rivitalizzazione del fiume São Francisco.
Quanto ai servizi igienico-sanitari, stiamo concludendo un progetto di legge teso a modernizzare il quadro normativo del settore e incoraggiare nuovi investimenti. A spingerci è la ricerca per l’universalizzazione di questo servizio di baseQuesto è il Brasile che ospita il Forum Mondiale dell’Acqua: un Brasile in cerca di soluzioni comuni per problemi globali, che fa e continuerà a fare la propria parte per preservare la nostra risorsa naturale più preziosa.
L'autore è Presidente della Repubblica Federativa del Brasile
Avvenire, 21 marzo 2018. Scoppiano ancora guerre per il possesso di uno dei più preziosi beni comuni dell'umanità. Sempre più frequenti e sanguinose saranno se parsimonia di risorse scarse e austerità negli stili di vita non prevarranno anche nei popoli spreconi
Dopo le città ortogonali inventate dai greci e quelle fortificate nel Medioevo, stiamo entrando nel secolo delle «città-spugna»? C’è da augurarselo, suggerisce l’ultimo rapporto Onu sulla valorizzazione delle risorse idriche mondiali, appena pubblicato con il titolo: «Le soluzioni fondate sulla natura per la gestione dell’acqua». In Cina, «entro il 2020, 16 “città-spugna” pilota saranno costruite su una superficie di oltre 450 chilometri quadrati, con più di tremila progetti di costruzione previsti e investimenti per un ammontare totale di 8,65 miliardi di yuan», evidenzia il rapporto, a proposito degli abitati avveniristici dotati di tetti vegetalizzati, rivestimenti permeabili al suolo ed altre soluzioni per captare, canalizzare, purificare, riutilizzare l’acqua piovana, di fronte al rischio di una grande sete planetaria nei prossimi decenni, fra crescenti consumi e annosi sprechi.
Ma gli scenari pessimistici non sono ineluttabili, sostiene il rapporto, presentando le strade già percorse o percorribili apparentate alle città-spugna. Ad accomunarle è il fatto di abbinare spesso l’ingegneria idraulica “grigia” convenzionale (acquedotti, canalizzazioni, sbarramenti ecc.) con soluzioni sapienti di gestione idrica che imitano la natura, oppure sfruttano processi chimico-fisici naturali. Certe pratiche anche antiche, spesso finanziariamente vantaggiose e talora inclusive delle popolazioni locali, potranno correggere la cecità mostrata nei contesti urbani e non in cui si è abusato del cemento.
La preservazione di ecosistemi umidi nelle campagne limita le inondazioni che hanno minacciato di recente pure Parigi ed altre grandi capitali, permettendo al contempo di alimentare gradualmente le preziosissime falde acquifere sotterranee. L’emergenza sete c’è già e lo si è visto anche a Roma e in altre città italiane. «Un terzo dei più grandi sistemi d’acqua sotterranei del mondo sono già in situazione di sofferenza», evidenzia lo studio, prefigurando gli scenari futuri: «Un forte aumento dei prelievi delle acque sotterranee dell’ordine di 1.100 chilometri cubi è previsto entro il 2050, il che corrisponderebbe a un aumento del 39% rispetto ai livelli attuali». Ampiamente trascurate in passato, le tecniche “verdi” appaiono vieppiù come un possibile salvagente planetario. Questo cambio di rotta «è essenziale per affrontare il problema della penuria d’acqua attraverso il capitolo dell’approvvigionamento idrico», soprattutto perché l’approccio “verde”’ «è riconosciuto come il principale modo per garantire la sostenibilità delle risorse idriche per l’agricoltura ».È infatti proprio per irrigare i campi che si consuma e si consumerà ancora gran parte dell’acqua necessaria all’umanità: oggi circa il 70%, contro il 10% per usi domestici e il 20% per l’industria. Favorire con soluzioni naturali la penetrazione graduale dell’acqua piovana nei suoli, attraverso tecniche conservative di aratura, semina, policoltura o silvicoltura, appare dunque ormai una posta in gioco decisiva. Se resta vero che «i flussi ascendenti e discendenti d’acqua e d’energia attraverso il suolo sono vasti e strettamente legati», come ricorda il rapporto, non si dovrà più sottovalutare un’oculata preservazione del ciclo idrogeologico, più che mai vitale per le popolazioni di tanti territori. Soprattutto nelle città e campagne d’Africa ed Asia, dove si prevede la maggiore crescita di popolazione del secolo.
Studio sintetico a cura dell’Unesco in cui convergono dati e lavori anche di altre agenzie Onu, sostenuto finanziariamente dal Governo italiano e dalla Regione Umbria, il rapporto coincide con l’8a edizione del Forum mondiale dell’acqua a Brasilia (18-23 marzo) e la Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo).A Brasilia il Forum mondiale sul più prezioso dei beni Le Nazioni Unite rinnovano l’allarme sull’emergenza-sete. Valorizzare le risorse.
Articolo tratto da Avvenire, dalla pagina qui raggiungibile
Ci sono luoghi dove la popolazione è ancora saggia e si rifiuta di sacrificare un paesaggio secolare, vissuto come patrimonio indennitario - e al tempo stesso universale - immolandolo a uno sviluppo energiforo e lontano. Accade in Sardegna, in Barbagia"
La Sardegna soleggiata e ventosa, prateria per le scorribande dei nuovi speculatori dell'energia. Ideale la bassa densità abitativa, ovviamente favorevole la circostanza dei grandi spazi vuoti per accogliere gli impianti da fonti rinnovabili: lontano dagli occhi potrebbe svanire l'attenzione sull'impatto. Difficile invece contenere i timori delle popolazioni che cominciano a reagire in modo inatteso ai tentativi di insediare torri eoliche e distese di specchi pure nelle campagne distanti.
Tocca ora a Bitti (Nuoro) sentire forte la minaccia. Quanto basta perché si ribelli la comunità: orgogliosa, forte di un sentimento civico che non ti aspetti da un gruppo sociale di 3mila abitanti (6mila, a metà del secolo scorso). Eppure basta guardarsi attorno per capire la relazione tra i bittesi e il paesaggio: si vede nell'ordine del territorio alle quote più elevate come nell'area urbana. Un' appartenenza alle strade e alle piazze. Lo dice quella ventina di chiese in un tessuto minuto ma costituito da tanti quartieri, più delle contrade di Siena.
Una concentrazione di intellettuali che non si trova nelle città, personalità autorevoli con lo sguardo curioso sul mondo, come Giorgio Asproni a metà Ottocento in contatto con Garibaldi, Cattaneo, Bakunin.
 |
| le case e i monti di Bitti |
Potrebbe cambiare per sempre il paesaggio attorno a Bitti. Si vedrebbe da molto lontano quella dozzina di torri eoliche in programma, alte 150 metri (poco meno della Mole Antonelliana). Con l'esteso corredo infrastrutturale che interromperebbe continuità ecologiche e potrebbe fare scempio di biodiversità e di beni culturali. Un danno per le attività agropastorali. Ma nel nome della solidarietà energetica nazionale. Come se l'isola non avesse già dato un sostanzioso contributo alla industrializzazione del Continente tra Otto e Novecento. Grandi quantità di legna e carbone vegetale – carburante di qualità – per fare girare le macchine a vapore altrove, dai telai ai battelli. Il patrimonio boschivo dell'isola ridotto in quel tempo di circa il 70%, e non solo a causa di incendi – come dimostrano gli studi di Fiorenzo Caterini. Tantissimi alberi sardi sacrificati per conservare le foreste di altre regioni. Nell'isola si chiamavano selve – sovrabbondanti per i bisogni di pochi abitanti – , e alle quali si dava poco valore.
 |
| Quartetto vocale di Bitti |
Ed è toccato al forestiero Alberto Larmora contrastare con successo il programma di un avvocato modenese, pronto a portarsi via – praticamente gratis – 100mila querce. Un caso fortunato, figurarsi in quell'epoca. La Sardegna povera e condiscendente: condannata a subire progetti di chi prendeva senza restituire nulla, come solo alcuni hanno osservato sollecitamente. Ad esempio Gramsci che nel 1919 imputava ai piemontesi la distruzione delle foreste dei sardi “ai quali non hanno mai dato scuole, né acquedotti, né porti, né giustizia (...)”.
L'aggressione è proseguita, e nel secondo Novecento con un rovesciamento del paradigma. Mettere invece di portare via. Fabbriche inquinanti, poligoni militari, e di recente gli impianti per catturare sole e vento, le trivelle in attesa. Nelle coste il ciclo edilizio perpetuo. Tutto favorito dalla poca popolazione dell'isola e dal valore sottostimato di terre. E secondo la convenienza degli investitori guardati con fiducia malriposta. Si credevano benefattori come oggi il gruppo Siemens-Gamesa deciso ad accomodarsi nel tranquillo altopiano di “Gomoretza” a Bitti, raccontandolo come “giacimento energetico rinnovabile” dove i giovani bittesi saranno addestrati alle professioni hi-tech da esportare nel mondo. La parodia della storia che si ripropone nelle forme tragiche della postmodermità. Produrre energia nell'isola per rivenderla chissà dove, benché in Sardegna non ne serva e quella utilizzata costi di più. Il solito paradosso dello sfruttamento di territori che arricchisce pochi e trasferisce i benefici altrove.
Si comincia a capirla la sconvenienza, pure dove la vita è grama e le promesse di lavoro ovviamente allettanti. Per questo il dissenso all'impianto a “Gomoretza” assume un valore simbolico. Grazie al Comitato “Santu Matzeu”, a guida femminile, che non vuole quelle macchine rotanti nell'orizzonte di Bitti. E ha deciso di combattere perché le terre non perdano la vocazione agropastorale.
 |
| Costume femminile |
E la Regione ? Aveva fatto la mossa giusta: la delibera di Giunta del 7/8/ 2015 per indicare i siti non idonei all' installazione di impianti eolici. Necessaria dopo i tentativi di contenere gli effetti del D.Lgs. 387/2003 in materia di energia censurati dalle sentenze della Corte Costituzionale: giudicato “astratto” il diniego agli aerogeneratori e simili. Si trattava di coglierle fino in fondo le sollecitazione dei giudici costituzionali ad esercitare le prerogative regionali per installare gli impianti da fonti rinnovabili nei luoghi più adatti. E compatibilmente con l'interesse pubblico. Oggi ci si interroga se un successivo atto – peraltro annunciato nella delibera – e soprattutto l'estensione del Ppr alle zone interne, non avrebbero consentito di rimediare ai difetti dell' art. 112 delle Norme di attuazione del Ppr, dove peraltro si rimanda a uno “studio specifico” per stabilire la localizzazione di impianti eolici. Senza questi adempimenti supportati dalle motivazioni per la tutela del paesaggio rurale, sarà complicato difendere il territorio di Bitti e di altri comuni isolani. Ma provarci è indispensabile. E conterà, come in altre occasioni, l'attenzione dell'opinione pubblica del Paese.
la Repubblica, 17 marzo 2018. Napoli, città dei contrasti: da un lato un complesso conventuale, San Paolo Maggiore, che si disfa per l'incuria dei suoi vecchi tutori, e dall'altro Sant'Eframo Nuovo, che resuscita e diventa Je so' pazzo, grazie all'ingresso di un nuovo popolo risanatore.
Il corpo di Napoli si disfa, ci precipita addosso. Non è un incidente quello di ieri, non una fatalità: ma l’ovvia, annunciatissima conseguenza di decenni di abbandono.
Quando, nel pieno Seicento, Napoli era la più grande metropoli d’Italia e una delle prime d’Europa, nel suo cuore antichissimo sorse una città nella città. Centinaia di chiese, conventi, monasteri, confraternite: una immensa ‘Napoli sacra’ che non conteneva solo luoghi di culto o dormitori, ma anche chiostri in cui il silenzio era rotto solo dalle acque abbondantissime delle fontane; incantati e profumatissimi giardini di agrumi; biblioteche; farmacie; opere d’arte d’ogni sorta. «Non è omo che non la brami, e che non desideri di morirvi … Napoli è tutto il mondo!» scriveva l’accademico Ozioso Giulio Cesare Capaccio nel suo Forastiero (1634). Il convento di San Paolo Maggiore era uno dei luoghi più illustri di questo ombelico del mondo: sorto sull’agorà della Napoli greca, ridette vita al tempio dei Dioscuri, usandone le colonne e conservandone l’aura. Ed è in uno dei suoi due chiostri che ieri sono venute giù due volte: senza provocare una strage solo per miracolo.
I lavori in corso erano quelli del Grande Progetto Unesco che, lentissimamente, sta finalmente provando a salvare ciò rimane del centro di Napoli. Dove nel Seicento si visitavano 400 chiese, quelle accessibili e in discrete condizioni sono oggi una cinquantina. Almeno altre duecento esistono ancora: ma sono sprangate per tutti tranne che per i ladri che le spogliano inesorabilmente di marmi barocchi che finiscono nelle ville dei boss, o sul mercato internazionale. Moltissime altre sono chiuse, spesso dal 1980: pericolosamente siringate di cemento dopo il terremoto, e poi riempite di ponteggi, disseminate di piccioni e topi in decomposizione, coperte da una infinita coltre di polvere.
Negli ultimi decenni questa vertiginosa e perduta Napoli Sacra è stata la grande rimossa di ogni politica culturale. Lo Stato, il Comune e la Curia (i principali proprietari di un patrimonio frammentatissimo) si sono dedicati agli eventi, all’industria delle mostre, da ultimo ai musei: dimenticando, però, il corpo di Napoli. Che ora ci ricorda che esiste nell’unico modo possibile: sfarinandosi.
Sono mancati i soldi, certo. Ma prima ancora l’attenzione, l’amore, la conoscenza: e, soprattutto, un progetto unitario. Una visione chiara di come ridare senso a questa enorme città nella città senza stravolgerne il carattere storico e artistico, anzi tutelandolo ed esaltandolo. Mentre la Curia affitta chiese mirabili a improbabili imprenditori, e il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno organizza mostre con i pezzi pregiati, solo la giunta di De Magistris ha dimostrato di avere un’idea: per esempio destinando l’ex Asilo Filangieri (che è parte di una altra grande insula monastica, quella di San Gregorio Armeno) ad un esemplare uso civico. È da qua che bisogna ripartire: perché la nostra generazione non salverà il corpo di Napoli se non saprà dargli un’anima nuova.

la Nuova Venezia, Corriere del Veneto, 13-15 marzo. Per salvare 5 aziende, e all'insegna di “consumo zero di territorio” si dà il via allo scempio: la cava in galleria nel Parco dei Colli Eugani. (m.p.r.)
la Nuova Venezia, 15 marzo 2018
CAVE, SI' ALLA LEGGE
«ORA SI VOLTA PAGINA»
di Albino Salmaso
«Nuove norme approvate: via libera ai tunnel per estrarre la trachite nel Colli Euganei ma stop a nuove concessioni»
Venezia. Piano cave, tutti d'accordo: dopo 36 anni di anarchia si gira pagina. La frase porta la firma di Maurizio Conte e Maurizio Calzavara, che hanno dato l'imprinting alla legge, approvata con 31 sì e 14 no (Pd e M5S e Cristina Guarda di Amp). La filosofia è il "consumo zero" del territorio, con lo stop a nuove concessioni e il test verità ci sarà la prossima settimana con il Prac. La legge Fracanzani varata nel 1971 per la tutela dei Colli Euganei finisce in soffitta e si apre la stagione delle "gallerie di trachite" per salvare cinque aziende tra Vo, Zovon, Montemerlo e Cervarese Santa Croce: quelle pietre formatesi 35 milioni d'anni fa, nell'era dell'Oligocene, sono un tesoro per la tutela dei centri storici.
Senza "masegne" di trachite, Venezia sarebbe una distesa di brutale cemento e così le piazze medievali di Padova, Vicenza e Verona e di mezza Italia, ma c'è sempre un punto di equilibrio da rispettare: la tutela dell'ambiente. E su questo tema il confronto si è fatto molto serrato, con il Pd e il M5S che hanno dato battaglia, con un insolito battibecco tra Andrea Zanoni e Silvia Rizzotto. «I comuni sono stati spogliati di ogni potere e si lascia assoluta libertà agli imprenditori nell'apertura di cave» ha detto il consigliere Pd durante la presentazione di uno dei suoi sessanta emendamenti, tutti bocciati. Immediata la replica della capogruppo della Lista Zaia: «Ma consigliere Zanoni, lei ha letto bene la legge? Ha capito o no che abbiamo impedito l'apertura di nuove cave? Zero concessioni. Ripeto: si congela la situazione attuale» ha urlato la capogruppo Silvia Rizzotto per dare il buongiorno all'aula, verso le 11.40 di ieri.
Lo scoglio più duro, l'articolo 32, ha occupato tre ore di dibattito, con il Pd e il M5S contrari al «colpo di mano maturato in commissione e mai discusso». È sempre Andrea Zanoni che va all'attacco, sostenuto da Graziano Azzalin e Claudio Sinigaglia: «L'articolo 32 arriva fuori sacco in commissione e si configura in aperta contraddizione con la legge istitutiva del parco dei Colli Euganei perché cancella il vincolo ambientale naturalistico per anteporre gli interessi di poche aziende». Luciano Calzavara, l'ex sindaco di Jesolo e relatore del provvedimento, non si perde d'animo: «È stato il comune di Vo a chiedere la sperimentazione delle cave-tunnel di trachite, si parte con una concessione di cinque anni nel rispetto di due esigenze: tutelare l'ambiente e bloccare lo sfregio dei Colli Euganei e al tempo stesso garantire la fornitura di questo pregiato materiale ai sindaci che vogliono rendere più belle le nostre città».
Alle 13 si passa alle dichiarazioni di voto. Parla Manuel Brusco del M5S: «La svolta è troppo timida, ci vuole più coraggio nelle sanzioni contro chi sgarra. Le Province sono tagliate fuori. Voteremo contro», dice l'alfiere delle battaglie contro i Pfas. Parla Massimo Giorgetti, (FI), che bacchetta Zanoni perché il governo Gentiloni ha impugnato alla Corte costituzionale la norma con cui il Veneto blocca le nuove cave: Roma sostiene che abbiamo violato la direttiva Bolkestein sulle liberalizzazioni e voi ci fate la predica. State zitti che vi conviene.
Ci sono delle norme rivoluzionarie: nelle aree ricomposte delle cave si potranno coltivare i noccioli per la Nutella o la marijuana per attività terapeutica senza sprecare territorio. Mi piacerebbe un voto unitario». Richiesta respinta. Pd e M5s non abboccano alla "cava alla marijuana": dopo il ko alle elezioni, per rianimare i Dem ci vorrebbe un doping stile Armstrong, mentre i grillini sono già gasati dal trionfo e non cedono alle tentazioni. Parla anche Sergio Berlato, che la butta in politica e punzecchia Azzalin del Pd. «Mi prendete in giro, ma se avessi voluto andare a Roma mi sarei candidato in un collegio uninominale blindato. Non sono uno stolto né un dilettante allo sbaraglio. Ho assolto al mio compito e la lista Fratelli d'Italia della Meloni è passata da 0 a 5 parlamentari. Il nostro successo è strepitoso, mentre il Pd piange ancora per la tremenda sconfitta. Non sono io a bloccare il riordino dei parchi naturali in Veneto». Poi si vota e finisce 31 a 14. E il presidente Roberto Ciambetti commenta: «Sono soddisfatto, è una riforma tra le più rilevanti di questa legislatura».
Corriere del Veneto, 13 marzo
CAVE, SCOPPIA IL CASO COLLI EUGANEI
LA REGIONE VUOLE SCAVARE NEL PARCO
di Angela Tisbe Ciociola
Padoova. Per secoli ha costituito una fonte di ricchezza per tutto il territorio della Serenissima, che l’ha usata come base per i nobili edifici che si affacciavano sulla laguna. Poi, negli ultimi decenni, la trachite, pietra estratta dai fianchi dei Colli Euganei, è piombata al centro delle polemiche: le sue cave, che hanno scavato le colline padovane tra Cervarese Santa Croce, Vo’ e Galzignano, oggi territorio protetto da un parco regionale (anche se commissariato e al centro di molti cambiamenti), da macchina da soldi erano diventate un attentato alla bellezza dell’area, e per questo motivo nel 1971 venne approvata una legge per impedire l’estrazione della trachite.
La proposta di legge regionale
Ecco perché la proposta di legge regionale che approderà martedì in Consiglio regionale a Venezia ha tutti i presupposti per suscitare un vero vespaio. La Commissione ambiente, infatti, ha inserito un emendamento, l’articolo 32, che regola le «disposizioni in materia di coltivazioni di trachite nel Parco dei Colli euganei». Stando al testo che martedì potrebbe essere approvato dall’assemblea di palazzo Ferro Fini, «al fine di incentivare l’impiego di metodi di coltivazione (cioè estrazione, ndr) innovativi rispetto a quelli tradizionali, funzionali alla diminuzione del consumo del territorio, delle alterazioni del paesaggio e degli impatti ambientali negativi, possono essere autorizzate, anche a titolo di sperimentazione operativa, attività di cava per l’estrazione di trachite, in deroga alle limitazioni contenute nel Piano ambientale e nel Progetto tematico cave».
Ma cosa significa tutto questo? «È una bella domanda - commenta il consigliere del Pd Claudio Sinigaglia -. In pratica viene data nuovamente l’autorizzazione a scavare in un parco naturalistico senza che venga specificato quanto si potrà scavare, quanto a lungo o quanto a fondo. È vero, parlano di metodi innovativi, quindi non ci saranno più le cave a cielo aperto come ci sono state fino ad ora: le aziende promettono che scaveranno solo gallerie in profondità, quindi tutto rimarrà nascosto alla vista e che tutto è soggetto all’approvazione di Comuni ed Ente parco. Ma tutto il materiale ricavato dovrà essere trasportato lontano. Questo significa che ci sarà un via vai di camion, con tutte le conseguenze su viabilità e inquinamento. E il rumore?».
Lo scontro politico
E se, interpellati, l’assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin e il presidente di Commissione Francesco Calzavara non hanno risposto, la minoranza promette battaglia. Anche perché il discorso è più ampio. «Tutto è partito da un contenzioso tra Regione e aziende che volevano un piano cave che, in Veneto, manca da 36 anni - chiarisce il consigliere dem Andrea Zanoni -. Due sentenze, una del 2014 e una del 2016, avevano stabilito la realizzazione di un Prac, un Piano regionale per le attività di cava, entro il marzo del 2018. I tempi ormai sono stretti. Quindi l’approvazione della legge è indispensabile per l’approvazione del Prac che dovrebbe arrivare in Consiglio la prossima settimana».
A dare il là all’emendamento, continua a spiegare Zanoni, è stata una proposta avanzata da Confindustria nell’agosto del 2017. «Sono state le aziende a chiedere nuovi scavi, esattamente con le stesse parole poi inserite nell’emendamento». Se lo scorso anno, quindi, Regione e associazioni ambientaliste si erano scontrate sulla modifica dei confini del Parco dei Colli Euganei, pensata per permettere la caccia ai cinghiali, con il progetto di legge di Sergio Berlato, il capogruppo di Fratelli d’Italia-An e patrono delle associazioni venatorie, favorevole a «riclassificare» il parco riducendo della metà la fascia di protezione (con la grande maggioranza dei Comuni che si è detta contraria), la questione delle cave si preannuncia altrettanto sensibile e promette di creare diversi problemi. Non c’è pace, quindi, per i Colli Euganei.

la Nuova Venezia,
11 marzo 2018. Intervista di Vera Mantengoli a Ugo Mattei. La sentenza del Tar su Poveglia spiana la strada per la riforma dei beni comuni. E sullo sgombero della Vida, la distinzione tra legale e legittimo. (m.p.r.) con riferimenti
La sentenza del Tar su Poveglia farà scuola nell'ambito giuridico e spianerà la strada alla riforma legislativa che la Commissione Rodotà sui beni pubblici auspica da anni. Lo conferma il docente Ugo Mattei, giurista torinese, autore di Beni comuni. Un manifesto, professore di Diritto internazionale a San Francisco e di Diritto civile a Torino. Mattei segue dall'inizio la storia dell'isola e ha letto con soddisfazione le parole del Tar.
Professore, cosa pensa della sentenza?
«È molto positiva. È un segno che il Tar si è messo in sintonia con un'evoluzione culturale molto avanzata che noi giuristi dei beni comuni e della Commissione Rodotà, nominata nel 2007, portiamo avanti da anni. Non c'è stata ancora una riforma, ma in tutta Italia qua e là si stanno facendo piccoli passi che dimostrano che, quando la cittadinanza è attiva e si rivela capace di prendersi cura di un bene, lo può gestire».
Conosceva il caso Poveglia?
«Certo, la laguna nella storia dei beni comuni inizia a essere un luogo molto interessante, a partire dalla sentenza nel 2011 sulle valli da pesca che ha proprio introdotto il concetto di bene comune, parlando di interesse della collettività. A maggior ragione adesso con Poveglia parliamo di un bene prezioso che è all'interno di un altro bene prezioso come la laguna. L'interesse collettivo mi sembra evidente».
Il Demanio dice che la parte edificata crolla e c'è bisogno di un intervento.
«La mancanza dei soldi che spesso viene tirata in ballo dalle istituzioni non può diventare una scusa per arrendersi a politiche di estrazione di valore dei beni comuni».
Che differenza c'è tra bene demaniale e bene comune?
«Il bene demaniale è quando il proprietario è l'apparato dello Stato che lo gestisce in totale libertà, magari vendendolo per usare i soldi a fini pubblici, ma quel bene è come se fosse suo. Si dice invece bene comune quando il bene è assegnato alla cittadinanza e lo Stato apparato, in nome dell'interesse delle generazioni future, non persegue l'interesse proprio. In questo caso lo Stato è servitore del popolo, in particolare quando viene dimostrato l'interesse pubblico e l'impatto sociale. Ecco, la sentenza del Tar su Poveglia pone le basi per questo ragionamento ed è per questo che il Demanio dovrebbe ritirare subito il bando e lasciarlo ai cittadini».
Ci sono altri casi simili in Italia?
«Certo, la battaglia dei cittadini per Poveglia non è solo veneziana, ma è nazionale e per questo è importante. Potrebbe creare un precedente o rafforzare delle situazioni analoghe dove i cittadini si sono dimostrati capaci di gestire e rendere fruibile un bene. Poveglia è in linea con quello che avviene in tanti altri posti in Italia, come la "Fattoria senza padroni" di Mondeggi a Firenze, la "Cavallerizza Irreale" di Torino o l'"Asilo Filangeri" di Napoli».
Quando si parla di bene comune?
«Un bene comune lo diventa una qualsiasi proprietà nel momento in cui si costituisce una comunità attorno che dimostra di essere attiva e si obbliga a renderlo aperto a tutti, senza l'esclusione di nessuno, rendendo quindi difficile qualsiasi alienazione. Mi viene in mente il Teatro Valle, un'occupazione che ha messo in luce una cittadinanza molto attiva. Ed è proprio su quell'onda che al Lido venne occupato il Teatro Marinoni che, con le numerose attività, contribuì a mantenere pubblico il teatro del vecchio Ospedale al Mare, dimostrandone l'interesse collettivo».
A proposito, in questi giorni a Venezia si parla anche del caso La Vida. Lei era intervenuto su Radio Tre, qual è il suo punto di vista?
«Ero intervenuto per spiegare la differenza tra legale e legittimo. Viviamo nel culto del principio di legalità, in particolare le amministrazioni si trincerano dietro a ciò, ma quando si porta avanti un interesse più alto, l'atto di resistenza è legittimo e il diritto piano piano si adatta. Pensiamo a Rosa Parks. Lei, non cedendo il posto in autobus a un bianco, ha compiuto un atto illegale, ma lo ha fatto in nome di un principio superiore, quello dell'uguaglianza, quindi è stata un'azione legittima. Il diritto non è rigido e la sentenza lo dimostra. Dal 15 al 18 marzo a Torino parleremo di beni comuni a "Legacy", in memoria di Rodotà che conosceva il caso Poveglia. Ora i cittadini non devono abbassare la guardia e, a mio parere, l'isola non dovrà mai diventare un albergo».
Riferimenti
In eddyburg abbiamo raccolto una serie di articoli su Poveglia. Qui vi segnaliamo i più rilevanti: l'articolo di Vera Mantengoli sulla sentenza del TAR, che da ragione all'associazione riconoscendo immotivato il diniego del Demanio e l'utilità sociale della proposta dell'associazione; la nota Poveglia per tutti: una ricchezza da non perdere e il dossier realizzato dall'associazione "Poveglia per tutti" sulle vicende dell'isola.
 In concomitanza con la Biennale d'architettura, verranno esposti all'Arsenale i progetti commissionati all'IUAV per camuffare il MoSE, per tentare di convincere almeno gli stranieri che il mostro s'ha da fare. Con riferimenti
In concomitanza con la Biennale d'architettura, verranno esposti all'Arsenale i progetti commissionati all'IUAV per camuffare il MoSE, per tentare di convincere almeno gli stranieri che il mostro s'ha da fare. Con riferimenti
In occasione della nuova Biennale di Architettura, che sarà inaugurata il prossimo maggio, riemergono i progetti per abbellire il MoSE, e rendere esteticamente più accettabile l’insieme delle pesantissime infrastrutture di cemento, ferro e acciaio che comporranno il Mose, volute, progettate e in costruzione da parte del gruppo di imprese Consorzio Venezia Nuova (CVN).
Ai lavori di abbellimento era stato già dato il nome di “mutandoni”, finalizzati come sono a nascondere le più evidenti vergogne del Mose. La loro confezione era stata affidata all’Università Iuav di Venezia, e alla sua società di progettazione di diritto privato, ISP, per un compenso di circa un milione di euro.
La confezione dei "mutandoni" era stata accantonata a causa delle inchieste giudiziarie sul MoSE, dalle quali sono emersi episodi di corruzione, tangenti, intese private tra controllori e controllati, fondi neri destinati a ungere le ruote dei controlli: uno scandalo che ha coinvolto politici, amministratori, imprese, magistrato alle acque, ministeri, guardia di finanza, e corte dei conti. Ora, il commissario all’attuazione del Mose, Giuseppe Fiengo, che ha sostituito il CVN è pronto a riprendere i "mutandoni", a dar loro una ripassata a e coprire di nuovo le vergogne perchè il pubblico della Biennale non le veda.
I progetti di abbellimento, camuffamento e inserimento paesaggistico saranno esposti nei locali della Thetis Spa (una società di ingegneria ambientale, coinvolta nella realizzazione del Mose) all’Arsenale, proprio laddove si tiene anche la Biennale, ma senza per ciò dover passare attraverso il processo di selezione richiesto agli altri soggetti che vogliano partecipare alla Biennale. La posizione della sede della Thetis (e del CVN), adiacente ai locali della Biennale consente di sfruttare la visibilità mediatica e dar rilievo ai progetti dei "mutandoni".
L’insieme dell’operazione, progettata con una sostanziale intesa tra Consorzio Venezia Nuova e Università Iuav, di Venezia ha l’evidente scopo di richiamare l’attenzione sui "mutandoni" per distrarla dallo scandalo del Mose. Fuor di metafora, per allontanare l’attenzione dalla mostruosa creatura, che sta già vistosamente confermando la sua inutilità, rivelando l’impossibilità tecnica di realizzazione, e preoccupando tutti per la gigantesca quantità del finanziamento necessario per la sua realizzazione, gestione e manutenzione.
Non tutti hanno taciuto. Una lettera aperta di protesta è stata inviata al presidente della Biennale Paolo Baratta, al rettore dello Iuav Alberto Ferlenga e alle curatrici della Biennale. È firmata dalle associazioni Ambiente Venezia, Sale Docks, Laboratorio Morion, Comitato No Grandi Navi, che chiedono di “rimediare” a questa decisione, dando la possibilità di esporre «gli innumerevoli studi e progetti alternativi al Mose, le critiche inascoltate alla grande opera, i materiali dell’epoca su mobilitazioni e proteste».
Baratta replica che gli spazi della Thetis non fanno parte della Biennale, e lo IUAV afferma che la mostra, semplicemente in concomitanza con la Biennale, è un contributo che va al di la del giudizio sul Mose, come se il coinvolgimento e l’operato dello Iuav, in quanto università, non possa essere sindacato.
Indipendentemente dalla qualità estetica dei "mutandoni" e dall’accessibilità che le opere di camuffamento apportano, il MoSE rimane un intervento inutile e dannoso. Oggi, più che mai, con tutto quello che è emerso (per una sintesi vedi qui sotto i riferimenti) perpetuare la strada della realizzazione del Mose, con o senza "mutandoni", significa appoggiare il progetto e avallare, seppur indirettamente, l’operato del Consorzio Venezia Nuova.
Riferimenti
Per leggere le ultime notizie dai giornali qui l'articolo sulla mostra e qui l'articolo sulla protesta di comitati e associazioni. Per una sintesi sul MoSE e il Consorzio Venezia Nuova si legga l'eddytoriale 174. Di seguito i link di alcuni articoli di approfondimento: Edoardo Salzano, Il Mose, storia di un conflitto tra interesse privato e natura, ottobre 2005; Eddytoriale 103, aprile 2007; Armando Danella, MoSE: prima che sia troppo tardi, luglio 2010. Vedi inoltre qui, nella cartella del vecchio eddyburg e qui, nella cartella dell'attuale archivio, tutti gli articoli pubblicati da eddyburg sul MoSE.

terraterraonline, 11 marzo 2018. Un reportage su un'altro caso emblematico dell'incapacità della politica, nonostante la retorica ambientalista, di tenere insieme le ragioni della salute umana e ambientale con il diritto al lavoro. (i.b.) Con riferimenti
Il gruppo Sider Alloys di Lugano ha acquisito lo stabilimento ex Alcoa di Portovesme, in Sardegna, il più importante impianto italiano per la produzione di alluminio primario. L’accordo è stato firmato il 15 febbraio presso il ministero per lo Sviluppo Economico (Mise), a Roma, e coinvolge Invitalia, l’agenzia italiana per gli investimenti. È stato annunciato un investimento di 135 milioni di euro per far ripartire la produzione: ma saranno in gran parte anticipati da Invitalia. I lavoratori della ex Alcoa, che da quasi quattro anni presidiano lo stabilimento per impedirne la chiusura, ora sperano di tornare al lavoro. Portovesme però è uno dei siti più inquinati d’Italia, in attesa di bonifica per rimediare a quarant’anni di scarichi industriali incontrollati. Tra le ragioni della salute ambientale e quelle del lavoro rischia di scoppiare un nuovo conflitto.
Solo trecento metri separano le ultime case di Portoscuso e i primi impianti della zona industriale. La strada passa sotto un ponte di nastri trasportatori, costeggia un deposito scoperto di minerali, supera la centrale termica dell’Enel e prosegue per cinque o sei chilometri tra giganteschi serbatoi, capannoni, un deposito di carbone a cielo aperto. Portoscuso è un comune di cinquemila abitanti sulla costa della Sardegna sud-occidentale, nella regione del Sulcis. La sua zona industriale, chiamata Portovesme, è una delle più grandi dell’isola (qui sopra una foto di Federica Mameli). Nata a fine anni ’60, è un insieme di impianti in cui si svolgeva l’intero ciclo di produzione dell’alluminio, dalla polvere di bauxite fino ai prodotti finali, oltre a una fabbrica di zinco, piombo e acido solforico. Quando lavorava a pieno ritmo qui il panorama era dominato dal nero del carbone scaricato nel porto e dal rosso della bauxite che volava dal nastro trasportatore, dal via vai di camion, e da un impressionante bacino rossastro: 125 ettari di scarti della lavorazione della bauxite, depositati a partire dal 1978 e separati dal mare solo da una lingua di sabbia finissima.
 |
| Le ciminiere di Portovesme a 300 metri dalle case di Portoscuso, foto di Marina Forti |
Oggi le ciminiere continuano a dominare la costa. Anche il bacino dei fanghi rossi resta là, ma le tracce di attività sono rare. I capannoni mostrano la ruggine. Resta in funzione la centrale Enel a carbone: ma per giorni non produce neppure un chilowattora perché non avrebbe a chi venderlo, tanto più che la stessa Enel ha disseminato la zona di pale eoliche per il fabbisogno locale. È attiva anche l’ex fabbrica di zinco e piombo, la Portovesme Srl, ma lavora solo rottame e “fumi d’acciaieria”, cioè scarti della lavorazione dell’acciaio da cui trae una (piccola) parte di metalli e una parte consistente di reflui. Il ciclo dell’alluminio invece è fermo dal 2012; solo pochi addetti accudiscono gli impianti nell’attesa di un rilancio.
Le istituzioni regionali e il governo promettono da anni di rilanciare l’area di Portovesme: trovare un acquirente per la ex Alcoa è stato il primo passo. Secondo il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, l’obiettivo è «rimettere il Sulcis in condizione di fare il ciclo completo dell’alluminio». L’Italia oggi importa alluminio, ha sottolineato il ministro; l’impianto acquisito da Sider Alloys potrà produrre a regime 150 mila tonnellate l’anno, circa il 15 % del fabbisogno nazionale. Anche la vecchia Eurallumina, oggi di proprietà del gruppo russo Rusal, promette di investire 200 milioni di euro per riprendere le attività, con un piano che prevede però di ampliare il famigerato bacino dei fanghi rossi e costruire un proprio impianto a carbone per generare vapore.
È questo il paradosso di Portovesme. Rilanciare il polo industriale porterebbe lavoro in una zona depressa: il Sulcis conta 38mila disoccupati su 130 mila abitanti. Ma porterà anche altro carbone e nuove discariche industriali in una zona ad “alto rischio di crisi ambientale”.
Alimenti contaminati
La crisi ambientale a Portoscuso scoppiò quando uno studio dell’università di Cagliari rivelò che gli scolari della prima media avevano quantità allarmanti di piombo nel sangue. Era il 1988: «Ci parlarono di “danno biologico accertato”» ricorda Angelo Cremone, allora operaio specializzato alla Alsar (poi divenuta Alcoa) e padre di uno di quei bambini. La zona industriale a quel tempo occupava oltre diecimila persone, era il primo datore di lavoro nel Sulcis. Ma scoprire che le fabbriche stavano avvelenando i propri figli fu uno shock. «Capimmo che ci nascondevano i fatti» spiega Cremone.
È nato allora un comitato di cittadini. Furono anni di proteste, denunce, ordinanze comunali. Cittadini e lavoratori erano egualmente coinvolti: un caso raro nell’Italia di allora, dove si moltiplicavano i conflitti tra il nascente movimento ambientalista e le organizzazioni dei lavoratori.
«Gli abitanti di Portoscuso cominciarono a capire cosa volesse dire un’area industriale così vicina alle case» ricorda il dottor Ignazio Atzori, allora ufficiale sanitario e assessore all’ambiente. Oggi Atzori è vicesindaco di Portoscuso e ha di nuovo la delega all’ambiente (nei primi anni Duemila è stato anche sindaco); lo incontro negli studi dell’Azienda sanitaria locale. Spiega che in quei lontani anni ’80 erano già comparsi segnali di allarme, nel vino e nei formaggi locali erano stati trovati piombo e fluoro: «Allora però se ne parlava più che altro in termini di risarcimenti».
Oggi sembra una follia mettere discariche in riva al mare e depositi di carbone accanto alle case. «Ma allora queste considerazioni non si facevano», osserva Atzori. «Le miniere dell’Iglesiente avevano appena chiuso, la zona era segnata dalla crisi. Su tutto prevaleva la necessità del lavoro, ai giovani non restava che emigrare. Così, nei primi anni ’70 tutti accolsero con grande favore la decisione di ubicare qui una nuova zona industriale».
Nel 1993 il governo dichiarò Portoscuso zona “ad alto rischio di crisi ambientale”. Arrivò il primo piano di disinquinamento, finanziato con 200 miliardi di lire. Più tardi (nel 2001) il ministero dell’Ambiente incluse Portoscuso-Portovesme nel più ampio “Sito di interesse nazionale” del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, con più di 200mila abitanti in 29 Comuni, una superficie di 620 kmq a terra e 900 kmq di mare, e una gran quantità di vecchie miniere, fabbriche e discariche.
Da allora l’aria a Portoscuso è migliorata: crollata la produzione industriale, sono venute meno anche le emissioni. La bonifica però non è mai stata completata. Nei terreni e nelle falde idriche un inquinamento profondo continua a contaminare la catena alimentare, con grave danno per gli abitanti (vedi “Una crisi sanitaria poco studiata”). A Portoscuso non si può consumare il latte delle pecore e capre che brucano nei dintorni, né mangiarne la carne, né raccogliere mitili e crostacei o vendere frutta e verdura: la Asl locale raccomanda soprattutto di non farli mangiare ai bambini. Nelle polveri sottili ci sono piombo e cadmio. Il terreno è impregnato di metalli pesanti. La falda sotto Portovesme è un concentrato di veleni, secondo l’ultima relazione dell’Agenzia regionale per l’ambiente diffusa nel giugno 2017: i campioni prelevati nell’area industriale rivelano arsenico, cadmio, fluoro piombo, mercurio, tallio, zinco e idrocarburi policiclici aromatici, tutto in quantità centinaia migliaia di volte oltre i limiti. Sostanze tossiche, neurotossiche, cancerogene.
«Il problema è che i soldi stanziati negli anni ’90 sono quasi finiti, ma gli interventi di bonifica non sono affatto conclusi» spiega Atzori. Parla delle strade rurali e urbane che nei primi anni Settanta erano state pavimentate con scorie di piombo e zinco della Samim (Eni): «Stiamo ripulendo perfino la strada davanti alla scuola materna».
Quanto all’area industriale, la Regione Sardegna afferma che sono in corso interventi di messa in sicurezza e bonifica per oltre 230 milioni di euro tra investimenti e e costi operativi, a carico delle aziende in base al principio chi inquina paga. Alla fine del 2017, dopo anni di gestazione, è stato approvato un progetto di “barriera idraulica” per mettere in sicurezza la falda idrica sotto a Portovesme: si tratta di pompare l’acqua prima che raggiunga il mare, trasferirla a impianti per depurarla, poi riutilizzarla nei processi produttivi o rimetterla nelle falde. È un’opera “consortile”, cioè coinvolge le diverse aziende che vi hanno impegnato 54 milioni di euro. Ma poi bisognerà fermare le fonti della contaminazione.
«Abbiamo assistito a un’incredibile serie di silenzi e omissioni» dice Angelo Cremone, che oggi rappresenta l’associazione Sardegna Pulita. Licenziato dall’Alcoa, ha continuato a dare battaglia contro l’inquinamento come consigliere comunale e ora come attivista. È tra le parti civili nel procedimento in cui la direzione aziendale dell’Eurallumina è imputata per “disastro ambientale”: ma il processo cominciato nel 2015 si trascina; il 16 febbraio l’avvio delle udienze è di nuovo slittato. «L’inquinamento è noto da molto tempo» insiste Cremone «e anche l’impatto sulla nostra salute: ma chi doveva intervenire non lo ha fatto».
Portovesme è presidiata
Nell’area industriale semi deserta, i cancelli della ormai ex Alcoa si riconoscono dalle bandiere sindacali e da uno striscione azzurrino: «Continua la lotta per il lavoro e il territorio», firmato dai «lavoratori Alcoa e appalti» del Sulcis Iglesiente.
Lo stabilimento è presidiato da quasi quattro anni. Alla fine del 2012 infatti Alcoa ha sospeso l’attività e messo tutti in cassa integrazione; finita questa, dal 2014 è tutto fermo: d’improvviso ottocento persone (di cui circa metà dipendenti di ditte in appalto) sono rimaste senza lavoro né cassa integrazione, affidate agli “ammortizzatori sociali”. Però non si sono rassegnate, e dal maggio del 2014 presidiano la fabbrica. «All’inizio ci siamo organizzati in squadre e abbiamo presidiato i cancelli 24 ore su 24, tutti i giorni» spiega Gianmarco Zucca, delegato di fabbrica della Fiom, la Federazione dei lavoratori metalmeccanici della Cgil. Poi è passato un anno, due, tre, «chi ha trovato dei lavoretti, chi ha perso la speranza. Ora siamo qui due giorni alla settimana».
È un venerdì di dicembre, giorno di presidio. «Quando sono entrato in fabbrica, nel 1989, era un vero inferno. Da allora però le cose sono cambiate. L’abbiamo visto sulla nostra pelle» continua Zucca. Anni fa «la fabbrica scaricava in modo selvaggio: ma poi hanno messo filtri, chiuso alcuni impianti. Oggi ci sono regole e controlli». Saliamo in macchina per perlustrare la zona. Ecco il capannone con le celle elettrolitiche per l’alluminio: uno dei lavori più pericolosi era preparare le vasche con la polvere di allumina in un bagno di fluoruro e sodio, e poi gli anodi in grafite. Gli addetti erano esposti a polveri e sbalzi di temperatura. File di carrelli poi portavano l’alluminio fuso in fonderia, per farne pani, bille o placche in leghe diverse secondo le ordinazioni: «Era alluminio di grande qualità, anche per le Ferrari». Vicino c’era la Metallotecnica, la «fabbrica-scuola» da cui uscivano ottimi carpentieri, tubisti, lavoratori specializzati.
Il presidio dell’Alcoa è retto da un centinaio di persone, più altre che passano in modo occasionale: «È anche un modo per tenersi in contatto» osserva Milena Masia, anche lei dipendente Alcoa. L’età media dei lavoratori qui è 38/40 anni, spiega, «tutti hanno figli a scuola o all’università, e mutui da pagare». Pochi hanno trovato un altro lavoro.
Si capisce che qui aspettassero con ansia la vendita dello stabilimento. Nel 1996, quando Alcoa acquistò lo stabilimento di Portovesme, il corso dell’alluminio sul mercato mondiale era alto e il governo italiano garantiva energia a prezzo agevolato (l’energia è quasi il 40% del costo di produzione dell’alluminio primario, cioè ottenuto dalla materia prima). Così Alcoa trovò conveniente produrre anche quando nel 2009, chiusa la Eurallumina, dovette importare la polvere d’allumina da fuori. Poi però l’Unione europea ha stabilito che quell’energia a prezzo di favore era un aiuto pubblico illegittimo, e nel 2011 la Corte di giustizia europea ha ordinato all’azienda di restituire allo stato italiano circa 300 milioni di euro di sovvenzioni. Il governo ha esteso allora le agevolazioni a tutte le imprese “energivore” delle isole, (è stato chiamato “decreto salva-Alcoa”). Ma ormai Alcoa aveva deciso di lasciare l’Italia – anche se nel solo 2012 ha fatto 600 milioni di euro di utile netto, fanno notare qui. «Hanno chiuso una fabbrica in perfetta efficienza, che sulle emissioni rispettava parametri più severi di quelli dell’Unione europea, aveva mercato e faceva profitti» si indigna Francesco Bardi, della segreteria della Camera del lavoro di Carbonia, che incontro davanti allo stabilimento presidiato. Quando infine nel 2016 Alcoa ha annunciato l’intenzione di smantellare gli impianti si è fatta avanti Invitalia, con il compito di cercare nuovi acquirenti per la fabbrica di Portovesme.
Oggi il presidio dei lavoratori continua. «Speravamo di conoscere i piani della nuova azienda, ma non abbiamo avuto comunicazioni ufficiali» spiega al telefono Roberto Forresu. Già: il piano industriale presentato dal gruppo ticinese al governo italiano non è stato diffuso, e neppure i termini dell’accordo tra Sider Alloys e Invitalia. È noto però che dei 135 milioni di investimento annunciato, ben 84 saranno anticipati da Invitalia a tasso agevolato, 20 saranno messi da Alcoa come contributo alla bonifica e 8 a fondo perduto dalla regione Sardegna. L’investimento di Sider Alloys si riduce a una ventina di milioni di euro.
Una dismissione rinviata?
Nei primi anni 2000 l’area industriale di Portovesme dava ancora lavoro a cinquemila persone tra dipendenti diretti, imprese in appalto e indotto. Oggi restano 1.300 addetti alla Portovesme Srl e 380 alla centrale Enel. Le imprese di servizio fanno altri trecento dipendenti; poche decine lavorano al porto industriale. Poi ci sono 120 persone che timbrano il cartellino alla Eurallumina, ora Rusal: anche loro sperano nel rilancio.
Il “piano di ammodernamento” dell’azienda russa però ha suscitato numerose obiezioni (pubblicate sul sito della regione Sardegna). Una riguarda il carbone: perché mai un nuovo impianto? Infatti quello Enel è sottoutilizzato (e l’Italia si è impegnata a “uscire” dal carbone entro il 2025). Intanto anche la Portovesme Srl promette nuovi investimenti, ma chiede per i suoi reflui una nuova discarica: l’attuale è esaurita e l’azienda di proprietà Glencore minaccia di chiudere se non sarà autorizzata a raddoppiarla. Il solito, vecchio “ricatto del lavoro”.
«La situazione del lavoro è drammatica» riconosce il vicesindaco Atzori, e però sarebbe meglio ragionare sulla dismissione: «Stiamo parlando di produzioni non competitive, le materie prime e l’energia vengono da fuori. Erano poco sostenibili già in passato, se non per le sovvenzioni pubbliche. Regge solo la Portovesme Srl perché è diventata una piattaforma di smaltimento di rottame».
«Quella di Portovesme non è un’industria che possa reggere» è il tassativo commento di Stefano Deliperi, presidente di un gruppo di giuristi e ambientalisti, il Gruppo di intervento giuridico, che ho raggiunto al telefono. «Quelle aziende vivono di cassa integrazione e ammortizzatori sociali. Non ha senso continuare a buttare via soldi pubblici per iniziative industriali fuori mercato» continua: «Sotto il profilo ambientale e della salute pubblica è un disastro, e se non si cambia rotta non potrà che peggiorare». Difendere il lavoro non significa quel lavoro: «Perché non trasformare Portovesme in un polo di produzione di alluminio riciclato, secondo il principio del riutilizzo?». Sarebbe un considerevole risparmio di energia, osserva Deliperi; si salverebbero posti di lavoro e sarebbe un’alternativa sostenibile. Ma finora è prevalsa «una logica clientelare: si tiene in piedi una parvenza di lavoro, corsi formazione, riqualificazione, cassa integrazione». Deliperi dice che la classe politica «usa il Sulcis come un serbatoio di voti».
Per il vicesindaco Atzori, il sospetto peggiore è che il rilancio nasconda l’ennesima beffa: «Si rinvia la dismissione degli impianti per evitare di spendere le centinaia di milioni di euro necessarie a smontare le fabbriche e bonificare questo sito industriale».
Una crisi sanitaria poco studiata
La situazione sanitaria intorno all’insediamento industriale di Portovesme è allarmante, anche se ancora troppo poco indagata. L’indagine più completa finora realizzata è lo studio epidemiologico sulle aree industriali, minerarie e militari della Sardegna coordinato nei primi anni ‘2000 dal professor Annibale Biggeri. Commissionato dalla Regione Sardegna grazie a fondi europei, lo studio è stato pubblicato nel gennaio 2006 dalla rivista dell’Associazione italiana di epidemiologia (Epidemiologia & Prevenzione).
Il primo rapporto Sentieri (l’indagine epidemiologica nelle zone esposte a inquinamento industriale in Italia, pubblicato dall’Istituto superiore di sanità nel 2011) segnala nella popolazione sia maschile che femminile un eccesso di mortalità per le malattie dell’apparato respiratorio, oltre che per il tumore alla pleura e per le malattie perinatali. Conferma inoltre che nel 1998 la piombemia nei ragazzi di Portoscuso era superiore al livello d’attenzione in vigore negli Usa (cioè 10 microgrammi per decilitro di sangue). Nei lavoratori dell’Alcoa, in particolare gli addetti alla preparazione degli anodi per l’elettrolisi dell’alluminio, era in eccesso la mortalità per tumori al pancreas. Lo studio Sentieri considera anche le vicine zone minerarie, cioè tutto il “Sito di interesse nazionale” del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, e conclude che «la componente occupazionale svolge un ruolo rilevante nelle malattie dell’apparato respiratorio (tumorali e non) e nel tumore del polmone».
Da allora non si segnalano nuovi studi, se non parziali. Non c’è un sistema di monitoraggio continuo né uno screening periodico della popolazione esposta; in questa zona della Sardegna non è ancora operativo neppure il Registro dei tumori. Paradossale: c’è una situazione di rischio ambientale conclamato, ma non c’è il monitoraggio sanitario che ci si dovrebbe aspettare.
Ripreso da terraonline.org, il blog di Marina Forti, qui accessibile.
Riferimenti
Puoi leggere su eddyburg un altro articolo sul disastro ambientale di Portoscuso "Nel Sulcis dei veleni", e un articolo di Giorgio Nebbia "Quale futuro per l'acciao in Italia" sui rischi che la produzione di acciaio comporta e sugli investimenti e trasformazioni indispensabili per poter continuare la sua produzione in sicurezza.
la Nuova Venezia, Poveglia per tutti, 9 marzo 2018. La positiva conclusione di una vicenda che ha visto prevalere un gruppo di cittadini, utilizzatori di un bene pubblico che il demanio statale si proponeva di alienare, con postilla
la Nuova Venezia
IL TAR BOCCIA IL DEMANIO
POVEGLIA, NUOVE SPERANZE
di Vera Mantengoli
«Per i giudici amministrativi il diniego dello Stato è stato immotivato alla richiesta dell'associazione di gestire per sei anni parte dell'isola»
Colpo di scena nell'infinita storia di Poveglia che ieri si è improvvisamente riavvicinata ai cittadini, aprendo uno spiraglio sulla futura gestione dell'isola. Il Tar ha infatti considerato immotivato il no che il Demanio diede a «Poveglia per Tutti» nel 2015 quando, dopo l'asta andata a male del 2014, l'associazione chiese una concessione di sei anni per poter investire i soldi raccolti dalla colletta e sistemare l'isola verde. Una sentenza che ha rimesso in moto l'entusiasmo dell'associazione. Lo scenario attuale è infatti quello di una riapertura delle trattative tra «Poveglia per tutti» e il Demanio che dovrà tenere presente le osservazioni del Tar. Grande la gioia dei quasi cinquemila soci che stavano perdendo le speranze dopo l'ennesimo no dello scorso novembre, il provvedimento di non avvicinarsi a Poveglia per presunti problemi di buche ed eventuali crolli e l'avvicinarsi inesorabile della seconda asta, prevista per giugno.
Il Tar, con la sentenza 273/2018, sostiene che il diniego nasconde una presa di tempo non motivata, che davanti a una proposta concreta le motivazioni date all'epoca, secondo cui c'erano possibili altri investitori, non giustificano un no, ma soprattutto il Tar sottolinea l'importante finalità sociale della proposta dei cittadini. «Oggi il Tar dopo tre anni dalla nostra richiesta temporanea di avere l'isola per sei anni, ci ha dato ragione» ha dichiarato Lorenzo Pesola, presidente dell'associazione Poveglia per tutti. «Già all'epoca avevamo fatto un lavoro dettagliato, frutto della collaborazione di centinaia di persone, a cui il Demanio aveva dato una risposta insensata. Questa sentenza ci ridà un po'di fiducia e ci permetterà di tornare a negoziare al tavolo con uno Stato che speriamo che sia più attento alle istanze di sussidiarietà orizzontale di cui questa nostra associazione si fa così chiaramente portavoce».
E ora, un passo indietro. All'asta senza vincitori del maggio 2014 avevano partecipato l'associazione Poveglia per tutti con 160 mila euro raccolti da oltre 3.000 cittadini e Luigi Brugnaro, a quel tempo imprenditore e non sindaco, con 513 mila euro. Il Demanio aveva considerato l'offerta dell'attuale sindaco troppo bassa, mentre quella di Poveglia per tutti non era nemmeno passata perché di molto inferiore. I cittadini non si erano comunque dati per vinti e avevano proposto al Demanio di utilizzare tutti i soldi ricavati dalla colletta che sfioravano i 400 mila euro. A fine 2014 l'associazione aveva quindi chiesto una concessione, presentando un progetto, ma dopo qualche mese si era sentita dire di no. A quel punto i legali Francesco Mason e Raffaele Volante avevano fatto ricorso. Ieri, dopo tre anni, la sentenza. «Siamo molto soddisfatti, soprattutto delle motivazioni» spiegano gli avvocati.
«Il Tar afferma dei principi importanti perché spiega al Demanio non solo come deve amministrare il bene pubblico, ma anche come si deve rapportare con la società civile, ricordandone l'importanza». Andando più nel dettaglio, per prima cosa il Tar dice che l'atto di diniego del demanio nasconde una presa di tempo e un'inerzia da parte del demanio non giustificata: «Il demanio aveva detto che c'erano altre manifestazioni d'interesse e che doveva parlare con l'amministrazione comunale» spiega Mason. «Il Tar dice che non si può dire di no perché potenzialmente ci sono altri investitori. Poi dice che se il demanio avesse voluto rimetterla all'asta, davanti a una proposta concreta, avrebbe potuto concederla con una clausola. In una parola, se c'è una comunità che ci mette i soldi per preservare il proprio bene non puoi dire di no e lasciare un bene allo sfacelo». Adesso il Demanio dovrà anche pagare all'associazione e le spese legali e riaprire il tavolo. L'intenzione infatti è quella di attendere che il demanio convochi Poveglia per tutti per mettere un punto su quanto è passato e ricominciare di nuovo. Questa volta mettendo in primo piano i cittadini.
Poveglia per tutti
TAR E POVEGLIA
UNA IMPORTANTE SENTENZA
Sono passati ben tre anni dalla nostra prima richiesta di concessione dell'isola di Poveglia, isola che giace abbandonata dal 1968. Più che di una “concessione” si trattava di un vero regalo da parte dei 4378 associati alla comunità tutta; una proposta dettagliata, fin nei minimi particolari. La sentenza del TAR del Veneto di ieri ha confermato che quel misero diniego con cui ci rispose l'Agenzia del Demanio, con cui si tentò un vero “seppellimento burocratico” del lavoro volontario di decine di professionisti, rappresentò "un eccesso di potere" immotivato ed arbitrario.
La nostra associazione allora non si arrese, e continuò con pazienza e coraggio a cercare di mantenere aperto un tavolo negoziale, non volevamo certo che questo pezzo di città divenisse un nuovo albergo ma che fosse fruibile agli abitanti. Tre anni. Tre anni che sono stati segnati purtroppo da un aleatorio quanto immotivato dilazionare, in cui il nostro interlocutore cercava, come il TAR oggi denuncia, di “rallentare per non decidere”, disconoscendo quelle che persino il tribunale oggi definisce “finalità di indubbia rilevanza sociale e collettiva”.
Fu una vera odissea di incontri. Ci siamo recati negli uffici veneti e romani per ben 21 volte, offrendo ogni volta proposte e soluzioni per superare ostacoli via via più pretestuosi. Finchè, ultimo in ordine di tempo, quello decisivo, nell’incontro del 16 novembre 2017, quando l'attuale direttore del Veneto Ing. Di Girolamo si e' unilateralmente ritirato dall'accordo il giorno stesso della firma, accordo su cui si era già espressa positivamente l'Avvocatura dello Stato.
Fortunatamente i nostri volontari hanno avuto la tenacia di chi sente con sé la ragione, il principio di sussidiarietà costituzionale, il calore della comunità. Leggere questa sentenza, oggi, ci dona un po' di respiro. Non sarà più possibile dire che 5000 cittadini, un veneziano per famiglia, non abbiano espresso un “sentire diffuso”. Per questo colpevole ritardo del Demanio, per una politica sostanzialmente dilatoria di questa agenzia, abbiamo perso altri anni. Anni segnati da un apparato che si è comportato con l’atteggiamento di un sovrano indispettito e non come amministratore della cosa pubblica. Ora il Tar costringe moralmente (e di fatto) l’agenzia a tornare ad un tavolo negoziale, a dare delle risposte serie alla comunità.
Il Demanio ha compiuto due errori madornali: non ha assegnato l’isola ai cittadini ed ora ha spinto il provveditorato a circondarla con un “filo spinato invisibile”; un’ordinanza suggerita al provveditorato dalla stessa Agenzia infatti, vieta oggi finanche l’accosto all'isola. Non ne commetta un terzo, fatale. Il terzo errore sarebbe utilizzare per Poveglia un bando solitamente utilizzato per i “fari”. Poveglia non è un faro. Questo bando ha assegnato negli ultimi anni 22 strutture su 24 ad un destino ricettivo-turistico, e non è perciò, palesemente, il contenitore giusto per una città così turistificata. Ascolti i cittadini. Un doveroso grazie ai nostri avvocati per questo successo.
Postilla
La vicenda di Poveglia dimostra quanto sia difficile affermare i diritti dei cittadini sui beni comuni. «Il Tar afferma dei principi importanti perché spiega al Demanio non solo come deve amministrare il bene pubblico, ma anche come si deve rapportare con la società civile, ricordandone l'importanza». (m.p.r.)
Qui la sentenza

The Submarine, 1 marzo 2018. Le politiche isolazionistiche dell'Europa sono inutili difronte alla desertificazione del Sahel. Occorre accettare e gestire i flussi migratori e mettere in campo misure per garantire nuovi accessi a risorse naturali. Qui l'esempio della muraglia verde. (i.b.)
La fascia del Sahel ha necessità di politiche di adattamento al cambiamento climatico che vanno redatte accettando la realtà dei conflitti locali, e la presenza di fortissimi flussi migratori; programmi che risolvano problemi fondamentali di accesso e disponibilità di risorse naturali, in modo da garantire nuove possibilità di sviluppo.
La desertificazione inarrestabile del Sahel sta rendendo invivibile un’intera regione del continente africano: è un problema da cui la politica europea non può (piú) scappare.
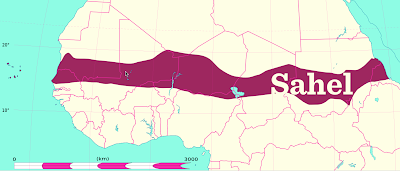
La definizione di “migrante climatico” è molto complessa. Gli eventi causati dalla crescente variabilità climatica sono così vari e imprevedibili che definire chi sia un migrante climatico è difficile, o forse impossibile.
Esistono i casi di migranti climatici in senso stretto, come gli agricoltori che devono spostarsi di fronte all’avanzata del deserto, ma ricadono in questa definizione anche persone che fuggono da conflitti o instabilità provocati dalla mancanza di risorse direttamente causata dal cambiamento climatico, o chi deve spostarsi in seguito a catastrofi imprevedibili.
Lo IOM (Organizzazione mondiale per le migrazioni) prova a definire il fenomeno come “persone o gruppi di persone che, principalmente perché colpiti negativamente dal cambiamento, improvviso o progressivo, nell’ambiente, sono costrette a abbandonare le proprie case, o scelgono di farlo, temporaneamente o permanentemente, e che si spostano all’interno del proprio paese o all’estero.” (Glossary on Migration, International Migration Law, no. 25, 2nd Edition, IOM, Ginevra, 2011, p. 33). Si tratta insomma, di una migrazione forzata che riguarda molte piú persone di quante in genere si pensi.
Il legame tra instabilità geopolitica e cambiamento climatico è forte quanto invisibile, e ignorato da una fetta di politici ancora piú ampia di chi già nega il cambiamento climatico.
È il caso dei migranti provenienti da vari paesi del Sahel, a sud del deserto del Sahara, che vengono puntualmente considerati dall’Unione Europea come “migranti economici,” e che la nostra politica usa volentieri come punching ball di retorica razzista e retrograda. Sono paesi come il Senegal, l’Algeria, la Nigeria e l’Eritrea — tra gli altri. Tutti i paesi della fascia del Sahel sono considerati dallaBanca mondiale come fragili — a causa di alti livelli di povertà, conflitti costanti, e governi tradizionalmente debolissimi. Secondo i dati raccolti lo scorso anno dall’OCHA, il 60% della popolazione della regione — 150 milioni di persone — è impiegata nell’agricoltura pluviale.
Catalogare come migranti economici persone che si vedono costrette a migrare di fronte a una desertificazione che avanza di vari chilometri l’anno è una lettura iperpoliticizzata di un problema da cui non si può scappare.
La migrazione, ovviamente, non è diretta, e sono tantissimi i fattori che offuscano il rapporto di concausa. Sara Vigil scrive, per “Out of Africa: Why People Migrate” (LediPublishing, ISPI, Milano, 2017) che “molteplici studi hanno sottolineato come nei periodi di siccità i fenomeni migratori diminuiscono. Questo è perché le persone usano le proprie ultime risorse per i bisogni primari (come il cibo), e non hanno quindi le risorse per imbarcarsi in viaggi piú lunghi.”
Le politiche che mirano a tenere il problema dei rifugiati fuori dal blocco europeo sono scandalosamente miopi. Spostare le cause della migrazione, anche quelle considerate strettamente politiche o economiche, nel contesto del cambiamento climatico rivela un’evidenza innegabile: che le grandi migrazioni dall’Africa subsahariana sono appena iniziate. La proiezione piú citata è quella firmata da Norman Myers, che calcola 200 milioni di persone costrette ad abbandonare la propria casa entro il 2050. Secondo dati raccolti da diverse organizzazioni umanitarie che operano nella zona, il 30% degli abitanti della zona del Sahel del Burkina Faso hanno dovuto migrare negli ultimi vent’anni.
La situazione è sistemica e riguarda l’intera fascia del continente — un abitante su quattro dell’Africa subsahariana vive in condizioni di malnutrizione. Sono 220 milioni di persone, che nel 2050 secondo le proiezioni di Meyers diventerebbero 330.
Malgrado queste condizioni di totale costrizione, i migranti saheliani non sono considerati tecnicamente rifugiati. Questo principalmente perché lo status di rifugiato riservato esclusivamente a chi si muove costretto da persecuzioni, è descritto da un documento molto datato, definito nel 1951 — anche se nel contesto politico mondiale contemporaneo i suoi contenuti sono di un’ambizione umanitaria sempre piú lontana alle sensibilità attuali, quasi un relitto di un momento di maggiore civiltà.
Ci sono voci che sostengono che le vittime del cambiamento climatico dovrebbero rientrare in questa definizione. È l’opinione, tra gli altri, anche di Alice Thomas, manager del programma di migrazioni climatica di Refugees International. “Per i poveri saheliani che devono ‘andarsene o morire qui’ — come una donna ha descritto il suo dilemma — leggi e politiche offrono protezione limitatissima, e pochissime soluzioni sul lungo termine,” dice Thomas.
“Negli ultimi 40 anni le temperature nella regione sono cresciute costantemente e la siccità è diventata un problema sempre piú costante e severo,” si legge in uno studio congiunto UNEP – IOP del 2011 coordinato da Alhousseïni Bretaudeau. La soluzione è ovviamente applicare politiche di adattamento al cambiamento climatico e cosviluppo — ne parleremo subito — ma non è possibile ignorare la necessità di gestire lo spostamento di persone causato da un evento di cui è fondamentalmente nostra la responsabilità.
Di fronte alla crescente povertà sono tantissime le persone saheliane che si trovano costrette a vendere i propri ultimi averi — spesso semplicemente, il proprio ultimo bestiame — per finanziare il proprio viaggio, arrivando a destinazione, sia all’interno del proprio paese che all’estero, in condizioni di estrema povertà — condizioni dalle quali nel labirinto di leggi e regolamentazioni internazionali diventa sostanzialmente impossibile risollevarsi.
La soluzione “aiutarli a casa loro” è inadeguata almeno quanto è odiosa. Quello che è necessario è un piano di cosviluppo che permetta all‘intera zona di uscire dalla povertà — e questo è possibile farlo solo attraverso investimenti, privati e pubblici, da donatori internazionali, sostanziali. È la tesi sposata anche da Grammenos Mastrojeni, responsabile ambiente del ministero degli Esteri italiano, e illustrata durante la presentazione del primo numero dell’edizione cartacea di Changes, magazine del gruppo Unipol.
È qui che crolla lo specchio isolazionista di così tante forze politiche europee, l’attivazione di piani globali non dipende dalla mancanza di risorse, ma da una visione politica necessaria per implementarli. Sollevare la zona al di sopra della povertà è anche negli interessi dell’Unione Europea — che dovrebbe vedere nell’Africa il proprio potenziale partner commerciale principale, al di là delle proprie responsabilità etiche e morali.
La fascia del Sahel ha necessità di politiche di adattamento al cambiamento climatico che vanno redatte accettando la realtà dei conflitti locali, e la presenza di fortissimi flussi migratori; programmi che risolvano problemi fondamentali di accesso e disponibilità di risorse naturali, in modo da garantire nuove possibilità di sviluppo. Si tratta di programmi difficili da stilare ma di cui esistono già bozze, che devono partire dal presupposto di combattere le ineguaglianze, di gruppi sociali quanto di etnia e di genere.
Sono necessari nuovi meccanismi di cooperazione regionali coordinati attraverso le varie organizzazioni delle Nazioni Unite — in particolare con l’obiettivo di creare un nuovo framework di leggi e norme sull’uso delle risorse naturali.
Si tratta, sostanzialmente, della necessità di ridefinire le proprie priorità: la presenza di flussi migratori intensi, di conflitti e governi instabili nella regione dovrebbe essere per l’Unione Europea motivo di investimento, concentrandosi sulle zone e le comunità piú fortemente colpite dal cambiamento climatico, o comunque dove le condizioni di vita sono piú fragili e a rischio.
Fondi per l’attivazione di programmi come questo esistono già, non vanno organizzati e non rappresenterebbero nuovi costi per i singoli stati — basti pensare al Fondo per il clima dell’UNFCCC. Si tratta, in ogni caso, di interventi il cui costo è irrisorio in proporzione al risultato: il paper di UNEP – IOP sopracitato pone il costo dell’attivazione di meccanismi di adeguamento su tutta la fascia attorno ai 12 milioni di dollari, compresa la costruzione di una nuova rete di stazioni meteorologiche e l’organizzazione di autorità nazionali e regionali per la pianificazione dell’adeguamento. Per fare le dovute proporzioni: all’ultima spending review questa cifra è l’equivalente di circa 4 ore di attività della Difesa dello Stato italiano.
Parlare di green economy per zone in profonda difficoltà come quelle dell’Africa subsahariana suona nell’attuale contesto socio-politico come un’idea rivoluzionaria, ma si tratta di una soluzione necessaria a un problema che finora abbiamo affrontato a stento alla giornata.
Senza una radicale ristrutturazione dei sistemi agricoli della regione il cambiamento climatico eroderà quello sviluppo che il continente è riuscito a strappare — con la forza — in queste decadi. Lo sviluppo di soluzioni ecologiche per l’Africa subsahariana vuol dire creare nuove possibilità di impiego specializzato. Una crescente industria agricola, capace di produrre posti di lavoro ben retribuiti e adeguata al cambiamento climatico, sarebbe una risorsa insostituibile nella lotta alle tensioni intestine di ogni paese presente nella zona — un altro mondo rispetto alle dannose politiche che vogliono risolvere il problema semplicemente addestrando e armando meglio uno dei fronti in battaglia.
Soluzioni al problema sono discusse dai primi anni cinquanta, quando Richard Barbe Baker per la prima volta presentò l’idea di costruire una Grande Muraglia Verde larga 50 km per contenere il deserto. L’idea è stata periodicamente riproposta, prima nel 2002 e poi nel 2005. Teoricamente la costruzione sarebbe in corso, con lavori in Burkina Faso e Senegal. Lo scorso settembre Amelia Martyn–Hemphill si è recata in Senegal per BBC per osservare come la costruzione del Muro stesse procedendo. Il paese ha già piantato 11 milioni di alberi, ma si tratta solo dell’inizio. La creazione di una barriera verde permette di bloccare l’avanzata del vento desertico che brucia le piantagioni circostanti immediatamente a sud. La situazione è così drastica che piantare e mantenere 11 milioni di alberi consuma meno acqua che contrastare i venti del deserto. Le foglie delle piante permettono di creare compost, e l’umidità prodotta dai tronchi, insieme all’ombra, riduce drasticamente il costo di mantenimento delle coltivazioni e degli orti. Le radici delle piante trattengono l’acqua nel terreno, ridando vita a pozzi che erano rimasti completamente a secco per anni. Gli effetti locali della Grande Muraglia Verde non sono solo ambientali — solo nella zona i nuovi campi coltivati hanno reso possibile l’assunzione di duemila donne.

La Grande Muraglia Verde è, questo sì, un progetto grandioso, in termini di risorse e tempistica. Ma solo attraverso il coraggio di avviare progetti come questo possiamo ridefinire le condizioni di vita nella fascia del Sahel e discutere seriamente di nuove politiche per l’Africa.
Tratto dalla rivista online The Submarine
qui raggiungibile.
Re:Common, 16 Febbraio. In piena campagna elettorale è stato concesso il prestito al gasdotto TAP, che il governo italiano appoggia nonostante le proteste dei territori. La sicurezza energetica non c'entra nulla, interessi politici e economici manovrano il progetto. (i.b) con riferimenti
Ieri si è svolto a Baku il quarto incontro dell’Advisory Council per il Corridoio Sud del gas. Presenti i rappresentanti dei governi interessati (per l’Italia, il sottosegretario del ministero dello Sviluppo economico Ivan Scalfarotto), ma anche il vice presidente della Commissione europea Maroš Šefčovič, che negli ultimi mesi non ha perso occasione per spendersi a favore del mega gasdotto “di priorità europea”. Lo ha fatto anche cercando di accelerare la difficile discussione interna alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) in merito al prestito da 1,5 miliardi di euro richiesto da TAP Ag per la tratta finale del corridoio, il gasdotto TAP. E’ stato proprio Šefčovič a scrivere al presidente della Bei lo scorso luglio, assieme al Commissario per l’energia Miguel Arias Cañete, ricordando l’urgente necessità di capitali del consorzio costruttore, a cui anche la Bei era chiamata a fare fronte.
E così alla fine la Bei ha concesso il prestito, ma non senza un significativo “aiuto” da parte della Commissione europea. Per portare il suo risultato a Baku, lo scorso dicembre la Commissione ha infatti deciso di garantire la copertura del rischio sul prestito della BEI tramite il Fondo europeo per gli investimenti strategici – EFSI (link).
Chissà quanto gli stessi Šefčovič e Cañete si saranno spesi per questo. Il dato di fatto è che sebbene sia la Bei ad aver concesso il prestito, sarà la Commissione europea a farsi carico del rischio, sempre con risorse pubbliche quindi.
Al netto della retorica sulla sicurezza energetica, a cui oramai non crede più nessuno, e delle dichiarazioni di intenti uscite ieri da Baku, orientate a rassicurare gli investitori – in primis i colossi della finanza privata, ovvero le grandi banche, ma anche i fondi investimento, i fondi pensione, e i gestori di capitali che potrebbero fare la differenza e dare la spinta necessaria alla costruzione – la verità è un’altra. Ovvero che senza una garanzia pubblica la sostenibilità economica del gasdotto rimane una chimera. E che a Baku le vere discussioni sono avvenute ovviamente a lato dell’incontro ufficiale.
La Baronessa Emma Nicholson, inviato della premier inglese Theresa May in materia commerciale per Iraq, Azerbaigian e Turkmenistan, non ha fatto mistero della fruttuosa cena d’affari a cui ha partecipato con il British Business Group of Azerbaijan (link).
Anche l’inviata della presidenza americana, Sue Saarnio, ha voluto comunicare che il sostegno statunitense al corridoio viene a lato di altre questioni ben più spinose, che hanno ovviamente a che fare con il conflitto in Siria e il sostegno alla NATO della Turchia. Equilibri complessi in cui l’Azerbaigian ha saputo destreggiarsi rimanendo con un piede in due scarpe, come del resto la Turchia, tra Stati Uniti e Russia, e ora Iran (link).
Curiosa anche la dichiarazione circolata dal rappresentante del governo italiano, il sottosegretario allo sviluppo economico Ivan Scalfarotto, che ha confermato il sostegno italiano al progetto indipendentemente dalle prossime elezioni. Forse per dire che non è Renzi il padrino di questo gasdotto? O per confermare la mano pesante contro le proteste sul territorio, che certamente hanno preoccupato Baku e anche la Commissione europea, e che non ha colore politico (link).
Un messaggio che ci fa riflettere molto, su cosa sia davvero importante: ascoltare le voci informate di chi dice no, chiedendosi perché, o andare avanti a prescindere, quasi che l’obiettivo ultimo del governo sia l’opera in se, e il sistema di relazioni collegato, molto più dei presunti benefici promessi dalla stessa?
Che la questione sia spinosa, e che il Corridoio sud e le sue relazioni siano sempre più tossiche, ce lo conferma l’attacco lanciato ieri dal governo dell’Azerbaigian alla rete di giornalismo investigativo OCCRP, il motore della mega inchiesta conosciuta come Azerbaijani Laundromat (di cui abbiamo parlato qui e qui).
Al centro dello scandalo, che ha portato alle dimissioni di diversi deputati a livello europeo, oltre che a un’inchiesta interna al Consiglio D’Europa e a un grande scompiglio nelle segreterie di partiti, governi e istituzioni, c’è l’ex deputato italiano Luca Volontè, sotto processo per corruzione e riciclaggio da qualche mese, dopo che nel giugno 2016 la stampa aveva fatto trapelare la sua indagine per avere ricevuto delle presunte mazzette dall’Azerbaigian.
Come riportato dal Corriere della Sera il 14 febbraio, il tribunale di Milano ha assolto Luca Volontè dall’accusa di riciclaggio. La notizia è stata ripresa brevemente anche da Il Sole 24 ore, ma di fatto è passata sotto traccia nel grande circo mediatico che segue l’attuale campagna elettorale. Non è passata inosservata invece per il governo dell’Azerbaigian, il primo a commentarla con diverse uscite stampa di alti esponenti del governo e con una non troppo velata minaccia di querela alla rete di giornalismo investigativo OCCRP, accusata di avere veicolato una campagna diffamatoria contro il paese del Caspio. Quello che il governo azero ha dimenticato di dire, e che invece si legge sul Corriere, è che il processo di Luca Volontè per corruzione internazionale continua. Forse è proprio questo il vero “problema”.
Ripreso dal sito Re:Common, qui raggiungibile.
Re:Common, 6 marzo 2018. Alla sbarra degli imputati le multinazionali Eni e Shell, accusate di corruzione internazionale legata all’acquisizione del maxi-giacimento di petrolio offshore in Nigeria da loro acquisito nel 2011 (i.b)
Ieri si è aperto a Milano il processo per il caso OPL 245, che vede alla sbarra degli imputati le multinazionali Eni e Shell, i loro top manager come l’attuale ad della società italiana Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni e alcuni intermediari.
Come ormai è noto, l’accusa per tutti i soggetti coinvolti nella vicenda è di corruzione internazionale legata all’acquisizione del maxi-giacimento di petrolio offshore in Nigeria. Tecnicamente la mazzetta pagata per acquisire il blocco OPL 245 ammonterebbe a 1,1 miliardi di dollari, un fiume di denaro dispersosi in vari rivoli destinati a politici nigeriani ma, ipotizzano i magistrati milanesi, anche ad alti dirigenti del Cane a Sei Zampe. Nessuna compagnia delle dimensioni della Shell è mai andata a processo per un caso di corruzione di queste dimensioni.
Secondo Lanre Suraiu, presidente dell’organizzazione nigeriana Human and Environmental Development Agenda, “il processo milanese è un chiaro segnale per l’industria del petrolio che in Nigeria non si possono condurre affari come accaduto in passato e che è arrivato il momento per fare giustizia su un caso così importante come l’OPL 245”.
La genesi del procedimento milanese parte dalla denuncia presentata nell’autunno del 2013 da Re:Common, dalle organizzazioni inglesi Global Witness e The Corner House, e dall’attivista anti-corruzione nigeriano Dotun Oloko. In seguito alle denunce dei gruppi, sono stati aperti dei procedimenti legali in Nigeria e negli Stati Uniti. Sul caso stanno indagando anche magistrati olandesi.
Shell, Eni e i loro dirigenti hanno sempre negato tutte le accuse.
Antonio Tricarico di Re: Common, ha dichiarato: “Questo caso annuncia l’avvento dell’età della responsabilità, un mondo in cui anche le più potenti corporation non potranno più nascondere i propri errori ed evitare la giustizia”.
Per anni, la Shell ha affermato che per l’acquisizione del blocco OPL 245 aveva pagato solo il governo nigeriano. Ma dopo le indagini congiunte di Global Witness e Finance Uncovered, la società anglo-olandese ha confessato di aver trattato con l’ex ministro del petrolio Dan Etete, già condannato per riciclaggio di denaro. Etete aveva assegnato il blocco petrolifero OPL 245 alla sua società di proprietà, Malabu, mentre prestava servizio come ministro.
La prossima udienza è in programma il 14 maggio. A causa del lavoro eccessivo della decima sezione penale del tribunale e per evitare ritardi troppo lunghi il procedimento è stato infatti trasferito alla settima sezione.
L'articolo è stato preso dal sito di Re:Common, qui raggiungibile.
dinamoPress, 6 marzo 2018. Lo sgombero del bene pubblico occupato per impedirne la svendita avviene a elezioni fatte. Le forze dell'ordine «ammassano per strada i giochi della ludoteca autogestita, i disegni dei bambini, i libri, le installazioni artistiche, le stufe con cui ci si riscaldava da quando erano stati tagliati luce e gas». (m.p.r.)
Sgomberato questa mattina l’Antico Teatro di Anatomia a Venezia, bene pubblico occupato 5 mesi fa per impedirne la svendita. Ora i cittadini sono per strada, ma promettono: “Non diventerà un ristorante”.
A due giorni dalla chiusura delle urne, e mentre ancora si finiscono di ripartire i seggi conteggiando gli ultimi decimali, va in scena a Venezia il primo sgombero post-elettorale. Ora che non c’è più da racimolare qualche consenso, il disprezzo della classe politico-amministrativa nei confronti della cittadinanza si può mostrare in tutta la sua limpidezza, senza preoccuparsi di provare almeno un po’ di vergogna.
È un risveglio brusco quello della città lagunare: l’Antico Teatro di Anatomia, conosciuto da tutti come La Vida, viene circondato da uno schieramento spropositato di forze dell’ordine e i suoi locali sgomberati. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza occupano militarmente Campo San Giacomo, e ammassano in strada i materiali di cinque mesi di liberazione di uno spazio pubblico svenduto dalla Regione in ossequio agli appetiti della speculazione turistica: sotto una pioggerella fine, vengono portati in campo i giochi della ludoteca autogestita, i disegni dei bambini, i manifesti e gli striscioni, i libri, le installazioni artistiche, le stufe con cui ci si riscaldava da quando erano stati tagliati – in pieno inverno – luce e gas. Una folla sempre più numerosa accorre a montare gazebo e tendoni per salvare i materiali e per presidiare un campo che proprio grazie alla riapertura della Vida era ormai diventato un punto di riferimento per il quartiere e per la città. Spunta anche qualche tenda, e il presidio inizia a dare l’idea di un’acampada improvvisata.
La storia recente dell’Antico Teatro di Anatomia è esemplare di ciò che succede nelle nostre città, strette tra dismissione del patrimonio pubblico, interessi speculativi e tentativi di riappropriazione pubblica e partecipazione cittadina. Si tratta di un edificio di proprietà regionale, sede di alcuni uffici sottoutilizzati e in passato sempre praticamente chiuso. Un comitato locale lo reclama da oltre un anno all’uso pubblico, presentando alle istituzioni un progetto di apertura e gestione elaborato di concerto tra diverse associazioni locali. La risposta della Regione a guida Zaia è quella a cui ci hanno abituato le istituzioni pubbliche di troppe città e regioni: un muro di gomma fatto di silenzio e – quando andava bene – promesse a mezza bocca subito smentite dai fatti. Il 25 settembre infatti l’amministrazione regionale perfezionava la vendita dello stabile all’imprenditore Alberto Bastianello (della famiglia di soci fondatori Pam e Panorama) per 911mila euro, con il progetto di realizzare l’ennesimo ristorante.
Gli abitanti della zona non stanno però a guardare. In una città dove quotidianamente chiudono i negozi destinati ai residenti ed aprono di continuo bar e locali, che occupano lo spazio pubblico con plateatici sempre più invadenti che sottraggono l’uso dello spazio pubblico ad una fruizione libera e non commerciale, in cui gli spazi per l’abitare si restringono sempre più e in cui è ormai un’impresa trovare una casa o una stanza in locazione, tanto è più conveniente l’affitto turistico, un folto gruppo di cittadini riesce ad aprire, due giorni dopo, la porta dell’Antico Teatro e restituirlo alla città. Sei di loro sono tutt’ora sotto processo per occupazione.
Nei cinque mesi che sono seguiti La Vida è diventata un luogo di nuovo vivo. Presidiato giorno e notte da persone di tutte le età, animato quotidianamente da presentazioni di libri, mostre, concerti, discussioni pubbliche, laboratori, ha costituito un prezioso luogo di aggregazione per residenti, studenti, famiglie, tutti determinati a non vedersi sottratto l’ennesimo bene comune cittadino. Entrarci era sempre una festa e una sorpresa: un’occupazione che era a tutti gli effetti una liberazione, un luogo in cui i bambini la facevano da veri padroni, scorrazzando tra la ludoteca e il campo, potendosi sentire a casa loro in una città che sembra ormai non contemplarli più, presa com’è nella morsa della monocoltura turistica che la sta trasformando in un museo a cielo aperto o, peggio, in un parco giochi per visitatori mordi e fuggi.
Ora le istituzioni fanno quello che sembrano fare meglio: tentano di sbarazzarsi della città viva per meglio poter sfruttare il suo patrimonio ai fini della speculazione privata. Non hanno però fatto i conti con la tenacia della comunità che attorno alla Vida aveva trovato una nuova casa, aperta e inclusiva. Mentre sotto la pioggia continua ad affluire gente, che porta la sua solidarietà e la sua indignazione, viene lanciata in Campo San Giacomo un’assemblea cittadina per questo pomeriggio alle 5. E dal campo fanno sapere che la storia della Vida non è finita qui: non basta la polizia in assetto antisommossa per mandare a casa chi ancora testardamente si ostina a voler abitare la propria città. L’Antico Teatro non diventerà mai un ristorante. Togliete alla comunità la sua casa e ve la ritroverete per le strade, in questo caso per calli e campielli.
il manifesto, 6 marzo 2018. Ecco come le organizzazioni criminali in Veneto sono entrate nel tessuto economico attraverso un rapporto di convergenza di interessi con il mondo delle professioni e dell’impresa». (m.p.r.)
Gianni Belloni e Antonio Vesco, Come pesci nell'acqua, Donzelli, € 28
La mitologica locomotiva del Nord Est è deragliata anche perché la propaganda accademica o confindustriale non poteva eclissare il binario morto: le mafie in giacca, cravatta, colletto inamidato e valigetta 24 ore.
Se lo scenario si poteva intuire già nell’altro secolo, oggi la «distrazione» istituzionale viene certificata nell’ultima relazione della Commissione parlamentare antimafia presieduta da Rosi Bindi: «Le organizzazioni criminali in Veneto hanno approfittato di un’insufficiente attività di prevenzione e contrasto per mimetizzarsi nel tessuto economico attraverso un rapporto di convergenza di interessi con il mondo delle professioni e dell’impresa». Di più. Edilizia e sanità pesantemente infiltrate sono servite a finanziare la nuova frontiera della holding mafiosa: «La grande distribuzione commerciale, i settori dei rifiuti, delle energie rinnovabili, del turismo e delle scommesse e sale gioco, i servizi sociali e dell’accoglienza dei migranti».
Gianni Belloni (già coordinatore dell’Osservatorio ambiente e legalità di Venezia) e Antonio Vesco (dottore di ricerca in Antropologia all’Università di Siena e Paris I Sorbonne) documentano l’inquietante geografia di un territorio infestato dall’altra faccia del «modello di sviluppo».
Come pesci nell’acqua. Mafie, impresa e politica in Veneto () è la spietata radiografia della peste mafiosa che la politica – non solo leghista – rimuove proprio mentre l’economia continua a riprodurre contagi.
È un originale, profondo, insindacabile saggio che misura, grazie al metro delle mafie, il tessuto sociale dell’ipocrisia insieme alla trama che ai buchi neri della pubblica amministrazione alterna il ricamo del business senza più regole. Belloni e Vesco hanno studiato gli squali dentro l’acquario, quanto le maree che li favoriscono. Fuor di metafora, affiorano i circuiti protetti e la rete «imprenditoriale» che azzerano il libero mercato, il controllo di legalità, l’interesse pubblico.
Come pesci nell’acqua sviluppa alcuni casi eclatanti con l’aggiunta di una sintomatica «diagnosi differenziale» del Veneto. A Verona ricostruisce il quadro dell’«altra ’ndrangheta» connessa con gli amministratori della giunta Tosi, come acclarato già da Report. A Padova, analizza l’inchiesta su Francesco Manzo che spicca perfino nell’operazione del centro direzionale di Interporto, rimasto uno scheletro: maxi-sequestro patrimoniale deciso dalla Dia di Venezia, ma revocato dal Tribunale di Padova… Poi c’è il «caso Pitarresi» che dalla provincia di Treviso conduce in Sicilia, sulla scia soprattutto dei permessi di soggiorno falsi: «Gli inquirenti calcolano che nell’arco di cinque anni, abbia maneggiato e, comunque, avuto la disponibilità di circa 15 milioni di euro».
Arriverà, invece, a sfiorare i due miliardi il giro d’affari con ramificazioni venete scoperto nell’operazione «Gambling» della Procura di Reggio Calabria. Infine, le inchieste Aspide e Catapano: secondo Belloni e Vesco, «svelano il ruolo cruciale svolto da professionisti, consulenti finanziari e procacciatori d’affari in genere nel supportare direttamente le attività delle due società. Un caso esemplare è quello del notaio Luca Arnone, di Lendinara». Come pesci nell’acqua non fa che nutrire la tesi con cui l’economista Stefano Solari dell’Università di Padova descrive il «compattamento delle reti a fronte della crescente incertezza dei mercati», in cui si annida il malaffare.
E alla fine del saggio arriva puntuale la conferma «indiretta». Attraverso lo scandalo Mose, che ruota intorno al Consorzio Venezia Nuova concessionario unico di 5 miliardi d’appalti. È il sistema politico bipartisan che diventa contraltare del vorticoso giro di soldi, fatture, assunzioni, sponsorizzazioni. Come si poteva facilmente immaginare fin dagli esordi, il Consorzio di Mazzacurati & Baita ha trasformato la laguna nella nuova Tangentopoli senza limiti. Uno degli investigatori sorride ironico durante l’intervista con Belloni e Vesco: «Era un sistema così ben congegnato che non ci poteva più entrare nemmeno un’acciuga».
È la «Mafia di Venezia» denunciata, da sempre, da chi non ha piegato la testa. È lo specchio istituzionale della presenza criminale a Nord Est. È il punto di non ritorno, quando un’impresa come Mantovani fattura in funzione del Mose, la politica (dal «doge» Galan fino ai sindaci Pd) diventa intermediazione e perfino l’ex patriarca ciellino contabilizza senza remore.
Sull'argomento vedi su eddyburg anche l'articolo di Filippomaria Pontani, da "il Fatto Quotidiano"

il Fatto Quotidiano, 5 marzo 2018. Un'inchesta di Fanpage su Porto Marghera, uno dei pestiferi prodotti dello sviluppismo del XIX secolo), e dell'opaco tessuto di corruzione che ne garantiscono l'inquinante presenza
Più permeabile delle ecoballe. Questa è l’impressione che lascia il sistema dello smaltimento dei rifiuti in Italia alla luce dell’inchiesta di Fanpage, qualunque cosa si pensi dei metodi con cui è stata realizzata.
La quarta puntata ha abbandonato la Campania dei De Luca per dedicarsi al Veneto, regione in cui da molti anni si moltiplicano i capannoni misteriosamente bruciati, le speculazioni sospette, i palesi atti di intimidazione, soprattutto nel settore dei rifiuti ma non solo: nonostante le molte inchieste sulla ’ndrangheta a Nord-est, nonostante i recenti allarmi della Commissione parlamentare antimafia, i veneti, più ancora dei lombardi e degli emiliani, faticano a riconoscere – a fronte della retorica, anche referendaria, del “padroni a casa nostra” – che il famoso “territorio” è sempre più in mano a consorterie armate di altra provenienza.
Nel video di Fanpage rimane sconcertante e controverso il ruolo della principale interlocutrice dell’agente provocatore, ovvero l’architetto
56enne Maria Grazia Canuto, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2002), già componente del Comitato Tecnico-Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sull’Amianto, già candidata alle comunali di Treviso con una lista civica di centrodestra (2013), vicepresidente (ora sospesa) dei Centri per l’Ascolto del Disagio, nonché presentata in diversi dibattiti pubblici come docente di Criminologia ambientale dell’Università di Padova (dove non risulta però aver avuto alcun incarico) e come consulente del ministero dell’Ambiente, dove pure smentiscono l’affiliazione. Resta allora da spiegare come mai nell’inchiesta ella venga indicata da più soggetti come il vero legame con la politica nazionale dei rifiuti e come mai tratti con familiarità tanto imprenditori di dubbia onestà quanto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro equanto lo stesso ministro dell'Ambiente Galletti.
Uno dei momenti-clou del filmato
di Fanpage è proprio il breve colloquio con Galletti, propiziato dalla
Canuto e avvenuto il 26 gennaio
scorso a margine della presentazione del nuovo piano di bonifica del sito di Porto Marghera In quell’incontro contro l’agente provocatore e l’imprenditore coinvolto nell’affare,
proprietario di un’area presso Fusina, limitrofa a quella del Comune,
presentano al ministro – ovviamente inconsapevole – un sistema “tombale” e innovativo per bonificare un milione di metri cubi di terreno, seppellendo tutto entro calcestruzzo munito di apposite guaine: dagli accordi presi in precedenza, si comprende che si tratta in realtà di un sistema per riciclare denaro di provenienza camorristica. La Canuto sostiene ora, sbandierando pregresse battaglie contro le ecomafie nella Terra dei Fuochi, di aver seguito il consiglio dei suoi avvocati e di aver dato corda alla proposta nell'attesa di denunciarla, anche quando ella garantiva apertamente il “lavaggio” dei soldi camorristici senza mostrare disagio verso i metodi spicci della criminalità, e anche quando riceveva una valigetta che pensava piena di contanti per 2,8 milioni di euro (in realtà c’erano dentro paccheri napoletani). Se è davvero così (lo stabilirà la magistratura), si può dire che la sua recita è stata estremamente credibile.
Porto Marghera, ancora oggi
Ma al di là del caso singolo, rimane la realtà di Porto Marghera, un sito tutt’oggi gravemente inquinato, per il quale proprio nell’incontro di gennaio è stata costituita una “cabina di regia” tra il governo (un governo in scadenza, le cui promesse – molti temono – rischiano di essere scritte sull’acqua), la Regione e la Città metropolitana: si sono sbandierate le consuete agevolazioni alle imprese che vengano a investire in questa “area di crisi complessa”. In verità nessuno sa di preciso come verranno usati gli ingenti investimenti pubblici promessi (80 milioni stanziati; nel 2015 la Commissione ecomafie aveva denunciato lo sperpero di ben 785 milioni in bonifiche rivelatesi poi inutili, anzi dannose). Secondo alcuni sindacati (anzitutto Filctem) nella gestione privatistica che viene disegnata si annida il rischio di infiltrazioni criminose e di affari incontrollati mossi da società opache. I comitati civici di Marghera denunciano il rischio che tutta l’area diventi pian piano – tentativi in tal senso sono stati già sventati negli ultimi anni – un territorio di inceneritori e trattamento rifiuti, in mano al business delle ecomafie.
Qualunque sia la retorica governativa di Marghera come “esempio di rigenerazione complessiva del territorio all’insegna della sostenibilità ambientale», a molti resta l’impressione, certificata dagli studiosi, di una notevole permeabilità al crimine organizzato. In questo contesto grida vendetta lo smantellamento, a opera dell’amministrazione Brugnaro, dell’Osservatorio ambiente e legalità creato in collaborazione con Legambiente dall’ex assessore Gianfranco Bettin: sin dal 2013 questo istituto diretto da Gianni Belloni ha redatto preziosi rapporti sulle infiltrazioni nell’edilizia, nella logistica, nelle rinnovabili, e ha mostrato come il Veneto si collochi al primo posto in Italia per il traffico illegale dei rifiuti, con particolare riferimento proprio al caso di Porto Marghera.
Sono i dettagli a essere rivelatori. L’incontro con Galletti e Brugnaro, il 26 gennaio scorso, si è tenuto in fondo al Padiglione Antares del Vega (lo si vede nel filmato di Fanpage). Il Vega è un grande parco scientifico e tecnologico, dalle alterne fortune, costruito 25 anni fa come prima prospettiva di rilancio di Porto Marghera (oggi, analoghe aspettative riguardano la bioraffineria “verde” dell’Eni, che però funziona con olio di palma, e il futuribile terminal delle Grandi navi, che comporterebbe però un’ulteriore devastazione della Laguna). Ebbene, nello stesso Padiglione Antares, in uno spazio adiacente alla sala convegni, è montata fino a maggio una mostra per il centenario di Porto Marghera (1917-2017), dal nome Industriae: non la mostra, magniloquente e un po’ pretenziosa, ospitata per poche settimane al Palazzo Ducale di Venezia, bensì una raccolta potente e curatissima degli strumenti di lavoro, delle tute degli operai, delle produzioni e delle materie prime trattate dalle tante industrie (chimiche, petrolchimiche, meccaniche, cantieristiche, cerealicole...) ospitate in cent’anni su questi terreni ora per lo più abbandonati al loro destino di morte.
I pannelli esplicativi chiariscono la nascita delle singole aziende, i loro momenti di gloria e di declino, le fusioni e i passaggi di proprietà: un pezzo, per lo più sconfortante, di storia industriale del nostro Paese, dal conte Volpi alla Montedison, dalla Vetrocoke all’Eni. In alto, degli schermi obliqui presentano interviste a operai e impiegati che ricordano le loro esperienze di fabbrica: manca la dimensione politica delle lotte operaie, ma quella è in fondo un’altra storia. Frutto di una ricerca che interessa l’appassionato di storia, di chimica e di scienza, questa piccola mostra schiude senza retorica il senso di un impegno umano che credeva nello sviluppo industriale del Paese, e che è stato travolto prima dai terribili veleni del petrolchimico e poi dalla crisi indotta dal mercato globale. C’è da sperare che le conferenze stampa e i più discreti pourparler che avvengono a pochi metri da quelle sacre reliquie, non abbiano a mostrarsi ancora troppo indegni di quel patrimonio di lavoro e di speranza cui sono chiamati a dare un futuro.

NENAnews, 3 marzo 2018. Un'intervista su tre robusti nodi, tra loro connessi, nel pettine della ricerca di equità, giustizia, democrazia: la condizione femminile, la Palestina oggi, il potere dell'Accademia
«Un’intervista con l’antropologa Ruba Salih, ospite ieri della rassegna "Femminile Palestinese» curata da Maria Rosaria Greco, su decolonizzazione e libertà accademica. "Il meccanismo attraverso cui una cultura giustifica la violenza gli permette di autoescludersi da essa»
A settant’anni anni dalla Nakba e la fondazione dello Stato di Israele il popolo palestinese vive da rifugiato, apolide e disperso. Dentro la Palestina storica la colonizzazione israeliana prosegue incessante, supera le frontiere ed entra nel linguaggio, la produzione del sapere, la narrativa internazionale.
Il processo di «memoricidio», come l’ha definito lo storico israeliano Ilan Pappe, ha permesso a Israele di radicare nell’immaginario collettivo miti che non hanno riscontro storico, un’idea di Israele che plasma una storia e forgia un linguaggio, quelli del vincitore.
Ne abbiamo discusso con Ruba Salih, antropologa italo-palestinese e docente alla Soas dell’Università di Londra. Con Pappe è stata all’Università di Salerno ieri per discutere di «Decolonizzazione e libertà accademica», evento della rassegna Femminile Palestinese curata da Maria Rosaria Greco.
Cosa significa decolonizzare l’accademia?
Gli effetti del processo coloniale del secolo scorso, la cui espressione attuale è l’occupazione israeliana, rimbalzano nel mondo accademico, non esistendo una produzione del sapere isolata dagli avvenimenti politici esterni. Si vede nei programmi, le politiche delle università, i testi spesso distorti in quanto riproduttori di canoni coloniali. La decolonizzazione si realizza in primo luogo individuando i legami che la produzione del sapere ha con l’apparato economico, militare e politico responsabile dei processi neocoloniali.
In secondo luogo svelando i modi in cui l’università riproduce una politica economica non neutrale ma basata su rapporti di potere: attraverso corporation e investimenti in paesi in cui tali processi sono in atto e attraverso l’ammissione di studenti di una certa classe o etnia, decidendo a priori chi diventerà élite e chi ne sarà escluso. In terzo luogo agendo sulla cultura politica quotidiana, ripensando la performatività dell’insegnamento e le modalità di rapporto con persone che non hanno la stessa tradizione pedagogica o epistemologica.
Infine, decolonizzando il sapere: analizzare come i paradigmi neocoloniali sono riproposti nella letteratura, ancora improntata sul sapere bianco, maschile, di upper class, che rappresenta culture e popoli diversi come soggetti chiusi e statici, oggetti di ricerca estranei alla loro dimensione politica e culturale. Una forma di feticismo.
In Italia sono stati cancellati eventi, anche da università, incentrati sulla Palestina. Lei è stata protagonista di un simile atto di censura. Cosa è successo?
A novembre avevo organizzato un evento con Omar Barghouti all’Università di Cambridge. L’ateneo lo ha cancellato e io sono stata accusata di non essere neutrale. Un attacco gravissimo, che prelude alla messa in discussione della mia capacità di insegnamento, e al mondo accademico in sé perché la censura è giunta nel quadro di Prevent, la legge britannica anti-terrorismo e anti-radicalizzazione. La sua oscura implementazione ha trasformato le università in luoghi di sospetto dove la libertà di espressione si è assottigliata.
E Prevent ha un capitolo dedicato alla questione palestinese, etichettata come area di radicalismo. Professori e studenti si sono mobilitati: sono state raccolte firme e il caso è stato reso pubblico. Cambridge è stata accusata di violazione della libertà di espressione e di insegnamento. E alla fine si è scusata, dicendo di aver ceduto alle pressioni di quelle che ha definito lobby. In Inghilterra sono fortissime, gruppi con la missione di limitare le espressioni di solidarietà con la Palestina.
Intervengono con diverse strategie: l’ambasciatore israeliano fa il giro delle università come ospite; attivisti pro-israeliani intervengono sistematicamente nei dibattiti per ridicolizzare la discussione, accusare di antisemitismo o filmare i presenti, compiendo violenza psicologica. Si difendono parlando di libertà di parola, che però non vale in senso positivo visto che ci impediscono di esercitare la nostra. Promuovono un’idea asettica e neo-liberal della neutralità, che si applica solo ad alcuni ambiti.
In un suo saggio su islamismo e femminismo parla della necessità di superare «l’approccio etnocentrico con cui molta parte del pensiero femminista occidentale ha per lungo tempo guardato ad altre esperienze di emancipazione, soprattutto nel mondo islamico». Siamo fermi alla visione coloniale del secolo scorso, paternalismo e superiorità intellettuale?
Oggi non esiste nemmeno più l’approccio paternalistico verso le donne dei paesi colonizzati, quella missione «civilizzatrice» che il colonizzatore si attribuiva. Si è andati oltre gerarchizzando l’umanità. Con la rinascita di movimenti neofascisti non c’è più bisogno di produrre un discorso legittimizzante: l’altro non esiste in quanto essere umano. Macerata ha palesato l’approccio suprematista che cancella il discorso culturale con cui il colonialismo si legittimava. Scompare anche la «curiosità» che mosse i colonizzatori, una conoscenza mirante al controllo in senso foucaultiano. Oggi l’interesse alla conoscenza non c’è perché una parte di umanità va esclusa ai fini dello sviluppo generale. Su questo ha un ruolo anche l’accademia dove riemergono pericolose riabilitazioni di rappresentazioni coloniali, che nella pratica pesano su studenti di una certa provenienza, sottoposti a draconiane misure di controllo.
Rientra in tale contesto anche il superficiale approccio all’Islam, etichettato come religione di oppressione femminile?
Si è fermi all’idea coloniale della donna come priva di volontà e capacità di decidere per sé. Il discorso è simbolico e politico: sui corpi delle donne si costruisce il senso della nazione e si misurano i suoi confini rispetto alle altre. La questione in Occidente non attiene alla donna in sé, ma alla necessità di giustificare l’enorme violenza che le società occidentali esercitano sulle donne.
Pensiamo alle due giovani uccise in Italia con quasi identiche modalità, Pamela a Macerata e Jessica a Milano: nel primo caso un paese si è mobilitato fino a un attentato terroristico quasi legittimato; sul secondo è calato il silenzio, seppur si tratti di identica violenza esercitata da un uomo. Il meccanismo attraverso cui una cultura giustifica la violenza gli permette di autoescludersi da quella violenza, riproponendo l’idea che il male sia altrove.
Domani, a Salerno, prenderà parte alla rassegna «Femminile palestinese», che racconta la Palestina attraverso le voci delle donne…
Il movimento delle donne in Palestina è vecchio di cento anni, inserito in una società tradizionale dove coestistono movimenti femministi, religiosi, comitati popolari, dove la resistenza è quotidiana. In Palestina dove c’è politica ci sono le donne, come ci sono nella produzione culturale e artistica di cui spesso hanno influenzato se non modificato la narrativa (penso a scrittrici come Sahar Khalifeh o poetesse come Fadwa Tuqan). Eppure per lungo tempo l’occupazione israeliana ha guardato alle donne palestinesi come soggetti fragili e quindi oggetto di minore violenza diretta. Non per umanità ma per una struttura mentale coloniale che guarda alla società palestinese come retrograda e patriarcale.
Oggi il cambiamento è dirompente: se nella Prima Intifada c’è stata una sospensione dei ruoli di genere, perché le donne partecipavano alle diverse forme di disobbedienza civile e alla costruzione della società esattamente come gli uomini, oggi le donne – lo dimostra Ahed Tamimi – hanno ripreso un ruolo su tutti i livelli, anche quello fisico, ponendo i loro corpi contro l’occupazione. È una presenza che parla agli uomini palestinesi ma anche all’occupazione, un doppio processo di de-mascolinizzazione.
Da giorni le università britanniche sono in sciopero. Quali le ragioni?
È il più grande sciopero della storia accademica britannica contro il progetto di far dipendere le pensioni dall’andamento del mercato: si profila un dimezzamento della pensione. Ciò significa che chi non viene da famiglie benestanti sarà escluso dal mondo accademico. È un attacco generalizzato alla cultura, giustificato con la bugia del deficit. Ma se gli studenti pagano in media 9mila sterline l’anno, gli atenei licenziano, ristrutturano e non reinvestono in borse di studio o programmi educativi. Al contrario raddoppiano gli stipendi dei manager e investono nel settore immobiliare. Nulla di nuovo nel panorama del neoliberismo. Di nuovo c’è il mix tra delegittimazione degli accademici e guerra dei ricchi ai poveri.