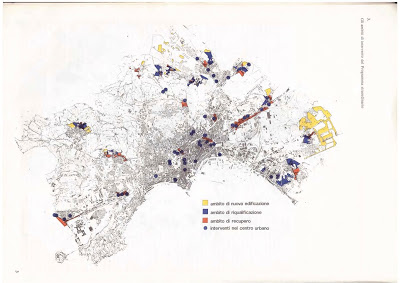Millenniourbano.it, 5 maggio 2016 (m.p.r.)
La ricorrenza dei cento anni dalla nascita a Scranton (Pennsylvania) di Jane Jacobs è una buona occasione per domandarci come le sue critiche dell’urbanistica novecentesca abbiano cambiato lo sguardo sulla città contemporanea. Esse hanno sicuramente esercitato una grande influenza non solo a New York, dove, da abitante del Greenwich Village, Jacobs si è battuta instancabilmente contro i progetti di rinnovamento urbano Robert Moses. La sua battaglia contro la Lower Manhattan Expressway che, se realizzata, avrebbe espulso migliaia di persone e sconvolto la vita di un intero quartiere, ha indicato - ovunque nel mondo alle comunità di persone spesso minacciate da simili progetti - che ogni abitante della città ha le competenze per esprimere la sua opinione in merito a come essa viene trasformata.
Da giornalista e madre di famiglia - non certo da urbanista - nel 1961, Jane Jacobs pubblicava Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane, una lettura della città contemporanea in cui veniva utilizzata l’esperienza quotidiana, fatta di vita di quartiere e di spostamenti con mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta, in contrapposizione all’idea di città-macchina di Robert Moses, il deus ex machina dei lavori pubblici di New York.
Il suo è un libro sulla diversità urbana che individua quattro fondamentali fattori in grado di generarla almeno alla scala del quartiere: la presenza del maggior numero di funzioni di base (abitazioni, attività commerciali, imprese, servizi, ecc.), la piccola dimensione degli isolati che ha come conseguenza il maggior numero di strade da percorrere e di “angoli da svoltare”, edifici di diversa età e condizione e una buona densità di popolazione per favorire l’incontro delle persone. Si tratta di aspetti che la città razionalista del ‘900 ha variamente contrastato, preferendo separare le funzioni, dimensionare al massimo edifici e isolati, prevedere zone omogenee per tipologie edilizie e densità e facendo in modo che quest’ultima fosse sufficiente bassa da prevenire i problemi di carattere igienico e sociale del sovraffollamento. La gran parte dei problemi con i quali sono confrontate le città oggi, compresa la loro incontrollata espansione suburbana, nascono da questo approccio.
Nella narrazione di Jane Jacobs la città è al contrario un sistema complesso che si auto-regola e di questa capacità di autoregolazione i suoi abitanti, a differenza di molti urbanisti, sono perfettamente consapevoli. Jane Jacobs ha sottolineato più di mezzo secolo fa come l’opera dell’erede newyorchese del Barone Haussmann (Moses amava riferirsi al prefetto della Senna che a metà Ottocento trasformò radicalmente Parigi), con il suo disprezzo per la gente che anima lo spazio urbano, è stata la rappresentazione più significativa della incapacità dell’urbanistica moderna di comprendere la vita delle città. Purtroppo non mancano le occasioni di constatare quanto sia viva ed operante l’eredità del pensiero di Moses, se qualcuno si sente in dovere di pubblicare un libro che, in maniera paradigmatica, s’intitola Contro l’urbanistica.
Saskia Sassen, che sui cambiamenti impressi alle città dai processi economici della globalizzazione scrive da qualche decennio, ha ricordato sulle colonne del Guardian il suo incontro con una anziana signora che agli inizi degli anni 90, durante una conferenza a Toronto, intervenne per criticare il suo modo di analizzare la città nel modo più acuto che avesse mai sentito. Ribaltando la visione di Sassen, Jane Jacobs (che a Toronto si era trasferita in opposizione all’intervento militare degli Stati Uniti in Vietnam) metteva al centro la questione del luogo, invitandola così a passare dalla scala macro delle grandi metropoli globali a quella micro dei quartieri, le cui specificità, a partire dalle esperienze dei residenti locali, vengono progressivamente cancellate. Questo differente sguardo sulla città ha condotto Sassen a rivedere il fatto che gli aspetti che rendono tale una metropoli - l’enorme diversità dei lavoratori, i loro spazi di vita e di lavoro, le molteplici sub-economie coinvolte - siano tutt’altro che irrilevanti, quasi appartenessero ad un’altra epoca, nello studio delle città globali.
Perché - si domanda Sassen - è così importante recuperare il senso del luogo nelle analisi dell’economia globale letta attraverso le grandi città? Perché ciò ci consente di vedere che nelle economie regionali, nazionali e globali sono incorporate le diversità economiche tipiche dello spazio urbano e viceversa che lo spazio urbano è il componente fondamentale di queste economie. Jacobs ha capito che la città è molto più della somma dei suoi residenti, dei suoi edifici e delle aziende: essa è la trama nella quale le sub-economie si intrecciano variamente, nei differenti quartieri, con la vita delle persone. Il modo in cui queste differenze economiche e spaziali reagiscono ad esempio alla massiccia gentrification della città contemporanea è qualcosa che andrebbe indagato attraverso l’approccio complesso con il quale Jane Jacobs ci ha insegnato a guardare la città. Non importa quanto esse possano diventare smart e globali, ciò che non bisogna smettere di fare è rimettere al centro dell’analisi urbana la dimensione del luogo, solitamente negletta da chi si occupa di economia delle città. D’altra parte già nel 1969, in apertura del suo L’economia delle città, Jacobs si chiedeva: «perché alcune città crescono mentre alte ristagnano e poi decadono?» Perché l’efficienza economica delle imprese non coincide con il successo delle città che le ospitano? E’ la diversificazione del tessuto produttivo delle città ciò che consente loro di prosperare ma questa diversità è un tipico prodotto urbano, qualcosa, appunto, che non si deve smettere di indagare.

«Esperienze di auto-determinazione di comunità locali. Poco importa se queste esperienze hanno differenze e grandi fragilità, una cosa è certa: ovunque gruppi di cittadini hanno smesso di delegare e dimostrano che è possibile creare luoghi sociali». Comune-info, 3 maggio 2016 (p.d.)
In molte città europee, come conseguenza delle varie ondate di crisi politiche ed economiche del passato decennio, il settore pubblico ha gradualmente ridotto l’erogazione di alcuni servizi. In alcune città, organizzazioni e gruppi di attivisti si sono impegnati a fornire quei servizi che non erano più offerti dalla pubblica amministrazione. Parallelamente, molti architetti, urbanisti e attivisti sociali hanno riconosciuto che i modelli di finanziamento e di organizzazione tradizionali non erano in grado di supportare iniziative di piccola scala e progetti urbani con un impatto sulle comunità locali, e hanno cominciato ad elaborare alternative per aiutare i cittadini ad accedere a questi servizi.
Il crescente bisogno di infrastrutture e servizi alternativi che fossero autosufficienti e comunitari, ha avuto un impatto significativo sulle nostre città. Gli attori di queste iniziative sono emersi come protagonisti (mediatori, organizzatori ed esperti tecnici) di un nuovo movimento che si focalizza sul coinvolgimento sociale e su interventi di piccola scala, mettendo a sistema le risorse locali con i bisogni delle comunità. Se da una parte la precarietà organizzativa ed economica di molte di queste iniziative ha portato alla conclusione di queste esperienze, dall’altra in alcuni casi ha comportato lo sviluppo di nuove sperimentazioni volte al consolidamento dei servizi di welfare alternativo erogati.Iniziative di questo tipo si sono sviluppate in varie città europee, con sfumature diverse a seconda del contesto specifico, e variano dalla gestione di spazi verdi a spazi culturali, da mense sociali a servizi di assistenza medica o educazione auto-organizzata.
Questo articolo racconta le iniziative sviluppate ad Atene, Berlino, Liverpool e Rotterdam, mostrando come questo sia un trend crescente in Europa e mettendo in luce diversi aspetti del rapporto che si costruisce tra le comunità e gli altri attori locali.
Atene: la rete di servizi civici
Se nei Paesi del Nord-Est Europa riscontriamo uno spirito di imprenditoria sociale economicamente più solida, nel Sud Europa prevalgono le iniziative promosse da movimenti e gruppi di azione civica. Queste ultime non sempre hanno sviluppato modelli economici sostenibili, forse anche a causa di una differente cultura locale e storia imprenditoriale. Nel caso di Atene, nel settembre 2015 siamo andati a conoscere molte di queste iniziative civiche che hanno sviluppato servizi come giardini condivisi, mense sociali, servizi di assistenza sanitaria, educazione, sport e cultura. Nel quartiere di Metaxiria abbiamo incontrato la mensa socia leed il dopo-scuola auto-organizzati da Kostantinos e la sua associazione. Entrando nello spazio ci hanno spiegato di aver affittato un grande appartamento per metterlo a disposizione del quartiere, ospitando i ragazzi dopo le ore scolastiche nonché fornendo quotidianamente pasti caldi agli abitanti della zona ma anche ai rifiugiati che erano accampati nelle piazze di Atene. La bellezza della filantropia di Kostantinos e dei suoi colleghi ci hanno commossi, ma come garantire una sostenibilità di queste iniziative nel tempo? Pochi giorni dopo abbiamo conosciuto Boroume (Possiamo), un’associazione che funge da piattaforma logistica per la raccolta degli scarti alimentari da ristoranti e supermercati e la redistribuzione verso le innumerevoli mense sociali, sia comunali che auto-organizzate, come quella di Kostantinos. I fondatori dell’organizzazione ci spiegano come Boroume sia un servizio pubblico, svolto senza sovvenzioni pubbliche, che collabora con l’amministrazione i per ottimizzare la distribuzione degli alimenti. Gli stipendi delle otto persone dell’organizzazione sono pagati grazie a donazioni e finanziamenti di fondazioni. Discutendo del loro modello organizzativo ed economico ci spiegano come sia complessa in Grecia la crescita delle imprese sociali perché, a causa di una lunga storia di corruzione e oscuri finanziamenti a Ong vicine al potere, la credibilità degli operatori economici sia fortemente debilitata agli occhi del pubblico.
Berlino: proprietà collettiva come spazio libero
“ExRotaprint è un progetto di sviluppo urbano che affronta il mercato immobiliare e l’economia, le tendenze di separazione ed esclusione sociale, le strategie di politica urbana […] è un esempio di come sviluppare nuovi progetti nello spazio urbano. Qui esiste un orizzonte di possibilità, senza scopo di lucro, basato non su ideologie ma su accordi e consensi. […] The gGmbH non-profit ExRotaprint scardina i meccanismi della spirale speculativa del mercato immobiliare e si appropria dell’edificio tramite un diritto di superficie ereditario. È responsabile per tutti gli aspetti di sviluppo, finanziamento, affitto degli spazi e restauro dell’edificio. I partner di ExRotaprint non traggono profitto dalle attività dell’edificio e non possono creare un incremento del valore dell’immobile tramite la vendita della loro quota. Pertanto allo spazio è garantita una stabilità durevole che può essere creata dagli utenti dello spazio seguendo le loro esigenze.”
Citazione da intervista con Daniela Brahm, ExRotaprint
Il complesso industriale ExRotaprint, è situato in una vecchia fabbrica di macchine da stampa a Nord di Berlino, nel quartiere di Wedding, ed è stato venduto dal Comune di Berlino a un gruppo di abitanti nel 2009, con l’aiuto di due fondazioni interessate a investimenti sostenibili e a progetti comunitari socialmente responsabili, con l’obiettivo di togliere dal mercato speculativo le proprietà immobiliari. Il complesso conta 10.000 metri quadrati e oggi, una voltaesclusa la possibilità di venderlo a costruttori, ospita varie attività sociali, culturali e produttive grazie ad una gestione cooperativa, che crea abbastanza profitto da garantire il restauro dell’edificio.
Nel 2009 un gruppo di artisti e di residenti decise di sviluppare un nuovo progetto per l’edificio ExRotaprint che era stato messo in vendita dal Comune di Berlino al miglior offerente. Dal momento che, sempre nel 2009, l’edificio era diventato patrimonio storico, non poteva essere abbattuto ma le sue funzioni future erano ignote. I residenti non furono inizialmente presi sul serio dal Comune, motivo per cui si consociarono in un’associazione di inquilini che avrebbe condiviso le stesse prospettive, portando avanti varie discussioni sul concetto di profitto e su come l’investimento di capitale avrebbe influito sul potere decisionale.
“Nessuno aveva soldi ma l’idea di generare denaro, la fantasia del profitto fu una vera bomba. Èstata la parte più difficile del progetto, l’idea del profitto ha quasi distrutto il gruppo ancora prima che si formasse”.
Citazione da intervista con Daniela Brahm, ExRotaprint
La proprietà dell’immobile segue un modello piuttosto interessante: gli abitanti hanno comprato l’edificio per il quale pagano l’affitto, fra i 3 ed i 4,5 euro al mq, uno dei canoni più bassi a Berlino. Con questi fondi si ripaga il mutuo acceso con la Fondazione Trias in Germania e la Edith Marion a Basilea, in Svizzera. Nonostante il diritto di superficie ereditario, la proprietà del terreno è stata data per 99 anni alle Fondazioni mentre la ExRotaPrint gGmbH, l’azienda non-profit che gestisce il progetto, possiede l’edificio. Questo modello toglie l’immobile dal mercato e previene meccanismi di speculazione immobiliare. La gestione dell’edificio è portata avanti dalla ExRotaPrint gGmbH, dove dodici partner che rappresentano gli inquilini si incontrano mensilmente per prendere decisioni sullaregolare amministrazione dell’edificio, mentre quattro si incontrano ogni settimana. Inoltre le decisioni sono prese in accordo con l’Associazione di Inquilini. Tutti gli interventi di ristrutturazione dell’edificio sono pagati con un mutuo di 2,3 milioni di euro stipulato con Coopera Sammelstiftung Puch, un Fondo Pensionistico Svizzero, che ha una rata fissa del 4 per cento. Lo spazio è organizzato con una divisione equa delle attività a fini sociali, culturali e produttivi. Il progetto ha un bilancio annuo pari a zero, perché i profitti, che provengono dagli affitti degli spazi e dal bed&breakfast, vengono reinvestiti per pagare il mutuo di Coopera Sammelstiftung Puch, per le ristrutturazioni, e quelli con le Fondazioni Trias ed Edith Marion, per l’affitto del terreno.
Sebbene il progetto abbia un importante impatto sociale, fornendo spazi a prezzi accessibili per attività di piccola imprenditoria, spazi culturali e sociali come corsi di lingua tedesca per migranti o scuole serali, esso è gestito completamente da privati, senza alcun tipo di cooperazione con l’amministrazione pubblica. Questo è anche il caso di Holzmarkt, una cooperativa che si è prefissata l’obiettivo di rigenerare l’ultimo spazio libero lungo il fiume Spree in modo da sviluppare un progetto sociale e inclusivo, o dello Spreefeld, un progetto di co-housing con 6.000 mq di residenze e 1.500 mq di servizi in parte accessibili anche al quartiere. Anche nel caso del Markthalle Neun, un mercato messo in vendita dal Comune di Berlino che a seguito di varie proteste cittadine acconsentì a dare l’edificio all’offerta migliore in termini di programma e offerta al quartiere con un prezzo fisso. Nel 2012 l’edificio è stato venduto ad un gruppo di giovani imprenditori e oggi ospita al suo interno un mercato di prodotti locali, oltre a un supermercato discount, caffetterie, ristoranti, fiere di vendita diretta dei produttori, un programma educativo, un parco giochi per bambini e uno spazio per piccoli spettacoli. Attualmente conta quaranta attività commerciali e dà lavoro a circa cento persone.
Liverpool: nuovi modelli di gestione e accesso alla proprietà collettiva
A seguito della Housing Market Renewal Initiative (iniziativa di Rigenerazione del Mercato Immobiliare) portata avanti dal governo britannico in molti quartieri popolari del Regno Unito, molte case furono evacuate in attesa di demolizione e ricostruzione. A causa della crisi economica del 2008, i lavori non sono iniziati e perciò rimangono ancora oggi intere strade con case abbandonate. Questo è il contesto del quartiere di Anfield di Liverpool, accanto al noto stadio, dove la comunità locale ha preso in gestione una panetteria, Homebaked (“cucinato a casa”) per sviluppare con la cittadinanza un centro di incontro e di dialogo per il futuro del quartiere. Dopo più di due anni di partecipazione, nel 2012 Homebaked è diventata una Community Land Trust con l’obiettivo di ristrutturare il complesso edilizio dove si trova la panetteria, creando spazi per imprese e abitazioni a prezzi accessibili. Un’esperienza simile è stata portata avanti dal progetti Granby Four Streets dove non lontano da Homebaked un’altra comunità locale ha preso in gestione un isolato del quartiere per creare abitazioni e spazi per imprese a prezzi calmierati, sempre tramite lo strumento del Community Land Trust. Queste ultime sono organizzazioni gestite dalle comunità locali che possono portare avanti una serie di attività, da abitazioni accessibili a giardini condivisi, dove la comunità gestisce il terreno garantendone l’accesso individuale nell’interesse della comunità. La proprietà del terreno e degli edifici è della comunità e non può essere oggetto di compra-vendite nel mercato immobiliare. Le forme di utilizzo, compresa la concessione in uso a famiglie, associazioni e imprese, sono decise dall’organizzazione, nell’interesse della comunità.
Olanda: imprenditorialità civica come strumento di inclusione
L’Olanda, grazie alla propria tradizione commerciale e alla propria cultura del compromesso, seguendo il “modello Polder”, ha sviluppato recentemente dei progetti dove la società civile ha mostrato spirito imprenditoriale e ha sviluppato collaborazioni sia con il settore privato che con quello pubblico.
Questo è per esempio il caso di Zoho a Rotterdam, dove lo studio di pianificazione Stipo, assieme alla Associazione Edilizia Havensteder, ha sviluppato un progetto di rigenerazione di un’area degradata accanto alla stazione di Rotterdam.Attraverso le negoziazioni con i proprietari e sono state create le condizioni per attrarre rappresentanti del settore creativo, imprenditori locali e cittadini. In questo modo è stato possibile rigenerare il quartiere in termini sociali, economici e culturali.
Una vicenda simile è stata portata avanti ad Amsterdam nel progetto De Ceuvel, dove è stato sviluppato unospazio per industrie creative e imprese sociali vicino al Canale Hasselt a Nord di Amsterdam. Il terreno è stato concesso con un permesso di dieci anni dal Comune ad un gruppo di sperimentatori che avevano vinto il concorso per la rigenerazione dell’area. Il sito era stato precedentemente utilizzato per usi industriali ed è oggi un esempio di sviluppo urbano sostenibile in Europa. Infatti, il terreno fortemente inquinato ospita oggi case-barca dislocate in una foresta di piante di bambù che purificano il suolo. Le barche sono state riutilizzate come abitazioni, uffici e laboratori e presto ospiteranno anche una sala da thè ed un bed&breakfast.Un’altra esprienza di auto-determinazione di una comunità è stata esplorata ad una scala di quartiere nel caso della Cooperativa Afrikaanderweik nel quartiere multi-etnico nell’omonimo quartiere nel sud di Rotterdam. La cooperativa è un’organizzazione che assolve la funzione di ombrello per collegare gli spazi di lavoro con negozianti, artigiani, associazioni e operatori del mercato di zona. Gli attori della zona hanno così potuto sviluppare una serie di servizi locali come una cooperativa energetica che crea un grande risparmio per le aziende locali come anche piccole imprese sociali di pulizia, catering o consegne a domicilio che operano nel quartiere includendo la popolazione locale.
Quale morale in queste storie?
Le storie che abbiamo raccontato brevemente sono soltanto un piccolo campione di un caleidoscopio di iniziative che si stanno moltiplicando, nelle città metropolitane di tutte le nazioni europee. La recente crisi economica è stata un’occasione di risveglio per molte comunità. Nonostante il grande entusiasmo verso queste nuove pratiche di sviluppo urbano partecipativo e di piccola scala, questo nuovo approccio non è privo di problemi . Se da una parte le comunità locali hanno cominciato ad avere un ruolo sempre più importante nello sviluppo locale dei quartieri, creando importanti infrastrutture come spazi pubblici, mense sociali o spazi culturali, dall’altro la maggior parte di loro sono tuttora molto fragili e precarie.
Superare questa condizione di fragilità, senza dipendere da sovvenzioni pubbliche: è questa la sfida principale da affrontare per chi crede nelle potenzialità delle iniziative promosse da gruppi e associazioni di cittadini. Gli esempi del nord Europa ci confermano che la sfida si può vincere, anche lasciando all’amministrazione il solo compito di creare le condizioni minime perché le attività si svolgano in modo regolare. Se poi qualche amministratore virtuoso volesse favorire queste iniziative e integrarle all’interno dei processi inclusivi di trasformazione della città, basta che si preoccupi anche del valore d’uso che può derivare dal riutilizzo di edifici e aree dismesse, e non soltanto del loro valore di mercato.
Funding the Cooperative City – Finanziare la Città Cooperativa, è un progetto di Eutropian Planning&Research che mira ad esplorare, promuovere e assistere esperimenti di sviluppo urbano comunitario nelle città europee. Si terrà a Roma un workshop il 5-7 Maggio e a Rotterdam il 28 Maggio, dove saranno invitate le iniziative selezionate dalla open call e faranno inoltre parte della pubblicazione “Funding the Cooperative City”.

ETS, 2016, pp. 15-21. 4 maggio 2016
La figura di Antonio Cederna, del quale si celebra quest’anno il ventennale della scomparsa, assume sempre più la statura di un grande protagonista della cultura e della vita civile dell’Italia del Novecento. Inoltre il progressivo abbandono delle politiche di tutela del patrimonio e dell’ambiente, derivante tanto dal declino economico strutturale che affligge l’Italia quanto dall’impostazione ferocemente e ottusamente neoliberista dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni alla guida del paese, a sentire in modo pungente l’assenza di una voce rigorosa e robustamente indignata come quella del grande giornalista milanese.
Negli anni recenti ci sono stati diversi buoni tentativi di ricostruire il profilo biografico e quello politico e intellettuale di Cederna, tra cui vale certamente la pena di ricordare il piccolo volume di Francesco Erbani uscito nel 2012, ’ampio e prezioso volume collettivo curato nel 2007 da Maria Pia Guermandi e Valeria Cicala dal bel titolo Un italiano scomodo. Attualità e necessità di Antonio Cederna e le numerose testimonianze sparse tra le opere di Vezio De Lucia, il sito di Edoardo Salzano e altri luoghi ancora. Ancor più importante è stato il lavoro svolto attorno all’archivio personale di Cederna dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma con la collaborazione dell’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Ambientali della Regione Emilia Romagna, che ha permesso non solo il riordino, l’inventariazione e la messa a disposizione del ricco patrimonio di carte personali del giornalista ma anche l’approntamento di un sito web ricco e ben organizzato.
Ciò che colpisce, tuttavia, è che l’eredità cederniana viene oggi studiata e rivendicata soprattutto riguardo ai temi dell’urbanistica, dei beni culturali e in parte del paesaggio, lasciando piuttosto in ombra il suo fondamentale contributo nel campo della tutela ambientale. Così il Cederna celebrato e ripubblicato resta ancora e sempre quello di Mussolini urbanista, di Storia moderna dell’Appia Antica, di I vandali in casa e se un ministero e la fondazione intitolata al suo nome approntano un’antologia di suoi scritti essa riguarda appunto “beni culturali, urbanistica e paesaggio”. Tra le poche eccezioni recenti stanno la bella relazione di Rita Paris e Bartolomeo Mazzotta a un convegno svoltosi nel 2013 a Santa Maria Capua Vetere dal titolo “L’archivio Cederna come fonte di studio per la tutela dell’ambiente”, scaricabile ora dal sito in forma digitale e arricchita da uno straordinario apparato iconografico, e il breve ma serrato profilo biografico contenuto nei Pionieri della protezione della natura in Italia di Franco Pedrotti
Può ben darsi che questo rimanere sullo sfondo del Cederna ambientalista dipenda dal fatto che gran parte delle persone che gli sono state maggiormente legate sono attive soprattutto nei campi dell’urbanistica, dei beni culturali e del paesaggio, nei quali è sempre molto vivace l’attività pubblicistica ed editoriale nello spirito della denuncia e della proposta cederniana, mentre questo tipo di intervento si è un po’ offuscato negli anni più recenti sul versante della protezione della natura. Il ricordo personale e le carte ci dicono però che l’interesse di Cederna per l’ambiente e il suo contributo alla battaglia ambientalista non sono stati né episodici né estemporanei né tantomeno ininfluenti. Essi sono stati al contrario il frutto di una conquista lenta e tenace, ottenuta - come nel suo stile - ediante un ammirevole sforzo di documentazione e di riflessione.
A dispetto della sua identità di giornalista, peraltro autore soprattutto di articoli incisivamente brevi, tanto le testimonianze di parenti, amici e collaboratori quanto le carte rimandano l’immagine di un uomo che è rimasto per tutta la vita uno studioso, per quanto sin da subito la vocazione civile ha finito col prevalere in lui su quella alla ricerca. La parabola del Cederna scrittore inizia non a caso con un’ampia relazione di scavo negli “Atti dell’Accademia nazionale dei Lincei” e termina con una severa polemica contro una deriva giornalistica che predilige il colore e la sensazione rispetto all’indagine accurata e al ragionamento approfondito. E se in molti rivendicano oggi a Cederna, come ricorda non a caso Edoardo Salzano, la qualifica di urbanista tout court le sue competenze e il suo livello di elaborazione in campo ambientale non furono da meno.
A testimonianza di ciò sta anzitutto il modo in cui Cederna si avvicinò alla protezione della natura. La quasi totalità dei suoi articoli degli anni Cinquanta, pubblicati invariabilmente su “Il mondo”, riguardano i beni culturali, l’urbanistica e - in qualche misura - il paesaggio. La questione ambientale comincia timidamente ad apparire soltanto nel 1960, cioè dopo quasi dodici anni di attività giornalistica, sotto la veste ancora tutta urbana del “verde”, come ancora in gran parte urbano è il taglio del primo convegno di Italia Nostra sull’argomento, del dicembre dello stesso anno e del quale Cederna riferisce puntualmente sul settimanale. L’imprinting del ricercatore si manifesta però molto presto: mentre l’associazione si muove con disagio e piuttosto timidamente sul “nuovo” terreno della protezione della natura, Cederna capisce subito che lì c’è un ampio terreno di impegno civile, di nuovi diritti e insomma di questioni politiche che travalica una impostazione limitata alla dimensione del verde urbano o del semplice paesaggio. Come mostra la sua corrispondenza privata degli inizi del 1962, oltre a documentarsi sulle attività del National Trust inglese egli si è procurata quella che all’epoca è una delle bibbie del protezionismo internazionale, cioè il volume Derniers refuges. Atlas commenté des Réserves Naturelles dans le monde pubblicato nel 1956 dall’Union internationale pour la conservation de la nature, l’Uicn, ma non bastando certamente questo tutto questo si rivolge con estrema umiltà a uno dei pochissimi grandi esperti italiani del settore: il direttore del Parco nazionale del Gran Paradiso, Renzo Videsott. Nella lettera che Cederna gli indirizza il 12 febbraio 1964 due cose colpiscono.
La prima è appunto l’umiltà, la fattiva serietà:
«Occorre che io mi istruisca sulla storia della protezione della natura nel mondo, metodi, istituti, mezzi, esempi stranieri, eccetera. Questo volevo chiederLe: Lei può consigliarmi in proposito, magari indicandomi una prima bibliografia sommaria e orientativa?»
La seconda è un brevissimo accenno che però anticipa una visione e una posizione che Cederna terrà fino alla fine:
«In Italia, come Lei ben sa, bisogna battersi accanitamente per la difesa della natura in tutti i suoi aspetti. Ma per fare questo occorre liberare la gente dall’imparaticcio della filosofia idealista che ha insegnato che la natura e il bello di natura non esiste, che è cosa soggettiva.»
Qui Cederna mostra anzitutto di aver compreso che la difesa della natura ha molti aspetti, alcuni dei quali sicuramente già conosce mentre altri gli sfuggono ancora, anche se non sono meno importanti. Qui credo che stia uno degli elementi che rende più gravosa l’“assenza” di Cederna e meno raccolta la sua eredità: il fatto cioè che Cederna era pervenuto a “vedere insieme”, in modo saldamente unitario, beni culturali, questione urbana e territoriale, paesaggio e protezione della natura nelle sue varie accezioni. Uno sguardo olistico che - mi pare di vedere - non ha avuto finora in Italia eredi alla sua altezza. In secondo luogo Cederna sembra comprendere sin da ora, anche se in modo ancora embrionale, che la questione della protezione della natura, del paesaggio e del territorio non si può definire soltanto o prioritariamente in termini di valori morali o estetici, con tutto il carico di preferenze squisitamente soggettive che uno sguardo di questo tipo comporta. Cederna sembra comprendere al contrario che proprio dal protezionismo viene la richiesta di fondamenta ulteriori e più salde per la battaglia in difesa di beni universali, sia che si tratti di beni patrimoniali sia che si tratti di beni ambientali: fondamenta che stanno anzitutto nel sapere tecnico-scientifico e nel riconoscimento dell’utilità collettiva di un modello di sviluppo moderno ma razionale. In questo Cederna si ritrova sintonia sia col “vecchio” protezionismo italiano rappresentato da Videsott e da Alessandro Ghigi sia coi giovani del “gruppo verde” di Italia Nostra che hanno iniziato a operare da pochi mesi in seno all’associazione: Arturo sio, i fratelli Carlo Alberto e Pier Dionigi Pinelli, Paola Onelli e il più maturo Bonaldo Stringher jr.
Nel corso degli anni Cederna affinerà progressivamente questa visione sia convertendo una parte cospicua della propria attività pubblicistica a questioni di protezione della natura e in particolare alla questione delle aree protette, sia ribadendo la necessità di un approccio nutrito, si, di una salda passione morale e civile e di una imprescindibile sensibilità estetica ma anche e soprattutto di solide valutazioni tecnico-scientifiche e di obiettivi chiari.
Ciò fa in modo che quando, verso la fine degli anni Sessanta, la questione dell’ecologia intesa ormai in senso planetario viene all’ordine del giorno anche in Italia Cederna può ritrovarsi in in pieno all’interno del piccolo drappello di giornalisti che si sforzano di illustrarla all’opinione pubblica e di approfondirla, accanto in particolare ad Alfredo Todisco e Giorgio Nebbia. Proprio con Nebbia, ad esempio, con Vi rginio Bettini e con una giovane GraziaFrancescato Cederna è a Stoccolma per raccontare il vertice globale sull’ambiente del giugno 1972 mentre assieme a Todisco coordina e anima l’anno successivo un convegno organizzato dal suo giornale, il “Corriere della Sera”, volto all’elaborazione di “80 proposte per salvare l’ambiente” che vede la partecipazione tra gli altri di Aurelio Peccei, Leonardo Benevolo, Giorgio Ruffolo, Alberto Predieri, Franco Tassi e Giuseppe Montalenti.
Ma Cederna ha modo di ribadire più volte nel corso degli anni, in pratica fino alla fine, il suo approccio olistico, anti-aristocratico e anti-idealista alle questioni del patrimonio, del territorio e dell’ambiente abbozzato nella lettera del 1962 a Renzo Videsott, in questo mostrando di essere un autentico erede della tradizione lombarda che discende da Carlo Cattaneo. Lo farà infatti ancora nel 1975 nell’ampio saggio che introduce il fortunato volume einaudiano La distruzione della natura in Italia nel quale mette sotto accusa - in modo persino ingeneroso - la legge sulla bellezze naturali del 1939 a causa del suo impianto essenzialmente visuale e lo farà nuovamente nel settembre 1991 in un articolo per “la repubblica” nel quale appoggerà l’integrazione dell’articolo 9 della Costituzione con un riferimento alla natura.
In ogni caso il Cederna ambientalista, in ciò effettivamente coerente con le sue origini di fondatore e animatore di “Italia Nostra”, i spenderà soprattutto per la difesa dei parchi naturali esistenti e per la creazione di nuovi lasciando così un poco più sullo sfondo le grandi questioni sollevate, ad esempio, dal Club di Roma. E l’impegno per l’istituzione della riserva di Migliarino-San Rossore - una delle campagne più antiche e vivaci del movimento protezionista italiano del dopoguerra - è solo uno dei tanti terreni su cui Cederna si cimenta a partire dal 1962-63. Una ricognizione complessiva di questo suo impegno per le aree protette è tutta da effettuare ma è possibile qui ricordare almeno come il legame personale con Renzo Videsott prima e con Franco Tassi poi lo renderà per anni testimone diretto e costante delle vicende dei primi due parchi nazionali italiani e come l’iter e l’approvazione della legge quadro del 1991 sarà una delle iniziative parlamentari che lo impegnerà di più nel suo mandato a Montecitorio.
 Come si incentiva l'accoglienza turistica? In deroga ai piani, ovviamente. Così prevede una legge della Basilicata che consentirà a chiunque di aprire un albergo in centro storico, con e senza opere.
Come si incentiva l'accoglienza turistica? In deroga ai piani, ovviamente. Così prevede una legge della Basilicata che consentirà a chiunque di aprire un albergo in centro storico, con e senza opere. La Gazzetta del Mezzogiorno
, 24 aprile 2016 (m.b.)Nessun vincolo. Si può mutare la destinazione d’uso di qualsiasi immobile legittimamente edificato. Che sia connesso o meno a alla realizzazione di opere edilizie, qualunque edificio del centro storico può essere trasformato in una struttura turistico-alberghiera. Lo stabilisce una legge della Regione. Spinto ai suoi limiti più estremi, è piuttosto il trionfo della deregulation. In inglese si dice così e da noi si ripete pari pari, forse anche per non farsi capire da tutti. Del resto, la traduzione in italiano non è il massimo. Si parla di deregolazione, oppure di deregolamentazione per indicare un processo vasto. Comporta l’allentamento dei controlli e delle restrizioni in economia come in urbanistica, con l’obiettivo di incoraggiare l’iniziativa, specialmente quella privata, confidando in una sorta di autoregolamentazione interna al sistema che promuove queste pratiche. Il dibattito, in realtà, va avanti da decenni ormai, perché spesso i mercati liberi da controlli hanno finito per rendere subalterno lo stato di diritto al mercato. Poche regole, significa anche far west. Con tanti saluti alla ricchezza del Bel Paese, faro di civiltà e attrattore da secoli dei visitatori del mondo intero, per ragioni storiche ben precise.
Basterebbe citare la prescrizione del poliedrico genio del Rinascimento italiano dal quale tutta la cultura urbanistica occidentale ha tratto nutrimento. Si trova nel De re aedificatoria, opera alla quale Leon Battista Alberti lavorò fino alla morte, nel 1472. Un trattato in cui, già nel Prologo, si sottolinea decisamente il legame tra attività progettuali, costruttive e convivenza civile: "a riunire e mantenere insieme gli esseri umani". Da allora, la ricerca di una finalità sociale e di un giustificazione morale è entrata nel centro dello statuto e della riflessione urbanistica in tutto il mondo.
Quanto però si coniuga a questa esigenza di convivenza civile la legge regionale n. 5 del 4 marzo 2016 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2016, non è chiaro. Anzi, è possibile mutare giudizio leggendo attentamente i tre comma dell’articolo 39 della legge. Si occupa di «Norme in funzione di Matera Capitale della cultura 2019. Riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente per stimolare l'accoglienza turistica». Ecco, nel dettaglio cosa dice: «1. La Regione, a seguito della designazione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, al fine di stimolare l'accoglienza turistica promuove iniziative di riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente. 2. Per le finalità di cui al comma precedente, nei centri storici dei comuni del territorio regionale, è consentito il mutamento di destinazione d'uso di immobili legittimamente edificati, connesso o meno alla realizzazione di opere edilizie, da residenziale, direzionale o commerciale a turistico- alberghiera. 3. I comuni di cui al comma 2, entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge possono, con motivata deliberazione, individuare gli immobili per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione»
Bisogna incrociare le dita e confidare sull’espressione «motivata deliberazione». Gli appetiti, indotti da una falsa rappresentazione della città, purtroppo non mancano. Trascorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, quindi, sul patrimonio edilizio esistente nel centro storico si potrà realizzare qualsiasi cosa per l'accoglienza turistica, e non solo a Matera, città patrimonio mondiale dell’Unesco. Ecco perché gli anglofili parlano di deregulation, mentre gli italiani - una minoranza sempre più esigua in verità - continuano a dire, senza esagerare, che spesso dietro quel termine si nascondono barbarie contro la storia e la civiltà. A giusta ragione.
Il Fatto Quotidiano online, 23 aprile 2016 (p.d.)
Cambiare tutto per non cambiare niente. Il nuovo Codice appalti è stato presentato dallo stesso premier Matteo Renzi durante la conferenza stampa del 15 aprile come una riforma "che chiude le strade alla corruzione". L’asso nella manica del capo governo doveva essere, anche questa volta, l’Autorità nazionale anticorruzione di Raffaele Cantone. Ma l’Anac, nella battaglia per garantire la trasparenza negli affidamenti di lavori pubblici, avrà le armi spuntate: i suoi esperti vigileranno solo su una piccola parte degli appalti, appena il 5%, come fa notare Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. Una nuova falla nella legge, dunque, dopo quelle segnalate nei giorni scorsi dai sindacati: nel testo definitivo sono saltate le norme sulla tutela del posto di lavoro nel cambio di impresa appaltatrice e sulla trasparenza nelle gare.
A questo quadro si aggiunge la sostanziale sopravvivenza delle gare al massimo ribasso, che negli annunci del governo dovevano andare in soffitta con il nuovo codice. "Basta gare al massimo ribasso", aveva dichiarato il ministro dei Trasporti Graziano Delrio il 3 marzo dopo il Consiglio dei ministri che aveva approvato il testo in via preliminare. Eppure, l’articolo 95 delinea uno scenario diverso. Il testo prevede che si possa ancora usare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo fino a un milione di euro, ancora una la volta la maggioranza dei casi: circa 8 su 10.
Ma la vera norma-beffa relativa ai poteri dell’Anac si trova all’articolo 77 della nuova legge. Nelle procedure di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione sulla proposta migliore è affidata a una commissione giudicatrice composta da esperti del settore. Per garantire la massima trasparenza in questo processo, i commissari saranno estratti a sorte da un apposito elenco preparato dall’Anac. Ma questa regola vale solo per le gare con importi che superano le soglie comunitarie, vale a dire i 5,2 milioni di euro. Se non si supera questa cifra, o se gli appalti "non presentano particolare complessità", liberi tutti: "La stazione appaltante può nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione". Insomma, i commissari saranno scelti dallo stesso ente che assegna l’appalto. Tutto in famiglia. Risultato: il 95 per cento degli appalti verrà assegnato esattamente come prima.
Non a caso, lo stesso Raffaele Cantone in audizione in parlamento aveva avvertito sui rischi insiti nella norma: "Tale previsione sembra non essere del tutto rispettosa del criterio di delega che, nell’obiettivo della garanzia della massima trasparenza nelle nomine dei commissari non distingue, per la nomina dei commissari, tra appalti di valore superiore ed inferiore alle soglie. Inoltre il riferimento troppo generico agli appalti di "non particolare complessità" sembra consentire una ulteriore troppo ampia possibilità di derogare al principio".
E i problemi sorgono non solo in fase di affidamento dell’appalto, ma soprattutto nella gestione esecutiva dei lavori. "La corruzione e le infiltrazioni mafiose si annidano non tanto nell’affidamento degli appalti, ma nella gestione esecutiva del contratto – spiega a ilfattoquotidiano.it Ivan Cicconi, direttore di Itaca, Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale – E in questo senso il codice lascia scoperto questo buco enorme". Ma Cicconi sottolinea anche un ulteriore aspetto delicato del nuovo testo legislativo. "Il buco di questo codice è che attribuisce un ruolo straordinario all’Anac, ma non c’è una riga su durata, composizione, modalità di nomina dell’autorità. Oggi il presidente è Raffaele Cantone, una persona per bene, ma se domani cambia il governo, il nuovo presidente del Consiglio potrà nominare un nuovo presidente senza alcun vincolo. Domani potrebbe essere nominato un delinquente alla guida dell’Anac".

In seguito al terremoto del 1980, a Napoli si attua un imponente programma di edilizia residenziale pubblica basato sul recupero dei centri storici. Una vicenda straordinaria, assai sottovalutata, che merita di essere raccontata.(m.b)
Il programma straordinario di edilizia residenziale di Napoli, approvato in seguito al terremoto del 1980, è il più importante intervento di edilizia residenziale pubblica realizzato in Italia attraverso il recupero dei centri storici.
Qui di seguito forniamo una breve cronologia e rendiamo disponibile una selezione di scritti dei protagonisti di allora, che consente di apprezzare ipresupposti, i contenuti e i risultati raggiunti.
A questa vicenda straordinaria abbiamo dedicato un'iniziativa nell'ambito di
Una città un piano. il 6 e 7 aprile 2016.
 |
Le aree interessate dal piano delle periferie, approvato nel 1980, con evidenziati i luoghi visitati durante l’iniziativa Una città un piano.
|
Una breve cronologia
16 aprile 1980. Il consiglio comunale di Napoli, approva all’unanimità il Piano per il recupero delle periferie. Il piano individua:
- le zone di recupero e delle aree da assoggettare a piano di recupero, ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge 457/1978;
- le aree particolarmente degradate da sottoporre a piani di edilizia pubblica (Pdz), ai sensi della legge 167/1962.
Il piano riguarda dieci nuclei antichi (ex casali agricoli) inglobati all’interno del comune di Napoli.
23 novembre 1980. Il terremoto dell’Irpinia causa danni ingenti anche al patrimonio edilizio della città di Napoli: più di 10.000 edifici danneggiati, oltre 6.000 dei quali inagibili, e ben 112.000 persone sgomberate dalle proprie abitazioni.
19 maggio 1981. Il Parlamento approva la legge n. 219, con la quale si approva un Programma straordinario di edilizia residenziale (Pser), per la costruzione di alloggi destinati ai cittadini dell’area metropolitana di Napoli e delle necessarie opere di urbanizzazione. Il sindaco di Napoli, Maurizio Valenzi, è nominato commissario straordinario del governo per l’attuazione del programma.
28 maggio 1981. L’ordinanza commissariale n. 1 vincola le aree interne al comune di Napoli per la realizzazione di 13.578 alloggi e delle urbanizzazioni primarie e secondarie. Si prevede che 8.600 alloggi, dei quali oltre 3.000 ricavati dal recupero di abitazioni esistenti, siano realizzati attraverso l’attuazione del piano per il recupero delle periferie. Oltre agli alloggi e agli esercizi commerciali e artigianali, il piano prevede la realizzazione di scuole, attrezzature collettive, impianti sportivi, e oltre 400 ettari di verde pubblico, per colmare il fabbisogno arretrato. In parole semplici, l’intervento straordinario del Pser accelera l’attuazione del Piano per il recupero delle periferie, approvato per via ordinaria dal consiglio comunale.
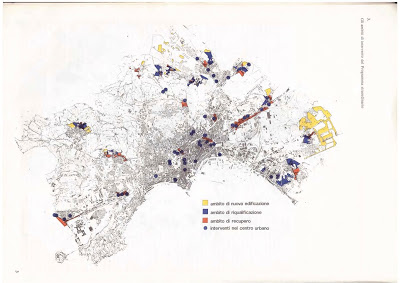 |
| Gli ambiti di intervento del programma straordinario approvato nel 1981 |
Scritti essenziali
VezioDe Lucia,
L’esperienza Napoli, inFilippo Ciccone (a cura di),
Recupero eriqualificazione urbana nel programma straordinario per Napoli; Giuffrèeditore, Milano, 1984.
Altri documenti interessanti, comprese fotografie e video dell’epoca, sono consultabili nelle pagine web di UrbaNa, curate dal Comune di Napoli.

«
Jane Jacobs. L’unica città funzionante è a misura di chi la abita. Contraria ai metodi di pianificazione, un ritratto dell’attivista e teorica critica dell’urbanistica moderna. Il suo saggio del 1961 ha segnato un punto di svolta per la sociologia urbana divenendo un punto di riferimento per accademici e non». Il manifesto,
21aprile 2016 (c.m.c.)
Chiamato ad aprire il recente European Regional Meeting sugli habitat urbani Jan Gehl, probabilmente l’urbanista e designer di spazi pubblici più importante e rispettato oggi al mondo (o almeno in Europa) ha dedicato quasi interamente il suo intervento a Jane Jacobs. Nel successivo incontro tematico sugli spazi pubblici di Barcellona, il 4 e 5 aprile scorsi, sono stati pochi i relatori che non hanno fatto esplicita menzione del suo nome, o almeno implicito riferimento al suo pensiero.
In entrambi questi appuntamenti, promossi sotto l’egida dell’Onu in preparazione della conferenza Habitat III per scrivere la «Nuova Agenda Urbana» e, nelle intenzioni, le linee guida dello sviluppo futuro delle città del mondo, è sembrato finalmente che a cento anni esatti della sua nascita la sua figura e il suo pensiero, dopo aver conquistato accademici, attivisti e addetti ai lavori, stiano finalmente raggiungendo anche il campo dei «decisori».
Parliamo di Jane Jacobs, nata Jane Butzner a Scranton, Pennsylvania, il 4 maggio del 1916 e vissuta principalmente fra il Greenwich Village di New York – nell’amata casa al 555 di Hudson Street – e Toronto, in Canada, di cui fece la sua seconda patria. Priva di uno status ufficiale nel mondo accademico, consegnò i suoi interventi critici intorno ad architettura e urbanistica all’autorevole Architectural Forum. Il suo acuto spirito di osservazione e il suo approccio inedito, basato sull’osservazione diretta della vita urbana e del comportamento dei cittadini vincolato alla fisicità degli spazi, la resero presto un’interlocutrice obbligata in tutti i luoghi in cui si discuteva – e se ne discuteva parecchio, nell’America degli anni ‘50 – di ripristino, rinnovo, o «miglioramento» urbano.
Vite insorgenti
Mentre veniva accusata di mancare di basi teoriche («rimedi domestici» aveva definito le sue proposte Lewis Mumford, che pure la stimava, in un celebre articolo sul «New Yorker»), Jane Jacobs non credeva invece nella pretesa scientificità dell’urbanistica moderna, che guardava alla stregua di una serie di «formule magiche» di natura ideologica, dagli esiti non prevedibili quando non notoriamente nefasti. Eppure, oltre che autrice, Jane Jacobs fu anche attivista, lottando dalla parte dei deboli insieme a tutte le comunità urbane con cui entrò in contatto – prima nella sua New York e poi in Canada, dove si trasferì nel 1968 come atto polemico contro la guerra del Vietnam, ma anche subito dopo aver subito un arresto per «incitamento alla sommossa» durante le proteste contro la costruzione di un’autostrada che avrebbe tagliato in due la Lower Manhattan.
Fu un’epica battaglia, di cui non fu l’unica ma certamente la più celebre protagonista, che la vide contrapporsi a Robert Moses, il più influente e potente pianificatore di New York, pari per autorevolezza, e anche per la radicale durezza delle sue soluzioni, a quel Barone Haussmann – cui lui stesso si paragonava – che aveva aperto i boulevard nella Parigi di Napoleone III, spianando interi quartieri della città vecchia considerati malsani, irrazionali e pericolosi. Con lo stesso piglio Moses voleva aprire grandi strade veloci nel cuore di New York, tagliando e spianando aree storiche come appunto una parte del Greenwich Village in cui però, per sua sfortuna, risiedeva Jane Jacobs. Il progetto di Moses procedeva dunque a gonfie vele, finché non si imbatté nell’opposizione di un gruppo di cittadini, e soprattutto cittadine, costituiti nel «Joint Committe to Stop the Lower Manhattan Expressway»: «Non c’è nessuno, nessuno contrario al progetto, tranne un gruppo di mamme», avrebbe gridato in occasione di un incontro uno stupito quanto contrariato Moses proprio all’indirizzo di Jacobs.
È storia che alla fine la battaglia fu vinta dalle «mamme» e che l’autostrada urbana non si fece, anche grazie a un piano sperimentale, promosso proprio da Jacobs, che andava nella direzione opposta e proponeva di chiudere completamente al traffico delle auto l’area del quartiere attorno al Washington Square Park. Il libro cardine di Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, uscito negli Stati Uniti nel 1961 e relativamente presto tradotto anche in italiano grazie a Einaudi (Vita e morte delle grandi città, 1969) è considerato da alcuni come il singolo libro più importante nella storia della pianificazione urbana, e l’affermazione non è lontana dall’essere vera.
Liberazioni urbane
Esplicitamente polemico: «questo libro è un attacco contro gli attuali metodi di pianificazione e di ristrutturazione urbanistica» recita l’incipit, e primo fra i suoi diretti obiettivi era l’urbanesimo modernista della «Città Radiosa» di Le Corbusier, che aveva proposto una forma urbana, poi diventata canonica, concepita in funzione di una vita isolata (le celebri «unità di abitazione», che non mascheravano troppo il loro intento disciplinare) e dominata dagli spostamenti in auto. Allo stesso modo Jacobs non risparmiava critiche all’idea di «Città Giardino» propugnata da Ebenezer Howard che, apparsa anch’essa come un’utopia possibile per il risanamento materiale e morale delle città, aveva contribuito nella pratica a promuovere la forma dispersa e inefficiente dei moderni suburbi.
Accomunava queste visioni, secondo la lettura di Jacobs, l’idea di separare, insieme con le funzioni degli edifici (con quartieri per negozi, per case, per uffici) e dei collegamenti (strade per le auto, per i mezzi pubblici, per i pochi pedoni rimasti) anche i cittadini, con la falsa pretesa di liberarli, perché la liberazione era intesa solo come liberazione dai loro bisogni. La presenza di grandi aree verdi – che pure accomunava i due disegni di Le Corbusier e di Howard – non poteva essere – e si rivelò non essere – una soluzione al «problema urbano», perché il tipo di problema che la città rappresentava era del tutto particolare.
La città – dice Jane Jacobs – è una complessità auto-organizzata che procede per tentativi ed errori: toglierle con una pianificazione «ideologica» la possibilità di rigenerarsi attraverso scambi e combinazioni anche casuali significava ucciderne la vitalità e minarne il successo. La città funzionante è dunque un intensificatore di vita ed è piuttosto questo tipo di liberazione, tendente verso un incremento delle possibilità per chi le abita, che i pianificatori dovrebbero perseguire; uno dei suoi grandi lasciti da rimeditare oggi, in presenza di un’intensificazione dei fenomeni di urbanizzazione senza precedenti.
Impegno diretto
Certo il suo lavoro non è stato e non è esente da critiche. A partire da quelle originarie sulla debolezza dei suoi presupposti teorici fino ad altre più recenti che le rimproverano una certa fede aprioristica nelle capacità taumaturgiche del mercato. In effetti Jane Jacobs non mise mai in questione le strutture sociali e il predominio dell’economia (dopo The Death and Life of Great American Cities molti dei suoi successivi studi furono dedicati a questioni economiche, e lei stessa riteneva di aver dato in questo campo i suoi migliori contributi), ma valga come attenuante che il suo interesse fu sempre per il piccolo mondo della vita di quartiere, per le botteghe artigiane e un tipo di vita urbana che stimolasse la creatività.
La si è anche accusata di «depoliticizzare» i cittadini, attraverso un’idea di auto-organizzazione che rischiava di apparire meccanicistico-organicista. Ma chi le ha mosso tale critica, come sottolinea bene Carlo Olmo nell’introduzione all’edizione italiana di The Death and Life, lo fa muovendo da una concezione politica che si risolve nel modello della democrazia liberale di tipo rappresentativo. Ben diversa dall’idea – e dalla pratica – di impegno diretto promossa da Jacobs, che mostra di aver retto alla prova del tempo.
Wade Graham, quando affronta la sua figura nel recente Dream Cities, Seven Urban IdeasthatShaped the World (Harper) lo fa in un capitolo intitolato «Corals»: coralli, come le strutture che crescono e si sviluppano per azione collettiva in una forma cangiante e senza direzione. La sua critica riguarda la possibilità di creare nuove zone urbane – nuove edificazioni – che riprendano la varietà di forme e di funzioni delle città del passato senza cadere nell’artificialità. In effetti però Jacobs non sembra parlare mai di urbanizzazioni nuove, ma sempre del miglioramento o del mantenimento di quelle esistenti, e dunque la critica è da indirizzare non tanto a lei, quanto a una parte del movimento del «New Urbanism» che anche dalle sue idee prese ispirazione.
L’urbanistica per Jane Jacobs non opera mai nel vuoto, e se dovessimo applicare il suo metodo all’espansione futura delle megalopoli dovremmo invece guardare a quella fascia di slums e insediamenti informali che le caratterizza come vita sorgente – verrebbe da dire: come potere costituente – con la sua dignità e le sue formazioni sociali spesso inedite, la cui energia e i cui equilibri sono l’energia e gli equilibri della città stessa,e non una sorta di tumore da debellare tramite l’uso ideologico della ruspa. Ma se queste sono lezioni utili per urbanisti, per politici e studiosi di fatti urbani, cosa possiamo imparare invece tutti e tutte da Jane Jacobs? Per esempio a guardare le città con i nostri stessi occhi, ad altezza d’uomo – e più ancora di donna – e a valutare con il nostro buon senso, perché non sempre i professori hanno ragione.
*
RICORRENZE. Il mondo festeggia i cento anni di Jacobs con iniziative da New York a Roma
Per i cento anni di Jane Jacobs sono tante le iniziative in giro per il mondo pensate per ricordare il suo pensiero e la sua azione. Conformemente, si tratta per lo più di iniziative a carattere partecipativo e aperto. Il «Center for The Living City», fondato nel 2005 a New York per promuovere e continuare il suo lavoro ha lanciato «Gifts to Jane», una raccolta di contributi delle comunità alla vita delle città. L’iniziativa è legata all’Urban Acupunture Network, rete per l’agopuntura urbana: come nell’agopuntura bastano infatti piccolissimi interventi per migliorare la vita di un vicinato, di una strada o un quartiere (www.janes100th.org).
Sempre a New York La Municipal Arts Society si è mobilitata con «Celebrating the City: Jane Jacobs at 100». Il tutto ruota attorno a un sito: www.jj100.org, un aggregatore in cui è possibile inserire o ricercare gli eventi. La stessa Municipal Arts Society è anche partner della «Jane Jacobs Medal» assegnata annualmente dalla Fondazione Rockfeller (che finanziò la ricerca alla base di The Death and Life of Great American Cities) a studiosi, attivisti o politici che hanno introdotto nuove visioni o strategie urbane. Per la prima volta nel 2016 le candidature saranno aperte anche al di fuori dagli USA.
In Canada, patria di adozione della Jacobs, il contenitore si chiama «Jane100» (www.janejacobs100.ca) e fra le proposte spicca il New Urbanism Film Fest di Toronto, ma anche qui la formula – non potrebbe essere altrimenti – è aperta a nuovi contributi. In Europa la Facoltà di Architettura dell’Università di Delft organizza una più tradizionale conferenza dal titolo Jane Jacobs 100: her legacy and relevance in the 21st Century, che si svolgerà fra Delft e Rotterdam il 24 e 25 maggio. In Italia da un anno sono approdate anche a Roma le Jane’s Walk: passeggiate guidate alla scoperta della città, degli angoli dimenticati e delle storie dei quartieri. L’appuntamento è per il 7 e 8 maggio (http://janeswalk.org)
|
Detect languageAfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHausaHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanLaoLatinLatvianLithuanianMacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSerbianSesothoSinhalaSlovakSlovenianSomaliSpanishSundaneseSwahiliSwedishTajikTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshYiddishYorubaZulu |
|
AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHausaHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanLaoLatinLatvianLithuanianMacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSerbianSesothoSinhalaSlovakSlovenianSomaliSpanishSundaneseSwahiliSwedishTajikTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshYiddishYorubaZulu |
|
|
|
|
|
|
|
Text-to-speech function is limited to 100 characters

Via libera al nuovo Codice Appalti per contrastarecorruzione, deroghe e scorciatoie e promuovere qualità dei progetti e degliinvestimenti utili. Dopo un anno diintenso lavoro del Parlamento e del Governo è arrivato dunque il nuovo Codicedegli appalti e servizi pubblici, pubblicato il 19 aprile 2016 in GazzettaUfficiale con il Decreto
Legislativo n. 50, che recepisce anche tre nuove direttive europee (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE). L’obiettivo dichiarato è di chiudere un ciclo di 15 anni nato con la Legge Obiettivo, poi proseguito con il codice De Lise e le continue modifiche peggiorative approvate negli anni al codice appalti del 2006.
Il dibattito ed il testo che ne è scaturito risentono delle inchieste della magistratura che periodicamente hanno scoperchiato tangenti, mafia, deformazione dei progetti, costi lievitati delle opere, evasione della concorrenza e scarsa trasparenza del mercato, praticamente in tutti i settori di appalti, servizi e forniture, al nord come al centro ed al sud del Paese.
Si legge nel Decreto la voglia di voltare pagina con la decisone di affidare all’Autorità Anticorruzione (ANAC) ed al suo presidente Raffaele Cantone, ampi poteri di regolazione, controllo e vigilanza su imprese, bandi di gara, appalti, concessioni, servizi e forniture: è questa la prima novità positiva del nuovo Codice, dove ANAC diventa il perno del nuovo sistema di affidamento della spesa pubblica. Potrà determinare una lunga lista di strumenti operativi per stazioni appaltanti ed operatori economici, avrà la gestione di tutte le banche dati pubbliche del settore, sarà chiamata a verificare la congrui
tà delle varianti delle opere pubbliche per evitare abusi e distorsioni.
Va in soffitta l’appalto integrato che aveva appiattito la progettazione sulla esecuzione dei lavori, creando pesanti deformazioni e commistioni di interessi, mentre adesso si restituisce centralità ed indipendenza al progetto. Anche se il testo non convince gli operatori dato che non contiene una sezione specifica per i servizi di ingegneria e architettura, cosi come poche sono le novità sui concorsi di progettazione.
Previsti vincoli molto stretti per le stazioni appaltanti, a partire dai Comuni. Si punta a ridurre le stazioni appaltanti in modo centralizzato, secondo il sistema di qualificazione dell’ANAC, in modo da controllare bandi ed esiti delle gare per tutti i lavori sopra 150.000 euro e per servizi e forniture sopra 40.000 euro. Il subappalto è rimasto fissato al 30% massimo dei lavori, da utilizzare in modo più trasparente da parte delle imprese. Sul subappalto si è consumata una dura e vincente battaglia dei Sindacati e del Parlamento che hanno osteggiato la liberalizzazione del 100% dei lavori, prevista nella prima bozza di decreto legislativo.
Innovativo anche il Rating reputazionale gestito da ANAC, in cui sarà registrata la storia dell’impresa, in aggiunta al sistema di qualificazione, per avere un quadro esatto dei lavori effettuati, della loro qualità, dei comportamenti e della correttezza di una impresa. Potranno essere escluse da appalti e subappalti le imprese condannate in via definitiva per alcuni tipi di reati: partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, reati terroristici, , lavoro minorile. Si introduce anche una articolo specifico sui “conflitti d’interesse” per evitare le interferenze indecenti che abbiamo visto in molte inchieste, tra progettisti, imprese, pubblica amministrazione, commissioni di gara, collaudi. Suona un po teorico ma il principio è sacrosanto. I bandi potranno contenere criteri di premialità legati alla sostenibilità ed al ciclo di vita dei materiali, premiando il risparmio energico e di consumi idrici, il riciclo di materiali e di materie seconde, l’uso di prodotti e tecnologie a basso impatto.
Nella versione definitiva del decreto non hanno invece trovato posto le richieste avanzate dal Parlamento (e dal Consiglio di Stato) sulla necessità di aumentare trasparenza e concorrenza sui piccoli lavori, rendendo obbligatorie le gare precedute da un bando, per gli appalti sopra i 150mila euro. Infatti resta la possibilità di affidare gli appalti fino a un milione con una procedura negoziata cioè una trattativa privata senza bando, con la consultazione di dieci imprese. Questo è un autentico limite del nuovo Codice Appalti perché le stime ci dicono che stiamo parlando dell'80% del mercato, che quindi resterà opaco e sottratto alla concorrenza. Cose come restano esclusi dall’applicazione del nuovo Codice Appalti, i lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza nazionale, della difesa, i contratti segretati, che come abbiamo visto anche in odierne inchieste per corruzione e tangenti, si prestano alla più totale opacità.
Scatterà da subito la limitazione al massimo ribasso nei bandi, ma assegnare i contratti tenendo conto solo del prezzo sarà possibile solo per le opere sotto al milione, che comunque sono una fetta decisiva del mercato. Negli altri casi diventa obbligatoria l'offerta economicamente più vantaggiosa, cioè una valutazione che tiene conto del prezzo più gli aspetti tecnici, di gestione, del cantiere, di gestione del servizio. Il massimo ribasso è vietato da subito anche per i servizi di progettazione, quelli ad alta intensità di manodopera - con il costo del personale oltre il 50% - negli affidamenti di servizi nella ristorazione scolastica, assistenziale e ospedaliera.
Un’autentica novità con l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, è la cancellazione della Legge Obiettivo 443 del 2001, la legge di semplificazione di Berlusconi e Lunardi per le grandi opere strategiche, ormai era diventata una specie di mostro con oltre 390 interventi del costo complessivo di 375 miliardi (naturalmente non disponibili) e poi confluita nel Codice Appalti 163 del 2006. Le nuove regole cancellano il Piano delle Infrastrutture Strategiche (PIS), l’esclusione dei Comuni dalle decisioni, la VIA sul progetto preliminare, approvazione dei progetti al Cipe, l’appalto integrato sul progetto preliminare.
Resta in piedi invece anche nel nuovo Codice Appalti il contraente generale, pur meglio vigilato e regolato con strumenti pubblici a partire dalla scelta del Direttore di Lavori (prima era lasciato alla decisone dell’impresa), cosi come sono ancora previsti i Commissari straordinari per le grandi opere, che invece speravamo di veder scomparire in un regime ordinario ed efficiente.
Cancellando la Legge Obiettivo si torna ad un unico regime ordinario di regole per realizzare le opere, l’intero procedimento sarà in mano al Ministero per i Trasporti e le Infrastrutture e non al Cipe, si applica la VIA sul progetto definitivo (e non preliminare), l’appalto integrato viene cancellato. Vengono istituiti per tutte le opere tre livelli di progettazione: il progetto di fattibilità, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo. Quindi viene cancellato il progetto preliminare che è di fatto sostituito dal “progetto di fattibilità” che oltre a definire un primo livello di progettazione deve verificare se “sussistano le condizioni tecnico-economiche, ambientali e territoriali per realizzare un’infrastruttura, in pratica quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività”. Vedremo come saranno poi concretamente applicati questi ottimi principi e criteri nella realtà.
La programmazione delle infrastrutture viene demandata a due strumenti fondamentali: il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica che deve indicare le politiche, gli obiettivi e gli strumenti, che motivano la scelta delle opere, da aggiornare ogni tre anni. Il secondo strumento è il Documento Pluriennale di programmazione (DPP) che deve integrare tutti i programmi esistenti nelle opere pubbliche – RFI, ANAS, Porti, Aeroporti, reti urbane, Concessionarie Autostradali - con coerenza secondo i principi del DglS 228 del 2011 e mai applicato.
A questo strumenti si aggiunge la project review, per rivedere le opere non ancora avviate ma già decise con le procedure della legge obiettivo. Ricordiamo che le sul totale della lista delle opere della Legge obiettivo, ben 190 opere per un costo complessivo di 145 miliardi sono state approvate con progetto preliminare, progetto definitivo o con il quadro economico e finanziario. E sarà necessario intervenire per selezionare, ridimensionare e cancellare una buona parte di queste opere, si spera con lo strumento della project review.
Non solo, il Ministro Delrio con la presentazione dell’Allegato al DEF della “Strategia per le infrastrutture di Trasporto e della Logistica” introduce queste positive novità previste nel Codice Appalti nella strategia generale per le infrastrutture, come il PGTL, il DPP, il project review. Ma conferma anche le 25 opere strategiche già decise con l’Allegato Infrastrutture del 2015, in parte in corso di realizzazione ed in parte in corso di progettazione, del valore di 70 miliardi e di cui sono disponibili 48 miliardi, incluse le risorse private dei concessionari. Anche su queste opere sarebbe opportuno applicare una verifica ed una revisione di progetto, per verificarne l’utilità ed il sovradimensionamento. Tra queste 25 opere vi sono pezzi di alta velocità come il terzo valico Milano-Genova o nuove autostrade come la Pedemontana Lombarda, che davvero dovrebbero essere riviste dato che la loro realizzazione è al 15% ed hanno un impatto e costi davvero notevoli a fronte di una scarsa utilità collettiva.
Altra novità rilevante è l’introduzione nel nuovo Codice del Dèbat Public, il dibattito pubblico alla francese sulle grandi opere, che diventa obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali che hanno un significativo impatto sull’ambiente, sulla città e sull’assetto del territorio. Viene convocata una conferenza di servizi a cui partecipano tutti i soggetti interessati ad esprimere un’opinione, inclusi i comitati di cittadini, che deve concludersi entro quattro mesi. Il parere che esce da questo confronto non è vincolante ma dovrà essere valutato dall’Amministrazione Pubblica in fase di approvazione del progetto definitivo. Ma la tipologia e la dimensione delle opere che dovranno essere sottoposti a questa procedura partecipativa dovrà essere decisa entro un anno, con un decreto del MIT su proposta del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici. Quindi ancora ampie sono le incogniti sulla effettiva partecipazione che verrà promossa in Italia con il Dèbat Pubblic.
Per svolgere questi compiti di programmazione, selezione e revisione resta in piedi la Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture, che dovrà svolgere questi delicati compiti di revisione e riconversione di un sistema fallimentare come quello della Legge Obiettivo e dovrà sovraintendere alla redazione del PGTL e del DPP. Alla guida della Struttura Tecnica per il “dopo Incalza” è stato chiamato dal Ministro Delrio il prof. Ennio Cascetta, da sempre attento alle esigenze delle città, alla qualità dei progetti ed alla pianificazione strategica nei trasporti.
Quindi buone notizie dal fronte delle grandi opere: gli ambientalisti da sempre critici con la Legge Obiettivo, hanno vinto una battaglia fondamentale e si torna alla pianificazione per la scelta delle opere utili.
Ma con altri strumenti ed altre procedure le semplificazioni sono sempre presenti e vengono rafforzate. Con la nuova Conferenza dei Servizi (in dirittura d’arrivo ai sensi del Dlgs Madia) con tempi ridotti di approvazione, il silenzio assenso anche per gli enti di tutela e la VIA con la possibilità di chiudere la conferenza dei servizi anche in caso di parere negativo con decisione finale del consiglio dei Ministri.
E secondo, con il Regolamento “sblocca opere” approvato dal Governo sempre ai sensi della norma Madia per la completa delegificazione della Pubblica Amministrazione il 20 gennaio 2016. Consente al Presidente del Consiglio di individuare ogni anno una lista di opere pubbliche o insediamenti produttivi, da inserire in un DPCM con una deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il DPCM potrà decidere termini accelerati di decisione fino al dimezzamento dei tempi e se i questi tempi non saranno rispettati potrà essere il premier ad approvare direttamente i progetti con poteri sostitutivi.
Con questa procedura super semplificata alla Presidenza del Consiglio, niente intesa con le Regioni, Conferenza dei Servizi e Cipe: siamo quindi ben oltre le semplificazioni della Legge Obiettivo. Una specie di clava in mano al presidente del Consiglio di turno per scardinare ogni programmazione strategica ed ogni coinvolgimento con Regioni ed Enti locali, che fa davvero a cazzotti con le nuove procedure del Codice Appalti appena entrate in funzione.
Ancora un focus sulle Concessioni e sul Partenariato Pubblico Privato (PPP), che hanno nel nuovo Codice Appalti diversi articoli di regolamentazione, anche ai sensi della Direttiva Europea 2014/23. Le concessioni dovranno affidare l’80% dei lavori mediante gara, mentre il restante 20% potrà essere svolto con società in house. Ma le concessioni avranno 24 mesi di tempo per adeguarsi a questa norma (adesso la quota a gara è il 60%) quindi tempi lunghi per la riorganizzazione delle imprese. Va ricordato che inizialmente nel passaggio al Senato della legge delega doveva essere il 100% ed era immediato ma la battaglia dei sindacati e la resistenza dei concessionari hanno fatto correggere il testo.
Il nuovo Codice prevede anche un giusto articolo per l’introduzione di “clausole sociali” per la riaussunzione dei lavoratori verso le nuove società risultate vincitrici di gara, per dare continuità occupazionale ai lavoratori, un tema fortemente sentito nel settore, che adesso non hanno queste tutele.
Nel settore delle concessioni autostradali si dovrà procedere con gara per la scelta del concessionario: per quelle già scadute si dovrà procedere entro sei mesi, per quelle entro 24 mesi procedere con gara per rispettare i tempi di scadenza. Ma per le società interamente pubbliche in house vi è la possibilità, anche secondo la direttiva e come previsto nel codice appalti, di lasciare la gestione in essere e procedere senza gara. In questa direzione sta andando il Ministro Delrio per la società Autobrennero e per la società Autovie.
Con il nuovo Codice debutta anche l’obbligo nelle concessioni di traferire al privato il “rischio operativo”, incluse le fluttuazioni del traffico per quelle autostradali, senza che siano presenti garanzie pubbliche: esattamente il contrario di quello che accade oggi con il Concedente pubblico che assicura tutte le garanzie possibili al concessionario con risorse pubbliche, aiuti fiscali, valore di subentro. Una buona regola questa innovazione sul “rischio operativo” ma resta da capire come e se verrà applicata alle concessioni in essere con lunghe scadenze, che hanno atti convenzionali già sottoscritti e che faranno una resistenza granitica all’introduzione di questo principio.
La fase transitoria non sarà ne semplice ne breve dato che per la sua attuazione sono previsti ben 40 decreti attuativi di molti dei 220 articoli del nuovo codice che dovranno essere emanati da diversi ministeri, da ANAC, da altre istituzioni e diversi non hanno nemmeno i tempi di scadenza entro cui adottare il provvedimento specifico.
Altro problema che dovrà essere risolto è il potenziamento con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali da assegnare ad ANAC, se vogliamo metterla nella condizione reale di svolgere al meglio il ruolo chiave che il nuovo Codice le assegna.
Sono tante le novità interessanti previste dal nuovo Codice appalti, servizi e forniture. Ma non mancano – come abbiamo sottolineato - contraddizioni ed ombre su cui vigilare perché i buoni principi si trasformino in regole stringenti contro la corruzione, per la qualità dei progetti, per imprese sane ed un mercato aperto e trasparente. E perché sia davvero cancellata la Legge Obiettivo e si torni a scegliere con criterio le opere utili alla collettività.

Primato del Consiglio regionale della Campania nella gara per il più coerente distruttore del territorio nelle terre più fertili del mondo comandano i peggiori cementificatori. Poi si vuole affidare alle regioni la lotta al consumo di suolo...
Non conosce pause il processo di peggioramento del “piano casa” in Campania. Con la legge regionale n. 6 del 5 aprile 2016 “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016” il consiglio regionale ha approvato le proposte della giunta De Luca in un numero cospicue di materie, fra cui, appunto, quella disciplinata, per dir così, dal “piano casa”.
L'Amministrazione regionale in carica aveva già deciso, a cavallo dello scorso Capodanno, di prorogare quel regime derogatorio alla pianificazione urbanistica ordinaria nella forma fino ad allora determinata dalla serie di modifiche apportate nel tempo all'originario testo del 2009, e da ultime da quelle della giunta di centro-destra presieduta da Caldoro.
Ora la maggioranza “detta di centro-sinistra”, per dirla con Crozza, ha voluto lasciare nell'incessante sequenza una propria impronta, riuscendo nell'impresa di scavalcare la maggioranza precedente nella rincorsa a piegare il governo del territorio agli interessi speculativi.
Due, in particolare, sono le modifiche significative. La prima concerne le modifiche di destinazione nelle zone agricole. Con le Linee guida del paesaggio introdotte anni fa nel piano territoriale regionale, poi approvato con la legge regionale 13/2008, si era riusciti finalmente ad affermare la riserva fondamentale del territori agricoli alle attività coltivatrici e agli interventi edificatori con esse strettamente connessi, sicché per consentirli occorreva che la loro necessità venisse documentata da un piano di sviluppo aziendale asseverato da un agronomo iscritto allo specifico albo professionale.
Come conseguenza sia pure tardiva di tale importante conquista, era avvenuto che la maggioranza a sostegno di Caldoro nel 2014 avesse corretto un suo precedente emendamento al “piano casa” : nell'art. 6 bis introdotto nel 2011 nella LRC 19/2009, venivano infatti limitati «i mutamenti di destinazione d'uso di immobili» nelle zone agricole (per intenderci, da stalle o depositi ad abitazioni) a quelli connessi con l' «uso residenziale del nucleo familiare dell'imprenditore agricolo». Ora, nel 2016, il centro-sinistra sopprime tale limitazione consentendo i mutamenti di destinazione d'uso in deroga ai piani urbanistici per l' «uso residenziale del nucleo familiare del proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederli» ai sensi del DPR 380/2001: si apre in tal modo un varco preoccupante per tornare a perpetuare l'aberrazione delle villette o dei condomini residenziali in campagna, che hanno distrutto in Campania vaste estensioni verdi trasformandole, e non solo nelle pianure conurbate, in tristissime periferie rur-urbane.
La seconda modifica rilevante concerne il “recupero” dei complessi produttivi dismessi. Con l'art. 7 bis il centro-destra nel 2014 aveva consentito, in deroga ai piani urbanistici, di demolire e ricostruire, con incrementi fino al 20 % della volumetria esistente, i complessi ex industriali in applicazione del decreto legge 70/2011, convertito in legge n. 106/2011. Tali interventi «sono autorizzabili anche con eventuale possibilità di delocalizzazione delle nuove strutture edilizie se tale forma di intervento sia prevista nella programmazione urbanistica locale, sia ritenuta utile ed opportuna dal comune, e vi sia la disponibilità dell’area alternativa rispetto a quella dove sussistono le volumetrie preesistenti oggetto dell’intervento». Ma, veniva precisato nel 2014, «sempre con destinazione ad attività produttive». Ora, il centro-sinistra consente invece qualunque destinazione, sopprimendo il vincolo produttivo.
Dato il carattere derogatorio della disposizione e la vaghezza delle formulazioni circa la previsione nella programmazione locale, il giudizio di utilità ed opportunità da parte del comune e la disponibilità di un'area alternativa, è evidente la portata eversiva della modifica ultima, che inevitabilmente si tradurrà in ulteriori aggressioni edilizie ai territori agricoli, in barba ad ogni sforzo per contenere il consumo di suolo.
Indovinate chi, a tanti mesi dal Capodanno, continua a brindare ?
 In occasione dell'iniziativa
In occasione dell'iniziativa Una città un piano
sul programma di ricostruzione del post-terremoto di Napoli, recuperiamo un articolo di Antonio Cederna che descrive i risultati raggiunti e le lezioni impartite, la Repubblica
, 20 maggio 1987 (m.b.)Non c’è solo la Napoli che vince il campionato di calcio, non c' è solo la città disastrata da inquinamento, caos edilizio e dalla speculazione: c' è una Napoli tutta diversa di cui bisogna parlare perché finora è stata completamente, inspiegabilmente ignorata dalla stampa, dalla televisione, dagli stessi partiti politici.
E' la Napoli delle periferie ricostruite dopo il terremoto del novembre 1980, che senza mezzi termini può essere definita un modello di pianificazione urbanistica. Chi vuole scoprirla deve affrontare itinerari inconsueti, essere accompagnato da qualcuno dei valenti tecnici dell' ufficio da sei anni preposto al programma straordinario di edilizia residenziale (in base alla legge 219 del maggio 1981), e arrivare finalmente a Soccavo, a Secondigliano, a Piscinola-Marianella, a S. Pietro a Patierno, a Ponticelli, a Miano, a Barra-San Giovanni.
E qui, dove più grave era il disagio abitativo e più pesanti i danni del terremoto, ci si può rendere conto che si sta portando a compimento il più importante piano di edilizia economica e popolare degli ultimi decenni in Italia. A sette anni dal terremoto il settanta per cento del programma è realizzato. Dei 14.000 alloggi (per 63.000 vani) previsti dalla legge della ricostruzione, più di 7.000 sono ultimati, e di questo quasi 5.000 sono già abitati. Assieme agli alloggi sono ultimate 32 sedi scolastiche (e altre 36 sono in fase avanzata), 6 impianti sportivi fra cui due piscine; oltre un centinaio di ettari sono riservati a parco, giardino, verde condominiale; 1.500 sono i negozi e i laboratori artigianali, in gran parte ricavati al pianterreno dei nuovi complessi edilizi, per 2.500 addetti. Insomma, oltre 22.000 persone vivono già negli insediamenti rinnovati della periferia: il che vuol dire che in appena quattro anni (da quando cioè è stata pubblicata la prima graduatoria per l' assegnazione degli alloggi febbraio ' 83 si è attuato senza particolari traumi, drammi o disordini un trasferimento di popolazione di proporzioni mai viste, da nuclei edilizi fatiscenti e con intollerabili indici di affollamento (fino a tre persone per stanza) a quartieri finalmente civili. Ed entro l' anno si prevede che saranno sistemate in tutto ottomila famiglie.
Già questo è un risultato eccezionale, ma altre ancora sono le lezioni che ci impartisce la ricostruzione di Napoli, avviata dalla giunta di sinistra nell' 81 allorché, in base alla legge, al sindaco furono assegnati poteri di commissario straordinario di governo. Gli uffici comunali vennero potenziati con un' équipe di giovani estremamente competenti coordinati da Vezio De Lucia e affiancati da consulenti di prestigio nazionale (ricordiamo solo Giuseppe Campos Venuti, Leonardo Benevolo, Cesare De Seta, Italo Insolera, Tommaso Giuralongo, Alessandro Dal Piaz): e i tempi strettissimi imposti dalla legge vennero rispettati.
In appena dieci giorni vennero individuate le aree, due mesi sono bastati per espropriare poco meno di 600 ettari e per stipulare le convenzioni con le imprese concessionarie. Tutte operazioni che meritano un commento.
1) Si è proceduto all' esproprio perché, come insegnano i paesi avanzati, non si possono condurre a buon fine interventi di tale entità, se l' ente pubblico non entra in possesso dei suoli per assicurarsi il controllo delle operazioni ed evitare speculazioni. Quei suoli sono stati espropriati a un prezzo maggiorato del 70 per cento rispetto a quanto previsto dalla legge Bucalossi del ' 77: per una spesa di 390 miliardi, che ha inciso per meno del 10 per cento sul costo globale della ricostruzione, e l' ha resa possibile.
2) Non si realizzano in modo razionale i programmi se non si può contare su un' imprenditoria efficiente e su un costante controllo pubblico. L' ufficio tecnico del commissariato ha saputo concordare procedure, tempi e modalità della ricostruzione, e ha esercitato una verifica permanente dei progetti e della loro rispondenza alle prescrizioni: l' istituto della concessione è stato così depurato dei rischi che di solito comporta quando il potere pubblico lascia carta bianca ai privati. Qui ricordano ancora un fatto memorabile, il giorno in cui nella sala della giunta comunale furono stipulate le convenzioni con le imprese private (ottanta, riunite in dodici consorzi): l' applauso che imprenditori e costruttori riservarono al comunista Guido Alborghetti, vicepresidente della commissione lavori pubblici della Camera, che il sindaco-commissario Valenzi aveva voluto dirigesse l' operazione. E poco dopo il giornale della Confindustria scriveva che a Napoli si era verificato quasi un miracolo. Quale? Per la prima volta, in questa città sottoposta da sempre a saccheggio edilizio, imprenditori e costruttori potevano iniziare a lavorare senza pagare tangenti. E Leonardo Benevolo commentava: Dopo decenni di malgoverno, si assiste al recupero della legalità, della correttezza urbanistica e dell' efficienza amministrativa.
3) E' una lezione più propriamente urbanistica. Per circa due terzi la ricostruzione (oltre ad alcuni interventi puntuali nel centro storico) è stata concentrata nella periferia, nei dieci ex-comuni rurali che mezzo secolo fa furono annessi a Napoli: gli stessi che erano stati compresi in uno strumento adottato dal comune sette mesi prima del terremoto, il piano delle periferie. La lezione è dunque questa: se il terremoto ha accelerato la decadenza della città abbandonata all' incuria, il piano straordinario di ricostruzione è sfuggito alla logica dell' emergenza e ha accelerato l' attuazione di un intervento ordinario. Ovvero, l' emergenza-terremoto non è stata usata per sconvolgere il piano regolatore, ma per realizzare un programma già predisposto e disponibile. A Napoli dunque si sta portando a compimento il più vasto programma di riqualificazione urbana mai attuato in Italia, e le modalità sono di grande interesse.
Non è stata scelta la strada facile della tabula rasa. Dei 14.000 alloggi previsti, circa 3.000 sono frutto di recupero: di un' operazione cioè che comprende la conservazione e il risanamento di quanto è possibile conservare e risanare, la sostituzione degli edifici in condizione di degrado irrimediabile e il completamento nelle aree marginali, il tutto finalizzato al sostanziale rispetto del tessuto insediativo preesistente. Così, la periferia riqualificata offre uno spettacolo non comune in Italia.
Colpisce l' ordine e la misura dei volumi edilizi, la presenza dei servizi e delle attrezzature sociali (che, altra cosa rara, vengono realizzati contemporaneamente agli alloggi), colpisce la qualità e la distribuzione delle aree verdi, l' accuratezza con cui vengono adottate le tecniche antisismiche nei vecchi edifici risanati, la buona qualità dell' architettura: a dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che la buona architettura può nascere solo dalla buona urbanistica.
Ammiriamo allora a Secondigliano (non lontano dall' omonimo quartiere di edilizia sovvenzionata che tanto male ha fatto parlare di sé) il modo in cui sia l' edilizia di sostituzione che quella interamente nuova rispettano la preesistente tipologia a corte e come siano permeabili dal verde, come sono sistemati il parco, il parcheggio, gli edifici scolastici. A San Pietro a Patierno, come i nuovi edifici sono inseriti nel vecchio tessuto, le vaste piazze a giardino all' interno dei lotti, la scuola col piccolo teatro all' aperto, il restauro in corso del vecchio nucleo. A Piscinola-Marianella le nitide case in armonia con l' andamento del terreno, collegate da passaggi coperti. A Milano, il lungo edificio curvilineo affacciato sul verde, le grandi corti attrezzate, la ristrutturazione in atto dell' edificato esistente. A Ponticelli la strada tra due file di edifici con percorsi pedonali sopraelevati, l' inalterata gerarchia dei percorsi stradali nella ristrutturazione del centro storico, l' ampio giardino su cui prospetta la bella scuola materna. A Barra, il restauro in corso delle vecchie case a corte, alcune sostituite con elementi prefabbricati, nel rispetto dell' antico impianto edilizio.
A S. Giovanni, il restauro del nucleo di Villa e, ai piedi del grande e nuovo edificio con strada interna a negozi, la grande sorpresa: un pezzo di Scandinavia calato nella periferia napoletana, senza paragone altrove nel nostro paese. E' il gran parco di Taverna del Ferro, di dieci ettari, col lago di acqua zampillante, la collina panoramica alberata, il giardino all' italiana, il giardino d' inverno, il vivaio, il teatro all' aperto, spazi per il riposo e il gioco. C' è da restare a bocca aperta.
Il verde pubblico è stato una delle più innovative realizzazioni del piano straordinario di edilizia residenziale: un centinaio di ettari (per 110 miliardi), parchi di quartiere e parchi urbani, che hanno più che raddoppiato la dotazione di verde di Napoli, portandola dalla media infima di 0,6 metri quadrati per abitante (un loculo, un tombino) a 1,77. Quando nel programma della ricostruzione queste aree furono destinate a verde, i tecnici furono presi per matti: per la torpida mentalità delle pubbliche amministrazioni il verde non è infatti un servizio pubblico essenziale alla vita associata ma un lusso, un vuoto da riempire se non un letamaio. Anche per questo è doveroso ricordare il nome di qualcuno degli esperti, competenti e appassionati, che hanno impostato e stanno portando a termine il programma straordinario: Elena Camerlingo, Giovanni Dispoto, Giancarlo Ferulano, Maria Franca de Forgellinis, Carlo Gasparrini, Roberto Giannì, Giuseppe Pulli, Laura Travaglini, e ci scusiamo con gli altri. (Coordinatore, oggi, è Michele Martuscelli).
Quale la dimensione finanziaria del programma? Circa 5.400 miliardi: 851 per gli alloggi, 427 per le opere di urbanizzazione primaria (strade, reti di servizi, ecc.); 571 per l' urbanizzazione secondaria (tra cui 1290 posti di asilo nido, incrementando del 430 per cento quelli esistenti; 2.450 posti in scuola materna; 12.350 posti-alunno della scuola dell' obbligo, verde, attrezzature collettive: dai distretti sanitari ai centri per anziani, dai centri culturali agli uffici comunali, dalle biblioteche ai centri civici eccetera); 1.300 per le infrastrutture generali (adeguamento della rete fognaria e idrica, grandi arterie viarie), il tutto al servizio di un bacino di utenti parecchie volte superiore alla popolazione insediata e da insediare negli alloggi del programma straordinario.
Una novità sostanziale è stata la fissazione del prezzo a forfait anche per il recupero per evitare le lungaggini e quindi le lievitazioni dei costi che avrebbe comportato la determinazione a misura: ed è stato confermato che il recupero alla fine risulta meno costoso delle costruzioni interamente ex-novo. Tutto perfetto dunque, chiederebbe a questo punto il furbo di turno?
I problemi naturalmente ci sono (qualche attività produttiva che si rivela incompatibile con la residenza, una ancora non risolta distinzione tra spazi pubblici e spazi privati che ha riflessi sui rapporti di vicinato, qualche difetto di progettazione come nel gran parco con lago che abbiamo ricordato, ancora viziata dai vecchi criteri del giardinaggio all' italiana, eccetera). Ma sono problemi marginali che col tempo e la gestione si aggiustano, problemi inevitabili proprio quando ci si deve adattare a migliori e più umane condizioni di vita associata: quel che conta è che si sta portando a termine una grandiosa operazione urbanistica, sociale, economica.
Una cosa che non sembra interessare il nostro paese amante delle chiacchiere: nemmeno il partito comunista che pure l' ha avviata ha mai dedicato ad essa un convegno, una discussione, uno studio, mai un articolo sull' Unità. Alla nostra cultura vetero-architettonica interessa di più la sagoma deforme del nuovo palazzo di giustizia in costruzione nel nuovo centro direzionale, che si intravede dalla tangenziale mentre ci si sposta da una periferia all' altra.
Materiale per "Una città un piano:Napoli" Recupero urbano, edilizia residenziale pubblica e servizi. Presupposti, obiettivi e primi risultati dell'eccezionale vicenda della ricostruzione di Napoli dopo il terremoto del 1980 (m.b.)
Introduzione alla pubblicazione curata da Filippo Ciccone, Recupero e riqualificazione urbana nel programma straordinario per Napoli, Giuffré editore, Milano, 1984
«Natura di cose altro non che il nascimento di esse»: l'esperienza di riqualificazione urbana e di recupero in corso a Napoli - i risultati raggiunti e i loro limiti - possono appieno apprezzarsi solo se si conosce, sia pure sommariamente, la complessa vicenda della ricostruzione dopo il terremoto del 23 novembre 1980, di cui quell'esperienza è parte.
In primo luogo, sembra perciò utile una cronaca, per quanto possibile oggettiva, dell'origine e dello sviluppo del Programma straordinario. In secondo luogo, questa premessa ha il dovere di intervenire nel dibattito che i metodi e le procedure adottate a Napoli hanno provocato fra i cittadini interessati, nell'opinione pubblica, in ampi settori dell'amministrazione e dei mezzi di informazione e fra gli operatori della materia. In particolare, interessa mettere in evidenza che l'operazione in corso ha senso solo se può proseguire in un' azione ordinaria di lunga durata, indispensabile alla soluzione dei drammatici problemi della città. Non è infatti difficile dimostrare - ed è l'ultimo argomento di queste note che la situazione abitativa dell'area metropolitana di Napoli (che è privo di significato parlare di Napoli isolandola dal suo territorio) raggiunge indici di bisogno e di disagio che non hanno riscontro nel resto del paese.
I contributi che Filippo Ciccone ha raccolto nelle pagine che seguono non hanno certo la presunzione di proporre regole di validità generale. Hanno il solo obiettivo di dar conto di un'esperienza condotta con grande impegno, «sul tamburo», nel fuoco di una permanente emergenza. Impegno tanto più faticoso e difficile, in quanto svolto «senza rete) , e cioè senza poter contare su riferimenti ufficiali certi, soprattutto in tema di normativa e di determinazione dei costi del recupero. Questa supplenza a lacune di pertinenza statale è senz'altro il più evidente merito di quanto è stato fatto a Napoli dagli uffici e dai consorzi concessionari.
Certo, ce n'est qu'un début, specialmente se si considera che il Programma straordinario opera in regime di intervento totalmente pubblico, di edilizia sovvenzionata, come si dice in gergo. Ma ora che si sono definitivamente messi a punto criteri adatti a questa specifica esperienza di recupero (che riguarda circa 3.000 alloggi), credo che sia importante divulgarne la conoscenza ed arricchirla dei contributi che fornirà il dibattito, per valutarne la «trasferibilità» ad altre situazioni ordinarie, e cioè anche in regime di proprietà privata degli immobili da riqualificare, a Napoli e altrove. Per questo penso debbano riconoscersi la sensibilità e la tempestività mostrate dal Cresme nel decidere questa pubblicazione.
I materiali qui raccolti consentono pure un'approfondita discussione sull'insieme del Programma straordinario, ormai tutto avviato a realizzazione, grazie anche ai finanziamenti integrativi recentemente disposti dalla legge. Siamo a metà strada. Realisticamente, fra tre anni, e quindi a sei anni dall'approvazione della legge, la ricostruzione potrebbe essere compiuta: un risultato che ha pochi paragoni nel panorama dell'azione pubblica, specialmente nel Mezzogiorno. Sempre che non prevalgano obiettivi di diversa natura, estranei e contrari agli interessi della città.
Cronache della ricostruzione.
Dopo il terremoto, con il passare dei giorni e delle settimane, ci si rese conto che, a differenza di quello sismico, il baricentro dei problemi sociali era a Napoli e non nelle zone interne dell'Irpinia e della Basilicata. Questo non significava, allora come oggi, una sottovalutazione del disastro enorme che aveva colpito le province di Avellino, Salerno e Potenza. Ma ci si rendeva conto, con una certa semplificazione, che nelle zone interne era questione di capacità organizzative e di congrue risorse finanziarie.
Tutt’affatto diversa la situazione di Napoli. Qui, come mano a mano riconobbero prima gli osservatori più attenti (e fra questi il commissario straordinario del governo Giuseppe Zamberletti) e poi l'intera opinione pubblica nazionale, il terremoto aveva agito come un potente acceleratore di secolari processi di degradazione. Non diversa la situazione dei comuni di cintura, da Pozzuoli a Castellammare a Pomigliano: una cintura cresciuta con gli stessi caratteri speculativi e distorti del capoluogo e che nella stessa misura venne sconvolta dal terremoto.
E infatti, il dibattito che si sviluppò all'inizio del 1981 sulla ricostruzione mise in luce soprattutto due aspetti: la dimensione «metropolitana» dei problemi di Napoli e la gravità del disagio abitativo, che già prima del terremoto faceva rilevare in quell'area una sovrapposizione di effetti negativi senza pari nel resto del paese. Per adeguare allo standard nazionale le condizioni dell'area partenopea fu infatti calcolato un fabbisogno di almeno 200.000 nuovi alloggi: un fabbisogno immenso, assolutamente sproporzionato alle risorse finanziarie ordinariamente destinate all'edilizia pubblica napoletana. E fu posto l'accento sulla totale mancanza di spazi disponibili e sui vertiginosi indici di densità territoriale nel capoluogo e nei comuni limitrofi (fino a 18.000 abitanti per kmq).
Le prime proposte per la ricostruzione suggerirono perciò disegni di risoluto decentramento dei nuovi volumi edilizi verso le fasce più esterne della conurbazione, seconde una strategia che prevedeva, contemporaneamente all'avvio di un processo di pianificazione comprensoriale, un insieme di azioni immediatamente operative basate sul meccanismo dell'urbanizzazione pubblica di notevoli estensioni' di aree. Il dibattito sulla ricostruzione fu però troncato dai «comandi prussiani» del titolo VIII della legge per la ricost ruzione che, imponendo la massimizzazione delle previsioni abitative nel territorio comunale di Napoli, azzerarono di fatto ogni ipotesi di complessiva riorganizzazione territoriale. (Non si deve dimenticare che una così perentoria scelta legislativa avvenne durante il rapimento dell'allora assessore regionale Ciro Cirillo, quando le Brigate rosse agitavano slogan rozzi, ma evidentemente efficaci, contro la «deportazione» dei napoletani. Da allora si è interrotto il dibattito sull'assetto dell'hinterland partenopeo, nella diffusa convinzione che la città di Napoli sia una specie di universo separato dal territorio circostante).
Così, nel giro di pochi giorni, scanditi dai messaggi dei terroristi, con un dibattito parlamentare di inconsueta rapidità, fu aggiunto, in calce a un provvedimento in esame sulla ricostruzione delle zone terremotate, un«titolo»di sei articoli relativo all'intervento statale per l'edilizia a Napoli».
La legge (14 maggio 1991, n. 219) dichiara «di preminente interesse nazionale) la realizzazione di 20.000 alloggi e delle relative opere di urbanizzazione nell'area metropolitana di Napoli, affidando tutti i poteri al sindaco della città, nominato ad hoc commissario straordinario del governo e soggetto soltanto al rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento. I tempi sono frenetici: entro dieci giorni dall'approvazione della legge devono essere individuate le aree disponibili nell'ambito del territorio comunale; nei successivi quindici giorni si deve provvedere all'occupazione degli immobili individuati; entro i quindici giorni ancora seguenti il sindaco-commissario deve procedere all'affidamento in concessione a società, imprese, cooperative, consorzi, degli alloggi e delle relative opere di urbanizzazione, da realizzare unitariamente. Per ogni scadenza non rispettata è previsto l'intervento sostitutivo del Cipe.
L'individuazione delle aree «è effettuata in deroga alla vigente normativa urbanistico-edilizia, anche per quanto riguarda la destinazione d'uso e gli indici di edificabilità». L'esproprio è compensato incrementando del 70% le indennità previste dalle norme vigenti. I costi di costruzione sono stabiliti dal Cipe. Allo stesso Cipe è demandata la definizione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi. La disponibilità finanziaria è di 1.500 miliardi. Organo di consulenza del commissario è un comitato tecnico amministrativo formato da cinque funzionari designati dall’Avvocatura di Stato e dai ministri dei Lavori pubblici, della Difesa, del Tesoro e delle Finanze. Ove i 20.000 alloggi non fossero realizzabili tutti nel territorio comunale di Napoli, le funzioni di commissario sono attribuite anche al presidente della Giunta regionale, che provvede, con le stesse procedure e gli stessi poteri del sindaco-commissario, a localizzare i restanti alloggi nei comuni dell'area napoletana. I tempi sono ovviamente sfalsati di dieci giorni, per tener conto delle decisioni nel frattempo assunte per Napoli.
Con leggi successive alla 219 sono state integrate e perfezionate le norme originarie. In particolare, si è chiarito che il Programma comprende anche interventi di recupero e che le urbanizzazioni primarie e secondarie vanno dimensionate anche «al recupero dei fabbisogni arretrati». Le disposizioni legislative configurano insomma un complesso programma, come si dice, per obiettivi (perché certamente i previsti 1.500 miliardi non sono sufficienti per la realizzazione dell'insieme di opere indicate) da realizzare in tempi ristrettissimi, attraverso il trasferimento in blocco agli operatori privati di tutti i poteri e le responsabilità normalmente di competenza della pubblica amministrazione.
Infatti, secondo la legge 219, «formano oggetto della concessione tutte le opere necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione e il pagamento delle indennità [...], la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il numero degli alloggi da realizzare, le tipologie degli stessi, le prescrizioni urbanistico-edilizie da osservare e i termini per la realizzazione dell'intervento, la progettazione esecutiva delle opere, la realizzazione delle stesse e quant'altro necessario per rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli assegnatari».
Va subito detto che nell'attuazione del Programma straordinario solo in parte sono stati utilizzati gli smisurati spazi offerti dal legislatore. È importante ricordare soprattutto che nel comune di Napoli -così come peraltro richiesto dal presidente del Consiglio dei ministri Arnaldo Forlani -non si è fatto ricorso, se non per questioni marginali, alla facoltà (quasi un obbligo) di deroga alla disciplina urbanistica e che i poteri riconosciuti dalla legge ai concessionari sono stati temperati da opportune procedure di indirizzo, vigilanza e controllo affidate agli uffici del commissario. La repentina approvazione della legge 219 determinò nell'amministrazione comunale di Napoli preoccupazione e tensione. Il sindaco Maurizio Valenzi (con la collaborazione del vicepresidente della Commissione Lavori pubblici della Camera dei deputati, Guido Alborghetti) prese subito contatto con le organizzazioni nazionali e locali degli imprenditori, con le quali si misero a punto i criteri di scelta delle imprese concessionarie e si impostò il modello di concessione. Lucido organizzatore degli imprenditori fu l'ing. Francesco Rallo, che assumerà poi funzioni di coordinatore dei concessionari.
La localizzazione delle aree d'intervento e la definizione delle caratteristiche urbanistiche ed edilizie degli insediamenti fu affidata all'Ufficio studi urbanistici del comune, formato da giovani architetti e funzionari che avevano già redatto il cosiddetto «Piano delle periferie», del quale parliamo qui di seguito.
Alla sfida della legge si rispose con un impegno eccezionale. A mezzanotte meno cinque del 28 maggio 1981, allo scadere cioè dei dieci giorni fissati dalla legge, vengono consegnati a Palazzo Chigi gli elaborati del Programma straordinario: localizzazione e dimensionamento di 13.578 alloggi e delle relative attrezzature. Viene intanto mobilitata un'armata di tecnici e di rilevatori che in quindici giorni prende possesso di 400 ettari e di centinaia di edifici oggetto del Program ma, redigendo quasi 9.000 stati di consistenza. Il mondo politico e imprenditoriale di tutt'ltalia osserva con incredulo stupore la prova di efficienza offerta da Napoli.
Nei termini previsti vengono intanto selezionate le imprese: il 18 giugno il sindaco-commissario pubblica sulla stampa nazionale un avviso con la specificazione dei requisiti richiesti (tra gli altri, 6 miliardi di fatturato nei tre anni precedenti per le imprese singole e 100 miliardi per i consorzi); il 22 giugno, alla scadenza del termine, rispondono quasi 150 operatori, dei quali circa 100 in possesso dei titoli richiesti; il 27 giugno viene disposto l'affidamento in concessione delle opere previste dal Programma a 12 raggruppamenti di imprese private, del movimento cooperativo e delle partecipazioni statali. Fra il 31 luglio e il 5 agosto successivi vengono stipulati i contratti di concessione. Intanto il Cipe ha stabilito i criteri di spesa, fissando in 500.000 lire (luglio 1981) il costo di un mq di nuova edilizia, mentre rinvia alle determinazioni a misura, sulla base di computi metrici estimativi, i costi delle urbanizzazioni e del recupero.
Ha inizio cosi «la più grossa operazione urbanistico-edilizia mai avviata nel nostro paese», scrive il «Corriere della sera». «Quasi un miracolo», commenta il quotidiano della Confindustria. E in effetti, in poco più di due mesi e mezzo, in una tremenda situazione sociale e di ordine pubblico (le Brigate rosse feriscono il consigliere democristiano Rosario Giovine e l'assessore comunista all'edilizia Uberto Siola) è stato svolto un lavoro che alla più efficiente delle amministrazioni ordinarie avrebbe richiesto non meno di un anno.
Le scelte urbanistiche del Programma straordinario si possono così riassumere:
- completamento dei Piani per l'edilizia economica e popolare di Ponticelli e Secondigliano, dov'è prevista la costruzione di oltre 4.000 alloggi e di servizi e infrastrutture per almeno 50.000 abitanti. Si tratta in sostanza di riorganizzare e attrezzare un intero settore urbano, la cosiddetta «Napoli orientale»;
-circa 50 interventi puntuali di restauro o di sostituzione, disseminati sull'intero centro urbano, dove si prevedono circa 800 alloggi e numerosi impianti pubblici. Sono interventi dichiaratamente sperimentali, con l'obiettivo di mettere a punto e verificare adeguate metodologie, in particolare per il centro storico di Napoli, per il quale non esistono proposte operative e che perciò è stato escluso dal Programma straordinario. Per alcuni di questi interventi è prevista la contestuale progettazione di «Piani di inquadramento», che si configurano, di fatto, come veri e propri Piani di recupero, il che estende il carattere sperimentale anche al versante urbanistico;
-attuazione del «Piano delle periferie», approvato dal Consiglio comunale nell'aprile del 1980, sette mesi prima del terremoto: un'ambiziosa iniziativa (illustrata in seguito da Elena Camerlingo), finalizzata alla riqualificazione -attraverso l'uso combinato della 167 e dei Piani di recupero - delle parti più degradate e mortificate del sistema insediativo napoletano. Le aree di intervento riguardano infatti 10 ex comuni che durante il fascismo furono aggregati al territorio del capoluogo. Il piano vi prevede opere di nuova edificazione, di recupero e soprattutto di attrezzature e servizi. Gli alloggi in programma sono 8.600, dei quali 3.000 da recuperare, ricavandoli da 6.000 alloggi esistenti, di dimensione minima.
Queste previsioni sono distinte nel Programma secondo due insiemi territoriali e procedurali, definiti ambiti: quelli di nuova edificazione, che comprendono gli interventi da realizzare su aree libere, e gli ambiti di riqualificazione, ubicati nel cuore del tessuto urbano periferico (prevalentemente dove il Piano delle periferie prevedeva il ricorso alla 167), che comprendono in particolare gli interventi di recupero. A questi primi due vanno aggiunti gli ambiti di recupero, (e gli equivalenti «Piani di inquadramento», di cui si è detto) le cui aree non sono soggette all'intervento pubblico, essendo stati incaricati i consorzi concessionari della sola progettazione urbanistica. Si dovrebbe in tal modo garantire omogeneità e continuità tra il Programma straordinario di iniziativa pubblica e la successiva azione ordinaria su aree private.
Accanto ai 13.578 alloggi (i rimanenti sono localizzati dal commissario straordinario-presidente della Giunta regionale della Campania in 17 comuni della provincia), il piano prevede: 30 scuole dell'obbligo e superiori, 33 scuole materne, 30 asili nido (per un totale di oltre 15.000 posti alunno); 15 sedi per attrezzature collettive, culturali e sociosanitarie; parcheggi pubblici per circa 20.000 posti auto; 20 ettari per attrezzature sportive; centinaia di locali destinati a esercizi commerciali e artigianali. Ma soprattutto interessa ricordare che quasi un quarto dei 400 ettari espropriati dal Programma sono destinati a verde. Forse più di ogni cosa i 21 parchi previsti nelle periferie, dei quali tre grandi quanto la «villa comunale» (che rappresenta un simbolo della città borghese), danno il segno dell'opera di riscatto avviata per le parti di Napoli più devastate dall' incuria e dagli abusi.
Nei torridi giorni dell'agosto 1981 ha quindi inizio il lavoro dei progettisti incaricati dai consorzi; i tecnici impegnati aumentano con il passare delle settimane: alla fine sono quasi mille. La convenzione prevede tre fasi - schema urbanistico, progetto di massima e progetto esecutivo - ciascuna soggetta all'approvazione del sindaco-commissario. Si organizzano, infatti, gli uffici di questa singolare istituzione, che si avvale anche della consulenza di qualificati esperti e di istituti specializzati, distinti in strutture «orizzontali» e «verticali». Le prime, una per ciascuno dei 12 comparti territoriali, operano in corrispondenza degli altrettanti consorzi concessionari, di cui rappresentano la «controfaccia»: le strutture orizzontali operano invece per materia di competenza (nuova edificazione, recupero, urbanizzazioni, attuazione degli interventi, sicurezza antisismica, ecc.). Il lavoro consiste essenzialmente in incontri a tre -committente, progettisti e impresa - che consentono una rapida soluzione dei problemi. I progetti sono poi sottoposti a una commissione che raccoglie i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate e degli enti erogator i di servizi.
A regime, si riusciranno ad approvare ogni mese progetti per 40 miliardi (lire 1981), importo di tutto rispetto se confrontato con i 100 miliardi all'anno ordinariamente assegnati alla Regione Campania per l'edilizia pubblica e che in parte restano inutilizzati.
All'inizio dell'estate 1982 sono stati approvati gli schemi urbanistici, quasi tutti i progetti di massima, molti progetti esecutivi e sono in funzione i primi cantieri. È stato intanto messo a punto il capitolato speciale che, tra l'altro, fissa le norme di comportamento degli uffici e dei concessionari e regola, secondo un moderno sistema di codificazione, i requisiti cui devono rispondere le opere che si realizzano . E si attiva il sistema di controllo e vigilanza dei lavori, che prevede anche l'utilizzazione di circa 80 collaudatori in corso d'opera, coordinati dal direttore generale Michele Martuscelli. A ottobre, in occasione del Saie di Bologna -dove sono esposti i progetti di Napoli -si tira un primo bilancio positivo.
Resta da dire del bando per l'assegnazione degli alloggi, pubblicato all'inizio del 1983, sulla base di un'apposita delibera del Cipe che, accogliendo puntuali proposte del comune di Napoli, modifica sostanzialmente le tradizionali modalità di assegnazione. Sono privilegiati, accanto ai cittadini che hanno perso la casa a causa del terremoto (o per gli interventi di ricostruzione), gli abitanti di alloggi impropri, gli sfrattati, le giovani coppie, gli anziani e i «mononuclei». Al bando partecipano quasi 85.000 famiglie.
Ma è aperto il problema del recupero. In primo luogo, bisogna misurarsi con l'insofferenza e l'ostilità al concetto stesso di recupero diffuse in tutti gli strati della società (ma non solo a Napoli), poi con le difficoltà oggettive dell'operazione, sulle quali ci si sofferma nelle pagine che seguono. All'inizio, uffici e progettisti cercano di sperimentare le soluzioni possibili, senza pretendere di far capo a teorie indiscusse. Ma nel corso del lavoro, sollecitati in particolare dall'esigenza di criteri sicuri e omogenei nella determinazione dei costi, si approda ad alcune prime sistemazioni normative e procedurali relative alle operazioni di «manutenzione urbana» che si intendono sperimentare con il Programma straordinario. Si mettono così a punto (nel febbraio del 1983) i criteri che regolano gli interventi di recupero, distinguendoli secondo tre modalità: la conservazione, che comprende le tradizionali categorie della manutenzione, del risanamento e della ristrutturazione edilizia; la sostituzione, sia puntuale sia estesa a intere unità tipologiche; il completamento, da realizzare nelle aree non edificate strettamente connesse al tessuto edilizie esistente.
I criteri e i vincoli definiti per la progettazione degli interventi di sostituzione e di completamento riconoscono un valore primario alle preesistenti tipologie urbanistiche. Si richiede perciò il rispetto dei lotti che compongono il tessuto insediativo, della scomposizione interna alle corti, delle loro caratteristiche tipologiche, distributive e dimensionali. Questa impostazione rende, di fatto, sostanzialmente indifferente la scelta fra conservazione e sostituzione: prevale l'ultima modalità quando ragioni di costo, o irrimediabili condizioni statiche degli immobili, rendono impraticabile la conservazione. (Questi argomenti sono oggetto del saggio di Carlo Gasparrini, cap. Il, cui si rinvia per ogni approfondimento).
Contemporaneamente alla definizione delle tecniche di intervento, si lavora, insieme ai consorzi, alla proposta di determinazione parametrica dei costi del recupero (cfr. il saggio di Ferruccio Orioli, cap. III), per superare le insormontabili difficoltà e, quindi, l'enorme impegno di tempo imposto dalle valutazioni a misura. Proprio l'esperienza in corso a Napoli dimostra l'incongruenza di un rapporto di concessione quando non sia rigorosamente predeterminato il costo (ovvero il meccanismo sintetico per la stima del costo) delle opere da realizzare. E infatti, mentre gli interventi di nuova edificazione, regolati dal sistema di pagamento a forfait stabilito dal Cipe, hanno rapida ed efficiente attuazione, non si riesce invece ad assicurare speditezza alle opere di recupero e di urbanizzazione, da valutare a misura. Essendo la proposizione dei progetti, e quindi dei costi, di esclusiva competenza dei concessionari, all'atto dell'istruttoria e dell'approvazione ci si trova di fronte al seguente dilemma: o accettare nella sostanza (secondo un'interpretazione «estremistica» dell'istituto concessorio) le proposte delle imprese, con evidenti, incontrollabili, lievitazioni dei costi; oppure (come avviene) impegnarsi in estenuanti trattative per la revisione dei progetti e dei dati economici.
Si sconta in sostanza, nonostante tanto parlare di recupero, l'assoluta carenza di dati ufficiali e di regolamentazioni, specialmente in materia di costi. È indispensabile perciò elaborare e presentare al Cipe (nell'estate del 1983) una proposta di meccanismo parametrico (necessariamente complesso) per la valutazione degli interventi di recupero e dei costi unitari per le attrezzature scolastiche. Così, finalmente, nel febbraio scorso, viene approvata una apposita delibera del Cipe che dà facoltà di adottare la proposta del sindaco-commissario, in alternativa al sistema del computo metrico estimativo. Ci sono quindi tutte le condizioni per il concreto avvio dell'opera di riqualificazione. Intanto il Programma subisce le inevitabili conseguenze della crisi del comune di Napoli. Nel settembre 1983, Valenzi è sostituito, come sindaco e commissario straordinario del governo, dal consigliere di Stato Giuseppe Conti. Poi, all'inizio del 1984, per tre mesi, dal nuovo sindaco Franco Picardi (che in precedenza, come assessore all'urbanistica, aveva attentamente seguito lo sviluppo del Programma) e dal sindaco dei cento giorni, Enzo Scotti(che si era molto impegnato –come ministro del governo Forlani - nel primo avvio della ricostruzione nella primavera-estate del 1981).
Il lavoro, nonostante tutto , procede abbastanza linearmente. Sono stati completati, e in gran parte assegnati, quasi 800 alloggi; 7.000 circa sono in avanzata fase di realizzazione; il recupero -come si è detto -è allo starter di partenza; sono pubblicati i primi elenchi dei vincitori del bando per l'assegnazione degli alloggi. Il problema più grave è rappresentato dalla carenza di opere di infrastrutturazione generale (acquedotti e fognature), cui devono allacciarsi gli edifici del Programma. Qui si scontano in particolare le inadempienze e i ritardi della Cassa per il Mezzogiorno. Se non si provvede con energia e tempestività, si rischia, specialmente nella zona di Ponticelli, di produrre alloggi per lungo tempo inagibili, come è purtroppo nella storia dell'edilizia pubblica meridionale.
II dibattito sul recupero
Si è già detto che, a un anno circa dall'avvio del Programma (estate-autunno 1982), gli interventi di nuova edificazione erano concretamente partiti; il meccanismo concessorio efficiente; le strutture tecniche (quelle pubbliche e quelle dei consorzi) all'altezza della situazione. In alto mare erano invece i progetti relativi agli ambiti di riqualificazione, cioè ai circa 3.000 alloggi da recuperare.
Inadeguata e insufficiente -ai fini del rapporto concessorio -appariva innanzitutto la normativa allegata alle concessioni, in buona misura riproducente quella del Piano delle periferie e perciò finalizzata a un’attuazione ordinaria, direttamente gestita dall'amministrazione. Se infatti espressioni come «edificazione a tessuto», esprimevano concettualmente bene il rifiuto di soluzioni ordinarie, basate sulla prevalenza di edifici in linea multipiano, mancava però qualsivoglia indicazione «in positivo», per orientare univocamente la progettazione urbanistica ed edilizia affidata ai consorzi.
La lacuna era stata solo in parte colmata dalla Direttiva commissariale n. 7, che precisa metodi e criteri di rilevazione degli immobili ricadenti negli ambiti di riqualificazione, con l'obiettivo essenziale di «recuperare» le regole formative originarie degli insediamenti oggetto dell'intervento, per riutilizzarle nei progetti di riqualificazione. Purtroppo, anche il più scrupoloso rispetto dei requisiti richiesti per i rilievi era fine a se stesso e non aveva seguito coerente in fase di progettazione. In altre parole, non si era riusciti ad assicurare una finalizzata continuità nella procedura rilievo-progetto.
Ammesso che fosse chiaro (ma in effetti lo era in termini tecnico-formali assai labili) l'obiettivo del committente, essendo però la progettazione di competenza dei concessionari, era inevitabile la situazione di impasse nella quale ci si trovò all'atto della consegna dei primi progetti. In più circostanze, l'esigenza di far capo all'impianto strutturale preesistente veniva interpretata in termini scenografici e ambientalistici. Su questo argomento ci sarà occasione di tornare.
In sostanza, nella situazione data, rischiava di andare in crisi, per gli interventi di recupero, la stessa filosofia del rapporto concessorio. Il progressivo chiarimento che si era raggiunto, a seguito di lunghe, appassionate e faticose discussioni con esperti e operatori, anche estranei al Programma straordinario, in ordine alla metodologia del recupero , pretendeva infatti la piena «disponibilità» della progettazione da parte del committente. E non che non ci fossero progettisti interessati, convinti e disponibili ad approfondire la linea che a mano a mano si metteva a punto negli uffici del commissariato e che aveva il punto di partenza nelle analisi storico-tipologiche di cui tratta l'esemplare saggio di Gianfranco Caniggia pubblicato in questo volume, (nel cap. Il). Anzi, proprio il contributo di più architetti e tecnici professionalmente impegnati nell'iniziativa è stato determinante per verificare la concreta praticabilità dei metodi che si definivano. Il problema era perciò essenzialmente di natura contrattuale in quanto la più precisa definizione della domanda da parte del concedente poteva entrare in conflitto con le «libertà già garantite agli operatori, in particolare attraverso la determinazione a misura del costo degli interventi .
I problemi di metodo (se si vuole, «culturali») erano insomma aggrovigliati a quelli economico-giuridici, il tutto condizionato dalla già ricordata, pesante situazione di ostilità pregiudiziale all'idea stessa del recupero, che continua a essere prevalente nell'opinione pubblica e nei quadri dirigenti della politica e dell'amministrazione (non solo a Napoli). Trascurando qui gli aspetti più manifestamente strumentali ai fini della lotta politica, è utile ricordare in breve gli argomenti più diffusamente utilizzati nell'opposizione al recupero e che attengono a questioni di costo e di modello abitativo.
Quanto ai costi, Ferruccio Orioli in questo fascicolo elimina una serie di incomprensioni, che finora hanno complicato le discussioni in proposito. Innanzitutto è vero che, coeteris paribus, il recupero «pesante», in particolare in zona sismica, costa di più di una nuova edificazione su area libera (un di più peraltro contenuto, che Orioli ha stimato pari a un maggior costo del Programma non superiore allo 0,89%). Questo però significa soltanto che ci sarebbe convenienza a costruire case nuove solo se si abbandonassero a un destino di progressiva accelerata degradazione l'antico patrimonio edilizio e i suoi abitanti. Non c'è invece nessuna convenienza se, in alternativa al recupero, si pensa a operazioni di cosiddetto rinnovo urbano, e cioè di radicale demolizione e sostituzione di interi segmenti urbani fittamente abitati.
Senza chiamare in causa questioni di storia e di cultura, in sintesi di qualità urbana, è facile calcolare che la rinuncia al capitale infrastrutturale e sociale esistente e le immense spese di sistemazione temporanea degli abitanti e delle attività insediati sono nettamente superiori al costo delle operazioni di «cuci e scuci» urbanistico distribuite nel tempo (Ovvero di manutenzion eurbana) che si stanno sperimentando con il Programma straordinario. AI recupero, allora, non c'è alternativa se non si vuole imboccare il vicolo cieco di un'espansione illimitata degli insediamenti (ma a Napoli, per esempio, dov'è lo spazio?), le cui parti più antiche continuano a marginalizzarsi socialmente ed economicamente.
Quanto al modello abitativo ci si limita qui a ricordare che la parola d'ordine più diffusa, con la quale deve fare i conti chiunque affronti l'argomento, almeno da Roma in giù, è la seguente: «l'antica edilizia va eliminata, perché rappresenta la testimonianza di un passato di miseria dal quale vogliamo riscattarci». A questa logica non estranea certa cultura di sinistra che, proponendo per la classe subaltema gli stessi valori e gli stessi comportamenti In precedenza assunti dai ceti borghesi, condanna di fatto alla subordinazione permanente della prima ai secondi. Nei decenni trascorsi sono state infatti le famiglie benestanti ad abbandonare per prime le vecchie residenze, ad esse preferendo i requisiti «moderni» dei pentacamere-termo-ascensori offerti dalIa speculazione nelle nuove espansioni (al Vomero-Arenella, o a Monte Mario, o altrove). Quest'offerta standard ha finito con il rappresentare lo status sociale più ambito e ad essa si è in qualche modo uniformata la stessa produzione dell'edilizia pubblica.
Ma negli anni più recenti, a partire dalla città e dai ceti con più solido assetto economico-intellettuale, la «moda» si è ribaltata, con la rivalutazione degli elementi di pregio (tecnici, urbanistici) degli insediamenti più antichi. E, proprio per contenere gli effetti socialmente negativi di questa tendenza, si è sviluppata la «via italiana» al recupero dei centri storici. Niente meglio dello slogan coniato circa quindici anni fa a Bologna, «il centro storico è la gente», illustra la chiarezza dell'obiettivo della duplice e contestuale salvaguardia dei manufatti edilizi e dei loro originari abitanti. Ma si tratta, evidentemente, di un'indicazione che stenta ad affermarsi, se prevale ancora (a Napoli, per esempio) una pregiudiziale insofferenza alle politiche di recupero cui si contrappongono i valori un po' stantii della nuova edilizia dovunque e comunque realizzata.
A impedire che questa mentalità prevalente raggiungesse lo scopo -da taluni esplicitamente dichiarato -di modificare il Programma alla radice, depurandolo degli interventi in ambito di riqualificazione, è stata soprattutto l'intesa che si è realizzata con i consorzi concessionari. Quest'intesa non è stata determinata da considerazioni di immediata e indiscriminata convenienza economica. Anzi, quei ragionamenti maturati all'inizio dell'operazione, circa l'appetibilità di interventi, qualitativamente e quantitativamente indeterminati, da compensare a misura, sono stati superati da una più evoluta concezione imprenditoriale, che ha fatto i conti con le rilevanti prospettive che il recupero offre nel nostro paese e, quindi, con le opportunità, il know how, che l'occasione napoletana consente.
Se infatti le esperienze finora condotte altrove avevano indotto a ritenere quello del recupero un comparto comunque secondario, i problemi della realtà napoletana hanno viceversa dimostrato la dimensione smisurata delle cose da fare e contribuito quindi a convincere che l'intervento sull'esistente rappresenta gran parte del futuro dell'attività edilizia. E questo spiega -ed è uno dei meriti indiscutibili dell'azione, anche formativa, svolta dal Programma straordinario- la netta modifica di posizione assunta dai costruttori in ordine ai temi del recupero. Basti confrontare le dichiarazioni dell'immediato terremoto (quando, evidentemente, l'emozione per l'immane tragedia indusse i costruttori a proporre di radere al suolo quasi l’intero centro storico di Napoli) con i più recenti documenti e interventi sulla stampa della categoria, favorevoli nettamente all'opera di riqualificazione. La disponibilità degli operatori è insomma un «patrimonio» in via di formazione, che sarebbe irresponsabile disperdere.
D'altra parte, il recupero del mondo dell'impresa a impegni carichi di valenze culturali e sociali stata una decisione consapevolmente assunta all'inizio dell'operazione. Non è stato certo facile rimuovere quell'insieme di ragioni (tutt'altro che infondate in un non lontano passato) che spingevano a ritenere definitiva l'estraneità degli imprenditori a farsi carico di responsabilità d'interesse pubblico. In effetti questo è stato possibile anche perché si sapeva di poter contare su livelli di qualità, di competenza e di lealtà degli uffici pubblici operanti in sede commissariale che garantivano da ogni rischio di involuzione. E si è in tal modo dimostralo, contrariamente a quanto molti di noi pensavano, che la concessione non comporta affatto un'automatica mortificazione e depressione dell'apparato pubblico, ma può esserne anzi occasione di crescita e di rinnovamento: sempre che ci siano i presupposti, in termini di «questione morale».
Tornando al recupero, l'approvazione della delibera Cipe per il forfait rappresenta la svolta decisiva. La portata del risultato raggiunto può essere apprezzata pienamente se si osserva che l'enorme lavoro preparatorio condotto dagli uffici e dai concessionari ha dovuto essere esplicato, contemporaneamente, in materia di metodi di progettazione e di definizione dei costi. E su entrambi gli argomenti sono del tutto insufficienti, se non addirittura assenti -come si è detto -i riferimenti normativi e i dati confrontabili di altre situazioni nazionali. Era perciò obbligatorio misurarsi con un impegno rilevante di carattere sperimentale - in assenza delle istituzioni che avrebbero il dovere di promuoverlo - impegno cui non si poteva supplire, per le dimensioni dell'intervento, con la pratica del buonsenso o con soluzioni volta a volta estemporanee.
Che questi risultati siano stati raggiunti mentre era in pieno svolgimento un'opera di dimensioni inusitate, e sotto la spinta di un'emergenza sempre trionfante dovrebbe essere un titolo di merito. Invece ad alcuni osservatori politici e giornalistici sembra che il non aver subito il ricatto della congiuntura sia una colpa di leggerezza, un cedimento all'effimero. In luogo di fare case comunque e dovunque si fa «filosofia del restauro» e, orrore!, si vorrebbero costruire parchi pubblici.
Ben più seria e impegnativa è la polemica che si è sviluppata fra studiosi e operatori della materia. Esempi autorevoli di critiche ricorrenti li forniscono Giancarlo De Carlo e Pietro Barucci. II primo, sul n. 22 di «Spazio e società», se la prende con le prescrizioni, regole e norme che tengono a freno l'immaginazione architettonica e urbanistica e scrive a un certo punto, che «alle opere che saranno realizzate a Napoli è stata negata la trasgressione dai luoghi comuni che garantiscono la mediocrità urbana». Con una splendida espressione , De Carlo si allinea perciò alla schiera, che il «riflusso» rende ogni giorno più nutrita, dei sostenitori della deregulation .
In altre sedi, per esempio a proposito del dibattito sull' abusivismo a Roma , sono stati denunciati i rischi del «trasformismo urbanistico» che si annida sotto spoglie libertarie. Qui preme sottolineare soprattutto l'errore in cui inciampano De Carlo e altri quando pensano che a tenere a freno l'immaginazione architettonica e urbanistica (e altri valori) siano prescrizioni, regole e norme, assunte a categoria indiscriminata. Come se una moderna civiltà industriale potesse sopravvivere senza una montagna di prescrizioni e di regolamenti. Come se potesse aversi giustizia fiscale senza enormi e complessi apparati di controllo. Come se, in tutta l'Europa occidentale, l'attività edilizia non fosse subordinata a sistemi di indirizzo e di verifica ben più elaborati di quelli vigenti in Italia. Il bersaglio allora non può essere la normativa in quanto tale, ma la viltà, la pigrizia, l'incompetenza e la corruzione che si nascondono dietro il paravento della norma, o il garantismo che deborda in degenerazioni burocratiche.
Si individui allora correttamente il bersaglio nel modo d' essere prevalente della pubblica amministrazione nel nostro paese. Da questo punto di vista, il funzionamento esemplare degli uffici è stato uno degli obiettivi specifici dell'azione del commissariato. E un risultato di quest'impegno sta proprio nella normativa messa a punto per il recupero. Questa, Pietro Barucci la definisce «manuale Valtur»: l'ironia non riesce a temperare l'insensibilità e l'insofferenza dell'architetto moderno» di fronte ai problemi e ai vincoli della storicità del territorio. Anche Barucci, eccellente architetto (e lo dimostra proprio la lettura in serie dei progetti per il recupero di Barra, successivamente elaborati per avvicinarsi alle prescrizioni degli uffici; progetti che non si apparentano affatto ai villaggi turistici sulle rive del Mediterraneo, cfr. cap. IV), non si sottrae all'ambizione corrente di chi vuole lasciare un segno vistoso sul corpo della città dove ha operato. La sua critica non è perciò a quella normativa o a quel comportamento degli uffici, ma a qualsiasi tentativo di coerente organizzazione della committenza pubblica.
Inevitabile perciò il conflitto con la struttura commissariale, che ha invece l'ambizione di orientare, con riferimenti precisi e oggettivi una complessa procedura di trasformazione urbana. Il modello di quest'azione non può essere l' Hansavirtel di Berlino dove, negli anni Cinquanta, architetti di ogni nazionalità furono invitati a cimentarsi, ciascuno costruendo un edificio in assoluta libertà: la città come fiera campionaria. Modello degli uffici di Napoli sono state -e lo ha rilevato più volte Tommaso Giura Longo -le organizzazioni pubbliche e private che hanno consentito le straordinarie realizzazioni urbanistiche ed edilizie della grande socialdemocrazia europea, del primo e secondo dopoguerra. Quelle organizzazioni per le quali hanno operato tanti maestri dell'architettura moderna, dando il meglio della propria professione, proprio in quanto non hanno preteso di misurarsi in gare di monumentalità, affrontando con rigore il tema dell'edilizia media.
Certamente gli obiettivi perseguiti dagli uffici solo in minima parte possono, oggi, ritenersi acquisiti; sono evidenti, per esempio, le differenze fra la «teoria» e la pratica espressa dai progetti finora messi a punto. Ma non è questo che può indurre a giudizi negativi. Una linea strategica, quale è quella che si sta perseguendo, può essere valutata solo su lunghi archi temporali, a mano a mano precisando e perfezionando metodi e procedure.
È di tutta evidenza, infatti, che il carattere sperimentale dell'intervento di recupero (e, per quanto si è detto, nella situazione data, il recupero in tanto è in quanto sperimentale) è stata una scelta assunta all'inizio dell'operazione: quando si è deciso di avviare subito la nuova edilizia su aree libere (il 75% del totale), per avere il tempo di approfondire metodi e criteri per gli interventi nelle aree edificate. Anche perché solo la disponibilità dei nuovi alloggi avrebbe consentito la sistemazione temporanea degli sventurati abitanti che continuano a vivere negli immobili da recuperare (come si può allora parlare di ritardi nel concreto avvio degli interventi di recupero?). Importante è perciò, ora, non solo la garanzia che il Programma vada avanti, ma che i metodi acquisiti possano svilupparsi altrove e ovviamente, innanzitutto, nell'affrontare gli enormi problemi dell'area metropolitana di Napoli.
Programma straordinario e area metropolitana di Napoli
Da un punto di vista socio-urbanistico -lo si è già detto -quando si parla di Napoli, non ha alcun senso riferirsi al territorio comunale del capoluogo. In proposito, basta ricordare che la provincia di Napoli (ivi comprese le isole del golfo) ospita quasi lo stesso numero di abitanti della città di Roma, ma misura una superficie nettamente inferiore a quella della capitale.
I problemi dell'urbanistica della casa, a Napoli, non possono quindi che essere affrontati in termini, come si dice, metropolitani. Questa non è, come sembra, un'osservazione del tutto ovvia. Mentre, infatti, in altre più o meno analoghe situazioni territoriali (per esempio, Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, ecc.) è dall'immediato dopoguerra che si sperimentano, con alterne vicende, ipotesi e istituti diversi di aggregazione fra i comuni; mentre, comunque, negli anni più recenti, in quelle situazioni si pratica una politica urbanistica ed edilizia coordinata, a Napoli l'esigenza di un'azione intercomunale resta un auspicio generico o un tema di esercitazione teorica. Da questo punto di vista, per le ragioni già esposte, è andata finora persa l'occasione offerta dalla ricostruzione.
Vediamo alcuni dati relativi alla condizione residenziale di quest'area, dati tratti dai primi risultati della ricerca che l'Ufficio tecnico del commissariato sta conducendo in materia. Napoli capitale dell'affitto è il più vistoso dei risultati acquisiti. A Napoli, infatti, oltre il 68% delle abitazioni risulta occupato in locazione, a fronte del 35% della media nazionale (Censimento 1981). E mentre nel decennio precedente lo spostamento medio nazionale verso il godimento in proprietà è stato di 9 punti percentuali, a Napoli lo è stato di solo 4 punti. Il dato è ancor più significativo se confrontato con l'evoluzione di altre grandi città italiane: nel 1971, per esempio, Milano e Torino presentavano lo stesso tasso di abitazioni in affitto di Napoli (72%), che però, in dieci anni, nelle due città del Nord si è ridotto di ben 12,4 e 11 punti percentuali.
Perché si può considerare questo dato decisamente rappresentativo del degrado edilizio? Per il paradossale, e patologico, assetto del mercato delle abitazioni in Italia, dopo l'equo canone. Presa in sé, un'alta percentuale di affitto è elemento positivo, è segno di mobilità sociale e territoriale, è una condizione per lo sviluppo economico: cosi è, infatti, nelle grandi aree metropolitane europee (specialmente in Germania e in Olanda). Da noi, invece, come si sa, l'equo canone ha fatto sparire gli alloggi in affitto (non è colpa della legge, ma del modo in cui non viene governata) e la mobilità residenziale è garantita solo a chi può accedere alla proprietà. A Napoli, la netta prevalenza dell'affitto si spiega perciò soltanto con l'esiguità del numero di inquilini con disponibilità economiche sufficienti per procedere all'acquisto dell'abitazione e con le condizioni così cattive del patrimonio in affitto da non provocare una significativa domanda di acquisto. D'altra parte, è noto che i parametri dell'equo canone incentivano il mantenimento della condizione di degrado. Ecco perché, nella particolare situazione napoletana, può sostenersi l'equazione: affitto = degrado. Napoli capitale dell'affitto significa perciò anche: capitale della degradazione urbana.
La diagnosi è confermata da un insieme di altri dati. A Napoli spetta ancora il primato di«vetustà» degli alloggi: il 39% del patrimonio edilizio è stato costruito prima del 1924, rispetto a una media nazionale del 23,3%. Napoli e Catania presentano ancora il più alto numero di alloggi in scadenti condizioni (35,4% e37,6%) con un forte salto rispetto ad altre situazioni negative (Palermo, con il 26,5%; Bari 26%; Venezia 20%). Lo scadente stato di conservazione delle abitazioni in affitto raggiunge a Napoli il 42,6% (e il 47% a Catania). L'esame dei dati consente insomma di affermare con sicurezza che sul patrimonio abitativo di Napoli (e della sua area metropolitana) si sovrappongono tutti i fattori negativi: si tratta di un patrimonio sostanzialmente vecchio e assai deperito, sia in generale sia, e soprattutto, per quanto riguarda lo stock in locazione.
Se questa è la situazione oggettiva degli edifici, ancor più deprimente è il quadro delle condizioni abitative soggettive, cioè riferite ai nuclei familiari. Basti citare le informazioni relative allo stato di affollamento. Il 38,2% del complesso delle abitazioni di Napoli città presenta un indice superiore a 1,5 (quasi il 40% nei comuni dell'hinterland) . Particolarmente elevata è la percentuale di alloggi collocata nella classe di maggiore affollamento (oltre 1,99 abitanti/stanza): il 24% a Napoli e il 22,3% nei comuni dell'area. Il distacco di Napoli e dei comuni della sua area metropolitana dalle altre situazioni è ancor più evidente se l'affollamento è riferito al patrimonio in locazione: il 44% degli alloggi in locazione a Napoli e il 48% nei comuni di cintura ricadono nelle due classi di maggiore affollamento (fino a 1,5).
L'indice di affollamento, come si sa, è uno degli elementi essenziali per la determinazione del fabbisogno di nuovi alloggi. L'altro elemento è la crescita della popolazione: si consideri al riguardo che -come risulta dalla citata ricerca -circa un terzo dell'incremento demografico registrato nell'insieme delle aree metropolitane italiane nel decennio 1971-1981 è concentrato nell'area napoletana.
Non si intende certo affrontare ora la questione delle nuove abitazioni necessarie. Tra l'altro, una valutazione astratta di siffatta quantità è impossibile, per definizione, se disgiunta da concrete ipotesi di politica del riuso. L' ordine di grandezza dell'incremento necessario a colmare il deficit sarà almeno pari a 1/ 4 dello stock abitativo esistente nella provincia di Napoli; ma, ovviamente, non importano tanto le cifre complessive, quanto gli obiettivi quantitativi prioritari su cui dimensionare la ricerca di risorse e gli strumenti programmatici e territoriali d'intervento. Quale che sia l'entità del fabbisogno abitativo di Napoli e dintorni in pratica esaudibile, non c'è dubbio, comunque, che avrà dimensioni molto rilevanti e non potrà essere soddisfatto da nuove edificazioni nell'ambito del territorio comunale.
I dati finora illustrati sono noti agli specialisti della materia e da un po' di tempo se ne occupa anche la stampa quotidiana. Ma c'è un elemento profondamente negativo e singolare della situazione abitativa napoletana finora sfuggito a ogni indagine: a Napoli, l'attività e il mercato edilizio o sono pubblici o sono abusivi; manca del tutto l'iniziativa privata regolare. Più ancora che nel mercato del lavoro, è in quello della casa che si esplica l'assistenzialismo indiscriminato, nei cui interstizi si annida la produzione nera. Il ripristino di condizioni in qualche modo ordinarie di mercato si pone, quindi, fra gli obiettivi prioritari dell'azione politico-amministrativa locale (e nazionale). Un sistema urbano non può infatti crescere e trasformarsi solo grazie all'edilizia sovvenzionata. Non solo mancano le risorse, ma si andrebbe incontro a deprimenti esiti sociali, già ampiamente verificati.
In conclusione, la situazione napoletana fin qui descritta può riassumersi come segue:
-un patrimonio esistente in avanzato stato di degradazione;
-un forte bisogno di nuovi alloggi;
-un mercato edilizio anomalo, privo di regolari iniziative private;
-una doppia e parallela disponibilità (effetto del Programma straordinario in corso) delle strutture imprenditoriali e dell'apparato pubblico per nuove prospettive di impegno.
Una situazione, come si vede. che solo in parte può essere affrontata localmente e che presuppone, in ogni caso, che sia risolto il problema del rapporto intervento pubblico-intervento privato. Una situazione sulla quale può essere di grande interesse proiettare l'esperienza fin qui condotta con il Programma straordinario, innanzitutto verificando le effettive possibilità di estensione del rapporto concessorio ad altre ipotesi di contesto istituzionale. Non c'è dubbio che, nel caso di intervento a totale carico pubblico, è abbastanza agevole -ma non certo scontata -la trasposizione di certe procedure dall'azione straordinaria a quella ordinaria. Molto più complesse simulazioni sono invece necessarie ove non si tratti di concessioni di sola costruzione, ma anche di gestione del patrimonio costruito ex novo o recuperato.
Sappiamo tutti che sono in corso riflessioni e ricerche su nuove forme di società immobiliari, sulle quali dovrebbe svilupparsi un dibattito più ampio di quanto non ci sia stato finora. Da questo punto di vista, dovrebbero sfruttarsi «in positivo» le stesse caratteristiche negative della situazione napoletana. Per esempio, a una così alta percentuale di alloggi in affitto dovrebbe corrispondere -nel rispetto di determinate condizioni -una più agevole manovra della mobilità abitativa, che è un presupposto essenziale per affrontare rilevanti problemi di riqualificazione urbana.
La riqualificazione urbana resta infatti il problema cruciale della futura attività urbanistica ed edilizia. L'esperienza di cui si dà conto in questo fascicolo può essere certamente, senza presunzioni, di rilevante importanza. Ma per tradursi in una diffusa politica abitativa ha bisogno -come altri ha sostenuto -di una convergenza di impegni (in termini concettuali, normativi, finanziari, operativi, progettuali, ecc.) equivalente a quella che si è esplicata per l'edilizia di nuovo impianto, a partire dalla legge 167 del 1962.
 bianchibandinelli.it (m.b.)
bianchibandinelli.it (m.b.)
“Ringrazio la presidente Laura Boldrini che dà prestigio alla nostra associazione con la cortesia della sua presenza. Ringrazio Walter Tocci che ha accettato di ricordare con noi Antonio Cederna, a vent’anni dalla scomparsa. Ringrazio quanti partecipano stasera alla nostra iniziativa. Ringrazio in particolare Desideria Pasolini dall’Onda che più di sessant’anni fece parte – con Giorgio Bassani, Elena Croce, Umberto Zanotti Bianco, Antonio Cederna e altri – del gruppo di benemeriti che fondarono Italia Nostra, per lunghi anni la più importante associazione ambientalista del nostro paese. (In verità Cederna, schivo come sempre, si tenne in disparte, e formalmente non figura fra i fondatori di Italia Nostra anche se ne è sempre stato l’ispiratore più importante).
Un mese fa, sabato 16 febbraio, abbiamo dedicato a Cederna un’indimenticabile passeggiata sull’Appia Antica, accompagnati da Rita Paris, Vittorio Emiliani e Giuseppe Cederna. Se i cittadini, non solo di Roma ma di tutto il mondo, possono godere di quello spazio sublime lo devono a Cederna che spese ogni sua energia per la salvezza dell’Appia. Uno spazio senza confronti, anzi l’unico confronto è con l’Acropoli di Atene, come ha scritto lo stesso Cederna.
In autunno, una terza iniziativa – curata da Giulio Cederna – riguarderà la presentazione di uno strumento navigabile e “interoperabile”, all’interno di una story-map dinamica dedicata alla ricostruzione delle principali tappe del lavoro e della vita del grande ambientalista. Come molti sanno, la splendida sede della soprintendenza archeologica di Capo di Bove ospita l’archivio di Antonio Cederna che la famiglia ha ceduto allo Stato. I circa tremila articoli disponibili presso l’archivio sono ormai tutti consultabili on line e, con il nuovo strumento che si sta mettendo a punto, consentiranno anche di costruire la carta dei luoghi di cui si è occupato Cederna e con che frequenza.
Stasera Walter Tocci ci ricorda Le politiche per Roma di Antonio Cederna (che era stato consigliere comunale e deputato di Roma). Mi pare evidente che ci interessa l’attualità del pensiero e dell’azione di Antonio Cederna. Cederna era un combattente, non subiva il fascino dell’Aventino, non si compiaceva di condannare e di esecrare, non amava isolarsi nello studio. Era invece attratto dall’agire collettivo, nelle associazioni, nei comitati, nella vita politica. Alla contundente efficacia di denuncia del suo giornalismo sapeva aggiungere, da militante ambientalista, una mirabile e concreta attitudine alla proposta, fino al disegno degli spazi (vedi l’Auditorium al Flaminio, o l’area archeologica centrale).
In questo sta l’attualità di Antonio Cederna. In una città come Roma che vive, ogni giorno di più, rassegnata e disincantata un terribile declino morale e culturale, conseguenza del malaffare e del malgoverno che hanno devastato la città, ricordare Antonio Cederna dovrebbe agire come una salutare scossa per restituire il senso dell’azione critica e dell’impegno, il gusto di partecipare alla costruzione del futuro. Di tutto ciò, che è la ragione della nostra iniziativa, parlerà Walter Tocci.
Mi fermo brevemente solo su un argomento. Chi mi conosce sa che sto per menzionare il Progetto Fori. Sono incapace infatti di pensare a Cederna senza abbinare la sua figura al Progetto Fori, e viceversa. D’altra parte, il più importante insegnamento che ho avuto da Cederna, è di non vergognarsi mai di ripetere le cose in cui si crede e che crediamo importanti, di sentirsi anzi obbligati a ripeterle senza preoccuparsi di apparire monotoni o noiosi. Non era solo una civetteria quando diceva che in tutta la vita aveva scritto sempre lo stesso articolo.
E in forza di quest’insegnamento ripeto anche stasera che il Progetto Fori è stata, in un secolo e mezzo di vita della capitale, la più straordinaria proposta di rinnovamento di Roma, non solo dal punto di vista dell’assetto fisico, ma anche dal punto di vista sociale e culturale. Del Progetto Fori – che da 35 anni è su un binario morto – vi dirà Walter Tocci che racconterà le vicende e ricorderà i protagonisti: Adriano La Regina, Giulio Carlo Argan, Leonardo Benevolo, Italo Insolera, Renato Nicolini. E soprattutto ricorderà la profonda, straordinaria, sorprendente intesa fra Cederna e il sindaco Luigi Petroselli.
Nel 1981, quando morì Petroselli, Cederna scrisse dello scandalo Petroselli, lo scandalo di un sindaco che credeva nell’importanza della storia nella costruzione del futuro. Ma non entro nel merito, il Progetto Fori lo ricordo per una ragione di stringente attualità. Mi riferisco al vivace dibattito in corso sulla valorizzazione del patrimonio archeologico. Valorizzazione che, negli ultimi tempi, è rivolta in maniera quasi esclusiva alla capacità dei beni culturali di rendere un utile economico. Anche le idee di Cederna e di Petroselli e dei protagonisti del Progetto Fori erano volte alla valorizzazione. Ma si trattava di un’altra valorizzazione, che rispondeva ai dettami di un’altra politica, una politica, aggiungo, concordemente condotta dallo Stato e dal Comune, anche se appartenevano a schieramenti politici contrapposti. Una politica che non si poneva il problema delle presenze turistiche e dell’utile economico, ma dell’utile culturale, dell’importanza dei beni culturali nella formazione di cittadini consapevoli. Una politica che voleva accorciare la distanza fra i cittadini romani, fra i borghesi del centro e i proletari e sottoproletari delle periferie. Una politica che voleva accorciare non solo i tempi di percorrenza, ma voleva anche – collocando i Fori Imperiali al centro della città moderna – ridurre la distanza fra i tempi della storia.
I meno giovani ricordano, nell’inverno 1980 – 1981, le domeniche pedonali lungo la via dei Fori Imperiali, una specie di estate romana in anticipo. Allora, per la prima volta, i cittadini, tutti i cittadini, ricchi e poveri, si sentirono eredi e custodi della loro storia.
Mi fermo. Da vent’anni ci manca Antonio Cederna. Ci manca il suo insistere che non esiste la civiltà moderna senza un rapporto vitale, non retorico, con la storia. E ci sentiamo obbligati a impegnarci perché Roma non dimentichi il suo esempio e le sue idee.
Walter Tocci è conosciuto da tutti e non devo presentarlo. Mi piace solo ricordare un stagione della nostra vita, a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta. Allora Antonio Cederna e io facevamo parte di un gruppo – posso dirlo? – di compagni (fra i quali, Piero Della Seta, Paolo Berdini, Giovanni Caudo, Paolo Grassi, Giancarlo Storto) che si incontrava per discutere ed elaborare proposte per Roma. Il nostro giovane leader era Walter che noi – anime innocenti – volevamo sindaco di Roma.”
 Vogliamo ricordarlo oggi, nell’anniversario della sua scomparsa. (m.b.)
Vogliamo ricordarlo oggi, nell’anniversario della sua scomparsa. (m.b.)
Nel 1989, Antonio Cederna presenta come primo firmatario una proposta di legge per Roma Capitale. Il futuro della città è immaginato attorno a tre linee fondamentali, riguardanti la direzionalità pubblica, il sistema dei trasporti e il parco storico-archeologico dei Fori e dell’Appia, vero e proprio elemento unificatore della città intera, dall’area centrale fino ai piedi dei Castelli Romani. Come ha scritto, su eddyburg, Vezio De Lucia “la relazione alla proposta di legge è una delle più suggestive e convincenti pagine dell’urbanistica moderna, una vera e propria lezione che dovrebbe essere diffusa nelle scuole e nell'università”.
In calce al testo, i presentatori della proposta di legge ringraziano Luigi Scano. Gigi era così, sempre disponibile a lavorare dietro le quinte, con generosità e competenza senza pari. A noi che l’abbiamo conosciuto piace ricordarlo così, mentre - tra una sigaretta e l’altra - contribuisce a scrivere alcune delle rare pagine belle dell’urbanistica italiana.
Riferimenti
La relazione e la proposta di legge sono consultabili nell’archivio della Camera dei Deputati. Nell’archivio di eddyburg, una cartella intera è dedicata a Gigi. Un suo ricordo, qui.
ItaliaOggi, 27 febbraio 2016, con postilla
Un provvedimento nato con i migliori propositi (valorizzare [sic] e limitare il consumo del suolo) ma che rischia di scontentare tutti: comuni e imprese. Dopo due anni di gestazione in commissione alla camera, il ddl (AC n. 2039), presentato dall’ex ministro delle politiche agricole Nunzia De Girolamo, torna a far parlare di sé. Questa settimana sono infatti arrivati alle commissioni riunite ambiente e agricoltura di Montecitorio gli ultimi pareri delle commissioni. E mercoledì con il conferimento del mandato ai relatori Chiara Braga e Massimo Fiorio (entrambi del Pd) i lavori entreranno nuovamente nel vivo.
Gli Affari costituzionali e la Bicamerale per le questioni regionali si sono espressi dando parere favorevole, ma chiedendo al tempo stesso significativi ritocchi al testo. A preoccupare i comuni sono soprattutto due emendamenti approvati in commissione. Il primo all’art. 10 a norma del quale «i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed a interventi finalizzati al riuso e alla rigenerazione, nonché alla tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio» In secondo luogo a preoccupare sono le norme transitorie e finali (art. 11 ) secondo cui, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, e fino all’adozione dei provvedimenti volti alla riduzione del consumo del suolo, e comunque non oltre il termine di tre anni, «non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici».
I sindaci, invece, chiedono l’utilizzo senza limiti dei proventi dei titoli edilizi rilasciati per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione già realizzate. Opere che altrimenti andrebbero incontro a sicuro degrado, dequalificando l’ambiente urbano circostante e rendendo necessari ulteriori interventi di manutenzione straordinaria che comporterebbero maggiori oneri economici. Inoltre, il divieto triennale di consumo di suolo (tranne che per lavori e opere già inseriti negli strumenti di programmazione dei comuni) rischia di essere troppo penalizzante, soprattutto per i piccoli comuni. Perché per esempio renderebbe illegittima la rivendicazione dell’Imu su diritti edificatori previsti, ma non più attivabili. Prospettiva questa «dalle conseguenze economiche insostenibili per i mini-enti che si vedrebbero coinvolti in contenziosi fiscali infiniti, destinati a produrre mancate entrate per cifre esorbitanti».
A chiedere modifiche al ddl sono all’unisono Anpci e Anci. L’Associazione nazionale dei piccoli comuni, presieduta da Franca Biglio, ha scritto il mese scorso ai ministri dell’ambiente e dell’agricoltura Gian Luca Galletti e Maurizio Martina e ai presidenti delle commissioni VIII e XIII di Montecitorio Ermete Realacci e Luca Sani. Stessa cosa ha fatto il presidente dell’Anci, Piero Fassino, che ieri ha sollecitato una richiesta di incontro estesa anche ai ministri Graziano Delrio ed Enrico Costa. «Data la rilevanza socioeconomica della tematica», scrive Fassino, «e nell’intento di contribuire alla definizione di proposte concrete e utili alla soluzione di talune criticità dall’Anci evidenziate nonché emerse anche in incontri con altri soggetti di rappresentanza, ritengo urgente avviare un lavoro che possa portare alla condivisione di alcune correzioni».
L’Anpci, dal canto suo, pur apprezzando l’impianto generale del disegno di legge, ritiene assolutamente indispensabile che vengano garantiti i diritti acquisiti. Perché una loro compressione, sostiene Franca Biglio, «si porrebbe in contrasto con la generale politica di incentivo della crescita e dell’occupazione: obiettivo questo da tutte le istituzioni riconosciuto come un’esigenza vitale per il Paese». Oltre alle critiche degli enti locali, il ddl deve fronteggiare anche l’opposizione delle imprese. A guidare la protesta è stata Confindustria Cuneo che con il presidente, Franco Biraghi, ha da subito evidenziato come il testo in discussione alla camera, se non modificato, rappresenti «una vera iattura per l’economia e le pmi perché nessuno di noi potrà più programmare la propria attività e il proprio sviluppo aziendale. Da un giorno all’altro, infatti, potremmo sentirci dire che il terreno industriale acquistato in passato nella prospettiva di ampliare il nostro capannone improvvisamente è diventato agricolo. Chi investirà più?». Il ddl 2039, secondo Biraghi, essendo basato «su una pioggia di divieti per le attività economiche e soprattutto industriali», prevede «esattamente l’opposto di quanto invece servirebbe alle aziende in questo periodo, ossia agevolazioni di natura fiscale e ambientale, premiando per esempio le imprese che riutilizzano terreni dismessi, attività oggi improponibile per gli alti costi previsti dalle leggi attuali».
postilla
Più passa il tempo, più crescono le proposte di ulteriori correzioni, più cresce la nostra convinzione che questa legge non solo sia del tutto ininfluente ai fini del contenimento del consumo di suolo (si veda l'eddytoriale n.168 e i collegamenti che contiene) ma sia anzi un nuovo passo nella direzione del peggioramento delle condizioni di vita nelle città. Se si volesse davvero bloccare l'aggressione ai territori rurali bisognerebbe provvedere con un atto autoritativo dello Stato, nei modi che abbiamo più volte illustrato. Poiché sappiamo che questo è oggi del tutto utopistico riteniamo che sia meglio lasciare le cose così come stanno anziché peggiorarle ancora.

Una ragione in più per abbandonare alla critica roditrice dei topi il progetto di legge sul consumo di suolo. Il fatto è che una legge sull'argomento che si affidi alla catena decisoria governo>regione>comune in Italia non funzionerà mai. Lavoce.info, 9 febbraio 2016
Dal limite al consumo alla riduzione progressiva
Il progetto di legge sul contenimento del consumo del suolo presentato dal governo Letta agli inizi del 2014 (atto della Camera 2039/2014) ha ricevuto il via libera dalle commissioni Agricoltura e Bilancio; dopo il parere delle altre commissioni interessate, se ne inizierà a discutere in aula. Già il governo presieduto da Mario Monti aveva presentato un disegno di legge sullo stesso tema, decaduto con la fine della legislatura. Ora l’obiettivo è il medesimo: frenare l’edificazione di terreno agricolo e puntare in via prioritaria sulla riqualificazione e il riuso delle aree già edificate per soddisfare la domanda di spazi destinati ad accrescere l’offerta di case e capannoni e alla realizzazione di infrastrutture. I disegni di legge dei due governi hanno in comune anche la stessa architettura complicata e gerarchizzata delle procedure. I dubbi sull’efficacia dell’impostazione del primo si ripropongono, per certi versi amplificati, per quello ora all’esame del parlamento.
L’obiettivo di contenere l’uso di terreno agricolo per finalità diverse dalla produzione di derrate è oggi affidato all’emanazione di un decreto del ministero delle Politiche agricole (d’intesa con i ministeri dell’Ambiente, dei Beni culturali e delle Infrastrutture), con il quale determinare “la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale” (articolo 3, comma 1). Il progetto di legge del governo Monti si proponeva di stabilire “l’estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio nazionale”.
In entrambi i casi, il contenimento del consumo di suolo è un obiettivo che richiede tempo (d’altra parte il traguardo del consumo zero di suolo è posto dall’Unione Europea al 2050, una data lontana). Può esserci una differenza rilevante, però, tra porre un tetto al consumo di suolo vergine in un determinato arco temporale e stabilire di quanto il consumo deve ridursi. Nel secondo caso c’è il rischio che alla quantificazione si arrivi dando un peso maggiore al dato storico rispetto al fabbisogno di territorio agricolo per costruire case, capannoni e infrastrutture. Probabilmente, sul versante della comunicazione e del consenso politico, dire che il consumo di suolo si riduce di un X è più accattivante dell’affermare che, nello stesso arco di tempo, si consuma la quantità Y di nuovo suolo, anche se la prima procedura può portare a un consumo molto superiore della seconda.
Una procedura macchinosa
Il meccanismo, oltre a essere particolarmente macchinoso, rischia anche di consolidare la mappa del consumo disegnata dalle scelte fatte finora a livello locale. La quantificazione della riduzione a livello nazionale deve essere fatta applicando criteri e modalità stabilite dalla conferenza unificata Stato-regioni-enti locali (o dalla presidenza del Consiglio, se la conferenza non adempie entro un termine stabilito). I fattori da considerare per il calcolo sono indicati dalla legge (stato della pianificazione, caratteristiche dei suoli, estensione e localizzazione delle aree agricole, tra l’altro). Non sarà agevole individuare i parametri per identificarli e il peso da attribuire a ognuno di essi. Il risultato al quale si perverrà dovrà essere distribuito (con deliberazione della conferenza unificata) tra le regioni, le quali, a loro volta, indicheranno ai comuni le modalità per concorrere all’obiettivo.
Percentuali e valore assoluto
Il calcolo di un valore assoluto darebbe una maggiore affidabilità alla previsione della riduzione del consumo di suolo a livello nazionale. Ma non è per niente agevole determinare quel valore e non è semplice ripartirlo a livello territoriale. È più probabile, perciò, che l’obiettivo sia perseguito stabilendo una percentuale nazionale di riduzione del consumo che i comuni dovranno applicare a quello registrato da ciascuno in un certo arco temporale precedente. È certamente la via più semplice da percorrere, anche se la quantificazione della riduzione del consumo a livello nazionale potrà essere fatta solo a posteriori, sommando i “risparmi” dei singoli comuni. Non è, però, il solo inconveniente al quale si va incontro.
La percentuale nazionale di riduzione dovrà essere verosimilmente applicata in modo uniforme in tutti i comuni. Il che creerà un paradosso: i comuni che in passato hanno consumato più suolo, saranno quelli che continueranno a consumerne di più e contemporaneamente a risparmiarne di più. Per illustrare il paradosso, supponiamo che si decida una riduzione del consumo di suolo del 10 per cento in un dato periodo; e che nei comuni A e B il consumo di suolo, nell’arco temporale preso a riferimento, sia stato rispettivamente di 50mila e 10mila metri quadrati. Nel comune A si risparmiano 5mila metri quadri di terreno agricolo ma si continuano a utilizzarne 45mila, mentre nel comune B i metri quadri sono rispettivamente mille e 9mila. La geografia del consumo muterà con lentezza. Di conseguenza, continueranno a registrarsi gli eventuali squilibri del passato tra domanda e offerta di nuovi spazi per l’edificazione.
Riferimenti

Oasis, I, 3 mag.-giu. 1985
TERRITORIO SPAZIO DI VITA
ra che i giochi politici sono fatti vedremo se le promesse e le parole spese durante la campagna elettorale si tradurranno in programmi e azioni concrete: se cioè verrà affrontato il problema di fondo dell’ambiente italiano, il problema delle risorse scarse e del loro utilizzo ragionevole e parsimonioso.
La risorsa scarsa, limitata, irriproducibile per eccellenza è il suolo, il territorio: ogni sforzo dunque va fatto per porre fine al consumo irresponsabile che ne è stato fatto in decenni di sprechi, leggerezze e saccheggi.
Se si continuasse col passo attuale della cieca espansione edilizia, stradale, industriale eccetera, tra poco più di un secolo tutta l’Italia sarebbe ricoperta da una continua, ininterrotta, repellente crosta edilizia e di asfalto, tale da distruggere ogni produttività agricola e cancellare la stessa fisionomia paesistica, naturale, culturale di quello che fu chiamato il Bel Paese. Bisogna dunque che con l’aiuto di urbanisti ambientalisti ecologi, le pubbliche amministrazioni (comuni, province, comunità montane, regioni, eccetera) si decidano a fare sistematicamente i conti, a fornire le cifre relative al consumo di suolo e territorio perché tutti possano rendersi conto del disastroso traguardo che ci sta davanti se non si cambia rotta: un’Italia a termine, destinata ad essere tutta consumata e finita nelle prossime tre o quattro generazioni.
Gli amministratori sono restii a fare calcoli e a fornire le cifre, perché sono un essenziale strumento di conoscenza che può mettere in crisi il partito dei saccheggiatori: ma qualcuno ha cominciato a informare la pubblica opinione. I dati sono ancora parziali: ma come le “proiezioni” fatte alla televisione dopo la chiusura dei seggi elettorali esaminando un numero assai limitato di schede, già possono dare attendibili indicazioni su quello che sarà il risultato finale. Dunque, dai calcoli del CENSIS coi dati dell’ISTAT, risulta quanto segue.
Il suolo agricolo utilizzabile nell’ultimo decennio è diminuito del 9,4 per cento, perché distrutto dall’avanzare dell’urbanizzazione o perché abbandonato.
Regione per regione, è diminuito dell’8 per cento in Veneto e Lombardia, dell’11 per cento in Calabria, del 12 per cento in Liguria, Piemonte e Sicilia, del 16 per cento in Sardegna, del 17 per cento nel Friuli-Venezia Giulia. Nell’ultimo trentennio le aree non più classificabili come utilizzabili a fini produttivi hanno raggiunto la dimensione di circa 5 milioni di ettari (una superficie pari a Piemonte più Lombardia): il consumo è proceduto a un ritmo medio di 150.000 ettari all’anno.
In particolare, le aree antropizzate, cioè urbanizzate, sono raddoppiate: l’espansione delle città ha divorato la campagna al ritmo di 25-35.000 ettari all’anno. In sintesi, come ha calcolato Giuliano Cannata della Lega Ambiente, dal ’70 all’81 i terreni perduti perché abbandonati o occupati da edifici, strade, industrie, cave, discariche eccetera, sono passati dal 12,5 al 20,6 per cento del totale, pari a un consumo medio dello 0,7-0,5 per cento all’anno: nell’ultimo ventennio circa 3 milioni di ettari di terreni agricoli sono andati distrutti (e sono un decimo dell’Italia). Come a dire che se si continuasse ad andare avanti così, “tutto il territorio italiano, dal Cervino a Capo Passero, sarebbe finito in poco più di cento anni”.
Questa prospettiva suicida è il risultato di quella distorsione mentale che il CENSIS chiama “rimozione del territorio”. Con incoscienza l’abbiamo considerato come un vuoto da riempire, una res nullius, un oggetto di baratto e una fonte di lucro: i comuni hanno confezionato strumenti urbanistici grottescamente sovradimensionati, senza alcun rapporto coi reali fabbisogni, praticamente considerandolo tutto edificabile. Qualcuno ha calcolato che se si sommassero le cubature previste da piani regolatori e programmi di fabbricazione, l’Italia risulterebbe capace di ospitare, sulla carta, una popolazione superiore a quella degli Stati Uniti o dell’Unione Sovietica. Costruire il superfluo e l’inutile, questa la regola, e basta osservare quel che risulta dal censimento: in dieci anni la popolazione è aumentata di due milioni di abitanti, mentre sono state costruite 22 milioni di stanze, in buona parte seconde, terze, quarte case (per non parlare dell’enorme massa dell’abusivo): per cui oggi per 56 milioni di italiani ci sono più di 80 milioni di stanze.
Il deprimente spettacolo che offre il nostro Paese è sotto gli occhi di tutti. Un inverecondo sparpagliamento edilizio sommerge pianure e colline, abolendo ogni distinzione tra città e campagna e sommergendo le aree agricole, nell’ignoranza completa delle caratteristiche del suolo, nel disprezzo per gli aspetti paesistici, per l’ambiente naturale. L’edilizia dilaga a nastro lungo le strade, a ragnatela nelle periferie urbane: al costruito si accompagna l’asfalto, le discariche di rifiuti, in terreni vaghi, degradati, l’abbandono (a ogni ettaro costruito ne corrisponde mediamente un altro in attesa di essere liquidato).
È il “deserto abitato” che avanza nel disordine totale, rendendo a poco a poco irriconoscibile l’Italia: una clamorosa smentita alle regole elementari del vivere associato, un’incolta irrisione a ogni norma elementare di pianificazione urbanistica, una crescita dissennata che aumenta paradossalmente proprio mentre cala l’incremento demografico.
Una documentazione fotografica di questo dissesto territoriale, nella sua varia tipologia, sarebbe quanto mai utile in una rivista come questa.
Due sono le indagini recenti che danno un’idea drammatica della situazione: una riguarda l’area metropolitana milanese e la Lombardia in generale, l’altra la provincia di Roma. Come è stato documentato recentemente dal “Centro documentazione e ricerche” della regione Lombardia, nell’area metropolitana milanese (oltre un centinaio di comuni, 180.000 ettari) il consumo di territorio ha ormai raggiunto il 33 per cento, in nove anni (1963-1972) ne è stato distrutto più che nel secolo precedente, e si procede al ritmo dell’1 per cento all’anno, anche se è finita la grande espansione economica e demografica.
Il piano territoriale comprensoriale ha posto dei limiti alle previsioni comunali, e si propone di contenere l’espansione complessiva entro il 50 per cento, entro il duemila, che è già una “soglia di allarme”: se invece le cose continuassero ad andare per il verso sbagliato, osserva Gianni Beltrame, direttore del comprensorio, tutto il suolo verde e agricolo dell’area metropolitana milanese sarebbe finito entro 67 anni.
Al consumo di territorio per incontrollato avanzare di urbanizzazione, si aggiunge quello dovuto al degrado (brutta parola diventata ormai di uso comune), cioè a quell’insieme di interventi in vario modo offensivi e distruttivi, che vanno dall’attività selvaggia delle cave alle discariche di rifiuti all’isterilimento del suolo nelle sudice frange periurbane. Come ha osservato l’economista Mercedes Bresso al citato convegno, in Lombardia le cave, “vera e propria industria del dissesto”, compromettono circa 20.000 ettari, pari al 2 per cento della superficie regionale. Ad essi va aggiunto un 1-2 per cento di discariche e depositi di rifiuti, più un 8 per cento di “degrado diffuso” (spazi compromessi da utilizzazioni precarie, fasce di rispetto stradale, variamente occupate, depositi di materiali industriali, fabbricati in stato di abbandono eccetera): si arriva così all’11 per cento di territorio degradato, pari a circa 100.000 ettari, quasi il 10 per cento del suolo utile lombardo. Disordine, spreco, inquinamento delle falde idriche, erosione del suolo, distruzione di terreno agricolo: quanto costa il risanamento, il ripristino, il recupero di un terreno così devastato? Si valuta che il costo sarebbe di 35-40 milioni ad ettaro, quindi in Lombardia occorrerebbe spendere 3.500-4.000 miliardi, che diventano almeno 10.000 se l’operazione venisse estesa ai casi che richiedono interventi complessi (sgomberi, abbattimenti eccetera). Ecco quali sono i costi sociali scaricati sulla collettività dal saccheggio del territorio.
Altri dati allarmanti vengono forniti dall’indagine condotta dall’Assessorato al bilancio e programmazione della provincia di Roma, circa le destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici dei 118 comuni che la compongono. Il risultato è che, senza contare Roma, è prevista l’edificazione (tra zone di espansione, di completamento e turistiche) di 2.300 stanze per altrettanti abitanti: se si aggiungono i 7-800.000 vani residui previsti dal piano regolatore di Roma (tra edilizia privata e pubblica) si arriva a più di 3 milioni di stanze: come costruire ex novo un’altra Roma accanto all’esistente. A tanto può giungere il sonno della ragione, l’allegra incoscienza urbanistica (intanto, da anni, il territorio della provincia romana viene consumato al ritmo di tre ettari al giorno).
La prospettiva è dunque catastrofica: il “giardino d’Europa” corre alla rovina, e rischia di essere consumato entro poco più di un secolo, a meno che mentalità, cultura e politica non cambino radicalmente. Che fare? Occorre mettere finalmente da parte il mito anacronistico, folle e rovinoso della crescita illimitata fatta solo di sprechi, e decidersi a considerare il territorio come il bene più prezioso perché scarso e limitato, quindi come bene collettivo da conservare gelosamente. Non si salva ciò che non si conosce: è urgente impegnarsi alla conoscenza scientifica del territorio e del suolo nei loro aspetti produttivi, fisici, geomorfologici, ambientali, paesistici, naturalistici (uno studio del genere è stato fatto dal comune di Padova), e imparare a rispettarli.
Dobbiamo rovesciare il nostro modo di agire: non più urbanizzare alla cieca risparmiando eccezionalmente (quando pure a fatica ci si riesca) qualche area eminente, ma trattare tutto il territorio come un parco in linea di principio inedificabile, alla cui rigorosa salvaguardia subordinare ogni eventuale intervento. Altrimenti assisteremo alla distruzione del nostro stesso spazio di vita, e poco a poco la terra ci sarà strappata materialmente di sotto i piedi.
Ci siamo abituati: le "buone intenzioni" delle leggi sono fumo per nascondere misfatti. Cosi in questa legge della Liguria analizzata e denunciata. C'è un modo per resistere: i comuni, se vogliono, possono ancora salvare quel po' di Liguria che sopravvive. Questa denuncia è anche un appello.
La legge regionale 49/2009, nota come “Piano casa”, modificata con L.R. del 22 dicembre 2015 n. 22 in vigore dal 7 gennaio 2016, già dal titolo [1] denota quello che è: un pasticcio di avanzi riscaldati e in parte già avariati. Nata nel 2009 da una intesa [2] ipocrita e incostituzionale, possedeva il solo merito di avere una scadenza. Dopo anni di proroghe e di modifiche, nonostante non abbia sortito il successo promesso e creato solo ulteriori brutture, si ripropone peggiorata e soprattutto perenne.
L'attuale Giunta regionale, seppure mossa da obiettivi condivisibili (Lavoro, riqualificazione del patrimonio edilizio, e tutela del territorio dal rischio idrogeologico) pare non riesca ad esprimere nulla di nuovo e quindi debba riciclare, peggiorandoli, i provvedimenti fallimentari della precedente amministrazione, con l' evidente conseguenza che raggiungerà senza dubbio l'opposto dei nobili scopi esplicitati.
Né casa, né lavoro, né territorio tutelato.
Sappiamo già da tempo che il così detto piano casa non significava dare una casa a chi non ce l'ha. Per rimarcare con maggior coerenza tale impostazione, in questa versione della legge è stata eliminata completamente anche quella piccola quota di edilizia da destinare alla realizzazione di edilizia sociale, compresa la sua eventuale monetizzazione a favore dei Comuni.
Il piano casa consente solo a chi ha già una casa, o più case, o meglio ancora ville, di ampliarle in deroga ai piani regolatori comunali. I poveri continueranno a non aver casa, ma in compenso i ricchi possono aumentare le loro cubature e le loro rendite alla faccia dei regolamenti faticosamente adottati nei vari comuni, pagati e rispettati dagli altri cittadini.
Un'altra novità, carica di apporto “educativo”, introduce la possibilità a chi ha costruito abusivamente e condonato di poter usufruire di ampie premialità volumetriche; si potranno traslocare cubature sulle nostre fragili colline agricole e non contenti si potrà costruire finalmente anche nei parchi.[3]
Qualcuno dei fautori dell'attuale Piano Casa ha mai pensato di fare una valutazione costi/benefici prima di rilanciare il gioco? Mi pare proprio di no. Sul Piano Casa però non sono mancati i pareri degli esperti (dai giuristi ai sociologi ed economisti) e anche degli imprenditori più attenti e lungimiranti, e tutti hanno espresso pareri negativi.
Il territorio ligure, è ormai ciclicamente sempre più spesso devastato da eventi meteorologici violenti e improvvisi, che generano quello che tristemente sappiamo. Ormai basta poco, uno scavo, una villettina innocente, una pertinenzina sopra una linea ferroviaria, una stradina che si arrampica , per rompere il delicato equilibrio di un versante, per sfregiare un paesaggio, per compromettere un parco e un ecosistema, per mettere ancora più a rischio di frane e alluvioni la popolazione del fondo valle.[4]
Aumentare il carico e la volumetria degli insediamenti
non si traduce in un aumento automatico della ricchezza e del benessere per la popolazione e, tanto meno, in aumento di occupazione.[5] Chi invece pagherà i danni prodotti all’ambiente e al territorio da questo Piano Casa? Basta con il gioco delle contrapposizioni ambiente - salute e lavoro, non è più utile a nessuno, nemmeno al ricco che crede di potersi salvare fra le mura della sua villa “che cuba sempre di più”contornata da pertinenze condonate che potranno anche cambiare destinazione d'uso.
Occorre davvero ricordare ancora una volta che il problema casa nel nostro Paese non è affatto dato da un deficit di volumi, ma piuttosto dalla sua scadente qualità, dall'assoluta indifferenza alle sue caratteristiche energivore, dall'inesistenza di una politica di alloggi a basso costo. Non sarebbe più conveniente provare ad orientare e incentivare il lavoro qualitativo delle imprese per avere territori più sicuri, città più giuste e paesaggi più belli?
Non ci vuole molto a capire che questa legge non potrà mai raggiungere gli obiettivi in essa enunciati. Ma la questione più grave, che può passare in un primo tempo inosservata è contenuta nel secondo comma dell'art. 1. [6]
Il piano casa non è più strumento di deroga “temporanea” alla programmazione urbanistica comunale, ma diviene permanente, fino a quando gli strumenti urbanistici comunali non lo recepiranno al proprio interno, copiando le previsioni indicate, con il principio secondo cui o si inserisce com’è oppure si applica lo stesso.
Un ragionamento che rende permanente una deroga, (un controsenso), e nega la potestà al Comune di programmare lo sviluppo edilizio del proprio territorio in maniera diversa da quello che prevede questo provvedimento. Trasforma uno strumento, straordinario e limitato nel tempo, finalizzato ad un incremento dell'attività edilizia, in un nuovo atto perenne, parziale, inidoneo, generico, che prevarica la più specifica e adeguata programmazione comunale; non solo una palese violazione della possibilità dei Comuni di pianificare sul proprio territorio, ma certamente l'imposizione di regole, che per la loro astrazione risultano indifferenti alla conoscenza territoriale e vanificano per sempre gli sforzi degli Enti, compresa la Regione stessa, di pervenire ad una attenta, consapevole, corretta e democratica pianificazione urbanistica.[7]
Perché la pianificazione urbanistica.
Il governo del territorio si attua, di regola, attraverso piani. La collettività locale deve cioè prefigurare le proprie esigenze di tutela, di uso e di trasformazione del territorio attraverso atti giuridici vincolanti con “disegni ordinati di condotte future composte di più elementi combinati ...”(Giannini) che considerino la totalità dell’ambito spaziale di competenza (Corte costituz. n. 378 del 2000, n. 379 del 1994, 327 del 1990).
Ciò è stabilito con chiarezza lapidaria dall’art. 4, l. n. 1150 del 1942: “la disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali (…)”. E tutte le leggi regionali – comprese quelle di nuova generazione (approvate dopo la legge costituz. n. 3 del 2001) – sino a oggi hanno confermato, nonostante numerose differenze, la centralità dei piani nel governo del territorio.
La pianificazione costituisce un essenziale strumento per la conoscenza (fisica, culturale, economica ecc.) del territorio e delle sue dinamiche complessive ed è quindi una garanzia di razionalità dell’azione amministrativa. Ma - cosa ancor più importante - essa, dopo la Costituzione, invera il principio democratico, in primo luogo, perché è imputata a organi che rappresentano le collettività interessate (consiglio regionale, provinciale e comunale); in secondo luogo, perché le procedure di adozione e approvazione garantiscono trasparenza delle decisioni e partecipazione dei cittadini all’assunzione; in terzo luogo, perché il piano è lo strumento che assicura una relazione fisiologica tra ciascuna collettività locale (complessivamente considerata) e il territorio sui essa è insediata. Questo principio inoltre consente di governare il pluralismo amministrativo, evitando che si giunga alla frammentazione del territorio. Attraverso le procedure di adozione e l’efficacia differenziata (e reciproca) dei vari livelli di pianificazione (regionale, provinciale e comunale), le esigenze delle diverse collettività si armonizzano, dando vita a un contesto regolativo coerente.
Perché la pianificazione urbanistica comunale
Il piano è quindi il primo principio per una corretta e democratica gestione del territorio; il secondo principio fondamentale riguarda il ruolo centrale del Comune. Se in base al nuovo titolo V, parte II della Costituzione, Comuni, Province e Regioni, in quanto enti autonomi, devono essere titolari di funzioni amministrative relative all’assetto del territorio, in base al principio di sussidiarietà (art. 118, comma 1, Cost.), ai Comuni devono essere assicurate tutte le funzioni di pianificazione e di vigilanza che non necessitino di esercizio sovracomunale. In altri termini, la legislazione regionale deve individuare gli interessi che vanno amministrati nei piani regionali e provinciali, in quanto essenziali per le rispettive comunità; tutti gli altri devono di regola essere attribuiti ai “Comuni, principali titolari dei poteri pianificatori in materia urbanistica nonché dei poteri gestionali” (Corte costituz., n. 196/04).
In questa materia, come noto, l’autonomia comunale è stata ulteriormente rafforzata. Tanto è vero che, per opinione unanime, i compiti comunali di gestione del territorio sono oggi considerati come funzione fondamentale dei Comuni; funzione che, in quanto tale, è oggetto di legislazione esclusiva dello Stato e non può quindi essere oggetto di eccessiva compressione da parte della legislazione regionale (art. 117, 2 c., lett. p, Cost.).
In base a questo principio, quindi, è precluso alle leggi regionali di privare i piani urbanistici comunali di adeguati ed effettivi spazi di manovra, potendo, al più, prevedere la sottrazione di alcune competenze in considerazione di “concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione più ampia delle esigenze diffuse nel territorio” (Corte costituz. n. 378/00 cit.). Le leggi regionali sono tenute cioè a valutare “la maggiore efficienza della gestione a livello sovracomunale degli interessi coinvolti” (Corte costituz. n. 286 del 1997), e non possono in alcun caso rendere inoperanti i piani comunali che – essendo espressione di funzioni fondamentali – sono garantiti direttamente dalla legge statale, in funzione dell’autonomia comunale.
In sintesi, questo principio preclude alle norme regionali di consentire l’autorizzazione di trasformazioni (rilevanti come nella fattispecie) che non siano il frutto di una preventiva, adeguata e specifica ponderazione degli effetti sul territorio e sulla collettività insediata, attraverso un procedimento ispirato a rigidi criteri di pubblicità e imputato a organi che siano espressione diretta della collettività interessata.
Motivi di incostituzionalità
La legge 49/2009 come modificata dalla L.R. del 22 dicembre 2015 n. 22, presenta , quindi, indubbiamente diversi motivi di palese incostituzionalità. In primo luogo si pone in contrasto con l’art. 118 della Costituzione che definisce in linea generale l’attribuzione delle funzioni amministrative ai Comuni in attuazione del principio di sussidiarietà, successivamente con l’art. 117, comma 6 che attribuisce ai Comuni autonomia regolamentare delle funzioni a loro attribuite e con l’art. 117 comma 3 che mette il Governo del territorio tra le materie concorrenti tra Stato e Regioni e non in ultimo con l’art 117, comma 2, lettera S: nella parte in cui, avendo eliminato dalla legge 49/2009 la disposizione che ne escludeva l’applicabilità ai parchi, sembra volere una estensione della efficacia delle previsioni derogatorie anche all’interno degli stessi.
…ADOTTARE SUBITO UNA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE per.....
In attesa che questa legge venga (si spera) fermata per le palesi illegittimità che essa manifesta, i sindaci liguri, se non vogliono dimostrare indifferenza e accidia verso il loro territorio e far perdere al loro comune e ai loro cittadini la potestà di gestirlo divenendo sudditi dell'Amministrazione regionale, devono entro il 7 marzo adottare una delibera ai sensi dell’articolo 12 (Disposizioni transitorie) della L.R. n. 22/2015 per :
a) individuare le parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3 bis della L.R. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
b) stabilire la superficie minima delle unità immobiliari derivanti dal frazionamento degli edifici oggetto di ampliamento o di mutamento di destinazione d’uso di cui agli articoli 3 e 3 bis della L.R. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
c) individuare le aree del proprio territorio nelle quali non è consentito il frazionamento degli edifici oggetto di ampliamento o di mutamento di destinazione d’uso di cui agli articoli 3 e 3 bis della L.R. 49/2009 e s.m.e i. stabilendo altresì che fino all’assunzione delle determinazioni comunali di cui sopra o fino alla scadenza del termine di sessanta giorni ivi previsto, non trovano applicazione gli articoli 3, 3 bis, 4 e 5 della L.R. 49/2009 come modificati o introdotti dalla L.R. 22/2015, ma continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 49/2009.
Si ribadisce che “il potere dei Comuni di autodeterminarsi in ordine all’assetto e alla utilizzazione del proprio territorio non costituisce elargizione che le Regioni, attributarie di competenza in materia urbanistica, siano libere di compiere. Si tratta invece di un potere che ha il suo diretto fondamento nell’art. 128 della Costituzione, che garantisce, con previsione di principio, l’autonomia degli enti infraregionali, non solo nei confronti dello Stato, ma anche nei rapporti con le stesse Regioni, la cui competenza nelle diverse materie elencate nell’art. 117, e segnatamente nella materia urbanistica, non può mai essere esercitata in modo che ne risulti vanificata l’autonomia dei Comuni” (Corte Costituzionale - Sentenza n. 83/1997).
…..RENDERE IL PIÙ POSSIBILE INNOCUO QUESTO SCIAGURATO PREVARICANTE ed INIQUO “PIANO CASA”.
NOTE
[1] “Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico – edilizio)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, Parte I, Anno XLVI - N. 22 del 23.12.2015 (allegato il testo coordinato)
[2] Il 31 marzo 2009 si è giunti a un’Intesa in sede di Conferenza unificata; intesa ai sensi dell’art. 8, l. n. 131 del 2003, per “favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni”. Si è trattato quindi di un accordo politico. In base all’intesa, le Regioni si sono impegnate ad approvare nel termine di 90 giorni leggi che: a) consentano interventi fino al 20% della volumetria di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi per un massimo di 200 metri cubi, al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica; b) consentano, allo stesso fine, interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35%; c) semplifichino e accelerino l'attuazione di detti interventi.
Le leggi regionali potevano però individuare ambiti in cui detti interventi fossero esclusi o limitati; tali interventi inoltre, salva diversa decisione, potevano avere validità temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi. In caso di inerzia o ritardo il Governo e il presidente della Giunta regionale interessata “determinano le modalità procedurali idonee ad attuare compiutamente l'accordo, anche ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003”.
Il Governo, dal suo canto, si era impegnato a emanare, entro 10 giorni, un decreto legge “i cui contenuti saranno concordati con le Regioni e il sistema delle autonomie” per “semplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello Stato” e per “rendere più rapida ed efficace l'azione amministrativa di disciplina dell'attività edilizia”. Il decreto legge non è stato emanato, anche perché non si è trovato un accordo sul suo contenuto con le Regioni e con il sistema delle autonomie. Non di meno ad oggi le Regioni hanno legiferato sul punto, in maniera ovviamente disomogenea. Dal sito di www.eddyburg.it
[3]«Nella lettera inviata da FAI, Italia Nostra, WWF, LIPU e Legambiente ai Presidenti dei Parchi Nazionali e Regionali infatti si chiede con allarme e giusta urgenza che nelle loro aree protette non siano applicate le nuove norme del Piano Casa regionale, che consente anche lì interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d’uso di fabbricati non residenziali. I parchi sono infatti ciò che di più prezioso e tutelato abbiamo in merito ai beni paesaggistici. Se dovesse passare la concezione che perfino queste aree protette, già istituite, possano essere a rischio di interventi invasivi, questo non solo sarebbe in contraddizione con lo spirito e con gli obbiettivi della legge sul consumo di suolo che presto arriverà in Parlamento, ma costituirebbe un precedente pericoloso per tutto il paesaggio italiano».(ANSA).
[4]«Come Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio non posso che condividere l’allarme lanciato questa mattina da tutte le più rappresentative associazioni ambientaliste italiane sull’impatto che la nuova legge sul Piano Casa della giunta regionale della Liguria potrà avere sulla tutela delle aree protette di quella regione, il cui territorio ha già drammaticamente mostrato la propria fragilità». Così dichiara Ilaria Borletti, sottosegretario Ministero dei Beni Culturali e del Turismo con delega al Paesaggio. «La Liguria – conclude il sottosegretario Borletti — ha nel suo paesaggio una straordinaria ricchezza, che se valorizzata e prima di tutto tutelata può essere volano di turismo e sviluppo per il territorio».(ANSA).
[5]“E’ evidente il fallimento delle prospettive e del modello di sviluppo immaginato nel Piano casa – afferma il presidente di Legambiente Liguria - e non è con una semplificazione delle norme, che valuteremo non si tratti di una vera e propria deregulation cementizia, che si rilancerà l’edilizia. Occorre piuttosto un Piano di adattamento e mitigazione del dissesto idrogeologico per la sicurezza dei centri urbani, che coinvolga pubblico e privato per garantire un rilancio economico della nostra regione.(ANSA).
[6]art.1 comma 2. “Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina dei piani urbanistici comunali vigenti e di quelli operanti in salvaguardia fino all’inserimento nel piano urbanistico comunale vigente o nel piano urbanistico comunale da adottare ed approvare ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni della specifica disciplina di agevolazione degli interventi di adeguamento e di rinnovo del patrimonio urbanistico-edilizio esistente con particolare riguardo agli immobili in condizioni di rischio idraulico ed idrogeologico o di incompatibilità paesaggistica e urbanistica in conformità alle regole e alle misure di premialità previste dalla presente legge e tenuto conto dei caratteri ambientali, paesaggistici ed urbanistici del proprio territorio.”
[7]«Il cosiddetto piano casa elaborato dalla Giunta regionale si configura come un vero e proprio superamento dell’ordinaria pianificazione urbanistica in Liguria. Una prospettiva che non può che suscitare preoccupazione». Lo afferma in una nota l’Istituto Nazionale di Urbanistica”.
QUI il pdf del testo della legge regionale 3 novembre 2009, N. 49 coordinato con la legge regionale 22 dicembre 2015, N. 22
L'articolo è stato inviato contemporaneamente a Informazione sostenibile on line
«Intendiamo produrre conoscenza, non apparenza, perché solo il rigore dello studio e della ricerca e l’applicazione costante al lavoro possono portare a uno sviluppo coerente e sostenibile, verificabile in itinere e, perciò, correggibile». La Repubblica, ed. Firenze, 28 gennaio 2016
L’intervento di
Tomaso Montanare coglie nel segno. Pistoia non è e non sarà la riproduzione miniaturizzata di se stessa nei gadget delle bancherelle e nei souvenir turistici. È una città apasso d’uomo, dalle antiche origini contadine, che ancora si riconoscono nel suo carattere riservato e persino introverso. Pur integrata nell’area metropolitana che arriva sino a Firenze, Pistoia ha preservato – grazie anche all’eccellenza produttiva del vivaismo – il confine tra il tessuto urbano e la campagna, quel limite che fonda e costituisce la città.
Ci siamo candidati convinti che una comunità, per promuovere se stessa, non debba presentarsi diversa da com’è, ma valorizzare le proprie caratteristiche e peculiarità: i progetti presentati sono il frutto di un lavoro intenso e spesso silenzioso che ha unito ed appassionato le tante anime della città. Abbiamo concorso non per trasformarci in un conglomerato fluttuante di turisti chiassosi e scomposti, ma perché orgogliosi di poter mostrare le nostre ricchezze e i nostri progetti. Intendiamo produrre conoscenza, non apparenza, perché solo il rigore dello studio e della ricerca e l’applicazione costante al lavoro possono portare a uno sviluppo coerente e sostenibile, verificabile in itinere e, perciò, correggibile.
Siamo convinti che il sapere e la cultura siano i primi e più significativi fattori per l’emancipazione di tutti gli umani, lievito per la crescita e la formazione di cittadini liberi e consapevoli, di cittadini democratici: la cultura come diritto di cittadinanza. Per questo, la cultura, in tutte le sue espressioni, costituisce la fonte ispiratrice di ogni nostra azione politica e di governo.
Per questo, il lavoro di restauro e recupero del patrimonio storico-artistico è stato ed è impegno prioritario per l’amministrazione: abbiamo già restituito alla città la chiesa di Santa Maria del Soccorso, il Chiostro di San Lorenzo, a breve recupereremo Sant'Jacopo in Castellare, la Saletta Gramsci, l’antica chiesa di San Salvatore e San Pier Maggiore. Il progetto di rigenerazione del Ceppo, che ci vede impegnati al fianco della Regione Toscana e dell’Asl, vedrà l’intera area monumentale del vecchio ospedale passare in proprietà al Comune di Pistoia, trasformata nel più importante polo museale cittadino. Qui sorgerà anche la Casa della Città, un urban-center che diventerà il cuore pulsante della partecipazione attiva dei pistoiesi alla vicenda pubblica.
La città è il primo dei beni che abbiamo in comune, spazio pubblico e luogo di esercizio diffuso della democrazia. Per assicurarne la cura è indispensabile una comunità partecipe e vigile, aperta e curiosa del mondo, che non cessi di interrogarsi sul proprio futuro. Per questo diamo vita ogni anno ad un appuntamento di riflessione critica sulle trasformazioni urbane, che consente anche una costante verifica dell’azione dell’amministrazione, leggere la città, nel corso del quale saremmo lieti di poter accogliere le stimolanti riflessioni di Tomaso Montanari, preziose anche per il lavoro che ci attende da qui al 2017.
Articoli di Gianmario Leone e Paolo Berdini. Il manifesto, 22 gennaio 2016
LA CONSULTA BLOCCA RENZI
di Gianmario Leone
«Asfaltato. Il contenzioso con il governo era nato a causa del mancato coinvolgimento della regione sulla realizzazione dell’autostrada Napoli-Bari. Il provvedimento è «incostituzionale». Dopo il via libera al referendum sulle trivellazioni, i giudici bocciano anche lo Sblocca Italia. Accolto il ricorso dell’ex governatore Vendola»
È una vittoria politica postuma, ma non per questo di minore importanza. La Corte Costituzionale ha infatti accolto il ricorso che la Regione Puglia presentò il 9 gennaio dello scorso anno, quando al governo c’era ancora Nichi Vendola, contro il decreto «Sblocca-Italia» in merito a quanto previsto nell’articolo 1 in materia di «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive».
Al centro del contendere, questa volta, non ci sono i permessi per effettuare indagini esplorative alla ricerca di petrolio e gas in Mar Adriatico e Mar Ionio, ma la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, previste dal Programma Infrastrutture Strategiche (disciplinato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443) e l’approvazione dei contratti di programma tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) e i gestori degli aeroporti di interesse nazionale. Il decreto «Sblocca Italia» infatti, da un lato ha affidato allo Stato la redazione del Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria di interesse nazionale o europeo senza prevedere l’intesa con la Regione interessata, dall’altro nelle materie del governo del territorio e dei porti e aeroporti civili, ha concesso allo Stato di esercitare la funzione amministrativa senza alcun coinvolgimento della Regione interessata.
Secondo la Regione Puglia, anche in base alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte Costituzionale, nell’ambito di tali materie sarebbe preclusa allo Stato l’allocazione a livello centrale delle funzioni amministrative, se non mediante una chiamata in sussidiarietà e nel rispetto delle garanzie partecipative previste a tal fine a favore delle Regioni interessate. Nei commi 2 e 4 dell’art. 1 del decreto impugnato, queste garanzie non sono osservate, perché la Regione può intervenire nella fase di approvazione e di esecuzione dei progetti solo in sede di conferenza di servizi, e, nel caso di un suo dissenso, che è preordinato al raggiungimento di un’intesa tra Stato e Regione, troverebbe applicazione solo quando il dissenso concerne la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, ovvero la tutela della salute e della pubblica incolumità. Per questo la Regione Puglia ha evidenziato nel ricorso la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto proprio grazie a quanto previsto dai commi 2 e 4 dell’art. 1 dello «Sblocca Italia», è stata operata una chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative senza il necessario coinvolgimento delle Regioni interessate, nella forma dell’intesa.
Secondo la Corte Costituzionale, il Piano di ammodernamento della rete ferroviaria non ha ad oggetto specifiche opere, ma la sola individuazione dei tratti della rete bisognosi di intervento, e concerne perciò una prospettiva necessariamente unitaria, che non si presta ad essere parcellizzata con riferimento alla posizione di ciascuna Regione. È per questa ragione che la sede naturale ove raggiungere l’intesa deve ravvisarsi nella Conferenza Stato-Regioni. In merito alla determinazione dei diritti aeroportuali e alla redazione dei piani di intervento sulle infrastrutture invece, la Corte sottolinea che verificandosi un concorso tra competenze esclusive statali («tutela della concorrenza») e competenze regionali («porti e aeroporti», e «governo del territorio»), che non può essere disciplinato secondo il criterio della prevalenza ed esige quindi l’introduzione di moduli collaborativi. Per questi motivi la sentenza n. 7 depositata ieri, ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 dello «Sblocco Italia» nella parte in cui «non prevede che l’approvazione del Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria avvenga d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e nella parte in cui, ai fini dell’approvazione, non prevede il parere della Regione sui contratti di programma tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale».
Uno smacco notevole per il governo, che ora dovrà rimettere mani al provvedimento tanto discusso. Soddisfazione per Vendola, che ricorda come il ricorso fu presentato «per assicurare che i territori abbiano voce quando si prendono decisioni strategiche e delicatissime sul destino delle loro risorse naturalistiche e bellezze paesaggistiche», senza contraddire i principi di partecipazione e leale cooperazione cardini di un sistema decisionale democratico che non possono favorire «gli appetiti famelici delle lobbies economiche
TACERE E OBBEDIRE
È LO SBLOCCA ITALIA
di Paolo Berdini
«Governo. Lo schiaffo a Renzi della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimi molti commi dell’articolo 1 del decreto legge 133/2014»
C’è ancora un giudice a Berlino. Matteo Renzi e il cerchio magico che ha scritto lo Sblocca Italia hanno subito un sonoro e meritato ceffone da parte della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi molti commi dell’articolo 1 del decreto legge 133/2014. Con il comma 1 si affidava all’Amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato il ruolo di Commissario straordinario per la realizzazione del collegamento veloce tra Napoli e Bari. Un’opera fondamentale per dare qualche opportunità ad una parte del sud Italia e sulla cui realizzazione c’era il generale consenso delle Regioni coinvolte.
Il ricorso della regione Puglia riguardava il rispetto della Costituzione poiché aveva il diritto di esprimere le sue volontà nella definizione delle caratteristiche e del tracciato dell’opera. Quell’articolo non lo permetteva umiliandola nel ruolo ancillare di chi è chiamato a sottoscrivere un atto senza fiatare.
Tacere ed obbedire, questa è la concezione della democrazia per Matteo Renzi: un plauso dunque all’ex presidente Vendola che si è appellato alla Corte ottenendo la cancellazione di molti commi di quell’articolo.
Durante la discussione parlamentare un autorevole gruppo di giuristi come Paolo Maddalena, urbanisti come Vezio De Lucia e di uomini di cultura come Salvatore Settis aveva dato vita ad una serie di contributi critici che vennero meritoriamente pubblicati da Altreconomia con il geniale titolo «Rottama Italia». Se il governo avesse avuto la sensibilità di leggere le critiche o chiamare quei personaggi in audizione ci sarebbe stato il tempo per correggere errori così grossolani. Nel volume Maddalena già affermava infatti che quell’articolo era incostituzionale perché non rispettava il ruolo delle Regioni. Ma l’ordine del cerchio magico è sempre e solo quello di ignorare le buone ragioni della società civile ed ha imposto la decretazione d’urgenza. Del resto, il ministro competente all’epoca era quel Maurizio Lupi che solo dopo poco tempo si sarebbe dimesso per una vicenda molto poco commendevole.
Questo pacchetto di gladiatori esce con le ossa rotte dalla vicenda: con la sentenza n. 7/2016 pubblicata ieri, la Corte Costituzionale nel ribadire il diritto del governo a definire le opere strategiche per il paese, afferma nel contempo che deve farlo coinvolgendo le Regioni come prevede l’articolo 117 della Costituzione. Chissà perché i consiglieri del presidente Napolitano non si sono accorti di una stesura cosi eversiva.
Due ulteriori considerazioni. La prima riguarda l’esistenza di una assoluta uniformità di cultura del territorio tra il Pd e la destra. L’ex presidente della Campania Caldoro non ha avuto la stessa sensibilità istituzionale della Puglia e non si è appellato: il partito della nazione faceva evidentemente le prime concrete prove di unità d’azione. La seconda riguarda una questione non più rinviabile: l’opera ferroviaria era stata decisa sulla base della Legge Obiettivo (241/90) voluta da Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti che ha cancellato molte regole di trasparenza, e provocato vergognose ruberie e scempi ambientali. Una legge definita da Raffaele Cantone come «criminogena». La Corte Costituzionale ha compiuto il suo dovere cancellando le norme sbagliate. E’ ora che il Parlamento cancelli quella legge: da quindici anni l’Italia realizza grandi opere con una legge che tutela il crimine invece degli interessi pubblici.
Sappiamo che il sempre più irrequieto primo ministro non metterà quest’ultimo punto tra le sue priorità. Aspettiamoci anzi che dopo lo schiaffo al corpo diplomatico il premier nomini il fidato Marco Carrai a presiedere la Corte. Lo so che non si può fare, ma per Matteo Renzi nulla è impossibile, almeno fino al voto degli italiani sul referendum contro lo scempio delle ”trivelle libere” contenuto sempre nello Sblocca Italia.

Il Senato ha approvato il via definitiva la Legge Delega per il recepimento di tre direttive europee (n. 23/14, 24/14 e 25/14) in materia di appalti e concessioni e la revisione completa del Codice Appalti del 2006. La Legge Delega, molto dettagliata, consente al Ministro Delrio di scrivere la norma attuativa che entro il 18 aprile dovrà recepire le tre direttive ed entro il 31 luglio 2016 riscrivere l’intero Codice degli appalti, servizi e concessioni. Ma il Ministro potrà anche scegliere di concludere recepimento e riforma entro il 18 aprile, che sarebbe la soluzione più efficace e semplice per i soggetti attuatori e per il mercato degli appalti.
La legge Delega, approvata anche sulla spinta di scandali e corruzione sulle grandi opere, contiene senza dubbio molte cose utili ed opportune, come il potenziamento dei poteri di intervento e controllo dell’Autorità Anticorruzione, una stretta sulle varianti e la centralità del progetto, la riduzione delle stazioni appaltanti, l’incremento dei poteri di vigilanza pubblici sul contraente generale, un incremento della messa a gara delle opere delle concessionarie.
Altre novità importanti riguardano una forte limitazione del massimo ribasso come criterio di aggiudicazione e l’inserimento di punteggi più elevati per i beni e servizi con minore impatto ambientale e maggiore efficienza, basato anche sul costo dell’intero ciclo di vita. Viene inserito anche il dibattimento pubblico, come uno strumento di informazione, dialogo e trasparenza verso le popolazioni interessante dai progetti e dalle grandi opere.
Una stretta viene data anche al direttore dei lavori, che si ricorderà nel caso della Legge Obiettivo veniva scelto dal General Contractor, con gli effetti nefasti ben descritti dall’inchiesta sulle grandi opere cha ha travolto il Ministero dei Lavori Pubblici: adesso sarà scelto in modo trasparente dalla pubblica amministrazione. (questa norma è già immediatamente operativa)
Interessante e positiva anche una clausola sociale inserita per premiare nei bandi chi assume i lavoratori del medesimo appalto (di un altro lotto completato) ai fini della tutela occupazionale: una norma chiesta da tempo da sindacati e lavoratori, per dare un po di stabilità ai lavoratori delle costruzioni. Ovviamente questa clausola sociale sta facendo molto discutere, con posizioni anche molto critiche da parte del mondo delle imprese. Altra norma positiva è l’indicazione per una disciplina organica della gestione delle risorse idriche che sia rispettosa degli esiti del referendum del 12-13 giugno 2011, e quindi che resti in mano pubblica.
Il superamento della Legge Obiettivo.
Una positiva novità contenuta nel testo approvato è il superamento della Legge Obiettivo 443/2001. Non solo, si prevede anche l’aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica del 2001, la riprogrammazione delle risorse alle opere sulla base dei criteri individuati nel “Documento Pluriennale di pianificazione (DL 228/2011)” nonché l’applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione di impatto ambientale (VIA).
L’ultima parte del testo prevede “norme transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti” e la ridefinizione della “famosa” struttura tecnica di missione del Ministero. Come dire che la strada per uscire dalla legge Obiettivo non sarà semplice, dato che ormai parliamo di una mostruosa lista di 419 opere per un valore di 383 miliardi, di cui decine di opere hanno già il progetto definitivo e spesso anche il soggetto realizzatore (Concessionarie, RFI, Anas, imprese private). Del resto anche la prima selezione adottata dal Governo nell’ambito del DEF per 25 opere prioritarie contiene diversi progetti sbagliati come la TAV Milano-Genova e la Torino Lione, le autostrade Pedemontana Lombarda e quella Veneta.
Proprio per questo la scelta di superare la Legge Obiettivo è indispensabile ed opportuna, per tornare a ragionare di politica dei trasporti entro cui collocare la lista delle opere utili, per restituire ai territori la possibilità di decidere sui progetti, per eliminare definitivamente tante autostrade inutili come la Orte-Mestre o il Tibre Parma-Verona, per restituire centralità alle opere per la riqualificazione ed i servizi delle città, la vera priorità, per applicare la VAS sulla pianificazione delle infrastrutture (che mai è stata applicata).
Regole deboli verso le concessionarie
In materia di regole destinate alle concessioni invece gli strumenti di governo e controllo pubblico restano deboli. Da un alto si invocano gare per la scelta del concessionario, senza proroghe, e si richiama anche “il rischio operativo” che deve restare in capo alla concessionaria come prescritto dalla Direttiva 23/2014, ma poi si consentono diverse eccezioni. Per esempio l’obbligo di gare per le concessioni, incluse quelle autostradali, solo per quelle che scadono tra 24 mesi. E questo significa che le gare non si applicano a quelle scadute o in scadenza (esempio AutoBrennero SpA ed Autovie Spa).
Altro distinguo è in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 23/2014 - che prevede che si possa affidare direttamente da una amministrazione o ente aggiudicatore ad una propria società in house un servizio su cui effettuare il controllo analogo - affidando le concessioni a società interamente pubbliche. Ed il Ministro Delrio sta lavorando con Autobrennero ed Autovie proprio a questa soluzione, escludendo il ricorso alla gara. Sarà possibile dunque sulla base delle regole europee affidare una nuova concessione diretta da parte dell’Autorità pubblica ad una Società pubblica, ma con diverse precauzioni per evitare distorsioni che nella Legge Delega non sono stati inserite. Ma che dovranno essere comunque applicate per essere coerenti con le Direttive da recepire.
Per la Direttiva le concessioni sono di norma quinquennali a meno che investimenti non giustifichino in modo motivato periodi più lunghi. Tutti i lavori e l’acquisto di servizi realizzati dalla concessionaria pubblica debbono essere sottoposti a gara. Nel caso di AutoBrennero per esempio la concessionaria ha vinto insieme a soggetti privati la realizzazione di tre nuove tratte autostradali sottoposte a gara in project financing (Cispadana, Campogalliano-Sassuolo e Ferrara-Mare). Deve risultare evidente che la nuova concessione affidata direttamente alla società madre in house non deve coprire e sussidiare in alcun modo gli impegni assunti con il bando di gara e relativo contratto di queste tre opere, dove il rischio operativo deve restare a carico delle tre concessioni specifiche. Altrimenti si configurerebbe una distorsione della concorrenza a posteriori rispetto agli altri concorrenti risultati perdenti alle tre gare. Ci sarà molto da discutere anche in sede Europea su come l’Italia intende applicare questa norma sulle concessioni in house.
Per quanto riguarda infine i lavori delle concessionarie, la legge delega ha previsto che l’80% dei lavori dovrà essere messo a gara (oggi è il 60%) ma è stato ridimensionato il 100% previsto inizialmente ed allungati i tempi di adeguamento a questa norma, passati da 12 a 24 mesi. Inoltre questo obbligo di mettere una parte dei lavori a gara sul mercato non si applica per le concessioni che hanno vinto o vinceranno una gara affidate con la formula della finanza di progetto o della concessione affidata con gara.
Adesso approvata la Legge Delega, dovremo attendere i decreti attuativi dei prossimi mesi per verificare la coerenza sia con le direttive e sia con i criteri di delega decisi dal Parlamento. Decreti che dovranno superare anche il doppio parere delle Commissioni Parlamentari. Perché è importante che i criteri si trasformino in regole efficaci contro la corruzione e per il superamento della Legge Obiettivo.
Greenreport, 7 gennaio 2016
Il lungo articolo di Enzo Valbonesi comparso il 30 dicembre su “greenreport” rappresenta una replica – a tratti quasi punto per punto – a un mio ancor più ampio e articolato saggio-denuncia apparso su eddyburg il 14 dicembre alla cui lettura non posso che rimandare.
Valbonesi è figura storica e di prestigio indiscusso nel mondo delle aree protette italiane e le sue osservazioni meritano quindi una seria e argomentata replica. Egli invita in apertura a “riaccendere il dibattito” sulle aree protette e io intendo prenderlo in parola chiedendogli sin d’ora di perdonare la schiettezza di qualche passaggio. Il dibattito non ha peraltro particolare bisogno di essere riacceso perché nel corso degli ultimi cinque anni esso è divampato furiosamente in molte sedi senza peraltro riuscire minimamente a influenzare l’impostazione dei “riformatori” della legge quadro sulle aree protette, impostazione che è rimasta infatti sempre la medesima. Il testo di “riforma” della 394 è riuscito anzi a passare, nel cambio di legislatura del 2013 da un proponente del partito di Berlusconi (Antonio D’Alì) a un relatore del Partito Democratico (Massimo Caleo) senza subire alterazioni realmente sostanziali, a testimonianza di una convergenza bipartisanindifferente a qualsivoglia suggerimento di modifica o osservazione critica.
A dare la misura del livello di scontro creatosi al riguardo sta, come ho già avuto modo di notare su eddyburg, l’ormai leggendario scambio di stoccate di fine 2011 tra associazioni ambientaliste (Fondo per l’ambiente italiano, Italia Nostra, Mountain Wilderness, Lega per la protezione degli uccelli e Wwf da un lato, Legambiente e Federparchi dall’altro) nel quale gli “innovatori” sono arrivati a dare delle “giovani marmotte”, portatrici di un “ambientalismo alla Disney”, a coloro che criticavano nel merito la “riforma”. Lo scontro è proseguito in questa legislatura – anche se Legambiente sembra essersi defilata – e oggi si concentra su quello che dovrebbe essere il testo unificato di tre disegni di legge, ma che in realtà non prende in alcuna considerazione le correzioni apportate dal ddl De Petris ad alcuni degli errori più gravi contenuti nell’originario ddl D’Alì e nel ddl Caleo.
Tutto l’intervento di Valbonesi – ma ci tornerò in chiusura, perché è un punto assai ricco di implicazioni – ruota attorno alla parola chiave dell’“innovazione”: per poter difendere le nostre aree protette sarebbe infatti fondamentale “innovare” e la “riforma” D’Alì/Caleo, quale emerge dal testo unificato, è in questo senso sicuramente la “cosa giusta”, una proposta cioè che cambia le cose giuste nel modo giusto.
Sono anni al contrario che la più gran parte dell’associazionismo ambientalista, delle personalità del mondo della culturae degli esperti insiste sul fatto che i punti salienti della proposta sono sbagliati – e anche su questo tornerò – ma è altrettanto interessante osservare come la “riforma” D’Alì/Caleo ignora completamente i problemi fondamentali in cui si dibattono oggi le aree protette italiane. In un volume collettivo edito dal Gruppo di San Rossore freschissimo di stampa (Cosa urge per i parchi, Pisa, ETS, 2016), ad esempio, l’ex direttore del Parco nazionale della Maiella Nicola Cimini indica in modo analitico molti di questi problemi, soprattutto in campo gestionale, e fa proposte precise e concrete per avviarli a soluzione. Ebbene: è opera assai ardua trovare qualche punto di contatto tra queste proposte, che vengono da una lunga e sofferta esperienza di gestione di parchi nazionali, e il testo difeso da Federparchi.
Valbonesi inoltre, e a mio avviso in modo del tutto corretto, osserva come uno dei problemi principali delle aree protette italiane non è una pretesa mancata applicazione della legge quadro del 1991 ma sono piuttosto le mutilazioni che essa ha subito proprio negli anni immediatamente successivi alla sua approvazione. L’abrogazione del comitato paritetico stato-regioni e quella del programma triennale nazionale delle aree protette hanno ad esempio vanificato la possibilità di creare un “sistema nazionale delle aree protette” e nella stessa direzione sono andate l’abrogazione del Comitato e della Consulta tecnica per le aree naturali protette e la mancata realizzazione della Carta della natura. Sono in questo modo saltati alcuni capisaldi cruciali per un’efficace politica nazionale delle aree protette e la deriva attuale è anche figlia di queste sciagurate decisioni. Una riforma veramente innovativa e attenta alle esigenze delle aree protette italiane dovrebbe necessariamente prevedere la reintroduzione di una visione e di strumenti di questo genere ma anche in questo caso è impossibile trovare traccia di tutto ciò nella “riforma” D’Alì/Caleo che oltre tutto sul programma triennale compie un pasticcio: si dimentica che il programma è stato soppresso nel 1998 dal decreto legislativo 112 (se lo era invece ricordato, inascoltato, il ddl De Petris) e invece lo introduce per le aree protette marine. E per spingersi ancora oltre si può osservare come le più importanti esigenze segnalate da tempo dallo stesso Valbonesi (strategia nazionale per la conservazione della biodiversità, armonizzazione con le strategie comunitarie e mondiali) non hanno alcun riscontro nel testo unificato in discussione in Parlamento (mentre anch’esse erano presenti nel ddl De Petris).
Insomma, la “riforma” D’Alì/Caleo è un testo che si segnala molto più per i problemi importanti su cui non ha nulla da dire e non dice nulla che per quelli che pretende di affrontare e che di conseguenza si può definire innovativa solo con una grande dose di immaginazione e di affetto.
I contenuti della “riforma” D’Alì/Caleo si riducono infatti ad alcuni interventi che se non vanno al cuore dei problemi attuali dei parchi introducono però rilevanti stravolgimenti alla filosofia, al funzionamento e al ruolo delle aree protette. Su tutto questo concorda la quasi totalità delle associazioni ambientaliste che in questi anni hanno più volte prodotto documenti e appelli – anche recenti – caratterizzati da una decisa e argomentata contrarietà, ma concordano anche autorevoli esperti che come abbiamo già visto hanno prodotto preziose analisi di dettaglio.
Valbonesi si sofferma velocemente su quattro aspetti-chiave della proposta di legge che sono al tempo stesso tra quelli più aspramente criticati. Ed è qui che vale dunque la pena di seguirlo passo per passo. I lettori di “greenreport” hanno già una buona conoscenza di questa materia perché è stata trattata più volte sulle sue colonne da figure autorevoli come Renzo Moschini e Carlo Alberto Graziani ma da un lato è sempre vero che repetita iuvant e dall’altro è forse possibile approfittare dell’occasione per aggiungere qualche riflessione in più, sintetizzando alcune argomentazioni già esposte in modo più approfondito in “eddyburg”.
In primo luogo la “riforma” attribuisce un ruolo abnorme a una associazione privata e squisitamente volontaria come Federparchi stabilendo che essa è titolare niente di meno che della “rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette”. In cambio, tale associazione si impegna graziosamente a non escludere nessuna area protetta che intenda aderirvi. Dietro questo anomalo riconoscimento si intravede facilmente la rinuncia definitiva alla creazione di un organismo nazionale e pubblico di coordinamento, la delega di questo compito a un ente privato e il riconoscimento – mi pare di poter tranquillamente aggiungere – dell’organicità di Federparchi alle politiche governative presenti e future.
Un’associazione che tra l’altro fa da anni tandem con una sola delle grandi associazioni ambientaliste nazionali e spesso, come ho cercato di mostrare, in aperto contrasto con le altre. Valbonesi ritiene al contrario che si tratti di ordinaria amministrazione e anzi di un adeguamento a quanto avviene in paesi sicuramente evoluti come la Francia: si tratterebbe da noi di fare “così come da decenni fa e con ottimi risultati il ministero francese con la sua Federazione dei parchi”. Disgraziatamente quest’ultima affermazione è del tutto infondata e introduce un elemento di grave confusione. In Francia anzitutto non esiste una “Federazione dei parchi” ma esistono due istituzioni molto diverse tra loro. Una si chiama Parcs nationaux de France ed è niente meno che “un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature” che comprende tutti i presidenti dei parchi nazionali francesi, un rappresentante delle regioni, uno dei dipartimenti, un deputato, un senatore, due personalità desingnate dal ministero e un rappresentante dei sindacati del personale: altro che associazione privata! L’altra istituzione è effettivamente un’associazione privata, si chiama Fédération des parcs naturels régionaux de France, collabora certamente da decenni e con ottimi risultati – come afferma Valbonesi – con i vari ministeri ma il Code de l’environnement le attribuisce solo una funzione consultiva su alcune questioni molto specifiche, al pari peraltro di altri soggetti, mentre la legge quadro sui parchi del 2006 neppure la nomina. Che la “riforma” D’Alì/Caleo faccia in fondo “come la Francia” costituisce – a voler essere buoni – una pia illusione ma certamente non un dato di fatto. Essa non solo non “fa come la Francia”, essa fa ben altro e fa sicuramente molto peggio, tanto più che in Francia un ministero dell’ambiente esiste, funziona solidamente e persegue efficacemente le proprie politiche mentre in Italia, come riconoscono ormai anche politici un tempo sostenitori della “riforma”, il ministero dell’Ambiente è ormai solo un palazzo abitato da fantasmi.
In secondo luogo Valbonesi difende come novità positive l’accentuazione “del ruolo delle comunità delle comunità locali nel governo dei parchi nazionali” e l’apertura “al coinvolgimento diretto degli agricoltori”, due provvedimenti che stravolgono aspetti fondamentali dell’identità stessa dei parchi nazionali concentrando di fatto i poteri decisionali in testa a soggetti portatori di interessi locali e di categoria e non più nazionali e generali nel momento stesso in cui questi ultimi soggetti – il mondo scientifico su tutti – vengono progressivamente eslcusi. Su questi aspetti gravidi di rischi – oggi come ieri: non a caso l’attacco speculativo al Parco nazionale d’Abruzzo dei primi anni Sessanta si appoggiava a proposte di legge dal tenore analogo – ha concentrato la sua attenzione con le analisi precise e taglienti già citate Carlo Alberto Graziani e ad esse non posso che rimandare ancora una volta.
In terzo luogo Valbonesi difende in modo un po’ obliquo, senza nominarla direttamente, la parte della “riforma” che prevede la possibilità di introdurre nelle aree protette attività più o meno impattanti in cambio di una compensazione monetaria. Qui il riferimento è “nobile” ed è quello ai cosiddetti “servizi ecosistemici”, il cui pagamento dovrebbe divenire “il perno dell’autofinanziamento dei parchi e allo stesso tempo il parametro di riferimento principale per misurare la loro capacità di iniziativa, di tutela e di messa in valore delle risorse naturali che essi conservano”. Anche se vogliamo limitarci a un’analisi “alta” della questione, risparmiandoci la sofferenza di immaginare cosa possa comportare tutto ciò nella prosaica e rude concretezza dei territori, qui la distanza tra le posizioni che io difendo e quelle che difende Valbonesi è davvero profonda. Il concetto di “servizi ecosistemici” costituisce infatti – come sostiene limpidamente Virginie Maris nel suo recente Nature à vendre – un’arma a doppio taglio che va esattamente nel senso che ho cercato di denunciare nel mio articolo per “eddyburg”. ale parola d’ordine, di successo molto recente, contiene e veicola infatti una considerazione sostanzialmente neoliberista di beni che sono e devono invece rimanere anzitutto collettivi e questa deriva, in Italia più forte che in altri paesi di tradizione statale più solida, costituisce per le aree protette un rischio ancor maggiore che per il pur minacciatissimo patrimonio storico-artistico. Di contro è indispensabile ricordare come nel nostro Paese la questione delle ricadute economiche – dirette e indirette – della tutela ambientale è stato al centro di tutto il dibattito sulle aree protette sin dalla metà degli anni Sessanta, con risultati sia teorici che operativi spesso di livello molto alto. Un dibattito che nella “riforma” D’Alì-Caleo viene miseramente e banalmente ridotto a una tenue compensazione monetaria di attività impattanti, a dispetto del manto nobilitante dei “servizi ecosistemici”.
Valbonesi espone infine una serie di interessanti considerazioni sulla questione dei criteri di nomina di direttori e presidenti dei parchi e sul loro ruolo, alcune sicuramente condivisibili e altre molto meno. Queste considerazioni prendono in gran parte spunto da una mia argomentazione contenuta nel saggio/denuncia del 14 dicembre, ma riportandola male e inducendo quindi in errore chi legge. Io avevo affermato che la “riforma” D’Alì/Caleo tende a codificare la tendenza in atto già da anni a limitare progressivamente l’autonomia amministrativa, culturale e operativa degli enti gestionali dei parchi assoggettando sempre più la scelta dei presidenti alla volontà delle segreterie (nazionali e locali) dei partiti politici e riducendo i direttori a fedeli esecutori di volontà esterne. Avevo anche affermato che tutto ciò, oltre che moralmente deplorevole, rischia di depotenziare in modo fatale la missione delle aree protette che è, per dirla con la formula che Valbonesi predilige, quella della “savaguardia della biodiversità”. All’interno di questo ragionamento avevo scritto – e qui lo riconfermo senz’altro – che senza il margine di autonomia garantito dalle precedenti normative, comprese quelle precedenti la legge quadro, i gestori delle aree protette italiane non avrebbero potuto essere come in effetti furono tra i maggiori protagonisti dello straordinario slancio che portò alla legge quadro e alla complessa e ricca configurazione attuale delle aree protette italiane. Dicevo anzi – e anche qui: lo confermo senz’altro – che la legge quadro è uscita in parte cospicua da discussioni degli anni Settanta e Ottanta svolte a Pescasseroli, nella sede del Parco nazionale d’Abruzzo, una circostanza oggi assolutamente inimmaginabile. Valbonesi, ricordando l’assai opaco esito di quella vicenda amministrativa, mi imputa una “mitizzazione” di quella esperienza. No, non è questo il punto. Io non mitizzo nulla, riporto un dato di fatto storico incontrovertibile per sottolineare una differenza tra quegli anni e quelli di oggi, tra una politica e una normativa che lasciavano margini, che permettevano l’iniziativa e la discussione e una politica e una normativa che sembrano preoccupate anzitutto di mettere tappi, di creare presidi ben controllati che non diano sorprese, che non deraglino. Una politica e delle normative che già ora sterilizzano gran parte delle energie che potrebbero dare un contributo rilevante alla soluzione dei tanti problemi dei parchi italiani. Tutto qui: ed è ben diverso dal mitizzare alcunché. Il punto è che la “riforma” D’Alì-Caleo mortifica programmaticamente quell’autonomia, già oggi ridotta al lumicino, e così facendo mortifica la capacità stessa delle aree protette di rappresentare qualcosa di innovativo e persino di difendersi da attacchi che pure ci sono e sono ben numerosi.
A fronte di questo giro di vite che accentra in mani sempre più ristrette e discrezionali i poteri decisionali Valbonesi scarta a priori l’idea che la soluzione ai problemi delle aree protette italiane possa risiedere nel tentativo “di risuscitare quel movimento di opinione che contraddistinse la fase più fervida dell’ambientalismo italiano degli anni 80” in quanto “oggi i cittadini sanno che l’obiettivo di istituire i Parchi è stato raggiunto ed è difficile, se non impossibile, mobilitarli per difendere i parchi [e che anzi] essi si aspettano che adesso siano le istituzioni a farli funzionare”. Abbiamo qui, evidentemente, due visioni opposte: da un lato un uomo delle istituzioni convinto che i cittadini siano oggi in attesa fiduciosa che le istituzioni stesse abbiano il pallino in mano e siano in grado di giocarlo correttamente; da un altro lato abbiamo cittadini che sono costretti a constatare una radicale incapacità/mancanza di volontà delle istituzioni nel garantire la sopravvivenza dei parchi e che ritengono che la prima risorsa sia come sempre la mobilitazione dell’opinione pubblica, per quanto in un contesto storico molto meno favorevole che in altre fasi. Solo da una onesta presa d’atto di questa divergenza è necessario partire se si vuole andare avanti.
Ma un aspetto che mi colpisce profondamente dell’intervento di Valbonesi – e con questo vorrei concludere – non riguarda tuttavia i contenuti bensì l’argomentazione, l’impostazione retorica.
Valbonesi utilizza infatti due argomentazioni parallele e complementari in questo periodo purtroppo molto in voga, estremamente deboli e persino logore ma che stanno facendo enormi danni a livello culturale e politico e altri danni sono certamente destinate a farne in futuro: la retorica dell’emergenza e un uso manicheo e caricaturale dell’opposizione innovazione/conservazione. È in senso stretto la retorica, brutalmente semplificatoria, che fa attualmente la fortuna del presidente del consiglio. La potremmo riassumere in questo modo: “la situazione è ormai incancrenita e immobile e un intervento incisivo e determinato è comunque il benvenuto; chi interviene modificando l’esistente perché ha il potere di farlo è comunque un innovatore, a prescindere dai contenuti. Chiunque provi invece a difendere l’esistente o pezzi dell’esistente, qualsiasi sia questo pezzo e in qualunque modo lo difenda, è comunque arroccato, è comunque conservatore, è comunque vecchio”. Le opposizioni (esplicitamente e ruvidamente valutative) vecchio/nuovo, innovatore/conservatore diventano insomma il passepartout per semplificare radicalmente il dibattito se non per chiuderlo preventivamente, sapendo che si gode comunque del vantaggio dei numeri. Da qui ai “gufi”, ai “professoroni”, ai “comitatini” che ornano la retorica renziana il passo è necessariamente brevissimo.
Eppure io non credo che questo sia il significato di democrazia e di partecipazione che per un pezzo di storia degli ultimi quarant’anni io, Valbonesi e migliaia di altre persone abbiamo condiviso e che ha costituito un pilastro cruciale delle realizzazioni di cui continuiamo ad essere giustamente orgogliosi. Cerchiamo insomma di stare il più possibile sul pezzo e di starci, se possiamo, con onestà e mente fredda. I “gufi” lasciamoli ad altri: con un po’ di buona volontà forse ce la facciamo.

Ieri, nella sua serafica casa senese, ci ha lasciato Mario Cusmano, protagonista fondante della cultura urbanistica italiana dalla metà del secolo scorso in poi. Ma anche Maestro di generazioni di studenti e laureati in Architettura a Genova, per poco tempo, e a Firenze per moltissimo e fruttuosissimo tempo, nella Facoltà di cui è stato anche equilibrato Preside.
In tale ruolo Mario fu capace di riportare la Facoltà, dopo anni difficili, ad un livello innovativo di forte dignità culturale e di chiarezza disciplinare e metodologica, estendendola dall'Urbanistica anche molti degli altri settori di ricerca e di studio.
La sua caratteristica principale come professore, sviluppata in decenni di impegno e sulla base di una cultura urbanistica e storico-architettonica "fatta a mano", su documentazioni molto più che su ipotesi, è stata una fortissima e appassionata impronta maieutica nei confronti degli allievi a lui più vicini, che Mario aveva il vezzo di vantare che fossero in genere di quantità non eccessiva.
Ma essa raggiungeva livelli superlativi nella infusione di capacità scientifiche che il suo metodo raggiungeva al momento della preparazione delle tesi di laurea, fino a far nascere il mito delle tesi del tipo Cusmano. Che era, e dovrebbe rimanere il tipo "ordinario" in quanto pretende ed ottiene di transitare dalle fondamenta conoscitive le più rigorose, alla investigazione critica la più ampia, alla ricerca delle categorizzazioni di volta in volta idonee, senza gli eccessi accademici (contro cui si ebbe modo di scontrarsi spessissimo), alla proposizione la più coerente delle trasformazioni ammissibili da proporre.
Infatti, per Mario Cusmano, l'ammissibilità deve dipendere da correttezze e coerenze proprie e interne alla elaborazione del pensiero urbanistico fortemente applicato ai luoghi specifici e alla dimensioni precipue delle città "proporzionate", opportunamente trasferite in regole intrinseche, che non costituiscono affatto dettagli valicabili a piacere ovvero sulla base di leggi e norma di comodo o ad hoc.
Da una tale impostazione discende che il ruolo del professionista urbanista, dell'autore del piano, al di là della forma transeunte in cui possa esercitarsi, non è eliminabile. Come deriva una concezione della ricerca scientifica applicata ai campi dell'Urbanistica nettissimamente caratterizzata dalla subordinazione agli interessi pubblici istituzionalmente sovraordinati, matrice di qualsivoglia tipo o sottotipo di metodica pianificatoria.
Tutto ciò ha consentito al Professor Cusmano di avviare programmi di ricerca applicata o applicabile sempre ben concepiti e pubblicamente ben orientati , concordati con Enti Pubblici ed , in genere, a chiaro scopo pianificatorio. Ciò soprattutto nel difficile campo degli studi su cui possono fondarsi le pianificazioni provinciali o di area vasta, fra cui quello relativo al territorio vasto fiorentino, le cui categorizzazioni rimangono esemplari quantomeno nella elaborazione concettuale, che, naturalmente, deve subire, per Mario, aggiornamenti costanti mai streotipizzate, nelle fasi operative.
Di Mario Cusmano, che fu per me il Maestro fondamentale a conclusione dei miei studi universitari, ho sentito già da quando ha voluto dedicarsi solo allo studio individuale e sento fortemente ora che ci ha lasciato il bisogno di avere a fianco la sua grande sua capacità di sinteticità critico-propositiva, che infondeva sicurezza e conforto, specie nell'ambito di questo nostro mestriere complesso e oggi, purtroppo, anche imbrattato da comportamenti che Mario, spesso con ben pochi altri, ha sempre avuto il coraggio di denunciare anche a costo di rimanere, ma solo apparentemente, isolato.
A Mario da tutti noi con affetto e nostalgia.
Il bilancio preventivo del presidente De Luca per i prossimi anni è l'occasione per un'analisi dei misfatti compiuti dalla legislazione urbanistica della Campania, di cui l'attuale, discusso Presidente si onora di essere il prosecutore. Lo strumento chiave: il trasversale "piano casa
"Con il comunicato stampa n. 1169 del 23 dicembre la regione Campania ha informato che, nella seduta del consiglio regionale del giorno precedente, «sono stati approvati a maggioranza i due documenti fondamentali e strategici dell’amministrazione regionale: il Documento di Programmazione Economico Finanziario (Defr), che per la prima volta ha dato una idea complessiva delle linee di governo della Giunta negli anni 2016 e seguenti, e la legge di Bilancio composta dalla legge di stabilità e dal Bilancio di previsione 2016-2018». Nell’elenco delle numerose Misure riorganizzative approvate figurano testualmente: «La proroga del Piano casa al 31.12.2017; La proroga della possibilità per i comuni di lavorare le pratiche dei vecchi condoni ancora in istruttoria relativi alle leggi dell’85 e ’94».
La giunta De Luca chiarisce così in modo lampante i propri orientamenti in materia di urbanistica, in continuità con le linee della precedente amministrazione di centro-destra.
Bisogna dire che il cosiddetto “piano casa” ha in Campania una genealogia del tutto trasversale: la sua prima formulazione regionale risale infatti agli ultimi mesi della giunta Bassolino, che macchiava così vistosamente l’apprezzabile lavoro compiuto con i precedenti provvedimenti per l’area a rischio del Vesuvio (2002), con la prima legge organica campana sulla pianificazione urbanistico-territoriale (2004), con la prima definizione (2004) del piano territoriale regionale (PTR) e con le linee guida del paesaggio, inserite nel PTR prima della sua definitiva approvazione (legge 13/2008).
La giunta Caldoro fra il 2010 e il 2015 ha coerentemente lavorato in direzione opposta. Certo, ha fornito qualche utile chiarimento circa l’articolazione del piano urbanistico comunale in componenti, strutturale ed operativa, riducendo le specifiche ambiguità in materia della legge 16/2004. Ma ha preteso di farlo con un semplice regolamento attuativo, il 5/2011, prestando così il fianco ad un contenzioso ora all’esame della Corte Costituzionale che rischia di invalidare anni di amministrazione dell’urbanistica nella regione. Per il resto ha costantemente tentato di smantellare le politiche per il territorio messe a punto dalla giunta precedente, a partire dal sistema integrato di mobilità e trasporti pubblici.
Per quel che concerne in particolare l’urbanistica e il paesaggio, l’amministrazione di centro-destra ha a più riprese mirato a cancellare o stravolgere specifiche disposizioni legislative precedenti inerenti al piano urbanistico-territoriale dell’area sorrentino-amalfitana o alla legge per la riduzione del rischio vesuviano o alle leggi per i condoni edilizi: il tentativo più cospicuo in tale direzione è stato condotto con un truffaldino disegno di legge per la pianificazione paesaggistica, la cui autentica finalità eversiva è stata fortunatamente contenuta dalla resistenza delle opposizioni, grazie anche ad una intensa mobilitazione culturale.
Sul “piano casa”, invece, la giunta Caldoro ha incontrato ostacoli assai minori. Sicché in Campania sono divenuti realizzabili, in deroga alla pianificazione vigente – e perfino negli ambiti disciplinati da piani specialistici con disposizioni diverse dalla assoluta inedificabilità –, interventi più che cospicui sotto il profilo dello sfruttamento delle parassitarie rendite urbano-immobiliari. A titolo esemplificativo, si possono citare esempi illuminanti.
Un edificio per uffici, o anche un albergo, con superficie utile lorda fino a 1.500 mq può essere diversamente destinato, in deroga al piano urbanistico, realizzando sole opere interne che non incidano su prospetti e sagoma e costituendo unità immobiliari non ulteriormente frazionabili: può quindi diventare un condominio residenziale con una trentina di mini-appartamenti.
Un albergo della dimensione di 10.000 mc che non abbia «goduto dei benefici contributivi», ubicato in aree urbanizzate diverse dal centro storico (ma anche in esso se costruito o ristrutturato negli ultimi 50 anni), può diventare, sempre in deroga al piano urbanistico, un condominio residenziale a patto che il 35% della volumetria sia destinato a edilizia residenziale sociale (cioè, in definitiva, riservato all’affitto): dando luogo, quindi, ad una quarantina di mini-alloggi “a mercato libero” e ad una ventina di alloggi vincolati all’affitto.
L’incremento di volume nella misura del 20% può essere realizzato a fini abitativi su edifici residenziali esistenti, ma perfino su edifici non ancora esistenti se realizzabili secondo le vigenti norme urbanistiche. E tale incremento si applica a immobili che appartengano ad una delle seguenti categorie: «a) edifici residenziali uni-bifamiliari; b) edifici di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi; c) edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto». Dunque non c’è limite volumetrico per le categorie a) e c). E si può incrementare di un appartamento da 300 mc un capannone di 1.500 mc.
Deve poi considerarsi residenziale anche un edificio che abbia destinazione abitativa solo per il 55%. E si ammette il cambio di destinazione del residuo 45% se si tratta di pertinenze agricole di una casa rurale ubicata fuori delle zone agricole.
Quando invece si procede con interventi di demolizione e ricostruzione l’incremento volumetrico in deroga alla normativa urbanistica vigente sale al 35% ed è consentito incrementare anche il numero degli appartamenti «purché le eventuali unità immobiliari aggiuntive abbaino una superficie utile non inferiore a 45 mq».
Nelle zone agricole possono diventare spazi abitativi «del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo» (anche non coltivatore) le precedenti stalle, depositi, fienili e via dicendo e – sempre in deroga ai piani urbanistici – si possono realizzare «nuove costruzioni ad uso produttivo» (artigianale ? commerciale ?) nella misura di 0,03 mc/mq.
Gli edifici industriali dismessi da almeno tre anni possono essere – in deroga al piano urbanistico – integralmente sostituiti secondo due soluzioni: a parità di volume con mutamento di destinazione a residenze, uffici (non più del 10%), esercizi di vicinato o botteghe artigiane, purché riservando non meno del 30% per alloggi sociali; oppure, anche con un incremento di volume del 20%, con destinazioni produttive non meglio specificate (potrebbero essere di tipo terziario ? anche “direzionali” ?), perfino delocalizzando l’intera volumetria assentibile «se tale forma di intervento sia prevista nella programmazione urbanistica locale, sia ritenuta utile ed opportuna dal Comune, e vi sia la disponibilità dell’area alternativa rispetto a quella dove sussistono le volumetrie preesistenti oggetto dell’intervento».
Le esemplificazioni potrebbero continuare, ma è già sufficientemente chiaro che il “piano casa” in Campania fra il 2009 e il 2014 è diventato un carrello di attrezzi idoneo a far saltare qualunque coerenza di governo pianificato del territorio. Ed è l’efficacia di questo carrello che la giunta De Luca ha prorogato fino al 31 dicembre 2017.
Quanto al condono, la proroga riguarda solo le procedure amministrative comunali. Ma testimonia comunque l’attenzione della giunta regionale ai problemi degli abusivisti. Del resto, all’inizio della campagna elettorale il candidato De Luca si era premurato di sostenere che sarebbe stato impossibile abbattere tutta l’edilizia abusiva non condonabile. Il provvedimento del 22 dicembre possiede il sapore inequivoco di un segnale: in attesa di circostanze opportune ….
Chi possiamo ritenere abbia brindato con più entusiasmo al capodanno in Campania ?
Il Sole 24 Ore, 29 dicembre 2015
Prima ancora che di una carenza grave di politiche e di misure di settore, come quelle per la mobilità o l’ambiente o il risparmio energetico, il caos “fai da te” delle città italiane sullo smog in questi giorni evidenzia una lacuna generale ancora più seria: l’assenza di una cornice di politica urbana nazionale come quella degli anni ’80, prima centrata su un ministero per le Aree urbane, poi via via depotenziata con deleghe ministeriali, dipartimenti, coordinamenti informali, semplici direttive e infine scomparsa del tutto, da 15 anni in qua, in concomitanza con il tentativo, fallito, di imporre un federalismo regionalista sostanzialmente anti-urbano e con l’imposizione di vincoli crescenti finanziari e politici ai sindaci, ben rappresentati nel modello dello “stupido” patto di stabilità interno. Si è tentata, con il governo Monti, una modesta inversione di rotta con il “piano città” che ha però avuto un esito misero in termini di progetti e di pratiche urbane coordinate dal centro.
Per questo la prima misura di un decalogo di governo per città pulite e motore di sviluppo sostenibile è la ricostituzione di un nocciolo duro di politiche urbane nazionali e di una adeguata cornice istituzionale, con una delega di coordinamento forte affidata a un ministro (magari un ex sindaco come Graziano Delrio) o tenuta direttamente per sé dal Presidente del Consiglio. Sarebbe una scelta in sintonia con un “governo degli ex sindaci” che ha già ridato dignità alla dimensione urbana con l’istituzione delle città metropolitane, con il ridimensionamento dello strapotere regionale (riforma del titolo V), con l’avvio di piani come quello dell’edilizia scolastica, con un primo vistoso ridimensionamento del patto di stabilità interno nella legge di stabilità 2016. Ma che ora deve accelerare su questa strada. Il caos di questi giorni dimostra che un coordinamento nazionale su politiche fondamentali non può essere episodico ma deve essere strutturale e prevenire i problemi per evitare di affrontarli in ordine sparso.
E veniamo – dopo questo primo punto – alle misure di settore, molte delle quali sono, peraltro, già in cantiere o abbozzate, senza però che si avverta l’urgenza di vararle.
Si prenda il ddl di riforma del trasporto pubblico locale, che è in ballo da almeno due anni e non riesce a vedere la luce e che contiene almeno tre delle misure del possibile decalogo anti-smog:
- un investimento nazionale di alcune centinaia di milioni che consenta, con formule di leasing, di mandare in pensione gli autobus euro 0, 1 e 2 (che sono oltre il 50% del totale) e di abbattere l’età media del parco italiano che, sfiorando i 13 anni, è quasi il doppio di quello europeo, fermo a 7 anni;
- un miglioramento del servizio che renda più competitivo il trasporto pubblico rispetto a quello privato, poggiando su nuove tecnologie (bigliettazione intelligente e infoservizi), strumenti nuovi di standard minimi (carte dei servizi) o l’ammodernamento di vecchi strumenti (contratto di servizi) capaci di superare una volta per tutte il patto scellerato comuni-ex aziende municipalizzate che si consuma da 25 anni a danno del cittadino-utente con servizi pessimi e del cittadino-contribuente con costi di gestione esagerati, contribuzione pubblica crescente, perdite di bilancio;
- una liberalizzazione del trasporto pubblico locale mediante l’avvio di una nuova stagione di gare che consenta l’ingresso di capitali e capacità imprenditoriali nuovi, italiani ed europei, nella gomma e nel ferro.
Questo disegno di legge è allo studio da due anni ed è ormai diventato una emergenza nazionale. Farebbe bene il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, a rompere gli indugi e presentare il provvedimento, con risorse adeguate.
Ci sono altre quattro misure in materia di mobilità urbana che, sia pure non strettamente connesse con il Ddl di riforma, sono tuttavia decisive:
- il potenziamento del “ferro” nella doppia accezione di potenziamento dei servizi ferroviari urbani (dove è decisiva la nuova gestione Fs ma anche direttive stringenti del governo) e di rilancio dei progetti infrastrutturali di tranvie veloci e metropolitane con fondi e strumenti autorizzativi dedicati (come fu la legge 211/1992);
- l’integrazione ferro-gomma che è una delle priorità del nuovo ad di Fs, Renato Mazzoncini, ma andrebbe considerata in una chiave più estesa e nazionale, valutando i benefici che si possono avere in termini di risparmi, efficientamento e miglioramento del servizio, dalle riduzioni delle sovrapposizioni fra ferro e gomma in ambito urbano ed extraurbano;
- la legittimazione e la liberalizzazione di servizi di “nuova mobilità” collettiva e privata come Uber o Blablabla e delle tecnologie che portano con sé , per rompere altri monopoli anacronistici e altre esistenze alla modernizzazione delle nostre città;
- una nuova stagione di pianificazione urbana che rilanci lo strumento delle tariffe intelligenti e flessibili per il trasporto pubblico, per i taxi e per la sosta dei veicoli privati e garantisca al tempo stesso modalità alternative di trasporto (piste ciclabili integrate), corsie preferenziali per il trasporto pubblico, parcheggi di scambio, l’uso di tecnologie informative in favore degli utenti, l’uso crescente di telecamere per garantire la sicurezza e il rispetto dei divieti.
Ma la crisi delle città non è solo una crisi di trasporto e di mobilità. Sappiamo che il consumo energetico, soprattutto per il riscaldamento e il condizionamento di abitazioni e uffici, è un tema cruciale. Funzionano a meraviglia i crediti di imposta del 65% per gli interventi di efficientamento energetico, ma, nonostante la meritoria proroga al 2016 e nonostante l’importante estensione ai patrimoni pubblici degli ex Iacp, il governo non è ancora riuscito a trasformare questa micromisura in una politica organica, in un gigantesco piano nazionale prioritario in cui far confluire risorse locali, nazionali ed europee, pubbliche e private, fiscali e creditizie, andando oltre la piccola dimensione e rilanciando la scala condominiale, di quartiere e urbana che occorre oggi. Questa era la nona misura.
Infine, un decimo punto, per quanto generico non può non essere dedicato alla questione urbanistica che non si affronta solo con il demagogico disegno di legge sul divieto di consumo di suolo all’esame della Camera. Le città devono essere dotate di strumenti fiscali, pianificatori e regolativi che superino la legge urbanistica del 1942 e consentano un ridisegno più agevole degli spazi, degli edifici e dei servizi urbani in chiave di riuso, rigenerazione, riqualificazione. Servono semplificazioni per andare più veloci, a partire da quel regolamento edilizio unico che il governo ha promesso e non arriva: potrebbe essere il primo tassello di una politica urbana nazionale davvero capace di dare un contributo alla modernizzazione renziana e di far correre nuovamente le nostre città, anziché incrostarle in vecchie contraddizioni di cui lo smog è una delle dimensioni evidenti a tutti e misurabili.
 «Jane Jacobs. L’unica città funzionante è a misura di chi la abita. Contraria ai metodi di pianificazione, un ritratto dell’attivista e teorica critica dell’urbanistica moderna. Il suo saggio del 1961 ha segnato un punto di svolta per la sociologia urbana divenendo un punto di riferimento per accademici e non». Il manifesto, 21aprile 2016 (c.m.c.)
«Jane Jacobs. L’unica città funzionante è a misura di chi la abita. Contraria ai metodi di pianificazione, un ritratto dell’attivista e teorica critica dell’urbanistica moderna. Il suo saggio del 1961 ha segnato un punto di svolta per la sociologia urbana divenendo un punto di riferimento per accademici e non». Il manifesto, 21aprile 2016 (c.m.c.)