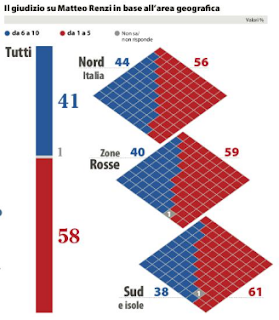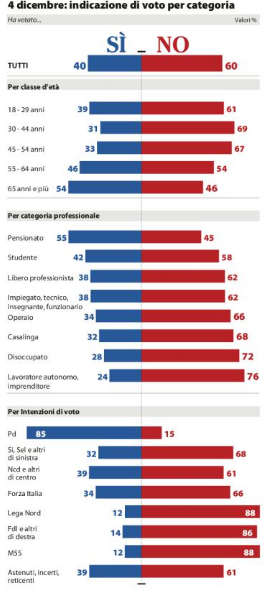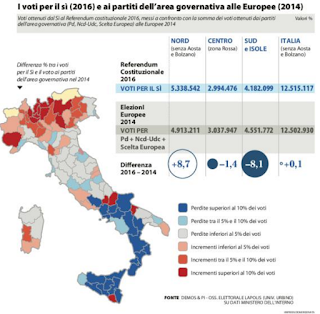Corriere della Sera,
La democrazia vive se riesce a creare benessere. Se, cioè, si dimostra in grado di distribuire un dividendo ai propri cittadini. Il neoliberismo, figlio della società welfarista e consumerista degli Anni 60 e 70, ha interpretato questo compito nei termini di un aumento delle possibilità individuali di scelta. In un sistema a possibilità crescenti (quello nato dalla combinazione tra globalizzazione e finanziarizzazione), un’idea vincente. È l’incepparsi di questa dinamica che, a partire dal 2008, ci ha fatto entrare in un’altra epoca storica.
Il punto è che il benessere è multidimensionale. Ha certamente a che fare con gli aspetti quantitativi e materiali della nostra vita, come avere a disposizione più beni, poter scegliere tra più possibilità, che però non li esauriscono. In particolare, si è sottovalutato il fatto che la sicurezza è un bene primario. Da molti anni se ne parla. Basterebbe citare Bauman, ripetutamente tornato sul punto. Ma, è solo dopo il 2008 che la questione da privata è diventata pubblica. La ragione è semplice: anche se non vogliamo ammetterlo, il tipo di crescita che abbiamo costruito tende a generare una insicurezza diffusa che tocca la vita quotidiana di un numero elevato di persone. Un effetto che è diventato sempre meno sostenibile al punto da rendersi indipendente dall’effettivo andamento delle cose, così come rappresentato dai dati statistici.
Si pensi all’esito paradossale delle riforme del lavoro di Renzi. In effetti, grazie al Jobs act l’occupazione nel suo complesso è cresciuta in Italia tanto che oggi, in Italia, si contano più di 22 milioni di occupati: un record storico. Ma il problema è che tale crescita è stata più quantitativa che qualitativa: la quota di lavoro instabile o mal pagato rimane troppo alta. Così che la percezione diffusa rimane problematica. O si pensi al tema dei migranti. I numeri non sono mai stati apocalittici e da tempo i flussi si sono arrestati. Ma, al di là dei dati (che dimostrano che non c’è stato un aumento degli atti criminosi), la percezione diffusa è di vivere in un mondo estremamente insicuro: il mix tra informazione mediatica ed esperienza quotidiana produce l’idea di un mondo ormai alla deriva, in cui il singolo cittadino si trova a dover gestire da solo questioni molto complesse (come appunto la convivenza con gruppi etnici completamente diversi e sconosciuti).
L’elenco potrebbe continuare: incertezza ambientale, spesso associata ai disastri naturali e alle inadempienze dei lavori pubblici; esposizione al terrorismo, che si mescola con i venti di guerra; arretramento lento ma continuo delle protezioni offerte dal welfare; fino ad arrivare a legami famigliari sempre più fragili (con il correlato drammatico della violenza domestica).
A tutto ciò si aggiungono poi altri fattori: la fine delle ideologie e la perdita di qualsiasi narrazione condivisa; la confusione del mondo ipermediatizzato dove è sempre più difficile distinguere il vero dal falso; e l’invecchiamento della popolazione, strutturalmente associato a maggiore instabilità e fragilità esistenziale.
Il problema, come scriveva Luhmann, è che la paura non è controllabile dai sistemi funzionali. Anzi, in taluni casi la miglior prestazione funzionale può correlarsi con più paura senza riuscire a eliminarla. Il che tende a far emergere un nuovo stile di morale che si fonda non più su norme, ma sul comune interesse a ridurre la paura. Le nostre società si strutturano ormai attorno a questa nuova faglia. Chi è protetto - perché ha un lavoro stabile, vive in un quartiere ordinato, ha una buona istruzione e di una rete relazionale solida - non riesce a percepire il problema. E non si accorge che dispone di beni che una società avanzata non è più in grado di produrre a sufficienza per tutti.
Se si tiene conto di tutto questo, si capisce l’errore delle élite in questi ultimi anni: non aver voluto vedere gli effetti collaterali della crescita e di conseguenza non aver capito che, nelle mutate condizioni storiche, il benessere distribuito non era più né quantitativamente né qualitativamente adeguato.
Solo così si capisce che questo è un tempo di politica e non di tecnica. La richiesta di sicurezza - spesso guardata con sicumera dalle élite - che viene dai ceti popolari è che sia ristabilito il filtro di una comunità politica in grado di riparare la vita quotidiana dall’esposizione alle conseguenze problematiche della crescita tecno-economica. Che questa istanza venga interpretata solo nella prospettiva sovranista - e in taluni casi decisamente reattiva e violenta - può essere un problema, anche perché le proposte di soluzione sono vaghe e ben poco convincenti. Ma a mancare è soprattutto la capacità di proporre un’idea di sicurezza positiva - non come chiusura o contrapposizione ma come relazione e inclusione - che presupponga un’idea più ampia e articolata di benessere. Una bella sfida, tutta politica.

la RepubblicaRignano, e che sta finalmente scomparendo dal teatrino della politica italiana
Il Pd rimane alla finestra a guardare, senza far nulla. La classica posizione dei depressi. C’è da capirlo. Una sconfitta così devastante, che ha portato il partito al minimo storico, annichilisce. Sette punti percentuali e 170 deputati in meno rispetto al risultato del 2013, giudicato allora dai renziani una sconfitta nonostante il Pd in coalizione con Sel godesse della maggioranza assoluta alla Camera, sono i dati duri e inoppugnabili della catastrofe. Nonostante tutto questo, Matteo Renzi, il leader che ha condotto il partito al disastro, continua a spadroneggiare. Le sue dimissioni sono una delle più sonore fake news degli ultimi tempi. Riunisce i suoi in qualche caminetto discreto e indica le azioni che solerti luogotenenti rendono operative. Invece di assumere un atteggiamento di decoroso e doveroso distacco, l’artefice della peggior Waterloo della sinistra italiana continua a voler dettar legge.
Può farlo perché sappiamo con quale cura abbia confezionato liste di fedelissimi alle elezioni, assicurandosi un adeguato manipolo di yes- man in Parlamento. Grazie al controllo di gran parte dei gruppi parlamentari, come si è visto con la scelta dei capigruppo, continua a dare la linea. Che è quella dell’immobilismo: rimanere a guardare le iniziative degli altri attori politici nell’attesa di un loro passo falso. Questa strategia avrebbe una sua logica se fosse chiaro cosa il Pd (o meglio, Renzi) si propone di fare dopo. Godere degli insuccessi altrui può lenire qualche taglio dell’anima ma politicamente è del tutto sterile.
Invece di discutere sul significato del risultato elettorale e sulle prospettive future, il Pd si ripiega in un immobilismo cadaverico, seguendo, in questo, la parola d’ordine lanciata da Renzi all’indomani delle elezioni. In effetti, solo se il Pd rimane imbalsamato in un rifiuto pregiudiziale ad ogni relazione politica con gli altri partiti, quasi una autoghettizzazione, l’ex segretario può mantenere il suo potere di interdizione.
Perché questo sembra l’obiettivo primario di Renzi: mantenere la propria presa sul partito, costi quello che costi. Se Renzi ricordasse quanto disse nella direzione che sancì la scissione dei bersaniani ( febbraio 2017), e cioè che si era « chiuso un ciclo alla guida del Pd, perché abbiamo preso un Pd che aveva il 25% e nell’unica consultazione politica lo abbiamo portato al 40,8%» dovrebbe umilmente prendere atto che portare il Pd al 18% implica una uscita di scena.
Allo stesso tempo, però, la minoranza, a parte il tonitruante Emiliano che ogni tanto lancia i suoi fulmini, si limita a qualche flebile lamento. Non è in grado di alzare la voce intimando a chi ha perso di passare la mano senza brigare e tramare. Fino a che il Partito Democratico non risolve la contraddizione di una leadership effettiva benché dimissionaria e, soprattutto, sfiduciata dai 2 milioni e mezzo di elettori mancati all’appello, non riuscirà né a ripensare sé stesso, né a progettare una strategia.
Forse, l’unica certezza è che lo sfondamento al centro con politiche pro-market, da tanti evocato per giustificare la politica renziana, sia fallito quanto la riproposizione di ricette socialdemocratiche pre- globalizzazione avanzate dagli scissionisti. Per ragionare a testa fredda sul futuro bisogna chiudere un altro ciclo, quello renziano.
 «Un progetto per una nuova sinistra non può che ripartire da quel "pieno sviluppo della persona umana" che l'articolo 3 della Costituzione indica come bussola alla Repubblica. Mai come in questa estate essere e restare umani appare un obiettivo rivoluzionario».
«Un progetto per una nuova sinistra non può che ripartire da quel "pieno sviluppo della persona umana" che l'articolo 3 della Costituzione indica come bussola alla Repubblica. Mai come in questa estate essere e restare umani appare un obiettivo rivoluzionario».
Huffington Post online, 9 agosto 2017
Disumano. Tutto, in questa terribile estate 2017 ci pare disumano. Il caldo mostruoso e il fuoco che divorano l'Italia: e le piogge che iniziano a sgretolarlo, al Nord. E disumano appare un discorso politico che di fronte alla più grande questione del nostro tempo, la migrazione di una parte crescente dell'umanità, reagisce invocando la polizia. Un muro di divise che faccia nel Mediterraneo quello che vorrebbe fare il muro di Trump al confine col Messico.
Eppure no: è tutto terribilmente umano. È stato l'uomo a cambiare il clima. È stato l'uomo a innescare la grande migrazione: sono state la diseguaglianza, l'ingiustizia, la desertificazione, lo sfruttamento selvaggio dell'Africa, la stolta politica internazionale e le guerre umanitarie. "Ascoltate, e intendetemi bene: è dal cuore dell'uomo che escono i propositi di male", dice Gesù nel Vangelo di Marco.
Umano, dunque: terrificantemente umano. Di una umanità sfigurata dalla paura, dalla rabbia, dall'avidità. Parliamo di tutto questo quando parliamo della vittoria della destra: peggio, di una egemonia culturale della destra che si estende sul discorso pubblico. Una egemonia culturale che domina – piaccia o non piaccia: è un fatto – il maggior partito italiano: già di centro-sinistra, oggi inequivocabilmente vittima del pensiero unico della destra della paura e dell'odio. E ci sono almeno tre differenti tipi di destra che si stanno mangiando oggi il corpo del Pd.
La prima è quella che ha dominato il pensiero unico del centrosinistra negli ultimi decenni: quella del neoliberismo appena travestito da terza via blairiana. Quella per cui ormai siamo non solo in una economia, ma in una società, di mercato. A cui non c'è alternativa. Per esempio: nella legge sulla concorrenza approvata la settimana scorsa c'è un articolo che distrugge alla radice l'idea stessa di tutela dei beni culturali. Che si potranno esportare con una semplice autocertificazione basata sulle soglie di valore. Il denaro come unico metro, la totale libertà dell'individuo, l'abdicazione dello Stato. Un articolo esplicitamente scritto dalla lobby dei mercanti d'arte, un cui rappresentante sedeva nella commissione, nominata dal ministro Franceschini, che ha scritto la legge.
Un provvedimento settoriale, certo: ma che confermando ancora che il denaro è l'unica misura della libertà chiarisce molto bene l'orizzonte anti-umano di questo "centrosinistra".
La seconda destra è quella, più tradizionale,
del ministro Minniti. Una destra law and order che vuole mettere la polizia a bordo delle navi Ong: una destra perfino un po' grottesca, perché vorrebbe resuscitare la faccia poliziesca dello Stato avendo però smontato del tutto lo Stato. Se non è la Guardia Costiera a governare la situazione, nel Mediterraneo, è perché centrodestra e centrosinistra hanno indistinguibilmente distrutto lo Stato, definanziando e disprezzando tutto ciò che è pubblico, dalle forze di polizia alla scuola, dalla sanità alla forestale, dalle biblioteche ai pubblici ministeri. E non è certo militarizzando le Ong che si ricostruisce lo Stato. Come non è con il reato di immigrazione clandestina che si può sperare di affrontare l'età delle migrazioni.
La terza destra
è quella di Matteo Renzi. Una destra anarcoide, individualista e populista. Una destra che sostituisce allo Stato una somma di gated communities: comunità separate dai soldi, divise per censo. Una destra che non ha nessuna chiusura verso le libertà individuali, anzi le incoraggia in chiave antisociale. Gratificando privatamente i cittadini a cui si toglie ogni dimensione pubblica, sociale, comunitaria.
E, come ha scritto Guido Mazzoni in
una analisi molto fine:
«Se un certo fondo di anarchismo unisce la destra populista al modello liberale classico, ciò che li separa è l'ethos. La destra populista costruisce se stessa attorno a un'antitesi netta, identitaria, fra Noi e Loro. ... Il senso comune cui la destra populista si richiama nasce dall'arcaico: è l'ethos dei primi occupanti, che separa i legittimi dagli illegittimi, i normali dagli anormali, gli autoctoni dai barbari. Il gruppo dei primi occupanti trasforma la propria identità nel corso del tempo, includendo gruppi di secondi occupanti radicati, o mostrandosi più tollerante verso identità di genere e comportamenti che fino a qualche anno fa avrebbero portato all'esclusione, ma non viene mai meno l'asimmetria fra chi viene-prima e chi viene-dopo».
È esattamente questa la chiave culturale che permette di comprendere l'affermazione di Renzi sull'"aiutiamoli a casa loro".
Dove il punto è la contrapposizione delle case: la nostra, la loro. Un fortissimo richiamo identitario: il conflitto tra "Noi" e "Loro" che prende il posto del conflitto di classe e di censo, negato, rimosso, depotenziato. E questa terza destra, si badi, non è solo del leader: la mutazione riguarda tutto il partito, come dimostrano le affermazioni di una esponente della segreteria Pd sulla "razza italiana" da perpetuare, quelle di un senatore sul fatto che salvare vite umane non è un obiettivo (perché sono le Loro vite, beninteso), quelle della sindaca che aumenta le tasse a chi accoglie Loro.
Mi pare che se non si prenda atto di questa triplice involuzione destrorsa del Partito democratico tutti i discorsi sul futuro della Sinistra italiana non faranno i conti con la realtà. È davvero possibile un centrosinistra se il centro è questo? E una forza come Mdp (che vota la legge sulla concorrenza e sostiene il governo del Codice Minniti) ambisce a contrastare l'egemonia culturale di questa nuova destra espansiva, o ne è a sua volta vittima? Sono questi i nodi da sciogliere.
Perché oggi un progetto per una nuova sinistra non può che ripartire da quel "pieno sviluppo della persona umana" che l'articolo 3 della Costituzione indica come bussola alla Repubblica. Mai come in questa estate essere e restare umani appare un obiettivo rivoluzionario.
 Ampia documentazione dei primati raggiunti da Matteo Renzi e dai suoi scherani, Paolo Gentiloni incluso, nell'incrementare le spese di guerra in Italia e nel favorire i nostrani mercanti di morte e fomentatori di conflitti nel mondo.
Ampia documentazione dei primati raggiunti da Matteo Renzi e dai suoi scherani, Paolo Gentiloni incluso, nell'incrementare le spese di guerra in Italia e nel favorire i nostrani mercanti di morte e fomentatori di conflitti nel mondo.
Comune.info, 6 giugno 2017. Una denuncia da ricordare
RENZI È NELLA STORIA
Lo sa, ma non lo dice in pubblico. E la notizia non compare né sul suo sito personale, né sul portale Passo dopo passo e nemmeno tra “I risultati che contano” messi in bella mostra con tanto di infografiche da Italia in cammino. Eppure è stata la miglior performance del suo governo. Nei 1024 giorni di permanenza a Palazzo Chigi, Matteo Renzi ha raggiunto un primato storico di cui però, stranamente, non parla: ha sestuplicato le autorizzazioni per esportazioni di armamenti. Dal giorno del giuramento (22 febbraio 2014) alla consegna del campanellino al successore (12 dicembre 2016), l’esecutivo Renzi ha infatti portato le licenze per esportazioni di sistemi militari da poco più di 2,1 miliardi ad oltre 14,6 miliardi di euro: l’incremento è del 581 per cento che significa, in parole semplici, che l’ammontare è più che sestuplicato. Una vera manna per l’industria militare nazionale, capeggiata dai colossi a controllo statale Finmeccanica-Leonardo e Fincantieri. È tutto da verificare, invece, se le autorizzazioni rilasciate siano conformi ai dettami della legge n. 185 del 1990 e, soprattutto, se davvero servano alla sicurezza internazionale e del nostro paese.
Renzi e il motto di BP
Un fatto è certo: è un record storico dai tempi della nascita della Repubblica. Ma, visto il totale silenzio, il primato sembra imbarazzare non poco il capo scout di Rignano sull’Arno che ama presentarsi ricordando il motto di Baden Powell (BP è il fondatore degli scout): “Lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato”. L’imbarazzo è comprensibile: la stragrande maggioranza degli armamenti non è stata destinata ai paesi amici e alleati dell’Ue e della Nato (nel 2016 a questi paesi ne sono stati inviati solo per 5,4 miliardi di euro pari al 36,9 per cento), bensì ai paesi nelle aree di maggior tensione del mondo, il Nord Africa e il Medio Oriente. È in questa zona – che pullula di dittatori, regimi autoritari, monarchi assoluti sostenitori diretti o indiretti del jihadismo oltre che di tiranni di ogni specie e risma – che nel 2016 il governo Renzi ha autorizzato forniture militari per oltre 8,6 miliardi di euro, pari al 58,8% del totale. Anche questo è un altro record, ma pochi se ne sono accorti.
Il basso profilo della sottosegretaria Boschi
Eppure non sono cifre segrete. Sono tutte scritte, nero su bianco e con tanto di grafici a colori, nella “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento per l’anno 2016” inviata alle Camere il 18 aprile. L’ha trasmessa l’ex ministra delle Riforme e attuale Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi.
Nella relazione di sua competenza l’ex catechista e Papa girl si è premurata di segnalare che “sul valore delle esportazioni e sulla posizione del Kuwait come primo partner, incide una licenza di 7,3 miliardi di euro per la fornitura di 28 aerei da difesa multiruolo di nuova generazione Eurofighter Typhoon realizzati in Italia”. Al resto – cioè ai sistemi militari invitati in 82 paesi del mondo tra cui soprattutto quelli spediti in Medio Oriente – la Sottosegretaria ha riservato solo un laconico commento: “Si è pertanto ulteriormente consolidata la ripresa del settore della Difesa a livello internazionale, già iniziata nel 2014, dopo la fase di contrazione del triennio 2011-2013”.
La legge n. 185 del 1990, che regolamenta la materia, stabilisce che l’esportazione e i trasferimenti di materiale di armamento “devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia”: autorizzare l’esportazione di sistemi militari a paesi al di fuori delle principali alleanze politiche e militari dell’Italia meriterebbe pertanto qualche spiegazione in più da parte di chi, durante il governo Renzi e oggi col governo Gentiloni, ha avuto la delega al programma di governo.
I meriti della ministra Pinotti
Non c’è dubbio, però, che gran parte del merito per il boom di esportazioni sia della ministra della Difesa, Roberta Pinotti. È alla “sorella scout”, titolare di Palazzo Baracchini, che va attribuito il pregio di aver consolidato i rapporti con i ministeri della Difesa, soprattutto dei paesi mediorientali. La relazione del governo non glielo riconosce apertamente, ma la principale azienda del settore, Finmeccanica-Leonardo, non ha mancato di sottolinearne il ruolo decisivo. Soprattutto nella commessa dei già citati 28 caccia multiruolo Eurofighter Typhoon: “Si tratta del più grande traguardo commerciale mai raggiunto da Finmeccanica” – commentava l’allora Amministratore Delegato e Direttore Generale di Finmeccanica, Mauro Moretti. “Il contratto con il Kuwait si inserisce in un’ampia e consolidata partnership tra i Ministeri della Difesa italiano e del Paese del Golfo” – aggiungeva il comunicato ufficiale di Finmeccanica-Leonardo. Alla firma non poteva quindi mancare la ministra, nonostante i slittamenti della data dovuti – secondo fonti ben informate – alle richieste di chiarimenti circa i costi relativi “a supporto tecnico, addestramento, pezzi di ricambio e la realizzazione di infrastrutture”.
Anche il Ministero della Difesa ha posto grande enfasi sui “rapporti consolidati” tra Italia e Kuwait: “rapporti – spiegava il comunicato della Difesa – che potranno essere ulteriormente rafforzati, anche alla luce dell’impegno comune a tutela della stabilità e della sicurezza nell’area mediorientale, dove il Kuwait occupa un ruolo centrale”. Nessuna parola, invece, sul ruolo del Kuwait nel conflitto in Yemen, in cui è attivamente impegnato con 15 caccia, insieme alla coalizione a guida saudita che nel marzo del 2015 è intervenuta militarmente in Yemen senza alcun mandato internazionale. I meriti della ministra Pinotti nel sostegno all’export di sistemi militari non si limitano ai caccia al Kuwait: va ricordato anche l’accordo di cooperazione militare con Qatar per la fornitura da parte di Fincantieri di sette unità navali dotate di missili MBDA per un valore totale di 5 miliardi di euro, che però non compare nella Relazione governativa. Ma, soprattutto, non va dimenticata la visita della ministra Pinotti in Arabia Saudita per promuovere “affari navali” (ne ho parlato qualche mese fa e rimando in proposito ai miei precedenti articoli).
Le dichiarazioni dell’ex ministro Gentiloni
Una menzione particolare spetta all’ex ministro degli Esteri e attuale presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. È lui, ex catechista ed ex sostenitore della sinistra extraparlamentare, che più di tutti si è speso in difesa delle esportazioni di sistemi militari. Lo ha fatto nella sede istituzionale preposta: alla Camera in riposta a due Question Time. Il primo risale al 26 novembre 2015, in riposta a un’interrogazione del M5S, durante la quale il titolare della Farnesina, dopo aver ricordato che “… abbiamo delle Forze armate, abbiamo un’industria della Difesa moderna che ha rapporti di scambio e esportazioni con molti paesi del mondo…” ha voluto evidenziare che “è importante ribadire che l’Italia comunque rispetta, ovviamente, le leggi del nostro paese, le regole dell’Unione europea e quelle internazionali (pausa) sia per quanto riguarda gli embargo che i sistemi d’arma vietati”. Già, ma la legge 185/1990 e le “regole Ue e internazionali” non si limitano agli embarghi, anzi pongono una serie di specifici divieti sui quali Gentiloni ha bellamente sorvolato.
Nel secondo, del 26 ottobre 2016, in risposta ad un’interrogazione del M5S che riguardava nello specifico le esportazioni di bombe e materiali bellici all’Arabia Saudita e il loro impiego nel conflitto in Yemen, Gentiloni ha sostenuto che “l’Arabia Saudita non è oggetto di alcuna forma di embargo, sanzione o restrizione internazionale nel settore delle vendite di armamenti”. Tacendo però sulla Risoluzione del Parlamento europeo, votata ad ampia maggioranza già nel febbraio del 2016, che ha invitato l’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione, Federica Mogherini, ad “avviare un’iniziativa finalizzata all’imposizione da parte dell’UE di un embargo sulle armi nei confronti dell’Arabia Saudita”, in considerazione delle gravi accuse di violazione del diritto umanitario internazionale perpetrate dall’Arabia Saudita nello Yemen. Questa risoluzione, finora, è rimasta inattuata anche per la mancanza di sostegno da parte del Governo italiano.
Ventimila bombe da sganciare in Yemen
Rispondendo alla suddetta interrogazione, Gentiloni ha però dovuto riconoscere le “la ditta RWM Italia, facente parte di un gruppo tedesco, ha esportato in Arabia Saudita in forza di licenze rilasciate in base alla normativa vigente”. Un’assunzione, seppur indiretta, di responsabilità da parte del ministro. Il quale, nonostante i vari organismi delle Nazioni Unite e lo stesso Ban Ki-moon abbiano a più riprese condannato i bombardamenti della coalizione saudita sulle aree abitate da civili in Yemen (sono più di 10mila i morti tra i civili), ha continuato ad autorizzare le forniture belliche a Riad. E non vi è notizia che le abbia sospese, nemmeno dopo che uno specifico rapporto trasmesso al Consiglio di Sicurezza dell’Onu non solo ha dimostrato l’utilizzo anche delle bombe della RWM Italia sulle aree civili in Yemen, ma ha affermato che questi bombardamenti “may amount to war crimes” (“possono costituire crimini di guerra”).
Nella Relazione inviata al Parlamento spiccano le autorizzazioni all’Arabia Saudita per un valore complessivo di oltre 427 milioni di euro. Tra queste figurano “bombe, razzi, esplosivi e apparecchi per la direzione del tiro” e altro materiale bellico. La relazione non indica, invece, il paese destinatario delle autorizzazioni rilasciate alle aziende, ma l’incrocio dei dati forniti nelle varie tabelle ministeriali, permette di affermare che una licenza da 411 milioni di euro alla RWM Italia è destinata proprio all’Arabia Saudita: si tratta, nello specifico, dell’autorizzazione all’esportazione di 19.675 bombe Mk 82, Mk 83 e Mk 84. Una conferma in questo senso è contenuta nella Relazione Finanziaria della Rheinmetall (l’azienda tedesca di cui fa parte RWM Italia) che per l’anno 2016 segnala un ordine “molto significativo” di “munizioni” per 411 milioni di euro da un “cliente della regione MENA” (Medio-Oriente e Nord Africa).
La legge n. 185/1990 vieta espressamente l’esportazione di sistemi militari “verso Paesi in conflitto armato e la cui politica contrasti con i princìpi dell’articolo 11 della Costituzione”, ma – su questo punto – nessun commento nella Relazione. E nemmeno da Renzi. Men che meno da Gentiloni. Che l’attuale capo del governo si sia dato come obiettivo quello di migliorare la performance di Renzi nell’esportazione di sistemi militari?

«». 7 maggio 2017 (p.d.)
Di Firenze resistente ho sentito parlare per la prima volta da Edoardo Detti, assessore all'urbanistica del Comune, ispiratore del piano regolatore della città dei primi anni Sessanta. Detti era un urbanista-professore e raccontava Firenze agli studenti con parole semplici, auspicava la sua capacità di conservarsi in salute, per continuare ad essere di tutti. Poi anche per Firenze sarebbero arrivati giorni difficili, aggressioni tentate e alcune riuscite, sempre incombenti i progetti di speculazione proporzionali ai elevati valori immobiliari da quelle parti. Nel 1989 il clamoroso no di Occhetto al disegno squilibrato per costruire la nuova città nella piana di Castello, stop al patto supino, il Comune subalterno a Fondiaria & C. Del seguito parlano le inchieste e le sentenze. Si racconta anche di questa storia nel libro – a cura di Ilaria Agostini – Urbanistica resistente nella Firenze neoliberista: perUnaltacittà 2004-2014, Aión, 2016.
Un caso esemplare che spiega il rinnovato interesse alle trasformazioni di aree di pregio del Paese da parte di potenti uomini d'affari in ottimi rapporti con la politica. Un programma per molte città italiane non percepito dai più. A lasciar fare, si sa, la vita nelle aree urbane peggiora, e ad essere penalizzati sono normalmente i più deboli. A Firenze c'è chi ha deciso di farci caso e di non lasciar fare; e di replicare nel merito ai teorici delle città funzionali alla rendita immobiliare, pure se chiamate
smart-city.
Un movimento attivo pure al tempo di Matteo Renzi amministratore della Provincia e poi del Comune (2004-2014) che ostentava la discontinuità con il passato. Calcando la scena toscana con con lo stile politico ridimensionato di recente (la rottamazione se conviene, decisioni fulminee, tutto
storytelling, ecc.). Criticato dai suoi oppositori fiorentini per il messaggio incubato “Firenze città delle opportunità”, meno tutele per la città dei tesori/più vantaggi per gli investitori.
Firenze, la palestra dove il sindaco si è preparato per trasferire il modello di governo locale alla scala dell'intero Paese. SbloccaItalia un primo traguardo immaginato nel corso dell'allenamento fiorentino. La legge per l'emancipazione dagli intoppi burocratici e dai tempi di valutazione dei progetti, mentre un po' dappertutto si rafforzava l'idea che ogni forma di cittadinanza fosse assoggettabile alle ambizioni di grandi costruttori, Sgr, gestori di fondi,
general contractor, società di
project management e via dicendo. Tutta roba che regalerà al Paese la sventola della bolla edilizia e anche di questo si parla nel libro.
Ilaria Agostini lo spiega bene, raccogliendo e richiamando opportunamente i contributi degli autori del volume. E indica la strada per reagire. Lo strumento è la mobilitazione civica sull'esempio di quella sperimentata a Firenze. Una forma di partecipazione svincolata dagli schemi convenzionali dei dibattiti pubblici guidati dalle istituzioni. Imprevista dal sindaco Renzi e raccolta attorno alla lista “perUnaltracittà” (poi laboratorio politico) a guida di Ornella De Zordo, massima l'attenzione ai temi urbanistici con il più alto grado di competenza, indispensabile per organizzare la resistenza della
civitas per l'
urbs. Per conservare le città che “avvolgono di poesia la vita di coloro che vi abitano” – sono parole di Simone Weil.
Un libro utile a chi è interessato alle vertenze per il diritto alla città, ma anche a chi volesse saperne di più su evoluzione e affaticamento del renzismo. È uscito circa un anno fa, quando le politiche di Renzi avevano un indice di consenso più alto; e letto allora il giudizio di “perUnaltracittà” poteva sembrare eccessivo e rubricabile tra le polemiche di provincia. Esaminato oggi, tante cose si capiscono meglio, dal particolare al generale. D'altra parte Firenze non è un dettaglio. E neppure Renzi.
Scritto per eddyburg e inviato contemporaneamente a La Nuova Sardegna.
 Il groviglio. Denis Verdini, Tiziano Renzi, Luca Lotti, Alfredo Romeo: qualcosa brucia anche attorno a Rignano, Toscana. Articoli di Massimo Franco, Ezio Mauro, Marco Travaglio.
Il groviglio. Denis Verdini, Tiziano Renzi, Luca Lotti, Alfredo Romeo: qualcosa brucia anche attorno a Rignano, Toscana. Articoli di Massimo Franco, Ezio Mauro, Marco Travaglio.
Corriere della sera, la Repubblica, il Fatto Quotidiano, 4 marzo 2017
Il Fatto Quotidiano
COMPAGNI DI MERENDE
di Marco Travaglio
L’altroieri, mentre i carabinieri arrestavano Alfredo Romeo a Napoli e perquisivano Carlo Russo a Scandicci, si spegneva a 86 anni, in un ospizio vicino a Firenze, Fernando Pucci, l’ultimo dei “compagni di merende” balzati agli onori delle cronache giudiziarie negli infiniti processi per i delitti del mostro di Firenze. Per anni il suo nome fu associato a quelli degli altri compari: Pietro Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti. Nessuna parentela con lo scandalo Consip, per carità: sia perché in quei processi si parlava di omicidi, in questa inchiesta invece al massimo di corruzioni, traffici di influenze, soffiate e favoreggiamenti; sia perché allora il Pucci e il Lotti erano testimoni d’accusa che collaboravano con la giustizia, mentre ora il Renzi e il Lotti (il ministro Luca, solo omonimo) sono indagati e negano pure l’evidenza. Ma la suggestione dei compagni di merende, cioè di quel mondo di furbi provincialotti di paese che si vedono al bar tabacchi e custodiscono segreti inconfessabili, viene naturale alla lettura delle carte dell’inchiesta Consip. Torna alla mente quel che disse della sua Firenze un cittadino doc come Dante Alighieri a Jacopo Rusticucci nel girone dei sodomiti, al canto XVI dell’Inferno: “La gente nova e i sùbiti guadagni/ orgoglio e dismisura han generata,/ Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni”. È più o meno quel che accadde quattro anni fa, quando dal contado toscano marciò e poi marcì su Roma quello che la stampa del servo encomio nobilitò come Giglio Magico e che oggi la stessa stampa convertita al codardo oltraggio sbeffeggia come Giglio Tragico o Giglio Marcio.
Stiamo parlando del Renzi da Rignano e poi da Pontassieve, del Lotti da Empoli, della Boschi da Laterina (Arezzo), del Bonifazi della Gavinana e di tutta l’allegra brigata, ben presto seguita alla luce del sole dal Verdini da Fivizzano (Lunigiana) e nell’ombra da babbo Renzi (sempre da Rignano), da babbo Boschi (sempre da Laterina), da Carlo Russo da Scandicci e da tutto il cucuzzaro. Un mondo chiuso, a parte, di gente nova irresistibilmente attratta da sùbiti guadagni. O, per dirla con Rino Formica, impareggiabile coniatore di definizioni immortali (“la politica è sangue e merda”, “intorno a Craxi vedo solo nani e ballerine”): “Renzi non ha cultura politica. È il provinciale che va in città, quello che entra nel negozio di lusso e tocca la merce, l’annusa”. Chissà se il babbo trafficava per sé o per altri (“il sangue – spiega Formica a Repubblica – oggi è sofferenza altrui, mentre la merda, il lavoro sporco, lo devono fare gli altri”).
E chissà se il figlio era come i cornuti, l’ultimo a sapere ciò che parenti e amici sapevano benissimo. In attesa di scoprirlo, non c’è miglior definizione di quella di Formica per una combriccola di parvenu troppo rapidamente assurti a statisti, riformatori, financo padri costituenti. Tutti accomunati da un’attrazione fatale per i furbastri, gli spregiudicati, talvolta anche i pregiudicati. Come dimenticare la prima comparsata del giovin Matteo a Canale5, alla Ruota della Fortuna? E poi la visita clandestina alla villa di Arcore da sindaco di Firenze, subito svelata dal padrone di casa per far capire chi dei due era quello furbo? E la missione romana di babbo Boschi che, volendo salvare Banca Etruria, si affida al re dei faccendieri d’antan Flavio Carboni, condannato definitivamente per bancarotta fraudolenta?
Uno legge le carte dell’inchiesta Consip, tra presunti pranzi “in bettola”, presuntissime tangenti cash col “metodo della mattonella” (come Totò e Peppino alle prese con la malafemmina), probabili “bistecchine” mangiate chissà dove con Romeo, i pizzini di quest’ultimo stracciati e ricomposti in discarica, le incursioni nel bosco di Rignano per confidarsi con gli amici del bar che ormai aveva troppi orecchi, le Srl di mamma Lalla, e tutto torna. Non sul piano giudiziario, per cui occorrerà attendere i classici 10-15 anni di processi. Né su quello della responsabilità etico-politica, concetto ormai caduto in desuetudine almeno quanto il conflitto d’interessi (infatti si continua a ripetere che le colpe dei padri non ricadono sui figli, come se fosse normale che il padre del capo del governo faccia affari con imprenditori che fanno affari con il governo). Ma sul piano antropologico ed estetico, che spiega la politica degli ultimi anni meglio di qualunque saggio o editoriale.
Per chi voleva vedere e capire, non c’era mica bisogno dell’ultima indagine. Di avvisaglie erano piene le cronache, soprattutto del Fatto, e qualche libro (chi ha letto i due dedicati al clan Renzi dal nostro Davide Vecchi lo sa bene) degli ultimi tre anni, anche se le meglio penne del bigoncio giravano alla larga, almeno finché il referendum del 4 dicembre non consegnò al Paese il certificato di morte almeno provvisoria del padrone pro tempore dItalia. Bastava unire i puntini, e già il disegno veniva fuori chiaro e lampante. Ricordate le decine di Rolex anche d’oro massiccio donati da sovrano dell’Arabia Saudita al premier Matteo e alla sua corte venuta a Riyadh a omaggiarlo? La legge, trattandosi di regali superiori ai 300 euro, imponeva di depositarli in un magazzino di Palazzo Chigi a disposizione dello Stato, invece sono spariti tutti, tranne uno: quello dell’irreprensibile interprete arabo. Chissà mai chi se li è fregati.
Ricordate gli scontrini nascosti dall’ex sindaco di Firenze passato nel frattempo a miglior carriera e dal suo successore, il sindaco al Plasmon Dario Nardella, sulle sue spese non proprio tutte “istituzionali” rimborsate dal Comune ai tempi di Palazzo Vecchio, proprio mentre il suo partito scacciava per molto meno il sindaco di Roma Ignazio Marino davanti a un notaio? Tra le poche ricevute emerse dalle indagini della Corte dei conti, il Fatto scoprì quelle di un viaggio Firenze-Roma del Renzi e del Lotti di nove anni fa: i due figli papà democristiani, l’uno sindaco di Firenze l’altro capo di gabinetto, ogni volta che erano chiamati nella Capitale da imprescindibili impegni politici nazionali, sceglievano di soggiornare all’Hotel Raphael di largo Febo, che Craxi aveva eletto a sua residenza capitolina, che ospitava i vertici con politici, faccendieri e portamazzette, che nel ’93 fece da sfondo al celebre lancio di sputi e monetine, e da cui un anno dopo – perduta l’immunità parlamentare – Bettino partì per l’ultimo viaggio dall’Italia ad Hammamet.
Una scelta curiosa, per una giovane marmotta democristiana che si era laureata in Legge con tesi su Giorgio La Pira e, divenuta sindaco, aveva respinto come “diseducativa” la proposta dei nostalgici del craxismo di dedicare una piazza di Firenze all’”esule” Bettino e infine da premier aveva rivendicato l’eredità di Berlinguer dall’appropriazione di Casaleggio. Ma forse il Raphael era semplicemente una scelta simbolica dello spirito-guida che segretamente si era scelto come modello politico. Tant’è che quasi tutti i reduci del craxismo arrembante, da Ferrara a Minoli, da Sacconi a La Ganga, senza dimenticare le truppe di complemento come Napolitano e Amato, avevano eletto “Renxi” a loro nuovo beniamino. E lui era ripartito proprio da Craxi, senza peraltro averne la stoffa: la “grande riforma” della Costituzione con Verdini, il decisionismo, il rampantismo, l’antiparlamentarismo, l’harem di imprenditori-prenditori e manager-magnager di fiducia, lo stuolo di leccapiedi, il culto della personalità, la Leopolda al posto della piramide di Panseca, le leggi pro-Mediaset e anti-giudici, il garantismo peloso (ma solo per gli amici) e la scomunica a Mani Pulite “barbarie giustizialista”.
E ora, inevitabile nemesi storica, a dannarlo arriva il Fattore S, come soldi. O A, come affari, sia pure non per linea diretta, ma ereditaria. Qualche webete già profetizza un imminente trasloco nella villa di Hammamet o nell’ospizio di Cesano Boscone, ma sarebbe troppo. Siccome, diceva Marx, le tragedie della storia tendono a ripetersi in forma di farsa, per questi compagni di merende pare eccessivo anche il bar sport di Rignano.
La Repubblica
IL GROVIGLIO
DEI FEDELISSIMI
di Ezio Mauro
TUTTI i nodi non sciolti negli anni del comando stanno soffocando Matteo Renzi oggi, nei mesi della sconfitta, e ciò che più conta rischiano di trascinare a fondo con lui l’intera parabola del Pd, tra scissioni, tesseramenti gonfiati, avvisi di garanzia. Sono nodi politici e giudiziari, riassumibili in un unico concetto: il groviglio del potere cresciuto intorno all’ex presidente del Consiglio, che lo ha coltivato o tollerato nell’illusione di proteggersi, fino a restarne imprigionato.
È infatti la concezione del potere del leader che merita fin d’ora un giudizio, mentre giustamente si attende che le ipotesi d’accusa dei magistrati inquirenti vengano accertate, e intanto gli indagati hanno il diritto di essere considerati giudiziariamente innocenti fino a prova contraria. Dunque l’inchiesta dirà se Tiziano Renzi approfittava del ruolo pubblico del figlio per influenzare nomine e appalti, se il ministro Lotti ha avvisato i vertici Consip dell’indagine in corso e addirittura delle “cimici” negli uffici, in modo che venissero rimosse.
Se Romeo teneva a libro paga il padre del premier, come credono i carabinieri che hanno materialmente ricostruito dalla spazzatura dell’imprenditore un appunto stracciato dove una “T.” figura accanto all’indicazione: 30 mila per mese.
Ma nell’attesa è inevitabile chiedere conto a Renzi di ciò che è già evidente, e soprattutto è sufficiente: il meccanismo di controllo e influenza che ha creato intorno a sé, nominando uomini di provata fedeltà personale nei centri più sensibili del potere pubblico, lasciando germogliare filoni di interesse privato che intersecano quei punti decisionali, mescolando come nei peggiori anni della nostra vita lobby, Stato e famiglia, perché da noi la degenerazione del potere pubblico passa spesso per scorciatoie affettive e tentazioni domestiche.
Ogni leader ha naturalmente il diritto di scegliersi gli uomini di fiducia, e può certo farlo rivolgendosi ai più vicini. Ma quando ha una responsabilità generale, perché non risponde soltanto di sé ma del governo del Paese e del destino di un partito, ha anche il dovere di scegliere le persone più brave d’Italia, non le più fedeli di Rignano. C’è certamente in Renzi una confusione tra Paese e paese. Ma c’è qualcosa di più, che si spiega in termini politici, non geografici o sociologici.
È l’eterna sindrome minoritaria di leader che non riescono a liberarsene nemmeno quando conquistano la maggioranza, senza capire che la vera supremazia sta nell’egemonia e non nelle tessere, nella nuova cultura che si installa e non nelle correnti che si contano, alleandosi oggi per separarsi domani. Potremmo dunque dire, paradossalmente per un leader egocentrico, che il vero limite di Renzi è di ambizione: pensare eternamente a proteggersi dai colpi e a colpire invece che a convincere e conquistare. Con un progetto capace di presentare una nuova sinistra come leva del cambiamento di un Paese in crisi, in un discorso di verità, tenendo insieme le eccellenze e le sofferenze italiane, in un nuovo disegno di società. Un disegno in cui si riconoscano tutte le anime della sinistra italiana, nella legittima e libera interpretazione che il leader del momento è chiamato a dare, facendosi però carico di una vicenda comune, di storie personali, di una tradizione che parla a un terzo del Paese.
Tutto questo non c’è stato. Più che come un leader, Renzi è calato sul Pd come un raider, che oggi viene accusato politicamente di insider trading, lasciando che rivoli di interesse pubblico zampillassero verso congreghe familiste o amicali, con al centro il potere, il denaro, gli appalti. L’ex premier deve dire al Paese — e al suo partito che sta per scegliersi il segretario con le primarie — se sapeva, se sospettava, se immaginava: e se no, deve dire cos’ha pensato quando ha scoperto che l’uomo da lui messo alla guida della centrale degli appalti pubblici toglie le “cimici” perché un ministro e il vertice dei carabinieri lo avvertono, quando lo stesso capo della Consip rivela che proprio da Tiziano Renzi dipendeva il suo destino professionale, fino alla revoca della nomina.
L’unica cosa che Renzi non può fare è stare zitto o rovesciare il tavolo attaccando la magistratura come lo incitano i berlusconiani, memori di una pratica abituale a destra. Ma la comunità politica a cui Renzi si rivolge e dalla quale deriva la sua legittimità ha sensibilità differenti, e pretese diverse. E infatti ieri Renzi ha incominciato a sciogliere il nodo famigliare dicendo che se suo padre è colpevole deve pagare due volte.
Resta il nodo politico, intatto. E qui, infine, c’è una risposta che Renzi deve dare a se stesso. Dove lo ha portato quel sistema fondato sugli amici degli amici, asfittico e famelico? La presidenza del Consiglio non meritava qualche ambizione in più di una gestione toscana degli appalti? Domande inevitabili, perché non si può predicare l’innovazione e poi rinchiudersi nella cerchia ristretta di un Consiglio comunale in gita premio a Roma, con visita fugace alle istituzioni. Mentre bisognerebbe sapersi accontentare della sovranità legittima appena conquistata, senza cercare una quota ulteriore e ambigua di sovranità impropria.
Tutto questo Repubblica lo ha chiesto pubblicamente all’ex presidente del Consiglio in un’intervista all’inizio dell’anno: perché scegliere i fedelissimi fiorentini per guidare la macchina governativa, dalla Manzione a Lotti, fino a Carrai incredibilmente proposto per la guida delle cyber security invece di qualche ufficiale dei carabinieri laureato al Mit dopo aver giurato fedeltà alla Repubblica e non al premier? Perché un capo della Rai scelto nel bouquet della Leopolda? Perché governare con Verdini, e usare il Pd come un taxi per arrivare a Palazzo Chigi? Perché questa attrazione fatale per gli imprenditori e per le banche? Perché non pretendere che quando si ha l’onore di guidare la sinistra e la responsabilità di presiedere il governo i propri familiari si astengano da affari che riguardano il potere pubblico?
Le questioni erano tutte sul tavolo, tre mesi fa. Renzi ha perso tempo, e il tempo non è neutrale. Non ci sarà nessun nuovo inizio se non si parte da qui, dalla denuncia di un sistema di potere malato, e da un sovvertimento radicale di uomini, di metodi, di mentalità. Dopo gli amici, è arrivato il tempo di parlare ai cittadini.
Corriere della sera
I TIMORI
DEL TUTTI CONTRO TUTTI
di Massimo Franco
Non più un Pd che considera quello di Paolo Gentiloni un «governo amico». Semmai, il premier costretto in qualche modo a tenersi a distanza dal suo partito, per i lampi di instabilità che sprigiona.
L a ricaduta immediata di quanto sta succedendo con le inchieste giudiziarie sulla Consip sembra questa. E il presidente del Consiglio l’ha capito così bene che ieri l’ha raccomandato a tutti i membri dell’esecutivo. Non è scontato che lo smarcamento riesca: dipenderà molto da come e a chi si allargheranno le indagini della magistratura, che coinvolgono il padre dell’ex premier, Tiziano Renzi, interrogato ieri, e il ministro dello Sport, Luca Lotti.
Ma Gentiloni è costretto a ritagliarsi margini di autonomia dal Pd, per non essere risucchiato nella sua crisi. Solo rispondendo al Paese, e non ai dem, può evitare di diventare il capro espiatorio delle tensioni interne. Perché già si intravede la seconda conseguenza di questa vicenda imbarazzante e opaca: trasformare il prossimo congresso del Pd in una sorta di ring dove si celebrerà il rito del «tutti contro tutti». Con la politica tenuta in un angolo, e le accuse di affarismo, disonestà, giustizialismo bene in vista; e destinate a dominare un dibattito avvelenato dall’eco delle inchieste.
La tentazione di rinviare tutto, primarie e congresso, si è affacciata nelle ultime ore ma per adesso è stata ricacciata indietro. Da Renzi, perché significherebbe ammettere difficoltà vistose, che tra qualche mese potrebbero aumentare e gli precluderebbero la strada verso la conferma alla leadership. E dai suoi concorrenti, perché i colpi che arrivano alla nomenklatura renziana dal tesseramento gonfiato e dal caso Consip si aggiungono alle convulsioni della scissione; e danno a Michele Emiliano e Andrea Orlando, governatore della Puglia e ministro della Giustizia, la speranza di contrastare una rielezione finora quasi scontata.
Forse, però, è la terza ricaduta che dovrebbe preoccupare di più i vertici del Pd. Riguarda la sconnessione evidente tra la realtà autoreferenziale raccontata da loro, e il fastidio che si capta nell’opinione pubblica. Renzi vede una situazione surreale e attacca «i processi fatti dai giornali». Ma surreale è un po’ tutto. Lo è il modo impietoso col quale alcuni avversari interni adesso lo attaccano: una virulenza assente prima della sua sconfitta referendaria. Lo è la iattanza dell’ex premier, che si difende con le unghie ma come se si trattasse di una manovra nata dal nulla. Lo è il silenzio dei suoi alleati, che si limitano a stare a guardare.
Rischiano di essere le premesse di un cannibalismo tra le tribù congressuali del Pd che, se non viene fermato in tempo, farà stappare ettolitri di champagne a Beppe Grillo. Un sistema in affanno ripropone la solita domanda di fondo: e cioè come mai, per l’ennesima volta, la politica si sia dovuta affidare alla supplenza della magistratura per capire che stava succedendo. E perché un partito che guida l’Italia da oltre tre anni in nome di un rinnovamento catartico, e inneggia al primato della politica, ha finito per umiliarla: se non altro perché non ha prodotto anticorpi in grado di arginare la commistione con l’affarismo.
La fauna umana e gli intrecci economici che emergono parlano di un ambiente intossicato da lobby di provincia fameliche e maldestre. Colpisce soprattutto questo, nello scandalo Consip: la caratura mediocre dei personaggi, il livello basso dei loro intrecci. Non c’è nessuna grandezza, nel declino della nomenklatura. Il ridimensionamento non avviene per un passaggio epocale della politica. Sfilano personaggi di un’Italietta che si crede furba e risponde a cliché al limite della caricatura. Solo che in una fase come questa può fare danni seri. E consegnare l’Italia a un populismo che ingrassa proprio grazie a una politica presuntuosa quanto permeabile all’infiltrazione di poteri esterni.
 L'impiego di due attrezzi ha caratterizzato il progetto renziano. Il primo, rendere dominanti l'ideologia e la prassi del neoliberismo (banche si, democrazia no, lavoro no). Il secondo, costruire un sistema di potere basato sul ricatto, la corruzione, l'impadronimento di fondi pubblici, la feudalizzazione delle istituzioni istituzionali. Il referendum del 4 dicembre ha incrinato il primo attrezzo, la magistratura sta smantellando il secondo.
L'impiego di due attrezzi ha caratterizzato il progetto renziano. Il primo, rendere dominanti l'ideologia e la prassi del neoliberismo (banche si, democrazia no, lavoro no). Il secondo, costruire un sistema di potere basato sul ricatto, la corruzione, l'impadronimento di fondi pubblici, la feudalizzazione delle istituzioni istituzionali. Il referendum del 4 dicembre ha incrinato il primo attrezzo, la magistratura sta smantellando il secondo.
il manifesto, 3 marzo 2017
Sul sistema degli appalti pubblici, l’amministratore delegato di Consip dice ai magistrati che «l’imprenditore Carlo Russo mi ha chiesto di intervenire su un appalto da 2,7 miliardi di euro per conto del babbo di Matteo e di Verdini». La rivelazione arriva a mezzo stampa attraverso le colonne de l’Espresso, è clamorosa e c’è poco da ricamare.
Del resto l’amministratore delegato di Consip, Marroni, dipendente dal ministro del Tesoro (Padoan gli ha appena confermato la fiducia) non si vede perché dovrebbe inventare le pressioni di un imprenditore toscano. Pressioni e richieste, possiamo immaginare, all’ordine del giorno. Meno normale che avvengano per conto di Renzi padre e dell’amico Verdini, proprio ieri condannato a 9 anni per bancarotta e frode.
Naturalmente non è il caso di imbastire processi a mezzo stampa. Anche perché è appena successo che il presidente del Pd campano, Stefano Graziano, accusato di intendersela con la camorra, sia stato scagionato dall’infamante accusa.
Quello che, invece, è politicamente importante, purtroppo è anche desolante e preoccupante. Si tratta di problema strutturale, la corruzione, che riguarda la destra e la sinistra. In Italia, come denunciava Berlinguer in una famosa intervista a Eugenio Scalfari nel 1976, la tangente origina «dall’occupazione dello Stato da parte dei partiti governativi». Un sistema di potere, di soldi e di partiti allora forti oggi morenti, che lasciano il campo a clan familiari.
In questo caso famiglie molto attive in Toscana con storiacce di banche fallite, di consulenze richieste a personaggi come Flavio Carboni, di grandi sintonie politiche con Verdini. E via elencando, compresi naturalmente i finanziatori della new-age renziana con elargizioni arrivate da chi è oggi in una cella di Regina Coeli, come l’imprenditore Alfredo Romeo. Un mondo salito alla ribalta del governo del paese.
Il Renzi padre smentisce tutto, il Renzi figlio va in tv a dire che ha fiducia nei magistrati, il ministro Lotti respinge al mittente i sospetti di coinvolgimento. Accusa e difesa si fronteggiano, ma in attesa di una sentenza, il Pd e l’ex presidente del consiglio sono travolti da una bufera politico-giudiziaria che coincide con l’avvio parecchio travagliato di un congresso e con la sfida delle primarie più “giudiziarie” della storia.
C’è un candidato, Renzi, che ha gravi problemi in famiglia. C’è il candidato Orlando che è anche ministro della giustizia. E c’è il candidato Emiliano che sarà sentito, lui magistrato, come testimone nell’inchiesta. E quando si gira lo sguardo al tesseramento del Pd campano lo spettacolo non è confortante.
Si lascia intravedere l’ipotesi di un ingorgo corruttivo che i magistrati tentano di dipanare mentre la politica annaspa. I legami potere-imprese, la ricca fauna di lobbisti e millantantori che fa da sfondo a un ristretto numero di contendenti i quali ambiscono a spartirsi tutta la torta del denaro pubblico, come raccontano alti funzionari infedeli che vuotano il sacco per sfuggire alla galera.
Ce n’è in abbondanza per dire che l’anomalia italiana fa sembrare lo scandalo Fillon che illumina le presidenziali francesi, una commediola di provincia.
 «L’attivismo di Renzi per tornare al potere appartiene al campo del tragico. Senza più alcuna credibile capacità offensiva, la sua presenza al timone è la garanzia più certa del naufragio inevitabile.».
«L’attivismo di Renzi per tornare al potere appartiene al campo del tragico. Senza più alcuna credibile capacità offensiva, la sua presenza al timone è la garanzia più certa del naufragio inevitabile.».
il manifesto 18 dicembre 2016
L’assemblea di oggi del Partito democratico dovrebbe rispondere a una domanda: quali caratteri di sistema ha la sconfitta di Matteo Renzi? Il plebiscito, che lo ha travolto, è il frutto di un processo lungo di perdita di ogni credibilità.
Nessun leader può vincere in una contesa se la sua stessa parola, a maggior ragione dopo un abbandono così riluttante, è percepita come ingannevole. Quando il loro leader ha perso l’ethos, ovvero il carattere, l’immagine che rende rispettabile, e degna di essere seguita, una figura pubblica, i ceti politici di supporto devono prendere gli accorgimenti inevitabili: affidarsi a un altro capo per sopravvivere. Occorre che qualcuno persuada i dirigenti del Pd oggi riuniti che è necessario che "pria facciate al duce spento/successor novo, e di voi cura ei prenda". Ma il Pd, che ha scambiato la personalizzazione della politica con il partito della persona, ha smembrato questo argine. E quindi, mentre il sistema bipolare proprio con il referendum ha replicato il grande crollo del 2013, si coltiva l’illusione di una sua restaurazione imminente, ad opera dello stesso leader annichilito, che crede di avere in dote un potere personale.
Dopo il tracollo di dicembre, che è il compimento di un ciclo e non una eruzione improvvisa di cieca protesta, Renzi non ha più alcuna seria possibilità di trionfo. Questo non significa che ormai irrilevante risulti la sua ombra nella prossima battaglia. «Nessun problema politico – spiegava Bismarck – giunge ad una completa soluzione di tipo matematico. I nodi appaiono, hanno i loro tempi, e poi scompaiono soltanto sotto altri problemi». Finché non si completa il seppellimento del capo, la cui fascinazione è dileguata, altri problemi non compaiono a strutturare i nuovi conflitti.
Non porterà alcun effetto ricostituente per la democrazia la cura rivoltante di un governo sotto tutela dei consoli gigliati spediti a presidiare palazzo Chigi. Accresce ancor più la rabbia un esecutivo che occupa il tempo solo per scaldare la poltrona vacante e riconsegnarla al capo voglioso di riavere lo scettro che ha solo accantonato per qualche mese.
Un leader del tutto annebbiato impone alle sue truppe una mappa irrealistica di risalita perché è saltato il sistema bipolare. Renzi pensa ancora ad un traino leaderistico esercitato dal capo con un preteso dono carismatico: spento rito delle primarie, incoronazione nella marcia dei gazebo e poi assalto disperato al palazzo. Il punto di debolezza della sua strategia è evidente: confida in un nuovo congegno maggioritario per blindare un bipolarismo solo immaginario.
L’attivismo di Renzi per tornare al potere appartiene al campo del tragico. Senza più alcuna credibile capacità offensiva, la sua presenza al timone è la garanzia più certa del naufragio inevitabile. Anche per questa sua vulnerabilità estrema il M5S lo ha irriso chiedendogli di rimanere a palazzo Chigi sino al voto. Non spaventa più come leader in ascesa, e perciò da temere, e anzi il suo spettro, che emana il volto sfigurato di una potenza in decadenza, incrementa le chances di successo dei nemici. È il peggio che possa capitare per un leader.
La conseguenza della sua nuova scalata alla guida del Pd sarebbe l’esplosione inevitabile del suo partito, entro il quale proprio il suo comando assoluto costituisce il principale elemento divisivo e l’ostacolo insuperabile ad ogni ipotesi di alleanza. Che i notabili del suo giro non ne tengano conto, e fingano di essere ancora sedotti dalla promessa di un simulacro di ordine bipolare, è anch’essa una manifestazione di propensione al tragico.
L’abbandono renziano, con la nostalgia dell’immediato ritorno, coltiva il vizio assurdo di esorcizzare un sistema tripolare con l’energia, con la stabilizzazione di una conquista del centro mediante un regime personale da consolidare attraverso la ripresa economica. Orfano del bipolarismo violato dal popolo, Renzi può mantenerne in vita una caricatura, con il progetto evaporato del partito della nazione, che assorbe i residui del berlusconismo e si erge a paladino del sistema della legittimazione che combatte e isola le forze antisistema (la Lega e il M5S).
Rientrano nel grottesco le gesta di un leader che dal buen retiro di Rignano minaccia di tornare presto al palazzo brandendo un’ipotesi già sconfitta: il bileaderismo. Renzi? È un problema in astratto risolto che però resiste complicando così le trame di un sistema che non può dedicarsi alle nuove questioni perché deviato dalle velleità di ritorno in sella di un leader del passato. Eppure l’accantonamento di Renzi è la condizione, non sufficiente e però indispensabile, per rispondere ai segnali sempre più preoccupanti di involuzione del sistema.
 Nonostante la potenza di fuoco mediatico, la forte capacità di acquisizione del consenso con i mille strumenti del dominio moderno, temono un altro fprte segnale di dissenso popolare. Le inventano tutte per sopravvivere nella loro palude.
Nonostante la potenza di fuoco mediatico, la forte capacità di acquisizione del consenso con i mille strumenti del dominio moderno, temono un altro fprte segnale di dissenso popolare. Le inventano tutte per sopravvivere nella loro palude.
Il manifesto, 14 dicembre 2016
Se quello sulla Costituzione ha provocato un terremoto, il referendum sul jobs act potrebbe essere uno tsunami di proporzioni ancora più imponenti, elettoralmente e socialmente. Non è difficile immaginare come voterebbero gli italiani sul tema del lavoro, giustamente in cima alle preoccupazioni di tutti, giovani in prima fila, saldamente in testa ai sondaggi sulle priorità del paese. Ed è la ragione per cui questo voto molto probabilmente ci verrà sottratto.
Tutto dipende da quanto durerà il governo, cioè quando Renzi deciderà di staccare la spina a Gentiloni, perché in caso di elezioni anticipate il referendum appunto salterebbe. E il più interessato a farlo naufragare è proprio Renzi, davvero costretto a ritirarsi a vita privata nel caso di un’altra batosta.
Ora il tema torna di attualità e in controluce agita gli schieramenti politici. Come dimostra il botta e risposta a distanza tra il ministro del lavoro Poletti, e la leader della Cgil Susanna Camusso.
Il ministro è sicuro che «si andrà alle elezioni prima del referendum». In replica Camusso ha esortato a «lasciar lavorare la Corte provando a essere rispettosi e a non fare pressioni». In soccorso di Poletti (che poi ha chiesto di non essere strumentalizzato, così cadendo nella classica excusatio non petita accusatio manifesta), ieri è arrivata anche Confindustria, guardia scelta renziana, con il suo presidente Boccia a dare l’allarme generale, paventando il rischio del blocco delle assunzioni in caso di referendum sul jobs act. Senza nemmeno l’onestà intellettuale di riconoscere che le assunzioni (senza più l’articolo 18) sono state il frutto dei poderosi sgravi fiscali offerti da Renzi, e che, finiti quelli, subito i posti di lavoro sono scesi in picchiata sostituiti da milioni di voucher che inondavano il mercato del precariato.
Il panico per il referendum sul jobs act ha un po’ ravvivato il clima depresso in cui si stava svolgendo il rito del voto di fiducia al governo. Che si è concluso come era iniziato. Con le aule parlamentari semivuote, gli interventi recitati nel deserto dei banchi di camera e senato. E gli addetti ai lavori attenti a leggere tra le righe del mesto dibattito, per capire quando si andrà a votare, o, per riprendere le parole del capogruppo del Pd, Zanda, quando arriverà al capolinea «il limitato orizzonte elettorale del governo».
Si potrebbe anche dire che a decidere la data delle elezioni sarà il vincitore del prossimo congresso del Pd, quindi Renzi.
Ma proprio sulla tabella di marcia che dovrebbe portarci alle prossime elezioni va a sbattere un appuntamento che potrebbe chiamarci alle urne in primavera, appunto il referendum chiesto dalla Cgil con la raccolta di un milione di firme (anzi: tre milioni, uno per ogni quesito). Nel caso di elezioni anticipate non potrebbe essere celebrato.
Naturalmente si deve prima pronunciare la Corte costituzionale chiamata a rispondere sull’ammissibilità dei quesiti, ma superata questa prova, si dovrebbe procedere alla fissazione della data referendaria che può cadere in un arco temporale che va da aprile a giugno.
Questo ingorgo elettorale la storia della nostra Repubblica lo conosce bene. Altre volte nel passato è successo che per far saltare i referendum gli italiani fossero chiamati al voto anticipato.
E’ evidente che nelle prossime settimane e mesi assisteremo a vari tentativi di disinnescare la mina del referendum. Il più semplice e probabile sarà appunto far cadere il governo-fotocopia entro giugno, giusto in tempo utile per evitare un’altra poderosa onda antigovernativa. Oppure si tenterà di escogitare qualche marchingegno legislativo per dire che del referendum non c’è più bisogno.
 ».
».
Il manifesto, 15 dicembre 2016 (c.m.c.)
Il grado di sofisticazione cui oggi è giunta l’analisi dei flussi elettorali ci consente di cogliere aspetti importanti del voto referendario. È stato a ragione segnalato il carattere «sociale» visibile nella geografia del No lungo la Penisola: la periferia delle città rispetto al loro centro, il Sud rispetto al Nord, i disoccupati rispetto agli occupati, i giovani rispetto agli anziani.
Ma uno sguardo alla cartografia del Sì non è meno interessante per la conferma di tale lettura. Esso fa intravedere le nette fratture, non solo generalmente sociali, ma di classe, che lacerano la società italiana. Le disuguaglianze crescenti dell’ultimo decennio hanno creato nel Paese due mondi separati: quello dei ceti che godono di reddito sufficiente e di sicurezza e possono affrontare la riduzione del welfare e la politica di austerità, e quello degli strati che indietreggiano verso la povertà o nella povertà sono già precipitati.
Quella cartografia ci mostra anche - certo all’ingrosso - un profilo sociologico delle base di consenso di cui godeva il governo Renzi e a cui lo stesso presidente del Consiglio guardava per il proprio progetto di affermazione. È in parte anche la base sociale di questo Pd, che rappresenta ormai prevalentemente gli interessi della media borghesia cittadina, gruppi finanziari e imprenditoriali, settori della stampa, del mondo intellettuale, parte del quale crede di appartenere ancora a una gloriosa tradizione e non si è accorto in quale nuovo continente è approdato.
La vittoria del No è dunque anche l’espressione di un conflitto sociale contro una strategia «classista» di governo che ormai mostrava nitidamente - al di là degli elementi di modernizzazione pur presenti in alcune iniziative - il suo carattere di progetto di «governo della crisi» fondato sul consolidamento di un blocco di classe.
La linea economica di questo esecutivo, l’abbiamo rilevato più volte, consisteva nel tentativo di rilanciare l’economia italiana tramite un rilevante afflusso di investimenti esteri attratti dai vantaggi offerti alla libera valorizzazione dei capitali. Nulla di diverso dallo schema neocoloniale perseguito dal ceto politico dell’Occidente negli ultimi anni. A tal fine si è offerta, o si è cercato di offrire, nuova flessibilità del lavoro (Jobs act), scuola subordinata ai bisogni del mercato del lavoro, agevolazioni fiscali alle imprese, esecutivo libero da eccessivi vincoli di procedure democratiche, ecc.
C’è un passaggio rivelatore, nella politica economica del passato governo, che mostra nitidamente la scelta di consolidamento di un blocco sociale contro le ragioni stesse dell’economia produttiva e di un possibile rilancio della domanda interna: l’esenzione dell’Imu dalla prima casa. Com’è possibile, in un Paese che in meno di 10 anni ha perso il 25% della sua base produttiva, premiare a tal punto la rendita fondiaria, se non per la ragione che Renzi voleva radicare il suo potere nei ceti abbienti della società italiana?
Nel voto del No c’è dunque la sconfitta di questa strategia, che non ha rilanciato l’economia italiana, non ha scalfito la disoccupazione dilagante, non ha ridotto ma esasperato le disuguaglianze, non ha contenuto ma moltiplicato la precarietà del lavoro, non ha attenuato ma accresciuto l’emarginazione della gioventù, non ha sollevato le sorti del Sud, ma ne ha spinto i ceti più deboli nella disperazione sociale.
Forse mai come in questo voto referendario c’è stato tanto conflitto politico contro le classi dirigenti e il loro governo.
Ma questa vittoria che oggi ci esalta, ci inquieta al tempo stesso. Esistono tutte le condizioni perché la sinistra si metta in sintonia con le grandi masse popolari del nostro Paese, con i ceti produttivi, con le nuove generazioni, con le genti del Sud, con i gruppi intellettuali, anche con quelli di area Pd, che devono prendere atto dell’inadeguatezza della loro lettura della crisi e del capitalismo attuale.
Ma dov’è la voce della sinistra? Sel ha compiuto il gesto generoso di sciogliersi per favorire un nuovo processo di aggregazione e si aspettavano le mosse e le iniziative di Sinistra Italiana. Quest’ultima doveva celebrare il proprio congresso fondativo in questo dicembre e lo ha spostato a febbraio. E nel frattempo? I gruppi dirigenti di SI, con l’apporto anche di intellettuali d’area, stanno elaborando una piattaforma programmatica che si mette alle spalle decenni di riformismo neoliberista. Sul piano teorico e culturale si sta scrivendo una nuova pagina progettuale.
Ma è evidente in questo momento l’assenza di senso del tempo, la capacità di seguire le scansioni della lotta in corso con spirito d’iniziativa e creatività di manovra. È oggi, non domani, che è necessario mostrare, ai mille gruppi dispersi della sinistra, ai lavoratori, ai giovani, un punto di riferimento, un centro aggregatore dotato di un serio progetto riformatore, all’altezza delle sfide che l’Italia deve affrontare. Non sappiamo da tempo che, se il nuovo partito nascerà a ridosso delle elezioni, verrà valutato dagli italiani come l’ennesimo tentativo di un ceto politico marginale di ritagliarsi uno spazio qualunque nella rappresentanza parlamentare?
«La crisi si è aperta perché il governo ha ritenuto di aver subito un'epica sconfitta elettorale, ma si è chiusa con lo stesso governo che prendeva a calci nel sedere ognuno dei 19 milioni di italiani che l'hanno sconfitto». Huffington Post online, 23 dicembre 2016
Rino Formica e Aldo Busi non hanno un granché in comune. Eppure, mentre il neo presidente del Consiglio Paolo Gentiloni finiva di leggere la lista dei ministri, mi sono venuti in mente tutti e due. Busi per il titolo di un suo libro - Cazzi e canguri (pochissimi i canguri) -, Formica per il suo più celebre detto, quello per cui «la politica è sangue e merda». Epigrafe perfetta per questo governo: pochissimo - tuttavia - il sangue.
Intendiamoci: durante tutta la campagna referendaria mi sono sgolato (insieme a molti altri: come ricordava oggi il presidente dell'Anpi Carlo Smuraglia in una intervista adamantina) a dire che non ci sarebbe dovuto essere alcun nesso tra riforma costituzionale e sorte del governo. A dire che, in caso di vittoria del No, non avremmo mai chiesto le dimissioni di Renzi: perché era stato un errore (un suo gravissimo errore) mescolare due cose che avrebbero dovuto invece rimanere ben distinte. Ma ormai era fatta, e il combinato disposto (ormai ci siamo affezionati all'espressione) tra l'alta affluenza e il numero dei No non ha lasciato scampo a Matteo Renzi, che si è autocondannato a recitare il suo copione fino in fondo.
Ma...: qua inizia il 'ma', che stasera è esploso in tutta la sua imbarazzante dimensione. La bestemmia era quella del 'governo costituente': e allora avrebbe dovuto lasciare tutto il governo, che si era impegnato per il Sì come un sol uomo, facendo strame di ogni dignità delle istituzioni. E invece no: non si è dimesso il governo, si è dimesso il Capo.
E questo certifica senza possibilità ciò che era evidente da mesi: un partito, un governo, un Paese sono stati inchiodati per mesi dalla incredibile irresponsabilità di un aspirante capo che cercava la consacrazione della folla. Siamo nel 2016, c'è internet, mandiamo una sonda su Marte, ma la spiegazione dello psicodramma collettivo che abbiamo vissuto è chiusa nell'unico mito che gli psicanalisti di corte delle leopolde e delle televisioni non hanno citato: quello di Narciso.
Ora che Narciso è stato inghiottito dallo stagno nero in cui si specchiava, a noi rimane per l'appunto lo stagno: quello della stagnante politica italiana, in cui siamo ripiombati subito, come per malìa. E qui entra in scena l'altra faccia di Narciso, quella del politicante da prima Repubblica (senza un briciolo della cultura di un Rino Formica, però). Che ora si rotola nel fango pur di ottenere che i suoi riescano a tenere un piede nella porta che gli si sta per chiudere in faccia.
E lo fa con il più incredibile disprezzo per quegli stessi 19 milioni di italiani che (a suo stesso dire) l'hanno licenziato: come è possibile che la Boschi sia sempre lì, e in un ruolo chiave? E l'idea grottesca di Lotti ministro dello Sport? Un soluzione che avrebbe fatto arrossire un Forlani o un Nicolazzi: evviva la modernizzazione della vita politica! La logica del Gattopardo non basta più: ora nulla cambia, perché nulla cambi.
Per non parlare della disinvoltura con cui mettiamo Angelino Alfano a capo della nostra diplomazia: tanto valeva metterci Lino Banfi, che è anche più noto, all'estero. O del cinismo con cui all'Ambiente viene confermato l'incredibile Galletti, e ai Beni Culturali viene cementato l'eterno autoreggente Dario Franceschini, che ogni giorno fa rimpiangere Sandro Bondi a chiunque sappia cos'è (o meglio cos'era) il patrimonio culturale.
Insomma: la crisi si è aperta perché il governo ha ritenuto di aver subito un'epica sconfitta elettorale, ma si è chiusa con lo stesso governo che prendeva a calci nel sedere ognuno dei 19 milioni di italiani che l'hanno sconfitto.
I più scafati osservatori notano che Gentiloni e il Quirinale sono riusciti a mettere in sicurezza i Servizi, sottraendoli al Giglio Magico. Può anche darsi che sia vero (tuttavia, in che Paese vivremmo se la partita fosse stata davvero questa?), ma l'unica cosa evidente ai comuni mortali è che l'ondata di sdegno che sta sollevando questo governo 'con pochissimo sangue' sortirà un unico risultato: far guadagnare ai 5 Stelle la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Anche senza Italicum: basta il Gentilonum.
Questo è quello che scrive il giornale che è stato tra i maggiori sostenitori di Renzi e del SI al referendum. Bisogna essere proprio ciechi per credere che con Renzi e il renzismo ci possa essre salvezza, e speranza di uscire dal baratro nel quale siamo precipitati.
La Repubblica, 13 dicembre 2016
Ieri sera, mentre i ministri giuravano al Quirinale, qualcuno faceva notare con ironia che il nuovo governo sarebbe stato perfetto se avesse vinto il Sì. In quel caso al posto di Gentiloni avremmo visto ancora Renzi, ma per il resto nessuna differenza. Maria Elena Boschi sarebbe stata premiata come in effetti è avvenuto: sottosegretario alla presidenza del Consiglio, un posto chiave per il quale occorre esperienza, tatto e profonda conoscenza della macchina statale. Doti che l’ex ministra delle Riforme non ha mai mostrato di possedere, se non altro per via della giovane età. In questo caso, tuttavia, le sarà sufficiente tener d’occhio il calendario delle nomine nei grandi enti e negli altri centri di potere, badando che i prescelti non siano sgraditi al segretario del Pd. Luca Lotti sarebbe diventato ministro, sia pure senza portafoglio. E davvero lo è diventato, mantenendo peraltro il suo ufficio a Palazzo Chigi, con competenza sull’editoria e, per buona misura, anche sul Cipe. In caso di vittoria del Sì il ministro dell’Interno avrebbe potuto pretendere un premio alla propria lealtà. Lo ha ottenuto lo stesso, visto che Alfano è da ieri ministro degli Esteri, responsabile delle relazioni internazionali dell’Italia, forse la poltrona più importante.
Si pensava che fosse interesse del nuovo presidente del Consiglio marcare un qualche grado di autonomia e non consegnarsi mani e piedi alla polemica dei Cinque Stelle e della Lega. Invece il tema del governo fotocopia, agitato dalle opposizioni, acquista legittimazione e addirittura viene sbandierato da un segmento scontento e frustrato della maggioranza come il gruppo di Denis Verdini, rimasto a mani vuote. Quasi fotocopia, per la verità: si deve riconoscere che l’ingresso di Anna Finocchiaro, parlamentare competente e da tutti stimata, è una delle poche note positive. Insieme ad altre due. La prima è la nomina di De Vincenti a ministro della Coesione nazionale, pur se il governo avrebbe tratto vantaggio dalla sua permanenza a Palazzo Chigi come sottosegretario alla presidenza e gestore dei dossier più delicati (il lavoro che da oggi, come si è detto, dovrebbe esser svolto da Maria Elena Boschi).
La seconda novità è la decisione di Gentiloni di trattenere per sé le deleghe sui servizi di sicurezza che nel precedente esecutivo erano nelle mani di Minniti, persona affidabile a cui è stata data la responsabilità del Viminale. Non è dato sapere con certezza se in questa scelta abbia pesato il consiglio di Mattarella. Di certo è fallito il complicato percorso di cui si vociferava e che avrebbe dovuto concludersi con le deleghe assegnate a Luca Lotti, l’efficiente amico e consigliere di Renzi. Questo è il punto politicamente più rilevante della giornata. La prova indiretta che il governo Gentiloni vive, come è ovvio, dell’appoggio parlamentare del Pd e dei centristi, ma anche di una buona relazione fra il nuovo premier e il capo dello Stato. È in una certa misura, o almeno dovrebbe essere, una sorta di “governo del presidente” che si appoggia da un lato al Parlamento e dall’altro al Quirinale. Al punto che si poteva immaginare che l’influenza del Colle riuscisse a favorire la nascita di un esecutivo dal profilo più alto e soprattutto più innovativo.
Così non è stato e il calcolo di Gentiloni è oggi quello di non approfondire il solco con Largo del Nazareno. Dove in effetti Renzi agisce come se il referendum avesse regalato al Pd un successo da coltivare con cura. L’idea, un filo paradossale, è che il 41 per cento del Sì costituisce un patrimonio del Pd e del suo leader. Quindi il problema è quello di non disperdere quei voti e di metterli nell’urna delle prossime politiche. Il che spiega anche perché nessun esponente del No sia stato invitato a entrare nel governo semi-fotocopia. Si capisce che il cammino di Gentiloni è impervio, forse più di quanto egli stesso immaginasse. Tuttavia il futuro è ancora da scrivere. Il nodo della legge elettorale resta cruciale e qui i toni misurati e concilianti del presidente del Consiglio, che non vuole invadere lo spazio del Parlamento, permetteranno — si spera — alle parti politiche di avviare un negoziato serio. Non saranno le “larghe intese”, ma è chiaro che la legge avrà bisogno del concorso di Berlusconi. Il che apre scenari non del tutto prevedibili.

LIl Fatto Quotidiano, 11 dicembre 2016
Quella frase
l’ha ripetuta sei volte. In radio, in tv e sui giornali. Ed era una frase bella. Semplice. Rivoluzionaria. Era uno schiaffo in faccia alla vecchia politica. Era un concetto altruista e generoso.
Oggi, però, sappiamo che era fasullo. Matteo Renzi non lascia la testa del Partito democratico. «Se perdo troveranno un altro premier e un altro segretario», aveva scandito davanti alle telecamere di Virus. «Se non passa il referendum la mia carriera politica finisce. «Vado a fare altro», aveva garantito a Radio Capital. «Io non sono come gli altri», aveva giurato al Messaggero. «Torno a fare il libero cittadino», aveva confermato a un Bruno Vespa troppo navigato per non essere perplesso.
Così, mentre nel nome di Renzi l’Italia prova a darsi un nuovo governo, sui taccuini dei cronisti resta solo quel crescendo rossiniano di promesse e spacconate destinato a segnare per sempre la sua carriera e le nostre vite.
Eppure, anche noi ci avevamo sperato. Dopo aver raccontato a una a una le contraddizioni di un presidente del Consiglio nato rottamatore e adesso destinato a morire restauratore, Renzi ci era piaciuto quando aveva affrontato a viso aperto la sconfitta. Il suo bel discorso d’addio a Palazzo Chigi di domenica 4 dicembre ci era sembrato il trampolino per un possibile riscatto. Quando avevamo letto i retroscena del giorno dopo, conditi da frasi che raccontavano i suoi dubbi e la sua voglia di lasciare, ci eravamo detti: “Dai, per una volta sorprendi tutti, prenditi davvero un anno sabbatico. Parti! Vai in giro! Scopri quell’Italia che non hai voluto e saputo vedere”. Pensavamo, o meglio ci illudevamo, che il molto sangue democristiano che scorre nelle vene dell’uomo di Rignano potesse portarlo a rileggere la storia di Amintore Fanfani, il Rieccolo di montanelliana memoria.
Renzi alla fine lo ha fatto. Ma ha sbagliato parte della biografia. Ha saltato a piè pari le pagine in cui si racconta come nel 1959 Fanfani, logorato dalla minoranza interna, si dimette da presidente del Consiglio e da segretario per tornare sulla scena, dopo mesi di auto-esilio e solitudine, non appena muore il governo Tambroni (appoggiato dal Msi). È in quel momento che Fanfani, assieme ad Aldo Moro inventa di fatto il centrosinistra e dà il via a una lunga stagione di produttive riforme: la scuola media, l’aumento delle pensioni, l’autostrada del sole, la Rai educativa e tanto altro. Poi c’è il secondo Fanfani. Quello a cui Renzi s’ispira.
C’è la parte di biografia che andrebbe bruciata e che invece Matteo, il giovane vecchio, divora. C’è il Fanfani che perde il referendum sul divorzio di 20 punti. Che crede di poter capitalizzare il 40 per cento ottenuto e che invece alle Amministrative del 1975 subisce una nuova débâcle. Una sconfitta che lo costringe ad abbandonare la segreteria.
Ovvio, la storia non si ripete mai uguale a se stessa. Renzi non è Fanfani. Nessuno per ora lo chiama il Rieccolo. In molti invece lo definiscono il Bomba. È un peccato, però. Perché quel nomignolo cattivo, nato dalle troppe promesse non mantenute, poteva essere spazzato via di colpo con le doppie dimissioni: da premier e da segretario.
E invece resterà. Accantonato per sempre nell’archivio dei nostri ricordi assieme all’illusione di una politica finalmente in grado di cambiare verso.
Postilletta
E tornerà anche al Governo, travestito da Gentiloni Silveri
 «È indubbio che questo referendum ha ulteriormente marcato l’impronta “personale” del PD. Convertendolo, in modo deciso e decisivo, nel PdR. Il Partito di Renzi».
«È indubbio che questo referendum ha ulteriormente marcato l’impronta “personale” del PD. Convertendolo, in modo deciso e decisivo, nel PdR. Il Partito di Renzi».
La Repubblica, 6 dicembre 2016, con postilla
Il referendum costituzionale, alla fine, si è tradotto in un referendum su Renzi, secondo le intenzioni dello stesso premier. Ma il risultato ha travolto anche lui, insieme alla riforma costituzionale. D’altronde, è una questione di “misure”. E la “misura” assunta dal No è al di là di ogni aspettativa.
I sondaggi, questa volta, non hanno sbagliato, sull’esito. Ma, appunto, sulle “misure”. Infatti, tutti i principali istituti demoscopici avevano previsto il successo del No, segnalando, però, un’ampia area di incerti, che avrebbe potuto rendere possibile perfino il sorpasso del Sì. Invece, il No si è imposto nettamente. E ha prodotto conseguenze immediate, anzitutto sul governo.
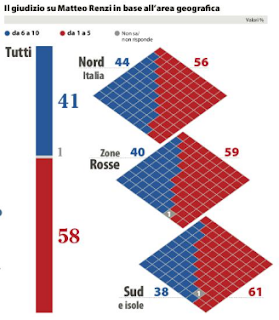
D’altronde, 6 italiani su 10 hanno votato contro la riforma, ma, anzitutto, contro Renzi. Troppi per non provocare le dimissioni immediate del Premier. Puntualmente rassegnate un’ora dopo la chiusura delle urne. Perché il significato “politico” del voto è indubbio. Sottolineato, anzitutto, dall’ampiezza della partecipazione elettorale. Quasi il 70%, in ambito nazionale. Molto più elevata rispetto ai precedenti referendum costituzionali. Infatti, nel 2001 l’affluenza si era fermata al 34%, mentre nel 2006 era, comunque, distante dal livello raggiunto in questa occasione: 54%. Così è probabile, come si era già osservato, che il Sì abbia intercettato il consenso di larga parte degli elettori del PD. Anche se non di tutti. Nel complesso, intorno all’85%. Più di quanto venga rilevato dall’Istituto Cattaneo, che però utilizza un metodo diverso e fa riferimento al voto in alcune città alle elezioni politiche del 2013. Mentre il sondaggio condotto domenica da Quorum per Sky offre stime coerenti con il nostro.
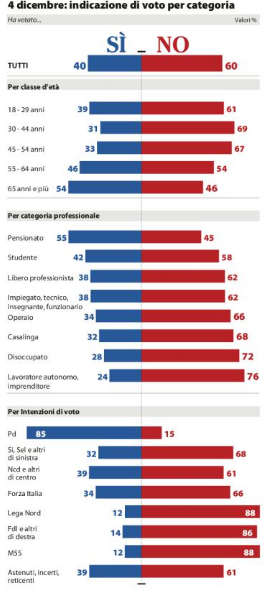
D’altronde, è indubbio che questo referendum abbia ulteriormente marcato l’impronta “personale” del PD. Convertendolo, in modo deciso e decisivo, nel PdR. Il Partito di Renzi. Che ora potrebbe indebolirsi, se non destrutturarsi. Producendo una nuova svolta rispetto alla tradizione e alla geografia elettorale del dopoguerra. Quando la DC, prima, e il Centro-destra Forza-leghista (come lo definì Edmondo Berselli), poi, apparivano radicati nel Nord Est e nella provincia del Nord. Mentre la Sinistra delineava una sorta di “Lega di Centro”, ancorata nei territori della (cosiddetta) “zona rossa”. Ma il M5s, alle elezioni politiche del 2013, e il PdR, alle europee del 2014, hanno assunto una distribuzione “nazionale” dei consensi. In questa occasione, però, la storia “regionale” del voto, in Italia, sembra riemergere (come ha osservato Antonio Gesualdi). Visto che le poche province dove ha prevalso il Sì sono, appunto, localizzate “al centro” dell’antica zona rossa. Al centro del Centro. Soprattutto in Toscana. Perché, come ha rilevato ancora l’Istituto Cattaneo, “alla mobilitazione degli elettori per il No si è sommata una relativamente maggiore mobilitazione degli elettori per il Sì”.
Eppure anche in questo caso il segno del cambiamento si conferma. Anzitutto, perché la base fedele alle indicazioni di Renzi appare ridotta. Al “cuore rosso” (come lo ha definito Francesco Ramella) della zona rossa. Nel complesso: una decina di province all’incrocio fra Emilia Romagna e Toscana. Mentre in Umbria e nelle Marche - le altre “regioni rosse” - il No appare dovunque maggioritario. Come, peraltro, in altre importanti province toscane: Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara. E dell’Emilia Romagna: Ferrara, Parma, Rimini, Piacenza.
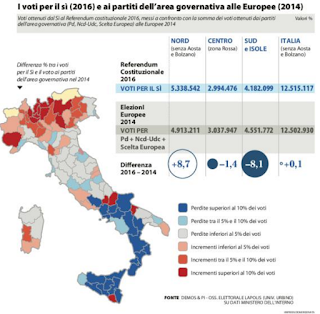
Così oggi il PdR appare minoritario. Fra gli elettori e ancor più sul piano territoriale. D’altronde, il grado di fiducia nei confronti di Renzi, rilevato da Demos due settimane fa, coincide con il risultato raggiunto dal Sì: 41%. Pressoché uguale il dato relativo alla fiducia nel governo. Una coincidenza, forse, casuale. Ma non troppo. Soprattutto se riproduce – in diversa misura – la distribuzione territoriale: del voto e dell’affluenza. Elevata nel Centro-Nord. Bassa nel Mezzogiorno. Dove la differenza rispetto alle europee del 2014, il momento di maggiore affermazione per il PD e per Renzi, appare molto ampia. Segno evidente del significato attribuito al voto da alcuni ambienti (in)sofferenti verso il Premier e il suo governo. Il Mezzogiorno, appunto. Scosso dalla crisi. Ma anche i giovani. I più convinti del significato (anti) “personale” del referendum. I giovani: in cerca di futuro. In fuga dall’Italia.
Questi appunti segnalano i problemi “politici” incombenti.
Per il PD e per Renzi anzitutto. Dunque, per il PdR. Che è stato sconfitto e dubito che possa “riprodursi” com’è adesso. Ma difficilmente potrà, comunque, tornare ad essere il PD. Cioè, il partito di prima. Perché, ormai, è un “Partito del Capo”, inserito in una “Democrazia del Leader” (per echeggiare le formule coniate da Fabio Bordignon e Mauro Calise). Ma non è chiaro chi e come lo possa “soccorrere”. Mentre non si vedono altri leader, altri Capi credibili, nel PD. E fuori. Dopo Renzi. Oltre a Renzi.
Le altre forze politiche dovranno, a loro volta, trovare una missione. Autonoma. Oltre l’antipolitica, interpretata e intercettata - con efficacia - dal M5s. Oltre il berlusconismo senza Berlusconi, tentato senza convinzione da Forza Italia. Mentre la Ligue Nationale di Salvini dovrà, infine, sperimentare la propria reale capacità di attrazione “oltre i confini del Nord” e del Nordismo. Per candidarsi alla leadership della Destra. E del Paese. Tuttavia, nel Fronte del No, non è possibile individuare nuovi motivi di “coalizione”, dopo il referendum. Oltre l’antirenzismo.
È, dunque, lecito attendersi una stagione - non breve – di instabilità. Perché questo Paese, oggi, appare senza leadership. Senza colori. E senza Un Nemico. Ma con un Bicameralismo e con un Senato solidi. Destinati a durare a lungo.
postilla
Nel commentare il risultato - e l'area del successo del PdR - rileverei che si tratta delle province dove è più forte la connessione storica di quel partito con la realtà economica che una volta era definita i "ceti medi produttivi" e che oggi è diventato un segmento del sistema globale del potere finanziario/immobiliare.
Aggiungo che continuare a definire il M5S solo l'«interprete e intercettatore dell'antipolitica», quindi per ciò stesso incapace di costituire un'alternativa al PdR, significa non aver compreso che la parte maggioritaria dell'elettorato non è contrario alla politica in sè (quella con l'iniziale maiuscola, alla quale si è riferito per esempio papa Francesco), ma la meschina, dannosa e obsoleta politiquepoliticienne di cui il Capo Renzi è pienamente rappresentativo. (e.s.)

La sconfitta al Referendum costituzionale. I commenti di Aldo Cazzullo, Goffredo De Marchis e Antonio Padellaro. , 5 dicembre 2016 (m.p.r.)
Corriere della Sera
GLI ERRORI DEL LEADER
di Aldo Cazzullo
E alla fine Matteo Renzi si ritrovò come in una vecchia puntata del Costanzo Show: solo contro tutti. A duellare con Zagrebelsky e con De Mita, a sfidare invano Grillo e D’Alema; se Maciste si fosse schierato per il no, avremmo visto Renzi contro Maciste. Da Napolitano aveva ottenuto l’incarico di governo dietro l’impegno di fare le riforme istituzionali, riportando al tavolo Berlusconi, ricompattando il partito democratico, ridimensionando Grillo. Invece Berlusconi si è sfilato dall’accordo - come ha sempre fatto da quando è in politica -, la sinistra Pd dopo aver detto per sei volte sì in Parlamento ha sostenuto il no, e Grillo non è mai stato così forte. Missione incompiuta, anzi fallita, anche al di là dei suoi demeriti.
Non era impossibile prevederlo. Qualsiasi governo che abbia sottoposto la propria linea agli elettori si è sentito rispondere no, in qualsiasi contesto e latitudine, da Londra a Bogotà a Budapest. L’errore di Renzi non è stato soltanto personalizzare il referendum sulle «sue» riforme; è stato proprio farlo, o meglio chiederlo. Non è inutile ricordare che il referendum non era obbligatorio: la Costituzione non lo impone, lo consente qualora sia mancata la maggioranza dei due terzi e ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera, 500 mila elettori o cinque assemblee regionali. Renzi non ha atteso che fossero le opposizioni a sollecitare il responso popolare; l’ha sollecitato lui stesso, per sanare il vizio d’origine, il peccato originale di non aver mai vinto un’elezione politica. Ma un conto è difendere il proprio lavoro da forze contrapposte che ne chiedono la cancellazione; un altro conto è chiamare un plebiscito su se stessi.
Il presidente del Consiglio si è mosso come se il Paese fosse ancora quello del 41% alle Europee. Ha sopravvalutato il proprio consenso e ha sottovalutato il disagio sociale. Gli va riconosciuto il merito di aver tentato di restituire agli italiani fiducia nel loro Paese e nel futuro. Ma per tre anni ha ripetuto un solo discorso: l’Italia che torna a fare l’Italia, l’Italia che può fare meglio della Germania, l’Italia che diventa locomotiva d’Europa. Ha recitato un mantra che avrebbe dovuto essere supportato da una robusta ripresa economica; che non c’è. Renzi può rivendicare di aver riavviato la crescita, di aver trovato un Paese con il segno meno e di lasciarlo con il segno più. Ma all’evidenza non è sufficiente; o almeno questo è stato il responso della netta maggioranza degli italiani.
Gli va dato atto anche di aver riconosciuto subito la sconfitta. I discorsi di accettazione gli vengono bene: era già successo anche nel dicembre 2012, quando Bersani lo sconfisse alle primarie. La prospettiva del passo indietro tattico è superata dai fatti. Più realistica una traversata del deserto, che non sarà lunghissima - alla scadenza naturale della legislatura manca poco più di un anno - ma è certo irta di pericoli. Renzi può ancora cercare una rivincita. Ma dovrà mettersi in gioco almeno due volte. Prima nelle nuove, inevitabili primarie del Pd, che non saranno scontate come potevano apparire ancora poco tempo fa. E poi in elezioni politiche che non saranno risolutive come vagheggiava: «Voglio un sistema elettorale in cui la sera del voto si capisca chi ha vinto e chi ha perso», amava ripetere. Ma con il proporzionale vincono sempre quasi tutti, e quasi nessuno perde mai per davvero. Renzi ha ancora la forza di impedire un ritorno al passato? La collaborazione con Berlusconi è una carta di riserva che non è mai uscita davvero dal mazzo, o rappresenta una resa, da far gestire a qualcun altro?
Ci saranno giorni per discuterne. Chi sogna un Renzi addomesticato, riflessivo, quasi mansueto, non conosce il personaggio. Può cambiare strategia; non natura. Può ancora avere una chance; ma una fase si è chiusa definitivamente. Con una sconfitta. Non soltanto non è riuscito a prosciugare Grillo o a prendere i voti di Berlusconi; l’alta partecipazione al voto, che nelle previsioni avrebbe dovuto rafforzare il governo, segna anche un rigetto personale nei confronti del premier. Nella campagna referendaria Renzi ha tentato di tornare il rottamatore della casta; ma dopo tre anni di Palazzo Chigi non è risultato credibile.
Una cosa è certa: Grillo ha ragione di esultare; Berlusconi può rallegrarsi; ma la soddisfazione della sinistra Pd rischia di avere vista corta e breve durata. Gli oppositori di Renzi non hanno un vero leader, né un candidato pronto a sfidarlo. Sono uniti dal rancore personale verso l’usurpatore, e da poco altro. Alla fine hanno fatto miglior figura i Letta e i Prodi, che si sono espressi per il sì senza entusiasmo, rispetto ai Bersani e ai D’Alema, che si sono battuti per un no destinato a far cadere un governo di centrosinistra, in una fase in cui un vento di destra soffia su tutti i Paesi del mondo.
La Repubblica
LA SOLITUDINE DEL PREMIER «SOTTO ASSEDIO IO NON CI STO. PIUTTOSTO VIA DALLA POLITICA»
di Goffredo De Marchis
ROMA. La tentazione di mollare tutto, Palazzo Chigi e segreteria del Pd, tornare veramente a casa a Rignano, lasciare la politica come disse un anno fa nella conferenza stampa di fine anno lanciando la lunghissima campagna referendaria. Tensione al massimo, tutti pendono dalle labbra di Matteo Renzi. La parola tocca a lui, il resto della truppa ha il volto paonazzo di chi ha preso una brutta botta.
Renzi è chiuso nella sua stanza al primo piano della sede del governo. Ha rischiato e si è rotto l’osso del collo, come ama dire. L’aria è pesantissima e i dati sull’affluenza danno la reale dimensione di un capitombolo, lasciando intravedere la sentenza più inaspettata: «Se tante gente va a votare e vince il No, vuol dire che il Paese intende mandarmi a casa». Un responso elettorale, quindi, una rivolta contro di lui. E il Paese profondo non sta nelle condizioni sociali ed economiche immaginate dalla sua narrazione.
All’amico ritrovato Matteo Richetti, qualche giorno fa aveva confessato: «Sono stanco, stanchissimo». Non solo del lungo viaggio per l’Italia, delle notti in bianco, delle maratone in tv. Ma del non essere stato compreso in uno sforzo, secondo Renzi, sovrumano. «Per riportare l’Italia al vertice dello scenario europeo e mondiale, al suo posto». Questo pensava di aver fatto nei mille giorni di governo. Parole confidenziali tra amici, che oggi assumono un altro significato: la resa e la consapevolezza di una sconfitta bruciante, una freccia conficcata nel cuore del renzismo.«Non posso fare finta di niente, davvero non sono come gli altri».
Il modello è il Prodi che torna a Bologna dopo essere stato sfiduciato dal Parlamento. Ma lì c’erano i giochi di palazzo, i tradimenti, le coltellate alle spalle. Qui invece il voto degli elettori. Lo andranno a cercare fin su le colline del Valdarno sapendo che è l’unico leader della sinistra in grado di vincere le elezioni, presto o tardi che siano? Ma il suo orizzonte forse non è quello di David Cameron che dopo la Brexit è stato immortalato su una banchina a mangiare fish and chips. Ma non è ai precedenti che Renzi pensa chiuso nel suo ufficio a Palazzo Chigi. Con Luca Lotti, il portavoce Filippo Sensi, il fotografo Tiberio Barchielli, la squadra instancabile della corsa al vertice. Altri ministri, compresi Maria Elena Boschi e Dario Franceschini, sono a Largo del Nazareno, nella sede del Partito democratico.
Il futuro della politica italiana è un rebus che il premier non risolve stanotte. Oggi pensa a sè e all’amaro della sconfitta. Con zero segnali positivi anche se nella war room renziana qualcuno mostra a “Matteo” alcuni dati. Se l’affluenza sfiora il 70 per cento anche con il 40 per cento di Sì, Renzi intercetta 13 milioni di voti. Sono due in più di quelli presi nel 2014 alle Europee quando il Pd conquistò mil 41 per cento. E con il 45 per cento i consensi sarebbero adirittura 15 milioni. «Ripartiamo da qui», suggerisce qualcuno nella stanza di Renzi.
Si può fare. Tenere la segreteria, dare le carte per un nuovo governo fotocopia che conduca in porto la legge di bilancio e i decreti di fine anno, pilotare la legge elettorale e sfidare subito i nemici interni convocando il congresso dem rimanendo in sella. Dipende dal dato finale. Con un Sì attestato al 45 per cento o sopra, Renzi organizzerà la rivincita, una nuova sfida combattendo «l’accozzaglia». Ma con il 40 per cento, sarà tutto più difficile. «Comincerà un assedio dentro il Pd, la minoranza e le correnti chiederanno di cambiare tutto, non solo il segretario. Basta primarie aperte, voto solo per gli iscritti, un’ offensiva rispetto al Partito della Nazione. Al grido: mai più gli elettori di Cosentino e Verdini ai gazebo del Pd. Li conosco».
Gli alleati per tenere almeno la segreteria non mancheranno. I franceschiniani, i giovani ì turchi, insomma una maggioranza solida per affrontare il congresso e rivincerlo. Ma a quali condizioni? Cedendo su cosa? Già nelle prossime ore, confida il presidente del Pd Matteo Orfini, verranno convocati gli organismi del partito, ovvero una direzione. Potrebbe partire subito il percorso congressuale, prima che si saldi un’asse tra la minoranza e altre componenti. Pier Luigi Bersani, qualche settimana fa, era stato chiarissimo: «Cambiamo le regole del congresso, apriamoci alle associazioni e immaginiano anche un segretario che non venga dal gruppo dirigente dem». Dario Franceschini è come al solito l’ago della bilancia. Ai suoi ha raccomandato: «Ricordatevi come si comportavano i vecchi democristiani. Non si fanno mosse azzardate, calmi con le dichiarazioni fino a quando la crisi non si manifesta nella sua pienezza». Il clima rischia di virare al brutto anche dentro il Pd.
VOLEVA TUTTO, HA PERSO TUTTO
di Antonio Padellaro
Il No venuto dal popolo italiano, forte e chiaro, che ha sbaragliato il tentativo di Matteo Renzi di rottamare la Costituzione della Repubblica ricorda un'altra vittoria del No, quella contro il referendum democristiano del 1974 sull'abrogazione del divorzio che il vecchio Pietro Nenni commentò con parole divenute famose: hanno voluto contarsi, hanno perso. La stessa illusione che ha perduto domenica 4 dicembre 2016 l'ambizioso politico fiorentino, che tra le sue qualità non ha quella della prudenza visto che come un giocatore d'azzardo al tavolo da poker da tre anni a questa parte non ha fatto altro che raddoppiare la posta: dalle primarie del Pd all'occupazione del Nazareno alla conquista di palazzo Chigi.
Poteva accontentarsi di guidare il Paese (anche se con l'imbarazzante soccorso degli Alfano e dei Verdini) fino alla scadenza della legislatura del 2018. Ma una perniciosa bulimia del potere, alimentata dal 40 per cento delle Europee del 2014 gli ha suggerito l'idea di accaparrarsi l'intero piatto. Attraverso il famoso combinato disposto costituito dal dominio sulla Camera (grazie al superpremio di maggioranza previsto dall'Italicum) e dalla trasformazione del Senato in un dopolavoro di nominati (grazie alla riforma Boschi).
Gli è andata male, anzi malissimo. Prima la progressiva crescita nei sondaggi dei Cinquestelle gli ha consigliato di smontare l'Italicum per non ritrovarsi Beppe Grillo seduto al suo posto a palazzo Chigi. Poi, questa notte Renzi è stato sommerso da un plebiscito: non quello che sperava ma di segno diametralmente opposto. Gli italiani sono corsi a votare in massa come nessuno aveva previsto avendo compreso l'enormità della posta in gioco. Così Renzi, che cercava da questo voto la legittimazione mai ricevuta in elezioni politiche, ha ricevuto la più pesante delegittimazione.
Ha voluto la conta e ha perso tutto. Ha travolto nella sconfitta, oltre al suo presente e forse al suo futuro politico, anche il governo e con il governo la stabilità tante volte invocata come bene supremo della nazione. Le sue dimissioni - inevitabili - aprono ufficialmente anche la resa dei conti nel Partito Democratico dove coloro, e non sono pochi, che in questi anni si sono sentiti ingiustamente emarginati e maltrattati non vedono l'ora della rivincita.
Matteo Renzi paga anche per responsabilità non sue ma che ha colpevolmente subìto. Non dimentichiamo che la riforma della Costituzione e il suo s travolgimento fu chiesta, anzi pretesa, da Giorgio Napolitano in quel blitz che in pochi giorni portò alla inopinata giubilazione di Enrico Letta e al conferimento dell'incarico al sindaco di Firenze. Renzi, per dirla tutta, si è imbarcato nell'avventura che lo ha portato al naufragio referendario su mandato imperativo dell'ex Capo dello Stato. Da cui, non dimentichiamolo, si fece anche pesantemente correggere la lista dei ministri, a cominciare da quel Nicola Gratteri, magistrato tra i più autorevoli nella lotta alle mafie, entrato al Quirinale come ministro della Giustizia e poi sostituito in gran fretta da Andrea Orlando. Fu da quel momento che la sua immagine di giovane iconoclasta dei soliti riti della vecchia politica cominciò a snaturarsi.
Su molti altri errori dovrà riflettere Renzi nel caso non faccia seguire alle annunciate dimissioni da premier il ritiro dalla vita politica, già ipotizzato e poi smentito (come troppi suoi annunci del resto). Primo: la Costituzione è patrimonio del popolo italiano non certo di un ceto politico inzeppato da opportunisti e voltagabbana. Secondo: riformare la Carta si può se necessario, ma l'aver trasformato 47 articoli determinati per il funzionamento delle istituzioni in un pasticcio incomprensibile è stato da irresponsabili. Un allarme lanciato dai più illustri costituzionalisti, non solo inascoltati ma definiti dal nuovo che avanza (anzi avanzava) come professoroni, gufi e rosiconi.
Terzo: l'incredibile sovraesposizione mediatica del premier la cui faccia spuntava a ogni ora da ogni schermo televisivo non solo non ha pagato ma ha finito per provocare una reazione di rigetto che certamente ha contribuito ad accrescere la dimensione della sconfitta. Quarto: con l'arroganza, la presunzione, il disprezzo per chi non la pensa come te, con espedienti vergognosi a partire dall'uso delle malattie come propaganda elettorale non si fa molta strada. E alla fine si va a sbattere.
 È proseguita alla Leopolda la rottamazioni di quello che ambiva essere un residuo della sinistra novecentesca. Un utile resoconto, peraltro un po' ingenuo.
È proseguita alla Leopolda la rottamazioni di quello che ambiva essere un residuo della sinistra novecentesca. Un utile resoconto, peraltro un po' ingenuo.
La Repubblica, 7 novembre 2016, con postilla
LA SETTIMA Leopolda renziana è il capolinea della sinistra italiana. Quel poco che era rimasto della vecchia “ditta” riformista attraversa la sua ultima stazione, dalla quale non uscirà più, o potrà uscire solo a pezzi. Colpisce l’asprezza dei toni con i quali Renzi ha regolato i suoi conti con la “minoranza” del partito, e ha lasciato che il suo popolo leopoldino gli urlasse “fuori, fuori”. Un brutto spettacolo, inutilmente rancoroso e fortemente autoreferenziale. Soprattutto per una kermesse che ha la giusta ambizione di parlare al Paese, non a se stessa. Ma c’è del metodo, in questa scelta renziana. Per almeno due buona ragioni.
La prima ragione riguarda il marketing. A un mese dal referendum che lo vede in svantaggio, il premier ha fatto esattamente quello che doveva fare. Con l’ennesimo testacoda, ha ri-personalizzato la campagna elettorale. L’ha definitivamente svuotata di ragionamenti “tecnici”, e l’ha nuovamente riempita di argomenti ideologici. La posta in gioco, il 4 dicembre, non è quindi la Costituzione riformata e l’Italicum, ma torna ad essere il premier e il suo governo.
Renzi aveva riconosciuto il suo errore iniziale: il voto sulla riforma costituzionale costruita come un’ordalia su se stesso. Aveva tentato di tornare a parlare del “merito”: discutiamo solo di Senato delle autonomie, di navette parlamentari, di leggi a data certa. Un compito arduo, un esito incerto. Perché questa riforma è un compromesso complicato e pasticciato, difficile da “vendere” bene agli italiani confusi (se non ai prezzi di saldo del populismo, cioè con la promessa che serve a “mandare a casa i politici” e a far pagare il conto alla “casta”). Con la “prosa” del tecnicismo costituzionale il Sì non recupera i “clienti” perduti. Puo farlo solo attraverso la “poesia” del leaderismo emozionale. Solo così puoi vincere. È la lezione di Christian Salmon, inventore dello storytelling in politica: «Votare è comprare una storia».
Dunque, si torna alla casella di partenza. La storia che Renzi rivende dalla Leopolda torna a raccontare il referendum del 4 dicembre come un “derby tra la rabbia e la speranza”. Come la “guerra dei mondi”: il vecchio contro il nuovo. Dove il nuovo è ovviamente lui medesimo, garante unico del cambiamento, macchinista di “un treno che passa ora o non ripasserà mai più”. E dove il vecchio, illividito di rabbia, non è tanto incarnato dagli avversari naturali della sinistra, cioè i Berlusconi e i Grillo. Ma è costituito soprattutto dalla sinistra stessa, cioè i Bersani e i D’Alema.
È contro questa sinistra, che Renzi consuma il suo strappo finale. Lo fa con una mossa di grande astuzia. Il compromesso sulle modifiche alle legge elettorale, firmato anche da Cuperlo, è poco più che una “scrittura privata”, che rinvia tutto a dopo il voto. Ma in quel pezzo di carta c’è tutto quello che la minoranza Pd aveva chiesto: l’eliminazione del ballottaggio, il premio di coalizione, il ritorno ai collegi uninominali, perfino l’elezione diretta dei nuovi senatori. Renzi, firmando quella carta, paga un prezzo altissimo alla coerenza (ha sempre definito l’Italicum «una bellissima legge che tutta l’Europa ci invidia»). Ma Bersani, negando ancora una volta la sua firma, stavolta rischia di pagarne uno ancora più alto (se accetti di partecipare alla commissione, e in quella sede accolgono tutto quello che hai chiesto, come fai a rifiutare? Puoi dire che non ti fidi di Renzi, ma allora ha ragione lui a sostenere che il tuo “movente” non è il no alla riforma, ma il no alla sua leadership).
Ma lo fa anche con un attacco definitivo contro «quelli che 18 anni fa decretarono la fine dell’Ulivo, e ora stanno provando a decretare la fine del Pd». E qui sta la seconda ragione, per la quale l’attacco di Renzi alla “ditta” non deve stupire. Una ragione che riguarda la politica. La settima Leopolda riflette la compiuta metamorfosi del Pd in PdR, il Partito di Renzi, per usare la formula di Ilvo Diamanti. Un partito che può e deve fare a meno di “quella sinistra”, ormai vissuta e costruita come nemico. Perché è ormai chiaro che il blocco sociale da aggredire, per il partito renziano trasformato in struttura servente del leader, è quello moderato e tuttora “congelato” dopo la diaspora berlusconiana.
Vale per il referendum di dicembre (secondo i sondaggi che Alessandra Ghisleri ha mostrato al Cavaliere, il 25% di italiani indecisi sarebbe attualmente diviso tra un 60% di No e un 40% di Sì, e dunque è su quel 60% che Renzi deve tentare un recupero). Ma vale anche per il dopo (come ha riconosciuto ieri Roberto D’Alimonte sul Sole 24 Ore, se vincessero i Sì l’unico sbocco possibile di un Italicum riscritto secondo il compromesso appena varato sarebbe “una coalizione con Forza Italia e/o Area Popolare”).
Nella narrazione renziana, nulla si salva prima del 2014. “Quelli che c’erano prima” hanno sfasciato il Paese e il partito. Per questo devono obbedire o scomparire. Si torna così dove tutto era cominciato: la rottamazione come “rivoluzione”. È evidente che la sinistra ha fallito. Il problema è che, dopo aver ucciso la “vecchia”, nessuna Leopolda ci ha ancora spiegato quale sia, e soprattutto se debba esistere, una “nuova” sinistra.
postilla
È veramente incredibile che persone intelligenti, che seguono gli eventi del teatrino della politica da anni, si illudano che da quella fabbrica possa nascere una "nuova sinistra". Incredibile che comprendano solo adesso che la politica di Matteo Renzi è stata fin dal suo inizio la politica preconizzata dalla Mont Pélerin Society e, più recentemente, dalla JP Morgan : politica della quale Berlusconi è stato il primo strumento e Renzi il secondo: più giovane, più efficace e meno volgare nei modi e nell'aspetto, ma comunque al servizio della medesima Azienda - quindi sempre disposto a collaborare col suo collega per i fini comuni.

Matteo Renzi sulla strada di Erdogan. Riceviamo e, indignati, pubblichiamo. Ma segnalazioni simili arrivano sempre più spesso, a voce, quindi non pubblicabili. perUnaltracittà-laboratorio politico, 4 novembre 2016
comunicato stampa
La prevista manifestazione contro le "cattive politiche" del governo Renzi, che doveva tenersi a Firenze domani sabato 5 novembre, in occasione della passerella trionfale e celebrativa del premier alla Leopolda, è stata vietata dalla questura.
Non solo è stata negata la possibilità di portare la protesta fino ai cancelli della Leopolda, è stato vietato tutto, anche il concentramento in piazza San Marco.
Con un atto senza precedenti si intende negare il diritto di manifestare, di esprimere un legittimo dissenso, di portare in piazza la protesta di chi, e sono sempre di più, è colpito, impoverito, umiliato dalle politiche neoliberiste del governo Renzi.
Nel mondo virtuale costruito ad uso e consumo del padrone non c'è posto se non per il plauso interessato e la cortigianeria: quelli brutti sporchi e cattivi, ma soprattutto poveri e sfruttati, che si ostinano a lottare per i propri diritti, non si devono vedere nelle immagini patinate da diffondere in ogni dove.
E invece c'è, e ci sarà, anche domani, chi dice NO, chi non ci sta, chi non china la testa, davanti alle varie "riforme" dell'attuale governo: dal jobs act alla buona scuola, dallo Sblocca Italia alla riforma costituzionale, si vuole disegnare uno Stato e una società sempre meno democratica, sempre più autoritaria, e piegata alla volontà del mercato e delle dottrine neoliberiste.
perUnaltracittà resta al fianco di chi non accetta di essere zittito e rivendica il proprio diritto a dissentire e manifestare.
eddyburg.it condivide
 Alcune sacrosante verità a proposito di terremoto, Nuvola, e soprattutto Matteo Renzi, gli effetti nefasti del suo regime e il dramma dell'assenza di una vera opposizione.
Alcune sacrosante verità a proposito di terremoto, Nuvola, e soprattutto Matteo Renzi, gli effetti nefasti del suo regime e il dramma dell'assenza di una vera opposizione.
Il Fatto Quotidiano, 1 novembre 2016 (p.d.)
Davvero ciò che serve all’Italia terremotata è la fine delle divisioni politiche in nome della Grande Unità Nazionale per la Ricostruzione? Davvero le piaghe strutturali e purulente riaperte dal terremoto infinito dipendono da un eccesso di conflittualità fra governi e opposizioni e solo un balsamico spegnimento della polemica politica ci aiuterà a ricostruire in assoluta sicurezza gli edifici e i monumenti crollati? A leggere i giornali, a vedere i tg e a sentire i politici di ogni colore che blaterano di “solidarietà nazionale”, “unità”, “pace”, “concordia”, “patti”,“tavoli”e financo di rinviare il referendum (quel gran genio di Castagnetti), parrebbe proprio di sì. A saper collegare i puntini della storia recente di un Paese che non riesce mai a trovare una sana via di mezzo tra la rissa permanente e l’eterno inciucio, si direbbe proprio di no.
1. Il governo Renzi si regge su un’ampia maggioranza alla Camera e su una più risicata al Senato: quindi, per far approvare i suoi provvedimenti, non ha bisogno dei voti delle opposizioni. Che devono controllare ciò che fa il governo, votando ciò che ritengono giusto e contrastando ciò che ritengono sbagliato.
2. Il governo Renzi è impegnato in una perenne polemica con la Commissione europea, a cui chiede alcune cose irragionevoli (il permesso di violare gli impegni da esso stesso assunti per la riduzione del debito e il contenimento del deficit) e alcune sacrosante (l’esclusione delle spese per la ricostruzione post-terremoto e per l’accoglienza dei migranti dal patto di Stabilità). Se non mendicasse le prime, avrebbe più potere contrattuale sulle seconde, che comunque l’Ue non pare intenzionata a negargli. E, sulle richieste ragionevoli, sarebbe più credibile se evitasse di reclamare 3,4 miliardi di nuova flessibilità per il terremoto per poi dirottarne i 3/4 sui bonus più o meno elettorali.
3. La legge di Stabilità appena presentata, sul post-terremoto è largamente insufficiente e talora: la ricostruzione di Amatrice e degli altri comuni devastati dal sisma di agosto è prevista entro il 2047, cioè fra 31 anni. E il piano Casa Italia per la prevenzione è poco più di un sacco vuoto. Siccome i comuni ad alto rischio sismico sono il 38%, con 6,2 milioni di edifici, occorrono decine di miliardi. Che non si possono trovare tutti subito, ma che bisogna iniziare a rastrellare. Non facendo altre cambiali da accollare alle future generazioni, sforando ancora il debito e il deficit, ma con un’imposta patrimoniale e una seria lotta all’evasione e agli sprechi. (La legge di Stabilità regala 97 milioni alla Ryder Cup di golf: e cambiano la Costituzione per risparmiarne 40?).
4. Inaugurando la Nuvola all’Eur, la sindaca Raggi ha denunciato 18 anni di sprechi e rinvii e s’è beccata i fischi dei magnamagna in platea. Standing ovation invece per i colpevoli degli sprechi e dei rinvii. In un Paese così occorre più opposizione, non meno.
5. Il mondo delle costruzioni non dà garanzie né di trasparenza né di efficienza. Nelle carte dell’ultima retata per le tangenti sulle grandi opere, l’aspetto meno allarmante è la corruzione: “colla”al posto del cemento armato e costi gonfiati ad arte (da 18 a 61 milioni per l’inutile Terzo Valico) dalla Salini Impregilo, festeggiata un mese fa da Renzi, che dovrebbe regalarci (si fa per dire) il Ponte sullo Stretto. Nella civilissima Lombardia, basta un Tir per polverizzare un viadotto; e un manager inquisito rivela che tutti gli appalti continua a spartirseli la solita cricca di coop rosse e bianche e costruttori noti alle cronache giudiziarie dai tempi di Tangentopoli. Un ras della ’ndrangheta dice di essersi pappato il 70% dei lavori di Expo col trucco dei subappalti. E i manager e costruttori sentiti dai pm che indagano su Expo assicurano che lo staff di Beppe Sala aveva un “unico interesse: concludere i lavori entro aprile 2015” a costo di “arretrare la soglia della legittimità amministrativa” con una “deregulation dettata dall’emergenza”. La Mantovani vinse una gara con un ribasso assurdo del 42%, ma anziché verificarne la congruità “Sala ripeteva che ‘l’unica cosa che non manca sono i soldi’”.
Tutto ciò non risale al solito vago “passato”da dimenticare. Accade oggi, età dell’oro del renzismo arrembante che si accinge a stanziare – com’è giusto – miliardi per la ricostruzione post-terremoto, affidando – com’è inevitabile – centinaia di appalti. Chi ci garantisce gare non truccate, niente appalti a trattativa diretta, niente subappalti a imprese mafiose,niente costi lievitati, niente risparmi sui materiali per accollare le mazzette ai contribuenti, nessuna impresa già condannata?
Renzi ripete il magico abracadabra: “Controllerà tutto Cantone” (cui il governo lesina 83 milioni per far funzionare l’Anac). Per fortuna non ha aggiunto “ricostruzione modello Expo”, come aveva incautamente fatto ad agosto. Ma, con tutto il rispetto per Cantone, anche Expo e le altre grandi opere degli ultimi scandali erano sotto controllo dell’Anac. Quindi Renzi la smetta di usarlo come il Dash che “lava più bianco” o il confetto Falqui che “basta la parola”. Cantone non basta se non cambiano le regole per la ricostruzione: gara obbligatoria per ogni appalto e incarico, niente subappalti, fuori le imprese condannate, agenti provocatori per offrire tangenti ai pubblici amministratori e testarne l’integrità. Le opposizioni devono battersi per questo, tenere gli occhi ancor più aperti e denunciare l’eventuale ritorno dei soliti andazzi e dei soliti noti. Se le norme antisismiche vengono violate da più di 30 anni, non è perché c’era troppa opposizione. Ma perché ce n’era troppo poca.

Quello che raccontano le statistiche è davvero scoraggiante, ogni volta che si parla si cose serie e si guarda dietro alle slides. Un'analisi di Antonio Sciotto e un commento di Andrea colombo. il manifesto, 23 ottobre 2016
ITALIA SENZA FUTURO:
SEMPRE PIÙ GIOVANI
A CASA CON I GENITORI
di Antonio Sciotto
Generazione precaria. Sono il 67% degli under 35 secondo Eurostat, 20 punti sopra la media Ue. Soprattutto maschi, molti hanno già un lavoro. Oltre 40 mila bambini nascono da mamme over 40: è anche questo un nostro «primato» nel continente
La notizia non è di quelle che stupiscono, ma sicuramente non per questo è meno negativa: i giovani italiani sono quelli che si fermano a vivere più a lungo presso i propri genitori (ci battono solo gli slovacchi), e la percentuale dei «mammoni» (così li hanno battezzati ieri, un po’ spregiativamente, agenzie e quotidiani on line) è addirittura in aumento. A certificarlo è l’Eurostat, l’istituto di statistica Ue, che ha diffuso ieri i dati relativi al 2015.
L’anno scorso, secondo Eurostat, oltre due terzi dei «giovani adulti» (il 67,3%), ovvero coloro che hanno tra i 18 e i 34 anni, in Italia viveva a casa con almeno un genitore, una percentuale in crescita sul 2014 (era al 65,4%) e al top nell’Unione europea, se si eccettua, come abbiamo detto, la Slovacchia. Quasi 20 i punti di differenza rispetto alla media del continente, che risulta pari al 47,9%. Si tratta di circa sette milioni di persone.
Il fenomeno è in crescita anche se isoliamo una fascia di età più ristretta, quella tra i 25 e i 34 anni, ovvero tra coloro che dovrebbero aver terminato gli studi e iniziato a lavorare. In questa fascia i giovani a casa con mamma passano dal 48,4% del 2014 al 50,6% a fronte del 28,7% in Ue e del 3,7% in Danimarca.
Ma i sette milioni in causa sono tutti disoccupati? O magari studenti? Niente affatto, si scopre infatti che una buona percentuale di chi decide di rimanere a vivere con i genitori ha un’occupazione, in diversi casi anche stabile. Dichiara di avere un impiego il 40,3% dei giovani intervistati, e ben il 25% ha un posto a tempo indeterminato. Il 18,8% si dichiara ancora studente, mentre i disoccupati sono il 24,3%.
Un dilatamento generale dei tempi che ha come conseguenza anche il rinvio del momento in cui si forma una famiglia, e per le donne vuol dire spesso gravidanze più tardive: fenomeni su cui l’Italia può vantare ugualmente dei primati nella Ue. Oltre 40 mila bambini nascono ormai da mamme ultraquarantenni, il dato più alto in Europa, mentre le mamme giovani risultano molte meno rispetto al resto del continente (quelle tra i 25 e i 29 anni sono meno della metà di quelle francesi).
È interessante notare che mentre da noi le percentuali di giovani che si fermano a vivere presso i genitori sono in crescita (dal 65,4% del 2014 al 67,3% del 2015, come abbiamo detto), in Europa invece si è registrata una discesa, per quanto molto piccola: dal 48,1% al 47,9% dei 18-34 enni.
In permanenza in famiglia ci superano dunque solo gli slovacchi (69,6%), mentre Malta è poco più di un punto sopra di noi (66,1%). A distanza siderale la vicina Francia (34,5%, dato per giunta in calo), e il Regno Unito (34,3%), un poco meno lontana la Germania (43,1%). Assolutamente irraggiungibile (perlomeno nel giro di pochi anni) la Danimarca, che svetta con il suo 19,7% e conferma la precoce (e proverbiale) autonomia dei ragazzi scandinavi.
La tendenza dei giovani italiani a non lasciare la casa dei genitori è ancora più evidente nella fascia tra i 25 e i 34 anni, perché in questo caso il confronto con diversi paesi Ue diventa quasi paradossale. In Italia, anche a causa delle difficoltà nella ricerca di un’occupazione, la percentuale di coloro che sono tra i 25 e i 34 anni e vivono con la famiglia di origine ha raggiunto il 50,6% (era al 44% nel 2011) con quasi 22 punti in più rispetto alla media europea (dietro solo alla Grecia con il 53,4%).
La distanza è siderale rispetto ai paesi del Nord Europa (3,7% la Danimarca, 3,9% la Svezia) ma anche rispetto alla Francia (10,1%, in calo di un punto), il Regno Unito (16%) e la Germania (19,1%) mentre la Spagna è al 39,1%. E l’aumento si è registrato nonostante gli sforzi del governo, da Garanzia giovani ai punti rosicchiati alla disoccupazione under 35.
Interessanti i raffronti (e sempre negativi per l’Italia), se consideriamo diverse fasce d’età: se si guarda a i18-24 anni, vive in casa il 94,5% del totale (79,1% nella Ue) mentre tra i 20 e i 24 anni la percentuale scende al 93% (è al 59,8% in Francia).
A restare a casa sono soprattutto i maschi con il 73,6% del totale tra i 18 e i 34 anni (quasi 3 su 4), in crescita dal 71,8% del 2014. La percentuale, sempre maschile, dei giovani tra i 25 e i 34 anni cresce dal 56,8% al 59,3%, con oltre 24 punti in più rispetto alla media europea. Le donne in questa fascia di età restano a casa nel 41,7% dei casi.
PERCHÉ RENZI
NON AMA IGIOVANI
di Andrea Colombo
Chiederselo è inevitabile: ma Renzi odia i giovani? A sentirlo si direbbe il contrario. Anzi, è tutto uno sproloquio giovanilista, pur se di maniera. Ma le parole costano poco, e i fatti raccontano una storia opposta. Il grande rottamatore, oltre ai suoi nemici politici, ha rottamato soltanto i giovani. È inutile che il ministro Poletti strepiti. Quando il presidente dell’Inps Boeri dice che la manovra massacra ulteriormente i giovani fotografa lo stato delle cose. Non è una novità.
Il Jobs Act sembra davvero un piano diabolico partorito da un mad doctor incarognito con chiunque sia sotto i 30. Gli incentivi studiati per consentire il trucco della trasformazione di contratto e dell’assunzione a tempo indeterminato spogliata di ogni sostanza erano fatti apposta per regalare briciole ai lavoratori attempati senza lasciare agli imberbi neanche quelle: si accontentassero dei voucher. I risultati vengono periodicamente immortalati dalla rilevazioni statistiche e ci vuole la faccia di bronzo del nostro premier per rivenderseli come una vittoria.
Su poco più di 500mila nuovi assunti reali, 402mila sono ultracinquantenni, e se il tasso di disoccupazione, almeno quello nominale, scende nel complesso, tra i giovani non si vede neppure uno spiraglietto. Così finisce che un giorno sì e l’altro pure ci scappa qualche titolone, una volta sui 100mila giovani che ogni anno lasciano il Paese, l’altra, proprio ieri, sulla scoperta che il 67,3% dei concittadini tra i 18 e i 34 anni campa a casa con mamma e papà.
C’è solo da sperare che non aggiunga la beffa al danno qualche dotto, come Elsa Fornero o il compianto Padoa-Schioppa, sentenziando che i fanciulli sono «troppo choosy» e forse decisamente «bamboccioni».
Non sarà antipatia generazionale, figurarsi, ma solo incapacità e solerzia nell’avvantaggiare chi di vantaggi già ne conta a mazzi, come le aziende o le banche, e se di mezzo ci vanno «i ragazzi» è solo per effetto collaterale. Non che siano peccati veniali, però. Il riflesso si coglie con precisione millimetrica nei sondaggi sul referendum. La riforma del giovanilista va fortissimo tra gli over 65, precipita nella fascia mediana, cola a picco tra i giovani, che le meraviglie del renzismo le sperimentano ogni giorno e si fidano dei Tg addomesticati un po’ meno dei nonni.
Sbirciando la legge di bilancio, pardon le sulla medesima perché la legge rimane fantasmatica e vai a sapere cosa ci sarà scritto davvero, sorge tuttavia il dubbio che almeno in quest’ultimo passaggio un po’ di consapevole malignità ci sia stata. La manovra, lo sanno tutti tranne Padoan e lo scrivono persino i giornali ridotti spesso a fanzines di palazzo Chigi, è una specie di befana anticipata.
I pacchetti sono piccoli, è vero, ma in compenso sono tanti. Il materiale non è eccelso, i doni si scasseranno presto rivelandosi mezze fregature o peggio, ma intanto regaleranno un attimo di gioia a molti giusto in tempo per spingerli a votare come conviene.
Eppure in tanta abbondanza i soliti giovani sono rimasti con in mano il classico carbone. Per loro non c’è neppure l’illusione di un miglioramento. Giusto la conferma di quel bonus cultura di 500 euro per i diciottenni che solo a nominarlo viene da ridere, o da piangere.
In un recente consiglio dei ministri Matteo Renzi l’ha spiattellata chiara: «Il voto di sinistra è perso, bisogna conquistare quello di destra». Vuoi vedere che si è anche detto: «Il voto dei giovani, con le mazzate che gli abbiamo dato, è perso. Meglio rinsaldare il consenso nelle fasce dove andiamo forte».
E se qualcuno trova strano che il futuro disegnato da Renzi piaccia solo a chi ha più passato che futuro, sarà pure giovane ma resta gufo.
 Anche Crainz si iscrive tra quanti considerano Renzi un esponente della sinistra e valutano la sua riforma costituzionale isolandola dal contesto della strategia sistematicamente praticata dal segretario del PD dall'inizio della sua ascesa al trono. Per uno storico non è il massimo.
Anche Crainz si iscrive tra quanti considerano Renzi un esponente della sinistra e valutano la sua riforma costituzionale isolandola dal contesto della strategia sistematicamente praticata dal segretario del PD dall'inizio della sua ascesa al trono. Per uno storico non è il massimo.
La Repubblica, 5 ottobre 2016
RIVELA molte cose l’appassionato dibattito su democrazia e oligarchia suscitato dall’articolo di Eugenio Scalfari e dal confronto stesso fra Gustavo Zagrebelsky e Matteo Renzi, come dimostrano le tante lettere arrivate al giornale. È una passione che segna da tempo i confronti e le assemblee pubbliche sulla riforma costituzionale: non mi riferisco qui (e non mi riferirò) alla “animosità da talk show” di alcuni protagonisti ma alla passione vera di molti cittadini, portati ad ingigantire sinceramente i rischi per la democrazia e a sentire vicina una sua crisi radicale ed irrimediabile. Non a caso stiamo parlando soprattutto del popolo della sinistra (quello della destra appare molto meno angosciato, esattamente come i suoi leader) ed ha qualche ragione il lettore che scrive in modo icastico: “la scomparsa di una identità di sinistra ha spalancato i cancelli dello zoo che ci circonda”. È questo popolo orfano di identità a muoversi, talora in modo esasperato, ed a spingerlo non è — o non è solo, a me sembra — la tradizionale “paura del tiranno”, su cui comunque non è lecito ironizzare. È qualcosa di più profondo e non ci parla di un immaginario “altrove”, ci parla di noi e delle nostre inquietudini. Per questo quella passione, portata talora a trasformarsi anch’essa in animosità, non va lasciata a se stessa e certo non può esser considerata solo il residuo di una sinistra ideologica. Per questo è “obbligatorio” passare dalla pancia (in primo luogo dalla nostra pancia) alla testa (in primo luogo alla nostra testa) come ha invitato a fare Mario Calabresi.
In questo passaggio ci aiuta certo la discussione classica su questi temi, e anche quella relativa alla democrazia novecentesca: una democrazia che ha sullo sfondo i processi di industrializzazione e il delinearsi della società di massa, la conquista del diritto di voto e l’affermarsi dei partiti di massa. Ci aiuta ancor di più, forse, una riflessione sulle ansie e sullo spaesamento indotti dal declinare di quella democrazia, dal suo incrinarsi per il drastico modificarsi della realtà sociale e culturale su cui si basava. Indotti, anche, dal contemporaneo e altrettanto radicale modificarsi delle modalità della politica. Viene da qui quello spaesamento, viene da qui quell’angoscia, e con questo dobbiamo misurarci. Diversi anni fa Bernard Manin, ricordato ieri da Nadia Urbinati, ha aperto la riflessione sulla “democrazia del pubblico” — sul trasformarsi cioè della comunità dei cittadini in una platea di telespettatori — e a questo si è aggiunta e sovrapposta poi la realtà della rete. Spettacolarizzazione della politica e delinearsi dei partiti personali hanno preso corpo insieme (e già prima della “discesa in campo” di Silvio Berlusconi, per quel che ci riguarda) logorando l’insediamento dei partiti della società e portando in ultima istanza, per dirla con Ilvo Diamanti ed altri, a partiti senza società e a leader senza partiti. Altri pilastri della democrazia novecentesca sono andati in crisi nei decenni scorsi, nel declinare dell’“età dell’oro” dell’Occidente. Quel declinare ha posto infatti in discussione le modalità tradizionali del welfare, così centrale per le democrazie occidentali (lo ha ricordato spesso con grande lucidità Ezio Mauro): sarebbe stato necessario un ripensamento generale sulle sue modalità e sulle possibilità di un suo allargamento — non di un suo restringimento — nel nuovo scenario che si è delineato, ma quel ripensamento non è venuto. Non è venuta neppure una riflessione sulla formazione e sulla selezione della classe dirigente, assolutamente urgente nel deperire e talora nel crollare delle precedenti forme dell’agire politico. E nel dilagare — non solo nel ceto politico — di forme di corruzione che hanno fatto impallidire quelle del passato.
C’è questo insieme di nodi, a me sembra, dietro le riflessioni sempre più insistite su Come la democrazia fallisce, per citare un libro di Raffaele Simone. C’è questa stessa ansia, questa stessa avvertita urgenza in un comune sentire sempre più diffuso, e non stupisce riconoscerlo nelle molte lettere giunte a la Repubblica o nei molti interventi che rendono talora incandescenti i confronti pubblici sulla riforma costituzionale. E che rischiano troppo spesso di renderli improduttivi, scontri fra opposte sordità, come avviene anche per due dei nodi evocati dal confronto fra Renzi e Zagrebelsky. In questo quadro di incertezze e disorientamenti, ad esempio, l’ipotesi di governi stabili diventa anche in molte assemblee e dibattiti non un segno di salute della democrazia ma quasi un rischio. E la sacrosanta attenzione al mantenimento e al rafforzamento delle figure e degli organi di garanzia porta talora a capovolgere la realtà: così è considerata addirittura un vulnus la norma che in realtà innalza il quorum necessario per l’elezione del Presidente della Repubblica, portandolo dalla maggioranza assoluta ai tre quinti dei votanti, e quindi al di fuori della portata di chi governa (a meno di non ipotizzare una assemblea letteralmente dimezzata nelle presenze, come ha fatto ieri Salvatore Settis). Evitare forzature polemiche o distorsioni è il primo passo per misurarsi con i nodi di fondo: sono nodi ineludibili e forse è un bene, non una iattura, che siano balzati in primo piano con tanta prepotenza. Lo è, per lo meno, se ad essi iniziamo faticosamente a dare alcune prime risposte.
 «Evgeny Morozov. L’esperto mondiale dei nuovi media: “Lo Stato dovrebbe proteggere i nostri dati in mano a Apple o Facebook, non trattarci alla pari”».
«Evgeny Morozov. L’esperto mondiale dei nuovi media: “Lo Stato dovrebbe proteggere i nostri dati in mano a Apple o Facebook, non trattarci alla pari”».
Il Fatto Quotidiano, 7 settembre 2016 (p.d.)
L'Italia è un ottimo esempio dello strapotere dei colossi digitali. Evgeny Morozov, 32 anni, è uno degli esperti dei nuovi media più stimati al mondo e venerdì sarà in Italia per il Festival della Comunicazione di Camogli. E sulle strategie digitali italiane è molto diretto.
Morozov, partiamo dalla cronaca. Che ne pensa del caos Apple-Irlanda?
Ci sono tre ordini di problemi. Primo: in Europa non esiste coerenza fiscale. Secondo: le aziende digitali giocano sulla collocazione del loro business perché i loro guadagni sono online. Terzo: fanno accordi con i governi, da pari a pari. La Silicon Valley è diventata un nuovo mostro.
In che senso?
Questi giganti hanno acquisito troppo potere, penetrano e utilizzano ai loro fini le istituzioni statali. L’Italia è un caso di scuola. Il governo non cerca l’innovazione, ma solo la sua immagine da vendere: stringe accordi o assume consulenti che vengono dalle multinazionali, proprio come è successo con Amazon (il nuovo consulente di governo per il digitale, Diego Piacentini, è un suo alto dirigente in aspettativa ndr).
Quale rischio si corre?
Questi consulenti non hanno esperienza nel settore pubblico e così si crea una graduale privatizzazione di un bene dello Stato mascherata da progresso: si aiutano i colossi a fare cose che i governi avrebbero dovuto fare loro e lo stesso linguaggio usato serve a mascherare la natura politica delle operazione compiute da queste società: si parla di
big food,
big energy e
big finance, ma nessuno parla di
big data. Google e Facebook sono imprese: i loro servizi non sono gratis. Si pagano con i nostri dati.
Come li ottengono?
Con gli oggetti intelligenti, la cosiddetta “internet delle cose”: è possibile tracciare tutto, ma solo loro hanno le infrastrutture per farlo. Il proprietario di una casa può verificare se le persone a cui l’affitterà sono affidabili: ci sono società che possono informarlo. A pagamento.
Una sorta di schedatura.
Ormai si è ben oltre il controllo delle mail. Si pensi alle
smart city presenti nelle agende di società come Microsoft, Hp o Cisco. Tutto, in queste città del futuro, è dotato di sensori. Informazioni che fanno gola ai governi e all’
intelligence, che però da sola non potrebbe mai averle.
Come evitarlo?
Affrontando la questione della proprietà dei dati. C’è un mercato, eppure non c’è nessun quadro regolatorio, nessuna struttura legale che formalizzi questo rapporto.
Potremmo vendere i nostri dati?
C’è chi lo teorizza. Molti dei dati che produciamo, però, potrebbero servire a migliorare il tessuto sociale e gli strumenti pubblici. Non dico di lasciarli alla completa gestione statale, ma di trovare il giusto equilibrio.
Chi dovrebbe farlo?
Istituzioni e gruppi sociali che non siano privati o aziende multinazionali.
Perché non ci si riesce?
Non si comprende ancora la portata di questi temi. La sinistra continua a combattere la
Fire Industry (Finanza, assicurazioni e immobiliare, ndr), ma se non ne percepisce le metamorfosi digitali non potrà mai vincere
Come trova l’Italia?
Il renzismo ha quasi completamente distrutto la capacità di discutere seriamente di tecnologia e digitale. Tutto è astratto, basato sull’idea che l’economia possa ripartire se si creano dieci centri con stampanti 3d. È folle. È un’Italia piena di bullshit, supercazzole. Ci sono personaggi come Riccardo Luna (Digital Champion del governo ndr ), che non hanno nessuna esperienza tecnologica però vogliono creare l’impressione che tutto sia possibile se si invita Google o Amazon. L’unico modo che hanno per dare la sensazione che qualcosa si muova è invitare pensatori vicini a Washington e alla Silicon Valley e creare think tank in cui non c'è nessuna attività utile ma solo lobby. È una tragedia: 20-30 anni fa l'Italia era un grande centro industriale, aveva tutto. Ora ci sono solo parole.

Il Manifesto, 3 settembre 2016 (p.d.)
Il governo somiglia a un club di sciamani. Evoca in suo soccorso forze misteriose per arginare la presenza del male (il terribile zero) che non sa come affrontare con politiche efficaci. Il ministero dell’economia, con le sue danze propiziatorie, gioca con i numeri e anticipa una crescita inesistente. Tocca all’Istat rimettere le cifre in ordine e confermare, nei giorni di Cernobbio, che la ricetta del governo dei bonus è miseramente fallita. Dopo «63 governi dormienti» Renzi si vantava di aver restituito velocità, vigore, ottimismo. Rivendicava persino un ritrovato contatto con la felicità. «Quando attaccano Happy days non lo fanno perché si sentono lontano da Fonzie, ma perché si sentono lontani dalla felicità», diceva Renzi. E però, dopo tre anni di potere vissuti secondo l’ «Italia col segno più», i numeri sgonfiano un chiacchiericcio che produce ormai più irritazione che consenso.
Sebbene abbiano una grande pazienza, i nudi fatti, a un certo punto, si infastidiscono dinanzi a una overdose di comunicazione deviante per la quale la realtà è solo un fastidio e «il vittimismo è un ostacolo alla crescita». Strattonati, i fatti reagiscono alla dittatura dell’ottimismo per decreto.
Senza opposizione e controllo, il governo riesce nell’impresa di affondarsi da solo, con l’incontinenza del suo cinguettio infinito che opera nel mondo del presso a poco. Le sue metafore, spacciate per fascinosa ipermodernità, cominciano a stufare anche i più distratti consumatori di spot che si infastidiscono dinanzi alla strafottenza del governo via tweet («si scrive legge di stabilità, si pronuncia legge di fiducia»). Il pubblico, sebbene indotto dai media alla passività, avverte che la narrazione delle «buone notizie» non corrisponde al vissuto reale. E per questo sente una crescente avversione per un potere che, anche dinanzi alle tragedie, gioca alla fabbricazione di pure trovate linguistiche, come Casa Italia, o in mezzo alle macerie pensa alla prenotazione di incontri mitici con archistar.
Una forma espressiva ricorrente della retorica renziana è quella che scandisce «è finito il tempo». L’intenzione del potere è di rimarcare l’eccezionale portata innovativa del governo del fare. Ogni campo sfiorato dalla mano magica dello statista gigliato diventa incredibilmente fertile. Una svolta epocale si registra ovunque il novello uomo del destino abbia deciso di intervenire, naturalmente con la sua proverbiale velocità di pensiero ed energia corporale.
E, in effetti, qualcosa di epocale nell’azione di governo c’è. Ma non è quella raccontata dalla narrazione («La Quaresima è finita», fantasticava un titolo di Repubblica), che viene trasmessa a media unificati: è o no l’Italia negli ultimi posti nella classifica mondiale della libertà di informazione? Il tempo è finito in senso letterale perché, per la prima volta, si inverte un ciclo storico lungo che ampliava le aspettative di vita. La spesa pubblica per la sanità, e per la prevenzione delle malattie, registra negli ultimi anni un decremento significativo, con conseguenze inevitabili sulla qualità della vita. Mentre il triangolo dell’Etruria dedicava un triennio dell’attività parlamentare per escogitare misure forzate utili a prolungare artificialmente la durata delle legislature e prefigurare gli esiti delle elezioni, la vita delle persone si contraeva senza rimedio. Un nesso tra fuga del pubblico e insicurezza si avvertiva anche nei rapporti di lavoro, abbandonati alla deregolazione della volontà padronale chiamata Jobs Act.
Anche qui «è finito il tempo» della costante contrazione delle morti bianche. E dopo 15 anni di regolare diminuzione, nel 2015 le morti sul lavoro crescono di oltre il 16,5%. Sarà che l’Italia riparte (o come si esprime la ministra Boschi «ha riavviato i motori»), ma per 1.172 lavoratori il tempo è finito per sempre nel dannato 2015.
È «finito il tempo» in cui cresceva la propensione allo studio. Dieci anni fa 73 diplomati su 100 si iscrivevano all’università. Oggi solo 49 su 100 sfidano lo scetticismo del ministro Poletti sul valore dello studio, soprattutto quello che si chiude con lode. Con il 23% di giovani con laurea (metà dei francesi) l’Italia è alla coda dei paesi europei nella scolarizzazione, altro che fandonie sulla generazione Erasmus.
Il governo ora invoca la flessibilità nei bilanci («i soldi me li prendo. Punto»), ma lo fa per distribuire bonus elettoralistici, per trasferire gli scarsi fondi pubblici alle imprese (decontribuzioni, tagli Irap: «Ancora sgravi per chi assume, meno di prima però, affrettarsi prego»), togliendoli ai servizi collettivi e alle politiche industriali. Oltre che inique (niente Tasi per tutti) e antisociali (nessun bonus agli incapienti), le politiche populistiche dell’esecutivo (un neolaurismo che ha appreso le fresche tecniche del marketing pubblicitario) sono del tutto inefficaci.
Mentre l’Europa dichiara guerra alle miliardarie evasioni fiscali del colosso americano dell’informatica, Renzi suole farsi riprendere a palazzo Chigi con una mela, che non è quella che sollecitava la curiosità di Newton («Sono stato denunciato da una associazione consumatori perché uso il Mac e dicono che faccio pubblicità occulta. Ragazzi, una camomillina, una tisana e passa la paura»). Quali sono le potenze che sostengono questo ceto politico della piccola borghesia toscana che dalle rive dell’Arno si accasa nella capitale e che prima sfrecciava con la bici e poi vola con il nuovissimo sup-jet?
All’ombra del Credito fiorentino e di Banca Etruria, dei consigli di amministrazione delle filiali locali, è nato il temibile potere costituente del partito della nazione che, con appoggi massicci e coperture illimitate, pone le basi della terza repubblica. Una palude di scambi, intrighi, ambizioni che accumula influenza nei giornali, nelle società controllate e partecipate, nella Tv e però ha un fondamentale difetto: abile nell’uso delle slide, non sa governare. L’improbabile timoniere annuncia che «l’Italia prosegue la lunga marcia». Verso la catastrofe.
 L'accorata denuncia per un gesto vergognoso della tribù dei renziani, lanciata dell'autrice e conduttrice
L'accorata denuncia per un gesto vergognoso della tribù dei renziani, lanciata dell'autrice e conduttrice
radiofonica della Rai Francesca Fornario e il preoccupato commento di Alessandro Gilioli. Il manifesto L'Espresso online, blog "Piovono rane", 9 agosto 2016
il manifesto
LA DIETA POLITICA DI RADIO2
ECCO PERCHÉ HO DETTO NO, GRAZIE
di Francesca Fornario
«Divieto di satira. "Niente battute su Renzi, niente politica, niente satira...". Le regole per la ripartenza di "Mamma non Mamma" e il casino scoppiato dopo un post su Facebook»
È scoppiato un prevedibile casino per un post che ho scritto su Facebook, annunciando la ripartenza del programma Mamma Non Mamma su Radio2. O meglio, la partenza di un altro programma con lo stesso titolo e le stesse autrici e conduttrici: attrice e imitatrice Federica Cifola, autrice satirica io. (E altre cose, che preferisco saper fare dieci cose male piuttosto che una sola bene, ma a Radio2, quando mi hanno chiamato nel 2008, non mi hanno voluto per scrivere i romanzi, mi hanno voluto per fare la satira, che faccio ogni giorno in pillole a Un giorno da pecora. Facevo, che a settembre Un giorno da pecora trasloca su Radio1). Ecco il post: «Ricapitolando: niente battute su Matteo Renzi, niente politica, niente satira, niente personaggi, niente imitazioni, niente copioni, niente ‘scenette’ qualunque cosa siano, niente comicità e che altro… ah, niente battute sul fatto che non si può dire ‘comunista’. Quel che resta – il mio imbarazzo e il bene che ci vogliamo io e Federica Cifola – va in onda ogni sabato e domenica in diretta su radio2, dalle 18 alle 19.30».
L’ho scritto per correttezza nei confronti dei nostri ascoltatori, che si sarebbero domandati – e si sono domandati – ma come mai non fate più le imitazioni? Ecco perché: ci hanno chiesto di fare un programma diverso. Diverso da quello che aveva funzionato benissimo anche in termini di ascolti, cosa per la quale si era complimentata con noi la direttrice Paola Marchesini due anni fa, dopo la prima edizione del programma. Poi, sono cominciati i paletti. Lo scorso anno Mamma Non mamma è tornato in palinsesto ma «Con una satira più attenta agli aspetti atropologici». Eh? Senza la mamma di Matteo Renzi. «Ma ha senso non fare la mamma di Renzi e fare quella di Alfano?!» Domando. Ovviamente no, e allora niente mamme dei politici e nemmeno politici, niente più Paola Taverna o Michaela Biancofiore.
Andiamo in onda facendo comunque satira politica (mica ho capito come si distingue quella antropologica da quella politica, ma è un limite mio), ad esempio con il personaggio di Angela Merkel che imponeva le riforme strutturali alla Grecia come scusa per incontrare ai vertici l’allora ministro delle finanze Varoufakis («Varoufakis, se non vieni qui subito vi chiudo le banche e vi spremo tutte le olive del Peloponneso!» «Ma gliele avete fatte chiudere veramente le banche!» «Ma era una scusa per vederlo! Non ti sei accorta che le mie erano tutte richieste senza senso?! Me ne inventavo di tutti i colori così lui era costretto a precipitarsi da me! E gli privatizzavo le autostrade, e gli tagliavo le pensioni… con questo nuovo ministro non mi diverto perché non si accorge che scherzo. “Tsakalotos! Taglia le pensioni!” E lui lo fa. “Tsakalotos, se vuoi restare nell’euro scrivi la seguente riforma strutturale: da domani in tutta la Grecia il Sirtaki parte veloce e finisce lento…» «Ma è una riforma senza senso!» «E perché, invece privatizzare il Pireo ti pare sensato?! Ma dai, siamo seri, è come se io privatizzo il Reno!»). O con la direttrice del Fmi Christine Lagarde, mamma così severa che ai figli non dava la paghetta: gli faceva un prestito.
Quest’anno ci chiedono di andare di nuovo in onda senza fare satira politica («Sì, come l’anno scorso», penso. E mi ricordo di un aneddoto che girava molti anni fa su come aggirare la censura in Rai: metti nel copione una bestemmia, una scena di sesso e la battuta sul politico che vuoi far passare. Il funzionario ti toglie la bestemmia e tu protesti. Ti toglie la scena di sesso e tu protesti. A quel punto, convinto di averti censurato abbastanza, ti lascia la battuta sul politico… era un aneddoto di molti anni fa, che oggi la scena di sesso se non c’è te la fanno aggiungere).
Mi metto a scrivere i nuovi copioni del mio personaggio preferito, il capo dell’ufficio del personale che ci chiama in diretta per piazzare i raccomandati: «Ma a cosa mi serve uno scenografo alla radio?!» «Fornario, questo deve lavorare perché è stato raccomandato da presidente del Consiglio in persona!» «Da Renzi?!» «Seh, magari! Con i tempi della burocrazia Rai dobbiamo ancora piazzare i raccomandati da Mussolini nel 1923!» «Ma se non c’era ancora la Rai!» «Certo, quella Mussolini l’ha creata apposta per piazzare i raccomandati. Che infatti prima si chiamava Eiar, Ente Italiano Raccomandati e Amici. Poi Rai, Raccomandati Italiani…».
Ma no, stavolta – ci spiegano – non solo niente satira politica su Renzi o sulla bambola gonfiabile di Salvini: proprio niente personaggi. Niente imitazioni, niente copioni, niente “scenette”. «Ma non possiamo rifare Mamma Non Mamma svuotandolo di tutto – osservo – perché verrebbe fuori un programma banale». (Inoltre, sarebbe stato utile sapere che queste erano le condizioni per lavorare prima di rifiutare altri lavori, ma così è la vita: il tempismo non è mai stato la mia specialità). E allora proviamo a dare un senso di servizio – di servizio pubblico! – al programma, facendolo diventare un’altra cosa. Resto convinta che sapessi assolvere meglio al compito facendo quello che so fare meglio, e il perché la satira sia un servizio pubblico, nel caso ci fosse bisogno di spiegarlo, lo lascio spiegare a Groucho Marx: «La prima cosa a sparire quando un paese viene trasformato in uno stato totalitario è la commedia e i comici. Poiché le persone ridono di noi, non credo che capiscano davvero quanto siamo essenziali per la loro salute mentale».
Nell’ultima puntata, ad esempio, abbiamo provato a dare un senso di servizio pubblico parlando dei libri per bambini che ti cambiano di un poco in meglio la vita, come La guerra del burro del Dr. Seuss (scriverne è anche un modo per dare un senso definitivo a questo pezzo). Questo senza però rinunciare a spiegare perché il programma prima era una cosa e poi un’altra: che secondo anche questo è un servizio pubblico, anche spiegarlo. Se tutti i colleghi che mi hanno scritto in privato dicessero in pubblico le cose che mi hanno scritto sarebbe evidente, ma non possono farlo perché vivono di questo lavoro e non possono rischiare di perderlo come l’ho perso io. Per mia scelta, eh, che stamattina, quando il post ha cominciato a circolare, ho ricevuto una telefonata della capostruttura, molto risentita perché avevo tradito la sua fiducia e dimostrato in questo modo la gratitudine per tutti i soldi che mi aveva fatto guadagnare in questi anni. Le ho spiegato, pacatamente, che non le devo nessuna gratitudine perché in questi anni ho lavorato con ottimi risultati e sono stata pagata per le mie prestazioni professionali, che si comprano quelle ma le persone no, o almeno non questa. Non ci sono quindi più le condizioni per fare satira politica su Radio2 e nemmeno più – per quel che mi riguarda – quelle per lavorare serenamente a un programma diverso, di servizio pubblico.
Ma c’è sempre La guerra del burro da leggere e un mondo fuori da raccontare da qualche altra parte, con qualche altro mezzo. A cominciare da questo, che ora avrò di nuovo tempo per scrivere sul manifesto! Oh, mi sa che ho armato questo casino apposta.
l'Espresso, blog "Piovono rane"
L'ARIA CHE RESPIRIAMO
di Alessandro Gilioli
Accade in Italia - nei giorni agostani di sole, vacanze e Olimpiadi - che un'autrice e conduttrice radiofonica della Rai spieghi su Facebook che quest'anno le hanno cambiato le regole di ingaggio: imponendole zero battute su Renzi, zero politica, zero imitazioni.
Accade che la Rai non possa credibilmente smentire il divieto, anche perché ne ha imprudentemente lasciato tracce. Insomma è tutto vero, oltre ogni possibile dubbio.
Accade il giorno dopo che questo fatto incontestato e incontestabile - il servizio pubblico che impone il divieto di satira sul capo del governo e sulla politica - sia ignorato dalla maggioranza dei media; e che un bene comune, un bene che dovrebbe essere trasversalmente prezioso per ogni schieramento - la libertà, il non asservimento del servizio pubblico al governante di turno - sia derubricato a questione di partito, se non di corrente.
Non so che cosa accadrebbe in Gran Bretagna se la stessa cosa accadesse a un comico della Bbc: ma non credo di mitizzare troppo la cultura anglosassone se ipotizzo che la questione sarebbe diventata in breve il tema politico dell'estate, e non per un giorno. Non credo di sbagliare nel credere che avrebbe acceso un dibattito ampio, coinvolgendo le maggiori testate, il Parlamento, lo stesso premier.
Da noi no. Da noi è il solito piccolo derby stanco, con l'aggravante canicolare. E altre miserie ancora: gli attacchi personali alla conduttrice, le irrisioni tipo "se c'è una dittatura andate a far la Resistenza in montagna invece di starvene al mare", la iattanza di chi ridicolizza la questione a fatto personale o di reddito e non vede - anzi finge di non vedere - il cuore del problema: il servizio pubblico che impone zero satira sul capo del governo, insomma il contrario di quanto avviene in ogni paese libero, dalla Francia agli Stati Uniti.
Del resto, anche sul caso di Bianca Berlinguer erano riusciti a far deragliare il dibattito, attaccando la direttrice che "voleva restare tale a vita come se fosse un diritto acquisito": quando invece, con ogni evidenza, il problema non era e non è la carriera giornalistica di Bianca Berlinguer, ma il fatto che una rete pubblica non abbastanza schierata con il governo e con il suo referendum sia stata modificata ai vertici per ottenere una rete pubblica più schierata con il governo e con il suo referendum.u
Ieri, sulla questione Rai-Fornario, una delle questioni più discusse era la responsabilità o la non-responsabilità del premier. In altre parole, "Renzi non c'entra", hanno detto i suoi supporter più aggrappati ai vetri.
Il che è probabilmente vero, in senso tecnico: dubito anch'io che Renzi abbia personalmente imposto l'ukaze che ha censurato una trasmissioni radiofonica minore. È abbastanza intuibile.
Il problema è che ad averlo fatto sono stati dirigenti messi ai quei posti da Renzi (o anche lì da prima, ma rapidamente convertiti al vincitore). I quali a Renzi e al suo inner circle sono graditi. E da Renzi e dal suo inner circle sono premiati.
Ed è proprio così che si crea un clima, un'omologazione: servilismo da parte di chi ha ruoli dirigenziali nei media e apprezzamento del servilismo da parte del governo. Anzi, qualcosa di più del semplice apprezzamento: se un direttore di tg non omologato all'esecutivo viene fatto fuori, il messaggio a tutti gli altri dirigenti è chiaro. Su come devono comportarsi, cosa devono fare, chi devono imbrigliare.
Non c'è insomma nessun bisogno di ipotizzare un interessamento diretto di Renzi per vedere le responsabilità oggettive della politica nel divieto di satira sulla radio.
E queste responsabilità potrebbero venire meno solo con un intervento forte e pubblico dello stesso governo a difesa della libertà di satira. E con il contestuale allontanamento dei dirigenti di cui vengono accertate le respinsabilità nel caso in questione.
Solo un gesto così cambierebbe il clima, lo rovescerebbe. A favore della libertà anziché dell'omologazione, del servilismo, della censura o autocensura. Dubito molto che quel gesto arrivi. E mi dispiace, perché considero la libertà un bene più prezioso del derby pro o contro Renzi.
Ah, a proposito di clima.
Ieri con Francesca Fornario mi sono brevemente sentito al telefono, nel pieno del casino scoppiato dopo il suo post su Fb. Le ho suggerito di stare soprattutto attenta, in ogni intervento pubblico, a non fare la vittima, a non sembrare arrabbiata, a evitare ogni rischio di iperbole. A non parlare di "regime" e a usare con estrema parsimonia perfino la parola "censura". Perché poi ti sfottono, ti dicono che non sei in una cella turca ma al comodo di un appartamento a Roma, ironizzano sul fatto che non sei abbastanza povera per piangere.
Perché questo è il clima, oggi: blame the victim. Che poi è il modo migliore per deligittimare le critiche. Caricaturarle. Ridicolizzarle. Definire "furiosi", "estremisti" e (immancabilmente) "grillini" quelli che osano criticare: anche se lo fanno con il sorriso, o con il ragionamento, o semplicemente con la cronaca dei dati di realtà.
E anche questo è tema che meriterebbe una riflessione, se fossimo un Paese civile, Renzi o non Renzi.
L'aria che respiriamo, insomma: piú importante di qualsiasi maggioranza di governo.

Renzi&laRepubblica uniti nella lotta contro la verità. Il referendum contro la de-forma costituzionale è un atto dovuto (articolo 138 della Costituzione), non un cortese omaggio del Capo. Il manifesto, 7 agosto 2016
Grande titolo in prima pagina subito sotto la testata, ieri ha annunciato ai suoi lettori e al mondo il «Via libera al referendum». Una decisione che secondo il quotidiano romano è stata presa venerdì dall’ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, che sarà ufficializzata lunedì ma che il giornale ha potuto «anticipare». La notizia era già stata pubblicata, con minore enfasi e certo per meno lettori, il giorno prima dal manifesto. Perché la riunione in cui i giudici della Cassazione hanno preso la loro decisione si è tenuta giovedì, non venerdì. «Via libera al referendum. I ribelli Pd pronti al No» il titolo di Repubblica ieri, «Referendum, arriva il via. Dieci No dai gruppi Pd» il nostro titolo il giorno prima.
Fin qui poco male, cose che capitano, a volte anche a noi. Molto male invece che si voglia far passare l’idea – aprendo la prima pagine del giornale su questa notizia, come abbiamo visto non precisamente inedita – che solo adesso possiamo essere certi che il referendum costituzionale si farà. Solo adesso che la Cassazione ha accolto l’ultima richiesta, quella dei comitati per il Sì sostenuta da quasi 600mila firme dichiarate. La richiesta di Renzi. Non è così, perché che il referendum si farà lo sappiamo con certezza da esattamente tre mesi. Dal 6 maggio, quando lo stesso ufficio della Cassazione ammise le richieste presentate prima dai parlamentari sostenitori del No e poi da quelli sostenitori del Sì. Con quanta enfasi trattò questa notizia allora
la Repubblica? Nessuna, si limitò a inserirla all’interno di un pezzo il cui titolo era «Riforme, la sfida di Renzi. Al referendum si vedrà con chi sta il popolo». Il genere di slogan, sia detto per inciso, che adesso il presidente del Consiglio evita di utilizzare anzi nega di aver mai usato, ora che «non sono io a personalizzare il referendum».
In effetti non c’era (e non ci sarebbe) da scaldarsi troppo per la decisione della Cassazione. Perché in definitiva il referendum costituzionale è un atto dovuto quando si presentano le condizioni previste dall’articolo 138 della Costituzione, la prima delle quali è che la riforma non abbia ricevuto in parlamento la maggioranza «qualificata» dei due terzi dei voti. Come in questo caso. Ovviamente per presentare il referendum come il risultato dell’iniziativa di Renzi bisogna mettere un po’ tra parentesi questi dettagli. E poi, annunciare che solo adesso possiamo stare certi che il referendum si farà aiuta palazzo Chigi a gestire la prossima mossa: la scelta della data.
Al punto in cui siamo, nulla impedisce al presidente del Consiglio di convocare la prossima settimana il Consiglio dei ministri che deve fissare la data del referendum. Più volte Renzi ha sostenuto che, fosse per lui, si andrebbe a votare «il più presto possibile». L’ha detto anche in televisione ma a ogni buon conto lo ripeteva ancora ieri in un retroscena sempre su Repubblica, dunque possiamo fidarci: «Io voterei anche subito». Da qualche tempo però, da quando le amministrative prima e i sondaggi poi hanno fatto capire al presidente del Consiglio che rischia seriamente di perdere la «sfida», a queste solenni intenzioni si accompagnava la necessità di aspettare la decisione della Cassazione. Che è giunta solo ieri, all’improvviso, senza dare il tempo di immaginare una data – perché così ci fa capire Repubblica. E non basta. Ora «ci sono i tempi tecnici da rispettare», aggiunge Renzi, sempre nel retroscena.
Ma neanche questi tempi «tecnici» sono misteriosi: il referendum si deve tenere minimo 50 massimo 70 giorni dopo il Consiglio dei ministri che lo indice. Dunque, convocando i ministri la prossima settimana, potremmo tranquillamente andare a votare nelle prime settimane di ottobre. Anche il 2 ottobre, come Renzi si augurò in tv prima che cambiasse il vento. La legge di stabilità, il parlamento impegnato nella sessione di bilancio non possono essere indicati come un ostacolo, arriveranno dopo (l’anno scorso il governo presentò la legge in senato il 25 ottobre). Eppure non andrà così e voteremo a novembre inoltrato. Perché per allora Renzi spera di aver risalito la china. Aiuti non gli mancano.









 ».
».