

Un'occasione d'oro per tentare di dare ordine, vivibilità e tutela delle qualità naturali e storiche del territorio e delle comunità che lo abitano. Ma si impegneranno su questo terreno le forze alternative ai «poteri forti dell’avidità speculativa e della sopraffazione»?
Com’è noto, la “legge Delrio”, la n. 56 del 2014, ha modificato radicalmente consistenza e procedure di formazione degli organi elettivi delle province, sostituendo queste ultime, per gli ambiti dei 9 più grandi capoluoghi regionali, con un nuovo ente, denominato appunto “città metropolitana”.
Esso è amministrato ope legis dal sindaco del capoluogo con l’ausilio di un consiglio metropolitano eletto fra di loro, con voto ponderato in relazione alla dimensione demografica dei comuni, dai soli sindaci e consiglieri comunali dell’ambito coincidente con il territorio della preesistente provincia. Una rappresentanza indiretta di questo genere determina una straordinaria debolezza politica del nuovo ente, percepito come lontano dagli interessi sociali dei territori e percorso da accordi feudali fra i partiti. La legge ammette il passaggio ad un ente con organi eletti direttamente a suffragio universale subordinandolo però a condizioni non facilmente conseguibili, quali la suddivisione del territorio metropolitano in “zone omogenee”, definita d’intesa con la regione, e quella del territorio comunale del capoluogo in municipalità, le une e le altre dotate di significative autonomie amministrative. A valle del conseguimento di tali condizioni, sarà poi necessaria l’approvazione di un’apposita legge elettorale statale.
A Napoli lo statuto metropolitano è stato approvato dalla conferenza metropolitana (l’assemblea di tutti i sindaci), su proposta del consiglio metropolitano, con qualche ritardo, solo al termine della primavera 2015. In aderenza alle indicazioni della legge Delrio, esso considera centrale per l’ente e le sue attività il “piano strategico” triennale (da aggiornarsi annualmente), con il quale deve rapportarsi, fra gli altri strumenti, il “piano territoriale metropolitano”, articolato in una componente strutturale, valida a tempo indeterminato, ed una operativa, di validità triennale.
A quasi tre anni di distanza dall’approvazione dello statuto, a conferma dei limiti politici del nuovo ente, le attività per la formulazione del piano strategico stentano ancora ad avviarsi, mentre si presenta meno arduo il percorso relativo al piano territoriale. Quello ora pubblicato, infatti, è in sostanza il piano territoriale di coordinamento proposto nel 2008 e aggiornato nel 2014 dalla provincia di Napoli. La città metropolitana aveva già deciso di adottarlo con delibere del sindaco metropolitano del gennaio e dell’aprile 2017, che avevano incontrato reazioni contrastanti dei comuni e delle forze sociali. Va sottolineato, innanzitutto, che la legge regionale sul governo del territorio, la 16/2004, cui sono state apportate più volte modifiche parziali, non è stata adeguata in merito, ragion per cui non sono ancora formalmente definiti né i contenuti del piano territoriale metropolitano né le procedure per la sua approvazione. In riferimento a tale situazione di incertezza giuridica, gli atti della città metropolitana dichiarano con chiarezza la volontà di interpretare l’iniziativa in corso come l’avvio di un percorso “ponte” verso il futuro strumento di governo territoriale.
La coincidenza temporale con la campagna elettorale per il parlamento nazionale non sta, tuttavia, facilitando il dibattito sul piano, pressoché ignorato dagli organi di informazione e considerato finora assai poco anche dalle amministrazioni comunali. Ed è una circostanza negativa perché esso può indubbiamente costituire un utile base di partenza, dal momento che la sua impostazione denota adeguata consapevolezza della complessità delle questioni con cui misurarsi e della necessità di un approccio strategico olistico e integrato. Le sue opzioni fondamentali mirano infatti ad intrecciare fra loro:
- la tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale come scelta strategica per un diverso sviluppo, liberato dalle mistificazioni della crescita quantitativa e basato sulla valorizzazione economico-sociale delle qualità identitarie, intese prima di tutto come fattori di benessere per le comunità insediate;
- il drastico contenimento del consumo di suolo, non consentendo le tradizionali espansioni urbane su territori agricoli, ma solo calibrate densificazioni insediative di aree già parzialmente urbanizzate o edificate con basse densità edilizie, e promovendo invece l’alleggerimento demografico degli ambiti vesuviano e flegreo a più elevato rischio vulcanico;
- il superamento degli squilibri fra il distretto centrale del capoluogo e i territori periferici dell’hinterland in direzione di una riorganizzazione policentrica e reticolare del sistema urbano verso “una città di città”, basata sulla riqualificazione ambientale, sulla complementarità funzionale e sull’integrazione socio-culturale di tutti gli aggregati insediativi;
- il perseguimento di un sistema intermodale di mobilità che valorizzi il trasporto collettivo e riduca il traffico automobilistico privato, integrando inoltre le reti di trasporto in modo da temperare l’antica polarizzazione radiocentrica sul capoluogo con nuove connessioni dirette fra i settori esterni dell’area metropolitana;
- la protezione e la riqualificazione paesaggistico-ambientale dei territori agricoli, tutelati anche per la loro elevata produttività, innervandoli inoltre mediante una adeguata rete di corridoi ecologici agganciati al sistema dei parchi (parco naturale nazionale del Vesuvio; parchi naturali regionali dei Campi Flegrei, dei Camaldoli, del Partenio, dei Monti Lattari e del fiume Sarno; parco agricolo dei Regi Lagni);
- la qualificazione polisettoriale delle attività produttive puntando su energie rinnovabili, tecnologie avanzate e interdipendenze settoriali, nel cui contesto ruolo prioritario viene riconosciuto alla rigenerazione urbana.
È evidente che l’anticipazione di fatto, rispetto al piano strategico, di uno strumento urbanistico così connotato determinerebbe qualche garanzia in più circa la sostenibilità delle prossime politiche di sviluppo. Diventa perciò decisiva, ora, la questione delle modalità di costruzione del piano strategico, soprattutto in rapporto alla necessità di coinvolgimento autentico, oltre che delle istituzioni elettive, anche di tutte le forme sociali di autorappresentazione e di tutti i soggetti che stanno animando le numerosissime vertenze dal basso oggi in atto, specie per la difesa dei beni comuni e il recupero sociale di immobili e spazi abbandonati o violati. Il confronto dovrà insomma assicurare non solo l’efficacia dell’elaborazione, ma anche una sua più sostanziale democraticità.
Salviamo il paesaggio, 8 gennaio 2018. Decine di ex soprintendenti e di cattedratici importanti smentiscono Franceschini: dov’è precipitata la tutela? (c.m.c)
La situazione di caos e di paralisi creata dalla “riforma” Franceschini separando la valorizzazione (nel senso di monetizzazione) dalla tutela e privilegiando la prima a discapito della seconda passa praticamente sotto silenzio – con pochissime lodevoli eccezioni – nella stampa e nella televisione nazionale.
Ciò è grave in sé. Ma è anche dovuto al fatto che i soprintendenti e gli altri tecnici della tutela non possono assolutamente fare dichiarazioni, denunciare lo stato di confusione fra Soprintendenze, Poli Museali e Fondazioni di diritto privato, di depotenziamento strutturale, di esasperata burocratizzazione in cui versano gli organismi e gli uffici che per oltre un secolo hanno operato per difendere dalle aggressioni speculative, dall’abbandono, dall’incuria il patrimonio storico-artistico-paesaggistico.
Tocca quindi a noi – in luogo dei tecnici imbavagliati e minacciati di sanzioni – denunciare pubblicamente la gravità di una situazione in cui ministro e Ministero continuano a magnificare conquiste straordinarie, mentre la spesa statale per la cultura rimane una delle più basse d’Europa, un terzo di quella francese, metà di quella spagnola, e i suoi recenti relativi incrementi, beninteso rispetto al minimo dello 0,19 % del bilancio statale toccato nel 2011 (governo Berlusconi IV) rispetto al 39 % del 2000 (governo Amato II), vengono indirizzati su obiettivi futili o sbagliati.
Ad esempio, si investono ben 18 milioni di euro nell’arena Colosseo per chissà quali spettacoli gladiatorii (dopo la farsa grottesca dell’ opera rock “Divo Nerone” sul Palatino) e si lascia agonizzare, senza mezzi né personale, lo strepitoso parco archeologico dell’Appia Antica o si istituisce un biglietto d’ingresso al Pantheon per poterne curare la manutenzione.
Si organizzano gare di canottaggio nella vasca della Reggia di Caserta o si propagandano al suo interno prodotti tipici della zona e intanto la vasca risulta ingombra di rifiuti e l’intonaco cade a pezzi in una sala importante.
Mentre, tanto per corroborare i vantati incrementi degli ingressi, si organizza al grande Museo Archeologico Nazionale di Napoli una mostra sul Napoli Calcio con magliette, ricordi e gadget di Maradona.
Non si tiene in alcun conto il pesante conflitto di interessi sancito dall’Autorità Nazionale Anti-Corruzione per un concorso tecnico-scientifico a Pompei, creando così un grave precedente. Si declama ad ogni passo la Bellezza dei paesaggi italiani, sempre più aggrediti da speculatori e abusivi, e per contro si lascia che la stragrande maggioranza delle regioni (17 su 20) non predisponga, d’intesa col Ministero, e poi approvi, i Piani paesaggistici previsti dal Codice per il Paesaggio del 2007. Nel contempo si tace sul tentativo dissennato – stornato per questa legislatura dalle opposizioni – di svuotare la legge Cederna-Ceruti n. 394/91 sulle aree protette (il 12 % ormai del territorio nazionale, montano soprattutto, con 23 Parchi Nazionali rispetto ai 4 ante 1991) anziché aggiornarla al Codice per il Paesaggio e applicarla seriamente.
A colpire è la strategia di fondo del MiBACT: da una parte si trasferisce dagli stessi Poli museali a fondazioni di diritto privato la valorizzazione sempre più commerciale del patrimonio e dall’altra si prospetta con la legge Madia la sottomissione delle Soprintendenze, decisamente indebolite, ad un organo di governo locale come la Prefettura. Una offensiva, antistorica scemenza.
Le denunce sullo stato penoso della tutela piovono ormai da tutta Italia e quindi il nostro elenco potrebbe continuare a lungo. Ci fermiamo qui per chiedere con forza ai partiti, al futuro Parlamento che questa deriva disastrosa venga fermata e ai media di ogni genere di cominciare almeno ad indagarla, a raccontarla seriamente – non limitandosi alle cifre di facciata, sempre più discutibili – ridando voce alle più collaudate competenze tecnico-scientifiche.
A questo punto la rete dissestata della tutela va letteralmente ricostruita. con la scelta strategica di far di nuovo prevalere l’interesse pubblico sugli appetiti privati, premiando i capaci e meritevoli, riempiendo i vuoti negli organici dei beni culturali, evitando la chiusura per “vecchiezza” di archivi e biblioteche dove l’età media del personale supera i 60-65 anni e i trentenni rappresentano lo 0,6-1,6 % degli addetti.
Il Ministero per i Beni Culturali non può, non deve diventare il Ministero del Turismo (attività chiaramente indotta dal patrimonio culturale e paesaggistico), né si possono sottomettere ai Prefetti le Soprintendenze. Un autentico oltraggio alla tradizione ammirevole dei nostri studi e degli interventi di restauro e di recupero sul territorio e un continuo danno inferto agli stessi interessi del Paese. Per il quale la cultura e la ricerca, in sé e per sé, cioè senza finalità economiche immediate, scolpite nell’articolo 9 della Costituzione, rappresentano il motore fondamentale.
Adriano La Regina, già soprintendente Archeologia Roma, Accademico dei Lincei
Francesco D’Andria, professore emerito di Archeologia greca e romana, Università del Salento
Andrea Emiliani, già Soprintendente ai Beni storici e artistici Bologna, Ferrara e Romagna, Accademico dei Lincei
Mario Torelli, già docente a Perugia di Archeologia, Accademico dei Lincei
Desideria Pasolini dall’Onda, fondatrice di Italia Nostra nazionale
Licia Vlad Borrelli, archeologo, già Istituto Centrale del Restauro
Giorgio Nebbia, ambientalista, professore emerito Università di Bari
Fausto Zevi, già Soprintendente archeologico Napoli e Caserta e docente alla Sapienza, Accademico dei Lincei
Pietro Giovanni Guzzo, archeologo, già Soprintendente in Puglia e a Pompei, Accademico dei Lincei
Maria Luisa Polichetti, già direttrice del Catalogo centrale e Soprintendente ai Beni architettonici delle Marche
Jadranka Bentini, già Soprintendente ai Beni storici e artistici di Bologna, Ferrara e Romagna, presidente di Italia Nostra a Bologna
Germana Aprato, già Soprintendente ai Beni Architettonici dell’Umbria
Lucia Fornari Schianchi, già Soprintendente ai Beni Storici e Artistici di Parma e Piacenza
Antonio De Siena, già Soprintendente archeologico della Basilicata
Anna Gallina Zevi, già Soprintendente archeologico ad Ostia Antica
Elio Garzillo, già Soprintendente ai Beni architettonici di Bologna e regione
Gianfranco Amendola, ex magistrato, docente di Diritto Ambientale
Carlo Alberto Graziani, già presidente del Parco Nazionale dei Sibillini e ordinario di Diritto Civile a Siena e Camerino
Valerio Magrelli, poeta, ordinario di Letteratura francese all’Università di Cassino
Bruno Toscano, professore emerito di Storia dell’arte Roma Tre
Ebe Giacometti, presidente Italia Nostra Lazio, delegata ai Parchi
Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, presidente emerito Corte di Cassazione
Claudio Meloni, coordinatore nazionale della FpCgil del MiBACT
Andrea Camilli, responsabile Assotecnici del MiBACT
Maria Teresa Filieri, già direttore dei Musei Nazionali di Lucca
Gianni Venturi, già ordinario di Letteratura italiana all’Università di Firenze
Paolo Liverani, archeologo, ordinario all’Università di Firenze
Sandro Lovari, professore emerito di Ecologia, Università di Siena
Carlo Alberto Pinelli, professore al Suor Orsola Benincasa di Napoli, presidente di Mountains Wilderness
Lucia Lepore, archeologa della Magna Grecia, già docente a Firenze
Carlo Pavolini, archeologo, già docente Università della Tuscia
Giovanni Losavio, magistrato, già presidente nazionale di Italia Nostra, ora della sezione di Modena
Vezio De Lucia, urbanista
Pier Luigi Cervellati, architetto e urbanista
Bernardino Osio, ambasciatore
Orio Ciferri, genetista, fondatore del primo corso interdipartimentale sui beni culturali a Pavia
Giorgio Boscagli, Gruppo dei 30 per i Parchi, già direttore Parco Nazionale Foreste Casentinesi
Katia Mannino, associato di archeologia classica, Università del Salento
Francesco Pardi, studioso del paesaggio, “Liberacittadinanza”
Luciana Prati, già direttrice Musei Civici e Biblioteca comunale Forlì
Francesca Valli, storica dell’arte, già coordinatrice delle raccolte storiche Accademia di Brera
Lucinia Speciale, storica dell’arte, Università del Salento
Francesco Mezzatesta, fondatore della LIPU, naturalista, coordinatore Gruppo dei 30 per i Parchi
Corrado Stajano, giornalista scrittore
Paolo Maddalena, giurista, già giudice della Corte Costituzionale
Benedetta Origo, presidente Comitato per la Val d’Orcia
Stefano Deliperi, presidente Gruppo di intervento giuridico Onlus, Cagliari
Maurizio Chierici, giornalista scrittore
Salvatore Bragantini, economista, editorialista
Gianandrea Piccioli, consulente editoriale
Fernando Ferrigno, giornalista tv e scrittore di Beni culturali
Ugo Mattei, professore di Diritto civile e dell’Ambiente, Università di Torino
Alberto Abrami, già ordinario di Diritto Forestale e Ambientale, Università di Firenze
Simona Agostini, ricercatrice Urbanistica, Università di Bologna
Andrea Buzzoni, già dirigente Ferrara Arte e delle Attività culturali del Comune, Ferrara
Luisa Bonesio, già associato di Estetica Università di Pavia, direttore dei Musei dei Sanatori di Sondalo (Sondrio)
Alessandro Gogna, alpinista, storico dell’alpinismo
Simona Rinaldi, Università della Tuscia
Pino Coscetta, giornalista scrittore
Luisella Battaglia, Istituto italiano di Bioetica
Matteo Righetto, scrittore, comitato scientifico Mountains Wilderness
Italo Sciuto, professore di Filosofia Morale, Università di Verona
Stefano Sylos Labini, ricercatore scientifico ed economista
Tomaso Montanari, ordinario di storia dell’arte moderna, Università Federico II Napoli e presidente di Libertà e Giustizia
Maria Pia Guermandi, archeologa, responsabile progetti europei sul patrimonio culturale
Natalia Piombino, docente Syracuse University Florence
Gaia Pallottino, coordinatrice Comitato residente città storica, Roma
Cristiana Mancinelli Scotti, Forum Salviamo il paesaggio
Angelo Maria Ardovino, già soprintendente archeologico di Milano, Salerno, Campobasso
Fabio Grasso, giornalista, storico dell’arte
Franca Arduini, già dirigente biblioteche MiBACT
Giovanni Solimine, ordinario di Biblioteconomia Università La Sapienza e già componente (dimissionario) del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici
Linda Giuva, Professore Associato di Archivistica, Università La Sapienza, Roma
Irene Berlingò, ex Soprintendente ABAP Cosenza
Aglia Englen, storica dell’arte in pensione
Elena Lattanzi, gia’ Soprintendente ai Beni archeologici della Calabria
Elisabetta Mangani, già direttore archeologo del MiBACT
Giuseppina Cerulli Irelli già Soprintendente Archeologo
Cecilia Ghibaudi già funzionario Soprintendenza Beni Storici e Artistici di Milano
Gabriella Pescatori già Funzionario del MIBACT
Giovanna Nepi Sciré già soprintendente al Polo Museale Veneziano
Adriano Maggiani, Archeologo, già professore ordinario di Etruscologia e archeologia italica all’Università Ca’ Foscari di Venezia
Rosalba Antonini, docente emerita Università degli Studi di Urbino
Gianfranco Madori, già Sindaco di Perugia e Professore Ord. nell’Università di Perugia
Enzo Marzo, presidente Fondazione Critica Liberale
Anna Maria Amonaci, docente di storia dell’arte e di fotografia all’Accademia di Brera
Andreina Draghi, storica dell’arte medievale
Nicola Cimini già direttore del Parco Naz. della Maiella, Gruppo dei 30
Vittorio Emiliani, giornalista e scrittore Beni culturali
ArcipelagoMilano, gennaio 2018. Analisi giustamente impietosa di una città, avvelenata dall'immobiliarismo, che si disfa a furia di distruggere e ricostruire, più brutte e più inique, parti di se stessa
«L’afflusso di capitali nella trasformazione fisica della città è sempre e comunque positivo, un segno della vitalità di Milano»: c’è questo assunto alla base delle scelte urbanistiche delle amministrazioni che si sono succedute a palazzo Marino dal dopoguerra a oggi. Ma è un assunto tutto da dimostrare. È vero che c’è stato un momento, nell’avvio della ricostruzione, in cui mettere mano alla città rispondeva, fra le esigenze vitali, alla necessità di creare lavoro in un’economia bloccata; così come è vero che per i due o tre decenni successivi è potuta apparire fondata l’affermazione per cui «quando l’edilizia va tutta l’economia va»; ma oggi una tale supposizione è sempre meno credibile.
Basti pensare che i grandi complessi edilizi appena realizzati nella città ambrosiana si configurano come assemblaggi di componenti per lo più non prodotti nel territorio sul quale sorgono (i vetri degli ultimi grattacieli, per fare un esempio, vengono dalla Cina). Ma soprattutto non si può non tenere conto dell’invenduto e delle risorse finanziarie che la produzione in eccesso di case e uffici immobilizza sottraendole a investimenti strategici. La crisi delle banche è all’ordine del giorno, ma difficilmente viene in chiaro che, tra le cause prime della crisi, c’è il sostegno incondizionato alla deriva immobiliarista.
A Milano il quadro sembra ora presentare un’impennata (del resto il nuovo skyline che cos’è se non l’istogramma della rendita immobiliare?). Così la messa in campo delle grandi operazioni che caratterizzeranno i prossimi decenni (Expo e Scali ferroviari) ha potuto avvantaggiarsi di un’onda montante: i peana elevati senza sosta dai media tanto al nuovo paesaggio urbano (da Porta Nuova a Citylife) quanto al crescente interesse dei grandi investitori per il capoluogo lombardo. Ma il coro plaudente ha molto della claque.
E che non sia innocente lo dice il silenzio degli stessi media sui grandi fallimenti: Santa Giulia, l’area ex Falck di Sesto San Giovanni, la “Nuova Defense” dello Stephenson Business District, il mancato recupero dell’ex Ortomercato, per limitarci ai casi più eclatanti. Sta di fatto che, invece che rimanere con i piedi per terra, chi ha la responsabilità dell’amministrazione della città preferisce esibirsi in volteggi su quell’onda mediatica, sperando che anche gli elettori finiscano per vedere la realtà attraverso il filtro magico delle sirene incantatrici.
La mistificazione, va detto, è di casa nell’urbanistica moderna. Nel secolo scorso obiettivi come il risanamento igienico e l’efficienza viabilistica hanno fatto velo sulle vere finalità dei piani urbanistici. Se nei bombardamenti della Seconda guerra mondiale Milano ha perso un quarto dell’edificato, in nome dell’igiene e dell’accessibilità automobilistica la città ha conosciuto altre due guerre in tempo di pace: quella ingaggiata dal piccone demolitore mussoliniano e poi quella condotta dal rinnovamento urbano degli anni della ricostruzione e del boom economico (quando si portavano a esecuzione molti dei piani messi a punto negli anni del fascismo).
Risultato: più di tre quarti della città entro i Bastioni ha meno di cent’anni. Ma invano, nelle relazioni di piano, si cercherà traccia del fatto che tutto questo abbia coinciso con un colossale ridisegno della topografia sociale (in senso classista) e con una radicale semplificazione della complessità urbana. Un’eccezione si è avuta sotto il regime fascista quando i rapporti di forza erano tali che non costituiva un problema chiamare le cose per nome. In quel contesto l’autore del piano regolatore del 1934, Cesare Albertini, poteva indicare apertis verbis nel novembre 1931 che l’obiettivo primo del piano per la città centrale era la sistematica rimozione, con «il ferro ed il fuoco», di quel che rimaneva dei quartieri popolari nella zona centrale e la «deportazione degli abitanti» (all’incirca 100.000 persone, secondo i calcoli di Graziella Tonon e di chi scrive).
Il trionfalismo sul successo immobiliarista attuale (che, come si è detto, è solo una faccia della medaglia) è l’ultimo espediente messo in campo per evitare che la pubblica amministrazione si misuri sulla portata strategica delle trasformazioni urbanistiche da essa innescate. Tutta l’attenzione è volta a rendere appetibile l’investimento immobiliare (da cui l’adozione di un irragionevole indice di edificabilità destinato a condizionare negativamente gli interventi sugli ex Scali ferroviari).
Nel contempo si ignora quello che l’esperienza dice in modo incontrovertibile e cioè che l’iniziativa privata è del tutto disinteressata agli obiettivi strategici sui quali dovrebbe invece puntare un responsabile governo della città. Così il destino di Milano viene consegnato nelle mani di operatori che non si porranno il benché minimo problema su due fronti essenziali: 1) la capacità delle trasformazioni urbanistiche di attrezzare la città e il contesto metropolitano alle sfide economiche della globalizzazione; 2) la qualità della civitas (le relazioni sociali) e la qualità dell’urbs (i singoli luoghi come l’edificato nel suo insieme). L’ottimismo che accompagna i quadri previsionali è funzionale all’esclusione di ogni verifica su tutto quanto concorre a definire la sostanza squisitamente civile e politica delle decisioni urbanistiche. Sostanza che si può sintetizzare in quattro punti: coesione del corpo sociale; inclusione; urbanità e bellezza dei luoghi; sicurezza.
Invece che perseguire questi obiettivi, l’amministrazione comunale concentra l’attenzione sulle entrate fiscali in cui hanno un peso rilevante gli oneri di urbanizzazione. Siamo all’ennesima mistificazione: quelle entrate non coprono gli esborsi attuali e futuri per le opere pubbliche e questo non farà che rendere cronico il deficit delle amministrazioni locali.
Ma il deficit più preoccupante è sul fronte del fare città. A Milano si è imboccata la strada del proliferare di spazi pubblici inospitali, presidiati da edifici fuori scala, oscillanti fra l’indifferenza al contesto e l’arroganza; quando invece si dovrebbe puntare su una riqualificazione urbana capillare, a cominciare dalle periferie. Lo scialo di denaro pubblico in un’operazione anti-urbana come quella del recupero dell’area ex Expo (vero e proprio buco nero di risorse collettive) dimostra che non è solo e tanto una questione di scarsità di risorse: fare città (nel senso di difendere e incrementare la qualità urbana dei luoghi) o disfare le città esistenti, è questo, più che mai, il tema centrale della politica.
Effetti perversi del piano casa a Roma che premia la demolizione di edifici storici con aumenti di cubatura. Le amministrazioni cambiano, i palazzinari restano. (m.b.).
 |
| Villa Paolina. L'edificio che sarà demolito |
Dopo la palazzina di Via Ticino, un’altra costruzione in un quartiere novecentesco di Roma è condannata alla demolizione. Si tratta di Villa Paolina di Mallinckrodt, che dal 1922 sino al 1997 ha ospitato l’istituto scolastico delle Suore della Carità cristiana. La società che ha acquistato l’edificio, grazie alla Legge regionale 21/2009 (il cosiddetto “Piano Casa”), potrà realizzare un palazzo di otto piani più un parcheggio interrato. Dopo le proteste dei cittadine e delle associazioni, fonti giornalistiche hanno riferito che la ditta è disposta a rivedere il progetto, concordando con il Comune "le indicazioni di ordine architettonico ed estetico" che verranno segnalate dal Comitato per l'Architettura dell'assessorato all'Urbanistica del Campidoglio.
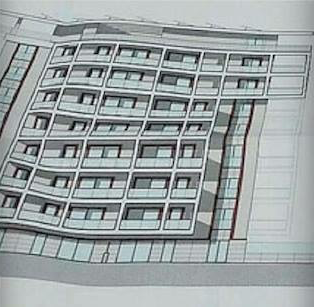 |
| Il progetto del nuovo edificio. Esteticamente rivedibile... |
Ma rispetto all'abbattimento dobbiamo dire la verità: non c’è (più) niente da fare. E la responsabilità non è del Comune di Roma, ma dell’amministrazione di centrosinistra della Regione Lazio. Noi di Carteinregola avevamo lanciato l’allarme nell’autunno 2014, quando ancora qualcosa si poteva fare. Il consiglio regionale del Lazio stava per approvare una nuova versione dello sciagurato Piano Casa, varato dal centrodestra nella precedente consiliatura, nella versione della Giunta dell'attuale Presidente Nicola Zingaretti, che ne riproponeva gli articoli e gli aspetti più discutibili, con ben pochi ritocchi. Inascoltate cassandre, avevamo fatto un presidio di un mese e mezzo presso la sede regionale (fino alle cinque del mattino dell’ultima notte, il 31 ottobre) chiedendo che fossero modificate le norme, che il Piano non fosse prorogato e, soprattutto, in caso di proroga, fosse almeno ridata al Comune di Roma (allora guidato dal Sindaco Ignazio Marino) la possibilità di escludere le demolizioni in molti quartieri storici che il Sindaco Alemanno e il suo Assessore Corsini nel gennaio 2013 avevano lasciato senza protezione.
Abbiamo ricevuto allora un no su tutta la linea e le conseguenze cominciano a vedersi oggi. Uno dopo l’altro piovono progetti, e presto potrebbe essere una grandinata. Le modifiche che chiedevamo, forse oggi sembreranno più comprensibili. La Legge regionale 21/2009 prevede che gli interventi edilizi di abbattimento e ricostruzione con aumento di cubatura, così come quelli di cambio di destinazione, non siano preventivamente sottoposti al parere dei Comuni; se rispondono ai requisiti fissati dalle legge e non confliggono con tutele specifiche, sono approvati in automatico, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati. Per esempio, nel caso di via Ticino, si può demolire l’edifico storico e ottenere, come premio per l’abbattimento, un ampliamento volumetrico del 35%. E’ quindi evidente che la lettera inviata alla Sindaca da Italia Nostra, la petizione lanciata da Liberi e uguali del II Municipio, così come altre lodevoli iniziative promosse da cittadini e associazioni, arrivano troppo tardi. Così come è inutile rivolgersi al Municipio, che ha ancora meno voce in capitolo del Comune.
L’unica cosa che si può chiedere – ma è una magra consolazione – è la pubblicazione di tutti gli interventi analoghi per cui sono state avanzate domande fino al 30 giugno 2017, almeno per sapere quante demolizioni e dove atterreranno. Il registro degli interventi è previsto dallo stesso Piano Casa, “istituito dai comuni al fine di monitorare l’incremento dei pesi insediativi nell’ambito del territorio comunale”, ed è trasmesso annualmente alla Regione. Nessuno finora ha provveduto e, almeno questo, potrebbe essere fatto rapidamente dalla giunta pentastellata, se non altro per coerenza con le posizioni sostenute nel 2014.
Non è questa la rigenerazione urbana di cui c’è bisogno. Gli interventi devono riguardare parti di città da riqualificare, non palazzi storici da gonfiare di cubature per mere ragioni di profitto. Devono portare nuova vivibilità e nuove funzioni sociali e, per questo, devono essere predisposti attraverso il confronto con la cittadinanza e, soprattutto, con il coinvolgimento attivo del Comune e del Municipio. Affidare alla proprietà privata tutte le decisioni su interventi che hanno forti ricadute sull’identità e sulla vivibilità dei quartieri è stato un gravissimo errore.
 arcipelagomilano.org n. 41, 12 dicembre 2017.Lo afferma un giurista:l’urbanistica è tecnica, ma prima è politica e dunque diritto. (m.c.g.) con postilla.
arcipelagomilano.org n. 41, 12 dicembre 2017.Lo afferma un giurista:l’urbanistica è tecnica, ma prima è politica e dunque diritto. (m.c.g.) con postilla.
In diritto hanno ragione i ricorrenti – Italia Nostra e gli altri, ciascuno per quanto gli interessa e tutti nell’interesse comune – a far annullare, perché illegittimo, lo sciagurato “Accordo di programma” che il Comune di Milano, la Regione Lombardia e il Gruppo F.S. hanno sottoscritto sulla “rigenerazione” urbana dei sette scali ferroviari che – venuta meno la loro destinazione al servizio ferroviario – sono tornati nel patrimonio pubblico dello Stato o, addirittura, del Comune di Milano.
Nell’accordo di programma ci sono protagonisti in più e protagonisti in meno di quello che sarebbe stato necessario e legittimo: in più ci sono certamente il fondo immobiliare Savills – un soggetto privato che non c’entra con il programma urbanistico oggetto dell’accordo, nel quale avrebbe potuto inserirsi dopo, ma come attuatore (e avrebbe dovuto inserirsi a seguito di pubblico concorso); in meno c’è la neocostituita Città Metropolitana di Milano, direttamente interessata, data la sua competenza concorrente con quella del Comune (e forse addirittura di essa sostitutiva), al governo del territorio insieme alla Regione.
Ma cosa c’entra il gruppo F.S., che invece è parte dell’accordo – e vi fa la parte del leone? Chi mai ha stabilito che sono sue (di sua privata proprietà) le aree dismesse del servizio ferroviario, e che solo a tale scopo, con tale specifica destinazione, le F.S. (allora Azienda dello Stato, ma oggi divenuta SpA “privata”) avevano in uso/concessione?
Ci sono due parole che servono a fissare le idee e a dimostrare che il c.d. “Accordo di programma” è un contratto senza base giuridica, che serve soltanto, in realtà, a privatizzare beni e funzioni pubbliche; e che esso è uno strumento di speculazione edilizia a favore di possenti Signori del mercato, ai quali, per ingenuità o per inesperienza, o per servilismo, i politici/rappresentanti del popolo, e i pubblici burocrati ai loro ordini, cedono le chiavi della Città, a loro delegando le funzioni di governo del territorio. Sono le parole “abdicazione” e “monopolio”.
Anche a prescindere da altre censure (pure pesanti) su sue particolari clausole, delle quali diciamo più avanti, l’Accordo si rivela radicalmente illegittimo se si considerano due effetti fondamentali che esso produce:
1) di abdicare, da parte del Comune/Città Metropolitana (e della Regione), alla loro funzione fondamentale di governo del territorio, e di abdicarvi a favore di un ente formalmente (e sostanzialmente) privato (che, quindi, provvederà a tale governo anzitutto nel suo proprio interesse);
2) di creare, in capo a tale ente (in sostanza, al Gruppo F.S.), una posizione di monopolista: invero, l’edificabilità in Comune di Milano, ora e per i prossimi 30 anni, sarebbe assorbita da quella correlata agli ex scali ferroviari: cosicché chi vorrà costruire dovrà acquisirne i diritti dal “concessionario” individuato dal c.d. Accordo di programma e da tale Accordo promosso a gestore/governatore del territorio e monopolista dei diritti edificatori nella Città di Milano. Per questo aspetto, l’Accordo merita una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Queste sono le anomalie fondamentali dell’Accordo censurato e impugnato. Alle quali vanno aggiunte – perché indiziarie di chi sia l’autore dell’Accordo, donde esso provenga (che esso, che non nasce da un dibattito trasparente e democratico, ha origine in privati colloqui in riservate stanze: ma quali?) e perché sintomatiche della sua non temperata propensione a favore di una parte – due clausole che nessun autorevole e accorto negoziatore della parte pubblica avrebbe accettato, se non “costretto”:
1. Quella che il cessionario, a fronte della proprietà delle aree, assume l’impegno di corrispondere al Comune 50 milioni di euro: allorquando stime attendibili valutano i ricavi dell’uso edilizio delle aree stesse in non meno di 600 milioni di euro;
2. Quella – di evidente importazione da culture giuridiche estranee alla nostra tradizione e al nostro ordinamento costituzionale – che stabilisce che l’impegno del cessionario di dare al Comune quei 50 milioni decade ove mai taluno osasse impugnare l’Accordo in sede giurisdizionale: clausola capestro vistosamente contraria al diritto di ricorso costituzionalmente garantito ai cittadini. Una clausola siffatta basta da sola a squalificare l’Accordo, inficiandone in radice la legittimità.
Ancora una volta è al diritto, e quindi alla Magistratura, che occorre far capo per frenare gli abusi di un’Amministrazione della cosa pubblica asservita dai politici (pseudo rappresentanti del popolo e che di tale “rappresentanza” abusano) ai loro interessi di casta, di tribù, di mercato – come li si voglia qualificare – anziché al bene comune.
postilla
L’articolo di un giurista, Scotti Camuzzi, pone in evidenza con chiarezza le gravi illegittimità procedurali dell’indecente Accordo di Programma sul riuso dei sette scali ferroviari milanesi. Su questo accordo si stanno accumulando molteplici ricorsi ed esposti da parte di associazioni, professionisti e cittadini: - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avanzato da Italia Nostra che ha denunciato la rinuncia del Comune a dirigere la riqualificazione delle aree, cedendo a Ferrovie dello Stato il timone dell’intera operazione, con l’esito che “questo operatore potrà trarre profitto dalla gigantesca speculazione immobiliare che metterà in pericolo la qualità della vita e il futuro della città”; - due ricorsi al TAR della Lombardia, recentemente depositati da parte di cittadini; - cinque esposti, presentati da soggetti interessati a vario titolo, all’Anac, al Garante della concorrenza, alla Commissione europea, alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica. L’articolo conferma altresì il danno erariale per la collettività che scaturirebbe da un accordo sleale quale è quello che si sta configurando: un ricavo netto di ben 600 milioni di euro, come ha cautelativamente calcolato Roberto Camagni, sui quali il Comune dovrebbe ricevere il 50%, sulla base della nuova legge sul contributo straordinario (art. 16 comma 4 del TU sull’Edilizia) e che il Comune sembra intenzionato a non esigere accontentandosi delle briciole (www.arcipelagomilano.org/archives/47304 ). Si annuncia una lunga battaglia in difesa dei beni comuni a rischio di privatizzazione con il consenso inaccettabile dell’amministrazione locale: una amministrazione, quella di Milano, che da lungo tempo ha rinunciato alle sue responsabilità in materia di governo pubblico del territorio. (m.c.g.)
 Come uno zombie riemerge dal passato - peggiorata - una vicenda che sembrava sepolta dalle buone intenzioni della sindaca Raggi. Ma il rullo compressore degli affari cementizi non si arresta mai.
Come uno zombie riemerge dal passato - peggiorata - una vicenda che sembrava sepolta dalle buone intenzioni della sindaca Raggi. Ma il rullo compressore degli affari cementizi non si arresta mai.
Nessuno ha più parlato del famigerato stadio della Roma, ci eravamo illusi che fosse su un binario morto, è invece prossimo all’approvazione. Come abbiamo scritto a suo tempo si tratta della più grossa operazione di urbanistica contrattata del nuovo millennio. La capitale non si smentisce, è sempre quella dell’Hilton e chiunque sia insediato al Campidoglio non sa resistere al richiamo degli interessi immobiliari. Il M5S, quando era all’opposizione, durante l’amministrazione Marino, si era tenacemente battuto contro, presentando addirittura una denuncia penale per fermare lo scempio. Adesso, con spregiudicata e sospetta inversione di marcia, ha dato l’assenso. Queste sono le credenziali di chi si accinge a governare l’Italia.
Il nuovo progetto dello stadio e degli annessi business park, centinaia di negozi e attività commerciali è all’esame della conferenza dei servizi decisoria convocata dalla regione Lazio che sta per dare il via libera. Rispetto al primo progetto, bocciato dalla conferenza dei servizi dell’anno scorso, la principale novità è la consistente riduzione delle previsioni relative alle attività direzionali e commerciali, un volume comunque superiore a quanto consentito dal piano regolatore. Ma alla riduzione della cubatura corrisponde un drastico ridimensionamento delle infrastrutture a servizio dello stadio e degli insediamenti connessi. Con la conseguenza che la viabilità di accesso è limitata alla sola via Ostiense-via del Mare senza una seconda uscita indispensabile in caso di emergenza.
A questo punto, in soccorso di James Pallotta (presidente della Roma e proponente) e di Paolo Parnasi (che costruirà lo stadio e il resto con l’impresa Eurnova), accorre il ministro Luca Lotti che suggerisce di realizzare a spese dell’erario un nuovo ponte sul Tevere (previsto nel primo progetto e cancellato a seguito della riduzione delle cubature) che risolverebbe i problemi dell’accessibilità e della sicurezza. Circa cento milioni, questo il costo del ponte, a esclusivo servizio di un insediamento privato, perché privati sono lo stadio, il business park, ecc. Il tutto, tra l’altro, in contrasto con le prescrizioni di legge che pongono a carico del proponente tutte le opere necessarie alla funzionalità degli interventi. Una soluzione che ci pare inaudita. E inquietante è l’assoluta latitanza della politica e dei mezzi d’informazione.
Politica e mezzi d’informazione sono stati assenti anche nei mesi scorsi quando il Mibact ha fermato il vincolo sulle tribune dell’ippodromo di Tor di Valle (costruito per le Olimpiadi del 1960) proposto dall’allora soprintendente Margherita Eichberg. Vincolo fermamente condiviso dai comitati di settore del Mibact per l’archeologia, per il paesaggio, per le belle arti, per l’arte e l’architettura contemporanea. Secondo Ugo Carughi, presidente di Docomomo Italia – associazione per la documentazione e la conservazione degli edifici e dei complessi urbani moderni –, le tribune sono state ottenute “attraverso l’accostamento aereo di pensiline, travi a mensola, pilastri sagomati, gradonate, vetrate […] composti in un miracoloso quanto precario equilibrio”.
Un ultimo appello perché non si compia una scelta urbanistica utile solo agli interessi immobiliari. Qui le pesanti critiche di due "opinionisti" di eddyburg: Insieme allo stadio si approvano 10 Hilton di Vezio De Lucia, e Uno stadiosalverà Roma, di Piero Bevilacqua. Molte altre pesanti critiche digitando "Stadio Roma sul "cerca"
La presentazione del progetto denominato (piuttosto pomposamente, per adesso) Human Technopole si è svolta, in fondo come suggerivano gli uffici stampa congiunti dei vari interessi coinvolti (segue)
La presentazione del progetto denominato (piuttosto pomposamente, per adesso) Human Technopole si è svolta, in fondo come suggerivano gli uffici stampa congiunti dei vari interessi coinvolti, ovvero puntando su un cocktail nazionalpopolare tra rendering di architettura e ariose metafore da centro studi di settore. E lo svarione del top manager di lungo corso leghista di nomina regionale, che ha reinterpretato l'ex Decumano Expo a verde chiamandolo con dizione comico-celodurista «il parco più lungo d'Europa», a suo modo conferma l'impressione. Impressione per nulla positiva se si esce da certi aspetti contingenti (come il sollievo generale per avere a quanto pare trovato uno sbocco al pasticcio finanziario con le aree combinato in epoca formigoniana) e si entra in considerazioni più ampie sulla cosiddetta idea di città che ne esce: soggetti, scenari, equilibri, e anche le forme, pur al netto delle importanti ma qui di secondo piano questioni architettoniche. Il fatto è che da lustri ormai si discetta qui e là del ruolo di punta delle economie della conoscenza nel delineare la città futura, e su cui si basano tante altre riflessioni su lavoro, ambiente, sostenibilità, e giù giù fino al ruolo dei trasporto o delle comunicazioni o della composizione funzionale.
Per capire che posto occupa questo costosissimo quartierino periferico ai confini autostradali tra Milano e hinterland metropolitano, nel dibattito sulla città futura in generale, forse val la pena di introdurlo in un processo più generale che potremmo tranquillamente chiamare «impresa e territorio», e che negli anni recenti si è arricchito dell'abbastanza noto scontro, più o meno dialettico, tra i fautori di una opzione urbana, e i sostenitori di modelli vari più meno legati all'antico decentramento produttivo, declinato in forme contemporanee. L'opzione urbana più nota e pubblicizzata da un individuabile filone tecnico e immobiliarista è quella delle nuove professioni creative, coi quartieri vivi su 24 ore 7 giorni la settimana, che confondono tempo di lavoro e tempo libero, dove tutti si aggirano a piedi in bicicletta coi mezzi pubblici o su veicoli elettrici, compulsandeo su qualche diavoleria elettronica il flusso di informazioni che si chiama «lavoro», e che naturalmente fornisce il reddito adeguato a viverci, in quei posti. Fatti di negozi esclusivi, gallerie d'arte, ambienti ibridi libreria-caffè-ufficio, e complessi residenziali più o meno densi costituiti da microappartamenti, simili più a uno studentato che a un condominio, perché tanta parte di quella vita post-adolescenziale si svolge negli «spazi pubblici» esterni. Inutile sottolineare come nella pratica questi quartieri o interi settori urbani siano diventati una variante della gated community, dove alle pareti fisiche si è sostituito uno zoning socioeconomico esclusivo, molto esclusivo.
 |
| La gerarchia spaziale capitale-lavoro a Crespi d'Adda (foto F. Bottini) |
Alle opzioni in qualche modo estreme corrisponde però una infinita serie di varianti possibili, dove si mescolano in equilibri diversi vari fattori, sia spaziali che sociali che di potere. Due esempi recenti e significativi riassumono molto bene due percorsi opposti ma in qualche modo convergenti. Il primo è il quartier generale che Amazon vuol collocare nella città che si mostrerà più accogliente, per approfittare delle economie esterne garantite dall'ambiente urbano in termini di mercato del lavoro prossimità e stimoli. Il rovescio della medaglia di questa scelta di insediamento centrale sta nel mantenimento del formato accentrato, che si traduce in un trasloco di fatto del grande campus suburbano autosufficiente dentro un ambiente centrale che si classifica in qualche modo di rango inferiore, e ovviamente senza alcuna contaminazione funzionale. Il percorso opposto è quello scelto dalla Microsoft per il proprio centro direzionale nell'area metropolitana di Seattle, dove nello stile della densificazione suburbana promossa da certa scuola New Urbanism, si cerca invece di introdurre pedonalità, multifunzionalità, pratiche sostenibili e modalità di lavoro più elastiche, in pratica tendenzialmente rendere più simile il campus di impresa a un normale quartiere dove si è insediata anche l'impresa.
Possiamo dire che la strategia insediativa dello Human Technopole in qualche modo appartiene di diritto a questa «terza via», del percorso misto, quanto a metodo (indipendentemente quindi da alcune osservazioni che si possono fare sul rapporto con la città e specie con le forme urbane italiane correnti). C'è una collocazione decentrata ma non troppo verso cui confluiscono funzioni di varia provenienza a costituire una massa critica di parco scientifico, a cui si aggiungeranno presto anche altre funzioni residenziali e di servizio, a discutibile ma effettivo riuso di un'area periferica ma fortemente integrata al tessuto urbano e metropolitano. Entra qui, proprio pensando alla dimensione metropolitana spesso evocata dagli stessi proponenti, il dubbio sull'inserimento organico o no, nell'equazione, delle dismissioni di altri spazi per le funzioni trasferite, e in particolare per dimensioni rilevanza e prossimità quella dell'Università Statale dal suo quartiere attuale a Città Studi, nel cuore di Milano. Sostanzialmente due le possibilità: la prima è che analogamente a una dismissione sul modello industriale, anche l'università in questo caso si faccia tentare dall'approccio puramente immobiliare-finanziario (e che in sede di contrattazioni varie nessuno possa correggere questa tendenza); la seconda è che il ruolo delle economie della conoscenza fisiologicamente orientate a interazioni di tipo urbano «alla Richard Florida» per usare una definizione schematica, riesca a cogliere i vantaggi di un approccio effettivamente a scala di regione urbana, facendo dialogare i due poli e cercando integrazione. Forse non si arriverà a cittadelle ideali del capitalismo più o meno illuminato del terzo millennio, ma si darà un segnale culturale importante.
Qualche considerazione in più su La Città Conquistatrice e un link alla descrizione puntuale del progetto Microsoft dal Seattle Times; specificamente su alcuni aspetti dell'operazione milanese il blog del lunedì sul quotidiano online Today
la Nuova Venezia, 23 novembre 2017. «Lo studio dell'Ispra presentato all'università Iuav: “Il Veneto risulta una delle regioni con maggiore consumo di suolo.(m.p.r.) riferimenti in calce
«La Regione non può più fare finta di nulla». È questo quanto emerso ieri alla presentazione del Report sul consumo del suolo 2017, presentato all'Università Iuav e disponibile sul sito dell'Ispra. Dai dati emersi, nel 2016 si è consumato tre volte più suolo nel Comune di Venezia (45,1%) di quanto invece sia avvenuto in provincia (17%). Il suolo viene cementificato a scapito dei terreni agricoli: si aumenta così il rischio di alluvioni o allagamenti, causati dalla riduzione della ritenzione idrica del terreno. Tra i numeri che vengono snocciolati città per città, colpisce quello del Comune di Venezia che, da novembre 2015 a luglio 2016, ha consumato ben 71 chilometri quadrati di suolo. In pratica il 45,1% del suolo è stato edificato, ma se si pensa che una buona parte del territorio comprende la città storica, il dato deve fare riflettere perché riguarda la terraferma.
Oltre 300 Comuni in Italia presentano un consumo di suolo inferiore al 15%; 23 invece hanno una percentuale di suolo consumato superiore al 30%. Padova è al primo posto (49,2%), seguono Venezia (45,1%), Treviso (39,7%) e Vicenza (31,8%). Per capire il rapporto con le altre città: i maggiori valori di superficie consumata si riscontrano a Roma (31.564 ettari), con una crescita di ulteriori 54 ettari nei primi sei mesi del 2016 (+0,17% rispetto al 2015) e in molti comuni capoluoghi di provincia: Milano (10.424 ettari), Torino (8.548), Napoli (7.408), Venezia (7.126, 47 ettari cioè +0,8% rispetto al 2015), Ravenna (7.088).
«Il Veneto risulta una delle regioni con maggiore consumo di suolo» spiega la docente di Pianificazione del Territorio Anna Marson «Una quantità solo in parte attribuibile all'autostrada Pedemontana in corso di costruzione perché, ad esempio, la provincia che registra i valori più elevati è Padova. Questo consumo ci toglie sempre di più terreni agricoli, proprio quelli di maggiore qualità». Dal 2012 al 2016 sono stati consumati nel Veneto circa 1.950 ettari, pari all'1,1% del territorio regionale.
Nell'ultimo periodo analizzato (da novembre 2015 a luglio 2016) il suolo consumato è stato pari a 557 ettari. Sempre in questo periodo, tra le province venete, Venezia ha consumato 36 mila ettari di sola pianura, mentre nelle altre città la pianura è stata solo in parte toccata. In pratica in provincia si è edificato per il 14,79%, meno che a livello comunale. Al 2016 la provincia di Treviso registra una percentuale di suolo consumato del 16,83%, Venezia del 17%, Vicenza del 13,13% e Padova del 19%, per rispettivamente 471 mq/abitante di suolo pro capite consumato nel caso della provincia di Treviso, 421 mq/abitante di Venezia, 412 mq/abitante di Vicenza ed infine 435 mq/abitante nel caso di Padova. Valori stabili rispetto al 2015 nel caso di Padova, in leggero aumento nel caso di Treviso e Vicenza, maggiori nel caso di Venezia.
eddyburg è stato promotore di iniziative e leggi per fermare il consumo di suolo. Al tema è dedicato un'intera sezione, che si può percorrere agevolmente attraverso la visita guidata Consumare stanca.
Sul finto stop al consumo di suolo della nuova legge regionale del Veneto si veda di Monica Zicchiero Stop al consumo del suolo, c’è la legge «Voto storico». «No, troppe deroghe» e di Chiara Mazzoleni Consumo di suolo e dissesto territoriale. Istruzioni per come attuarli.
 Internazionale, 13 novembre 2017. Inaugurata a Bologna la "Disneyland del cibo": grazie all''alleanza fra pubblico e privato in cui, come eddyburg ha rupetutamente denunciato, il privato si arricchisce con i soldi del pubblico, ossia del contribuente, ossia di noi creduloni (m.c.g.) con riferimenti in calce
Internazionale, 13 novembre 2017. Inaugurata a Bologna la "Disneyland del cibo": grazie all''alleanza fra pubblico e privato in cui, come eddyburg ha rupetutamente denunciato, il privato si arricchisce con i soldi del pubblico, ossia del contribuente, ossia di noi creduloni (m.c.g.) con riferimenti in calce
L’olandese Randstad è una delle principali agenzie al mondo di lavoro interinale. È finita nel mirino delle proteste studentesche del 13 ottobre 2017 per un progetto intitolato “Un giorno da Fico”. I ragazzi contestavano una delle novità più importanti della legge del governo Renzi sulla Buona scuola: il principio dell’alternanza scuola-lavoro, che prevede l’obbligo per gli studenti dell’ultimo triennio delle superiori di fare un’esperienza formativa - tra le 200 e le 400 ore a seconda che si tratti di un istituto tecnico o di un liceo - in un’azienda, un’istituzione, un’associazione sportiva o di volontariato, perfino in un ordine professionale.
Nell’elenco c’è pure Fico Eataly World, la Fabbrica italiana contadina di Oscar Farinetti - una società partecipata da Eataly World, Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno - che aprirà il 15 novembre. La Randstad è finita sul banco degli imputati perché accusata di reclutarle manodopera gratuita.
Per capirne di più chiedo ai diretti interessati. Negli uffici dell’ex Mercato ortofrutticolo alla periferia di Bologna, negano accuse e sospetti. Spiegano che il progetto è della Randstad, si svolgerà nelle scuole e alla fine da loro arriverà solo un pugno di ragazzi, “non più di sette o otto”, e comunque “non verranno a fare i lavapiatti”.
A Bologna tutti i poteri cittadini, istituzionali e privati, sono in qualche misura coinvolti
L’amministratrice delegata Tiziana Primori dice che c’è un protocollo “sulla tutela dell’occupazione, la qualità del lavoro e la valorizzazione delle relazioni sindacali” firmato con i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil e il comune di Bologna, per “favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, l’agibilità sindacale, il diritto d’assemblea e la trasparenza della filiera delle aziende presenti nel parco”. Fico, spiega, darà lavoro stabile a settecento persone, mentre altre tremila lavoreranno nell’indotto.
Ne parlo con Marta Fana, ricercatrice all’università Sciences Po di Parigi, autrice di Non è lavoro, è sfruttamento. “Bisognerà vedere quante saranno le assunzioni stabili e quanti i contratti di somministrazione, dunque precari”, dice. Fana contesta a Farinetti la “gestione politica” della nascita di Fico: “Perché la regione ha speso 400mila euro per la formazione di persone per le quali non c’è la certezza di assunzione?”. A suo parere, le istituzioni locali, guidate dal Partito democratico, non avrebbero dovuto mettersi al servizio di quello che definisce solo “l’ennesimo centro commerciale”.
Dalla Randstad rendono noti i contenuti dell’accordo con la nuova impresa di Farinetti: i dipendenti della multinazionale olandese gireranno le scuole di tutta Italia per “illustrare ai ragazzi i nuovi trend del mercato del lavoro, guidarli in un tour virtuale di Fico Eataly World e lanciare un project work” sul tema dell’innovazione nella filiera agroalimentare. Il progetto coinvolgerà 20mila studenti, appunto, e prevede 300mila ore di alternanza scuola-lavoro, ma a Fico i ragazzi ci passeranno appena una giornata, per assistere a un convegno sul tema della “Food innovation”, al termine del quale saranno premiate le scuole vincitrici.
Istituzioni, università, entusiasti
I visitatori, dice, potranno seguire l’intera filiera del prodotto. Prima di sedersi a tavola per mangiare un piatto di pasta, per esempio, saranno condotti da un “ambasciatore del gusto” a vedere un campo di grano, la macinazione in uno dei due mulini a pietra e la nascita di una tagliatella di Campofilone in uno dei tre pastifici. A supervisionare il tutto saranno le facoltà di veterinaria e agraria dell’università di Bologna.
Fico sarà un esempio dell’Italia che riparte? O è un modo furbo per capitalizzare la tendenza a mangiar bene, pulito e sano?
A Bologna tutti i poteri cittadini, istituzionali e privati, sono in qualche misura coinvolti. Il comune ci ha messo la struttura, che varrebbe 55 milioni di euro. Per la ristrutturazione sono stati raccolti 75 milioni di euro di fondi privati: 15 milioni sono arrivati dal sistema cooperativo, dieci da imprenditori locali e altri 50 da casse previdenziali professionali. Al progetto partecipano centocinquanta imprenditori grandi e piccoli (da piccoli artigiani a grandi consorzi come quello del Parmigiano reggiano), i ministeri dell’ambiente e dell’agricoltura, l’associazione dei borghi più belli d’Italia e l’Ente nazionale italiano per il turismo (Enit), Slow food, le università di Bologna e quella di Napoli, la Suor Orsola Benincasa .
Nelle ambizioni dei fondatori, la “Disneyland del cibo”, com’è stata soprannominata, dovrebbe attirare quattro milioni di visitatori il primo anno e arrivare a sei milioni nel giro di tre. Il sindaco Virginio Merola è così entusiasta che è andato a Manhattan per presentarla alla stampa americana sulla terrazza del Flatiron building, il grattacielo all’incrocio tra Broadway e la Fifth avenue che oggi ospita Eataly New York. Per portare i turisti che immagina diretti a frotte verso la periferia bolognese, ha annunciato un servizio di bus elettrici.
Dentro il parco
 Mi portano a visitare la struttura: centomila metri quadrati, di cui 80mila coperti, percorribile a piedi o su piste ciclabili con l’immancabile carrello della spesa. Ci sono due ettari di campi e stalle con più di duecento animali, dal maiale calabrese alla pecora di Altamura, e duemila cultivar. Solo un piccolo agrumeto è coperto, per ragioni climatiche. All’interno, 40 fabbriche contadine producono carni, pesce, pasta, formaggi e dolci. C’è anche una torrefazione del caffè. A ricordare che siamo a Bologna ci pensano una fabbrica di Grana Padano e un intero padiglione dedicato alla mortadella. Al centro ci sono un auditorium, un teatro e un cinema che sarà gestito dalla Cineteca di Bologna.
Mi portano a visitare la struttura: centomila metri quadrati, di cui 80mila coperti, percorribile a piedi o su piste ciclabili con l’immancabile carrello della spesa. Ci sono due ettari di campi e stalle con più di duecento animali, dal maiale calabrese alla pecora di Altamura, e duemila cultivar. Solo un piccolo agrumeto è coperto, per ragioni climatiche. All’interno, 40 fabbriche contadine producono carni, pesce, pasta, formaggi e dolci. C’è anche una torrefazione del caffè. A ricordare che siamo a Bologna ci pensano una fabbrica di Grana Padano e un intero padiglione dedicato alla mortadella. Al centro ci sono un auditorium, un teatro e un cinema che sarà gestito dalla Cineteca di Bologna.
Qui, fino all’altro ieri, sorgeva il Centro agroalimentare di Bologna (Caab), nato negli anni novanta ma progettato nei settanta. Il presidente era Andrea Segré, ex professore di politica agraria all’università di Bologna e ideatore del Last minute market, un mercato nato per recuperare e riciclare i prodotti invenduti. A quattro mesi dalla nomina, capito che il Caab languiva e non avrebbe avuto futuro, Segré aveva contattato Farinetti “per sviluppare l’idea del parco agroalimentare che da anni mi frullava nella testa”.
Era il novembre del 2012 e, ora che tutto si è realizzato, sarà lui a presiedere la fondazione Fico, che dovrà promuovere programmi di “cultura della sostenibilità economica, sociale, ambientale ed alimentare”. Il comitato scientifico, presieduto dall’europarlamentare Paolo De Castro, ex ministro delle politiche agricole nei governi D’Alema e Prodi, ha già messo in cantiere le prime iniziative: una giornata sulla dieta mediterranea e la creazione di un frutteto della biodiversità.
L’architetto ferrarese Thomas Bartoli ha rimesso a nuovo la struttura, salvando pure un pezzo del vecchio mercato, che non chiuderà del tutto. Bartoli è un fedelissimo del fondatore di Eataly. Mi spiega di aver mantenuto la vecchia architettura industriale, ma con l’obiettivo di creare una “sensazione contadina”, creando un continuum tra l’interno e i campi, e che il suo progetto è a “cemento zero”, anzi ha recuperato due ettari “per aumentare la superficie verde”. Ma, si schernisce, “l’idea di Fico è talmente forte che la realizzazione architettonica è passata in secondo piano”.
Una Disneyland del cibo
 Tutto bene, dunque? Fico sarà un esempio dell’Italia che riparte da cibo e turismo, cioè due dei suoi punti di forza? O, come sostengono i critici, è solo un modo furbo per capitalizzare la tendenza a mangiar bene, pulito e sano, come sostiene un fortunato slogan coniato dal fondatore di Slow food, Carlo Petrini?
Tutto bene, dunque? Fico sarà un esempio dell’Italia che riparte da cibo e turismo, cioè due dei suoi punti di forza? O, come sostengono i critici, è solo un modo furbo per capitalizzare la tendenza a mangiar bene, pulito e sano, come sostiene un fortunato slogan coniato dal fondatore di Slow food, Carlo Petrini?
In un libro intitolato La danza delle mozzarelle, lo scrittore Wolf Bukowski prende di mira il modello di narrazione del cibo che parte da Slow food, e prima ancora dal Gambero rosso, per finire a Coop, a Eataly e alla sua ultima evoluzione: la Fabbrica contadina di Bologna, appunto. “Fico non è solo un parco giochi per rudi cooperatori e costruttori edili, ma è proprio una Disneyland, un mondo dove fantasia e realtà del capitale si rispecchiano reciprocamente”, scrive Bukowski, che attacca frontalmente l’ideologia di Renzi e Farinetti, improntata al marketing e all’ottimismo, in politica come al supermercato, in cui il conflitto è visto come qualcosa di anormale.
Bukowski vede in Fico la saldatura tra il pensiero di Farinetti e il capitalismo emiliano di derivazione postcomunista: una sorta di socialdemocrazia economica in una regione dove il pubblico governa e le cooperative rosse prosperano. Definisce Bologna “la città coop”, portando come esempio il fatto che nel giro di poche centinaia di metri, in pieno centro cittadino, sono nati negli ultimi anni il Mercato di mezzo, che è stato voluto dall’amministratrice delegata di Fico, Primori, e può essere considerato un prototipo del Parco, e una libreria Coop con annesso punto vendita Eataly. Tutto attorno, una teoria di super e ipermercati Coop.
I due alleati
Da quando quelli con il marchio Slow food sono finiti sugli scaffali di Eataly, la loro diffusione è decuplicata. La richiesta di collaborazione è arrivata pure per Fico, e dall’associazione di Petrini hanno risposto sì, pur mantenendo uno sguardo critico.
Ne parlo con Carlo Petrini, l’uomo incoronato da Time tra gli “eroi del nostro tempo”, in quanto guru di una filosofia e di un movimento nel frattempo divenuti globali. A suo avviso il problema, a questo punto, è di “governare il limite”. Spiega che qualsiasi produzione, se supera una certa soglia, diventa “invasiva”, pur se buona, pulita e giusta. Il fondatore di Slow food ritiene invece che si debba evitare il “rivendicazionismo sui prezzi”, altra critica frequente. A suo parere va bene che un alimento di qualità costi di più se tutti sono pagati meglio, dal contadino al trasportatore.
Farinetti concorda su quest’ultimo punto. Spiega che “il 15 per cento di quello che vendiamo lo produciamo noi, il resto arriva da piccoli, medi e grandi produttori”, selezionati da un gruppo di giovani provenienti dall’università di Pollenzo e spediti in giro per l’Italia. Accorciando la filiera, dice, “riusciamo a pagare la carne il 31 per cento in più e a venderla a un prezzo decente”.
Sulla questione della produzione ritiene invece che ci siano margini ulteriori di crescita. “In Italia ci sono 14 milioni di ettari di terreni coltivati, negli anni ottanta erano 19, anche se oggi si produce di più”, dice. Vuol dire che l’agricoltura di qualità (convenzionale a residuo zero, biologica, biodinamica, simbiotica) può svilupparsi ancora molto e puntare al mercato italiano (tuttora gastronomicamente poco educato a dispetto delle apparenze) e soprattutto a quello estero.
È su quest’ultimo punto che il patròn di Eataly ha trovato l’intesa con Coop Alleanza 3.0. Sebastiano Sardo, che ha selezionato i produttori del neonato Parco agroalimentare, dice che l’obiettivo è “creare una piattaforma dei prodotti italiani da esportare” per contrastare i cosiddetti italian sounding, il mercato dei prodotti venduti come italiani ma che non lo sono. Secondo i dati dell’Assocamerestero, l’associazione che raggruppa le 78 camere di commercio italiane all’estero, l’italian sounding ha un giro d’affari di 54 miliardi di euro, mentre l’ industria alimentare italiana si aggira sui 132.
L’accusa di monopolio
Gli anelli istituzionali di congiunzione sarebbero il sindaco di Bologna Virginio Merola, già nel mirino per gli sgomberi di spazi occupati e centri sociali, e il ministro del lavoro Giuliano Poletti, ex presidente di Legacoop e ideatore insieme al governo di Matteo Renzi del Jobs act. Questo contribuisce a spiegare le proteste studentesche e lo scetticismo di un pezzo di sinistra radicale.
Al fondatore di Eataly si imputa di essere diventato il “braccio imprenditoriale di Slow food” e non gli si perdona l’infatuazione per Matteo Renzi, culminata nella partecipazione alle manifestazioni organizzate dal segretario del Pd all’ex stazione ferroviaria fiorentina della Leopolda.
La prima volta è stata nel 2012, quando ha detto che “la politica è come la maionese impazzita e Renzi vuole rifarla da zero”. Nel 2013 l’allora sindaco di Firenze ha tagliato il nastro di Eataly Firenze e nel 2014 l’ha accolto come “l’amico Oscar”. Lui ha ricambiato dimostrando sintonia con lo spirito della Leopolda. “Questo è un posto dove ci si lamenta poco, mentre ciascuno esprime con sintesi le proprie idee di soluzione”, ha dichiarato a La Stampa.
Un anno fa, alla vigilia del referendum costituzionale del 4 dicembre che è costato le dimissioni a Renzi, fiutando il clima sfavorevole ha affermato: “Dobbiamo tornare a essere simpatici”. Un anno dopo, appare più disincantato ma non ha cambiato opinione. “Renzi è stato tradito dal suo carattere, però è onesto”, dice. Nel frattempo, a inaugurare Fico è stato invitato il più mite Paolo Gentiloni.
riferimenti
su eddyburg seguiamo da tempo le imprese di Oscar Farinetti, abile imprenditore, che all’insegna della modernità e della “cultura”, contribuisce al saccheggio dei beni comuni anche con il supporto della pianificazione urbanistica. A questo proposito si veda Fico, la Disneyland del cibo pronta al debutto di Mara Monti, Un tram chiamato Farinetti.“Gli fanno una linea ad hoc” di Ferruccio Sansa, Qui si mangia di Carlo Tecce. Sul fronte della cultura si veda di Tomaso Montanari Carta e bellezza non fanno rima, Santa Lucia Farinetti, incinta tra le mortadelle, Milano e Firenze, chiese a uso privato (m.p.r.)
il Fatto Quotidiano, 21 novembre 2017. «"Cosa possiamo fare se un luogo che amiamo non sa più prendersi cura di sé?" Cosa dovremmo fare, se questo luogo si chiama Italia?». (p.d.)
A lui risale, con la passiva complicità di Sandro Bondi, il dimezzamento del bilancio dei Beni culturali, le cui conseguenze ancora si sentono; a lui, con l’attiva complicità di Mariastella Gelmini, gli irresponsabili tagli ai bilanci di università e ricerca che costringono all’esilio migliaia di giovani ricercatori, accolti a braccia aperte in tutto il mondo, e a nostre spese (la formazione l’abbiamo pagata noi). E il degrado dei patrii costumi non si arresta: forse per mostrare che con la cultura si mangia, a Montepulciano il famoso paramento murario di palazzo Bucelli, che schiera in facciata decine di urne etrusche come biglietto da visita di un collezionista settecentesco, serve ormai ad appenderci salami e prosciutti. La foto, scrive l’egittologo Francesco Tiradritti, parla più di mille parole. Segnala una gerarchia, prima gli affari e poi gli etruschi; e mette in soffitta la storia sotto una coltre d’insaccati. Col permesso o col silenzio, s’immagina, delle “autorità preposte”. E sì che gli Statuti di Montepulciano del 1337 stabilirono chiaramente “che siano conservate e mantenute in buono stato tutte le strade pubbliche, e non sia permesso ad alcuno di occuparle abusivamente”, punendo severamente chiunque vi faccia per proprio vantaggio qualcosa d’improprio. I contravventori, proseguono gli Statuti (art. VI, 194) dovranno essere obbligati dal sindaco a riparare ogni danno.
la Repubblica on line, 17 novembre 2017. L'agenzia europea per l'ambiente ha messo a punto una mappa interattiva che riporta i valori della qualità dell'aria. L'Italia non solo non fa nulla per ridurre l'inquinamento, ma non comunica neppure i risultati delle rilevazioni. (p.s.)
 Gli inquinanti dell'aria sono infidi e di solito invisibili, ma ora possono essere visualizzati in tempo reale su una mappa europea. L'ha messa a punto l'Agenzia per l'Ambiente (AEA), che l'ha presentata in occasione del "Clean Air Forum" della Commissione europea che si è aperto ieri a Parigi. La mappa "Air Quality Index" raccoglie i dati di oltre 2mila centraline, ogni tre ore si aggiorna e misura i diversi inquinanti che danneggiano salute e ambiente: le micropolveri PM10 e PM2.5, Ozono, diossido di zolfo (SO2) e diossido di azoto (NO2). Che vengono tradotti in pallini colorati dal verde al rosso, rilevando il valore peggiore per ogni inquinante, in un sistema interattivo che permette ai cittadini di zoomare e conoscere la situazione anche nei dintorni di casa propria. Grande assente, ed è una mancanza che salta agli occhi, l'Italia, costellata di pallini grigi, ovvero spenti: le nostre centraline ancora non risultano, come quelle di Romania, Bulgaria e Grecia.
Gli inquinanti dell'aria sono infidi e di solito invisibili, ma ora possono essere visualizzati in tempo reale su una mappa europea. L'ha messa a punto l'Agenzia per l'Ambiente (AEA), che l'ha presentata in occasione del "Clean Air Forum" della Commissione europea che si è aperto ieri a Parigi. La mappa "Air Quality Index" raccoglie i dati di oltre 2mila centraline, ogni tre ore si aggiorna e misura i diversi inquinanti che danneggiano salute e ambiente: le micropolveri PM10 e PM2.5, Ozono, diossido di zolfo (SO2) e diossido di azoto (NO2). Che vengono tradotti in pallini colorati dal verde al rosso, rilevando il valore peggiore per ogni inquinante, in un sistema interattivo che permette ai cittadini di zoomare e conoscere la situazione anche nei dintorni di casa propria. Grande assente, ed è una mancanza che salta agli occhi, l'Italia, costellata di pallini grigi, ovvero spenti: le nostre centraline ancora non risultano, come quelle di Romania, Bulgaria e Grecia.
La città invisibile, 14 novembre 2017. Non c'è da meravigliarsi delle cortesie dell Unesco vero le malfatte fiorentino (come con quelle veneziane). È noto che l'Italia è tra i maggiori contribuente dell'agenzia Onu per la cultura
Camera con vista”, il titolo del romanzo di Edward Morgan Forster, è anche la metafora del viaggiatore inglese che nell’Ottocento, a Firenze o, meglio ancora, a Fiesole, viveva una vacanza più o meno lunga, lontano dalle bruttezze della rivoluzione industriale. “Camera con vista” perché l’élite anglosassone preferiva contemplare il paese da lontano, fantasticando di Beato Angelico e Benozzo Gozzoli, godendo delle nebbioline che celavano dall’alto la vita reale, ma non amava scendere in strada e mescolarsi alla gente comune. Questo comportamento deve avere ispirato la missione Unesco-Icomos a Firenze del 25-27 maggio 2017, di cui ora conosciamo il Rapporto, ben lontano dalle preoccupazioni espresse in una lettera dell’agosto del 2015 indirizzata al Comune di Firenze, per mesi tenuta nascosta dal Sindaco Nardella.
Del resto i “riconoscimenti” (aknowledgements) già spiegano tutto: “L’amministrazione fiorentina è stata estremamente generosa con expertise, tempo e ospitalità. Il Sindaco Dario Nardella, sia formalmente che informalmente, ha prestato un grande interesse al nostro lavoro… Siamo grati a tutti per avere contribuito al successo della missione e per avere reso così piacevole la nostra permanenza”. E ci immaginiamo i nostri due viaggiatori, bon vivant, alloggiati in alberghi di lusso, magari con vista sull’Arno, gratificati dalla buona tavola e dal buon vino, immersi in colloqui, sopralluoghi, visite e passeggiate, perché no, nel centro storico ancorché affollato di turisti, abbacinati dal bello e dalla storia, tardi epigoni dei loro antesignani ottocenteschi. Informati – ci immaginiamo – direttamente o indirettamente anche da molti dei sostenitori delle infrastrutture inutili o dannose, aeroporto e tunnel della Tav in primis. Dei molti comitati attivi a Firenze, solo pochi quelli invitati con due ore contingentate, memorie scritte in inglese e qualche sommario appunto.
Ma veniamo al Rapporto Unesco-Icomos sulle principali questioni fiorentine.
Sull’aeroporto la missione apprezza la riduzione dell’impatto sulle ville medicee, e prende per buono il racconto che solo una frazione marginale dei voli passerà sopra il centro di Firenze. Su tutto il resto tace con un livello di approfondimento degno di un depliant di Toscana Aeroporti. Troppo impegnativo, evidentemente, leggere il parere del nucleo di valutazione della Regione Toscana, le osservazioni dell’Università di Firenze, le 142 prescrizioni della Via non ancora ufficializzate ma tuttavia ben note. Quello che interessa è la property, cioè l’area direttamente tutelata, il resto può andare alla malora.
Ancora più sbrigativo il giudizio sul sottoattraversamento dei treni ad alta velocità che, secondo il rapporto, provocherà solo qualche millimetro di subsidenza e paradossale la conclusione che avalla la serietà tecnica del progetto. Ignora la missione, anche se su questo era stato presentato dal comitato no Tav una memoria scritta, che le prescrizioni della Via, mirate a un approfondimento degli studi ambientali e geologici, sono state rimandate al progetto esecutivo (peraltro difforme da quello originale), vale a dire ignorate con il beneplacito di un osservatorio cieco; e che la maxi stazione sotterranea, diventata nel frattempo mini, è in entrambe le versioni priva di valutazione ambientale. La conclusione che “the proposals have been subject to intensive expert scrutiny by the authorities” appare, perciò, più che superficiale, mistificatoria. Sulla stessa lunghezza d’onda l’apprezzamento della politica che sta svendendo, o facilitando la svendita, di edifici pubblici nel centro storico di Firenze per trasformarli in alberghi o residenze di lusso; politica che, invece, secondo il rapporto assicura la permanenza dei valori culturali e della loro fruizione pubblica.
Un contentino per compensare i giudizi encomiastici: la raccomandazione di non sottoattraversare con una nuova linea della tramvia il centro di Firenze e di ripensare l’idea di un parcheggio sotterraneo in piazza Brunelleschi, a due passi del Duomo. Due progetti demenziali su cui perfino i nostri missionari hanno qualcosa da ridire. Tralasciamo per brevità le altre considerazioni e raccomandazioni che ognuno può leggere sul rapporto on line. Annotiamo solo che vi sono delle blande preoccupazioni per l’eccessiva concentrazione di turisti nel centro storico e per la possibilità che il nuovo aeroporto, con i voli low cost, incrementi il turismo modi e fuggi. Per il resto tutto va bene. Naturalmente il Sindaco Nardella e i corifei della stampa locale hanno lanciato grida di giubilo, con il primo cittadino che ha straparlato di via libera all’aeroporto di Firenze – da chiedersi se avrebbe tenuto in altrettanta considerazione un parere negativo.
Scriveva nel 1855 Cosimo Ridolfi, rivolgendosi agli stranieri che descrivevano la campagna toscana come un grande giardino, che per conoscere tutta la vera Toscana arretrata, arida, scoscesa, moralmente disabitata, bisognava, prendere non le strade maestre della pianura o della dolce collina; e aggiungeva “ed allucinati dal nostro bello, anche gli ingegni più severi si fecero artisti e videro qui l’Eldorado, perché scrutarono la gentilezza dei modi, ammirarono la vaghezza dei siti e lodarono senza chiedere conti a nessuno… perché chi traversa i paesi in posta e scrive le sue osservazioni, non fa, in genere, che dei romanzi”. Come gli epigoni dell’Unesco.
Dario Franceschini è un ministro che ama molto gli annunci. Anche se la materia prima degli annunci non è molto consistente. Di recente ha convocato una Conferenza sul paesaggio anche se i piani paesaggistici co-pianificati, prima sotto Renzi e poi sotto Gentiloni, si riducono alla miseria di 3 appena su 20 e la Giunta di centrosinistra della Sardegna sta cercando di smantellare gli eccellenti piani salvacoste della Giunta Soru (pure di centrosinistra) coordinati da Edoardo Salzano nel 2004, attaccando pure frontalmente l’ottimo soprintendente sardo che si oppone a quel disastro. Sulla legge detta “sfasciaparchi” in discussione al Senato e che indebolisce palesemente i Parchi Nazionali non ha trovato mai il modo di emettere un accenno di critica e di difesa della valida legge-quadro Cederna-Ceruti del 1991 con la quale sono stati creati ben 19 Parchi Nazionali oggi semiabbandonati a se stessi quando non frammentati.
la Nuova Venezia, 3-4 novembre 2017. Sindaco, categorie, Città metropolitana e Regione tutti d'accordo per il nuovo mega progetto dell'archistar Zaha Hadid che porterà in Veneto un nuovo centro commerciale, altre strade e tanti turisti. Ma è di questo che si ha bisogno in una regione che ha un folle consumo di suolo e turisti da record? (m.p.r.)
Jesolo«Jesolo Magica dovrà essere un centro multiservizio non solo per gli jesolani, ma per tutti i turisti del litorale e soprattutto da Venezia». Il presidente dell'Aja, associazione jesolana albergatori, Alessandro Rizzante, lancia la carica degli operatori del turismo in vista delle futura apertura di uno dei centri commerciali, se così riduttivamente può essere descritto, più grandi e avveniristici in Europa. Un "monumento" di architettura moderna che sarà soprattutto accattivante e attirerà tanti visitatori all'interno di un circuito turistico più ampio che si unirà alle bellezze naturali, l'arte, la storia, l'intrattenimento. La paura iniziale dell'impatto sulla città e le attività commerciali sta lentamente svanendo tra le categorie di Jesolo che a puntate stanno apprendendo le prossime tappe della presentazione secondo i canali ufficiali. Dopo tanto silenzio, quasi il mistero che avvolgeva il progetto, ora si parla finalmente di date, investimenti, proiezioni. «Io credo che riflettendo sul futuro di un simile centro», aggiunge Rizzante, «Jesolo dovrà avere una viabilità e collegamenti moderni per portare qui tanti visitatori. E mi riferisco in particolare a una linea nautica per e da Venezia. Non possiamo più farne a meno dopo che il sindaco e presidente della Città Metropolitana Brugnaro ce l'ha presentata in estate. Jesolo sta crescendo di continuo nella qualità dei servizi e del commercio oltre che dell'ospitalità e accoglienza. Ormai dobbiamo ragionare sui grandi numeri del turismo, i circuiti internazionali e tutto l'anno. Ecco perché parlo di linea nautica, perché Jesolo Magica dovrà catalizzare grandi flussi, in primis da Venezia».
la Nuova Venezia, 3 novembre 2017
INVESTIMENTO DA 450 MILIONI
la Nuova Venezia, 4 novembre 2017
«JESOLO MAGICA, SI AL MEGA CENTRO
«Sardegna - Il milionario del Qatar ha comprato mezza Costa Smeralda e spinge per costruire. Intanto rimanda il via all’ospedale»
Prima la bandiera granata a nove punte ha sventolato sugli hotel dorati di Porto Cervo, poi sul grande ospedale che fu di don Verzé, infine sulla compagnia aerea Meridiana. Quando lo sbarco nell’isola ha passaporto qatariota è tutto un inginocchiarsi. Defunta la Sir di Rovelli e circoscritta la Saras dei Moratti nell’area di Cagliari, l’emirato è oggi la presenza economica estera più forte in Sardegna. Tutto è avvenuto in cinque anni: il primo colpo fa data al 2012, quando la Qia (Qatar Investment Foundation) compra la Costa Smeralda dall’indebitato finanziere americano Tom Barrack. Il pacchetto comprende quattro resort tra i più prestigiosi al mondo, la Marina, il Pevero golf club e 2.300 ettari di terre ancora vergini. Oggi l’unico proprietario è lui, l’emiro Tamin bin Hamad Al-Thani.
Un solo ostacolo rallenta l’espansione del suo braccio immobiliare “Sardegna Resort”: il Piano paesaggistico regionale (Ppr) del governatore Renato Soru: dal 2006 obbedisce al Codice del Paesaggio ed è l’unico argine all’avanzata del cemento. Per i qatarioti è un problema: i petroldollari ci sono, ma i progetti si infrangono sulla legge.
Il Mater è nato come struttura privata del San Raffaele di don Verzé e finito nel crac della fondazione Monte Tabor. Nell’estate 2014 arriva il fondo dell’emiro che lo rileva per 1,2 miliardi di euro dalle banche creditrici. Un’operazione costruita in anni di relazioni diplomatiche condite dai viaggi a Doha di Mario Monti ed Enrico Letta e che avrà in Matteo Renzi il suo più autorevole sponsor nonché padrino al taglio del nastro (maggio 2015). Il progetto sembra già approvato nel 2013 quando viene sottoscritta una manifestazione di intenti tra Cappellacci, allora governatore, Rashid Al Naimi, Ad del fondo Qatariota, e Giuseppe Profiti manager del Bambin Gesù (poi rinviato a giudizio in Vaticano per distrazione di fondi nella vicenda dell’attico del cardinale Bertone).
Ma il Mater rimane un’incompiuta e l’inaugurazione slitta: doveva arrivare a marzo 2015, ora pare si arrivi al 2018, ma c’è anche chi teme non aprirà prima del 2020. E mentre le date si rincorrono, la politica lavora per il Qatar. La cosa importante è non far scappare l’investitore d’oro, e così nell’imponente riforma sanitaria che ridefinisce la rete ospedaliera di tutta l’isola succede che il consiglio regionale voti a maggioranza bipartisan per posticipare al 2020 l’assegnazione dei posti letto per la sanità privata: fate con calma, la Regione e i malati possono aspettare. “Questa è buona politica, il Mater figlio di tutti, Cappellacci e Pigliaru, rende giustizia a un’intera classe”, festeggia il deputato Pd Giampiero Scanu.
 la Repubblica, 26 ottobre 2017 «Benvenuti al gran luna park delle mostre inutili.Un saggio di Tomaso Montanari e Vincenzo Trione attacca il sistema delle esposizioni blockbuster» (c.m.c.)
la Repubblica, 26 ottobre 2017 «Benvenuti al gran luna park delle mostre inutili.Un saggio di Tomaso Montanari e Vincenzo Trione attacca il sistema delle esposizioni blockbuster» (c.m.c.)
il Fatto quotidiano online, 22 ottobre 2017.Terremoti o beni culturali, suoli fragili o acque inquinate, dissipazione energetica o avvelenamento dell'aria, il discorso è sempre lo stesso: investire sulla prevenzione nn sulla riparazione dei danni
La pietra che piove a Santa Croce si allinea infatti con troppi altri sintomi simili, che sono altrettanti segnali di un generale malessere della tutela dei beni culturali in Italia. Oggi Santa Croce, ieri Pompei, ma anche pezzi di Lungarno che franano nella stessa Firenze, il sito archeologico di Sibari allagato, il tempio greco di Caulonia che scivola in mare, il muro di contenimento degli Orti Farnesiani sul Palatino che si sbriciola, due chiese storiche di Pisa (San Paolo a Ripa d’Arno e San Francesco) chiuse al culto per anni onde evitarne il crollo; e così via. Storie di cui perdiamo rapidissimamente ogni memoria, e di cui nessuno tiene il conto. E se ci chiedessimo perché?
Il patrimonio culturale di cui l’Italia si vanta è enorme e prezioso, ma è anche antico e fragile. Richiede cure. Se pensiamo alla salute del nostro corpo, sappiamo che è meglio prevenire che curare, e non aspettiamo di essere colpiti da gravi morbi per correre ai ripari. “Prevenire è meglio che curare” è la regola d’oro anche per il patrimonio culturale, ma continuiamo a ignorarlo. Per misteriose ragioni, attrae di più la retorica del mirabile restauro, dell’intervento prodigioso che riporta in pristino il monumento o il quadro in disfacimento. Ma il più grande direttore nella lunga storia dell’Istituto Centrale per il Restauro, Giovanni Urbani, predicava invece, senza trovare molto ascolto, che meglio di qualsiasi restauro è la conservazione programmata: monitorare preventivamente lo stato di salute dei monumenti e delle opere d’arte, operando minimi, mirati interventi periodici che allontanino il rischio del degrado e il bisogno del restauro (intanto i Musei Vaticani hanno pubblicato da poco, in italiano e in inglese, un bel libro sulla conservazione preventiva, Come si conserva un grande museo di Vittoria Cimino [Allemandi]).
Ma la cultura della conservazione preventiva stenta a farsi strada. E le condizioni del Ministero dei Beni Culturali (bilancio e personale) non aiutano. Da quando il duo Tremonti-Bondi borseggiò il bilancio del Ministero tagliandone quasi la metà (2008), il Ministero è in coma, solo di poco ravvivato da qualche timida inversione di tendenza negli ultimi anni. Ma il grande tema della conservazione programmata è penalizzato non solo da quei tagli irresponsabili, ma anche da una concezione perversa della spesa pubblica nel settore. Secondo i Soloni che tengono i cordoni della borsa, tutto quel che vale come “manutenzione” va ascritto al capitolo “spese correnti” e non “d’investimento”; e la vana rincorsa alla riduzione del debito pubblico (che viceversa continua a crescere) ha provocato drastici tagli alla spesa corrente di tutti i ministeri. Ma la manutenzione, che so, dei corridoi del ministero dell’Economia (che è davvero una spesa corrente) è tutt’altro che la manutenzione del nostro patrimonio artistico e monumentale, che dovrebbe essere classificata tra i più preziosi, indispensabili, cruciali investimenti che il Paese può fare sul proprio futuro. Che da decenni nessun governo e nessun ministro voglia capirlo è un mistero insolubile. Questo errore di prospettiva, che scambia per spesa corrente quel che è invece un investimento essenziale, spiega come mai i fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Ministero dei beni culturali siano stati progressivamente tagliati, fino a giungere nel 2015 a meno di 13 milioni di euro (il 36% della programmazione totale); nel 2017 si è visto un incremento a 16 milioni (43% della programmazione totale), platealmente inadeguato alle dimensioni del nostro patrimonio e alla sua fragilità, destinata a crescere via via che lo si abbandona a se stesso. E dato che assai meno di metà della spesa è destinata alla tutela che è il core business del Ministero, chiediamoci: in che cosa si spende tutto il resto?
Come se non bastasse, la riforma Franceschini ha radicalmente indebolito le Soprintendenze territoriali, a cui spetta la sorveglianza capillare dei monumenti, concentrando ogni sforzo su un manipolo di “grandi musei”, e spostandovi una parte significativa dello scarso personale. La mancanza di turn-over nelle Soprintendenze è colpa dei governi degli ultimi vent’anni (almeno), e sembra preludere alla loro messa in liquidazione, che sarebbe in sintonia con la fatwa secondo cui “Soprintendente è la parola più brutta del vocabolario” (Renzi) e “le Soprintendenze vanno abolite” (Boschi). Un presidente del Consiglio che spara sugli organismi di tutela è l’anima gemella di un altro presidente del Consiglio, Berlusconi, che elogiò l’evasione fiscale: è dunque inevitabile che i due convolino a giuste nozze.
Franceschini, è vero, è riuscito a mettere a concorso 500 posti per l’organico del suo ministero; ma è il primo a sapere che fra il momento dell’annuncio e quello in cui i fortunati prenderanno servizio ci saranno stati ben più di 500 pensionamenti. Per ridare smalto e fiato alla tutela sul territorio, ci vuol altro: almeno cinquemila nuove assunzioni, per concorso e per merito ed esperienza, che diano una prospettiva di lavoro alle decine di migliaia di laureati in beni culturali che sostano in anticamera.
Se non si concepirà la spesa in beni culturali come un vero progetto di investimento sul più grande bene di questo Paese, e non si provvederà presto a massicce assunzioni, sul nostro sempre più desolato patrimonio continueranno, inesorabilmente, a piovere pietre.
la Repubblica, 20 ottobre 2017 Non era sindaco di Firenze quel tale he disse di aborrire le soprintendenze? e non era ministra dei beni culturali quello che promosse lo sfascio degli uffici statali per la tutela?
È straziante l’idea che si possa morire perché un destino incredibile e orrendo ti inchioda, nella frazione di secondo fatale, sulla traiettoria di un pezzo di pietra che si stacca da uno dei monumenti più importanti del mondo. E per commentarlo ci vorrebbe un filosofo, o un poeta o un prete.
Quel che, invece, uno storico dell’arte può aggiungere, almeno in questi primissimi momenti, sono solo domande.
Si è fatto tutto quel che si doveva fare, e che da secoli si fa, per tenere in piedi e in buona salute, la gran macchina di Santa Croce? La manutenzione, le verifiche, i restauri di quella porzione di architettura erano stati fatti? E, se sì, erano stati affidati alle ditte giuste, e quindi monitorati come si deve?
E ancora — allargando il raggio, e ovviamente senza pensare ad un rapporto di causa-effetto con ciò che è accaduto ieri -, ha senso che Santa Croce appartenga al Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, questa anacronistica istituzione che dovrebbe finalmente cessare di esistere, cedendo il suo straordinario patrimonio al Ministero per i Beni Culturali?
E ha senso che l’Opera di Santa Croce sia presieduta dalla stessa persona che presiede anche un centro dell’arte contemporanea come il Museo Pecci di Prato? Cioè, è giusto rivolgersi a professionalità manageriali, in sé magari ottime, ma del tutto sganciate dalla conoscenza di ciò che sono chiamate a guidare? È giusto che nel cda dell’Opera di Santa Croce (nominato dal ministro dell’Interno) siedano alcuni ex politici? O non sarebbe più ragionevole orientare queste istituzioni in senso tecnico, dedicando ogni energia alla conservazione e al valore culturale di questi monumenti?
Comunque si risponda a queste domande (che, tengo a ripeterlo, prescindono del tutto da questa singola tragedia, magari inevitabile) non c’è dubbio che oggi non abbiamo una sufficiente consapevolezza dell’importanza della manutenzione.
Solo per rimanere a Firenze, nel gennaio del 2012 venne giù un gran blocco dalla Colonna della Dovizia, nella centralissima piazza della Repubblica: una strage fu evitata per miracolo. E, nel maggio dell’anno scorso, fu un intero Lungarno a franare. Le nostre antiche città non vivono senza un continuo investimento nella loro manutenzione. Ma la manutenzione porta oggi pochissimo consenso a chi governa città e monumenti: e alla cura delle pietre si preferisce l’organizzazione di eventi.
Se vogliamo provare a dare un senso a questo evento atroce, non dobbiamo mai dimenticare che le cose antiche continueranno a illuminare il nostro cuore solo se noi ci cureremo del loro fragile corpo materiale.
 Nel dibattito sul destino del prestigioso complessodella Cavallerizza Reale di Torino interviene Enrico Bettini, tra gli autoridel progetto di restauro e riutilizzazione degli spazi di uno dei maggiori “monumentiurbani” di cui l’antica capitale del Regno d’Italia dispone.
Nel dibattito sul destino del prestigioso complessodella Cavallerizza Reale di Torino interviene Enrico Bettini, tra gli autoridel progetto di restauro e riutilizzazione degli spazi di uno dei maggiori “monumentiurbani” di cui l’antica capitale del Regno d’Italia dispone.
Il vicesindaco di Torino Guido Montanari (11.10.17), nel confutare le affermazioni di Forni-Negro (della cui ricerca si è avvalsa una proposta meta-progettuale coordinata dal sottoscritto) sulle intenzioni della sua giunta nei confronti del complesso castellamontiano denominato “Cavallerizza”, vuole dimostrare, a suo dire, che la giunta stessa è impegnata ad interrompere il processo di vendita e a riacquisire l’immobile anche se, per colpa di Fassino, non c’è un euro in cassa. Vengono di seguito forniti diligentemente i dati (con un po’ diconfusione tra sup. territoriale e sup. coperta): 16.000 sono i mq. diproprietà della Cassa Depositi e Prestiti (CDP); 25.000 i mq. di proprietà delfondo di cartolarizzazione attivato in precedenza dalla città (CCT); 1.200 imq. che la precedente amministrazione aveva già decartolarizzato,corrispondenti al solo Maneggio al chiuso, opera di B. Alfieri, il gioielloarchitettonico dell’ex ‘Zona di comando’ militare dei Savoia).
E’ evidente, anche ai profani di urbanistica, che questo non corrisponde forse al frazionamento in senso catastale ma in compenso rappresenta l’assoluta frammentarietà dell’idea progettuale; rappresenta l’incapacità (non volontà, più probabile) di fondare il progetto su linee guida unitarie e coerenti, su un’idea autenticamente di insieme: quella idea che per Amedeo di Castellamonte era la realizzazione di un’ampia zona della città di allora per la funzione militare per il regno; per la Torino di oggi, è –dovrebbe essere- la sua trasformazione in cittadella della formazione e della creatività giovanili secondo i principi inclusivi dell’inter-cultura promossa e coordinata grazie al coinvolgimento delle istituzioni culturali cittadine (Università e Politecnico, in primis) chiamate a realizzare un grandioso programma di unitarietà di intenti. Ne dovrebbe conseguire che ragionare a pezzi, come fa Montanari, è l’dea più sbagliata che si possa avere. E dire che nelle tante discussioni sulla Cavallerizza (quando Montanari non era ancora un politico) l’assioma per il suo riuso era l’unitarietà del progetto-programma di riuso e che avrebbe avuto senso solo se comprensivo di tutte le sue parti, nessuna esclusa. Ricordo che Montanari additava l’albergo nella ‘manica del Mosca’ (previsto dal ‘masterplan Fassino’) come emblema del modo scorretto e indegno di affrontare il ‘problema Cavallerizza’. Ora, preso –di fatto- il posto di Fassino, propone un ostello per giovani, gestito da un ente esterno. Un gran salto, non c’è che dire! Si era insieme criticato, a muso duro, il bando della giunta Fassino edito per la manifestazione d’interesse di investitori sulla Cavallerizza perché riguardava neanche la metà del compendio. Ma è evidente: era un altro Montanari, allora.
Risultato? Abbiamo perso per strada Università, Politecnico, Accademia delle Belle Arti, Conservatorio, Museo del cinema, Archivio di Stato, Cantiere scuola di restauro, ecc. ecc. primi attori della formazione di tutti. La formazione non è abbastanza civica? non è considerata importante? È stata dimenticata? Non fa parte della cultura? Che cos’hanno di non pubblico le migliaia tra studenti, ricercatori, artisti, professionisti, docenti, artigiani, attori, registi, restauratori, letterati, pubblicisti, strumentisti, linguisti, ecc. ecc. che un impianto fondato sulle gambe delle alte istituzioni culturali cittadine (situate tutte nei paraggi della Cavallerizza) avrebbe garantito? L’interpretazione spontaneista e movimentista della giusta esigenza di partecipazione civile ha sacrificato l’obiettivo strategico dell’organizzazione della convergenza delle diverse scuole e specializzazioni della cultura esistenti, cosa ben più difficile che pensare di risolvere il tutto con un po’ di mostre di super-avanguardia e programmi di visibilità decisi da assemblee di neo-comunardi (così da dispensare l’ente pubblico da ogni responsabilità). Molto più difficile, utile e urgente, incidere sull’assetto omologante e omologato delle istituzioni produttrici di cultura a Torino. L’obiettivo strategico rimane quello della ricostruzione della Cavallerizza da ‘zona di comando militare’ a un quartiere interculturale della Torino del XXI sec. per la ricerca totale di nuova cultura, germe di una possibile nuova società.
Si è persa per strada la sapienza secondo cui la vitalità, lo sviluppo e lo sperimentalismo culturali, l’innalzamento della creatività artistico e di largo pensiero dipendono proprio dalla struttura e dall’operatività sinergica delle agenzie di formazione del sapere. Avrebbe bisogno di una sede molto coesa e ben articolata tutto ciò. La Cavallerizza sarebbe stata la sua sede-città. Peccato.
 lacittàinvisibile 15 ottobre 2017.« Il testo prova a restituire i numerosi spunti emersi durante il dibattito ‘Bologna oltre Bologna. Costruire la città dell’alternativa’ tenutosi a Bologna il 27 settembre 2017» (c.m.c.)
lacittàinvisibile 15 ottobre 2017.« Il testo prova a restituire i numerosi spunti emersi durante il dibattito ‘Bologna oltre Bologna. Costruire la città dell’alternativa’ tenutosi a Bologna il 27 settembre 2017» (c.m.c.)
Negli ultimi anni i contesti urbani sono stati un laboratorio di sperimentazione economica e politica di innegabile interesse. La città contemporanea, infatti, si manifesta e si produce continuamente attraverso una tensione tra i condizionamenti esercitati dai processi socio-economici e l’azione creativa e interpretativa di individui e gruppi che interagiscono e (spesso) si oppongono a queste dinamiche costruendo forme alternative di appartenenza, partecipazione e consumo. In un’epoca in cui i processi di urbanizzazione (3) rivestono un’importanza fondamentale, la gestione e organizzazione degli spazi diventa centrale.
La città neoliberale
Innanzi tutto, le città sono state il punto di caduta finale delle politiche di ridefinizione del welfare e di riduzione degli investimenti pubblici che negli anni della crisi hanno subito una radicale espansione; anche la funzione delle amministrazioni locali è stata ridotta, in molti casi, alla gestione degli effetti delle misure di austerità. Allo stesso tempo, le città sono diventate sempre più oggetto di interessi economici: dalle grandi opere urbane all’espansione del turismo, dagli investimenti immobiliari allo sviluppo del platform capitalism.
In tutte queste dinamiche gli spazi rivestono un ruolo fondamentale. Il consumo di suolo, inquadrando la questione all’interno della temporalità lunga del capitalismo, si è spostato sempre più dalla campagna alla città, favorendo meccanismi di rendita immobiliare e finanziaria. Già a partire dall’inizio degli anni ’80 si riduce l’intervento statale (4) nella forma della pianificazione urbana come mediazione fra diversi interessi mentre lo sviluppo della città è affidato sempre più alla negoziazione tra istituzioni e grandi gruppi.
Oggi questa dinamica assume spesso il nome di “riqualificazione” o “rigenerazione”. Questi processi – che si prefiggono di recuperare luoghi abbandonati, inutilizzati o “degradati” – si accompagnano a fenomeni di gentrificazione (5): la “nobilitazione” degli spazi impatta sui quartieri e sui territori in maniera complessiva e porta a cambiamenti quali l’espulsione di alcune fasce di popolazione da determinate zone, l’aumento degli affitti, l’applicazione di ordinanze restrittive, etc…
Queste politiche di rigenerazione, inoltre, sono legate all’elaborazione di leggi e piani urbanistici. In tal senso, Bologna ha subito profonde trasformazioni infrastrutturali negli ultimi anni. Il caso di studio paradigmatico è sicuramente la Bolognina ma pensiamo anche al recupero delle caserme abbandonate (all’interno del quale si inserisce la vicenda del Làbas Occupato (6)). Oppure teniamo a mente grandi opere quali FICO Eataly World, il Passante o il People Mover, oggetto di opposizione da parte di comitati locali (7). La recente proposta di legge urbanistica regionale varata dalla giunta dell’Emilia- Romagna è stata fortemente contrastata a causa dei contenuti neoliberisti che si riverserebbero nella pratica urbanistica, tutti in favore dei privati e degli interessi particolari (8).
Al contempo le istituzioni cittadine combattono una guerra senza quartiere all’illegalità cosiddetta “di necessità” contrastando quelle pratiche – come ad esempio le occupazioni di spazi abbandonati – che sorgono da una serie di problemi irrisolti nel contesto urbano (diritto all’abitare, accoglienza, riduzione del welfare, mancanza di spazi di socialità). Esiste un legame tra queste politiche e la stagione degli sgomberi che si sta consumando da alcuni anni, specie a Bologna (9): per valorizzare gli spazi occorre espellere quei soggetti che non rientrano in dinamiche di valorizzazione (10).
Organizzarsi nella crisi
Queste politiche economiche, ovviamente, non possono non avere degli effetti più generali. Si registra una tensione fra politica e società che assume la forma di un doppio movimento di de- e ri- politicizzazione.
Il progetto neoliberista che punta a mercificare spazi e welfare (casa, socialità, servizi, educazione) porta a una restrizione della dimensione politica: si limitano i margini di azione collettiva a favore del mercato; si riducono le possibilità di confliggere e proporre alternative attorno a questioni basilari come la cittadinanza o la giustizia. Gli strumenti tramite i quali si operano queste forme di restrizione della sfera pubblica sono, da una parte, la logica emergenziale (11) e, dall’altra, i cosiddetti saperi tecnici.
In quest’ottica, i progetti partecipativi promossi dalle municipalità sembrano riconoscere parzialmente questo scollamento tra amministrazione e tessuto sociale e provano a ristabilire forme di legittimazione collettiva delle scelte politiche, ma assumono troppo spesso la forma di percorsi il cui esito è stabilito in partenza.
È però difficile limitare le trasformazioni urbane a processi unilineari; piuttosto, spesso sono oggetto di confronto fra visioni diverse e contrastanti. A fronte dell’acuirsi delle dinamiche di sfruttamento del territorio e degli effetti sociali ed ambientali che queste determinano a livello urbano, gruppi di cittadini e movimenti sociali provano ad esercitare un maggiore controllo sui processi decisionali che condizionano in maniera diretta le loro vite. Se da un lato le politiche urbane privilegiano gli interessi privati su quelli collettivi, le pratiche di auto-organizzazione rivendicano il diritto e la necessità di costruire spazi alternativi di convivenza (12). Si tratta perlopiù di esperienze che, facendo ricorso a pratiche di volontariato e mutualismo, istituiscono welfare di prossimità e comunità, reti di economia solidale, luoghi di socializzazione.
Tali pratiche possono essere fatte risalire alla tradizione socialista e operaia di fine ‘800 e oggi assumono nuova vitalità. In comune tutte sembrano avere l’obiettivo di trovare nuove forme di organizzazione nella crisi e ricostruire solidarietà nei territori. Queste esperienze urbane forniscono modelli alternativi dentro e contro l’erosione del welfare pubblico e, tramite il recupero di spazi, vengono a costituire un nuovo tessuto sociale all’interno della città.
Dall’analisi delle pratiche informali a quella degli usi temporanei degli spazi emerge una forma di socializzazione della politica: la partecipazione alla vita pubblica e democratica assume i tratti dell’impegno concreto e collettivo rispetto a bisogni specifici avvertiti all’interno del contesto urbano. Detto altrimenti, le nuove forme di attivismo e partecipazione – soprattutto a livello giovanile e metropolitano – non passano più per i canali tradizionali (come, ad esempio, i partiti) né si danno sulla base di scelte “ideologiche”, ma si esprimono prevalentemente attraverso pratiche di impegno sociale.
Il diritto di decidere
Resta però il problema del rapporto fra queste esperienze e le istituzioni. Gli strumenti a disposizione delle amministrazioni locali (nel caso di Bologna, i patti di collaborazione o il regolamento sui beni comuni) appaiono inadeguati rispetto al carattere aperto, fluido e partecipativo di tali pratiche.
Inoltre è difficile ridurre queste esperienze alla semplice fornitura di servizi, in quanto spesso pretendono di decidere sulle scelte politiche e urbanistiche della città. È in questa prospettiva che possono essere lette sia alcune tipologie attuali di conflitti urbani che esperienze come quelle neo- municipaliste (13) le quali partono dalla contaminazione fra sociale e politico. La ristrutturazione del welfare e l’invenzione di nuovi processi democratici passano anche attraverso lo scontro con le politiche di governance e le dinamiche economiche di profitto.
Bologna negli ultimi anni ha vissuto in pieno queste contraddizioni. Da una parte, l’amministrazione ha investito in grandi opere e progetti di “rigenerazione”; dall’altra la città ha espresso un punto di vista autonomo sul suo futuro – anche tramite pratiche di liberazione di spazi e di vertenzialità metropolitana – che parla di accoglienza, socialità, mutualismo. Il grande corteo (14) #RiapriamoLàbas di sabato 9 settembre ha condensato in maniera fortemente tangibile questa potenza sociale autonoma.
Gli spazi urbani – concepiti non come semplici superfici fisiche ma come luoghi di relazioni sociali (15) – diventano dunque il punto di partenza per reinventare la politica come spazio pubblico: la ri- politicizzazione del sociale va intesa come allargamento dello spazio della decisionalità politica e inclusione di soggetti precedentemente esclusi o poco influenti.
NOTE
1 Il testo prova a restituire i numerosi spunti emersi durante il dibattito “Bologna oltre Bologna. Costruire la città dell’alternativa” tenutosi a Bologna il 27 settembre 2017 e a cui hanno partecipato Paola Bonora, Nicola De Luigi e Lorenzo Bosi. Ringrazio loro per disponibilità e Vito Giannini per il confronto sui temi trattati.
2 Dottore di ricerca in Politica, istituzioni e storia presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna e attivista del centro sociale TPO.
3 Da una parte nei termini di divenire globale delle città (cfr. Saskia Sassen, The Global City, 1991), dall’altra in quelli del farsi metropoli del globo (Neil Brenner, Implosions/Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization, 2014).
4 In una recente intervista, David Harvey ha dichiarato: «Quando lo Stato ha iniziato a ritirarsi dalla fornitura di servizi sociali, il progressivo declino del welfare state, si sono aperte una serie di questioni rispetto a chi e come si dovesse sviluppare la distribuzione dei servizi sociali. E uno dei modi coi quali lo Stato si è relazionato a tale problema è stato quello di ributtare tutte queste funzioni addosso ai governi delle città dicendo: “non è un mio problema, risolvetevela voi”. E chiaramente a quel punto non è che lo Stato ha inviato maggiori risorse alle città, nonostante queste stessero affrontando un numero crescente di problematiche come il social housing, l’aumento delle povertà ecc… Le municipalità vennero abbandonate, dovendo cominciare a trovare le risorse in maniera autonoma. È quello che ho definito come il passaggio da una forma manageriale del governo locale a una governance urbana di tipo imprenditoriale. A quel punto il tema dello sviluppo urbano è divenuto centrale, con un peso sempre più rilevante acquisito dai developer, di fatto gli unici soggetti a garantire un gettito fiscale per il bilancio delle città per poter affrontare i problemi sociali. Purtroppo ciò ha prodotto uno spostamento netto delle risorse, che sono andate sempre meno a coprire i costi necessari per il sociale e sempre più a sussidiare le corporation, proprio mentre i fondi statali diminuivano. E nessuno si oppose a ciò. Qualcuno disse che si poteva costruire una città in cui i bisogni sociali sarebbero stati affrontati col gettito proveniente dallo sviluppo urbano» (Niccolò Cuppini, L’effetto contagio dei movimenti urbani globali. Intervista a David Harvey, 2017).
Cfr. anche David Harvey, From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism, 1989).
5 Cfr. Giovanni Semi, Gentrification. Tutte le città come Disneyland?, 2015.
6 Cfr. https://labasoccupato.com/2014/08/18/occupare-ed-auto-organizzarsi-per-una-nuova-democrazia-urbana/ e http://www.glistatigenerali.com/cdp_turismo/cdp-il-capitalismo-di-stato-fa-acqua-su-immobili-e-turismo/
7 Rispettivamente La foglia di fico (https://fogliadifico.noblogs.org/), Passante di Mezzo – No grazie!
(http://www.passantedimezzonograzie.it/index.php) e No People Mover (https://nopeoplemover.wordpress.com/)
8 Cfr. Ilaria Agostini (a cura di), Consumo di luogo. Neoliberismo nel disegno di legge urbanistica dell’Emilia-Romagna, 2017, il pdf del libretto è scaricabile a questo indirizzo: http://www.officinadeisaperi.it/eventi/cerano-una-volta-i-comuni-rossi-dellemilia/
9 Ad esempio, sul rapporto fra trasformazioni urbane in Bolognina e minacce di sgombero al centro sociale XM24 si veda http://www.eddyburg.it/2017/04/a-bologna-la-rigenerazione-si-fa-congli.html
10 Cfr. Saskia Sassen, Expulsions, 2014.
11 I processi di securitarizzazione che perimetrano e neutralizzano lo spazio pubblico – ad esempio, tramite i decreti di sicurezza urbana – sembrano rientrare in questo tipo di logica basata sull’urgenza e lo stato d’eccezione della misura applicata, oltre che sulla presunta pericolosità dei soggetti da disciplinare.
12 Cattaneo e Engel-Di Mauro, Urban squats as eco-social resistance to and resilience in the face of capitalist relations. Case studies from Barcelona and Rome, 2015.
13 Bertie Russell e Oscar Reyes, Fearless Cities: the new urban movements, 2017:
http://www.redpepper.org.uk/fearless-cities-the-new-urban-movements/
14 https://www.facebook.com/events/1396308287155571/
15 Henri Lefebvre, La producion de l’espace, 1974.
 ilSole24ore, 14 ottobre 2017. Come funziona il partenariato: il pubblico cambia le regole, il privato costruisce, il pubblico paga l'affitto... e se ne vanta. (p.s.)
ilSole24ore, 14 ottobre 2017. Come funziona il partenariato: il pubblico cambia le regole, il privato costruisce, il pubblico paga l'affitto... e se ne vanta. (p.s.)
Sulla carta, si tratta di uno dei principali progetti di trasformazione urbana per la Città di Torino e, allo stesso tempo, di uno degli investimenti principali nei prossimi anni. Si tratta del futuro Parco della Salute, la cittadella universitaria che sostituirà tre dei principali ospedali della città. Un’opera da 568 milioni da realizzare con in partenariato pubblico-privato: 437,5 milioni serviranno per gli edifici, 18,5 milioni andranno alle bonifiche e 112 milioni saranno destinati a tecnologie e arredi. In primavera, assicura la Regione, ci sarà il bando ed entro tre o quattro anni il nuovo polo sanitario e di ricerca potrebbe essere pronto.
«Il progetto guarda al futuro della città e agli investimenti, sarà un forte catalizzatore di innovazione e ricerca per il territorio, ora bisogna realizzare l’opera e farlo in fretta» dice il responsabile degli industriali Dario Gallina durante la giornata di lavori organizzata dall’Unione per fare il punto sull’iter del progetto. Il privato sosterrà il 70% della spesa di realizzazione degli edifici, 306 milioni di euro, e sarà remunerato grazie al canone ottenuto dai risparmi sui costi della gestione corrente. «Un canone – entra nel vivo Antonio Saitta, l’assessore regionale alla Sanità – che la Regione potrà versare grazie ai risparmi che otterremo dal passaggio alla nuova struttura».
Dal canto suo il ministro della Salute Beatrice Lorenzin invia a Torino un messaggio e apre alla sottoscrizione a Roma dell’accordo di programma che riguarderà tanto la realizzazione del Parco della Salute di Torino che la Città della salute e della scienza di Novara. Il finanziamento statale per la costruzione delle due strutture è di 238.457.500, a cui si aggiungono i 12,2 milioni della Regione. La formula del partenariato pubblico-privato metterà in moto un finanziamento aggiuntivo di 526,6 milioni da parte dei privati, sommato ai 146 milioni di costi stimati per le tecnologie, si arriva a superare i 922 milioni per l’intero Piemonte.
Il Parco della Salute di Torino, spiega il commissario della Città della Salute Gian Paolo Zanetta, si estenderà per circa 300mila metri quadri, avrà 1.040 posti letto ad alta complessità e sarà realizzato nell’area Oval-ex Avio, alle spalle del Lingotto. E’ destinato a sostituire quattro ospedali attualmente in funzione, le Molinette, il Regina Margherita e il Sant’Anna – edifici datati e con altissimi costi di manutenzione – e il Cto. Quest’ultimo resterà comunque in funzione come ospedale di media complessità.
Nel Parco della Salute saranno concentrate tutte le attività di ricerca applicata e a ridosso dell’ospedale saranno realizzati gli spazi per la didattica e i laboratori di Medicina. l Comune, dal canto suo, ha già approvato la variazione al Piano regolatore che permetterà, come spiega il vicesindaco Guido Montanari, «di ripensare completamente una parte importante della Città seguendo alcune linee che abbiamo indicato, anzitutto la tutela della storicità di parte degli edifici, la realizzazione di aree verdi e la definizione di collegamenti con il resto della città, con una attenzione particolare alla mobilità verde. Ci saranno spazi residenziali, aree per le residenze protette per le residenze degli universitari e servizi». A Torino, ricorda il vicesindaco, «abbiamo trovato 4 milioni di metri quadri di aree abbandonate, da trasformare, abbiamo avviato progetti per oltre un milione e mezzo di metri quadri, per noi è importante puntare su progetti rilevanti per l’intera comunità».
La scelta della formula del partenariato nasce dalla volontà di attivare il massimo degli investimenti privati e accordare i tempi di realizzazione. «La presenza del privato in questo progetto ha come obiettivo quello di elevare il livello delle strutture in fase di realizzazione – spiega Saitta – si tratta di una procedura che consente di realizzare opere velocemente, il canone al privato infatti viene riconosciuto al momento della fine dei lavori». Per il Piemonte si tratta della prima volta, «le imprese devono essere pronte» è il messaggio in sala.
 A La Spezia è messa in discussione la sorte del nuovo piano urbanistico comunale, basato sul contrasto al consumo di suolo e sulla rigenerazione urbana. Un cambio di rotta preoccupante che andrebbe scongiurato. (m.b.)
A La Spezia è messa in discussione la sorte del nuovo piano urbanistico comunale, basato sul contrasto al consumo di suolo e sulla rigenerazione urbana. Un cambio di rotta preoccupante che andrebbe scongiurato. (m.b.)Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni preoccupate sulla possibilità che il nuovo piano urbanistico comunale (PUC) di La Spezia non venga approvato e decadano le misure di salvaguardia scattate con la sua adozione. Legambiente Spezia ha promosso al riguardo una petizione on-line, di cui trovate il link in calce all'articolo seguente, nel quale sono illustrate le questioni in gioco. Ci sembra una vicenda meritevole di essere seguita con attenzione. (m.b.).
Che cosa può rappresentare per un’Amministrazione e i suoi cittadini la revisione di un piano urbanistico, dopo tredici anni di attuazione? Vecchie e nuove esperienze di pianificazione, rinnovate tecniche dell’abitare e, più in generale, una maggiore consapevolezza delle ripercussioni ambientali, ci dovrebbero obbligare, come tecnici, amministratori o cittadini, ad occuparci del territorio per quello che è: un insieme complesso, dove ad ogni azione corrisponde una reazione della quale, almeno in parte, dovremmo aver imparato gli effetti nel breve e medio periodo. Questa cognizione ci impone una maggior responsabilità che non sempre, però, riesce ad esprimersi in forme efficaci. Una condizione che ha molto a che vedere con il “fare urbanistica” in quest’epoca.
L’esperienza del Nuovo PUC del Comune di La Spezia può leggersi anche a partire da questo.
Dal 2015, per quasi un triennio, l’Amministrazione ha colto l’occasione della revisione del proprio strumento urbanistico, in vigore dal 2003, per interrogarsi sugli effetti delle scelte sul territorio, verificandone lo stato di attuazione, i progetti attivati e realizzati e misurando, attraverso un processo partecipato (maggio–luglio 2015), il grado di soddisfazione e le mutate esigenze dei cittadini.
Cosciente delle nuove esigenze e criticità ambientali, il Nuovo PUC traccia un suo confine ordinatore tra urbano ed extraurbano, tra costruito e agricolo-bosco, tra costa e collina. Un atto di rifondazione consapevole dei rischi ambientali e sociali e dei costi ecosistemici sostenuti dalla collettività (ad esempio quelli del post emergenza). Un atto di rifondazione consapevole del suo “non ritorno” e delle reazioni che l’arresto del consumo di suolo avrebbe comportato. Complessivamente dal 1995 al 2013 il territorio urbanizzato si è incrementato del 2,3%, quasi esclusivamente ai margini collinari della città, senza riqualificarla, ma consumandone le aree immobiliari più appetibili. Il sistema delle tutele introdotto dalle norme ambientali dagli anni ‘90 ha evidenziato la fragilità del golfo spezzino e la necessità di pianificare in modo integrato le sue dinamiche di trasformazione con una rete ecologica in grado di “percolare” il territorio: dalla riqualificazione dell’ecosistema costiero, attraverso gli spazi del verde urbano e dell’agricoltura, fino ai grandi giacimenti di biodiversità (Parchi e Rete Natura2000).
La scelta del Nuovo PUC di arrestare il consumo di suolo (riducendo, tra l’altro, del 45 % la nuova edificazione) è certamente una necessità ambientale, ma è anche un’opportunità di sviluppo alternativo della città. L’idea rifondatrice vuole evitare il conflitto con le risorse disponibili residuali, puntando su strategie di recupero dell’edilizia e delle terre incolte (LR n° 4/2015), di manutenzione della collina (perequazione ambientale) e di rigenerazione della città. L’obiettivo è di porre le basi per una “La Spezia–smart city”, una città sostenibile capace di gestire le proprie risorse in modo creativo e non dissipativo. A partire dalle innovazioni introdotte con la Variante Colline (2013), Il Nuovo PUC, adottato il 18 aprile 2017, introduce presupposti di coerenza per le trasformazioni di un territorio fragile e ormai incapace di sostenere logiche speculative.
Un percorso costruito faticosamente e reso incerto prima dalla dichiarazione di improcedibilità della Regione Liguria per difformità formali in violazione dell’art. 27 della LR n. 36/1997 (Legge Urbanistica) rettificata con una successiva nota come richiesta di integrazioni istruttorie, e poi dai mutati equilibri politici locali, con l’insediamento della nuova Giunta di centro-destra (giugno 2017) che ha attivato un nuovo tavolo con la Regione (luglio 2017) per “(…) decidere come intervenire, nella prospettiva di avere un PUC conformato alle nuove visioni della amministrazione tenendo conto della necessità di riqualificare e riutilizzare l’esistente. (…)”. Le “nuove visioni della amministrazione”, le inevitabili contrapposizioni politiche e la scadenza del termine di ricevimento delle osservazioni (agosto 2017) con l’avvio delle controdeduzioni alle 250 pervenute, rendono ormai difficile una conclusione dell’iter di approvazione coerentemente con l’impostazione originaria del piano.
Mentre rimane quindi incerto il destino del Nuovo PUC della Città Della Spezia (interverranno modifiche sostanziali ai suoi contenuti con la risposta alle osservazioni? sarà necessaria una nuova adozione? e, entro metà novembre, il PUC proseguirà l'iter di approvazione in Regione?, oppure, si andrà verso una sua “naturale” decadenza?), quello che sembra certo è il progressivo svilimento della sua visione rifondatrice. L’inadeguatezza dell’iter amministrativo e dell’azione politica ripropone ancora una volta la difficoltà del “fare urbanistica” anche a fronte di un Piano non perfetto, ma consapevole e lungimirante, che meriterebbe di proseguire il suo corso con gli opportuni contributi tecnici, amministrativi e politici della fase di osservazioni, nel più ampio interesse pubblico generale.
Nota.
Qui potete leggere le ragioni della petizione di Legambiente ed eventualmente sottoscriverla.