

la Nuova Venezia, 20 novembre 2017. Analisi critica del documento Delrio per spostare le navi da San Marco. «Con pregiudizio, senza pianificazione e rispetto delle norme, la Pubblica amministrazione non può procedere nel perseguimento dell'interesse generale». (m.p.r.)
Per le dichiarazioni del ministro Delrio, entro tre anni le navi da crociera di grandi dimensioni saranno dirottate a Marghera (canale nord, sponda nord). Nel testo del "Documento programmatico di percorso", "Documento Delrio", presentato nel corso dell'ultimo Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo ex art. 4 legge 798/84 (Comitatone) relativo al punto dell'ordine del giorno "Prospettive e sviluppo per la crocieristica nella laguna di Venezia", sono presenti errori di riferimento normativo e omissioni di parti di Atti presi dallo stesso Comitato, nella riunione dell'8 agosto 2014, oltre ad attribuzioni di funzioni non previste e assunzioni di metodologie di valutazione discrezionali e non reperibili nella normativa e quindi di alcun valore.
Anche l'art. 6 del precedente testo dell'art. 8, è stato completamente sostituito (dall'art. 7, comma 1, decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169) e ha cambiato contenuto, al comma 12 recita: all'interno delle circoscrizioni portuali, le Adsp amministrano, in via esclusiva, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, le aree e i beni del demanio marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, a dire quindi che l'Autorità portuale di Venezia non è sola a poter decidere financo sulle vie di navigazione qualora provvedimenti contrastino con la salvaguardia della laguna e di Venezia.
la Repubblica on line, 17 novembre 2017. L'agenzia europea per l'ambiente ha messo a punto una mappa interattiva che riporta i valori della qualità dell'aria. L'Italia non solo non fa nulla per ridurre l'inquinamento, ma non comunica neppure i risultati delle rilevazioni. (p.s.)
 Gli inquinanti dell'aria sono infidi e di solito invisibili, ma ora possono essere visualizzati in tempo reale su una mappa europea. L'ha messa a punto l'Agenzia per l'Ambiente (AEA), che l'ha presentata in occasione del "Clean Air Forum" della Commissione europea che si è aperto ieri a Parigi. La mappa "Air Quality Index" raccoglie i dati di oltre 2mila centraline, ogni tre ore si aggiorna e misura i diversi inquinanti che danneggiano salute e ambiente: le micropolveri PM10 e PM2.5, Ozono, diossido di zolfo (SO2) e diossido di azoto (NO2). Che vengono tradotti in pallini colorati dal verde al rosso, rilevando il valore peggiore per ogni inquinante, in un sistema interattivo che permette ai cittadini di zoomare e conoscere la situazione anche nei dintorni di casa propria. Grande assente, ed è una mancanza che salta agli occhi, l'Italia, costellata di pallini grigi, ovvero spenti: le nostre centraline ancora non risultano, come quelle di Romania, Bulgaria e Grecia.
Gli inquinanti dell'aria sono infidi e di solito invisibili, ma ora possono essere visualizzati in tempo reale su una mappa europea. L'ha messa a punto l'Agenzia per l'Ambiente (AEA), che l'ha presentata in occasione del "Clean Air Forum" della Commissione europea che si è aperto ieri a Parigi. La mappa "Air Quality Index" raccoglie i dati di oltre 2mila centraline, ogni tre ore si aggiorna e misura i diversi inquinanti che danneggiano salute e ambiente: le micropolveri PM10 e PM2.5, Ozono, diossido di zolfo (SO2) e diossido di azoto (NO2). Che vengono tradotti in pallini colorati dal verde al rosso, rilevando il valore peggiore per ogni inquinante, in un sistema interattivo che permette ai cittadini di zoomare e conoscere la situazione anche nei dintorni di casa propria. Grande assente, ed è una mancanza che salta agli occhi, l'Italia, costellata di pallini grigi, ovvero spenti: le nostre centraline ancora non risultano, come quelle di Romania, Bulgaria e Grecia.
Azioni di persuasione non sempre lecite per convincere, con successo, i nostri governanti e la Commissione Europea a continuare una politica energetica basata sul gas, che è tutt'altro che un' energia pulita.
L’articolo ripreso su eddyburg dall’open democracy riporta alcune delle tante azioni di “lobby”, ampiamente descritte nel rapporto, messe in campo dall’industria del gas. Queste comprendono tangenti per ingraziarsi i politici europei, elargite con soldi riciclati attraverso il paradiso fiscale azerbaigiano nonchè azioni apparentemente più morbide, come le pressioni fatte a istituzioni accademiche in cambio di collaborazioni varie, la sponsorizzazione di eventi culturali e sportive. L’Azerbaijan è noto per le violazioni dei diritti umani, la repressione dell’opposizione, e la sua “diplomazia del caviale" che con abbondanti doni, da tappeti di seta a oro, argento e chili di caviale, si compra sia il silenzio sull’infrangimento dei diritti umani che l’appoggio alla costruzione del Trans Adriatic Pipeline (TAP), uno dei mega progetti in previsione (vedi la mappa qui sotto) per allargare l’approvvigionamento e consumo di gas.
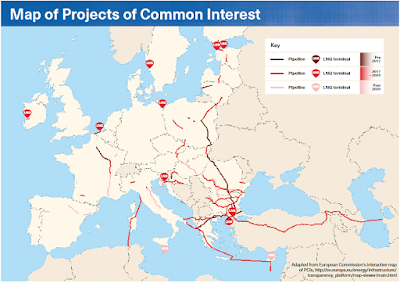 |
| Fonte: Balanyá, B. e Pascoe Sabido, P. (2017) The Great Lock-in, Corporate Europe Observatory |
Una lobby che ha dato i suoi frutti! Infatti la Commisssione Europea e i governi nazionali, anziché trasformare il sistema energetico in direzione del vento, del sole e soprattutto della riduzione del consumo di energia, hanno sostenuto, approvato e finanziato l’espansione della fornitura di gas.
Il TAP è un progetto iniziato a metà 2016 per la costruzione di un gasdotto che trasporterà il gas dall'Azerbaijan all’Europa, attraversando la Turchia - dove si collegherà al Trans Anatolian Pipeline - la Grecia settentrionale, l’Albania e l’Adriatico per poi approdare in Puglia, collegandosi alla rete nazionale. I lavori sono gestiti da un consorzio di aziende, tutti colossi dell’energia: Bp, Socar, Snam, Fluxys, Enags e Axpo.
«Una volta realizzato, costituirà il collegamento più diretto ed economicamente vantaggioso alle nuove risorse di gas dell’area del Mar Caspio, aprendo il Corridoio Meridionale del Gas, una catena del valore del gas lunga 4.000 chilometri, che si snoderà dal Mar Caspio all’Europa.» (dal sito della TAP: www.tap-ag.it/).
Ma vantaggioso per chi? Non certo per i cittadini.
Ad aprile un’ inchiesta dell’ Espresso, che aveva potuto esaminare i documenti riservati della Commissione Europea, aveva già rivelato come il progetto celava il riciclaggio di denaro mafioso con la compiacenza dei governanti e ovviamente di tutte le ditte coinvolte. Qui il link all’articolo, già ripreso da eddyburg.
La questione più spaventosa di questo intrigo tra affari, mafia e potere politico è che questa scelta costringerà l’intera Europa a protrarre per oltre 40-50 anni la sua dipendenza dai combustibili fossili, con conseguenze disastrose per il clima, le comunità locali e per i territori lungo tutta la tratta del gas, infrangendo gli impegni presi in materia di cambiamenti climatici ed energia pulita.
Il gas – nella sua forma convenzionale o quella ora più gettomata derivante da giacimenti non convenzionali in argille (fracked gas) - sebbene sia una fonte energetica più pulita del petrolio appartiene alla lista dei combustibili fossili e responsabile dell’incremento del cosiddetto effetto serra.
Il processo di estrazione dei fracked gas richiede alti volumi di acqua e prodotti chimici inquinanti, ha impatti particolarmente negativi sui territori e comunità locali. Ma anche l’estrazione del gas convenzionale provoca seri problemi in quanto favorisce la formazione di dissesti geologici. Per esempio nei Paesi Bassi il governo è stato messo sotto pressione per ridurre l’estrazione di gas dal campo di Groningen dopo ripetuti terremoti che hanno danneggiato migliaia di case.
Anche l'impatto sul clima è enorme. Nonostante il gas viene spacciato dalla lobby, dalla Commissione Europea e dai governi nazionali come “energia pulita” e “un ponte verso l’energia rinnovabile” esso rimane un dannosissimo combustibile fossile. È vero che quando brucia emette meno anidride carbonica rispetto al carbone, ma essendo il gas naturale composto in gran parte da metano, si verifica che il suo impatto, in arco di tempo di 10 anni sia 100 volte di più dannoso della CO2. Inoltre c’è una grande perdita nel trasporto e tariffe più alte di quanto stimate in precedenza. Lo scienziato Americano Robert Howarth ha affermato che "il gas naturale è un ponte verso il nulla".
Infine i danni causate dalle infrastrutture stesse. Le campagne “Platform” e “Re:Common” hanno documentato numerose violazioni lungo la rotta dal Mar Caspio all’Europa. Ma in Azerbaijan, dove inizia il gasdotto, quelli che tentano di denunciare il progetto sono finiti in carcere o assoggettati a dura repressione.
Non mancano le proteste in Italia, il Comitato No Tap cerca da tempo di fermare il progetto. Anche se la Commissione europea, il governo italiano e la società Tap dicono che i cittadini e le autorità locali, si sono mosse troppo tardi, le opposizioni si sono fatte sentire sin dal 2011. Su eddyburg abbiamo pubblicato un articolo a questo proposito: “No Tap, la lunga storia dell'opposizione al gasdotto pugliese”.
Proprio di recente, anche il ricorso della Regione Puglia non è stato ascoltato. La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il conflitto sollevato dalla Regione Puglia contro lo Stato, quindi la costruzione proseguirà. Il governatore della Puglia accusa il governo di avere agito senza l’intesa della regione e dei suoi abitanti in un progetto in cui "La prepotenza di questa scelta è sotto gli occhi di tutti", ed è calpestata "la volontà delle popolazioni che non accettano, giustamente, l'approdo del gasdotto" vicino a una delle spiagge più belle del Salento (Repubblica.it, 10 ottobre 2017). La Puglia accusa il governo – nella fattispecie il ministero dello Sviluppo economico (Mise) che ha autorizzato la costruzione dell'opera - di non avere intrapreso nessuna trattativa per trovare una soluzione condivisa, in particolare sul punto di approdo del gasdotto, ma la Consulta ha ritenuto non ammissibili i motivi del ricorso.
il Fatto quotidiano, 17 novembre 2017. Una iniziativa esemplare di utilizzazione comune di un bene comune, abbandonato dalle istituzioni e restituito alla produzione di beni per la vita quotidiana
“Quando vivi in un piccolo paese – spiega Matteo, uno degli occupanti di Mondeggi Bene Comune – e vedi per anni migliaia di ulivi abbandonati, puoi fare una sola cosa: prendertene cura”. Bagno a Ripoli e Capannuccia sono Comuni dell’area fiorentina. Mondeggi è una tenuta agricola di proprietà della Provincia di Firenze: 200 ettari tra bosco, oliveto, vigneto, seminativi, casolari e una villa di età medicea. Nel 1538 la tenuta fu acquistata dai Conti della Gherardesca. Nel 1964 la proprietà passa alla Provincia che gestisce il fondo tramite l’Azienda Agraria Mondeggi Lappeggi Srl. Nel 2009 l’azienda finisce in liquidazione per un debito di circa 1,5 milioni, i terreni vengono abbandonati.
Nel 2012 la Provincia mette all’asta la tenuta per ripianare il debito. Ma gli abitanti si oppongono. Partono campagne di sensibilizzazione, centinaia di cartoline arrivano al governatore della Toscana, Enrico Rossi, con la richiesta di non alienare i terreni. Nel 2013 nasce il comitato “Mondeggi Bene Comune”. L’asta va deserta, tranne che per alcuni lotti. Gli ulivi sono soffocati da piante infestanti, il terreno incolto. È questo a spezzare il cuore agli abitanti. “L’iniziativa di occupare la terra non è partita dai giovani o dagli studenti – racconta ancora Matteo – ma dagli anziani. Loro hanno spinto i giovani a organizzarsi e a prendersi cura di Mondeggi”.
Nel giugno del 2014, si occupa il primo casolare, i volontari e gli abitanti dei paesi limitrofi iniziano a ripulire le aree. “Le istituzioni – dice Stefano, pensionato – ci vedono come ladri di olive, ma gli ulivi stavano morendo, soffocati dai rovi e dall’edera, ma noi però ne abbiamo salvati circa 7 mila e tanti pensionati come me hanno ritrovato il senso del vivere in comune”.
Partono i primi progetti: oliveto, vigna, orti, birrificazione. Ciascuno si prende cura di una particella, di circa una trentina di ulivi, il fabbisogno annuo di olio per una famiglia. Nelle aree a seminativo si coltivano grani antichi, trasformandoli in pane. Da poche decine i volontari diventano trecento. Nasce una Scuola contadina, formata da agricoltori, giovani agronomi, docenti e ricercatori universitari. I corsi sono aperti a tutti: apicoltura, orticoltura, viticoltura.
Ci si interroga sul modello giuridico da adottare, ispirandosi all’uso civico e collettivo sperimentato all’Ex Asilo Filangieri di Napoli. Anche Mondeggi si dota di una dichiarazione di uso civico, citando la nozione di “utilità sociale” (articoli 41, 42 e 43 della Costituzione), il principio di sussidiarietà (articolo 118) e la nozione di “bene comune” elaborata nel 2007 dalla Commissione Rodotà. Nascono collaborazioni con associazioni e con progetti internazionali.
La Città metropolitana, che ha sostituito la Provincia, dichiara guerra: non riconosce la comunità come interlocutore, diffida le associazioni locali dallo svolgere le proprie attività nell’area auto-gestita da Mondeggi Bene Comune, “invita” a eliminare dai propri programmi qualsiasi riferimento alla realtà sociale.
Eppure, negli anni, dalla parte di Mondeggi sono scesi in campo giuristi come Paolo Maddalena. “Se l’ente proprietario – spiega l’ex vicepresidente della Corte costituzionale – pubblico o privato che sia, abbandona i beni, essi tornano nella disponibilità del popolo che è l’originario proprietario collettivo a titolo di sovranità. Questo implica il pari uso del bene da parte del popolo e la conservazione del bene stesso, la vendita è esclusa”. L’asta continua, così come la resistenza degli abitanti di Mondeggi
 la Nuova Venezia, 17 novembre 2017. L'intelligente lavoro volontario di un vasto gruppo di cittadini per la rinascita e la fruizione comune di un bene pubblico cancellata dal Demanio. i pescecani del turismo sono in agguato. (m.p.r.) con riferimenti in calce
la Nuova Venezia, 17 novembre 2017. L'intelligente lavoro volontario di un vasto gruppo di cittadini per la rinascita e la fruizione comune di un bene pubblico cancellata dal Demanio. i pescecani del turismo sono in agguato. (m.p.r.) con riferimenti in calce
Doveva essere il giorno dell'accordo, ma si è rivelato quello della rottura. Ieri mattina il Demanio ha comunicato all'Associazione Poveglia che la concessione dell'isola fino al successivo bando non è più fattibile. Uno schiaffo agli oltre 4500 soci che, dopo sedici incontri con il Demanio e numerosi dossier su come spendere i 350 mila euro della colletta, si sono sentiti presi in giro. «Siamo offesi e arrabbiati» ha detto il presidente dell'Associazione Poveglia Lorenzo Pesola «Sono due anni che chiediamo di sistemare il verde, facciamo tutto come richiesto, ci prendiamo cura dell'isola. È uno sfregio agli sforzi di tutti noi che ci abbiamo messo tempo e competenze. Purtroppo è emblematico di una città dove i cittadini non sono ascoltati».
riferimenti
Su eddyburg la Lettera che l'associazione "Poveglia per tutti" ha inviato al direttore dell'agenzia centrale del Demanio, sollecitando una risposta alla richiesta di concessione dell'isola e una nota del costituzionalista Paolo Maddalena. Altre notizie sono facilmente raggiungibili digitando la parola "Poveglia" nel nostro "cerca"
la Nuova Venezia, 17 novembre 2017. «Le anomalie dell'ultimo Comitatone finiscono in Parlamento. “La Legge speciale non tutela lo sviluppo del crocierismo ma la laguna”». (m.p.r.)
«La Legge Speciale non prevede la tutela dello sviluppo crocieristico ma della laguna. Per questo Venezia è questione di preminente interesse nazionale. L'ultima riunione del Comitatone si è conclusa con un nulla di fatto, e ha dato soltanto all'opinione pubblica internazionale un messaggio ingannevole: che il problema sia stato risolto. Ma non è così». Nella polemica sulle grandi navi interviene il senatore Felice Casson. Ex candidato sindaco, autore nel 2014 dell'ordine del giorno che aveva chiesto al governo di «confrontare tutte le soluzioni alternative». Iniziativa che adesso riporta il dibattito sulle grandi navi in Parlamento. Perché Casson chiama in causa il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. E chiede di sapere «se il premier sia a conoscenza di quanto accaduto nella riunione del 7 novembre», e «quale valore politico e giuridico attribuisca ai lavori del "Comitatone" del 7 novembre e alle sue conclusioni». Dove si parla di «presa d'atto» e «invito» alle amministrazioni». Ma non c'è traccia di Atti di Indirizzo o di provvedimenti del governo.
il Fatto Quotidiano, 15 novembre 2017. «Oltre 60 miliardi di investimenti nelle energie rinnovabili: l’isola del Pacifico cerca di smarcarsi da Pechino puntando sull’ecologia. Ma alla Cop23 viene messa alla porta». (p.d.)
Long- Jin, ad esempio, è l’amministratore delegato della Get – Green Energy Corporation di Taichung, città nella regione centro-occidentale. Guadagna circa 200 milioni di dollari l’anno. “L’energia solare è la più grande bugia del nostro tempo – esordisce durante l’incontro – produce l’immondizia più inquinante del mondo”. L’intuizione: a un certo punto i pannelli solari si esauriranno e dovranno essere smaltiti. Così Long- Jin ha deciso di riciclarli e trasformarli in altri oggetti. “Come questa maglia – dice indicando gli abiti che indossa – o quel crocifisso”, aggiunge puntando il muro con un dito. Si scompongono i pannelli e, con trattamenti chimici, se ne estrae il silicio con cui poi si creano altri oggetti: batterie a litio, tessuti e materiali isolanti, pezzi di smartphone. “È una fabbrica di soldi”, commenta Long Jin, figlio di un pastore protestante in un paese prevalentemente buddhista, tornato a Dio dopo il fallimento dell’impresa americana con cui produceva aerei da guerra per la Cina. Oggi ha convinto il board della sua azienda a donare il 10% del profitto a organizzazioni caritatevoli. L’anno prossimo aprirà una fabbrica in Spagna. Produrrà pannelli per due anni, inizierà a smaltirli dal 2020. Non ha però intenzione di sbarcare sul mercato cinese. “Non finché non avrò accumulato almeno 2 miliardi di dollari”. Non vuole che accada ciò che succede a qualsiasi compagnia tecnologica che è entrata nel mercato cinese: “Nel giro di due o tre anni si prendono tutto e il proprietario diventa un dipendente. Fagocitano ogni idea. Non hanno paura di nulla”.
Ampia analisi dell'ideologia, delle strategie, degli strumenti amministrativi e tecnici, grazie ai quali la salvaguardia della Laguna di Venezia si è tradotta nella sua distruzione (e in un gigantesco affare per una banda di pescicani). Con riferimenti
Cercare alle radici del fallimento
Il 4 novembre del 1966 avevo 17 anni. Da una vita tento di capire come mai si sia potuto scegliere di costruire un marchingegno così mastodontico, inappropriato e di incerto funzionamento – oltre che inutilmente costoso – come lo sono i quattro sbarramenti con paratoie elettromeccaniche a spinta di galleggiamento, incernierate al fondale delle bocche di porto della laguna di Venezia. La risposta che mi sono dato è già nel bellissimo titolo della giornata dedicata al Mose organizzata dall’associazione PER Venezia Consapevole il 21 ottobre all’Iuav: «Il senso delle cose sta oltre tutti i linguaggi che le rappresentano». Che, a mio vedere, è un altro modo per esprimere un concetto ecologico: non bisogna confondere una parte di un sistema con il tutto, poiché la somma delle singole parti che compongono un organismo non basta a spiegare il suo funzionamento. Peggio: la separazione e la frantumazione degli elementi di un ecosistema porta alla sua morte. Il Mose è il risultato di una riduzione a questione idraulica del problema della preservazione dell’ecosistema lagunare collocato nella ancora più vasta bioregione che va dall’Adriatico alle Dolomiti, dalla Piave al Po. A monte della scelta degli sbarramenti di separazione mare/laguna c’è un difetto culturale profondo e diffuso, una drammatica insipienza tanto “scientifica” quanto “politica”e, per contro, una sconfitta del pensiero ecologista proprio nel punto in cui la sfida si presentava più necessaria, alta ed evidente.
Di fronte al conclamato fallimento della gigantesca rubinetteria del Mose - perché è di questo che stiamo parlando - non ci dobbiamo accontentare di risposte facili, pur vere, ma parziali e, alla fine, persino psicologicamente consolatorie: la corruzione, l’affarismo, l’abdicazione della comunità scientifica. Da Nicolazzi a Matteoli, da Bernini a Galan. Questi sono stati i “nostri” ministri e governatori. Ma anche alti funzionari dello stato, dirigenti di Regione, persino magistrati e finanzieri hanno pilotato un progetto che altrimenti non sarebbe mai stato approvato. La tesi delle “mele marce”, dei parassiti approfittatori in proprio, non regge. Il Sistema Mose è lo stesso di tutte le “grandi opere” (strade e autostrade, treni ad alta velocità e aeroporti, persino ospedali), del business facile delle concessioni alle grandi imprese di costruzione di cui il Consorzio Venezia Nuova è stato solo l’apripista. Così come sistematica è la sussunzione dei centri di ricerca pubblici e delle università da parte delle imprese. Consulenze, collaudi, direzioni lavori, porte girevoli tra pubblico e privato sono la regola dei rapporti tra Stato e imprese.
Come è potuto accadere tutto questo? Indagare su Venezia può essere istruttivo per capire come va l’intero paese. Venezia è un caso di scuola per studiare non solo gli effetti nefasti dell’avvento dell’industrializzazione (manifatturiera prima, turistica ora) sull’ambiente (subsidenza, alluvioni, anossia, inquinamenti…), ma anche sulla perdita di memoria e di empatia degli abitanti nei riguardi del proprio territorio, di “coscienza di luogo”, come direbbe Alberto Magnaghi. Un processo lento di sradicamento, legato al “grande esodo” della popolazione autoctona e al prevalere di un’economia di rapina. Solo chi ha imparato ad andare a remi e a nuotare in laguna può capire cosa significa estraneazione culturale della città d’acqua dal suo ambiente.
Ha scritto recentemente Edoardo Salzano: «Due visioni si sono scontrate a Venezia: una logica sostanzialmente meccanicistica, che intendeva isolare i problemi e a dare loro soluzioni indipendenti e fortemente ingegneristiche, e una logica sistemica, che si proponeva di evidenziare le correlazioni tra tutte le dinamiche in atto». (Editoriale del 1 ottobre 2017 su www.eddyburg.it ). Proviamo a capirne di più con l’aiuto dell’ecologa Vandana Shiva: «I sistemi viventi evolvono, si adattano, si rigenerano. Non sono ingegnerizzabili. Il dominio del paradigma ingegneristico inizia con l’era dell’industrialismo e del meccanicismo (…) Un sistema di conoscenza fondato su un paradigma meccanicistico, riduzionista e materialistico (…) Crediamo di essere al di fuori e sopra della Terra, crediamo di controllarla, di esserne i padroni. Lo crediamo [ma] ecco che i cambiamenti climatici, gli eventi estremi, i disastri ci ricordano con sempre maggiore frequenza che siamo parte della Terra. Ogni atto di violenza che distrugge i sistemi ecologici minaccia anche le nostre vite (…) Dobbiamo trasformarci da specie predatrice e incurante a specie che si prende cura, che lavora in co-creazione e co-evoluzione con la Terra». (V. Shiva, Solo il carbonio vivo salverà la terra, “il manifesto”, 22 settembre 2017). Potremmo continuare a lungo citando altri riferimenti scientifici ad una concezione di “ecologia integrale” – come la chiama Bergoglio nella enciclica Laudato si’ – o sistemica, come la chiama il grande fisico Fritjof Capra: «Una vera concezione della vita implica pensare in termini di relazioni, configurazioni e contesti, che nella scienza è conosciuto come “pensiero sistemico”». (F. Capra, Vita e Natura, Aboca, 2014).
Scientia [et] Potentia generano mostri
La ragione di fondo per cui la politica (nel discorso pubblico corrente e nel modus operandi delle istituzioni) preferisce l’approccio deterministico, lineare piuttosto che quello ecologico, ricorsivo sta – a mio avviso – nel fatto che la forma mentis, il modo di pensare e il linguaggio della politica sono quelli del dominio. La politica è vista e vissuta come affermazione ed esercizio del potere come comando. Il potere di disporre sugli altri e sulla natura. Non importa con quali mezzi e a quale prezzo. L’importante è “dare risposte”, rassicurare, conquistare il consenso popolare. In questa logica, per definizione, non è ammessa l’esistenza di problemi che non siano nella disponibilità della volontà di potenza del potere. Se qualche cosa si frappone al volere del governo essa va semplificata, rimossa e annullata.
La politica del dichiarare/decidere/disporre non può rispettare i tempi della conoscenza, dell’ascolto, della partecipazione condivisa delle popolazioni insediate. Procedure come la Valutazione degli Impatti Ambientali nate per far partecipare le popolazioni locali al percorso decisionale o direttive internazionali per la trasparenza degli atti come la Convenzione di Aarhus, non sono ammesse a fronte della “straordinarietà ed eccezionalità” degli interventi e dell’“l’interesse nazionale” prevalente delle opere. La militarizzazione della Val di Susa docet. Ma non meno gravi sono state anche le forzature operate da vari governi per giungere all’approvazione del Mose nonostante pareri negativi della commissione nazionale Via, del Consiglio nazione dei Lavori Pubblici, della Corte dei conti.
Per queste ragioni il linguaggio della politica non può essere ecologico, ma ingegneristico. Per imporsi, questo modo di fare politica ha bisogno della mediazione del linguaggio scientista (che è il contrario del metodo scientifico, per intenderci, quello che mette permanentemente in dubbio i saperi esistenti). I decisori pubblici, a corto di argomentazioni davvero convincenti, hanno bisogno di allearsi ai chierici delle “scienze esatte” per imporre le proprie scelte. Parafrasando Francis Bacon (Scientia est potentia) potremmo dire che l’alleanza tra scienza e potere ha generato molti mostri. Per validare “razionalmente e oggettivamente” le decisioni prese senza concedere possibilità di replica, sono chiamati in gioco gli esperti, i supertecnici, i saggi, i sapienti… La storia dei progetti per la salvaguardia di Venezia è costellata di commissioni e comitati scientifici (ne ho contati almeno otto) chiamati a proporre e a giudicare le migliori soluzioni proposte dagli uffici tecnici delle imprese di costruzione.
La complessa realtà biofisica e socioeconomica del territorio lagunare è stata parcellizzata, segmentata, numerata e modellizzata con l’intento di riprodurla in scala (vedi la ridicola storia del modello fisico della laguna di Valtabarozzo) e di imitare il suo funzionamento con software sempre più evoluti. Peccato che ogni tentativo di modellizzare grandi ecosistemi naturali, influenzati da complessi fenomeni meteorologici, biologici e antropologici comporti inevitabilmente una riduzione della complessità della realtà e una perdita di rappresentatività. L’imponente mole di dati e studi prodotti dal Consorzio di imprese Venezia Nuova è stato mirato a sostenere le scelte progettuali con il risultato di azzerare gli uffici statali (ad iniziare da quello idrografico del Magistrato alle Acque) e di mettere fuori gioco i “saperi diffusi”, esperenziali e contestuali sulla laguna basati sulla osservazione diretta dei fenomeni naturali (Ufficio maree del Comune, Biologia del mare e Grandi masse del CNR).
I “saperi esperti” degli istituti di idraulica chiamati a supporto delle scelte progettuali delle imprese di costruzioni (in pratica ristrette baronie universitarie di Padova e Genova) hanno avuto il monopolio della certificazione della scientificità del Mose. Roberto Ferrucci, nel suo ultimo bel racconto Venezia è laguna, li chiama: «I truffatori del buonsenso, i sabotatori del paesaggio». Per anni i tecnici accreditati dal Consorzio Venezia Nuova ci hanno spiegato con grafici, modelli e disegnini animati che la profondità dei canali portuali non è causa di erosione della laguna, che lo scambio mare-laguna è in equilibrio, che le acque medio alte più frequenti non sono un problema per la città, che le barene possono essere ricostruite con burghe di pietrame, ed ora, ci vogliono far credere anche che le grandi navi non fanno onde!
Può essere istruttivo riascoltare Giovanni Cecconi, uno dei massimi responsabili tecnici del CVN, incaricato di comunicare le meraviglie del Mose, ad una televisione amica, qualche tempo prima che scoppiasse lo scandalo del Mose.
Shock Economy in laguna
Per attecchire il decisionismo politico e il determinismo scientifico hanno bisogno di procedere lungo una sequenza logica che può essere definita così: emergenzialismo, decretazione, contrattazione. Provo a spiegarmi seguendo l’esempio veneziano.
 |
| A sinistra: Il Gazzettino del giorno dopo. A destra: Il sindaco Favretto Fisca con Ted Kennedy e la contessa Foscari in sopralluogo a Pellestrina |
Ma mentre le indicazioni organiche della commissione si sono tradotte in legge (peraltro del tutto disapplicata) solo nel 1989 (legge n.183 sui piani di bacini idrogeologici e la difesa del suolo e delle acque), i decisori politici hanno preferito dare risposte parziali e specifiche alle varie “emergenze”. La legge speciale per Venezia n.171 del 1973 è una di queste. Un modo di procedere che ha avuto nella Legge Obiettivo del 2001 (tutt’ora operante) di Lunardi e Berlusconi la sua più compiuta codificazione. Vale a dire l’abbandono di ogni approccio programmatico e pianificatorio, coerente e permanente, a favore di interventi concentrati, sporadici, contrattati di volta in volta tra stato centrale e sistema delle autonomie regionali e affidabili a grosse associazioni tra imprese.
L’arte di trasformare l’ordinario in straordinario è una tattica ampiamente usata anche in altri paesi del mondo che la giornalista ambientalista canadese Nomi Klein ha chiamato shock economy, dopo aver assistito al disastro di Katrina a New Orleans nel 2005. La tattica consiste in questo: primo, lasciare precipitare la situazione di degrado trascurando la cura ordinaria e la manutenzione del territorio; secondo, considerare i disastri ambientali come un potente acceleratore dei processi di liberazione del patrimonio immobiliare dagli abitanti autoctoni più poveri; terzo, concentrare finanziamenti pubblici straordinari capaci di innescare grandi business e di rivalorizzare il patrimonio immobiliare.
Le “specificità” di Venezia sono state usate per giustificare l’approvazione di una normativa e di una strumentazione “straordinarie”, ipercentralistiche e falsamente efficientistiche che hanno nel tempo permesso di derogare a tutte le più elementari regole della buona amministrazione. In un articolo del 1 agosto del 1989 su Repubblica, Giuseppe Galasso, insigne storico e già sottosegretario ai beni culturali e ambientali, ebbe a scrivere: «In Italia tutte tende a farsi straordinario: non solo i terremoti o la mafia; ora anche le alghe». Era il tempo dell’eutrofizzazione dei mari e dell’invasione della Bava Mucillaginosa.
Governare per decretazione
Il secondo modo di procedere tipico del determinismo autoritario è il governo per decretazione. Anche qui il caso del Mose ci viene d’aiuto. Non è stata la Legge speciale del 1973 a compiere la scelta progettuale. La Legge speciale, nello stabilire gli obiettivi generali, si limitava ad affermare che: «La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione».
Saranno gli “indirizzi” del Governo, un paio d’anni dopo (marzo 1975) a scendere nel particolare e stabilire le modalità tecniche necessarie a realizzare gli obiettivi della legge: «La conservazione dell’equilibrio idrobiologico e l’abbattimento delle acque alte (…) devono essere ottenute mediante un sistema di opere di regolazione fisso alle bocche di porto che possa essere successivamente integrato da parti manovrabili».
Nessuna commissione tecnica, nessuna istituzione scientifica si era azzardata a scendere a tanta precisione progettuale (tant’è che nel corso degli anni l’indicazione è stata modificata). Ma le esigenze della politica richiedevano una dimostrazione di capacità decisionale a prescindere dallo stato degli approfondimenti conoscitivi scientifici, anche in mancanza di un quadro d’insieme degli interventi e di un piano generale di riassetto del bacino idrografico lagunare, che ancora stiamo aspettando. La politica intesa come mero esercizio di potere ha le sue logiche e deve poter affermare coram populo l’avvenuta soluzione dei problemi.
La retorica del potere ha reso necessarie varie “inaugurazioni” del Mose. La prima volta ad annunciare “la sopravvivenza e lo sviluppo di Venezia” è stato Fanfani nel 1982 nel discorso alla Camera di insediamento del suo V° governo. Poi è stata la volta di Craxi in Palazzo Ducale, l’8 novembre del 1986 nel ventennale dell’alluvione con i ministri Granelli, Gullotti, Degan, Di Lorenzo, Visentini, il sindaco Laroni, il presidente della Regione Bernini e ospiti d’onore come Gianni Agnelli e Carlo De Benedetti. Quindi De Michelis il 3 novembre del 1988 per il varo del prototipo del Mose con i ministri Fracanzani, Ferri il sindaco Casellati e il presidente della Regione Bernini. Infine è venuto il turno di Berlusconi, il 24 maggio 2003 al collegio navale Morosini, con il cardinale Scola, il sindaco Paolo Costa, i ministri Lunardi, Matteoli e Buttiglione.
Un susseguirsi di fanfare e cori entusiasti. Ad esempio scrive Roberto Bianchin su Repubblica il 30 ottobre 1988: «Quattro grandi torri rosse, una lingua d’acciaio nascosta dentro, il tricolore dipinto sul fianco, il ferro da gondola, simbolo del Conorzio di imprese Venezia Nuova, disegnato da Forattini. E un nome, Mose, che i tecnici si affannano a spiegare che vuol dire modulo sperimentale elettromeccanico ma che tutti, a cominciare dal vicepresidente del consiglio Gianni De Michelis, ribattezzano subito Mosè, con l’accento sulla é. É la diga, dal nome biblicamente evocatore, che salverà Venezia dalle acque alte».
Bianchin non era il solo. «Ecco Mose, salverà Venezia», titolava la Stampa. «Mose ha fatto il miracolo. Perfettamente riuscito l’esperimento di Venezia», titolava il Giorno. «Ore 11,14 La paratoia si solleva. Un attimo di emozionata concordia», titolava il Gazzettino.
Ciò che ora chiamiamo Mose un tempo si chiamava più bonariamente Progettone, Progetto preliminare di massima, ed era solo una parte del Progetto Venezia. Era un intervento tra i molti che avrebbero dovuto affrontare, in una strategia integrata ambientale, socio-economica e istituzionale, il “Problema di Venezia”. Con il tempo abbiamo assistito ad un abbandono di ogni coerenza e organicità degli interventi e ad un procedere a foglie di carciofo. Tuttora non esiste un piano di bacino idrogeologico delle acque. Il Magistrato alle acque è stato (giustamente) sciolto a seguito dello scandalo del Mose, ma non è stato sostituito né dalla autorità di bacino “ordinaria” (ex lege 183), né dalla “agenzia” che avrebbe dovuta essere costituita per sovraintendere il funzionamento e gestire le chiusure mobili.
Il Piano comprensoriale è stato insabbiato illo tempore dalla Regione assieme ad ogni organica architettura della Città metropolitana. Il parco naturale della laguna è uscito dalla Legge quadro nazionale e quello di iniziativa locale è stato azzerato dal Comune. L’allontanamento dei traffici petroliferi dalla laguna (prescrizione di legge dal 1973) non è stato realizzato mentre è aumentato a dismisura quello crocieristico. La riapertura delle valli da pesca e la loro ri-acquisizione al demanio (sentenza n. 3665 del 14 febbraio 2011 della Corte di Cassazione in occasione di una infinita disputa che riguarda le valli da pesca) non sono state attuate. Abbandonato il progetto per la rimodulazione del Canale dei petroli. Nessun rilancio del Cnr, dell’Ispra e degli altri istituti di ricerca pubblici. Persino le sale dedicate alla laguna del Museo di storia naturale non sono state allestite. Per non parlare delle politiche abitative, sociali e produttive completamente liquefatte.
A fronte di tanti e tali fallimenti il vecchio Progettone ha via, via conquistato l’intera scena. Con il giovane avvocato Luigi Zanda presidente del CVN (dal 1985 al 1995) il Progettone ha subito una rivoluzione linguistica degna del miglior marketing aziendale. Il nuovo Mosé è la tecnologia made in Italy, l’Ottava meraviglia del mondo. Più ancora - dirà in un appassionato intervento Zanda al convegno organizzato dal P.C.I. “12 parchi nel Veneto”: «Mi azzardo a dire che il nostro progetto è il primo di una nuova generazione di opere pubbliche. Reti autostradali, ponti sugli stretti, sono cose imponenti e impegnative ma tradizionali. La nostra è la prima opera pubblica che dopo anni di disattenzione e di imprudenze, ripropone la centralità dell’ambiente. Le tecnologie più avanzate si devono plasmare ed adattare per fare, appunto della “ingegneria dell’ambiente”.(…) La tecnologia è stata spesso additata come elemento di rottura: noi la riproponiamo come strumento di riequilibrio». (Venezia 26 settembre 1986).
Parole analoghe orientate all’ecologia saranno pronunciate poche settimane dopo da Craxi in Palazzo Ducale per il ventennale dell’alluvione: «Il progetto Venezia è il primo di una nuova generazione di opere pubbliche che pongono la tecnologia al servizio dell’ambiente, per rigenerare nuove condizioni di equilibrio e di armonia che l’uomo, e in parte la stessa natura, avevano modificato. Si tratta di ricostruire un vero e proprio “ecosistema”, che era stato violato, attraverso il riequilibrio idrogeologico e una vasta opera di disinquinamento agricolo, industriale ed urbano. E’ una impresa che non si materializza in un grande cantiere, in una grande opera fisica, ma richiede uno studio, una intelligenza, una invenzione continua per andare alla radice dei fenomeni che hanno causato il deterioramento e rimuoverne globalmente le cause» (Venezia 8 novembre 1989).
La svolta ecologista di Zanda e Craxi durerà poco. Servirà a gettare un po’ di fumo negli occhi ad una opinione pubblica scettica e ai rilievi critici del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Corte dei Conti. Esaurita la realizzazione del lungo elenco delle “opere complementari” e “preliminari”, le dighe di separazione mare/laguna, sono tornate ad essere il fulcro del sistema, lo scopo stesso dell’esistenza del Consorzio di imprese Venezia Nuova.
Il caso Venezia sta tutto dentro questo dilemma: porto o salvaguardia. Siamo ancora al punto di partenza. 35 anni fa l’Associazione degli industriali e l’Ente zona industriale di Porto Marghera si chiedevano se si potesse «difendere Venezia senza uccidere il porto» (Massimo Mazzariol riferisce sul il Gazzettino del 14 novembre 1982). Per esserne certi affidarono uno studio ad una équipe di docenti di Cà Foscari: Muscarà, Marguccio, Elio Canestrelli e Paolo Costa. «Il responso dei quattro docenti è confortante: la chiusura temporanea delle bocche di porto ha un costo sopportabile, ma non tutti i rischi sono valutabili», riporta il giornalista. Quindi, dicono i professori: «Meglio costruire una paratia alla volta, piuttosto che tutte e tre simultaneamente».
Passa il tempo, cambiano i ruoli, ma siamo ancora qui. Pochi giorni orsono, il 10 ottobre 2017, il giornalista Albero Zorzi sul Corriere del Veneto, scrive: «Era lo spauracchio del presidente uscente dell’Autorità portuale Paolo Costa e lo è anche del suo successore Pino Musolino. L’acqua alta, le paratoie del Mose sollevate a chiudere la bocca di porto di Malamocco e le navi che aspettano fuori o che percorrono lentamente la conca di navigazione (…) il porto di Venezia rischia di essere piano piano abbandonato. Ed è partendo da qui che il provveditore interregionale alle opere pubbliche Roberto Linetti sta pensando ad un modo per ridurre il più possibile le chiusure del Mose a Malamocco». (Mose a metà per salvare il porto. Così passano anche le crociere, pag. 5 14/10/2017).
Venezia può venire inghiottita dalle acque, ma le navi potranno passarci sopra. Come bene documenta questa foto.
Riferimenti
Tra i numerosi articoli dedicati da eddyburg all’argomento si vedano, tra i più recenti. l’Eddytoriale n. 174, in gran parte dedicato alla banda, Consorzio Venezia Nuova, che inventò, progettò costruì, gestisce (e soprattutto beneficio degli ingenti finanziamenti pubblici impiegati per l’opera, l’articolo di Paola Somma "La città del Mose", che illustra il contesto metropolitano nel quale il “sistema Mose” agisce, quelli di Edoardo Salzano "Venezia e la modernità" , con la replica di Piero Bevilacqua, di Armando Danella, "Il rischio Mose".
La città invisibile, 13 novembre 2016. Analisi, a partire di Firenze, del turismo d'oggi come nuova forma di economia di saccheggio delle risorse operato dalle aziende globalizate nei deserti creaati dallo "sviluppo"
L’industria del turismo prolifera nella città storica, vuota di residenti stabili. È un’economia di rapina che saccheggia le città monumentali. Il turismo cava denaro da un patrimonio monumentale di dimensione finita e non è in grado di riprodurne. Assume caratteri simili a quanto, nel Sud del mondo, è stato definito “estrattivismo”: economia di saccheggio delle risorse e loro esportazione, attuata spesso con metodi violenti contro il volere delle popolazioni insediate.
Questa nuova forma di colonialismo operato non più dagli stati-nazione ma dalle multinazionali globalizzate, prospera – sub specie turistica – nei deserti urbani, nella città dei recinti, delle zone rosse, dei limiti invalicabili (che nascono e si moltiplicano nel clima determinato dagli attentati terroristici, indirizzati proprio verso le città d’arte). Nella città dei recinti, la cittadinanza è espropriata dei luoghi centrali di vita urbana, quando non fisicamente espulsa dai “centri storici” cui, negli anni Settanta, fu attribuito un forte ruolo sociale, aggregativo, civilmente costitutivo e oggi interamente soppiantato dal loro potenziale economico.
Ma come avviene l’espropriazione degli spazi urbani pubblici, monumentali, degli spazi comuni e di relazione? Quali sono le politiche di gestione e i meccanismi amministrativi che determinano l’espulsione fisica dei residenti e degli abitanti?- Cominciamo dagli spazi pubblici e dagli immobili di uso collettivo. Negli ultimi tre decenni, nelle città d’arte italiane, abbiamo assistit– all’allontanamento delle funzioni dal centro (operazione che un tempo andava sotto la voce “decentramento”). Sia delle funzioni rare (università, tribunali, teatri etc.) sia dei servizi al cittadino, diffusi nel tessuto centrale (uffici postali, anagrafe, poliambulatori, asili etc.);– alla compulsiva messa in vendita degli edifici pubblici, in posizione centrale, rimasti vuoti o appositamente svuotati di usi collettivi: caserme, tribunali, corte d’assise, etc., ma anche immobili destinati a residenza popolare (ERP);– alla trasformazione dei grandi immobili in disuso, sia quelli privati che quelli pubblici alienati di fresco, in strutture esclusive, rivolte al consumo di lusso, al di fuori ogni programmazione o comunque in deroga alla pianificazione;– alla pedonalizzazione di vaste aree centrali non compensata da un organico piano del servizio del trasporto pubblico: a Firenze, l’esclusione del transito dei mezzi pubblici da piazza del Duomo non affiancata da un’organica riorganizzazione della rete del trasporto pubblico medesimo ha sottratto l’accesso al Quadrilatero romano – piazze del Duomo, della Signoria e della Repubblica – a una fetta consistente della popolazione. La privatizzazione dell’ATAF (Azienda trasporti area fiorentina) ha fatto il resto;– alla metamorfosi dei monumenti e musei in cash machines (da fine anni Ottanta, nelle città storiche peninsulari le principali chiese sono trasformate in musei e, a causa del biglietto d’entrata, sostanzialmente chiuse ai residenti);
– alla mercantilizzazione delle piazze, dei ponti, delle strade e degli ambienti monumentali (musei, biblioteche etc.) tramite affitto temporaneo, finalizzato ad ospitare attività lucrative;
– alla liberalizzazione del commercio dovuta al decreto 114/1998, detto “Bersani” – che ha oliato il processo di propagazione dei centri commerciali suburbani, in voga negli anni ‘90 e duemila – e alla conseguente trasformazione delle botteghe artigiane e di vendita al dettaglio in luoghi del foodismo: l’assenza di piani del commercio che possano effettivamente definirsi tali asseconda il moltiplicarsi e il continuo ricambio di locali di ristorazione, settore di primario interesse della malavita organizzata (cfr. Rapporto Agromafie 2017).
L’espulsione della popolazione residente dal centro urbano monumentale è stata graduale, ma numericamente significativa. A dimostrazione del contrario – ma scambiando artatamente la residenza con il transito – il sindaco di Firenze ha gioito pubblicamente a seguito della pubblicazione di uno studio di mobile analytics che stima il passaggio giornaliero dal centro cittadino (in una città in cui il traffico privato e pubblico, su gomma e su ferro, è sostanzialmente centripeto e nella quale il polo fieristico è situato sul circuito delle mura trecentesche) in decine di migliaia di fiorentini e “city-users”.
Tale espulsione ha riguardato le fasce sociali basse e medie (che nel frattempo col turismo fanno i loro affari affittando appartamenti a breve termine), ma sta togliendo il respiro ai diseredati, agli ultimi, che si accalcano nei “bassi” e negli appartamenti più sfortunati delle aree ancora non appetibili, sulle quali tuttavia gli appetiti progressivamente si estendono. Diseredati e ultimi che pure costituiscono l’esercito dei manovalanti, sfruttati e malpagati, dell’industria turistica.
Verso gli ultimi, la guerra è in atto, su vari livelli. Sul fronte del diritto alla casa, innanzitutto: l’eclissi dell’edilizia residenziale pubblica e il ricorso diffuso e insistente a sfratti esecutivi hanno creato una pletora di famiglie in disagio abitativo legato alla mancanza di lavoro sicuro e tutelato.
L’altro livello di espulsione è fondato sul securitarismo, ed ha vari gradi di incisività: arredo urbano a carattere disciplinare (panche prive di schienale, dissuasori di sedute, catene e catenelle etc.); cancellate a chiusura dei portici di città, da secoli luoghi di pronta accoglienza per erranti; diffusione di illuminazioni in stile carcerario delle strade “calde” e la loro parziale militarizzazione. Infine, ultimo solo cronologicamente, il Daspo urbano: atto di «una guerra senza quartiere ai marginali d’ogni risma» che estende all’intera città le misure vigenti negli stadi, in nome della sicurezza e del decoro urbano.
Ciò che sconcerta è che il Daspo incide proprio sulle aree turistiche: mendicanti, poveri, diseredati, rom, “clandestini”, venditori “abusivi”, antagonisti, punkabbestia, dissidenti, graffitari, lavavetri, saltimbanchi e cantastorie rischiano infatti un «provvedimento di allontanamento» per condotta non consona al decoro delle aree urbane su cui insistono – eccoci al turismo – «musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici» (art. 5, comma 2, lett. c, del decreto Minniti del febbraio 2017).
È stato scritto che con il Daspo «Lo Stato Sociale si trasforma in Stato Penale»: l’attribuzione in capo ai sindaci della potestà di istituire un recinto turistico, un divieto ad personam di accesso alla città, corrisponde infatti all’abbandono della lotta alle diseguaglianze sociali dando l’avvio a una nuova battaglia, di stampo liberista, in favore dei privilegi proprietari.
Quali strumenti mettere in atto per confermare la tradizione di inclusività delle città storiche? Come restituirle alla cittadinanza espulsa? Come liberarsi dalla monocoltura turistica?
All’ostinato servilismo degli amministratori nei confronti delle multinazionali del turismo, alla gestione urbanistica ridotta a mera ragioneria, alla coincidenza tra città storica e Mercato, l’alternativa – almeno dal punto di vista urbanistico – risiede innanzitutto nella messa a fuoco del progetto comune sullo spazio comune (che ha interesse culturale globale), nell’assunzione di una visione organica delle trasformazioni, degli usi e delle disponibilità sociali degli spazi urbani centrali. Per colmare l’assenza di programmazione e di progettualità, e interrompere quel procedere per singole operazioni legate alle opportunità offerte dal Mercato a Comuni in balìa degli investitori esteri, è necessario far ricorso – e individuarne una possibile evoluzione – ai piani per la città storica messi in atto a partire da Bologna (1969). E, in primis, come nell’esempio appena richiamato, è urgente che l’edilizia residenziale pubblica torni nel cuore città storica.
Se è certamente necessaria una visione programmatoria del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi, ancor più lo è per un utilizzo sapiente e coerente dei grandi immobili pubblici dismessi, affinché caserme, ex conventi, case di mendicità, stabilimenti di manifatture etc. – trasformati in sedi di residenza collettiva, provvisoria e popolare, luoghi di lavoro e di elaborazione culturale – diventino, nei rioni, nuclei, fuochi di urbanità.
Abbandonato il ruolo di servizio alla rendita, le politiche urbane possono finalmente orientarsi verso pratiche di accudimento della città esistente (il centro quanto le periferie), di cura e di recupero, anche in senso sociale. Attraverso l’ascolto della cittadinanza – di quella più avvertita, più critica, e del fermento che agisce nelle città e nei territori dove si elaborano collettivamente forme di resistenza ed esistenza socialmente soddisfacenti e desiderabili – possono essere messe in atto pratiche di ricostruzione dei legami sociali e relazionali in senso ecologico.
Il distacco dal paradigma economicista-finanziario – fondato sul mito della produttività, dell’efficacia, della competizione – costituisce la premessa inaggirabile per questo rivoluzionario “balzo” verso un modello di riproduzione, di cura dell’esistente, di costruzione di sapienti relazioni col vivente tutto.
Il presente testo è la trascrizione del contributo dell’autrice all’incontro “Il selfie del mondo. Indagine sull’età del turismo”, con Marco D’Eramo, Franca Falletti, Ornella De Zordo e Clash City Workers. L’incontro, tenutosi a Firenze il 21 ottobre 2017, è il primo appuntamento del ciclo “La fabbrica del turismo nelle città d’arte: il caso Firenze” organizzato dal laboratorio politico perUnaltracittà e CCW.
Internazionale, 10 Novembre 2017. Le accattivanti soluzioni tecnologiche del Google Urbanism mascherano un urbanistica basata su libero mercato e profitto, dove le decisioni sono determinate dalle domande di mercato. (i.b.)
Un’astuta provocazione? Forse. Ma la Alphabet, la società madre di Google, prende sul serio la questione. I suoi dirigenti hanno accarezzato l’idea di prendere alcune città in difficoltà e di reinventarle sulla base dei servizi della Alphabet: mappe, informazioni sul traffico in tempo reale, connessione wifi gratuita, auto che si guidano da sole e così via. Nel 2015 la Alphabet ha creato una divisione dedicata alle città, i Sidewalk Labs, diretti da Daniel Doctorof, ex vicesindaco di New York e veterano di Wall street.
Il passato di Doctorof fa capire le intenzioni di Google Urbanism: usare i dati per allearsi con immobiliaristi e investitori istituzionali. Da questo punto di vista, Google Urbanism ha poco di rivoluzionario. I dati e i sensori hanno un ruolo secondario nel determinare cosa viene costruito, perché e a quale costo.
Potremmo chiamarla urbanistica alla Blackstone, in omaggio a uno dei più grandi protagonisti finanziari del mercato immobiliare statunitense. Visto che Toronto ha scelto la Alphabet per trasformare Quayside, un’area non edificata di 48mila metri quadrati sul lungomare, potremo finalmente vedere all’opera la natura pseudo-rivoluzionaria di Google Urbanism e la sua resa
alle forze finanziarie che modellano le nostre città.
L’obiettivo a lungo termine della Alphabet è sostituire regole e divieti formali con obiettivi flessibili meno rigidi e basati sui feedback. Parlando di città, anche luminari del neoliberismo come Friedrich Hayek e Wilhelm Röpke erano d’accordo con forme di organizzazione sociale slegate dal mercato. Consideravano la pianificazione una necessità pratica: non c’era altro modo per gestire le infrastrutture o costruire le strade in modo economico. Per la Alphabet non ci sono ostacoli simili: i lussi di dati possono sostituire le regole del governo con quelle del mercato.
Google Urbanism presuppone l’impossibilità di ampie trasformazioni del sistema come per esempio la limitazione del possesso straniero delle proprietà immobiliari. Anticipa la fine della politica, promettendo di usare la tecnologia per far adattare i cittadini alle tendenze globali immutabili come la disuguaglianza crescente.
Queste tendenze significano che, per la maggior parte di noi, le cose peggioreranno. Ma la Alphabet è convinta che le tecnologie possono aiutarci a sopravvivere, per esempio un’app può aiutarci a trovare del tempo libero nelle nostre vite di genitori carichi di lavoro. Indebitarci per comprare un’auto, visto che nessuno ne possiederà più una, non avrà più senso. E l’intelligenza artificiale farà abbassare i costi dell’energia.
È qui che sta la promessa populista di Google Urbanism: la Alphabet può democratizzare lo spazio personalizzandolo grazie ai flussi di dati e ai materiali prefabbricati a basso costo. Ma questa democratizzazione delle funzioni non sarà seguita da una democratizzazione delle risorse urbane. È per questo che la democrazia algoritmica della Alphabet si basa sulla “domanda del mercato”. Poco importa se l’urbanistica della Alphabet non piacerà agli abitanti di Toronto. Il suo obiettivo è impressionare i futuri residenti, per esempio i milionari cinesi che si riverseranno sul mercato immobiliare canadese.
L’urbanistica alla Blackstone continuerà a modellare le nostre città anche quando sarà la Alphabet a smaltire i rifiuti. Google Urbanism è un modo accattivante di nascondere questa realtà.
Più 10 per cento. Da solo, l’ostello con i suoi 85 mila clienti ècome se avesse aumentato del 10% le presenze turistiche, stimate a Mestre in 2milioni e 900 mila l’anno. «A Mestre si viaggia con un più 4% di presenze»,ricorda l’assessore al turismo Paola Mar. Le presenze a Mestre sono passate dai2 milioni e 800 mila del 2015 a 2 milioni e 927 mila del 2016, con un più 4,5%.E la permanenza sale a 1,9 giorni.
Tante le famiglie che approfittano dell’offerta diavere i figli, fino a 18 anni, gratis in camera coi genitori. «I viaggi nellecittà possono essere terribilmente costosi per le famiglie, ma noi lo rendiamoalla portata di tutti», spiega la Wallmann. E prosegue: «Il nostro clientetipico non spende molto tempo nella stanza in albergo, perché ha tanto da farea Venezia e poco tempo per vedere tutto. Il nostro prodotto è essenzialmente ilpernottamento. Non c’è un ristorante o l‘area spa e anche l’attrezzatura dellecamere è molto basic (senza minibar o telefono), perché non si usa la stanzaper nient‘altro che per dormire. Poi si va in città e non si ritorna fino allasera».
Il viaggiatore, aggiunge, «vuole spendere più per mangiare bene, fare loshopping o andare in museo». A beneficio di Venezia, di giorno e di Mestre lasera. Se si trova cosa fare.
Mestre in fermento. Forse l’effetto dormitorio con scelteintelligenti si può evitare. «Noi di AO vediamo una grande opportunità perMestre. Ogni giorno ritornano i nostri ospiti da Venezia e ci chiedono dove sipuò andare per mangiare o dove sono i bar. Siamo contenti di dare suggerimentilocali. Siamo l’inizio del cambiamento a Mestre e vogliamo che tutti nebeneficino», conclude la Wallmann.
Altri 1.900 posti letto. Altri investimenti, austriaci, valore 70 milionidi euro, stanno costruendo di fronte all’ostello altri 4 alberghi per 1.900camere pronte per aprile 2019. Questo significa che tra due anni la degradatavia Ca’ Marcello diventerà distretto alberghiero con 3.900 posti letto.
Cambiamenti e servizi. E cambierà volto. Qualcosa già si muove: bar epizzerie si rinnovano. Actv ha potenziato le corse del bus 4L per Venezia perl’aumento di turisti indotto dall’ostello. Nell’area dei quattro alberghi silavora ad un marciapiede che conduca dentro la stazione. E la città si muove?Molto lentamente.
«Sui servizi stiamo lavorando. Ai commercianti non faccio che ricordare leopportunità . Ci sono nuovi locali aperti tra Corso del Popolo e via Torino»,ricorda l’assessore Mar. «Mi risulta che alcuni commercianti ad agosto abbiamo fattoil loro fatturato solo grazie ai turisti. Ma c’è tanto da fare. Dai menù chedevono essere anche in inglese e in lingue orientali, per esempio, allamentalità generale da cambiare. I primi segnali ci sono, ma il turismo è unaoccasione che Mestre non deve perdere», ricorda. «Noi ci mettiamo gli eventi,come l’Happy Friday».
Salgono a 90 le Frecce da e per Venezia: Due nuove corseFrecciarossa tra Roma e Venezia e due tra Milano e Venezia, portano a 90 icollegamenti con la Laguna. Il Frecciarossa 9402 parte da Roma Termini alle5.35 con fermate a: Roma Tiburtina (a. 5.43 - p. 5.45), Firenze Santa MariaNovella (a. 7.07 - p. 7.15), Bologna (a. 7.50 - p. 7.53), Padova (a. 8.52 - p.8.54), Venezia Mestre (a. 9.08 - p. 9.10) e arrivo a Venezia Santa Lucia alle9.20.
Il Frecciarossa 9415 invece parte da Venezia Santa Lucia alle 9:35 con fermatea Venezia Mestre (a. 9.45 - p. 9.47), Padova (a. 10.01 - p. 10.03), Bologna (a.11.02 - p. 11.05), Firenze Santa Maria Novella (a. 11.40 - p. 11.48), RomaTiburtina (a. 13.08 - p. 13.10) e arrivo a Roma Termini alle 13:20.
Sulla rotta Torino - -Milano - Venezia, una nuova corsa Frecciarossaproveniente da Torino Porta Nuova alle 13.02 è prevista da Milano Centrale alle14:15 con arrivo a Venezia Santa Lucia alle 16:40. Da qui invece la nuovapartenza è prevista alle 12:20 e l’arrivo a Milano Centrale alle 14.45.
Il Frecciarossa 1000 arriva anche a Venezia: I plus del Frecciarossa1000 arrivano anche sulla Trasversale Padana (Torino - Milano - Venezia).Quattro corse che uniscono attualmente Torino, Milano e Venezia beneficiano deivantaggi del prodotto di punta di Trenitalia in previsione anche delle futurevelocizzazioni rese possibili da questa tipologia di convogli.
La città invisibile, 14 novembre 2017. Non c'è da meravigliarsi delle cortesie dell Unesco vero le malfatte fiorentino (come con quelle veneziane). È noto che l'Italia è tra i maggiori contribuente dell'agenzia Onu per la cultura
Camera con vista”, il titolo del romanzo di Edward Morgan Forster, è anche la metafora del viaggiatore inglese che nell’Ottocento, a Firenze o, meglio ancora, a Fiesole, viveva una vacanza più o meno lunga, lontano dalle bruttezze della rivoluzione industriale. “Camera con vista” perché l’élite anglosassone preferiva contemplare il paese da lontano, fantasticando di Beato Angelico e Benozzo Gozzoli, godendo delle nebbioline che celavano dall’alto la vita reale, ma non amava scendere in strada e mescolarsi alla gente comune. Questo comportamento deve avere ispirato la missione Unesco-Icomos a Firenze del 25-27 maggio 2017, di cui ora conosciamo il Rapporto, ben lontano dalle preoccupazioni espresse in una lettera dell’agosto del 2015 indirizzata al Comune di Firenze, per mesi tenuta nascosta dal Sindaco Nardella.
Del resto i “riconoscimenti” (aknowledgements) già spiegano tutto: “L’amministrazione fiorentina è stata estremamente generosa con expertise, tempo e ospitalità. Il Sindaco Dario Nardella, sia formalmente che informalmente, ha prestato un grande interesse al nostro lavoro… Siamo grati a tutti per avere contribuito al successo della missione e per avere reso così piacevole la nostra permanenza”. E ci immaginiamo i nostri due viaggiatori, bon vivant, alloggiati in alberghi di lusso, magari con vista sull’Arno, gratificati dalla buona tavola e dal buon vino, immersi in colloqui, sopralluoghi, visite e passeggiate, perché no, nel centro storico ancorché affollato di turisti, abbacinati dal bello e dalla storia, tardi epigoni dei loro antesignani ottocenteschi. Informati – ci immaginiamo – direttamente o indirettamente anche da molti dei sostenitori delle infrastrutture inutili o dannose, aeroporto e tunnel della Tav in primis. Dei molti comitati attivi a Firenze, solo pochi quelli invitati con due ore contingentate, memorie scritte in inglese e qualche sommario appunto.
Ma veniamo al Rapporto Unesco-Icomos sulle principali questioni fiorentine.
Sull’aeroporto la missione apprezza la riduzione dell’impatto sulle ville medicee, e prende per buono il racconto che solo una frazione marginale dei voli passerà sopra il centro di Firenze. Su tutto il resto tace con un livello di approfondimento degno di un depliant di Toscana Aeroporti. Troppo impegnativo, evidentemente, leggere il parere del nucleo di valutazione della Regione Toscana, le osservazioni dell’Università di Firenze, le 142 prescrizioni della Via non ancora ufficializzate ma tuttavia ben note. Quello che interessa è la property, cioè l’area direttamente tutelata, il resto può andare alla malora.
Ancora più sbrigativo il giudizio sul sottoattraversamento dei treni ad alta velocità che, secondo il rapporto, provocherà solo qualche millimetro di subsidenza e paradossale la conclusione che avalla la serietà tecnica del progetto. Ignora la missione, anche se su questo era stato presentato dal comitato no Tav una memoria scritta, che le prescrizioni della Via, mirate a un approfondimento degli studi ambientali e geologici, sono state rimandate al progetto esecutivo (peraltro difforme da quello originale), vale a dire ignorate con il beneplacito di un osservatorio cieco; e che la maxi stazione sotterranea, diventata nel frattempo mini, è in entrambe le versioni priva di valutazione ambientale. La conclusione che “the proposals have been subject to intensive expert scrutiny by the authorities” appare, perciò, più che superficiale, mistificatoria. Sulla stessa lunghezza d’onda l’apprezzamento della politica che sta svendendo, o facilitando la svendita, di edifici pubblici nel centro storico di Firenze per trasformarli in alberghi o residenze di lusso; politica che, invece, secondo il rapporto assicura la permanenza dei valori culturali e della loro fruizione pubblica.
Un contentino per compensare i giudizi encomiastici: la raccomandazione di non sottoattraversare con una nuova linea della tramvia il centro di Firenze e di ripensare l’idea di un parcheggio sotterraneo in piazza Brunelleschi, a due passi del Duomo. Due progetti demenziali su cui perfino i nostri missionari hanno qualcosa da ridire. Tralasciamo per brevità le altre considerazioni e raccomandazioni che ognuno può leggere sul rapporto on line. Annotiamo solo che vi sono delle blande preoccupazioni per l’eccessiva concentrazione di turisti nel centro storico e per la possibilità che il nuovo aeroporto, con i voli low cost, incrementi il turismo modi e fuggi. Per il resto tutto va bene. Naturalmente il Sindaco Nardella e i corifei della stampa locale hanno lanciato grida di giubilo, con il primo cittadino che ha straparlato di via libera all’aeroporto di Firenze – da chiedersi se avrebbe tenuto in altrettanta considerazione un parere negativo.
Scriveva nel 1855 Cosimo Ridolfi, rivolgendosi agli stranieri che descrivevano la campagna toscana come un grande giardino, che per conoscere tutta la vera Toscana arretrata, arida, scoscesa, moralmente disabitata, bisognava, prendere non le strade maestre della pianura o della dolce collina; e aggiungeva “ed allucinati dal nostro bello, anche gli ingegni più severi si fecero artisti e videro qui l’Eldorado, perché scrutarono la gentilezza dei modi, ammirarono la vaghezza dei siti e lodarono senza chiedere conti a nessuno… perché chi traversa i paesi in posta e scrive le sue osservazioni, non fa, in genere, che dei romanzi”. Come gli epigoni dell’Unesco.
officinedeisaperi.it online, 12 novembre 2017. Nei drammi della periferia romana la testimonianza di ciò che accade quando le politiche dei decisori perde ogni contatto con la quotidianità delle vite vissute dalle persone.
La pianificazione si occupa ormai dei luoghi del consumo; della produttività; del commercio; dell’arte, nella misura in cui è funzionale al mercato; dello sport, laddove è conforme alla possibilità di essere mercificato. I luoghi destinati alla vita di relazione, allo scambio di emozioni e di esperienze, in altre parole la città pubblica, è scomparsa dalle visioni della politica e delle amministrazioni fantasma nelle quali si traduce. I bisogni immateriali degli esseri umani sono schiacciati prepotentemente su una qualsiasi delle chiavi sopra indicate, invitati a trovare la loro falsa realizzazione in uno dei modi attraverso i quali possono essere messi a profitto. Le città non somigliano più neppure lontanamente a quanto ancora la parola “città” prova ad evocare semanticamente in noi. Sono simulacri privi di una qualsiasi forma di vita indipendente dalle leggi della vendita e della compera. Si dice che dal medioevo a oggi ci sia stato un progresso democratico. Qualsiasi centro medievale attesta il contrario. In qualsiasi centro medievale è certamente più ingombrante il potere, ma vi si scorge chiaramente l’attenzione per il luogo della vita comunitaria. Si sente ancora il respiro del luogo ed è facile riscontare l’armonia con il territorio. Nel moderno medioevo delle nostre città, dei nostri quartieri, invece, il potere è certamente meno visibile e ingombrante, ma la sua apparente assenza è compensata da un’assoluta mancanza di senso. Si tratta di luoghi anonimi, che hanno perso il rapporto con i territori che li circondano e sembrano disabitati anche e soprattutto quando sono pieni di gente.
Oggi abitiamo luoghi progettati per non essere vissuti. Ostia è un esempio illuminante in questo senso. È forse l’unico posto di mare al mondo dove non c’è più neppure un pescatore, vale a dire nessun uomo che viva della specificità del suo territorio e questo qualcosa ci dice. È un luogo che ha perso ogni rapporto vitale con il mare che gli vive accanto, svilendone le tradizioni e consumandolo villanamente alla prima parvenza d’estate. Una piccola cittadina che ci ostiniamo a chiamare quartiere, votata a dissolvere la meraviglia in cui potrebbe vivere facilmente se solo lo volesse, o tornasse a volerlo. A Ostia l’insoddisfazione è l’unico sentimento ad avere qualche possibilità di futuro, ma in quanto sentimento, è anch’esso destinato ad essere messo a profitto. Le diverse organizzazioni in odore e in metodo di malavita, non fanno altro che provare a organizzare le uniche relazioni contrastive del vuoto progettuale cui altrimenti quei luoghi sarebbero destinati, da politiche cieche e sovra-determinate. In questo senso non solo vanno comprese, ma persino rivalutate.
In un luogo dove si ha l’abitudine di lasciare carcasse di animali morti lungo la strada, non ce la si può prendere con gli avvoltoi. È normale e persino un bene che ci siano. A Ostia, come ovunque nell’epoca moderna, le istituzioni che hanno determinato il deserto umano che ci circonda a partire dal piano urbanistico che lo rende visibile, non possono avere né l’autorevolezza, né la moralità necessarie, per contrastare l’orrore e promuovere il riscatto.
Sono le istituzioni e le politiche dei “minima moralia” e della “triste scienza” ad aver offeso la vita a Ostia come altrove. Il riscatto è possibile solo con un cambio generale di paradigma, con la restituzione al quotidiano e al territorio della morale universale del profitto. Sembra un passaggio difficilissimo, ma in realtà oltre ad essere l’unico possibile, è anche ampiamente nel novero delle nostre possibilità. È, o potrebbe essere, la semplicità che è difficile a farsi, la soluzione dietro l’angolo. Come il mare a Ostia.
la Nuova Venezia e Corriere del Veneto, 12 novembre 2017. La confusione regna sovrana. Una sola certezza: di proseguire la distruzione della Laguna (Canale dei Petroli) non frega niente a nessuno. Articoli di Silvio Testa e Alberto Zorzi (m.p.r.)
 Di un Governo con le valige in mano perché in scadenza di mandato, solo un ministro, Graziano Delrio (Infrastrutture), ha partecipato al Comitatone per Venezia, che si preannunciava storico e che invece ha partorito il classico topolino, avendo prodotto in assenza di tutti i ministri competenti solo un banale "Documento programmatico di indirizzo" (che sarà mai? ), senza lo straccio di una delibera. Un Comitatino. Tutti si sono dichiarati contenti, anche il presidente dell'Autorità Portuale, Pino Musolino, e il sindaco, Luigi Brugnaro, benché di fatto si siano visti affondare l'idea dell'utilizzo del Canale Vittorio Emanuele per continuare a portare le grandi navi in Marittima, evidentemente destinata alle sole navi più piccole (vedremo quali) e agli yacht, come da anni chiedevano i cittadini mobilitatisi contro un crocerismo incompatibile.
Di un Governo con le valige in mano perché in scadenza di mandato, solo un ministro, Graziano Delrio (Infrastrutture), ha partecipato al Comitatone per Venezia, che si preannunciava storico e che invece ha partorito il classico topolino, avendo prodotto in assenza di tutti i ministri competenti solo un banale "Documento programmatico di indirizzo" (che sarà mai? ), senza lo straccio di una delibera. Un Comitatino. Tutti si sono dichiarati contenti, anche il presidente dell'Autorità Portuale, Pino Musolino, e il sindaco, Luigi Brugnaro, benché di fatto si siano visti affondare l'idea dell'utilizzo del Canale Vittorio Emanuele per continuare a portare le grandi navi in Marittima, evidentemente destinata alle sole navi più piccole (vedremo quali) e agli yacht, come da anni chiedevano i cittadini mobilitatisi contro un crocerismo incompatibile.
«No Navi al Tar e alla Corte dei Conti: Comitatone illegittimo. Il ministero: tutto regolare»
Si dice «combattivo, non arrabbiato». Ma i suoi legali, in primis l’ex sindaco di Genova Giuseppe Pericu sono già al lavoro sull’esito del Comitatone e sulla scelta di Marghera per il futuro delle grandi navi. «Noi avevamo già scritto prima a tutti i membri, contestando l’iter, ma non ci hanno ascoltati e ora siamo pronti a fare i ricorsi», dice Cesare De Piccoli, ex viceministro dei Traporti, proponente con la società Duferco del progetto Venis Cruise 2.0, che prevede un terminal di scalo alla bocca di Lido, in modo da tenere le grandi navi da crociera fuori dalla laguna: da lì verrebbero infatti portati all’attuale Marittima con delle motonavi di ultima generazione, senza smog e senza moto ondoso.
Un progetto che l’Autorità portuale, già con Paolo Costa e ora anche con il nuovo presidente Pino Musolino, ha bocciato senza appello: quest’ultimo ha presentato al ministero un’analisi «multicriteria» che ha visto il Venis finire sempre all’ultimo posto in cinque classifiche diverse, mentre a vincere è stata l’ipotesi del Canale industriale nord, sponda nord, sposata dal governo e dal ministro Graziano Delrio. Ed è questo il primo punto che non va giù a De Piccoli. «Di questo studio non sappiamo nulla, non siamo stati interpellati - ironizza De Piccoli - ma questa procedura ha violato il decreto Clini-Passera (quello che per primo ha avviato la ricerca di vie alternative al passaggio davanti a San Marco, ndr ): in primis perché l’individuazione delle ipotesi, come avvenuto nel 2013/2014, spettava alla Capitaneria di Porto e non all’Autorità portuale, poi perché non tiene conto della commissione Via, massimo organo tecnico dello Stato». Via che ha promosso, seppur con prescrizioni, il progetto Duferco, mentre, in una fase preliminare, aveva sollevato dubbi su Marghera.
Dubbi che lo stesso De Piccoli fa propri, non prima però di una premessa. «La scelta di Marghera in un certo senso ci aiuta, perché si ammette la possibilità di un terminal diverso dalla Marittima e con il coinvolgimento di privati, che sono due critiche fatte dal Porto nel ricorso al Tar contro la nostra Via - dice - Addirittura quello è un progetto su terreni privati, mentre il nostro sarebbe su area demaniale. Per questo chiedo a Musolino di ritirare il ricorso». Ma la critica all’ipotesi Marghera è tecnica: «Sul canale nord ci stanno due navi, così hanno detto - dice De Piccoli - e le altre 2-3 necessarie per replicare l’attuale Marittima dove le mettono? Cosa succederà quando nei sabato e domenica estivi le grandi compagnie vorranno portare le navi da 140 mila tonnellate? Ci sarà una lotteria?». C’è poi il problema dell’accessibilità nautica: «La Via ha già detto delle cose: ci sono interferenze con i traffici nautici, criticità ambientali, rischi della zona industriale». In realtà su quest’ultimo punto la Capitaneria si era espressa di fronte a «coni di rischio» che poi sono stati aggiornati. De Piccoli boccia anche il Vittorio Emanuele, previsto da Musolino nella fase transitoria. «Il piano regolatore portuale prevede una profondità di 11 metri e una cunetta di 80 - dice - Ma questo significa che ci passano al massimo navi da 30-32 metri, non certo le “medie” di cui si parla. Ma di fronte a questo scenario le compagnie sono d’accordo? Io non lo credo».
Al Tar e alla Corte dei Conti sono pronti ad andare anche i No Nav, che venerdì si sono riuniti in assemblea. «Al momento del voto era presente solo il ministro Delrio e non è stato possibile, per mancanza del numero legale, approvare una delibera, ma solo un anomalo “Documento programmatico” - dicono - Valuteremo dei ricorsi per bloccare decisioni assurde e pasticciate». Dalle Infrastrutture nessuna replica ufficiale, ma solo la sottolineatura che ogni ministero era rappresentato da un delegato e che c’erano stati numerosi incontri preparatori.
Corriere del Veneto, 12 novembre 2017. Una dura critica al "project finanzing all'italiana (paga sempre il contribuente), e un consiglio: cancellare il CVN, padrone del Mose
Venezia. Dell’immane lavoro dei commissari sul Mose «ancora non si vedono i frutti», ammette; avverte che «i project financing possono creare un danno enorme alle casse pubbliche» e quando sente ripetere la solfa che la sua authority sta ingessando i lavori pubblici, sbotta: «Il problema della corruzione è diventato il problema dell’anticorruzione. Un clima preoccupante».
Il presidente dell’Autorità Anticorruzione Raffale Cantone è come Mr Wolf di Pulp Fiction: risolve problemi. Dopo quelli di Expo e Mose, l’Anac affronterà anche i risarcimenti per le banche venete e a breve dirà la sua anche sulla terza convenzione tra la Regione e Sis sulla Pedemontana Veneta.
Presidente, un emendamento alla legge di stabilità presentato da alcuni senatori veneti incarica l’Anac di gestire il costituendo Fondo per le vittime dei reati finanziari. Ha già indicazioni sui criteri di risarcimento?
«In realtà non ne so nulla. Come presidente dell’Anac, invece, presiedo il collegio arbitrale che dovrà decidere i risarcimenti ai titolari di obbligazioni subordinate di Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti e CariFerrara. Ci è stato detto che ci sarà un’estensione alle due venete ma per le obbligazioni subordinate. Mai saputo di risarcimenti per le azioni».
Anac si sta invece occupando del Mose, attraverso i commissari del Consorzio. Ci sono problemi di cassa, di pagamento delle rate del prestito Bei, i cantieri sono fermi, Mantovani è in crisi con 260 lavoratori e accusa i commissari di avergli tolto 100 milioni di lavori. Cosa sta accadendo?
«A metà degli anni Duemila la Commissione Europea ha verificato che c’era stata una totale restrizione della concorrenza e si decise che una serie di opere dovessero essere assegnate con appalti. Cosa che non è avvenuta con la precedente gestione e i commissari ritengono che le opere ora debbano andare a gara per rispettare il quadro di regole concordate con la Commissione. Non so se Mantovani ha ragione ad avanzare le sue rimostranze ma l’ingresso dei commissari ha portato alla necessità di rispettare le indicazioni europee».
I commissari fanno un sforzo enorme per capire meccanismi, leggere le gestioni passate, rimettere in asse il concessionario unico. Eppure non si vede ancora la luce, sul Mose.
«Non si vedono ancora i frutti del commissariamento, sono d’accordo. Il Consorzio gestiva soldi pubblici con la logica di rappresentare le imprese, una situazione di conflitto di interessi. Era una macchina che poteva marciare solo con un certo autista e quando questo è cambiato ed è diventato indipendente, si sono creati problemi enormi. La difficoltà sta nel dover continuare nella struttura del Consorzio ma nel rispetto delle regole. La situazione è oggettivamente entrata in crisi».
Sta dicendo che sarebbe opportuno eliminare il Consorzio Venezia Nuova, il concessionario unico?
«Non spetta a me dirlo. Ma è un ginepraio che richiede interventi legislativi, l’anomalia del Consorzio deve essere risolta in maniera politica. Il ministero deve decidere se questo meccanismo ha le condizioni per andare avanti. Pochi giorni fa ho parlato con Delrio, col quale c’è totale sintonia, per capire quale strada intraprendere per uscire dall’impasse: una soluzione va trovata e il Mose va ultimato».
Il rispetto delle regole sta creando problemi alle imprese: giovedì il presidente dell’Ance veneta Ugo Cavallin ha chiesto a Renzi di sospendere il codice degli appalti, la norma che vieta rapporti con la pubblica amministrazione a chi ha una condanna in primo grado e ha detto che l’Autorità Anticorruzione ha determinato una paralisi.
«Anche l’Ance nazionale ha chiesto la sospensione del codice con toni di una durezza inaudita. Sembra che il problema della corruzione sia diventata l’anticorruzione! Vorrei si usassero toni così accesi quando emergono fatti gravi di corruzione come quelli del Mose, anche cacciando i corruttori dalle associazioni di categoria. Per quanta riguarda l’esclusione delle imprese con condanna di primo grado, l’Anac ha raccolto un suggerimento del Consiglio di Stato ma riguarda solo reati di particolare gravità. L’Autorità è nata per spostare l’asse dalla repressione penale alla prevenzione amministrativa. Se le regole ingessano, qual è l’alternativa? Le mani libere? Non mi pare che leggi che hanno consentito di avere le mani libere come la Legge Obiettivo abbiano accelerato le opere pubbliche e anzi hanno favorito il malaffare».
La scorsa primavera lei aveva espresso dubbi sul terzo contratto tra Regione e concessionario Sis sulla Pedemontana. Ora l’atto è firmato e i bond sono stati collocati. Anac ha tratto le conclusioni?
«Ci sono alcune perplessità di cui daremo conto all’esito di un’istruttoria che sta per essere chiusa. Uno dei prossimi Consigli sarà dedicato alla Pedemontana e l’Autorità farà sapere a breve cosa ne pensa dell’atto aggiuntivo. In generale, il partenariato pubblico-privato, che funziona negli altri Paesi del mondo, da noi si sta rivelando un meccanismo a rischio. I Project nascono come libri dei sogni spacciati come fattibili. Ma poi vengono riportati a terra dai fatti quando le opere vengono iniziate, e con l’alibi che non possono non essere concluse, si chiede al pubblico di intervenire cambiando le regole del gioco. Le casse pubbliche rischiano di avere un enorme esborso dall’accoglimento di progetti sbagliati».
Dario Franceschini è un ministro che ama molto gli annunci. Anche se la materia prima degli annunci non è molto consistente. Di recente ha convocato una Conferenza sul paesaggio anche se i piani paesaggistici co-pianificati, prima sotto Renzi e poi sotto Gentiloni, si riducono alla miseria di 3 appena su 20 e la Giunta di centrosinistra della Sardegna sta cercando di smantellare gli eccellenti piani salvacoste della Giunta Soru (pure di centrosinistra) coordinati da Edoardo Salzano nel 2004, attaccando pure frontalmente l’ottimo soprintendente sardo che si oppone a quel disastro. Sulla legge detta “sfasciaparchi” in discussione al Senato e che indebolisce palesemente i Parchi Nazionali non ha trovato mai il modo di emettere un accenno di critica e di difesa della valida legge-quadro Cederna-Ceruti del 1991 con la quale sono stati creati ben 19 Parchi Nazionali oggi semiabbandonati a se stessi quando non frammentati.
Video e testo dell'intervento inviato all'incontro dell'Assemblea popolare per la democrazia e l'uguaglianza. Bologna, 10 novembre 2017.
.
La città
In un formato abbastanza sintetico un programma di lavoro per rendere il mondo più vicino a quanto ci piacerebbe che fosse. A Tomaso non è dispiaciuto
Città, territorio, urbanizzazione, territorio urbanizzato, habitat dell’uomo. La città è la forma che ha assunto, in una determinata fase della storia dell’umanità, l’insediamento della società (delle società) sul territorio: una forma caratterizzata dalla spiccata densità della popolazione, dalla forte intensità delle relazioni tra i suoi abitanti, e dalla parallela consistenza delle trasformazioni fisiche e antropiche del suolo (al limite “la repellente crosta di cemento e asfalto” A. Cederna).
Nel tempo, la contrapposizione tra città e territorio rurale, dove dominava ancora la natura e le trasformazioni erano lente, si è affievolita. IL processo di espansione della civiltà urbana si è esteso molto al di là dei confini delle città, investendo parti via via più ampie del territorio del pianeta Terra. In gran parte del mondo, la condizione urbana, un’espressione di Manuel Castell per indicare una situazione socio-economica, politica e culturale, oltre che fisica, investe e comprende il territorio. Il termine “territorio urbanizzato” può volta per volta essere adoperato sia per indicare questa condizione, che travalica i confini della città tradizionale, che per identificare l’area interessata dal processo di urbanizzazione e trasformazione fisica del suolo.
Gli esseri viventi continuano a insediarsi in modi diversi e non sempre secondo quella densità di relazioni che contraddistinguono la città. Ma gli insediamenti sono sempre il risultato di un rapporto particolare tra essere umano e la natura circostante, con tutte le implicazioni che questo comporta. Per enfatizzare l’importanza di questo rapporto, nel parlare della città, del territorio e degli insediamenti umani in generale, si può usare l’espressione “habitat dell’uomo” di Piero Bevilacqua.
2. Il blocco edilizio: l’appropriazione privata della rendita urbana
“Il blocco edilizio” è il titolo di un geniale saggio di Valentino Parlato (il Manifesto, 1970, oggi su eddyburg), e di una realtà sociale, tutta italiana, che ha ostacolato, e continua a ostacolare, i tentativi di governare efficacemente il territorio e la società che lo abita. Questa analisi della produzione edilizia e delle stratificazioni che ne fanno parte o ad esso subordinate, mette in luce la saldatura tra interessi privati, (grandi e piccoli, industriali e commerciali), poteri pubblici e rendita immobiliare che caratterizzano l’affare casa in Italia e detta legge nelle scelte urbanistiche e di pianificazione del territorio.
Allo stesso livello di analisi, si pone la successiva analisi di Walter Tocci sul trionfo della rendita, nell’età del finanzcapitalismo (L’insostenibile ascesa della rendita urbana, 2008, oggi su eddyburg. Questo saggio mette in luce le ulteriori trasformazioni avvenute nella città neoliberista con finanziarizzazione dell’economia, che ha rafforzato l’intreccio tra rendite finanziarie e rendite immobiliare, a scapito del salario e del profitti.
L’esistenza della rendita immobiliare e della sua continua crescita in relazione alle trasformazioni quantitative e qualitative delle diverse porzioni della città esprime una caratteristica peculiare e un’anomalia di fondo. La rendita, quando gli interessi ad essa legati sono dominanti, fa si che il perimetro della città si allarghi indipendentemente dalle reali necessità delle comunità che ci vivono e che i suoli edificabili a fini privati prevalgano su quelli destinati ad usi collettivi. L’anomalia sta nel fatto che gli attori che provocano gli aumenti di rendita, in virtù delle trasformazioni apportate nell’area, sono generalmente collettivi e spesso pubblici, mentre l’appropriazione del suo effetto (l’incremento della rendita) è individuale e generalmente privato.
3. il conflitto di fondo: città della rendita o città dei cittadini
Dalla definizione della città come habitat dell’uomo, e peso che ha nelle sue trasformazioni l’appropriazione privata della rendita, nasce il conflitto di fondo che caratterizza la città. Occorre domandarsi se le sue trasformazioni (fisiche, funzionali, proprietarie, fruitive) devono essere dominate dalla logica dell’accrescimento dei benefici economici ottenibili attraverso la loro privatizzazione, oppure da quella del suo miglioramento qualitativo in relazione ai bisogni della società che la abita?
4. Che cosa deve essere la “città dei cittadini?
Se vogliamo combattere davvero la città della rendita non possiamo fermarci agli slogan: dobbiamo raccontare che cosa vogliamo nel concreto. Dobbiamo esprimere un’ immagine chiara di ciò che vogliamo. Proviamo subito a farlo, ma rendiamoci subito conto che il nostro racconto sarà parziale: sappiamo quello che vorrebbero le persone che hanno avuto modo di esprimere le loro esigenze, non sappiamo che cosa vogliono i giovani di oggi, e gli abitanti di domani e come dobbiamo comporre queste esigenze con quelle già note. Proviamo a elencare alcuni requisiti, già emersi nelle esperienze degli adulti e degli anziani, delle donne e dei bambini, degli operai e degli impiegati.
Una città bella perché equa: una città in cui siano presenti tutti i luoghi e i servizi necessari al di là dell’uscio della propria abitazione, distribuiti sul territorio in modo che siano raggiungibili da tutti quale che sia il loro reddito. Una città nella quale , accanto alle aree trasformate e rese artificiali c’è la maggiore quantità possibile di suolo naturale per mantenere l’adeguato approvvigionamento di acqua, cibo, e contatto con la natura. Una città senza barriere né recinti, fisici o sociali che siano: che faciliti le relazioni tra le persone e i gruppi sociali diversi, in cui l’identità delle singole parti non cancelli né impedisca il colloquio tra le diversità, e anzi lo stimoli. una città che consenta agli esseri umani di mantenersi in salute, facendo fronte all’inquinamento sempre più grave e a una produzione di cibo, la cui qualità oggidipende dal quanto ciascunopuò spendere. Una città che consenta agli altri essere viventi, animali e piante, di vivere in armonia con gli umani. Una città capace di razionalizzare la propria produzione di merci per tornare a dare alle merci un valore d’uso più che di scambio e consentire una riduzione degli sprechi e dei rifiuti. Una città capace di decidere del proprio futuro attraverso la pace e il dialogo, seppure lungo e strenuante, e aperta alla collaborazione e cooperazione con i territori vicini e non in competizione con essi.
5. Le regole necessarie per trasformare il territorio
La città e le sue trasformazioni possono essere il risultato di una somma di eventi individuali oppure possono essere guidate da una o più politiche pubbliche. La prima soluzione, almeno a partire dall’epoca dell’affermazione del capitalismo si è rivelata fallimentare.
D’altra parte si è rapidamente compreso che la vita urbana richiedeva una forte integrazione tra la collocazione sul territorio delle diverse sedi per la vita e le attività degli uomini e gli strumenti della connessione fisica.
È nata così l’esigenza di far precedere le singole trasformazioni del territorio (insediamenti residenziali, industriali, commerciali, strutture per i servizi collettivi, infrastrutture per il trasporti delle persone, delle merci ecc.) da un inquadramento complessivo generalmente costituito da una rappresentazione fisica del territorio e delle trasformazioni desiderate) e da un testo normativo, capaci nel loro insieme di trasmettere ordini o divieti ai singoli utilizzatori/trasformatori del territorio.
La prima legge urbanistica italiana degna di questo nome è quella dell’ agosto 1942.
Essa statuiva, o confermava da leggi precedenti, alcuni principi di notevole rilievo, che si sono in gran parte smarriti nel tempo: il primato del pubblico sul privato nelle decisioni sulle trasformazioni del territorio, la multiscalarità, la facoltà del pubblico di espropriare le aree necessarie all’espansione senza riconoscere ai proprietari l’aumento di valore dei loro beni.
Negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, quando l’esigenza di ricostruire ciò che la guerra aveva distrutto e governare la trasformazione della struttura economica da prevalentemente agricola a prevalentemente industriale, avrebbero richiesto il massimo impiego della pianificazione urbanistica e territoriale, queste invece furono totalmente abbandonate.
La struttura generale della legge è rimasta pressoché immutata, salvo le importanti modifiche intervenute dopo l’istituzione della Repubblica e nella metà degli anni Sessanta del secolo scorso. Gli standard urbanistici
Un progresso decisivo nella legislazione urbanistica italiana (purtroppo molto meno nella prassi) è stata l’introduzione degli standard urbanistici: cioè della regola che ad ogni abitante spettasse il diritto di godere dell’uso di una determinata porzione di spazi pubblici e di uso pubblico (6 agosto 1965). Questo evento va segnalato con una forte sottolineatura per molte ragioni:
1. perché è la prima affermazione, nel sistema legislativo italiano, del “diritto alla città” (Henri Lefebvre, 1967), bandiera per i movimenti che a partire da quegli anni hanno operato per il miglioramento della condizione urbana, attraverso la richiesta di servizi e spazi ad uso collettivo ed accessibili a tutti da sottrarre alla logica della rendita;
2. perché è un risultato raggiunto grazie all’incontro fecondo tra forze sociali -esprimenti esigenze diverse (donne, studenti, classe operaia, intellettuali), ma confluenti - di radicali mutamenti nell’organizzazione dell’habitat dell’uomo;
3. perché costituivano un primo passo verso l’affermazione che la città e un “bene” e non una ”merce”, caratterizzata da una logica “comune” e non “individuale;
3. perché poneva alcune basi essenziali per il miglioramento concreto delle condizioni di vita di tutti gli abitanti della città.
6. La città e la società del benessere
Quella che abbiamo sommariamente decritta –e si è affermata in Italia dal dopoguerra in avanti raggiungendo il suo più elevato grado, negli anni Settanta e Ottanta - può essere definita la “città del benessere”. Essa è uno degli elementi di una società che gode anch’essa dello stesso attributo.
Città del benessere e società del benessere sono il frutto della medesima politica, della quale abbiamo a lungo goduto i frutti senza renderci conto che, se ci sono dei frutti, devono esserci delle radici e chi le annaffia e le nutre, a che se in una parte del mondo ci sono dei guadagni in un’altra parte ci sono delle perdite.
Vivevamo nel mondo del capitalismo (quello privato in una parte del mondo e quello di Stato in un’altra: in modo differenziato sotto molti profili al di qua e al di là della “cortina di ferro” e a seconda del differente grado di maturazione del capitalismo e dei suoi conflitti, ma sostanzialmente in modo migliore che nel resto dl mondo.
Là dove si era consolidata la città del benessere, e si abitava meglio, quelle stesse lotte che avevano contribuito a raggiungere questo risultato avevano condotto a ottenere risultati importanti e positivi (per chi poteva goderne) anche su altri terreni: il lavoro, la condizione delle donne, la tutela della salute e della vecchiaia e quella dell’ambiente.
Si trattava della città e della società nelle quali il compromesso tra i diversi gruppi sociali antagonisti (a partire dalle classi) segnava la conclusione di ogni conflitto.
Ma la storia insegna che il sistema capitalistico non è regolato da una logica dialettica perfetta. Il conflitto tra “tesi” e “antitesi” non si risolve in una “sintesi”, che assorbe e compensa gli interessi dell’una e dell’altra: essa si è di fatto risolta non “risolvendo” le contraddizioni, ma “esportandole”.
Ecco allora che, quando il bilanciamento tra la forza contrattuale della classe sfruttatrice nei confronti della classe sfruttata diminuiva, ecco allora che la prima allargava i confini dell’area dello sfruttamento. Ecco allora manifestarsi le varie fasi dello sfruttamento ad altri paesi, altre regioni, e altri settori, prima di allora esclusi, o solo relativamente coinvolti, nell’area del sistema capitalistico.
7. A Lampedusa
Una mattina ci siamo svegliati, e le contraddizioni del nostro modello di sviluppo sono diventate palesi, anche se moltissimi tentano ancora di evitare il confronto con la realtà. Centinaia di persone sono morte, affogate nel Mediterraneo, perché il nostro benessere era stato pagato da un meccanismo che, attraverso le varie fasi dello sfruttamento delle risorse altrui, aveva trasformato le loro regioni in inferni, dai quali tentavano di scappare.
La morte nei nostri mari, a pochi passi da noi, di quelle persone ha posto la domanda del perché fuggivano sapendo dei grandissimi rischi da affrontare. La risposta ha fatto comprendere, a coloro che se la sono posta, che il prezzo del nostro benessere era stato pagato con l’impoverimento dei popoli di cui avevamo rubato le risorse: a cominciare dagli uomini resi schiavi agli albori del colonialismo, per proseguire con l’estrazione dal suolo dei loro minerali e del loro petrolio, per proseguire ancora con la sostituzione delle nostre colture industriali ai loro regimi alimentari, con la distruzione delle loro culture e delle loro lingue, con la sostituzione del nostro imperialismo ai loro poteri, delle nostre lingue alle loro. E’ la truffa della parola “sviluppo” utilizzata per giustificare lo sfruttamento di popoli e risorse situati su territori lontani, in nome di una cultura superiore, più “sviluppata”.
Sviluppo non significava aumento della nostra capacità di ascoltare e comprendere gli altri, qualunque lingua essi adoperassero, utilizzando insieme cervello e cuore: significava solo aumento della produzione e consumo di merci, aumento della ricchezza di chi produceva e induceva a consumare merci sempre più inutili , sacrificando per una merce inutile ma fonte di maggior ricchezza il produttore a un bene che veniva distrutto (un bosco antico per qualche tonnellata di legname, una città storica per una marea di turisti, un paesaggio di struggente bellezza in una selva di palazzoni o una marea di villette).
Questo sviluppo, da un obiettivo è diventata una religione, una credenza cui tutti si inchinano obbedienti. In nome di questo sviluppo abbiamo invaso, saccheggiato, distrutto altre regioni e altri popoli, abbiamo trasformato paradisi in inferni da cui fuggire. E alla fine del ciclo abbiamo trasformato i fuggitivi da nostri simili in cerca di salvezza in nemici da abbattere.
8. I nostri doveri nei confronti del mondo
Il primo passo che dobbiamo compiere è diventare consapevoli del fatto che la miseria e la disperazione degli inferni del mondo sono fortemente dipendenti dalle decisioni prese nel nostro mondo – e dalla credenza dello “sviluppo” che abbiamo accettato e praticato. I passi successivi si chiamano accoglienza, cittadinanza e una politica estera profondamente diversa.
Accoglienza: i migranti vanno accolti e aiutati a mettersi in salvo, costruendo canali protetti per chi vuole fuggire, sconfiggendo le azioni malavitose che si generano attorno alla domanda di fuga. E non solo tragitti organizzati fisicamente con vettori adeguati, ma politiche di assistenza sanitaria e sociale, alle quali l’Europa deve contribuire a dare il suo sostegno.
Cittadinanza: non assimilazione e omogeneizzazione ma riconoscimento agli stranieri degli stessi diritti e doveri degli italiani, nel rispetto delle differenze culturali e religiose. Significa predisporci noi stessi a diventare diversi da quello che siamo: di diventare noi stessi meticci (se già non lo siamo).
Politica estera: una politica indipendente e incerniera sulla pace e su aiuti umanitari genuini, non legati a meccanismi di sfruttamento di risorse locali, favoreggiamento di interessi economici nazionali, o ricatti politici.
9. Un nuovo modello di sviluppo
Esiste una stretta correlazione tra il modello di sviluppo dominante, l’impoverimento economico e sociale della nostra società, le devastazioni ambientali entro e fuori i nostri confini, e i flussi migratori indotti provenienti dai paesi del Sud del mondo verso il Nord. E chi maggiormente subisce gli effetti negativi di questo sviluppo sono le persone più povere, fragili e molto spesso coloro che meno hanno contribuito a provocarli.
La parola sviluppo è quella che forse più di ogni altra è stata capace di plasmare un’epoca. Per oltre settant’anni, il concetto di sviluppo come sinonimo di progresso, civilizzazione, e positività a priori (senza il bisogno di qualificare lo sviluppo con un attributo) ha orientato le politiche di tutti i paesi del mondo e colonizzato le menti, impedendo ad altre concezioni di essere approfondite e altre pratiche di essere attuate.
Nei decenni successivi c’è stata una progressiva sovrapposizione tra sviluppo e “sviluppo economico” compiendo una forte riduzione dei significati complessi e che il termine comprende. Così come ci sono stati tentativi di riabilitare la parola stessa nei suoi momenti di crisi, per esempio durante il momento di presa di coscienza ambientale, di preoccupazione per la scarsità di risorse e lo sfruttamento sfrenato della natura.
Se questa coscienza ha introdotto l’importante concetto di “limite alla crescita”, la nozione di sostenibilità - che invece ha vinto - ha matrici diverse. Infatti, quest’ultimo concetto è avvolto da una “modernizzazione ecologica”, dove l’innovazione tecnologica riveste un ruolo centrale. Si riconosce una crisi ecologica, ma a differenza del movimento radicale sul limite della crescita si crede fermamente di poter interiorizzare la cura per l’ambiente.
10. Lo sviluppo: una credenza
La caratteristica peculiare dello sviluppo, e dell’immaginario che lo accompagna, è che la crescita e il progresso possano svilupparsi all’infinito, anche grazie all’aumento costante delle merci prodotte. Ma, come scrive Gilbert Rist, l’egemonia dello sviluppo si è potuta affermare solo grazie ad un’illusione semantica, attraverso la creazione del sottosviluppo, cioè creando uno “pseudo contrario” che ha trasformato una credenza in senso comune, e facendo credere nella possibilità di trasformare l’intero mondo ad immagine e somiglianza.
Invece, a distanza di 70 anni ci ritroviamo un pianeta caratterizzato da profonde diseguaglianze socio-economiche, in cui lo sfruttamento delle risorse naturali e la protezione dei capitali e dei profitti dei grandi investitori sta provocando espulsioni di lavoratori, agricoltori e residenti non abbienti da un numero sempre più consistente di aree e progressivamente deteriorando l’ambiente fisico, sociale e culturale in cui viviamo. Queste contraddizioni non sono esportabili all’esterno del suo core (la società nord-atlantica), ma colpiscono il suo stesso bacino sociale e le misure adottate dai governanti sono tali da aggravare la crisi anziché mitigarne gli effetti.
Occorre superare il paradigma dello sviluppo e dell’infinita e indefinita produzione di merci, poiché è una produzione indipendente da ogni valutazione delle loro qualità intrinseche in funzione del miglioramento dell’uomo e della società. L’economia “data”, (vogliamo alludere con questo termine al fatto che questa non è né l’unica economia storicamente esistita né l’unica possibile), va radicalmente trasformata. Due paradigmi a cui appellarci, per esplorare, indagare, studiare e sperimentare un nuovo sistema socio-economico, sono quello dei “beni comuni” e della “città come bene comune”.
Per cominciare, una nuova visione del mondo e dell’economia, radicalmente diversa da quella nel cui ambito viviamo da troppi secoli. Non è uno sforzo né semplice né breve, ma se la distanza tra il mondo attuale e quello che vogliamo costruire è grande, grande, determinato e costante dovrà essere il nostro impegno.
Occorre anche essere pronti a superare l’eurocentrismo, che ha prodotto una sorta di inamidatura dei modi di vivere, produrre, consumare, rapportarsi agli altri. In questo senso, l’ondata immigratoria può costituire una risorsa e un’opportunità di rinnovamento della civiltà europea, nord-atlantica e globale. La globalizzazione, se intesa in questo senso di commistione, condivisione, confronto, dialogo e sintesi (al plurale) di modi di vivere e concepire diversi, diventa un’occasione di innovazione ed emancipazione.
11. Una nuova visione del lavoro
Un nuovo modello di sviluppo richiede una revisione del concetto e visione del lavoro.
Nell’economia capitalistica, esiste una immensa quantità di lavori necessari per la sopravvivenza e il miglioramento delle condizioni di vita che non vengono effettuati, perché il Mercato non li considera utili (non producono né profitto né rendita). Esiste insomma una enorme domanda insoddisfatta di lavoro. Pensiamo alla ricostituzione dell’integrità fisica dei terreni non urbanizzati, alla ricostituzione del reticolo idrologico, ai rimboschimenti, allo sviluppo di un’agricoltura articolata secondo le diverse potenzialità e le diverse domande alimentari. Pensiamo alla ristrutturazione edilizia e urbanistica delle lande urbane devastate dalla speculazione. Pensiamo a una ricostruzione dei sistemi per la mobilità non più basati su modalità energivore e inquinanti. Pensiamo alle dotazioni di spazi pubblici articolati in relazione delle esigenze, delle loro caratteristiche.
Il lavoro è qui inteso come l'insieme delle attitudini fisiche e intellettuali che esistono nella corporeità, ossia nella personalità vivente d'un uomo, e che egli mette in movimento ogni volta che produce valori d'uso di qualsiasi genere (K. Marx). Il lavoro, quindi, deve essere utilizzato dall’uomo non solo in relazione soltanto alla sua propria sussistenza e riproduzione, ma a qualsiasi fine socialmente utile e produttore di valor d’uso a cui egli ritenga utile applicarlo, comprendendo tra tali attività tutte quelle finalizzate alla ricerca della verità, della bellezza, della comunicazione di se stesso e alla comprensione degli altri, mediante l’impiego di tutti gli strumenti espressivi impiegabili.
Naturalmente, ciascuno di tali impieghi del lavoro dovrebbe essere retribuito nella misura necessaria per continuare a svolgerlo. È l’economia, in altri termini, che deve essere subordinata al lavoro, non il lavoro all’economia. Il contrario di ciò che avviene nel sistema capitalistico.
12. E nell’immediato che fare?
In una simile nuova economia la distribuzione delle risorse tra le possibili opzioni alternative avverrebbe (e noi speriamo, avverrà) in modo del tutto diverso che nell’attuale Mercato (l’oligopolio costituito da un gruppo di poche decine di padroni del mondo delle finanze). Ma nel frattempo occorre porsi due domande:
1. come reperire le risorse finanziarie necessarie per soddisfare l’enorme domanda insoddisfatta di lavoro di cui abbiamo detto, retribuendo adeguatamente la forza lavoro che dovrà esservi impiegata?
2. come difendere quello che di positivo è rimasto?
13. La spesa militare come risorsa finanziaria
La risposta alla prima domanda è facile. Basta pensare alla gigantesca mole di risorse impegnata per realizzare opere inutili e spessissimo anche dannose, la cui realizzazione è motivata solo, o prevalentemente, da interessi economici dei promotori e realizzatori. E basta pensare alla quantità di risorse, non solo finanziarie, dissipate per convincere il consumatore che questo prodotto è utile ed è diverso da quest’altro Basta infine alla dimensione degli sprechi causata dalla “obsolescenza programmata” degli oggetti d’uso corrente.
Ma vogliamo porre l’accento su un’altra spesa gigantesca, e per di più terribilmente nociva per l’umanità: le spese militari.
L’Italia nel 2017 spenderà per le forze armate almeno 23,4 miliardi di euro (64 milioni al giorno), più di quanto previsto. Quasi un quarto della spesa, 5,6 miliardi (+10 per cento rispetto al 2016) andrà in nuovi armamenti (altri sette F-35, una seconda portaerei, nuovi carri armati ed elicotteri da attacco) pagati in maggioranza dal ministero dello Sviluppo economico, che il prossimo anno destinerà al comparto difesa l’86 per cento dei suoi investimenti a sostegno dell’industria italiana. La sovrapposizione delle competenze di due ministri (Difesa e Sviluppo economico) aiuta a comprendere le ragioni dell’opacità delle informazioni provenienti dalle fonti ufficiali italiane (I dati che qui riportiamo provengono dall’istituto di ricerca svedese SIRTI).
Le spese militari italiane sino in aumento costante dal 2.000. Nell’ultimo decennio italiane sono cresciute del 21 per cento – del 4,3 per cento in valori reali – salendo dall’1,2 all’1,4 per cento del Pil.
Il 70 % della spesa è costituita dalle spese per il personale, in massima parte costituito da graduati. Ciò aiuta a comprendere l’ampiezza del blocco sociale favorevole al mantenimento della spesa militare ai suoi attuali livelli. C’è infine da osservare che gran parte della spesa per armamenti l’Italia è tributaria di fornitori stranieri.
Questi dati (cui bisognerebbe aggiungere quelli sui numerosi coinvolgimenti di contingenti militari italiani in guerre in altri paesi) rendono stupefacente il fatto che il tema della lotta per la pace sia scomparso dall’attenzione della sinistra.
14. La pianificazione come tutela della città dei cittadini
In attesa di elaborare e rivoluzionare il sistema economico-sociale in cui viviamo (ciò che significa anche sconfiggere alla radice “la città della rendita”) occorre orientare e plasmare il più possibile il sistema in cui viviamo. Lo scopo è chiaro: una tensione verso la “città dei cittadini” attraverso la difesa delle conquiste sociali già ottenute (ma sempre a rischio), della salvaguardia delle risorse ambientali in cui viviamo sfruttando le conoscenze già in possesso, e una promozione dei valori della pace, partecipazione, e diversità culturale.
Alcune questioni che la pianificazione si deve fare immediatamente carico, sapendo che ciascuna di esse richiede una lotta contro la rendita e i poteri che la difendono:
1. sovranità e qualità alimentare. I cambiamenti climatici in corso e il deterioramento dell’ambiente naturale pone l’alimentazione come una sfida non solo per i paesi poveri, ma anche per quelli ricchi. L’Italia deve difendere la propria relativa autonomia alimentare non come “marchio Italia” ma come pratica per sostenere una popolazione in salute. L’accesso a tutti a una alimentazione sana e di qualità deve diventare una priorità non solo per le politiche sociali, ma anche per le politiche economiche e territoriali. Il “ritorno alle terra” sentito da molte nuove famiglie e individui dovrebbe essere incoraggiato e sostenuto.
2. la salute ambientale, dalla tutela della qualità dell’aria e dell’acqua, alla difesa da erosioni, alluvioni e terremoti attraverso una politica di vera prevenzione e non di emergenza, come quella che ha caratterizzato l’Italia negli ultimi decenni.
3. Una nuova stagione di politiche pubbliche urbane e territoriali nelle quali siano posti al centro il valore d’uso e un’idea ampia di cittadinanza ponendo l’attenzione sugli standard (aggiornati e ampliati per rispondere ai nuovi bisogni) e al connesso sistema degli spazi e servizi pubblici, nonché sulle “piccole opere” di manutenzione, ri-uso e cura dell’esistente.
IB, ES, 10 novembre 2017
la Nuova Venezia e Corriere del Veneto, 11 novembre 2017. «Il sindaco di Venezia ha anche richiesto la costruzione del mini offshore commerciale per navi container a Santa Maria del Mare, un luogo di grande valore paesaggistico, nel cantiere dei cassoni del Mose che per legge deve invece essere smantellato». (m.p.r.)
la Nuova Venezia
Il Comitatone del 7 novembre ha approvato una delibera, che, per sviluppare la crocieristica, reale scopo del Governo, individua ben tre accessi, e forse altri ancora, alla laguna. Unico voto contrario, quello del sindaco Ferro di Chioggia, vero eroe della giornata perché il solo a tutelare la Laguna. Grazie a Delrio, ai comuni di Mira, Venezia, Cavallino - Treporti e Jesolo, a Zaia e ai Ministeri competenti, la Laguna diventa così un colabrodo, un porto diffuso che nemmeno Paolo Costa poteva sognare e che invece gli ambientalisti o semplicemente le persone interessate alla tutela della bellezza e fragilità di Venezia e della sua Laguna potevano immaginare nei peggiori incubi.
Il grottesco è che non si pongono limiti massimi di tonnellaggio, bensì limiti minimi! E non si individua una via di accesso alternativa a quella vietata (come prescriverebbe il decreto Clini-Passera) ma se ne indicano ben tre! Se oggi il limite posto dal decreto sarebbe 40 mila tonnellate ma di fatto è 96 mila, la delibera del Comitatone prevede per le navi sopra (sottolineiamo sopra!) le 130 mila tonnellate l'ingresso per la bocca di Malamocco, il passaggio per il Canale dei Petroli e l'attracco a Marghera, nel Canale Nord; per quelle sotto alle 130 mila tonnellate consente egualmente il transito per il canale dei Petroli e poi per il canale Vittorio Emanuele (da escavarsi, e per cui non c'è nemmeno la certezza della Via!) e l'approdo alla Marittima; per quelle sotto le 40 mila tonnellate conferma l'ingresso per il Lido, il passaggio per il Bacino e l'attracco alla Marittima, di cui ribadisce la centralità.
Ma non solo: per queste navi minori sono possibili anche altri attracchi, forse Chioggia o chissà. Interessante notare che il sindaco di Venezia ha ottenuto che, quale approdo delle grandi navi a Marghera, nella delibera non venisse genericamente indicato il Canale Nord, com'era in bozza, ma precisamente la sponda nord del Canale Nord. Area di più facile accesso da terra, ma privata, e fra le più inquinate di Marghera, trovandovi luogo, un tempo, la lavorazione del carbone. Tempi lunghi dunque e incerto futuro. Certissima invece è la mancanza di limitazione alle dimensioni delle navi, se non quella imposta dalla presenza delle linee dell'elettrodotto, che il sindaco di Venezia durante la seduta ha chiesto venga presto interrato. Nessun limite!
Il sindaco di Venezia ha anche richiesto come necessaria la costruzione del mini offshore commerciale per navi container, probabilmente come vorrebbe il presidente dell'Autorità di sistema portuale a Santa Maria del Mare, un luogo di grande valore paesaggistico, nel cantiere dei cassoni del Mose che per legge deve invece essere smantellato. La Laguna diventerà dunque un porto diffuso per navi commerciali e crocieristiche di ogni stazza e lunghezza, ma prevalentemente di enorme tonnellaggio, assecondando l'imperante tendenza al gigantismo. La Laguna si piega così alle navi e agli armatori. E il canale dei Petroli, artefice della distruzione della laguna, dovrà essere potenziato e verosimilmente raddoppiato e delimitato da scogliere (il progetto c'è già e data al 2013), dovendo accogliere come minimo 1000 transiti navali in più e di navi sempre più grandi.
Ricordiamo che gli studi scientifici, reperibili anche in rete, provano indiscutibilmente che l'erosione di cui soffre il bacino lagunare centrale (vale a dire la voragine ai lati del primo tratto del canale dei Petroli nonché l'atrofizzazione della rete dei canali naturali) è dovuta agli effetti idraulici del canale stesso e al traffico navale che vi si svolge. Secondo le leggi e i piani vigenti, il canale dei Petroli deve essere invece ridimensionato e riconfigurato, riducendone l'impatto negativo. Le Leggi speciali prevedono infatti - come ha ricordato inutilmente con una lettera a Delrio il nostro presidente nazionale - il «riequilibrio idrogeologico dellalaguna», «l'arresto e inversione del processo di degrado del bacino lagunare e l'eliminazione delle cause che lo hanno provocato», e «l'innalzamento delle quote dei fondali determinatesi per l'erosione presso le bocche di porto e nei canali di navigazione».
Rileviamo inoltre che si rischia di imboccare una strada simile a quella presa per il Mose: la decisione di ieri si qualifica come meramente politica, aprioristica, non presa sulla base di un progetto definito (che non è stato presentato), e svincolata da qualsiasi valutazione scientifica. Rileviamo anche l'assoluta mancanza di informazione e trasparenza, per non parlare dell'assenza del dibattito pubblico e della comparazione fra i progetti, da sempre richiesti da Italia Nostra e prescritti dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
Dal Comitatone nessuna tutela della laguna, dunque. E rimarchiamo, oltre all'incredibile assenza del ministro dell'Ambiente, quella del ministro dei Beni e delle attività culturali, Franceschini, che ha presenziato solo alla discussione del primo punto all'ordine del giorno, riguardante la Legge speciale, e non alla discussione del secondo, relativo al problema della crocieristica (nonostante la laguna sia sottoposta alle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Posizione grave, che ci fa intendere come nemmeno dal ministero dei Beni culturali la laguna venga considerata un bene culturale, prima che ambientale, di inestimabile valore.
Lidia Fersuoch è Presidente della sezione di Venezia di Italia Nostra Venezia
Corriere del Veneto
CROCIERE A MARGHERA, IL NODO DELLE AREE
«I proprietari: aspettiamo le proposte. L’ipotesi dei parcheggi. Il ruolo di D’Agostino»
Venezia. Chiudete gli occhi per un secondo e al posto di quelle due piccole navi nere attraccate proprio in punta immaginate due «grattacieli del mare» da 140 mila o più tonnellate. Canale industriale nord, sponda nord. Qui il governo, con il Comitatone dell’altro giorno, ha deciso che arriveranno le grandi navi da crociera, risolvendo finalmente il problema del passaggio davanti a San Marco, anche se non prima di 3 o 4 anni. Qui, dove una volta veniva stoccato il carbone della Italiana Coke e, nella punta, c’era un’attività di importazione di cemento, e dove ora ci sono terreni deserti e con lavorazioni minime, sorgerà il nuovo terminal crociere: qui, con i due approdi previsti inizialmente, arriverebbero 10 mila crocieristi al giorno.
La linea è tracciata, ora però si apre il percorso tecnico. E il primo problema è quello delle aree. Problema che il presidente dell’Autorità portuale Pino Musolino ha già iniziato ad affrontare in questi mesi, vedendo in gran segreto alcuni dei proprietari, che sono sostanzialmente quattro. La Fabbrica Concimi di Crema è proprietaria proprio dell’area in punta, 25 mila metri quadri con 300 metri di banchina sul canale nord. «Siamo stati contattati dal presidente Musolino alcuni mesi fa e abbiamo dato una disponibilità di massima», dice l’ingegner Nicola Ferrari, della St Srl, professionista veneziano che segue l’azienda lombarda.
Ovviamente il Porto ha, da parte sua, la forza dell’esproprio, qualora il progetto fosse dichiarato di pubblica utilità, come sarà; dall’altro però i privati potrebbero opporsi e andare in tribunale e questo allungherebbe i tempi. Per questo sul tavolo sarebbe stata messa la possibilità di coinvolgerli nell’operazione, lasciando, per esempio, la gestione dei parcheggi. L’idea è infatti quella di un project financing, in cui potrebbe entrare anche Vtp, sebbene ci sia il problema che difficilmente la concessione sarà estesa in automatico dalla Marittima al terminal di Marghera e dunque si ripartirà da zero con una gara europea o comunque sarà prevista nell’ipotesi di project .
C’è poi la questione dei tempi. Delrio e Musolino hanno parlato di 3-4 anni, pensando a un anno per la progettazione e le procedure burocratiche - soprattutto per le bonifiche, visto che non dovrebbe essere prevista la Via - e poi 2-3 per la realizzazione. St Srl aveva già fatto una bozza di progetto, in cui veniva prevista una spesa di 62 milioni di euro e 630 giorni tra iter e realizzazione, ma solo per attrezzare la banchina, chiudere i marginamenti e dragare il canale industriale nord, dove andrebbero le navi, che ha una quota di appena due metri. Qui i fanghi dovrebbero essere abbastanza «puliti», a differenza di quelli del canale Brentella, dove ci sarebbe qualche problema in più. Ci sarà infine da gestire il rapporto con Roberto D’Agostino e l’Ati che, proprio su quella stessa area, ha protocollato una proposta di project financing da 250 milioni: difficile far finta che non esista.
la Nuova Venezia
«RICORSO AL TAR CONTRO
IL VOTO DEL COMITATONE»
Le varie anime del comitato No Grandi Navi si sono ritrovate ieri pomeriggio in Sala San Leonardo per discutere sulle decisioni assunte dal Comitatone martedì scorso. Un dibattito acceso, che ha accompagnato una disamina approfondita della situazione e l'annuncio di un'assemblea cittadina il 2 dicembre sempre in Sala San Leonardo e, una settimana dopo, a Marghera. Prima, una delegazione del Comitato andrà in Sovrintendenza per chiedere un incontro urgente con il ministro Franceschini e in Capitaneria di Porto, perché - come spiegano - l'ordinanza transitoria prevista dal documento del Comitatone durerà dieci anni.
la Nuova Venezia
CROCIERE A CHIOGGIA
cittaconquistatrice.it, 8 novembre 2017. Articolo del 1938 che già usava la parola sprawl per indicare la dispersione suburbana, individuandone abbastanza chiaramente i rischi: ambientali, socioeconomici, di sviluppo locale. (f.b.)
il Fatto Quotidiano, la Nuova Venezia, la Repubblica, Corriere del Veneto, 8 novembre 2017. Comitatone: tutti i portatori di interessi rappresentati tranne uno: la Laguna. Articoli di Giuseppe Pietrobelli, Alberto Vitucci, Francesco Bottazzo, Francesco Furlan, con postilla
il Fatto Quotidiano
GRANDI NAVI
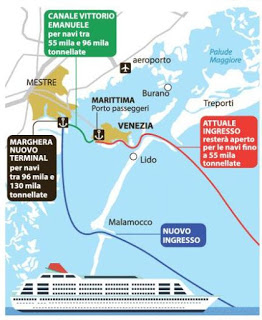 Il ministro Graziano Delrio, non senza una certa enfasi, a conclusione del Comitatone per Venezia, annuncia: “Le grandi navi non passeranno più dal canale della Giudecca e dal Bacino di San Marco”. Frase non nuova, a cinque anni dal decreto Clini-Passera che aveva imposto lo stop al transito dei grattacieli del mare a due passi dagli storici palazzi del capoluogo lagunare. In questo arco di tempo i transatlantici, con il loro carico di migliaia di turisti, non hanno cessato di imperversare nelle acque della Serenissima, causando notevoli danni alle fondamenta e all’ecosistema. E puntualmente molti altri ministri hanno annunciato che il traffico sarebbe stato dirottato lontano dal cuore più sensibile di Venezia. Delrio ha anche fatto una previsione cronologica. “Tutte le navi oltre le 55 mila tonnellate nell’arco di 3-4 anni andranno a Marghera”. Il che significa che per quasi dieci anni dal decreto che le aveva messe fuorilegge, il via vai delle imbarcazioni non cesserà. Anche perché l’arrivo fino a Marghera potrà essere garantito solo da importanti lavori di scavo dei canali già esistenti.
Il ministro Graziano Delrio, non senza una certa enfasi, a conclusione del Comitatone per Venezia, annuncia: “Le grandi navi non passeranno più dal canale della Giudecca e dal Bacino di San Marco”. Frase non nuova, a cinque anni dal decreto Clini-Passera che aveva imposto lo stop al transito dei grattacieli del mare a due passi dagli storici palazzi del capoluogo lagunare. In questo arco di tempo i transatlantici, con il loro carico di migliaia di turisti, non hanno cessato di imperversare nelle acque della Serenissima, causando notevoli danni alle fondamenta e all’ecosistema. E puntualmente molti altri ministri hanno annunciato che il traffico sarebbe stato dirottato lontano dal cuore più sensibile di Venezia. Delrio ha anche fatto una previsione cronologica. “Tutte le navi oltre le 55 mila tonnellate nell’arco di 3-4 anni andranno a Marghera”. Il che significa che per quasi dieci anni dal decreto che le aveva messe fuorilegge, il via vai delle imbarcazioni non cesserà. Anche perché l’arrivo fino a Marghera potrà essere garantito solo da importanti lavori di scavo dei canali già esistenti.«Dalle prime indiscrezioni che giungono da Roma sembra che l’avevamo vista giusta. I distruttori della Laguna vogliono continuare con le loro opere assurde e devastanti» è il commento a caldo di Luciano Mazzolin, del Comitato No Grandi Navi. «Vogliono approvare la peggiore soluzione possibile, con attracchi a Porto Marghera per le navi da crociera più grandi (che oggi non entrano in Laguna) e per le altre navi da crociera (superiori alle 40.000 tonnellate di stazza) il passaggio attraverso il canale Vittorio Emanuele per arrivare ancora in Marittima». Secondo gli ambientalisti, questa soluzione, se realizzata, avrà effetti devastanti sull’equilibrio lagunare, penalizzerà la portualità commerciale e la vocazione industriale e manifatturiera di Porto Marghera, ma avrà anche «oggettivi ostacoli per lo sviluppo prevedibile e sostenibile delle grandi navi da crociera a Venezia». E’ per questo che No Grandi Navi preannuncia azioni di mobilitazione, sulla scia del referendum che in primavera ha bocciato l’ingresso delle navi in Laguna e che a settembre ha creato una rete dell’ambientalismo europeo a tutela dei territori.
Il ministro Delrio ha spiegato: «A regime le grandi navi andranno tutte nel canale nord di Marghera. Non ci saranno interferenze con il traffico commerciale. Le due realtà possono coesistere in questa fase transitoria fino a quando il terminal di Marghera sarà attrezzato. Metteremo in campo una nuova determinazione dell’autorità Marittima per disciplinare il traffico temporaneo con nuovi criteri che tengano conto di tutte le variabili architettoniche, paesaggistiche e ambientali per preservare al massimo la laguna. Continuiamo a studiare ed esplorare la possibilità di sfruttare gli attuali canali perché non se ne scavino di nuovi”.
La via di transito sarà quindi il canale di Malamocco, come ha spiegato il sottosegretario Pierpaolo Baretta: «Dopo anni di incertezze siamo giunti a una decisione capace di proiettare Venezia e l’intera laguna nel futuro. La soluzione rappresenta un punto di equilibrio tra tutela ambientale, sviluppo territoriale e attività imprenditoriale”.
la Nuova Venezia
GRANDI NAVI A MARGHERA
Venezia. Grandi navi a Marghera, in canale Industriale Nord, sponda Nord. Stop al Vittorio Emanuele, per cui vanno fatti ulteriori studi per risolvere le criticità degli scavi e analizzarne i rischi. Centralità della esistente Stazione Marittima, ma solo per le navi «medio-piccole». Il Comitatone ha approvato ieri a Roma la delibera di intesa sulla soluzione al transito delle navi in bacino San Marco, a cinque anni e mezzo di distanza dal decreto Clini Passera.
la Repubblica
VENEZIA, GRANDI NAVI VIA DA SAN MARCO
Corriere del Veneto
GIGANTI DEL MARE A MARGHERA
«Giganti del mare via da San Marco. Lo ha deciso il Comitatone riunito ieri a Roma. Nell’arco di tre anni, attraverso il canale di Malamocco, andranno a Marghera tutte le navi da 130 mila tonnellate. Il ministro Delrio ha spiegato che non ci saranno interferenze con il traffico commerciale. «Le due realtà possono coesistere in questa fase transitoria fino a quando il terminal di Marghera sarà attrezzato». Archiviata definitivamente quindi la soluzione Contorta-Sant’Angelo del 2014 «per mancanza di presupposti». Reazioni positive, dal sindaco Brugnaro al governatore Zaia. Ma è scontro con gli enti locali sulla Marittima».
Roma. Ancora per tre o quattro anni le grandi navi da crociera passeranno davanti a San Marco, ma con nuovi limiti, non più basati sul tonnellaggio (e quindi sulla grandezza) ma sulla qualità (se cioè inquinano meno e sono più sicure). Poi, quelle più grandi, da 130 mila tonnellate, faranno tappa a Marghera. Le più piccole, quelle che passano già ora, continueranno ad arrivare alla Marittima entrando in laguna però dalla bocca di porto di Malamocco, costeggiando le fabbriche e percorrendo il canale Vittorio Emanuele che dovrà essere scavato.
Il governo ha deciso – condividendo la posizione con il Comune, la Regione e l’Autorità di sistema portuale di Venezia e Chioggia – di mettere un tetto alle crociere davanti a San Marco, ma ha lasciato la porta aperta sul canale Vittorio Emanuele, su cui servono ulteriori approfondimenti, da fare velocemente, compresa l’assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. «Dopo tanti mesi di studio abbiamo trovato una soluzione vera per un attraversamento sostenibile della laguna senza penalizzare una presenza turistica importante per Venezia», dice soddisfatto il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio al termine del Comitatone (il comitato interministeriale per la salvaguardia di Venezia), a cui hanno partecipato anche il ministro ai Beni culturali Dario Franceschini, il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, i sindaci di Venezia, Cavallino, Mira, Chioggia e Jesolo, il governatore del Veneto, il presidente del Porto e il provveditore interregionale alle Opere pubbliche. L’ultimo era stato l’8 agosto 2014, quando fu deciso di valutare tutti i progetti alternativi al passaggio delle navi a San Marco.
D’accordo, serviranno studi e probabilmente anche la Via (anche se si tratterebbe solo di scavi limitati: dai 7,5-9 metri ai 10,5 necessari), ma difficilmente verrà messo da parte. Del resto nel documento finale votato all’unanimità (tranne dal sindaco di Chioggia) si parla chiaramente di centralità dell’esistente stazione marittima per le navi di dimensione medio-piccola. L’importante è che «non siano scavati nuovo canali», ha precisato il ministro. «Dopo anni di incertezza - commenta Baretta - siamo giunti finalmente a una decisione capace di proiettare Venezia e l’intera laguna nel futuro». «Finalmente c’è un piano di lavoro - ha commentato il governatore del Veneto Luca Zaia - La Marittima sarà destinata ad accogliere il turismo luxury che porta valore».
la Nuova Venezia
Roma. Chioggia torna da Roma con un gruzzoletto importante della Legge speciale, ma con forti timori sulla crocieristica. Il sindaco Alessandro Ferro potrà contare a breve su 3 milioni di euro di risorse legate alle annualità 2016 e 2017 e successivamente su altri finanziamenti di 1.5 milioni all'anno. «Sono risorse importanti», spiega il sindaco, «che dovremmo subito mettere a frutto prevedendo progetti veloci per evitare che finiscano negli avanzi di amministrazione. I primi 3 milioni dovrebbero arrivare entro fine anno, ci metteremo subito in moto. Abbiamo anche ottenuto promesse importanti sull'alleggerimento dei vincoli del Patto di stabilità che non ci permettono di utilizzare i 60 milioni di euro di residui di Legge speciale che abbiamo fermi in deposito. Ci saranno alleggerimenti progressivi, per usare piccole parti delle risorse accantonate, fino alla liberalizzazione totale nel 2021».
postilla
Questi chiacchieroni che straparlano su Venezia e Laguna non hanno compreso che l'una e l'altra si stanno degradando irrimediabilmente per tre motivi: (A) perché l' aggressione provocata dal turismo, ricco e povero che sia è incompatibile con le dimensioni, la delicatezza la fragilità delle carattristiche fisiche della città; (B) perché gli effetti del turismo sono devastanti per la struttura sociale della città; (C) che la ragione prima della distruzione della Laguna è nella costruzione del Canale dei Petroli, che infatti mezzo secolo fa si era deciso di eliminare. Se lo avessero compreso non continuerebbero nel proporre interventi "salvifici" tutte le soluzioni "tutelatrici" che: (1) non riducono di uno il numero dei turisti; (2) consolidano e raddoppiano il Canale dei Petroli.
Su la Repubblica di oggi Il grande fotografo Gianni Berengo Gardin esulta perché alle Grandi navi verrebbe impedito il passeggio dinnanzi al Palazzo ducale e Piazza San Marco. I vedutisti dunque hanno vinto. Ma Venezia e la sua Laguna corrono verso la distruzione.
The Guardian, 31 marzo e 31 ottobre 2017. Mentre si sta completando un grande progetto di rinnovamento di spazi pubblici, avanza la demolizione in massa di case economiche che sfratterà circa un milione di abitanti. (i.b)
Il centro della città di Mosca si sta rinnovando attraverso un grande progetto di riqualificazione urbana denominato “Moja Ulitsa” che significa “La mia via”. Lanciato nel 2014 dall’amministrazione comunale sta completando la realizzazione di 50 nuovi parchi, la risistemazione di 50 km di strade e piazza, 12 lungofiumi, e il restauro di moltissime facciate storiche, con progetti del Design Strelka e alcune star dell’architettura mondiale.
 |
| Uno dei lungofiumi riqualificati dal programma "La mia via" Fonte: Russia Beyond |
 |
| Una delle strade rinnovate dal programma "La mia via" Fonte: Russia Beyond |
 |
| In primo piano i "khrushchevka" da essere demoliti, sullo sfondo i nuovi edifici Fonte: The Guardian |
 |
| Il sistema prefabbricato di un edifico costruito nel 1961. Fonte: The Guardian (Getty Images) |
All’approvazione della demolizione i residenti hanno 90 giorni di tempo per evacuare e trovarsi un altro alloggio. Sono circa un milione le persone coinvolte nel programma di demolizione dei palazzi sparsi in diverse zone della città.
Con il sostegno del presidente Vladimir Putin, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha dichiarato il programma una "necessità assoluta" per poter sostituire le vecchie abitazioni. Mentre per molti abitanti questa è un operazione di pura speculazione, in cui i soldi hanno il sopravvento su qualsiasi altra cosa. I residenti sostengono che, pur non essendo perfetti e avendo bisogno di essere ristrutturati, sono solidi. Inoltre non solo rappresentano un pezzo di storia ma danno un senso di appartenenza a comunità di quartier consolidate nel tempo. Non vogliono trasferirsi in nuovi grattacieli costruiti in zone a loro estranee. Perchè nonostante le promesse dell’amministrazione sarà difficile che gli abitanti potranno rimanere in zona.
 |
| Uno dei "khrushchevka" in procinto di essere demolito Fonre: The Guardian |
Gli articoli del Guardian, qui sotto ripresi, documentano questo processo.
La seconda operazione riguarda la completa riqualificazione dei cortili residenziali. L'ufficio del sindaco sostiene che questi spazi, situati all’interno di grandi complessi, non dovrebbero essere dei passaggi pubblici aperti di collegamento, ma devono diventare degli spazi privati.
L’amministrazione è in procinto di adottare entro la fine dell’anno nuove norme regionali di pianificazione urbana che dividono per la prima volta i quartieri residenziali in aree private e pubbliche. Gli accessi al piano terra ai negozi e attività aperte al pubblico avverrà solo dalla strada per consentire che le corti di diventare degli spazi di “comfort” con accesso riservato e solo pedonale. Qui il link a un articolo del Russian Reader . (i.b.)
MOSCOW'S BIG MOVE: IS THIS THE BIGGEST URBAN DEMOLITION PROJECT EVER?
di Alec Luhn
Finally his turn came, and he and his wife were given a two-room flat at 16 Grimau Street. Built in 1957, the four-storey, 64-flat building is considered the first “Khrushchevka”, a kind of prefabricated, low-rise flat block that was erected in the tens of thousands across the USSR and came to be called after then-Soviet leader Nikita Khrushchev (The colloquial term has come to apply to almost any late Soviet five-storey residential building.)
Now 16 Grimau Street, along with up to 7,900 other Soviet flat blocks in Moscow, are to be torn down, in what will be one of the largest urban resettlement programmes in history. With the backing of the president, Vladimir Putin, Moscow mayor Sergei Sobyanin has declared the programme an “absolute necessity” to replace ageing housing. He promised the replacement flats would be 20% larger on average.
To Rudakov, however, it is just another example of profit taking precedent over heritage. “This is the first housing block that Khrushchev built. They don’t have any regard for this now,” he said of his home. “Money comes before anything else.” He added that he didn’t “know why Putin said” to tear such flat blocks down. “The building is good, the walls are thick.”
 |
| Yevgeny Rudakov, che vive in quello che è considerato il primo "krushchevka", costruito nel 1957. Fonte: Alec Luhn /The Guardian |
Furthermore, the federal legislation to give the Moscow city government power to knock down entire neighbourhoods has worrying implications for the rights of residents and small-business owners. Residents who do not sign an agreement to transfer ownership of their flat within two months will be taken to court. “They are forcing people out, like under Stalin,” said activist Lena Bogushch.
Opposition activist and former MP Dmitry Gudkov noted that the legislation would allow the government to tear down not just Soviet prefabricated flat blocks, but also nearby “analogous” buildings. When asked about how the fate of nearby buildings would be decided, the author of the law, MP Mikhail Degtyaryov, recently told TV Rain that a city commission would simply “take a neighbourhood and circle” the whole thing for demolition.
“The law allows the programme to be realised not in the interests of residents, but in the interests of the construction lobby,” Gudkov said.
Since Sobyanin came to power in 2010, Moscow has tackled several huge urban development projects. It has refurbished Gorky Park, opened the Moscow Ring Railroad, and started a 120bn-rouble (£1.4bn) renovation of one million sq metres of streets. It has encouraged the demolition and redevelopment of gigantic Soviet industrial areas.
But the programme to renovate five-storey buildings, as the city euphemistically calls it, will be by far the largest undertaking yet. Although the city has yet to list the buildings that will be demolished, Sobyanin has promised that 25 million sq metres of residential real estate – more than 10% of the city’s housing stock – will be torn down. An estimated 1.6 million people will be resettled. The city says it will spend at least 300bn roubles, and independent experts have estimated the actual investment will be 3tn roubles.
It’s not clear what kind of buildings will replace the Soviet housing. Moscow’s chief architect declined to comment, and the mayor’s office asked for written questions but failed to answer them.
 |
| Il Soviet costruì circa 200 milioni di metri quadrati di appartamenti tra il 1933 e il 1970. Fonte: The Guardian (skyNext/Getty Images/iStockphoto) |
Thus began a three-decade housing drive that was unprecedented in human history. It ushered in a new, industrial approach to construction: several different designs for prefabricated flat blocks were tried out in the Cheryomushki neighbourhood, where Rudakov lives, as was a residential district layout – minimising through-traffic and maximising green space – that would be repeated throughout the country.
Working mostly with concrete panels and other factory-produced components, brigades of labourers competed to see who could put together the huge flat blocks the fastest. One team managed it in 11 days. According to the Russian state statistics service, the amount of housing built by the state jumped from 26.9 million sq metres during the second five-year plan (1933-37), to 152.2 million sq metres in 1956-60 and 227.6 million sq metres in 1966-1970. Between 1955 and 1964, a quarter of the Soviet population, or 54 million people, received their own flats. By 1975, the state had built 1.3bn sq metres of housing, and it continued to build in huge amounts up until the Soviet breakup.
For the first time, large numbers of people had private housing in the city. This huge resettlement marked a boost in quality of life, a change in living habits, and a cultural shift that was commemorated in works including Dmitry Shostakovich’s operetta Cheryomushki, named after the neighbourhood where the first Khrushchev flats were built. “Look the hallway is ours, look the coat rack is ours! The whole flat is ours, ours! The kitchen too is ours, ours!” sang the main characters in a 1962 film based on the operetta.
According to Olga Kazakova, an art history PhD student and director of the Institute of Modernism, one theory is that along with Khrushchev’s de-Stalinisation policies, the privacy allowed by Khrushchevka flats contributed to the rise of dissident activity, such as samizdat (the copying and passing of banned literature by hand), in the 1960s.
In addition, the new housing was fairly low-density, and its common areas and green space facilitated socialising among neighbours, according to Nikolai Yerofeyev, a philosophy student at Oxford who is writing his dissertation on postwar Soviet housing. He also owns a flat in a Khrushchevka that will probably be torn down.
Of course, such mass-produced housing had drawbacks. The height of functionalism, Khrushchevka were architecturally monotonous: rectangular, five-storey boxes with evenly spaced windows, balconies and staircases. The ceilings were low and single-room flats were typically only 30-33 sq metres, while two rooms were 33-45 sq metres. Lifts and trash chutes were shunned as a costly extravagance. There were complaints about sound isolation and heating in the wintertime. Some included strange innovations, such as a small niche beneath the kitchen window, separated from the outside by only a few centimetres, meant to function as a refrigerator in the cold months.
The five-storey buildings were designed to last about 25 years. Most have served longer, with mixed results. Retired dentist Sofa Shkolnik, who lives with her husband, Felix, in a five-storey flat block built in 1962, said she is warm in the winter and can barely hear the neighbours. The building, which is surrounded by green space with apple, cherry and pear trees and several playgrounds, is on a tentative list of blocks to be torn down. Shkolnik fears they will be resettled to a high-rise building or moved far away from their daughter, granddaughter and great granddaughter, who all live nearby (the city has promised to resettle residents within their districts, but some of these cover large, incongruous areas).
 |
| La famiglia Shkolnik nel loro soggiorno Fonte: The Guardian (Alec Luhn) |
But Felix said the sewage drainage system had not been replaced and had burst a pipe twice in the past decade. “We’re on a state of alert in case it breaks in another place, because the utilities are old,” he said, adding that he had recently drilled into the concrete panel wall to find it was disintegrating.
Sobyanin argued that the five-storey buildings are too difficult to renovate, since the pipes for plumbing and central steam heating are built into the wall. “Even if we do some sort of renovations in these buildings, in 10 to 20 years they will nonetheless turn into hazardous housing,” he told Komsomolskaya Pravda newspaper.
The quality and condition of five-storey buildings varies widely. While many were built with concrete, others were built with bricks, which are typically sturdier and more heat-efficient. The most dilapidated Khrushchevka buildings in Moscow have already been torn down, according to Yerofeyev. He called the programme an attack on “low population density, [which] apparently is too big a luxury in Moscow now”.
“The argument that they are in bad condition structurally is not convincing, especially since there are massive projects to reconstruct Khrushchyovka buildings in eastern Europe,” he said. “There are many methods of how to deal with (ageing prefabricated housing), and of course tearing it down and building a new tower is not the best one.”
n one notable example, Stefan Forster architects in Leinefelde, Germany, knocked down the top floors of eight Soviet flat blocks from the 1970s, stripped them down to their concrete structure and outfitted them with new windows and balconies and ground-floor gardens as part of an urban regeneration project.
Forster said renovation costs depend largely on how much is rebuilt to modern construction standards, such as better sound isolation requirements. “In principle, prefab flat blocks are suitable for conversion to affordable housing,” he said.
But Moscow is reportedly not up to the difficulty and cost of such a task. Earlier this month, the respected business newspaper Vedomosti quoted an unnamed official as saying the city had decided that building new housing would be cheaper than renovating. According to official statistics, half of the residential buildings in Moscow are in need of major structural repairs, and only a few dozen have been redone.
Another reason may be political, as Sobyanin and Putin are both likely to run for reelection in 2018. Political analyst Dmitry Orlov estimated that as long as residents aren’t moved too far away and small business owners are fairly compensated, the new programme could boost electoral support in Moscow by 15% for the mayor and 7% for the president. He based this on how a smaller resettlement programme under previous mayor Yury Luzhkov had “changed public opinion (and) allowed him to preserve a high level of trust over the years”, he said.
Activists’ main complaint is that the programme is mostly about money, and both developers and the city stand to make a handy profit. They point to a recent example of a partially completed programme started in 1999 to replace 1,722 five-storey buildings. For that scheme, the city contracted private developers, who built new tower blocks, set aside 30% of the apartments to resettle residents of the old buildings, and sold the rest. Vedomosti quoted a source in the mayor’s office as saying the new programme will free up a large number of land plots that will be sold to investors at auction.
The devil will be in the detail, and specifically in what kind of housing is built and where; new residential towers in Moscow are often as tall as 25 storeys, leading to less personable neighbourhoods and more traffic congestion. Already, Moscow traffic jams are among the worst in the world. Housing density will almost certainly increase, given that that five-storey buildings now occupy 8,000-10,000 sq metres per hectare, while city norms allow for up to 25,000 sq metres per hectare.
“They haven’t told us what technologies will be used in the new buildings, how they will look, and the quality of modern construction in Russia is not that high,” Kazakova said.
According to Maxim Trudolyubov, editor-at-large of Vedomosti, the programme’s results will depend largely on whether private firms or a state construction company build the new housing. “Private companies will need to sharply increase the amount of square metres that exist in Moscow, “which will choke the city for good with torrents of people and transport,” he wrote in a recent column.
For now, residents face an uncertain future. “Where will they put the people?” asked the Shkolniks’ daughter, Anna. “That makes us uneasy.”
31 ottobre 2017
THE WRECKING BALL SWINGS AT MOSCOW
A PHOTO ESSAY
di Chris Leslie and Jonathan Charley
In June this year, the Moscow Duma unanimously approved the demolition of more than 4,000 apartment blocks in various sites across the sprawling city, home to nearly 2 million people. Most of this housing is privately owned, the consequence of the privatisation of state housing after the collapse of the Soviet Union. It has been a highly controversial decision, bringing thousands of Muscovites into the streets in protest.
 |
| Al centro la serie di edifici "khrushchev" nel quartiere Butirsky che saranno demoliti Fonte: The Guardian |
The prototype
The Fedosovas’ estate is well-connected to the city centre. Essential services – kindergarten, schools, a health centre, transport links – are easily accessible on foot, and their flat looks down on to apple trees, flowers and a children’s play park. It is tranquil, the air is fresh and the development is planned at a human scale. Both Fedosova and her father grew up there; several generations of her family live in nearby flats.
Under the June law, if two-thirds of residents in a block vote yes to the so-called “renovation programme”, the block will be demolished. Fedosova voted no: for her, the demolitions won’t just destroy buildings, but also a sense of history, home and belonging.
Enough yes votes were cast, however, to slate the building for demolition. Once she receives the official notice, Fedosova will be required to leave her home in 90 days, or face forced eviction. She will be given no option of where to live, likely moved to a newly built tower block. The authorities have promised that residents will be rehoused in the same district, but many fear their longstanding networks of families and friends won’t survive the move. Above all, Fedosova fears being exiled in “New Moscow”, the hastily erected towers on the city’s periphery, many of which remain unsold. .
“The attitude towards people is bestial,” she says. “How is it possible to take people and move them to where the authorities want, in high-rise pens with just a patch of greenery in the middle? You cannot treat Moscow and its inhabitants like this. We are not here for the short-term. The city should be built for the comfort of its residents and not developed for the sake of maximising profits at all costs. I’m afraid of the new areas, they are creepy.”
The fix
To counteract the rumours that the renovation programme is really all about profiting from real estate the mayor of Moscow, Sergey Sobyanin, is working overtime to persuade residents that there is no alternative to demolition. His team are busily constructing show flats kitted out with state-of-the-art furnishings. Sobyanin insists that the Khrushchevka flats are beyond redemption: the kitchens are too small, there are no lifts or waste disposal system and the roofs often leak.
Yet many residents maintain nothing is wrong with their flats that standard repairs couldn’t fix. Anastasia Yanchikova is one of numerous residents left exasperated and confused by these explanations.
“I feel safe here. I can see my children in the yard,” she says. “We leave our bikes at the bottom the stairs. I have a right to stay in my neighbourhood. I want to choose myself where to live, in what kind of building, place and so on.
“I feel deceived. Two years ago politicians obliged me to pay into a capital repair fund for the overhaul of our housing that was scheduled to be completed by 2030. They told us that the houses are strong. And then this year the same politicians tell us that our homes are in an emergency condition and need to be demolished?”
Tatjana Goreleva, a lawyer, and her husband say they have invested more than 1m rubles in their apartment, in a five-storey block of robust brick in the Nishegorodsky district. Like Yanchikova’s, her house was also scheduled for major repairs in 2016 that were never carried out. Her anger mixes with suspicion.
“It is as if this has been done deliberately to bring the house into an emergency condition, and to finish off the opponents of demolition and renovation – morally and physically.”
There are undoubtedly problems with some of the older flats; the build quality is variable. Some architects and engineers argue, however, that the faults can be remedied without prohibitive expense. Professors at the prestigious Moscow Academy of Architecture such as Yuri Pavlovich Volchok and architect Evgeny Asse have said that with intelligent design many of the blocks can be given a new lease of life; structural engineer Sofia Pechorskaya notes that the planning process, which she calls “technically illiterate”, has been carried out without proper research and professional consultation.
Vladimir Komarov, a retired government worker, lives in a veritable theatre set of Russian history. His flat is lined with antique green wallpaper, the floors are original hardwood, and he is surrounded by family portraits and clocks made by his horologist grandfather. Three generations have lived here; his grandmother is buried in the cemetery next door. When he received his eviction notice, Komarov had a stroke that put him in hospital for two months. He says he has been loyal to the state all his life, and feels betrayed.
His friend, Vera Voronina, boasts a brand new bathroom, kitchen and living room in her apartment. Over a six-year period, she and her husband saved everything they could and renovated the flat themselves. Though it is nearly complete, the majority of residents in her block voted for demolition, so they will be thrown out.
The residents of their building say their neighbourhood has its own special ecology: it boasts a district heating system and is well served by hospitals, clinics, schools, shops and transport links. Speculation swirls that this is why their apartments face the wrecking ball while other blocks that, they say, are more clearly in need of repairs but more isolated, are left standing.
One option for homeowners is monetary compensation based on what the authorities reckon the flat is worth. But many residents doubt they will receive a fair price. “Since May of this year we have lived as if on top of a powder keg,” says Goreleva. “We do not agree with the renovation program, but to challenge the new laws is not an easy thing to do,” Goreleva adds. “We are law-abiding citizens, and if the state has established the rules on renovation, we are compelled to obey them. But in respect of our home, there has been a clear violation of laws and regulations.”
One of the consequences of the privatisation of the Russian housing sector was that homeowners became responsible for the upkeep and maintenance of their properties. For many people on low incomes who couldn’t afford to invest in repairs and renovations, this became an impossible burden. Vast numbers have voted for demolition having been lured by the prospect of a new apartment. Not surprisingly, the vote has caused considerable friction between friends and neighbours on opposing sides of the debate.
Olga and Vassily Leskova met at school. They have lived in their beautifully appointed apartment for 50 years, and seen their children and grandchildren grow up here. They are distraught at the news of their eviction.. Vassily sums it up in one phrase: “Pure deception.”
For the Leskovas, the vote has meant the breakup of the social foundations on which people have built their lives. The peace and harmony of their block has disintegrated. Arguments and shouting matches have broken out. The atmosphere has become hostile. The required meeting of all the residents to decide on the fate of their block never happened; instead, people voted individually and in secret.
One person who has seen both sides of the story is Tatyana Buyanova, an architect and town planner who lives a 10-minute walk away from the Leskovas with her son. Her picturesque two-storey cottage sits on prime land. A former employee of one of the development companies, Buyanova was involved in the selection of potential sites for new housing in the earmarked “renovation zones”.
Buyanova began to suspect that the urban restructuring programme was more about real estate speculation than any social commitment to improving people’s lives. Some journalists, lawyers and engineers say that building codes – including for light, height and proximity of buildings – are being relaxed, and construction permits expedited. When her own home – which she maintains was in good condition – was included on the demolition list Buyanova resigned and joined the protest movement.
“I can not understand how something that in principle is a good idea turned into a horror and a nightmare,” she says. “My neighbours voted for the demolition. I was against it, but it didn’t change anything. The city will not talk to me. One of the deputies even said, ‘Dissenters must submit!’ My apartment is everything that I hold dear – and now I’m losing it.”
Pavel Novikov, an engineer, lives in the former industrial district of Metrogorodok. His flat is not included in the programme, which he suspects is because the building site is too narrow to be of interest to developers. The blocks either side are coming down.
A member of the Muscovites Against Demolition protest group, he is typical of the activists who are resisting the demolitions. Most are ordinary folk: pensioners, single parents, newcomers to political action. Notably, a majority are women.
“One of the strange things about the protest movement,” Novikov says, “is that it has awakened in Muscovites a sense of having civil rights, and of their ability to oppose the state’s interference into their private lives.”
Certainly the sense of illegal dispossession is palpable, and in the early days of the protests banners were emblazoned with the word “deportation”. Nikolai Kanchov, who ran in the recent municipal elections for the Yabloko opposition party, argues that the forced evictions violate the Russian constitution, which guarantees the right to private property.
“In a nutshell, the demolition program has deprived me of my right to a home,” he says. “It has made me worried and uncertain about the future. I can’t be sure that my family and I won’t be forced out of our home tomorrow by the will of some tricky bureaucrat, greedy for money. I’m forced to study the legislation and collect testimony, write petitions, claims and appeals, gather signatures, all in order to protect my home. Instead of working and earning my living.”
As well as standing for local government, lobbying deputies, and holding street demonstrations and social media campaigns, dissidence has taken other forms. Artem Loskutov and Lucia Stein came to the attention of residents who noticed a new addition to the graffiti in the Basmanny district: plaster casts of a woman’s breasts, glued to five apartment blocks scheduled for demolition, accompanied by the slogan: “I will protect your home with my breasts.”
It made Stein a minor celebrity, and at just 21 years old she has just been elected as an independent deputy for the Moscow municipal government.
The demolition
Photographer Vivian del Rio can stare down, from her current flat, on the partially demolished neighbourhood where she once lived. She still remembers the chaos of moving out: people were still packing their bags as the wrecking crews moved in. Reluctantly, she has accepted a new flat in multi-storey tower.
“The view from up here is good, but I miss the birds and fruit trees, the high ceilings, and the neighbourliness. Also, this flat is poorly built. They wallpapered over cracks in the concrete. The doors were replaced within two months and they cheated me by including my balcony in the overall area of the flat.”
 |
| Anche il cottage di Tatiana Buyanova sarà demolito Fonte: The Guardian |
A kilometre down the road house lies a neighbourhood that will be completely razed. According to the Moscow Development Department’s interactive map, which shows all the properties scheduled for demolition, 80 apartment blocks will be removed in just this one locale. The website also shows the locations of the new replacement tower blocks – and the large area of land that will then become available for sale. Tellingly, it is close to the city centre, and only two stops from fashionable Gorky Park and the Tretyakov gallery. The land will be sold into the private sector; several luxury towers featuring penthouse flats have been built; there is speculation that other plots may be handed directly to banks by struggling construction companies to repay loans.
After the 90-day eviction period, the timing of the demolition itself is not made public, but the process can be rapid: whole blocks have disappeared in a day. In the Butirsky district of north Moscow, you can see the rubble of recently demolished five-storey buildings. From the top floor of one partially evacuated block, an old lady looked out with a smile. The flats either side of hers are already empty, but she doesn’t look in any hurry to move.
In Krilatskoye, in the north-west of the city, furniture is flying out of the frameless windows. In the empty flats, children’s drawings hang from the wallpaper and family photographs lie on the floor. Clothes, shoes and a ceramic print of someone’s grandmother sit in a pile. People have left in a hurry.
On the third floor of what otherwise appeared to be an entirely deserted block, one padded front door remains locked. The inhabitants have pinned a sign to it:
“We live in this apartment. If you don’t understand, take a look at article 139 of the Russian constitution: ‘The violation of the inviolability of the home.”
Chris Leslie is a documentary photographer and film-maker. Dr Jonathan Charley is a writer and teacher at the department of architecture of the University of Strathclyde. You can read more about their Disappearing Moscow project here.
la Nuova Venezia, 4 novembre 2017. Ciò che resta della città storica si sfalda come una nocciolina schiacciata tra due potenti ganasce: le Grandi Navi dall'acqua, i Grandi Alberghi dalla terra. Intanto, la Laguna, con postilla
«Mestre. AO avvia i lavori per il secondo edificio per 300 camere. Gru alte fino a 45 metri di altezza e accordo per il nuovo porticato»
MESTRE. Cinque grandi gru svettano in via Ca’ Marcello nella grande area di espansione dei nuovi alberghi di Mestre. Due grandi braccia metalliche, la più alta arriva a 45 metri, sono arrivate nel “cratere” a fianco dell’ostello della AO per sancire il via al cantiere del raddoppio della struttura alberghiera che nascerà con un nuovo edificio, dalle ceneri dell’ex agenzia delle Entrate, demolita nei mesi scorsi. Come promesso, i cantieri sono veloci: i lavori di costruzione del nuovo complesso alberghiero in via Ca’ Marcello hanno mosso i primi passi con l’arrivo delle grandi gru. Dall’altra parte ce ne sono tre, la più alta arriva a 40 metri, nella grande area ex Demont dove gli austriaci del fondo Mtk corrono per costruire altri 4 alberghi, di fasce differenti.
L’ostello AO è stato aperto alla fine di luglio con 300 camere e un migliaio di posti letto. Dopo la demolizione dell’ex palazzo dell’Agenzia delle Entrate, attiguo al nuovo ostello che attrarre turisti, soprattutto giovani e famiglie del Nord Europa, si va al raddoppio. Richiamati al lavoro gli operai della stessa impresa impegnati a realizzare l’edificio “gemello” per altre 300 camere. Un tunnel sopraelevato, spiega il progettista, l’architetto Sandro Bisà, collegerà i due edifici ma il nuovo ampliamento avrà una propria reception ed uno stile architettonico del tutto identico a quello del primo edificio, nato anch’esso da una demolizione: quella dell’ex officina Vempa.
I due edifici “gemelli”, spiega ancora Bisà, avranno in comune anche il porticato. L’obiettivo di AO è quello di realizzare un porticato in continuità tra i due edifici, che crei un percorso coperto dalla stazione verso l’ostello.
Ma il sedime dell’ex Agenzia delle Entrate, demolita, è arretrato rispetto a quello del vicino ostello in piena attività e di conseguenza la società sta discutendo con il Comune di Venezia per ottenere la disponibilità di una striscia di terreno, di proprietà comunale, per portare il porticato in linea con quello esistente e allungare il percorso coperto in direzione della stazione. A quanto è dato sapere, l’accordo in sostanza c’è già ma mancano una serie di adempimenti burocratici.
Nel frattempo il cantiere comincia a mettersi in moto dopo il rilascio da parte del Comune del permesso a costruire lo scorso mese di agosto e dopo che l’area di cantiere è stata interamente liberata dai detriti della demolizione dell’ex Agenzia delle Entrate, chiusa da anni. Il conto alla rovescia è iniziato: l’obiettivo della AO Hostels è quello di aprire il raddoppio, con altre 300 camere, «entro la primavera del 2019». Dall’altra parte della strada c’è grande fermento anche nel cantiere degli austriaci di Mtk che hanno, con un investimento di 70 milioni di euro, avviato i lavori per costruire quattro nuovi alberghi con due silos parcheggi per 745 nuove camere d’albergo e 1.900 posti letto. Gli edifici cominciano a prendere lentamente forma. I contratti con i nuovi alberghi sono siglati.
Arriveranno in via Ca’ Marcello la anglo-irlandese “Stay City” specializzata nei rent apartment; l’albergo a 4 stelle della catena tedesca “Leonardo Hotels” , del gruppo israeliano Fattal; l’ ostello “Wombat’s” del gruppo City Hostels. E i cinesi della Plateno, gigante alberghiero a cinque stelle che sbarca a Nordest per la prima volta. Aperture in calendario per aprile 2019, ribadusce l’architetto Luciano Parenti.
Via Ca’ Marcello, vista dal cavalcavia di Mestre, cambia ogni settimana. Gli edifici crescono in un’area degradata che sta vivendo un fermento edilizio e di presenze: grazie all’ostello tedesco in due mesi sono passate di qui già 50 mila persone. Un via vai di viaggiatori che si porta dietro l’apertura, verso la stazione, di nuovi bar e pizze al taglio.
postilla
Il Moloch che divora tutto è il turismo. Le Grandi Navi da un lato, adesso si aggiungono i Grandi Alberghi dall'altro. Il movimento di resistenza non si è ancora accorto del parallelismo dei fini e degli effetti: forse la comune lotta contra gli uni e gli altri è una dei possibili legami tra i cittadini dell'una e l'altra parte della città per combattere contro il vecchio che avanza.
Intanto la Laguna (senza la quale Venezia è impensabile) vacilla contro i colpi menati col maglio dell'approfondimento del Canale dei petroli, che vorrebbero consolidare costruendo due argini in c.a. per consentire alle Gransi navi di raggiungere Porto Marghera: quel devastante Canale dei petroli che Parlamenti avveduti avevano imposto dagli anni 1970 di eliminare, per ricostituire l'unitarietà della Laguna.
I veneziani? Gran parte di essi si accontenta di raccogliere con lingue servizievoli le briciole che il Moloch lasca cadere; gli altri, i sopravvissuti, si approssimano a chiedere il regime di "riserva indiana". Potranno così sperare in ottenere una parte della spesa che pagano per far ingrassare il Moloch: sapete che un contribuente veneziano paga, per la sola eliminazione dei rifiuti, 355 € all'anno, contro i 222 dei milanesi, i 212 dei bolognesi, i 160 dei trentini e dei triestini (vedi Repubblica online, AF del 3 novembre)