
«». MicroMega online, 3 luglio 2017 (c.m.c.)
«Siamo giunti ad un sistema che alla luce del sole privatizza i profitti e socializza le perdite». Con una recente intervista in cui dichiarava che alle presidenziali francesi non avrebbe votato «né per la fascista Le Pen né per il liberista Macron» Emiliano Brancaccio aveva diviso il popolo della sinistra.
Ora - a partire dal recente provvedimento del governo che in una notte ha stanziato ben 5 miliardi per il salvataggio di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza - l'economista ragiona sulle contraddizioni del nuovo intervento statale in economia, fatto soprattutto di compravendite a favore del capitale privato. Il mondo intorno a noi si trasforma mentre, secondo lui, in Italia la sinistra si attarda in «una estenuante, ipertrofica discussione sui contenitori politici e ripropone schemi di un ventennio fa, come se nulla fosse accaduto nel frattempo».
Autore di pubblicazioni di rango internazionale in tema di Europa e lavoro, promotore del “monito degli economisti” pubblicato sul Financial Times, Brancaccio è un marxista rispettato anche dai suoi antagonisti teorici. Un bel po’ di gotha della finanza e della politica italiana è venuto ad ascoltarlo pochi giorni fa a Roma, in un seminario organizzato dalla società Vera e dal Foglio sul ruolo odierno dell’intervento statale, al quale partecipavano anche l’ex banchiere centrale Lorenzo Bini Smaghi, il presidente della Commissione Industria del Senato Massimo Mucchetti e il ministro per la coesione territoriale Claudio De Vincenti.
Professor Brancaccio, nella sua relazione introduttiva al seminario di Roma lei ha fornito dati piuttosto sorprendenti sul ritorno dello Stato negli assetti proprietari del capitale globale...
I dati indicano che a livello mondiale, soprattutto in Occidente, dopo la recessione del 2008 si è registrata una quantità enorme di acquisti statali di partecipazioni azionarie in banche e imprese, per un valore addirittura superiore alle vendite di Stato che erano state realizzate nel decennio antecedente alla crisi. E’ un’inversione di tendenza che segna una cesura rispetto all’epoca delle privatizzazioni di massa. Siamo all'inizio di una nuova fase storica.
Quali sono i segni distintivi di questa nuova fase?
Un tempo lo Stato acquisiva i mezzi di produzione per finalità strategiche di lungo periodo, talvolta anche in aperta competizione con il capitale privato. Oggi questo tipo di acquisizioni pure si verifica, ma è un fenomeno minoritario. La maggior parte degli interventi statali odierni rivela un livello senza precedenti di subalternità agli interessi privati dei principali operatori sul mercato azionario. Lo Stato infatti compra a prezzi più alti dei valori di mercato, assorbe le parti “malate” del capitale e poi rivende le parti “sane” prima di una nuova ascesa dei prezzi, in modo da sgravare i privati dalle perdite e predisporli a ulteriori guadagni. Potremmo dire che in questa fase, più che in passato, lo Stato è “ancella” del capitale privato, nel senso che asseconda i movimenti speculativi dei grandi proprietari, li soccorre quando necessario e ne assorbe le perdite. Questo ruolo dell’apparato pubblico è ormai apertamente riconosciuto ai massimi livelli del capitalismo mondiale, proprio per garantire la ripresa e la stabilizzazione dei profitti dopo la “grande recessione” del 2008.
Quali sono le conseguenze di questi continui soccorsi statali a favore del capitale privato?
Nella grande maggioranza dei casi l’intervento dello Stato a favore dei capitali privati implica aumenti significativi del debito pubblico. In prospettiva si tratterà di capire se tali aumenti saranno fronteggiati tramite nuovi tagli al welfare oppure attraverso una stagione di “repressione finanziaria”, in cui il debito viene ridotto a colpi di controlli sui capitali e crescita dei redditi monetari e dell’inflazione rispetto ai tassi d’interesse. La scelta tra l’una e l’altra opzione sarà un bivio politico decisivo per i prossimi anni.
Gli economisti liberisti la raccontano diversamente: essi continuano a sostenere che lo Stato rappresenta una zavorra per il capitale privato…
Poi però si affrettano a invocare il salvataggio pubblico quando qualche banca privata fallisce, e a ben guardare non si scandalizzano nemmeno quando lo Stato compra a prezzi alti e poi rivende a prezzi bassi qualche spezzone di capitale industriale. Il divario fra le loro teorie e le loro ricette si fa sempre più ampio.
Qualcuno di essi obietterebbe che lo Stato fa bene a soccorrere il capitale nelle fasi di crisi ma non deve restare a lungo nelle compagini proprietarie, dato che l’impresa pubblica è comunque meno efficiente di quella privata. Non trova?
La realtà è diversa. L’impresa pubblica può perseguire obiettivi di carattere sistemico, che sfuggono alla ristretta logica capitalistica del profitto. Inoltre, anche adottando criteri di valutazione puramente capitalistici, l’impresa pubblica si rivela più efficiente di quanto si immagini. Da una recente ricerca dell’OCSE effettuata sulle prime 2000 aziende della classifica mondiale di Forbes, si evince che le imprese a partecipazione statale presentano un rapporto tra utili e ricavi significativamente maggiore rispetto alle imprese private e un rapporto tra profitti e capitale pressoché uguale. L’Italia non si discosta molto da queste medie internazionali.
Per l’Italia però si riporta sempre il caso del vecchio IRI, da molti considerato un “carrozzone” di sprechi. Che ne pensa?Bisognerebbe ricordare che al momento della sua privatizzazione molti settori della holding pubblica segnavano ampi attivi, e che nel 1992 le perdite aggregate dell’IRI non si discostavano molto dalle perdite che all’epoca registrava la maggior parte dei gruppi privati italiani. Come vede, sono ancora molti i miti liberisti da sfatare, specialmente in Italia.
In Gran Bretagna il leader laburista Corbyn ha ottenuto un notevole risultato elettorale con un programma basato su un ritorno dell’intervento statale in un’ottica non “ancillare” ma di lungo periodo, che prevede pure la nazionalizzazione delle ferrovie e di altri settori chiave. In Francia Melenchon ha sfiorato il ballottaggio presidenziale su una lunghezza d’onda analoga e altri in Europa si muovono nella stessa direzione. Sembra farsi strada l’idea di un diverso modello di sviluppo, con un ruolo centrale per gli investimenti pubblici strategici e forti richiami alla partecipazione democratica alle decisioni. E’ giunto il tempo di una sinistra che intercetta i cambiamenti del capitalismo e tenta di sfruttarne le contraddizioni?
Tra le macerie del vecchio socialismo filo-liberista qualcosa lentamente si muove. Ma la nuova concezione dell’intervento pubblico che queste forze emergenti propongono richiederebbe cambiamenti macroeconomici imponenti, tra cui una messa in discussione della centralità del mercato azionario e della connessa libertà dei movimenti di capitale. Mi sembrano propositi molto ambiziosi per movimenti politici ancora incerti, fragili, ai primissimi vagiti.
Però questi fenomeni politici emergenti sono anche trainati da una nuova generazione di elettori, costituita da giovani lavoratori e studenti. Mi pare un punto di forza importante.
Questa è una delle novità più promettenti della fase attuale. I giovani elettori che istintivamente muovono verso sinistra non esprimono un mero voto d’opinione. La loro scelta sembra piuttosto la risultante di un profondo mutamento dei rapporti di produzione, fatto di deregolamentazioni e precarietà, che negli ultimi anni ha inasprito le disuguaglianze di classe. Questi giovani sperimentano presto lo sfruttamento, crescono già disillusi e sembrano quindi vaccinati contro le vecchie favole dell’individualismo liberista. Tuttavia, organizzare una tale massa di disincantati intorno a un progetto di progresso e di emancipazione sociale non è un’impresa facile. Nell’attuale deserto politico e culturale, la loro rabbia può sfociare facilmente a destra.
Lei dunque ci spiega che il capitalismo si muove, si trasforma, e apre nuove contraddizioni sociali. Nel resto d’Europa, pur con tanti limiti, alcune forze di sinistra iniziano a cogliere i segni di questo mutamento. E in Italia la sinistra che fa?
In Italia la sinistra sembra immobile. Una estenuante, ipertrofica discussione sui contenitori politici che ripropone schemi di un ventennio fa, come se nulla fosse accaduto nel frattempo. E poi, quando provi ad aprire quelle scatole ti ritrovi in un limbo, un oscuro mondo in cui nulla è chiaro.
Cosa non la convince del dibattito che si è sviluppato in questi giorni alla sinistra del Partito democratico?
Ho sentito esponenti politici di vertice affrettarsi a dichiarare la loro appartenenza alla famiglia liberale e la loro distanza dalle “sirene neo-stataliste” provenienti dalla Gran Bretagna. Ne ho sentiti altri sostenere che le elezioni vanno il più possibile rinviate per evitare che i mercati si “innervosiscano” e lo spread aumenti di nuovo. Ma soprattutto, ho assistito a un maldestro balletto sui temi cruciali del diritto del lavoro, che dovrebbero situarsi al vertice di qualsiasi proposta politica di sinistra e intorno ai quali, invece, prevalgono la confusione e i miopi tatticismi. A sinistra del Pd noto ancora molta subalternità culturale ai vecchi slogan del liberismo, sebbene la realtà si rivolti da tempo contro di essi.
Un punto di discrimine netto però esiste: sulla scia della vittoria referendaria del 4 dicembre, molti esponenti della sinistra invocano la difesa della Costituzione e dei suoi principi di uguaglianza contro i ripetuti tentativi di rottamarla.Una difesa che ovviamente condivido, ma che ho sempre considerato insufficiente. Il modo migliore per tutelare i principi costituzionali della “Repubblica fondata sul lavoro” consiste nel delineare una proposta di politica economica coerente con essi. Mi pare che in materia ci sia ancora poco lavoro collettivo, e ancora molti nodi irrisolti.
Il prossimo numero di Micromega, un almanacco su Europa e Stati Uniti, pubblicherà i testi di un dibattito tra lei e Romano Prodi che si è tenuto all’Università di Bologna nel febbraio scorso. In quella occasione l’ex premier ed ex presidente della Commissione UE ha condiviso apertamente la sua proposta di introdurre controlli sui movimenti internazionali di capitale. Lo considera un segnale positivo?
Lo è senz’altro, ma devo ricordare che già da qualche anno capita che persino il Fondo Monetario Internazionale plachi i propri entusiasmi per le liberalizzazioni finanziarie e segnali i pericoli di una indiscriminata libertà di circolazione dei capitali. Il mondo intorno a noi cambia rapidamente, la politica italiana sembra sempre un po’ in ritardo. Specialmente a sinistra.
 «A tanta potenzialità desiderata, espressa o in formazione corrisponde una straordinaria povertà di politica pragmaticamente propositiva».
«A tanta potenzialità desiderata, espressa o in formazione corrisponde una straordinaria povertà di politica pragmaticamente propositiva».
La Repubblica, 4 luglio 2017 (c.mc.)
E' in corso dal 4 dicembre un proliferare di movimenti a sinistra del Partito democratico, voci che emergono dalla società civile e aspirano a proporre visioni politiche. Singole personalità della cultura mosse dal senso civico di contribuire alla vita pubblica per rimediare alla debolezza dimostrata dalla leadership del Partito democratico. Sigle politiche nate per progressiva secessione dal Pd nel corso degli anni, a partire dalle primarie seguite al ritiro di Veltroni fino alle più recenti, e soprattutto dopo il 4 dicembre. Questo movimento plurale nella sfera pubblica è positivo, il segno di una società non apatica, ricca di potenzialità, insoddisfatta del corso attuale del partito di governo e del governo stesso e preoccupata del persistente e crescente astensionismo elettorale.
La questione sociale è grave e i timidissimi segnali di ripresa dell’economia non sono accompagnati da un effettivo percepito miglioramento delle condizioni di milioni di cittadini e lavoratori che vivono o nell’indigenza o vicini alla povertà. Diritti sociali che sono in molti casi diritti solo formali, e politiche governative che non hanno preso sul serio né i principi di giustizia ed eguaglianza contenuti nella Costituzione né le promesse democratiche, che non si riducono a mettere in piedi governi che durino. «Finché non sarà garantito a tutti il lavoro, non sarà garantita a tutti la libertà; finché non vi sarà sicurezza sociale, non vi sarà veramente democrazia politica; o noi realizzeremo interamente questa Costituzione, o noi non avremo realizzata la democrazia in Italia», diceva Lelio Basso all’Assemblea costituente il 6 marzo 1947. Dopo settant’anni quegli intenti sono ancora allo stato di desiderio, con l’aggravante che oggi è debole la convinzione che lavoro e cittadinanza debbano stare insieme, che siano i valori fondamentali su cui impegnarsi. C’è uno spazio vuoto di progettualità politica da riempire perché l’insoddisfazione non si traduca in disillusione e senso di impotenza o, che è anche peggio, reazione xenofoba e nazionalistica.
A tanta potenzialità desiderata, espressa o in formazione corrisponde una straordinaria povertà di politica pragmaticamente propositiva. Povertà per troppa ricchezza di attori individuali e, soprattutto, per l’abitudine ad un linguaggio che è emotivo e morale, incapace di farsi politico, di nominare problemi invece che leader, idee programmatiche invece che frasi a effetto, critiche motivate sulle cose invece che attacchi personali. La “vibrante società civile”, per usare un’espressione habermasiana, dovrebbe riuscire a incanalarsi nella deliberazione politica; e perché questo avvenga sono indispensabili forme di partecipazione che sappiano articolare e unire. A questo servono i partiti. La loro asfissia, anzi la loro scomparsa fuori dalle istituzioni e la loro sostituzione con manifestazioni personali di leadership: questo è uno dei maggiori problemi del presente (che non sia solo italiano non è di alcun sollievo).
Il 4 dicembre ha squadernato questo problema, che è colossale, e ha messo a nudo la miopia di una politica leaderistica e plebiscitaria. Ma quel che ha lasciato è una pratica personalistica tracimante. Cosicché oggi il problema non deriva dalla scarsità dell’offerta individuale, ma dalla sua sovrabbondanza. Ogni voce si presenta come vera rappresentante della sinistra, come la parola che manca o quella più autentica. Alla fine, la sinistra sembra sempre più una categoria metafisica indecifrabile alla quale ci si appiglia per coprire un disordine di elaborazione che è proporzionale al numero dei candidati a risolverlo.
I partiti politici hanno una funzione che in questi tempi di attivismo senza bussola emerge con chiarezza: rendere le varie personalità che la vita politica naturalmente genera capaci di collaborare, di dialogare, di trovare nella loro rappresentatività singolare una forza che arricchisca progetti collettivi. Senza questa cooperazione per uno scopo elettorale comune, la pluralità di leader è un problema. Ed è quanto rischia di accadere a questa sinistra fatta di tanti soggetti individuali ma con una gracilissima coralità. Una sinistra di tanti capitani di ventura, con eserciti transitanti e, anche questi, composti di menti singole, abituate a dichiarare e asserire sui social, ma troppo poco a delibeare o discutere con altri. E invece, ad ogni idea una persona, ad ogni persona una sinistra, e a ogni sinistra un leader. Questa proliferazione per partenogenesi di individualismo dissociativo uccide la politica.
Senza dialogo, senza una trama comune di idee, senza una riflessione competente su progetti possibili, senza riannodare tradizioni di valori e di studio — senza l’accettazione del fatto che la politica nella democrazia elettorale deve costruire soggetti collettivi per competere e non può corrispondere soltanto a capi plebiscitari — senza tutto questo la vibrante società civile resta tale. E la profusione di bandiere nuove che sventolano, di siti internet e di sigle è destinata a restare una selva che non ha unità di senso, che non orienta ma disorienta.
 «È possibile combattere la miseria senza combattere i meccanismi che la producono? No. Eppure è ciò che facciamo se non affrontiamo il tema del debito pubblico».
«È possibile combattere la miseria senza combattere i meccanismi che la producono? No. Eppure è ciò che facciamo se non affrontiamo il tema del debito pubblico».
comune-info, 2 luglio 2017 (c.m.c.)
Sono decenni che i governi italiani dichiarano con solennità di voler abbattere il debito. Poi però, con puntualità svizzera, si tolgono di mezzo lasciando un debito più alto. Questa bizzarra consuetudine non si verifica perché la gente scialacqua, come ci fanno credere, ma perché siamo divorati dagli interessi. Lo Stato ha rinunciato al potere di stampare moneta, così ogni volta che deve spendere più di quel che incassa chiede denaro al sistema finanziario privato. Diventiamo sempre più poveri mentre banche, assicurazioni e fondi di investimento ingrassano con un debito che diventa cattivo quanto il colesterolo che devasta le coronarie. Nel 2016 abbiamo risparmiato 25 miliardi di euro ma il debito pubblico è cresciuto di altri 40 miliardi perché il risparmio non arrivava a coprire la spesa per interessi. La storia si ripete dal 1992, da allora il debito è passato da 850 a 2270 miliardi di euro nonostante 768 miliardi di risparmi. Su una somma complessiva di 2038 miliardi di interessi, 1270 sono stati pagati a debito. Per cambiare davvero non ci sarebbe che la pressione popolare, peccato che ai governi e ai media che contano non sia affatto simpatica.
È possibile combattere la miseria senza combattere i meccanismi che la producono? La domanda è retorica: non esiste altra risposta che no. Eppure è ciò che facciamo se non affrontiamo il tema del debito pubblico. A onor del vero, va detto che il debito pubblico è come il colesterolo. C’è quello buono che rappresenta ricchezza e quello cattivo che rappresenta miseria. Il debito è buono quando la moneta è gestita direttamente dallo Stato in un’ottica di piena occupazione. In tale contesto la spesa in deficit si trasforma in ricchezza perché l’ammanco è finanziato con moneta stampata di fresco che entrando nel circuito economico stimola l’economia con effetti positivi su produzione, occupazione, consumi e risparmi. Il debito è cattivo quando lo Stato si priva volutamente di sovranità monetaria, ossia del potere di stampare moneta. In tal caso ogni volta che decide di spendere più di quanto incassa deve chiedere un prestito al sistema finanziario privato. Che lo darà solo in cambio di un tasso di interesse. Così il popolo si impoverisce a vantaggio di banche, assicurazioni, fondi di investimento e ogni altra struttura finanziaria che di mestiere presta denaro.
Purtroppo da una trentina di anni, già prima di entrare nell’euro, lo Stato italiano si è ridotto al pari di una qualsiasi famiglia o azienda che dipende dalle banche per qualsiasi spesa supplementare. Il suo debito nei confronti dei privati oggi ha raggiunto 2270 miliardi di euro[1] e si comporta come una zecca che affonda l’arpione nelle casse pubbliche per sottrarre denaro in base al livello dei tassi di interesse esistenti. Nel 2016 i soldi sottratti sono stati 68 miliardi di euro, nel 2012 addirittura 87 per un semplice capriccio della speculazione. Soldi di tutti, che invece di andare a finanziare asili, ospedali, scuole al servizio della collettività, vanno ad ingrassare gli azionisti delle grandi strutture finanziarie. In effetti solo il 5,4% del debito pubblico italiano è detenuto dalle famiglie. Tutto il resto è nelle mani di banche, assicurazioni, fondi d’investimento, sia italiani che esteri. Più precisamente le strutture finanziarie italiane detengono il 63,1 per cento del debito pubblico italiano, quelle estere il 31,5 per cento.[2]
Si può senz’altro affermare che il debito cattivo è un meccanismo di redistribuzione alla rovescia: prende a tutti per dare ai più ricchi. Perché solo i ricchi hanno risparmi da investire in titoli di Stato. E i risultati si vedono: l’Italia è sempre più disuguale. Da società a uovo si sta trasformando in società a piramide. Prima c’era un piccolo numero di famiglie con redditi bassi, un piccolo numero con redditi molto alti e nel mezzo un gran numero di famiglie con redditi medi. Oggi molte famiglie di mezzo stanno migrando verso il basso mentre quelle di cima sono sempre più esigue e naturalmente più ricche.
Da un punto di vista patrimoniale, ossia della ricchezza posseduta sotto forma di case, terreni, auto, gioielli, titoli, depositi, le famiglie italiane possono essere divise in tre fasce. Quelle di cima, pari al 10 per cento, che detengono il 46 per cento dell’intera ricchezza privata. Quelle di mezzo, equivalenti al 40 per cento che controllano il 44 per cento della ricchezza. Quelle di fondo, che pur rappresentando il 50 per cento delle famiglie italiane, si aggiudicano appena il 9,4 per cento della ricchezza privata. [3] Mediamente la ricchezza delle famiglie appartenenti al 10 per cento più ricco è 22 volte più alta di quelle appartenenti al 50 per cento più povero. Ma se possibile la realtà è anche peggiore. Uno studio del Censis certifica che i 10 individui più ricchi d’Italia dispongono di un patrimonio di circa 75 miliardi di euro, pari a quello di quasi 500mila famiglie operaie messe insieme. Poco meno di 2mila italiani, appartenenti al club mondiale degli ultraricchi, dispongono di un patrimonio complessivo superiore a 169 miliardi di euro e non è conteggiato il valore degli immobili. In altre parole lo 0,003 per cento della popolazione italiana possiede una ricchezza pari a quella detenuta dal 4,5 per cento.[4]
I segni di un’Italia sempre più disuguale si ritrovano anche nella distribuzione del reddito. Il 10 per cento più ricco della popolazione intasca il 25,3 per cento del reddito disponibile, il 10 per cento più povero solo il 2,1 per cento. In termini monetari ogni individuo del 10% più ricco dispone di 77.189 euro all’anno. Quelli del 10% più povero si fermano a 6.521 euro.[5] Un divario di quasi 12 a 1. Situazione peggiore di metà degli anni ottanta quando il rapporto era 8 a 1.
Il sottoprodotto dell’ingiustizia è la miseria che il debito aggrava tramite l’austerità, scelta classica di uno Stato totalmente asservito alle banche. Al pari di una famiglia, quando uno Stato senza sovranità monetaria si accorge di non avere abbastanza soldi per pagare interessi e capitale, cerca di raggranellare il dovuto aumentando le entrate e riducendo le spese. Due mosse che hanno ambedue conseguenze gravissime perché se lo Stato smette di offrire servizi, le famiglie debbono rivolgersi al mercato che nel frattempo si è impossessato di servizi primari come l’acqua, i trasporti, la scuola, la sanità. Con la differenza che prima erano gratuiti, mentre ora sono a pagamento. Così le famiglie italiane, già tartassate dal carico fiscale, sono sempre più salassate dalle imprese private per il godimento di bisogni fondamentali. Basti dire che in ambito sanitario la spesa privata è salita, anno 2015, a 34,5 miliardi di euro, il 3,2 per cento in più rispetto al 2013. In totale gli italiani che si rivolgono alla sanità privata, spinti da ticket sempre più alti e da liste di attesa sempre più lunghe, sono oltre 10 milioni. Ma contemporaneamente sono cresciuti anche quelli che rinunciano a qualsiasi tipo di cura perché non hanno soldi né per pagare i ticket, né le parcelle. Nel 2016 gli italiani rinunciatari sono stati 11 milioni confermando che lo spostamento dalla sanità pubblica alla sanità privata si accompagna alla sanità negata.[6]
Che il binomio più tasse, meno servizi, impoverisca gli italiani, lo dicono i numeri. La forma più grave di povertà è quella di chi è in arretrato con le bollette, di chi non riesce a scaldare adeguatamente la casa, di chi non può permettersi un pasto appropriato almeno una volta ogni due giorni. Le persone in questo grave stato di deprivazione materiale sono 7 milioni, 11,6% della popolazione. Ma se allarghiamo lo sguardo a chi vive in bilico a causa del suo stato di precarietà e di incertezza, troviamo che le persone a rischio povertà, o esclusione sociale, sono 17 milioni e mezzo, il 28,7 per cento della popolazione italiana, il 3 per cento in più del 2004.[7] Persone a cui basta un dente da riparare, una batteria di esami sanitari imprevisti, una riparazione d’auto fuori programma, per mandarle sott’acqua e costringerle ad arrangiarsi chiedendo un prestito o rinunciando ad altre spese importanti.
L’assurdo della situazione è che ora neanche i creditori sono più così sicuri di voler spingere lo Stato debitore a pagare. La loro paura è di finire come quei bombaroli che non avendo calcolato bene la lunghezza della miccia sono colpiti anche loro dalla deflagrazione. Fuori di metafora, la paura è che a forza di estrarre ricchezza, il sistema possa impoverirsi a tal punto da entrare in una spirale di crisi che trascina tutti verso il fondo. Il punto delicato è la domanda, perché viviamo in un sistema che si regge sulle vendite. Solo se c’è un livello di domanda pari, o addirittura superiore, alla capacità produttiva, tutto funziona regolarmente e possono addirittura aprirsi prospettive di crescita come tutti invocano. Se invece la domanda si contrae, le imprese entrano in crisi e licenziano in una spirale sempre più ampia. Esattamente come succede nelle economie ad alto debito pubblico, dove i cittadini hanno meno soldi da spendere a causa dell’elevato livello di tassazione e lo Stato stesso spende meno per risparmiare risorse da destinare agli interessi. Tanto più che neanche i ricchi aiutano. Benché con più soldi, in virtù degli interessi intascati, la loro spesa non cresce. Non spendono in consumi perché tutti i loro bisogni sono già stati soddisfatti e non spendono in investimenti perché non sono così stupidi da avviare nuove attività produttive quando non ci sono prospettive di vendita. L’unica strada che imboccano è quella della finanza che si espande sempre di più.
Negli ultimi dieci anni, complice la crisi bancaria, l’austerità e la concentrazione della ricchezza, in Italia la domanda complessiva si è ridotta ai minimi storici facendo salire la disoccupazione alle stelle. Nel 2016 i disoccupati erano 3 milioni pari all’11,7 per cento della forza lavoro. Ma il dato si riferisce solo a chi cerca attivamente lavoro. Se si includesse nel conteggio anche quelli che un lavoro salariato lo vorrebbero, ma non lo cercano perché scoraggiati, il numero dei disoccupati salirebbe a 5 milioni e mezzo, il 21,6 per cento della forza lavoro.[8] Purtroppo anche la pubblica amministrazione contribuisce al problema dal momento che fra il 2013 e il 2016, ha perso 84mila unità.[9] La disoccupazione colpisce in maniera particolare i giovani fra 15 e 29 anni. Nel 2016 i giovani disoccupati sono 960mila pari al 44 per cento della forza lavoro giovanile. In pratica ogni 10 giovani disposti a lavorare, 4 non lo trovano. Ed ecco la crescita dei Neet, giovani stanchi e sfiduciati che né lavorano né studiano secondo la definizione inglese Not in education or in employment training. Nel 2016 i giovani nullafacenti fra i 15 e i 29 anni ammontano a più di 2 milioni, il 24 per cento del totale.[10]
Da oltre trent’anni, ogni governo dichiara di porsi come priorità l’abbattimento del debito, ma se ne va lasciandosi dietro un debito ancora più alto. E non perché viviamo al di sopra delle nostre possibilità, come qualcuno vorrebbe farci credere, ma perché non ce la facciamo a tenere la corsa con gli interessi. L’esame dei bilanci pubblici dimostra che siamo dei risparmiatori, non degli scialacquatori. Ad esempio nel 2016 abbiamo risparmiato 25 miliardi di euro perché a tanto ammonta la differenza, in negativo, fra ciò che abbiamo versato allo Stato e ciò che abbiamo ricevuto indietro sotto forma di servizi, investimenti, previdenza sociale. Ciò nonostante nel 2016 il debito pubblico è cresciuto di altri 40 miliardi perché il risparmio accumulato non è stato sufficiente a coprire tutta la spesa per interessi. Questa storia si ripete dal 1992 e ciò spiega perché da allora il nostro debito è passato da 850 a 2270 miliardi di euro nonostante 768 miliardi di risparmi. È semplicemente successo che su una somma complessiva di 2038 miliardi di interessi, 1270 sono stati pagati a debito.[11]
Il debito che si autoalimenta attraverso la via degli interessi è una delle forme più odiose di sottomissione e strangolamento di un popolo. Ogni anno avvolge attorno al suo collo un nuovo giro di catena per tenerlo sempre più stretto e succhiargli sempre più sangue. Fuori di metafora è un’organizzazione perfetta di latrocinio per travasare quote crescenti di ricchezza dalle tasche di tutti a quelle dei ricchi. Ma ora è arrivato il tempo di alzarci in piedi e rivendicare il diritto di sottrarci a questo meccanismo perverso. Gli strumenti per farlo ci sono: vanno dal congelamento del pagamento degli interessi al ripudio del debito illegittimo; dall’imposizione di un prestito forzoso a carico dei cittadini più ricchi ad una tassazione progressiva di reddito e patrimonio; dall’introduzione di una moneta complementare nazionale alla riforma della Banca Centrale Europea, dal controllo della fuga di capitali alla regolamentazione della speculazione sui titoli del debito pubblico. Il problema non sono gli strumenti, ma la volontà. Purtroppo neanche i politici più progressisti hanno messo a fuoco la gravità della situazione ed hanno posto al centro del proprio programma politico la gestione alternativa del debito.
L’unica forza che può indurre al cambiamento è la pressione popolare. Ma i cittadini si attivano solo se si rendono conto dei danni provocati dal debito pubblico. Di qui il ruolo cruciale dell’informazione. Ma chi la darà? Non c’è da aspettarsi, né sarebbe auspicabile, che la dia chi ha interesse a mantenere lo status quo, l’unica opzione possibile è che questo compito venga assunto dalla società civile che lotta contro il disagio sociale. Associazioni e cooperative, fondazioni e sindacati, realtà laiche e religiose, tutti insieme dovremmo organizzare una grande campagna di informazione pubblica finalizzata a tre obiettivi: creare consapevolezza nei cittadini sui nessi esistenti fra debito pubblico e disagio sociale; obbligare i media ad accendere i riflettori sulle conseguenze sociali del debito, suscitare un grande dibattito pubblico sulle soluzioni alternative al solo pagare.
La storia ci insegna che i cambiamenti sono possibili, ma solo se si infervorano gli animi. E gli animi si infervorano se scatta l’indignazione che deriva dalla consapevolezza. Nessuno meglio di noi può assumersi il compito di fare sapere. Possiamo e dobbiamo farlo. Ma dobbiamo unire le nostre forze.
[1] Banca d’Italia, Finanza pubblica: fabbisogno e debito, 14 aprile 2017
[2] Elaborazione dati, Banca d’Italia, Finanza pubblica: fabbisogno e debito, 14 aprile 2017
[3] Banca d’Italia, La ricchezza delle famiglie italiane, Bollettino n.65 del 13 dicembre 2012
[4] Censis, Crescono le diseguaglianze sociali: il vero male che corrode l’Italia, 3 maggio 2014
[5] Banca d’Italia, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2014, 3 dicembre 2015
[6] Censis, Dalla fotografia dell’evoluzione della sanità italiana alle soluzioni in campo, 8 giugno 2016
[7] Istat, Condizioni di vita e reddito, 6 dicembre 2016
[8] Istat, Rapporto annuale 2017
[9] Marco Rogari, Nel 2017 «effetto spending» da 30 miliard, Il sole 24 ore, 20 giugno 2017
[10] Istat, Rapporto annuale 2017
[11] Elaborazione dati Centro Nuovo Modello di Sviluppo su serie storiche Istat e Corte dei Conti
 Il modo in cui le reti delle donne stanno andando fuori dalle strutture dello Stato e si mettono in relazione con le organizzazioni per i diritti umani, è una mobilitazione che è oltre e contro lo Stato ed è transnazionale».
Il modo in cui le reti delle donne stanno andando fuori dalle strutture dello Stato e si mettono in relazione con le organizzazioni per i diritti umani, è una mobilitazione che è oltre e contro lo Stato ed è transnazionale».
connessioniprecarie.org, 2 luglio 2017 (c.m.c.)
L’intervista è stata realizzata mercoledì 28 giugno a Bologna, dove Judith Butler si trovava come promotrice della conferenza internazionale «The critical tasks of the University» e per partecipare alla Summer School «Sovereignty and Social Movements» organizzata dall’Academy of Global Humanities and Critical Theory (Duke University, University of Virginia, Università di Bologna).
La scorsa settimana hai promosso a Bologna un convegno internazionale sul ruolo critico delle università, che in questo momento negli Stati Uniti, dichiarandosi santuari per i migranti senza documenti, si stanno attivamente opponendo alle politiche di deportazione di Trump. Pensi che anche questo tipo di iniziativa rientri nel loro ruolo critico e come sarà colpita dalla riorganizzazione dello Stato pianificata da Trump e Bannon e dall’azione sempre più arbitraria della polizia?
È molto importante che le università dichiarino lo status di «santuari». Manda un segnale forte al governo federale dichiarando che le università non applicheranno le politiche di deportazione. Il programma di Trump non è ancora effettivo, ma i funzionari dell’immigrazione e incaricati delle deportazioni possono agire autonomamente in modo più aggressivo, perché non c’è una politica federale chiara, il presidente dice una cosa, le corti di giustizia vanno in un’altra direzione, cosicché i funzionari decidono in modo discrezionale di andare nelle scuole o nelle case per cercare le persone senza documenti. Le università però hanno il potere di decidere se consegnare ai funzionari i nomi di quelli che non hanno documenti o se resistere alle loro richieste. Hanno il potere di bloccare l’implementazione dei piani di deportazione e questo significa che possiamo diventare parte di un più vasto network che resiste all’applicazione delle politiche federali.
Anche alla luce di questo tipo di resistenza, alcuni vedono nell’elezione di Trump un’opportunità per i movimenti sociali. Condividi questa prospettiva?
Ci sono due modi di leggerla. C’è chi crede in una concezione dialettica della storia per cui un movimento di resistenza, per crescere, ha bisogno di un leader fascista, sicché dovremmo essere contenti in questa circostanza. Da parte mia non sarò mai contenta di avere un leader fascista, o neofascista, o autoritario… stiamo ancora cercando di capire come descrivere questo potere. Spero che i movimenti sociali non abbiano bisogno di questo per essere galvanizzati. C’è però un secondo modo di vederla, e che sono più disponibile ad accettare, per cui il trionfo della destra negli Stati Uniti ha reso imperativo che la sinistra si unisca con una piattaforma e una direzione davvero forti. Non è chiaro se questo possa accadere attraverso il partito democratico, o se ci debba essere un movimento di sinistra ‒ il che non coincide necessariamente con una politica di partito ‒ che sappia che cosa sta facendo e come e, su questa base, possa decidere se accettare un partito, o se avanzare le proprie rivendicazioni a un partito. Ma non è detto che si debba cominciare dall’essere un partito politico. A volte è positivo che i movimenti sociali diventino un partito politico, non è necessariamente qualcosa a cui opporsi, ma non dobbiamo accomodarci in una distinzione o situazione esistente, per cui ci sono i democratici, i repubblicani e tutto il resto è considerato una minoranza radicale senza potere. È il tempo che i movimenti sociali si coalizzino per formare un movimento forte, che abbia idee molto chiare sull’uguaglianza, sull’economia, sulla libertà, la giustizia, e questo significa avere ideali e piattaforme separate dalla politica di partito. Solo a questo punto un movimento sociale è nella posizione di negoziare.
In che modo la campagna elettorale, e in particolare l’apertura di Sanders verso i movimenti sociali ‒ che è stata spesso contraddittoria e incapace di raccogliere le loro istanze ‒ può offrire indicazioni rispetto a come strutturare l’opposizione a Trump nei termini che hai appena descritto?
La corsa di Sanders alla presidenza è stata molto interessante, perché ha messo insieme molta gente ed è stata molto più popolare di quanto Clinton si aspettava che fosse, conquistando alle primarie anche Stati che si pensava avrebbero sostenuto Hillary. Ma è stato anche frustrante, perché non era chiaro se Sanders sapesse come rivolgersi agli afroamericani, sembrava che pensasse che quella di classe fosse l’oppressione primaria e quelle di razza e genere fossero secondarie, e questa è una prospettiva che abbiamo combattuto negli anni’70 e ’80. Da una parte si è vista una sinistra capace di attrattiva, e questo è stato interessante, ma forse non lo è stata abbastanza. Forse è necessario distinguere Sanders dall’«effetto Sanders», che sta coinvolgendo molti più gruppi permettendo loro di pensare che possono avere un po’ di potere. Sanders si è definito socialista, anche se in una versione soft, ma un partito socialista non c’è ancora anche se alcuni si sono appellati a lui per uscire dal partito democratico e costituirne un altro. Vedremo se può succedere negli Stati uniti, sarebbe degno di nota.
I migranti sono stati protagonisti negli ultimi anni di importanti movimenti sociali e sono tutt’ora impegnati nell’organizzazione dell’opposizione al razzismo istituzionale di Trump. Nel tuo lavoro hai molto insistito sulla loro posizione, sottolineando il modo in cui hanno esercitato performativamente un «diritto ad avere diritti». Ma possiamo considerare i migranti non solo come una figura dell’esclusione da «noi, il popolo», ma anche come una prospettiva che ci permette di capire le trasformazioni contemporanee della cittadinanza e del lavoro nel suo complesso. Come fai i conti con queste trasformazioni nella tua teoria della precarietà?
Forse non ho una teoria della precarietà, ti posso dire che cosa sto facendo adesso, perché ho scritto Vite precarie dopo l’11 settembre per rispondere a quelle circostanze storiche, ma in altri libri sono emerse altre circostanze e magari si possono adattare ad alcune persone e ad altre no. Nel bene e nel male, il mio è un pensiero vivente e può cambiare, non ho una singola teoria che si adatti a tutte le circostanze, posso modificare la mia teoria, questo è il modo in cui lo descriverei. Quello che posso dire è che io vivo nello Stato della California e l’agricoltura lì si basa fondamentalmente sul lavoro migrante, se Trump fosse in grado di deportare migranti messicani senza documenti, costruire muri e bloccare l’afflusso di nuovi messicani, i principali interessi economici che lo hanno supportato sarebbero immediatamente in difficoltà. Di fatto l’economia della California funziona con i migranti senza documenti, non ci sono dubbi. E se andiamo indietro nella storia della California, vediamo che le ferrovie sono state costruite dai migranti cinesi. Molti di noi sono stati migranti, mia nonna non parlava nemmeno bene l’inglese, siamo arrivati, siamo andati a scuola, ci siamo dimenticati di essere migranti, pensiamo che i migranti siano sempre gli altri. Ma chi non è un migrante? Questa dimenticanza è parte della formazione del soggetto americano ed è diventata davvero pericolosa nel momento in cui abbiamo deciso che i migranti sono esterni a quello che siamo. Sono parte di quello che siamo, ci basiamo sul loro lavoro, siamo il loro lavoro.
Contro questa condizione, i migranti – non solo negli Stati Uniti ‒ hanno scioperato, e l’8 marzo di quest’anno c’è stato uno sciopero transnazionale delle donne. Nel tuo ultimo libro (Notes toward a Performative Theory of Assembly, nella traduzione italiana L’alleanza dei corpi) tu includi lo sciopero tra i modi in cui è possibile ‘assemblarsi’. Lo sciopero non è solo un modo di convergere, ma stabilisce anche una linea di opposizione nella società, una linea lungo la quale si pratica l’interruzione di un rapporto sociale di potere. La tua riflessione sulle assemblee articola la necessità o la possibilità di questo tipo di linea di conflitto come condizione stessa dell’assemblea?
Spesso, quando i sindacati vogliono unirsi per discutere le condizioni del loro lavoro, assistiamo a tentativi disperderli o negare il loro diritto di riunirsi in assemblea. Almeno nel diritto degli Stati Uniti e in qualche misura in quello internazionale, questo diritto nasce anche dalle assemblee sindacali, fatte per discutere le condizioni di lavoro o per decidere di scioperare. Ci sono modi di riunirsi in assemblea là dove c’è uno sciopero. Ma nell’era di internet possiamo entrare in rete nel web e decidere uno sciopero senza riunirci di persona. La vera domanda diventa allora come il modo tradizionale di funzionamento dell’assemblea, per cui i corpi si assemblano nello stesso spazio, sta in relazione con il networking digitale, o con una modalità politica di mettersi in rete che può anche essere la base per lo sciopero. Non intendo dire che nella vita contemporanea non c’è assemblea senza un insieme di connessioni digitali, o che non sappiamo nemmeno di essere assemblati se non mandiamo un messaggio che lo comunica. Tuttavia, l’assemblea può dare voce a certe rivendicazioni che devono essere comunicate attraverso il web. Di solito gli scioperi, soprattutto quelli internazionali, che sono molto interessanti, sono principalmente forme di messa in rete per la resistenza. Si tratta di una forma tra le altre possibili di associazione e alleanza tra gruppi, una forma che è legata all’assemblea anche se non sono esattamente la stessa cosa. Non c’è un’unica sfera pubblica per tutti, nemmeno internet è la stessa sfera pubblica per tutti, non tutti ce l’hanno e non tutti comunicano, non c’è un’unica sfera pubblica globale, non c’è una piazza mondiale. I media aiutano a fare in modo che succeda, quando succede. L’anno scorso coloro a cui non è assolutamente permesso di assemblarsi, i detenuti nelle prigioni palestinesi, negli Stati uniti e in altre parti del mondo, hanno fatto uno sciopero della fame. Molte persone che si opponevano alla pratica carceraria dell’isolamento sono andate in sciopero della fame e lo hanno fatto esattamente nello stesso momento. Hanno comunicato attraverso le reti di sostegno dei prigionieri, hanno creato un network internazionale senza bisogno di un’assemblea, hanno scioperato nello stesso momento per attirare l’attenzione dei media sul fatto che l’isolamento è una pratica disumana a cui tutti insieme si stavano opponendo. Alleanze a rete di questo tipo sono precisamente quello che è necessario per portare una questione al centro dell’attenzione politica. Anche lo sciopero delle donne è molto interessante perché non ha un solo centro, ed è accaduto in tutto il mondo in modi e luoghi diversi.
Infatti, lo sciopero dell’8 marzo è stato lanciato dalle donne argentine di Ni una menos con un appello internazionale che ha avuto un’incredibile risonanza in tutto il mondo. Non si è trattato di uno sciopero tradizionale, inteso come strumento di contrattazione sindacale, ma è stato un modo per rifiutare una condizione di violenza e oppressione che assume molte forme.
Lo sciopero della fame e quello delle donne non sono scioperi tradizionali, di tipo sindacale, ed è importante che siano accaduti. La cosa che mi pare più interessante sono i network che li hanno resi possibili e che hanno permesso che accadessero, perché questi network possono comporre movimenti globali di solidarietà. Se però si riducono a uno sciopero che dura per un certo numero di ore per un giorno solo, questo non è abbastanza, perché un’azione simbolica. Ma anche un’azione simbolica può aiutarci a vedere quali sono i network, chi sono le persone che ne fanno parte in Argentina, qual è la loro relazione con la Turchia, con Bologna o con il Sudafrica. Il punto è usare l’occasione dello sciopero simbolico per solidificare reti internazionali che possano poi produrre effettivamente un senso più forte della sinistra femminista transnazionale o dell’opposizione transnazionale alle condizioni inumane nelle prigioni.
Forse però ci sono delle differenze tra lo sciopero della fame in prigione e lo sciopero delle donne o quello dei migranti. In prigione diventa un modo di conquistare in primo luogo quello che chiami un «diritto di apparire» per mettere sul tavolo rivendicazioni che altrimenti sarebbero inascoltate. Lo sciopero delle donne e quello dei migranti hanno stabilito una linea di conflitto, nel caso dell’8 marzo la linea in cui si mostra che la violenza patriarcale è la base per la riproduzione di rapporti sociali di potere su scala globale. Da questo punto di vista è interessante che lo sciopero sia stato proposto in Argentina, dove la violenza contro le donne sta diventando un’arma sistematica del governo neoliberale.
Penso che anche lo sciopero della fame in prigione stabilisca una linea di opposizione, perché in prigione tu non comunichi, non ti riunisci in assemblea, non avanzi rivendicazioni soprattutto se sei in isolamento. La voce dei detenuti non si sente, hanno bisogno di altri che possano articolare la loro posizione, che parlino per loro, e attraverso quel network hanno trovato il modo di articolare una rivendicazione che altrimenti non sono nella condizione di avanzare e che riguarda la violenza strutturale delle prigioni, che è anche un confronto frontale con quella violenza strutturale. Osservando il modo in cui le prigioni funzionano in Brasile o in Argentina, diventa evidente la relazione delle prigioni con la violenza della polizia, con il femminicidio, possiamo trovare una violenza strutturale che le connette. Angela Davis lavora sulle prigioni negli Stati uniti e in Brasile e sostiene che la violenza delle prigioni si manifesta attraverso un razzismo che colpisce i poveri e le donne in modo strutturale, una violenza dello Stato che articola disuguaglianze sociali fondamentali. D’altra parte dobbiamo considerare che i media hanno i loro cicli. Quanto più ci appoggiamo ai media per creare connessioni transnazionali, tanto più dobbiamo stare attenti al modo in cui il ciclo dei media ci fa diventare una notizia che un attimo dopo scompare. C’è un momento in cui siamo in sciopero e poi chi se ne ricorda? Che cosa succede poi? Come si traduce questo in pratiche o nuovi network, in nuove possibilità per i movimenti? Il modo in cui i media gestiscono lo sciopero di un giorno può dargli vita per un momento e poi estinguerlo. Dobbiamo trovare modi per lavorare contro questa temporaneità dei media per sostenere le nostre connessioni politiche.
Il problema riguarda però la capacità di accumulare sufficiente potere da forzare i media a dare conto di quello che accade. Lo sciopero è precisamente un modo di dare prova di un potere, che è in primo luogo il potere di non essere vittime, di rifiutare una condizione di oppressione.
Sono d’accordo. Dire, come spesso fanno i media, che le donne non si mobilitano o che siamo ormai post-femministe per me non è altro che una barzelletta. Non sarò mai post-femminista. È grandioso avere un momento globale in cui le donne emergono in marcia, come è successo a Washington e in tutto il mondo il 21 gennaio, ma questo deve continuare a succedere, e abbiamo bisogno di scioperi e manifestazioni che abbiano le loro infrastrutture, i loro network, i loro modi di sviluppare fini e strategie e forme di resistenza. Dobbiamo costruire queste connessioni.
La marcia del 21 gennaio e lo sciopero dell’8 marzo hanno visto le donne protagoniste ma hanno coinvolto moltissimi altri soggetti. Le donne in queste occasioni hanno posto una questione generale, ad esempio rifiutando le politiche neoliberali che smantellano il welfare e che impongono proprio alle donne di farsi carico del lavoro riproduttivo e dei servizi che non sono più erogati dal pubblico. A questo riguardo, pensi che le donne, in virtù della loro posizione materiale e simbolica, possano avere anche una posizione specifica nella lotta contro le relazioni neoliberali di potere su scala globale?
Io penso che le donne debbano assumere una posizione politica specifica per via del fatto che sono prioritariamente responsabili di relazioni di cura nei confronti dei bambini o degli anziani, e quando i servizi dello Stato e pubblici sono distrutti dal neoliberalismo o dal fallimento di altre infrastrutture, penso che questo ponga su di loro un carico ulteriore che ha effetti anche sul lavoro produttivo. Vorrei dire anche, però, che è estremamente importante includere tra le donne anche le donne trans, che dobbiamo avere una visione più ampia di che cosa significa essere una donna, una visione che includa anche le donne che non prendano parte alla riproduzione o al lavoro domestico, che hanno scelto di non essere o semplicemente per altre ragioni non sono sposate, che hanno altre alleanze sessuali e sono senza figli. Le donne ora vivono forme sociali molto diverse che includono e devono includere anche le donne trans. Uno dei problemi che ho con l’idea che le donne siano completamente identificate con la sfera riproduttiva è che in questo modo si operano delle restrizioni. Se, nel cercare di dare una specificità e una visibilità alle condizioni materiali delle donne, stabiliamo una specifica comprensione simbolica di che cosa la donna è, tutte le donne ne sono colpite, diventa un limite.
Sono completamente d’accordo, e il punto mi sembra precisamente la possibilità di rifiutare quel modo di essere identificate come donne. Si tratta di rifiutare la divisione sessuale del lavoro che costringe le donne a occupare certi ruoli, proprio questo rifiuto diventa politicamente rilevante oggi. Ma allo stesso tempo l’idea di includere le persone trans nella categoria delle donne non rischia di limitare la possibilità di questo rifiuto, esattamente perché presuppone una definizione identitaria di che cosa sia «donna»?
Non credo. Sta già succedendo. Ci sono persone che vivono come donne, senza essere riconosciute come tali. E ci sono persone riconosciute come donne che non si pensano affatto come donne. Dobbiamo accettare che spesso la percezione sociale non corrisponde all’esperienza vissuta delle persone. Non è solo una questione identitaria perché riguarda il modo in cui sei trattata a casa, a scuola, nelle istituzioni religiose, nel lavoro, se sei chiamata nell’esercito, quale bagno usi… ci sono un sacco di questioni pratiche che dipendono dalla designazione di genere, che può anche avere implicazioni concrete sulla vivibilità o invivibilità della vita. Se qualcuno mi interpella come donna in un certo modo e si aspetta che io viva in quel modo, in certe circostanze sociali, non potrei vivere in quella società, dovrei andarmene, ci sono implicazioni concrete e materiali che seguono a questo tipo di designazione e penso che se ci limitiamo a parlare di questioni di identità ‒ come ti definisci, qual è il tuo pronome, se è una questione di scelta individuale e di nominare se stessi – ci sfugge il fatto che spesso si tratta di una questione di vita o di morte.
Capisco il punto ma mi piacerebbe insistere. Da una parte sostieni, e sono d’accordo, che sia necessario rifiutare l’identificazione delle donne con le loro funzioni riproduttive, con i ruoli di madre, moglie, di coloro che sono ‘naturalmente’ deputate alla cura. In questo senso non si tratta semplicemente di una scelta individuale, ma di contestare l’imposizione di un ruolo e di una posizione sociale e la riproduzione di un rapporto di potere che presuppone quel ruolo e quella posizione. Dall’altra sostieni che altre soggettività di genere dovrebbero essere considerate donne, perché questo colpisce materialmente la loro possibilità di vivere. È indiscutibile che sia necessario allargare il riconoscimento di diritti civili e sociali, ma non c’è una qualche contraddizione tra il primo e il secondo punto, nella misura in cui il primo implica il rifiuto di una definizione che comporta anche l’imposizione di un ruolo, mentre il secondo la presuppone?
Questo mi permette di chiarire quello che intendo. Penso che ci siano molte donne che vogliono essere e sono madri e questo significa molto per loro, e non dovrebbero rifiutarlo, è grandioso che siano madri, hanno un grande piacere a essere madri e a vivere come vogliono vivere, e ci sono donne che vogliono essere sposate ed essere sposate con uomini. E se lo vogliono e questo le soddisfa è giusto e non devono rifiutarlo. Ma dare una definizione di donna che valga per tutti è un errore. Perché questo limita le possibilità all’interno dello spettro di che cosa significa essere una donna. Ci sono altre che non vogliono essere madri ma si pensano nonostante tutto come donne, che hanno relazioni di convivenza senza essere sposate e non intendono farlo, e questo è un altro spettro di possibilità in quello che chiamiamo essere donna. E ci sono donne trans che sono donne in molti modi, che sentono con forza che questo è esattamente ciò che sono socialmente e psicologicamente, e vogliono vivere in quella categoria ma non hanno lo spazio di farlo. Non penso che quelle che sono sessualmente donne debbano rifiutare di fare figli o di sposarsi, non lo direi mai, ma ci sono lesbiche che vogliono sposarsi e questo va bene, e ci sono trans che vogliono avere figli e sposarsi e questo va bene, e se non vogliono sposarsi e avere figli potrebbero comunque essere coinvolte nella cura dei figli con altre persone, non dobbiamo prendere una sola scelta e renderla una norma per tutti, questa sarebbe una forma di violenza simbolica.
Lo sarebbe senz’altro. Ma non bisognerebbe perdere di vista una critica della famiglia come luogo in cui si organizzano rapporti di oppressione e di dominio. Se guardiamo la cosa dal punto di vista della libertà individuale è certamente necessario mantenere l’apertura che hai appena descritto. Ma istituzioni come il matrimonio e persino la scelta, certamente personale, della maternità vanno anche pensate in relazione al loro significato sociale, ai ruoli che prescrivono alle donne ed è in questo senso che sono state oggetto della critica femminista. Proprio questo cercavo di dire all’inizio: le donne in un certo modo hanno la possibilità, proprio perché si suppone che occupino certe posizioni, di criticare quelle istituzioni in quanto riproducono rapporti sociali di potere.
Capisco questo, ma penso che le istituzioni abbiano una storia, non sono le stesse in ogni cultura e contesto storico. Per esempio, se il femminismo vuole essere globale è estremamente importante che veda che non tutte le donne si muovono in una cornice di libertà individuale come in Europa, che ci sono diversi rapporti di connessione familiare e parentela che allargano la famiglia, e che questa non ha solo la forma della famiglia nucleare. Se pensiamo alla parentela e alla famiglia nucleare come una modalità di parentela tra le altre, e a relazioni di sostegno diverse dalla famiglia nucleare, partire da un modello occidentale è un’ingiusta imposizione culturale. Non mi interessa la questione della scelta personale e individuale, mi interessa di più che cosa è invivibile, è una cornice diversa, perché per alcune persone non sarebbe vivibile la struttura familiare o la struttura di parentela allargata, mentre per altre persone è l’unico modo per sopravvivere e fiorire, e altre persone vivono forme di ambivalenza fortissime nella struttura familiare, come uomini che si prendono cura della casa o curano i figli o sono in rapporti che non dipendono dalla divisione sessuale del lavoro. Ci sono alcune persone che stanno attivamente ristrutturando questi rapporti e ci stanno riuscendo in qualche misura, le famiglie lesbiche e gay non sono famiglie tradizionali, sono famiglie miti, ci sono madri dal primo matrimonio o dal secondo matrimonio, con un padre gay, le relazioni di amicizia possono dare strutture di parentela più elaborate. Non penso che possiamo risalire a Engels per trovare la famiglia come una struttura oppressiva che rimarrà sempre tale, l’analisi strutturalista non ci permette una concezione storica della famiglia, e io penso che ci serva un’analisi che ci permetta di capire come questa istituzione funziona.
Sono d’accordo che non si possa prescindere dalle condizioni storiche in cui si articola la critica alla famiglia. Ma mi pare anche piuttosto chiaro che nelle condizioni attuali, in Europa e non solo in Europa, il neoliberalismo sta riportando al centro una concezione tradizionale della famiglia, e quindi prescrivendo alle donne una specifica posizione, perché si tratta di una struttura fondamentale di riproduzione della società, tanto più in un contesto in cui la fine di ogni politica sociale impone un’assoluta individualizzazione delle responsabilità per la propria vita come quella che tu stessa descrivi nella tua riflessione. Mi pare che questo renda necessaria una critica femminista della famiglia e non solo l’idea che debba essere allargata a figure che non rientrano nel suo modello.
Capisco quello che dici e possiamo complicare ancora di più questa situazione perché abbiamo un femminismo neoliberale, abbiamo Hillary Clinton, lei si è fatta da sola, è un autoimprenditrice, vuole che le donne avanzino negli affari, che facciano le piccole imprenditrici, si è forse preoccupata se la cura dei figli sia finanziata e non sia soggetta a tagli e coinvolta in politiche di austerità? Avrebbe dovuto! E invece è con i Clinton che sono cominciati i tagli ai welfare e l’abbattimento di tutto quello che è rimasto della socialdemocrazia negli Stati uniti. Molte donne non hanno votato per lei, molte donne nere non si sono sentite rappresentate da lei, molte donne bianche povere non si sono sentite rappresentate da lei, il suo femminismo è completamente centrato sull’autoavanzamento e questo è l’obiettivo neoliberale.
Questo è stato un punto ampiamente dibattuto nell’accademia negli Stati uniti quando Nancy Fraser ha sostenuto che il femminismo è diventato l’ancella del neoliberalismo, e che questo è accaduto nel momento in cui le identity politics hanno preso il posto delle istanze di redistribuzione della ricchezza durante gli anni ’80.
Penso che anche qui dobbiamo distinguere il femminismo che è diventata una politica ufficiale di Stato, anche se per certi versi non lo è più, non abbiamo più femminismo nelle istituzioni e nemmeno donne, è stato un colpo di coda durissimo. Ma molti aspetti del femminismo socialista, del movimento delle donne contro la violenza, o dei movimenti contro la povertà che in modo sproporzionato colpisce le donne non sono stati ascoltati dal femminismo ufficiale. Ed è una pena vedere come il femminismo sia stato incorporato, ne saranno forse contente le femministe liberali, che sono soprattutto o esclusivamente bianche, ma la critica del liberalismo o del neoliberalismo non è certo esaurita.
Questo ci riporta alla capacità dei movimenti di consolidarsi. Nelle tue note sulle assemblee hai molto insistito sul fatto che le assemblee sono temporanee, contingenti, e sottolinei che ciò non è necessariamente un limite perché possono accadere in ogni momento. Questa idea di contingenza o transitorietà come si confronta con il problema della continuità e dell’organizzazione delle assemblee? Se la contingenza è il modo di essere delle assemblee, non c’è il rischio che solo la loro rappresentazione nelle istituzioni possa dare loro continuità?
Oltre alla temporaneità io ho sottolineato che le assemblee possono articolare un certo tipo di critica. Per esempio anche lo sciopero delle donne dell’8 marzo ha articolato dei principi, per cui il punto diventa come quei principi sono tradotti in pratiche e organizzazione e movimento. Penso che il grande momento pubblico abbia un’importanza quando i principi che annuncia sono raccolti da altri tipi di movimento che magari non sono così spettacolari e pubblici. Ma c’è un altro punto che mi interessa sottolineare: un’assemblea che dura molto tempo diventa un accampamento, o magari un’occupazione, che dura più tempo o si allarga e può diventare un movimento sociale e anche una lotta rivoluzionaria. A seconda da quanto spesso accadono, da quanto grandi diventano, da quanto a lungo durano, puoi tracciare il modo in cui ciò che comincia come un piccolo gruppo di persone che si riunisce può trasformarsi nel tempo e nello spazio in un più largo e sostenuto movimento sociale. Questo mi interessa e mi porta a pensare allo sciopero generale, non uno sciopero per un giorno, non «oggi non lavoriamo», ma «non lavoreremo più finché non cambiano le condizioni», non solo questo giorno ma ogni giorno finché queste condizioni sono mantenute. Lo sciopero generale è il rifiuto di un regime, di un’intera organizzazione del mondo, della politica, di un regime di apartheid, di un regime coloniale, li abbiamo visti abbattuti dai movimenti di massa. So che la gente dice che i movimenti non possono fare niente, invece lo fanno, sbagliamo a sottovalutare il potere dei movimenti di massa, ma ci vuole tempo per accumulare e la gente deve avere più di qualche slogan per andare avanti, devono sapere che ci sono principi, un’analisi, per potersi considerare parte di quello che sta succedendo e che quello che accade in una parte del mondo è connesso a quello che succede da un’altra parte. Se pensiamo alle popolazioni che sono rese precarie dalle politiche economiche neoliberali, o da governi autoritari, o dalla decimazione dei beni pubblici, dei sussidi, dell’educazione, della salute, ci sentiamo molto soli finché non realizziamo che altri stanno facendo esperienza dell’accelerazione e intensificazione della povertà o dell’abbandono o della perdita del lavoro. Deve essere chiaro che questo accade sul piano transnazionale e deve essere messo in termini che la gente possa capire, perché possa riconoscere l’ingiustizia della propria sofferenza. C’è il pericolo che la gente pensi che la propria situazione è solo un problema locale, quando invece ha una dimensione transnazionale. E se possiamo tornare indietro alla lotta al femminicidio, quella è un’enorme ispirazione per me, perché ci sono statistiche terribili su quante donne e quanti trans sono uccisi in un posto come l’Honduras, che forse ha le statistiche peggiori, in Brasile in Argentina, sono statistiche sconcertanti, ma lo sforzo di costruire network tra le donne e quelli che si oppongono ai femminicidi è impressionante. Mi rendo conto di quanto duro debba essere leggere quelle statistiche, riunirsi e fare un’analisi che la gente possa accettare e quanto è stato importante per quel movimento essere prima di tutto interamericano, e che i tribunali abbiano dichiarato il femminicidio un crimine. Il problema è che la polizia in tutti quegli Stati non ha nessuna intenzione di farsi carico del crimine e riconoscerne l’importanza, e spesso arrestano le donne che denunciano, è un terrorismo di Stato inflitto a coloro che portano questo problema in pubblico, perché la struttura del patriarcato locale e le alleanze patriarcali tra la polizia e lo Stato sono molto forti. Il modo in cui le reti delle donne stanno andando fuori dalle strutture dello Stato, in cui si mettono in relazione con le organizzazioni per i diritti umani e si rivolgono alle corti interamericane e producono alleanze transnazionali non dipende dal potere dello Stato, ma chiede conto allo Stato della sua complicità. Penso che questo sia enormemente interessante, è una mobilitazione che è oltre e contro lo Stato ed è transnazionale, quindi penso che dovremmo studiare questi movimenti e trarne ispirazione. Forse non sono ancora riusciti a porre fine a questa pratica atroce, ma hanno allargato la possibilità di farsi ascoltare, ora il mondo sa che cosa accade, e hanno prodotto network per supportarsi e sviluppare impressionanti pratiche di resistenza.

«». Left online,
Oggi, primo luglio in piazza Santi Apostoli, a Roma, Giuliano Pisapia spiegherà finalmente – almeno così in molti speriamo – quale strada intende imboccare. Grande coalizione da Carlo Calenda a lui, passando per il Pd di Matteo Renzi, ma con un governo a guida di Piero Grasso, si dice oggi, mentre scrivo. La formula Genova, insomma: il che non suona rassicurante, visto il risultato. Ma non è questione di formule, è questione di sostanza. E la sostanza è che queste grandi manovre di vertice danno per scontato che metà del Paese non voti più. Se per caso l’altra metà degli italiani tornasse a manifestarsi, anche solo al dieci per cento, tutto questo castello di carte verrebbe giù: come insegna il voto del 4 dicembre.
Anna Falcone, io, le 1.500 persone che erano al Brancaccio e le 65.000 che hanno seguito in streaming l’assemblea del 18 giugno: saremmo stati tutti felici se Pisapia avesse accolto il nostro invito a parlare, e ad ascoltare. O se solo avesse risposto alla nostra richiesta di prendere oggi la parola a Santi Apostoli. Ma mi rendo conto che non abbiamo l’appeal di Bruno Tabacci, o del napoletano Michele Pisacane. Provo allora a scrivere qua ciò che gli avrei voluto chiedere in pubblico.
È d’accordo, caro Pisapia, sul ripristino dell’articolo 18 e anzi sull’estensione, che era prevista dal quesito referendario della Cgil? È d’accordo ad istituire un reddito di dignità così come lo propone Libera? È d’accordo con la ricostruzione di una seria progressività fiscale, che alzi oltre il 60% lo scaglione per i redditi più alti? È d’accordo nel riaffermare il ruolo centrale dello Stato nella economia? Cioè, in concreto, è d’accordo nel sospendere le alienazioni del patrimonio pubblico e nel fermare le privatizzazioni? È d’accordo nella ricostruzione di un vero diritto alla salute, omogeneo sul territorio nazionale? È d’accordo nello stabilire il consumo di suolo a zero e nel varare una grande opera pubblica di risanamento del territorio? È d’accordo nel dire no al Ceta? È pronto ad impegnarsi a togliere dall’articolo 81 della Costituzione il pareggio di bilancio? È d’accordo nel ritirare lo Sblocca Italia, la Buona Scuola e il decreto Minniti? È pronto a dividere draconianamente le cariche di partito dalle cariche di governo, a cominciare dalla presidenza del Consiglio?
Non è un programma estremistico. È anzi assai più moderato di quello che propone Jeremy Corbyn. Ed è esattamente questo l’orientamento condiviso dalla base a cui lo stesso Pisapia dice di richiamarsi. Per esempio: l’assemblea regionale lombarda di Articolo Uno – Mdp che si è riunita il 24 giugno, ha approvato una mozione in cui si legge: «Occorre un nuovo soggetto politico che sappia offrire al vasto mondo del centrosinistra un’alternativa al Pd, che sia credibile e con ambizioni di governo. Un nuovo centrosinistra non può esistere a prescindere da questo nuovo soggetto. Per fare questo serve: il riconoscimento degli errori compiuti negli ultimi tre anni di governo, ma anche una forte discontinuità con le politiche neoliberiste che hanno condizionato anche le migliori esperienze di centrosinistra degli ultimi 20 anni; la piena consapevolezza di ciò che ha rappresentato il voto del 4 dicembre».
Su questa base la sinistra non solo sarebbe unita: sarebbe anche una bella sinistra. Troppo bella, per essere vera?

la Repubblica, 1 luglio 2017 (c.m.c.)
Appaiono non solo incomprensibili, ma destituite di ogni fondamento storico e culturale, le obiezioni relative al nucleo stesso della legge sullo Ius soli. Per una ragione molto semplice: in Italia l’idea stessa di nazione è indissolubile dal territorio come costruzione culturale. Non siamo mai stati una nazione etnica, “per via di sangue”: non c’è nazione più felicemente “impura” di quella italiana, frutto dei più vari e numerosi meticciati. È un’altra, la nostra storia.
Negli stessi versi dell’XI canto del Purgatorio in cui Dante mette in chiaro che Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti e poi soprattutto lui stesso hanno la gloria di aver fondato il volgare italiano, vengono esaltati Cimabue e Giotto, padri dell’altra lingua degli italiani: quella dell’arte figurativa, e dei monumenti. E quando Raffaello, nel 1519, prova a convincere papa Leone X a difendere le rovine di Roma antica, definisce questa ultima «madre della gloria e della fama italiane»: in un momento in cui l’idea stessa di nazione era ancora solo un vago progetto, era già evidente il ruolo decisivo che in esso avrebbe avuto il suolo, e ciò che su quel suolo avevamo saputo costruire. Come tre secoli prima aveva capito Cimabue rappresentando (sulla volta della Basilica Superiore di Assisi) l’«Ytalia» attraverso i monumenti di Roma, è proprio la lingua monumentale dell’arte quella che, lungo i secoli, ha reso noi tutti “italiani” per purissimo Ius soli.
È un filo, questo, che si può seguire fino al Novecento. Per esempio, fino al momento in cui un gruppo di intellettuali antifascisti (Piero Calamandrei, Nello Rosselli, Luigi Russo, Attilio Momigliano, Benedetto Croce, Alfonso Omodeo, Leone Ginzburg e altri ancora) intraprese una straordinaria serie di “gite” domenicali per cercare nel paesaggio e nei monumenti «il vero volto della patria». Scrive Calamandrei: «C’era prima di tutto un grande amore, proprio direi una grande tenerezza, per questo paese dove anche la natura è diventata tutta una creazione umana… Era questo amore, che nelle nostre passeggiate ci guidava e ci commoveva; e lo sdegno contro la bestiale insolenza di chi era venuto a contaminare colla sua presenza l’oggetto di questo amore, e a preparar la catastrofe (che tutti sentivamo vicina) di questa patria, così degna di essere amata». Mentre il fascismo pervertiva il concetto stesso di nazione, si sentiva che era dal territorio - cioè dal suolo, dalla sua natura e dalla sua storia - che potevano rinascere un’idea di nazione e di patria.
È ciò che, dopo la Liberazione, riconosce la Costituzione, dove la Repubblica prende solennemente atto che siamo nazione per via di cultura. Accade nell’unico dei principi fondamentali dove appaia la parola “nazione”, il 9. Dicendo che la «Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione» si iscrive nella Carta fondamentale la vicenda nazionale preunitaria. E lo si fa attraverso che cosa? Non attraverso la lingua, non attraverso il sangue, non attraverso la fede religiosa, ma attraverso la storia, l’arte e la loro inestricabile fusione con l’ambiente naturale italiano. In altre parole, la Repubblica prende atto del ruolo fondativo che la tradizione culturale e il suo sistematico nesso col territorio hanno avuto nella definizione stessa della nazione italiana, agli occhi dei propri membri e agli occhi degli stranieri.
Non è un’idea astratta. Chiunque abbia un figlio che frequenti una scuola pubblica vede con i propri occhi come bambini di ogni provenienza divengano giorno per giorno italiani: facendo propria la lingua delle parole, ma anche prendendo parte a quell’antico rapporto biunivoco per cui noi apparteniamo al suolo patrio, che a sua volta ci appartiene. Siamo tutti, da sempre, italiani per via di suolo e cultura. La legge sullo Ius soli si può certo discutere laddove (per esempio riferendosi al reddito del genitore non comunitario) rischia di introdurre una cittadinanza per censo. Ma la necessità di migliorarla ed ampliarla (ciò che si dovrà fare in seguito) non può certo indurre a dubitare della necessità di approvarla quanto prima: se non altro perché non fa che riconoscere un antico dato di fatto.
 «l’Italia si trova in una condizione drammatica, la cui ultima frontiera è il più massiccio processo di sostituzione di forza lavoro retribuita con forza lavoro non pagata dell'epoca recente.Un nuovo ossimoro, il lavoro gratuito».
«l’Italia si trova in una condizione drammatica, la cui ultima frontiera è il più massiccio processo di sostituzione di forza lavoro retribuita con forza lavoro non pagata dell'epoca recente.Un nuovo ossimoro, il lavoro gratuito».
Granello di Sabbia n. 29 di Maggio - Giugno 2017 (m.p.r.)
«Interrogare il passato non serve a niente. E’ al futuro che bisogna fare le domande. Senza il futuro il presente è solo disordine». Un passaggio tratto da “Chourmo”, opera seconda della splendida trilogia marsigliese dell’indimenticabile Jean Claude Izzo. Un passaggio che ben si attaglia anche alla drammatica situazione vissuta, oramai da tempo infinito, nel nostro Paese da intere generazioni e, più in generale, riconducibile alla decadente parabola del pianeta rispetto proprio alle soluzioni da proporre alla questione giovani/lavoro/prospettive.
Ci raccontano costantemente di un Paese che non c’è più, legato al remoto ricordo del boom dei “gloriosi anni trenta”, il periodo del dopoguerra che consentì ad intere generazioni di sognare e praticare in ascesa la mobilità sociale, cioè la possibilità di migliorare la propria posizione sociale rispetto a quella di provenienza. Ma non c’è oggi, purtroppo, un solo indicatore - sociale o economico - che invece lasci intravedere un barlume di speranza, di “ripresa”, di superamento di quelle pazzesche diseguaglianze ingenerate dal “malsano quarantennio del liberismo”.
Le politiche neoliberiste degli ultimi quarant’anni, nel primo ventennio (‘75-’95) sincopate e quasi invisibili, almeno in Occidente, ma già dirompenti nelle “aree test”, Sud-America e Africa, poi ovunque apertamente e diffusamente aggressive, hanno posto le condizioni per lo sgretolamento del tessuto sociale, esaltando la libertà dell’individuo a scapito della dimensione collettiva.
Una simile libertà basata sull’assenza di limiti, sul disinteresse per il bene e i beni comuni e sul conformismo, è in realtà illusoria per la sua assoluta sudditanza ai modelli e ai consumi imposti dal mercato, e ha come conseguenza l’aumento dell’impotenza collettiva e la paralisi della politica, sempre più sottomessa ai poteri forti e totalmente insignificante sul versante di una moderna e funzionale gestione della res publica. La vità individuale è così ipersatura di cupi pensieri e di sinistre premonizioni, tanto più terrorizzanti in quanto subite in solitudine interiore ed acuite dalla continua competitività individuale alla quale siamo chiamati per mantenerci a galla. In questa sorta di isteria collettiva, il risveglio è stato brusco, assai brusco: il mondo contemporaneo si ritrova quale contenitore colmo fino all’orlo di paura e di frustrazione diffuse, sia sociali che economiche, alla disperata ricerca di un tipo di sfogo che chiunque soffra possa ragionevolmente sperare di avere in comune anche con altri.
Per sentirsi meno soli, meno isolati. Meno fragili.
Per superare la fragilità individuale devi riacquisire la dimensione collettiva. Quindi in maturazione, forse, il bisogno di tornare ad essere comunità, collettivo. Per ora questo “bisogno” si palesa più con fughe, con derive che si incentrano con l’adozione degli “ismi” - qualunquismi, sovranismi, nazionalismi – più che rispetto al tentativo di ri-costruire un senso di appartenenza prospettico, nel quale saper coniugare la propria libertà individuale con il bisogno e l’impegno collettivo, dove tornare ad interrogarsi insieme per trovare risposte innovative e coerenti alle sofferenze individuali, in modo condiviso, comune, politico.
La vorticosa diffusione degli “ismi” è anche frutto di una studiata e meticolosa strategia messa in campo dalle istituzioni: come possono le istituzioni offrire sicurezze e certezze, in un simile disastroso contesto socio-economico? Quest’ansia, sempre più estesa e diffusa, viene convogliata verso un’unica condizione, quella della sicurezza, della sicurezza personale. Se per mitigare l’insicurezza e l’incertezza servono azioni comuni, gran parte delle misure adottate per garantire la sicurezza individuale risultano invece volutamente divisive: seminano il sospetto, allontanano le persone, le spingono a fiutare nemici, invasori, competitori, cospiratori.
Ansia e incertezza colpiscono tutti, proprio tutti, è oramai una situazione prospettica intergenerazionale, colpisce indistintamente donne e uomini, anziani e cinquantenni, tutti ne sono direttamente coinvolti. Ma risulta invece una vera epidemia sistemica per quanto riguarda le prospettive dei giovani: per la prima volta dal dopoguerra la mobilità sociale è in vorticosa discesa, tutti stanno introiettando il reale peggioramento della propria posizione sociale. La maggior parte delle nuove generazioni ha vissuto e sta vivendo questo processo di declassamento rispetto alla posizione acquisita dai loro genitori. Quello a cui si sta assistendo è, né più né meno, la storia della scomparsa dal mondo produttivo di una generazione, che, come viene ben descritto in alcuni degli articoli contenuti in questo Granello, è vittima di una serie di soprusi pazzeschi, tutti collegati alle logiche dell’economia a debito, come i “prestiti d’onore” per lo studio o il lavoro gratuito.
I giovani, gli studenti nel mondo sono oggi definiti con l’acronimo Ninja (No Income, No Jobs, No Assets), nessun reddito, nessun lavoro, nessun patrimonio. E anche quando i pochi fortunati trovano un impiego, gli interessi che devono pagare per rispettare “il debito d’onore” contratto per laurearsi, sono così alti che non riescono quasi mai ad estinguerlo. Ben pochi ce la fanno, gli altri ingrossano le fila dei “moderni peones” o se preferite degli “schiavi precari”. Il problema è serissimo, strutturale, ricorrente e su questo tema si incardina sia questo bel
Granello di Sabbia sia la prossima Università Estiva di Attac Italia (
Lavoro e non lavoro, Cecina Mare 15-17 Settembre). Il ricorso all’indebitamento come surrogato al reddito è sempre più esteso e praticato ed è un male così inarrestabile, una moderna “peste nera” che conduce alla più perversa e tragica degenerazione del capitalismo e ad una diffusione epidemica delle diseguaglianze prima e della povertà diffusa poi.
L’unico antidoto a questa degenerativa e contagiosa patologia è riuscire ad attivare una contro-narrazione puntuale ed efficace alle teorizzazioni dell’ Economia del debito che sappia condurci in tempi brevi almeno all’abolizione di tutti i debiti illegittimi. E’ lo scenario che occupa da tempo i maggiori sforzi di Attac Italia e che ha portato - come ben sapete – alla costituzione di uno specifico Centro Studi orientato all’azione, Cadtm Italia.
«Uno dei guai più grossi della nostra Società è che ha smesso da tempo di interrogarsi» (Cornelius Castoriadis). Le università sono da decenni la trincea vera del pensiero unico liberista, hanno sfornato intere generazioni “assuefatte” al mantra che il mercato sappia davvero regolare tutto e che il fondamentalismo capitalista di Milton Friedman sia l’unico zenit proponibile. La decadenza di un Paese si misura innanzitutto sulla condizione sociale e culturale delle sue giovani generazioni. Risiede in quella fascia di età l’energia, la creatività, la possibilità di un futuro per l’intera società. Un Paese che non investe sui giovani sta segando il ramo su cui è seduto. E senza futuro, c’è solo disordine.
Da questo punto di vista, l’Italia si trova in una condizione drammatica, la cui ultima frontiera è il più massiccio processo di sostituzione di forza lavoro retribuita con forza lavoro non pagata dell'epoca recente. L’ultima trovata del fondamentalismo capitalista è proprio questa: l’introduzione di un nuovo ossimoro, il lavoro gratuito. In Italia questa accelerazione (governi Renzi e Gentiloni, con Pd sempre in prima fila nel togliere diritti trasformandoli in doveri, ora pure “gratuiti”) prende la forma dell’alternanza scuola- lavoro resa obbligatoria dalla “buona Scuola” di Matteo Renzi, dalla trasformazione del servizio civile da volontario in obbligatorio, dal lavoro volontario per i migranti (Legge Minniti-Orlando), nella trasformazione del sussidio di disoccupazione in “patto di servizio”.
Suggerisco su questi aspetti la lettura del preziosissimo libro collettaneo curato dalla nostra Francesca Coin Salari Rubati. Economia politica e conflitto ai tempi del lavoro gratuito – Ed. Ombre Corte, con contributi, tra gli altri, di Marco Bascetta, Anna Curcio, Alessia Acquistapace, Cristina Morini, Andrea Fumagalli, Silvia Federici, Christian Marrazzi, Franco Berardi “Bifo”. «Il lavoro gratuito - afferma Francesca nel libro – è un moto di spontanea solidarietà del lavoro nel confronto del capitale, legittima la competizione al ribasso che acuisce la povertà e la diseguaglianza sociale».
E’ una brutta epoca, ecco tutto!
«Interrogare il passato non serve a niente. E’ al futuro che bisogna fare le domande. Senza il futuro il presente è solo disordine». In dialetto provenzale Chourmo, il titolo del romanzo di Izzo, significa la ciurma, i rematori delle galere. Negli anni ’90 a Marsiglia viene ripreso dalle band alternative per indicare gruppi di incontro, di supporto, di fan. Lo scopo era che la gente si “immischiasse”. Degli affari degli altri e viceversa. Esisteva uno spirito chourmo. Non eri di un quariere o di una cité. Eri chourmo.
Nella stessa galera a remare.
Per uscirne fuori.
Insieme.
Fuori dal lavoro gratuito, dalla precarietà, dal disordine del non aver futuro, dall’economia a debito, fuori da tutti gli “ismi”.
Usciamo fuori. Tutti, insieme. Chourmo!

« il manifesto,
30 giugno 2017 (c.m.c.)
Da molto andiamo dicendo che è passato il tempo di linguaggi e immaginari che si richiamano a concetti come l’«unità della sinistra» o, peggio ancora, il «centrosinistra» (vecchio o nuovo che sia). Abbiamo detto in tutte le salse – in tanti, in Italia e in Europa – di non essere interessati a riesumare idee di sinistra che non ci sono più o che paiono ormai in «stato vegetativo permanente».
Non è possibile pensare che il futuro siano una sinistra identitaria chiusa nella propria «autonomia», o all’opposto una «socialdemocrazia» impraticabile e inutile, nell’attuale contesto storico. Quel che ci interessa è camminare domandando, inventare una sinistra ancora da scrivere. È questa la risposta a quell’80% di giovani che il 4 dicembre ha bocciato la riforma Renzi-Boschi. Senza girarci intorno, è bene riconoscere che quel mare di giovani No, non ha difeso la «Costituzione più bella del mondo» per il semplice fatto che queste persone non hanno mai conosciuto la Costituzione come strumento di emancipazione quotidiana. Per queste persone, il referendum è stato soprattutto occasione di rigettare l’austerità come forma di governo delle proprie vite.
La sinistra, allora, ha senso se, a partire da questo dato generazionale e sociale, è in grado di trasformare ansia e rabbia in partecipazione ri-costituente. È importante aver trovato riscontri chiari di questa urgenza nella grande giornata del teatro Brancaccio. Anna Falcone e Tomaso Montanari, con la loro iniziativa, hanno segnato paletti rispetto ai quali non si torna indietro. Il percorso politico cominciato al Brancaccio prende congedo dal centrosinistra come ipotesi politica. E finalmente! Del resto, ciò non significa essere minoritari o settari. Nessun veto può essere posto alla partecipazione di chicchessia: ma allo stesso tempo al Brancaccio è emerso chiaramente che l’assenza di veti non può essere un alibi, usato ad arte per rimuovere le responsabilità politiche di tanti dei protagonisti del passato più o meno recente.
Con le responsabilità dei vecchi ceti politici occorre fare i conti senza nuovismi o rottamazioni. Al contrario è necessario lanciare, su pratiche e forme della politica, una grande sfida fatta di impegno teorico e di strumenti concreti quali la Carovana delle Piazze dell’Alternativa. Dato, però, che la mobilitazione politica non si inventa, su questo è bene insistere. Non abbiamo tempo né interesse di continuare a evocare come un mantra l’unità della sinistra, aspettando di volta in volta Godot, Gotor o Pisapia. Il nostro destino non può essere quello di diventare «frequentatori di kermesse della sinistra», che rischiano di ripetersi autoreferenziali e inconcludenti. Non possono interessarci allusioni evocative, dunque. Abbiamo bisogno – un bisogno figlio della precarietà che condividiamo con milioni di persone! – di qualificare subito questo percorso sulla qualità delle proposte e sulla intensità della presenza nella società.
Per queste ragioni è necessario rifiutare discussioni politiciste e inconsistenti, subito ripartite dopo l’assemblea del 18. Al contrario, è urgente prendere parola solo sui contenuti e sulle pratiche: ossia su ciò che concretizziamo ogni giorno nei territori, nelle battaglie cui partecipiamo, nella Carovana delle Piazze dell’Alternativa. Sforziamoci di capire se «unità» significhi avere proposte concrete e di rottura, solo per fare qualche esempio prioritario: su «industria 4.0», precarietà e composizione del lavoro; su welfare e senso del reddito minimo garantito; su diritto all’abitare e diritto alla città da opporre alle politiche securitarie; sulla conversione ecologica dell’economia; su quel bene comune che è la conoscenza; su migrazioni e accoglienza; sulla questione meridionale; sul contrasto alle mafie; sull’Europa che vogliamo.
Lo scorso 2 dicembre Stefano Rodotà ci ricordava che «abbiamo avuto e abbiamo una grande forza che deriva dall’aver continuato a ragionare». Onoriamo la sua memoria con il nostro impegno militante. Sarebbe il miglior contributo possibile non tanto alla mitologica unità della sinistra, quanto piuttosto alla costruzione di un programma che abbia l’obiettivo di liberare parti sempre più grandi delle nostre vite dal bisogno e dal ricatto di quella violenta relazione sociale che chiamiamo capitale.
 «Mentre emergono le macerie che dobbiamo rimuovere, non appare chiaro cosa vogliamo costruire e come».
«Mentre emergono le macerie che dobbiamo rimuovere, non appare chiaro cosa vogliamo costruire e come». il manifesto,
28 giugno 2017 (c.m.c.)
Inutile girarci intorno. Possiamo confrontare il numero dei Comuni in cui vince il centro-sinistra o il centro-destra, mettere insieme comuni grandi e piccoli o fare altre alchimie – Renzi ci ha già provato – ma il senso di queste elezioni è netto: ha vinto il centro-destra, soprattutto ha perso il centro-sinistra, più precisamente, è stato sconfitto il Partito Democratico. Perché un inizio così netto e drastico? Perché quello che è accaduto era scritto nella storia degli ultimi anni ed è la conseguenza di due fenomeni ben noti: astensionismo e sistemi con ballottaggio nelle realtà non più bipolari.
Se nei sistemi bipartitici o bipolari l’elettore si trova a scegliere tra il partito in cui si riconosce ed il partito avversario, in un sistema tripolare o multipolare gli elettori che non si riconoscono tra i due contendenti sono spinti in gran parte ad astenersi e per il resto a votare contro il partito più nemico. Questo produce una mutazione della stessa natura dell’atto elettorale: dal voto per al voto contro, dal voto per simpatia a quello per antipatia. Il fenomeno era stato evidente già nelle elezioni comunali di Roma e Torino. E non è bastato che Renzi non si presentasse nelle piazze dove si votava. Serviva forse un passo in più.
Oltretutto si è aggiunto un altro fattore che ha influito sul voto. Dopo il 4 dicembre siamo entrati in una fase di ristrutturazione delle forze politiche italiane che sta interessando soprattutto il campo che va dal centro alla sinistra. In questa fase si sono collocati il congresso «incompiuto» del Pd, la fuoriuscita da esso di tanti iscritti e dirigenti di valore, il congresso che ha visto Sinistra Italiana subire una scissione prima di nascere, e, più di recente, i movimenti di Art.1, di Pisapia e di Falcone e Montanari. Un grande fermento, insomma, che produrrà, speriamo, effetti positivi, ma che oggi non ha aiutato perché le elezioni sono intervenute a «lavori in corso». Mentre, cioè, emergono le macerie che dobbiamo rimuovere, ma non appare chiaro cosa vogliamo costruire e come e mentre i direttori di cantiere che si presentano sono guardati con sospetto.
Le prossime tappe del processo di ristrutturazione – legge elettorale e di conseguenza schieramenti ed alleanze – saranno decisive. E per tutti. Il processo riguarda anche il centro destra, ma esso opera col vento in poppa del populismo che indica nel migrante il nemico e nel protezionismo la risposta al bisogno di sicurezza che la crisi della globalizzazione produce. A sinistra il processo è, invece, più complesso: non dobbiamo smarrire i nostri valori – accoglienza, diritti civili e sociali – ma abbiamo un bisogno urgente di «fare opinione», mobilitare, unire, conquistare, costruire convergenze, individuare resistenze ed avversari.
Allora più che parlare di schieramenti ed alleanze la «Costituente della sinistra» dovrebbe fissare le nostre parole chiave. Eguaglianza, lavoro, garanzia di reddito debbono essere declinati per farli diventare nostri obiettivi precisi, condivisi e visibili, sui quali aggregare persone, società civile, organizzazioni. Ma abbiamo bisogno anche di indicare e far emergere le resistenze che troveremo, che dovremo contrastare ed i soggetti che le rappresentano: l’economia finanziaria, le banche, i grandi patrimoni, i grandi profitti dei nuovi padroni dell’economia digitale, i poteri e le corporazioni che bloccano la mobilità sociale e perpetuano stratificazioni economiche e sociali che bloccano speranze ed ambizioni dei giovani.
Insomma di fronte al rischio che ciascuno scarichi il suo malessere su quello che gli sta a fianco o sotto, dobbiamo ricostruire una gerarchia di ruoli e responsabilità perché in una società che cresce poco non ci potranno essere più uguaglianza e più lavoro senza progressività e redistribuzione. Il voto ci chiama a fare una sinistra nuova, ma più radicale. Quello che in altri paesi dirigenti – vecchi o nuovi che siano – stanno cercando di fare.
 «Amnesty international Italia. Scrivere finalmente quella parola indicibile nel codice penale può comunque scoraggiare i negazionisti».
«Amnesty international Italia. Scrivere finalmente quella parola indicibile nel codice penale può comunque scoraggiare i negazionisti».
il manifesto, 28 giugno 2017 (m.p.r.)
La nuova legge sulla tortura che la Camera si appresta ad approvare in via definitiva lascia l’amaro in bocca, ma non è inutile. E’ vero che dopo decenni di discussioni sterili, di proposte puntualmente archiviate ad ogni fine di legislatura, era lecito attendersi che il Parlamento approvasse una legge migliore. Ma il fatto di porre fine alla rimozione della tortura, scrivendo finalmente quella parola indicibile nel codice penale non è un’operazione priva di una sua logica apprezzabile.
La definizione della nuova fattispecie, frutto di un faticoso compromesso, è lunga e confusa. Ha alcuni difetti specifici, problematici sia dal punto di vista giuridico (nella prospettiva dell’applicabilità della norma) sia, soprattutto, da quello politico-culturale (per l’atteggiamento di diffidenza nei confronti dell’obbligo di punire severamente tutte le forme di tortura che inevitabilmente esprimono). In particolare, il requisito del “verificabile trauma psichico” ridimensiona l’applicabilità della nuova fattispecie alla tortura mentale. E lascia decisamente perplessi la formulazione da cui si desume la necessità, perché vi sia tortura, di più comportamenti (come se questa non potesse essere il risultato di una sola, gravissima, azione).
Una valutazione equilibrata richiede però che si tenga conto anche di un altro aspetto: quello della sistematica negazione della tortura e della necessità di contrastare quell’atteggiamento. L’esperienza di Amnesty International mostra come in tutto il mondo gli stati accusati di praticare la tortura reagiscano negando i fatti. E se ciò non è possibile, minimizzano, sostengono che si tratta di episodi isolati da attribuire a poche “mele marce”. E se neppure questo è possibile, argomentano che non si tratta di “tortura”, ma di qualcosa di meno grave … è disponibile un nutrito repertorio di eufemismi.
Nel nostro Paese la negazione e l’occultamento della tortura si sono tradotti soprattutto nella volontà di mantenere il silenzio del codice penale (quantomeno di quello ordinario, l’unico che interessa veramente) sulla tortura. Di non prevederla per non dovere ammettere che esiste o che può esistere anche da noi. E’ per questo che ci sembra che chiamare la tortura con il suo nome, prevederla in modo specifico nel codice penale, potere eventualmente discutere di “tortura” (senza nascondersi dietro l’“abuso d’ufficio” o le “lesioni”) in un’aula di tribunale, anche se la definizione è deludente, possa rappresentare un piccolo ma utile passo avanti.
Nessuna delle alternative, del resto, è credibile: né l’idea del tutto irrealistica che il Parlamento possa migliorare il testo della norma entro la fine di questa legislatura né quella di chi preferirebbe rinviare, per l’ennesima volta, nella speranza a dir poco incerta che un nuovo Parlamento possa avere un atteggiamento diverso dagli ultimi cinque. La chiusura dell’ennesima legislatura con un nulla di fatto servirebbe soltanto a rassicurare ancora una volta coloro che continuano a sostenere, a torto ma con determinazione, che una legge sulla tortura, qualsiasi legge sulla tortura, sia contro gli interessi delle forze di polizia.
Antonio Marchesi è presidente di Amnesty International Italia
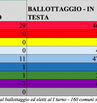
». la Repubblica, 27 giugno 2017 (c.m.c.)
Il passaggio elettorale di giugno annuncia una stagione politica particolarmente calda. Perché i risultati hanno delineato uno scenario instabile. Per molti versi, in-definito. Con alcuni aspetti di continuità e altri di novità rispetto agli ultimi anni. Aspetti, peraltro, che coincidono largamente. Perché la novità maggiore è il ritorno del bipolarismo fra centro-sinistra e centro-destra.
Sembrava incrinato, se non destrutturato, dopo l’affermazione del M5s, annunciata giusto alle precedenti amministrative, cinque anni fa, con la conquista di Parma ad opera di Federico Pizzarotti. Che domenica è stato rieletto, con una maggioranza chiara. Ma con una lista nuova. Personalizzata. Creata da lui. Intorno a sé. Ma l’Italia dei sindaci uscita dal voto di domenica mostra un profilo più tradizionale. È un’Italia bi-polare, dove 117 dei 159 eletti sono espressi dalle due coalizioni maggiori. Centrodestra e centrosinistra.
La maggiore novità è, però, costituita dalla forte crescita del centrodestra, che sale da 44 a 59 città (maggiori) amministrate. Mentre il centrosinistra (se si considerano anche gli “altri candidati di sinistra”) perde oltre venti sindaci. E scende da 81 a 58. Per cui ha ragione Renzi quando afferma di avere vinto. Ma ha anche perso. Molti sindaci. Il M5s, infine, allarga la sua presenza nei governi locali: da tre a otto. Ma si conferma fluido, proiettato sull’arena nazionale ma scarsamente consolidato nel territorio. Tuttavia, fluido appare l’assetto politico del Paese, nell’insieme. È, infatti, difficile individuare in Italia zone specifiche, per concentrazione e continuità del voto. Com’è avvenuto fino a quasi dieci anni fa. Oggi quelle Italie non si riconoscono più. L’intero territorio sembra aver perduto i colori e gli orientamenti tradizionali.
Il centrosinistra. Era radicato nelle regioni dell’Italia centrale. Definite, per questo, “zone rosse”. Ma oggi non sembrano più nemmeno “rosa pallido”. Il centrosinistra, prima, in quest’area amministrava 13 comuni maggiori.
Oggi ne governa otto. Ha perduto, fra l’altro, Pistoia e Piacenza. Nelle regioni del Nord-ovest, peraltro, è più che dimezzato: da 29 a 14 città. Superato dal centrodestra, che oggi ne governa 24. Fra queste, alcune città particolarmente importanti. Per prima: Genova. Ma anche La Spezia e Monza. Oltre a un luogo mitico, come Sesto San Giovanni. Perduto dopo settant’anni di governo.
Il centrosinistra, per contro, si è meridionalizzato. Nel Mezzogiorno e nelle Isole la sua presenza nei governi locali si è allargata: da 24 a 26. Mentre il peso del centrodestra è sceso da 21 a 14. Il mutamento delle zone geopolitiche in Italia ha interessato anche il Nord-est. Tradizionale zona “bianca”. Prima democristiana, in seguito forza-leghista. In questa occasione è stato teatro di una rimonta del centrosinistra. Che si è affermato, fra l’altro, a Padova. Si disegna, così, una mappa dai colori incerti. Che riflettono l’incertezza e il distacco degli elettori. L’astensione, infatti, è risultata ampia come poche altre volte, in passato.
Ai ballottaggi, infatti, ha votato circa il 46% degli elettori, 12 punti in meno rispetto al primo turno. E il calo è apparso particolarmente sensibile nel Sud: circa venti punti. Quasi 25 anni dopo la riforma della legge elettorale relativa alle amministrazioni delle città, la stagione dei sindaci è in declino. L’elezione diretta alle amministrative appariva in origine una via per superare il vecchio sistema politico, travolto da Tangentopoli. Le persone al posto dei partiti. La soluzione individuata per restituire fiducia nelle istituzioni. Ma oggi quel modello mostra i suoi limiti. Anche perché, senza partiti, il legame tra politica, amministrazione e società si indebolisce.
Così, sul territorio si riproducono i vizi e i contrasti che si osservano sul piano nazionale. I cattivi risultati del centrosinistra nelle città, infatti, riflettono le divisioni fra il Pd e i gruppi politici alla sua sinistra. In parte ispirati dai soggetti scissionisti. Ai quali, peraltro, fanno riferimento molti dei candidati nelle maggiori città. Dall’altra parte, il centrodestra “unito” appare in grado di competere e di vincere in molte zone e in molti contesti. Il problema, semmai, è quando si passa all’ambito nazionale.
Allora le divisioni riemergono, acute. Sul piano personale, oltre che politico. Perché Berlusconi (rieccolo…) non ha alcuna intenzione di cedere lo scettro della coalizione a Salvini. Il quale ambisce ad esserne la guida. Anche se non è legittimato a “governare”, senza l’appoggio e la mediazione di Berlusconi e di Forza Italia. Soprattutto per ragioni internazionali. Per il rapporto con la Ue. Il principale “avversario” della Lega e dei suoi alleati. I populisti (anti)europei. Per primo, il Front National di Marine Le Pen. La Ue. Contro la quale il M5s costruisce la propria identità. Così, passate le amministrative, l’attenzione politica si proietta altrove. Dalla dimensione locale verso l’Europa. L’orizzonte, ma anche la vera “frattura” che delimita lo spazio politico del prossimo futuro. Anzitutto: del prossimo anno.

«». la Repubblica, 26 giugno 2017, con postilla
In fondo alle urne di un secondo turno desertificato dall’astensionismo, c’è la vittoria del centrodestra. Vittoria netta e indiscutibile, a cominciare da Genova, città simbolo di queste elezioni comunali. Era una storica roccaforte della sinistra, da oggi avrà un’amministrazione di destra, sull’asse Forza Italia-Lega- Fratelli d’Italia che già governa la regione con Toti.
Ma le liste berlusconiane e leghiste si affermano un po’ ovunque, da Nord a Sud. Berlusconi dimostra di essere politicamente immortale: un moderno “Rieccolo” come ha detto qualcuno ricordando la definizione che Montanelli aveva coniato per Amintore Fanfani. Ma è un Berlusconi che nel settentrione deve molto alla Lega e anche all’afflusso degli elettori Cinque Stelle (quelli che si sono scomodati per andare a votare, s’intende). L’esclusione del partito di Grillo da quasi tutti i ballottaggi — tranne Asti e Carrara — ha avuto l’effetto di rinforzare i candidati del centrodestra a scapito degli avversari strategici del M5S, vale a dire le liste del Pd. Certo, è una magra consolazione per il movimento anti-sistema, le cui ambizioni erano più alte e che si è ritrovato di fatto a spalleggiare uno dei protagonisti del sistema contro l’altro. Annoverando per se stesso solo la vittoria a Carrara.
Per il centrosinistra invece è una sconfitta cocente e molto dolorosa. A parte Genova, anche altrove i dati sono sconfortanti. Si è molto detto circa la pretesa di Renzi di essere autosufficiente, cioè non condizionato dai gruppi alla sua sinistra. Ma queste amministrative dimostrano che anche laddove il Pd si presenta come centrosinistra allargato, comprendendo quindi la sinistra radicale, il risultato è ugualmente negativo. Si veda il capoluogo ligure, appunto, ma non solo. La sconfitta — con l’eccezione di Padova — riguarda un ventaglio di centri troppo ampio per non suggerire urgenti riflessioni al vertice del partito renziano. Ci sono tutte le città che contano. C’è persino L’Aquila, che alla vigilia veniva data per acquisita alla sinistra come emblema di un ritrovato rapporto con l’opinione pubblica dopo gli anni travagliati del dopo-terremoto.
A questo punto il Pd deve considerare i suoi errori. A livello locale ma soprattutto nazionale. Sarebbe miope individuare qualche capro espiatorio o peggio denunciare inesistenti complotti. È evidente che il partito ha perso credibilità e non riesce più ad afferrare il bandolo della matassa. A oltre sei mesi dal referendum perso il 4 dicembre, la sconfitta in queste comunali è grave proprio perché capillare.
Difficile pensare di cavarsela affermando che si tratta di “fatti locali”. Quando gli aspetti, diciamo così, locali esprimono lo sfilacciarsi di un tessuto politico e sociale tale da abbracciare una porzione così significativa del territorio, significa che la rotta è sbagliata. E non si tratta solo di alchimie, di alleanze da cercare a tavolino o di un ceto politico da riconnettere. A questo punto c’è una relazione con il proprio elettorato che va ripensata prima che sia troppo tardi. Ammesso che già non sia tardi. In verità il segnale del 4 dicembre è stato ignorato e oggi il partito di Renzi paga le conseguenze di questa sordità. Senza peraltro che altri abbiano in tasca la soluzione della crisi.
Quanto al centrodestra vincitore, il limite è che si tratta di elezioni locali. Nel senso che Berlusconi e forse anche Salvini sono i primi a sapere che l’alleanza vincente a livello locale non può essere riproposta tale quale a livello nazionale. Soprattutto se il sistema elettorale sarà proporzionale, con ciò incentivando la presentazione di liste separate. E non è solo questo. La linea di Salvini verso l’Europa non è conciliabile con quella dell’ultimo Berlusconi, di nuovo vicino al Partito Popolare e ad Angela Merkel.
Prima di immaginare una lista unica del centrodestra alle politiche, qualcuno dovrà cambiare idee e posizioni in modo netto. Forse è più facile prevedere che ognuno vada per conto suo a raccogliere voti per poi discutere nel nuovo Parlamento. Un Parlamento che a questo punto potrebbe anche avere una maggioranza di centrodestra. Chissà se è lo scenario preferito da Berlusconi. Forse no: l’idea di governare insieme a un Salvini trionfante non è proprio in cima ai desideri del “Rieccolo” di Arcore.
Se il partito di Renzi avesse dovuto comprendere il segnale del 4 dicembre, come afferma Folli, avrebbe dovuto dissolversi. Non lo ha fatto, ci sta pensando l'elettorato a farlo. L'alto astensionismo non è certo un caso: perché mai gli elettori desiderosi di un qualche cambiamento "a sinistra" avrebbero dovuto scegliere tra Berlusconi e Renzusconi, visto che la merce offerta è la stessa?
«La cultura di massa sta cambiando. Corbyn, Sanders, il lavoro, i cortei in piazza... il passato non è più tutto da buttare. Il "nuovo" sta perdendo terreno. E va ricostruito». Ma, osserviamo noi, il "vintage" non basta, serve il "nuovissimo". il manifesto, 24 giugno 2017, con postilla
Il successo di Jeremy Corbyn nel resuscitare il Labour, che ormai tutti davano per cotto e stracotto, non è un fatto eccezionale nel panorama politico occidentale. E diversi segnali ci dicono che non si tratti di un caso isolaSotto traccia, infatti, stiamo assistendo a un mutamento culturale profondo che ha un effetto rilevante anche nella sfera della politica.La sbornia neoliberista non è finita ma sta perdendo una delle basi su cui si è costruito il suo successo: è entrata in crisi l’idea che il «nuovo» sia sempre meglio del «vecchio», che le magnifiche e progressive sorti dell’umanità ci attendono, che il domani sarà necessariamente migliore di ieri. È stata proprio questa visione dominante della vita, mutuata e prodotta dalla società dei consumi, dove l’innovazione è fondamentale per mantenere in vita il mercato, che ha portato anche nella sfera politica a sentire come superate quelle forze politiche che appartenevano al passato.A sentire come vecchie e superate parole come «uguaglianza», «giustizia sociale» o lotta di classe/conflitto sociale, a guardare come a riti inutili le commemorazioni dell’Anpi o le manifestazioni di piazza contro le politiche del governo. Al più, tra i più sensibili, resisteva un sentimento di solidarietà umana, quasi di benevola comprensione per queste forme politiche del passato.
Di contro il successo di Corbyin, simply red come lo ha giustamente definito/colorato Tommaso Di Francesco, ci dice che un anziano, nell’era del giovanilismo imperante, che parla il vecchio linguaggio della sinistra pre-Blair , che dice cose semplici ma le rende credibili con la propria storia personale, può riportare una parte importante delle forze popolari a votare per una autentica «Sinistra».Non diversamente qualcosa di simile si è registrato negli Usa con l’inaspettata ascesa dell’anziano Bernie Sanders, bloccato in maniera poco trasparente da una candidata espressione dell’establishment come Hillary Clinton .
Che cosa è successo, al di là di tanti elementi contingenti che possono spiegare il fenomeno? Per comprenderlo, proviamo a spostarci su un altro piano, quello del mondo delle merci.Negli ultimi anni in diverse città italiane ed europee, in particolare a Firenze, sono sorti diversi esercizi commerciali che vendono prodotti di un’altra epoca che sono tornati di moda, anzi sono diventati preziosi perché rari.Nelle strade cittadine vediamo sempre più spesso andare lentamente le vecchie 500 Fiat degli anni ’60 , così come il vecchio Maggiolino, la Lambretta, la Vespa, ecc. Lo stesso accade per alcuni abiti, per la forma antica dei telefoni fissi, per alcuni ambiti dell’arredamento e in tanti altri settori. È il trionfo del vintage che ha un significato che non può essere banalizzato.
Certo, si può leggere questo fenomeno come una scelta di consumo radical-chic, facente parte di quella spasmodica ricerca di distinzione in una società dai consumi standardizzati. Ma, se allarghiamo lo sguardo ci accorgiamo che il vintage esprime anche il bisogno di non buttare a mare il passato, di valorizzarne oggetti e valori che sembravano essere perduti. Ce ne accorgiamo guardando al ritorno con grande seguito dei cosiddetti classici, nel cinema (si pensi solo a Totò e al neorealismo che rivediamo spesso volentieri) quanto nella letteratura (basti pensare, al di là della bravura di Benigni, al revival della Divina Commedia).
se la sinistra diventa vintage esce da qual complesso di inferiorità culturale, di essere superata dal cambiamento imposto dal turbocapitalismo, e ridiventa un punto di riferimento per chi cerca persone e ideali ben radicati nella storia, per chi è stanco di una società «liquida» e narcisista.
Ma, tutto ciò non basta assolutamente. Non basta parlare di eguaglianza e di Costituzione che va realizzata nei suoi valori e programmi.
Questa è una condizione necessaria ma non sufficiente per rispondere alle grandi sfide che abbiamo di fronte. In primis la questione ambientale, la salvezza dell’ecosistema, la capacità di risposta ai mutamenti climatici, senza pensare di salvare capre e cavoli come tentò di fare il «Rapporto Brundtland» che coniò nel 1987 l’espressione «sviluppo sostenibile» con cui si è giustificato il perpetuarsi dello sfruttamento delle risorse naturali.
In secondo luogo la questione del lavoro, che diventerà drammatica nei prossimi anni con l’accelerazione dell’automazione. Senza una drastica riduzione dell’orario di lavoro non c’è via d’uscita chiunque governi. E ancora: le nuove forme di alienazione legate alla diffusione delle tecnologie della comunicazione che distruggono legami sociali e creano monadi che pensano di stare al mondo perché sono iperconnessi ogni momento.
E quindi tutta la grande sfida dell’educazione oggi, di una scuola/università che non possono essere ridotte ad aziende che producono merci. Infine la grande questione della sicurezza che è stata regalata alla Destra e ridotta a terrorismo islamico e immigrati quando la nostra insicurezza nasce sul luogo di lavoro, in quello che mangiamo, che respiriamo, e anche nel fatto di essere aggrediti dalla piccola quanto dalla grande criminalità organizzata (mafia, camorra e ‘ndrangheta), dall’emergere di una nuova classe sociale – la borghesia mafiosa – che si è alleata con la borghesia finanziaria producendo, su scala globale, una deriva criminale del capitalismo. Senza dimenticare l’urgenza di una politica di pace per tutta l’area del Mediterraneo come priorità per la sicurezza del nostro paese.
Questi ed altri i temi rilevanti e sensibili che riguardano la nostra vita quotidiana ed il nostro futuro. Una forza politica di vera sinistra deve provare a tradurli in proposte concrete, a parlare di nuovi stili di vita ed a praticarli prima della presa del potere, a dimostrare, anche simbolicamente, che è possibile.
Su questo punto passa una distinzione profonda col passato: non aspettare la conquista delle poltrone o il successo elettorale come misura della bontà della proposta politica ma praticare insieme a tutte le forze sociali disponibili nuovi modelli economici, sia pure su scala locale, nuove forme di mutualismo sociale, di consumo responsabile, di un uso alternativo del denaro (dalla moneta fiscale alle monete locali complementari), a un (neomunicipalismo realmente partecipato.
Se ci sarà questo cambiamento profondo allora la stessa, desueta, parola «compagno» potrà riacquistare un significato forte e chiaro.
postilla
"Il grande problema di fronte al quale ci troviamo oggi era sconosciutodalla sinistra del secolo scorso: appena intravisto da pochi misconosciuti profeti. Molto schematicamentepotremmo sintetizzarlo così. Il sistema capitalistico ha concluso il (oppure “un”?),suo ciclo storico in un processo nel quale ha avviluppato e coinvolto il suoantagonista storico, il proletariato. La crescita irrefrenabile dello sfruttamento (fino alla dissipazione) di tutte lerisorse disponibili (dall’uomo a tutte le altre componenti dell’ambiente) hareso impossible a masse sempre più ampie di esseri la sopravvivenza sul pianetaTerra. Al cospetto di una tale mutazione. Sebbene l’obiettivo finale rimane sempre quello del superamento delmodello economico del capitalismo, è lecito nutrire forti dubbi sul fatto chesia sufficiente una “sinistra vintage” per concepirlo (e.s.)

il manifesto, 23 giugno 2017, con riferimenti
In un articolo sul manifesto di poco tempo fa (8/6/2017) avanzavo una previsione che è risultata, inconsuetamente, azzeccata e formulavo un auspicio che invece, a quanto sembra, stenta non dico a concretizzarsi, ma più semplicemente a farsi strada.
La previsione era quella di un progressivo, sempre più rapido e sempre più insolentemente dichiarato, slittamento del Movimento 5 Stelle verso posizioni praticamente coincidenti con quelle dell’estrema destra. Le testimonianze, nel corso degli ultimi giorni, sono numerose.
Ma preferisco fermarmi all’ultima, per il suo carattere davvero speciale. E’ la posizione assunta sulla legge dello ius soli. In politica, com’è noto, esistono, a seconda delle prospettive, posizioni giuste, sbagliate, discutibili, contraddittorie, ecc… Ma se una posizione non è né giusta né sbagliata ma semplicemente disumana, come quella sostenuta da Grillo sulla richiamata legge, significa che tra quella forza e le altre, più o meno discutibili, ma che non la pensano come lui, s’è aperto un fossato invalicabile (come ovviamente per gli stessi motivi, e ancor più, con la Lega di Salvini ecc…).
Il brutto è che ciò era chiaro, chiarissimo fin dal giorno in cui Grillo emise il suo primo strillo incoerente su di una piazza italiana (si potrebbe manifestare qualche stupore perché tra gli attuali sostenitori di una sinistra “dura e pura” ce ne siano che se ne sono accorti con impressionante ritardo, per essere degli innovatori…).
Io,invece sulla base di una forse settaria ma alla fin fine fondatissima preveggenza, mi permetto di reiterare, anzi, di raddoppiare la previsione: con posizioni di questa natura Grillo perderà più voti di quanti pensa di acquistarne. Ossia: il declino del Movimento 5 Stelle sarà lento, ma è ormai inevitabile.
Quanto all’auspicio, mi auguravo che le sinistre, disunite, trovassero un’occasione o un luogo comune per discutere. Non sarebbe solo un problema di correttezza etico-politica, è molto, molto di più. E’ un problema di sopravvivenza. Si direbbe che, al contrario, ognuna di quelle sinistre si sforzi sempre più puntigliosamente di dimostrare e dichiarare come e perché sia diversa da tutte le altre. E’ ancora possibile invertire questa micidiale tendenza?
Avanzerò qualche sommaria riflessione.
Uno dei motivi del contendere, e perciò della divisione, è, a quanto sembra, la parola d’ordine del centro-sinistra. Si può cominciare a ragionarne, confrontando due apparentemente contrari ma in realtà simmetrici, e anzi convergenti, punti di vista.
Innanzi tutto: la parola d’ordine del centro-sinistra rappresenta una prospettiva strategica per la sinistra in Italia. Infatti quando mai la sinistra può aspirare a diventare in Italia forza di governo, localmente e nazionalmente, se non in una prospettiva di centro-sinistra? Non ignoro che nella sinistra esistono componenti e posizioni le quali, del tutto legittimamente, puntano su di un altro versante della lotta politica, quello movimentista, che nasce dal basso e agisce sul basso, ecc… Ma cosa impedisce ad un centro-sinistra di governo di avere rapporti e scambi molto proficui, anzi essenziali, con quest’altra sinistra? Ma il centro-sinistra di cui stiamo parlando è quello che si batte per arrivare a gestire il paese e le sue lotte da una posizione di governo. Quindi, è a questa prospettiva che l’unità delle sinistre dovrebbe innanzitutto guardare.
Ma: un centro- sinistra, nella pienezza delle sue forze e potenzialità, non si può fare con Matteo Renzi. Perché Matteo Renzi è la negazione vivente del centro-sinistra: cultura, ideologia (più o meno profonda), metodi e pratiche di governo spingono in lui, strumentalmente, nella direzione opposta. La battaglia per il centro-sinistra coincide dunque perfettamente – questo dev’essere chiaro – con la battaglia contro l’egemonia nel Pd, e fuori del Pd, di questo personaggio.
E’ ancora possibile questa battaglia? E cioè: è il Pd, innanzitutto, prima di qualsiasi altra componente di sinistra, recuperabile a una prospettiva di centro-sinistra (certo, con lacerazioni interne anche profonde e la liquidazione di ogni tipo di “giglio magico”)? Difficile dirlo. Ma di certo, se non ci si prova, i tempi si allungheranno, tenderanno di diventare semisecolari.
Ma: una battaglia di questa portata e natura, che va ben al di là delle contingenze elettorali, di oggi e di domani, si può iniziare e vittoriosamente condurre senza mettere le carte in tavola? E cioè: noi chiediamo legittimamente il cambiamento, chiediamo di abbattere Renzi per renderlo possibile, solo se discutiamo, progettiamo e propagandiamo un vero e proprio programma, appunto, una serie di punti chiari e definiti intorno a cui far quadrato e, come si diceva una volta, “chiamare alla lotta”.
Di tutto ciò per ora non c’è traccia, né da una parte né dall’altra. Una Costituente di sinistra consisterebbe semplicemente in questo: su cosa siamo d’accordo? Su cosa non siamo d’accordo? I disaccordi sono componibili oppure no? L’unità è una conseguenza di questo, non il presupposto.
Se si passa da qui, una luce si accende. Altrimenti resteremo nell’oscurità profonda che circonda i “quattro dell’Orsa maggiore”: Renzi, Grillo, Berlusconi, Salvini. Mamma mia.
Riferimenti
Sull'argomento abbiamo pubblicato, oltre agli scritti di Anna Falcone e Tomaso Montanari, commenti di Norma Rangeri, Luciana Castellina, Livio Pepino, Piero Bevilacqua, Alfonso Gianni, ed espresso il nostro punto di vista in A proposito dell'iniziativa di Anna e Tomaso (e.s.)

« il manifesto, 23 giugno 2017 (c.m.c.)
L’assemblea del Brancaccio ha avuto il merito essenziale di porre con i piedi per terra il tema della costruzione di una «lista di cittadinanza a sinistra». Il percorso è tutto da costruire, né poteva essere preconfezionato. Ma alea iacta est, indietro non si deve e non si può tornare. Il percorso non sarà facile e il tempo è breve. Proprio per questo conviene da subito affrontare alcuni nodi. La contraddizione nella quale si dibatte la costruzione della lista di cittadinanza a sinistra è chiara e non va sottaciuta.
Da un lato si tratta di favorire il massimo dell’unità possibile, perché il risultato elettorale non risulti deprimente e perché la rappresentanza parlamentare che ne consegue sia dotata di forza e consistenza. Dall’altro lato bisogna garantire la sua autonomia in particolare da qualunque sogno di riedizione di un fantomatico centrosinistra, che ucciderebbe la nuova creatura prima del parto. Tenere insieme e conciliare questi due elementi non è semplice, ma neppure impossibile e soprattutto necessario. Le ragioni non sono solo elettorali, ma più profonde. Comincerei da queste ultime.
Qui non si tratta di (ri)unificare forze di sinistra già esistenti. Non che queste manchino e che non debbano in primo luogo unirsi. Sarebbe ingeneroso oltre che autolesionista dimenticarlo o pensare di farne a meno. Ma esperienze comprovate dimostrano che la somma non fa il totale. Anche se lo facesse, rischierebbe di essere troppo poco persino per superare l’inevitabile asticella del quorum, peraltro per ora ignota come il resto della legge elettorale con cui si voterà, ma soprattutto per reggere la sfida della stagione politica che si apre. La quale appare contrassegnata dal fronteggiarsi di diversi e spesso opposti populismi: lo scontro tra destra e sinistra non sparisce affatto – come dimostrano anche le recenti esperienze di voto europee – ma avviene su quel terreno, ovvero nella crisi della politica, entro un senso diffuso di distacco dalle istituzioni e di diffidenza – eufemismo – verso l’establishment politico-istituzionale ai suoi vari livelli.
L’unico punto fermo sono i valori di fondo della Costituzione, lo abbiamo ben visto con il voto popolare il 4 dicembre, quello stesso però che non si è ripresentato nella stessa misura alle urne delle recenti amministrative facendo lievitare ancora una volta l’astensionismo.
D’altro canto la recente crisi del M5Stelle, cui il gruppo dirigente reagisce con una evidente virata destrorsa, può liberare voti a sinistra (e non solo a destra, come sembra stia ora avvenendo) solo se lì vi è una forza in grado di attrarli. Il compito che ci sta di fronte è quindi ben più complesso: costruire senso, più che cercare consenso. Infatti va ben al di là dell’appuntamento elettorale. Lo trascende in un auspicabile, ma non predeterminato, processo costituente di un nuovo soggetto di sinistra, senza però poterlo bypassare perché la politica non prevede il salto del turno, ma al contrario che di volta in volta si spenda tutto quello che si ha in tasca.
Che senso avrebbe anteporre la scelta delle alleanze – il centrosinistra – senza avere dimostrato che una sinistra autonoma e riconoscibile per profilo politico-programmatico e qualità dell’agire, esiste? E poi centrosinistra con chi? Con un centro – il Pd – che guarda a destra (per parafrasare e capovolgere la celebre espressione di De Gasperi) come dimostrano politiche e recenti sostegni parlamentari? Propugnatore del più ambizioso quanto fallimentare progetto di stravolgimento oligarchico dell’ordine costituzionale?
Non sottovaluto affatto l’importanza delle scissioni e delle diaspore avvenute in campo Pd. Sono il frutto diretto o indiretto delle battaglia politiche e soprattutto referendarie di questi mesi. Queste ultime tanto temute da costruire la truffa del voucher reloaded. Un fatto positivo, dunque. Che andrebbe aiutato a liberarsi definitivamente dai fili vischiosi del bozzolo del passato. Non promuovendo l’abiura, ma una politica senza piombo sulle ali. Se invece si pensa a un centrosinistra senza Renzi, o ci si illude – visti gli esiti delle ultime primarie – o si finisce in bocca ai vagheggiamenti (à la Repubblica) di chi vuole semplicemente cambiare di spalla al fucile, sapendo che un Calenda sparerebbe nella stessa direzione.
La contraddizione di cui sopra può essere superata solo spostando la definizione, da subito e nei modi necessari, di programmi e candidature ai livelli della partecipazione popolare diretta. Da qui la centralità del carattere «di cittadinanza» della lista, che pratica un diverso agire nel momento stesso in cui lo proclama.
Significa costruire la sinistra a partire dalla responsabilizzazione del suo popolo diffuso, che non ha mai smesso di esistere anche se la sua espressione come forza e soggetto politico ancora non c’è.
 Donatella Coccoli intervista il giurista Livio Pepino. «Bisogna partire da un programma coerente e dalla forza delle associazioni del territorio che rispondono all’appello
Donatella Coccoli intervista il giurista Livio Pepino. «Bisogna partire da un programma coerente e dalla forza delle associazioni del territorio che rispondono all’appello
». Left, 22 giugno 2017 (c.m.c.)
Mentre ci si avvicina al secondo turno delle amministrative e diventa sempre più stretto il rapporto tra Mdp e Giuliano Pisapia che il 1 luglio convoca il suo Campo Progressista a Roma, continuano le reazioni dopo l’assemblea al Teatro Brancaccio del 18 giugno. All’appello per una lista unica di sinistra lanciato da Anna Falcone e Tomaso Montanari hanno aderito in molti, e tra questi c’è anche Livio Pepino, ex magistrato prestato all’editoria (cura le edizioni del Gruppo Abele). «Io sono uno dei molti che spera che sia questa sia la prospettiva giusta e cercherò di dare una mano» dice dopo l’incontro.
Durante il suo intervento aveva toccato tre punti, di cui uno era quello delle alleanze. Cioè, lei ha detto, non deve essere questa la principale preoccupazione per costruire una lista unitaria.
Bisogna partire dalle fondamenta e non dai tetti come ha detto anche Tomaso Montanari. Cioè bisogna partire dal programma, dalla forza delle associazioni che rispondono all’appello. E visto che c’è un po’ di tempo ancora, visto che la scadenza elettorale non sarà immediata, occorre stilare un un programma coerente e dopo di che procedere, senza fare l’esame del sangue a nessuno e senza fare recriminazioni sulle storie personali di ognuno. La cosa importante è che ci sia un’adesione convinta al programma, se non c’è, è inutile dire che mi alleo con Tizio, Caio o Sempronio. Ricordiamoci che nel passato questo modo di agire ha portato a sconfitte, come quelle della lista Arcobaleno.
Qual è la sensazione rispetto all’assemblea del 18 giugno?
C’è molto da lavorare, ma mi sembra una buona partenza, c’è stata un’ottima adesione, si sono ascoltati buoni interventi. Questa però è solo la premessa. Si gioca la prima parte della partita nei prossimi due mesi. A settembre bisogna capire se questo appello ha avuto nei territori delle reazioni positive, se c’è mobilitazione forte, voglia di costruire. Io credo che possa funzionare, ripeto, le premesse in qualche modo ci sono, anche se sono tutte le da verificare.
Nel secondo punto da lei toccato, ha parlato di chiarezza nel programma e nell’agire politico.
La chiarezza è collegata naturalmente al primo punto. La cosa importante è il radicamento nel territorio: ora questo potrebbe essere l’ennesimo slogan, ma per me significa che bisogna cercare di mettere insieme e di far ragionare tra di loro una serie di realtà che nel territorio ci sono, fanno cose interessanti e sono orientate verso prospettive egualitarie e però sono distanti dalla politica. Sono associazioni, sono persone che lavorano con i migranti, una parte dei movimenti studenteschi, pezzi del mondo del lavoro che non si sentono rappresentati, ma che però esistono. Ci sono tanti spezzoni che non hanno rappresentanza, il problema non è pensare alla sinistra come a un luogo del Parlamento, il problema è pensare a questi pezzi qui, che se si mettono in rete e in collegamento tra di loro possono fare molto.
Non saranno solo speranze?
Non sono un ingenuo movimentista che pensa che si possa realizzare tutto da un giorno all’altro, ma alcune esperienze ci sono nel mondo. Quello che ha fatto la differenza in Inghilterra con Corbyn e negli Usa con Sanders è stata la mobilitazione di una serie di settori che non lo facevano da decenni e che lo hanno fatto. Hanno trovato un riferimento. E al di là della distinzione vecchi-giovani, perché non è questo il problema, il problema è la coerenza del progetto, dire le parole giuste e avere una storia senza scheletri nell’armadio.
E a proposito di scheletri nell’armadio, lei ha detto al Brancaccio che è un errore non aver fatto una discontinuità con il passato.
Io parto da un’analisi sia del non voto che su quello che in parte, in Italia come in altre parti d’Europa, è diventato un “voto di vendetta” come l’ha chiamato Marco Revelli. In quel 20% delle classi subalterne che negli Usa ha votato per Trump, credo che nessuno pensasse che lui avrebbe risolto i suoi problemi ma che almeno con quel voto gliel’avrebbe fatta pagare agli altri. Anche il voto dei 5 stelle io lo vedo in quest’ottica. Lo si è visto sin dalle prime manifestazioni, quelle del vaffa. Ecco, questo è il sentire comune, io credo a torto ma in buona parte anche a ragione. Ora noi non bisogna cavalcare la demagogia, bisogna fare discorsi seri ma con modalità, facce, parole, forma di rappresentanza che dimostrino effettivamente che si è voltato pagina. E questo al di là delle responsabilità soggettive, perché non è vero che tutti sono uguali. In questi anni c’è chi ha sbagliato. E quando il ceto politico ha perso credibilità per una serie di ragioni, non è che glielo puoi riproporre agli elettori.
E allora cosa fare, come conciliare i vari pezzi dell’alleanza?
Il problema è che non bisogna escludere a priori nessuno. Ma se domani le liste possono anche comprendere pezzi che hanno fatto politica in passato tuttavia devono esserci in prevalenza volti nuovi, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Il senso deve essere quello di un’altra cosa, diversa dal passato. Certo, bisogna dare delle risposte giuste. Per esempio, nel dibattito sulla sicurezza, a chi ha paura non si può dire non devi avere paura, bisogna saper dare delle soluzioni. A chi dice che questo sistema non funziona, è marcio, non gli puoi dire non è vero, gli devi dare delle risposte che, se mai dimostri che su alcuni punti ha torto, ma deve essere una risposta diversa che lo deve portare da qualche parte. Se no, faremo dei programmi bellissimi e nessuno li sosterrà.
Come deve essere una politica seria di sinistra?
Chi è riuscito di nuovo ad aggregare è riuscito a fare una politica concreta: in una città deve aprire delle mense, ambulatori medici gratuiti ecc. Insomma bisogna dare risposte alle persone. Se lo fai, la gente si fida e allora puoi essere anche credibile nel momento in cui fai anche dei progetti più ampi. Oggi, siccome tutti promettono ogni sorta di cosa, e la realtà poi è estremamente deludente, la reazione dell’opinione pubblica è quella di sfiducia.
 Testo della lettera inviata ad Anna Falcone e Tomaso Montanari a proposito della loro iniziativa politica: le ragioni del consenso e la perplessità.
Testo della lettera inviata ad Anna Falcone e Tomaso Montanari a proposito della loro iniziativa politica: le ragioni del consenso e la perplessità.
L’iniziativa politica di Anna Falcone e Tomaso Montanari è,in Italia, l’evento più promettente degli ultimi anni, dopo la caduta delprogetto di Maurizio Landini. Per la prima volta si parla di Politica in sensoproprio: come un’impresa da condurre insieme per migliorare le condizioni di vita,tendenzialmente, di tutti. La stessa dimensione dell’evento del 18 maggio aRoma ne è la testimonianza.
Come spesso accade quando i media danno la loro impronta aciò che raccontano degli eventi, attorno all’incontro del 18 giugno, e allaproposta politica che è alla sua base, si è alzata una discreta quantità dipolvere, a partire dal peso assegnato dai media al ruolo svolto da quelli che definiremmo“entristi”: quei personaggi della vecchia storia delle sinistre italiane che sisono intrufolati cercando una nuova verginità. Qui voglio sottolineare leragioni per cui, fin dal primo momento, la proposta mi ha convinto e ho cercato,con eddyburg, di seguirla con attenzione.
Le ragioni delconsenso
In primo luogo, la netta rottura con il passato della “politicapoliticante”, con i suoi riti, le sue struttura organizzative, i suoi piccoloPantheon. Craxi, Berlusconi e Renzi, certamente, ma non solo questi. In unaparola, la rottura con i gusci grandi e piccoli delle sinistre (e ovviamente ledestre) del secolo scorso. Voglio precisare: con i gusci, non con le personeche sono capaci di liberarsene.
In secondo luogo, l’affermazione dell’eguaglianza comeessenziale valore e principio da conquistare: un’eguaglianza non solo deidiritti statuiti, ma di quelli sostanziali di ogni essere umano, quale che siail suo censo, il suo ruolo sociale, il sangue o il suolo dal quale proviene, lalingua che parla, la religione che professa.
Ancora il forte riferimento alla difesa e all’attuazione aivalori e principi della costituzione repubblicana del 1948, summula delpositivo che lo scorso millennio ci ha lasciato.
Infine, per scendere dall’ideologia alla politica nelleistituzioni, condivido la scelta di Anna e Tomaso di parlare a tutti ma dirivolgersi in primo luogo a quel “popolo di sinistra” che è sceso in campo e havinto nelle grandi battaglie per la difesa della Costituzione, e prima e insiemeper la difesa dei beni comuni (dall’acqua alla cultura, dalla salute alpaesaggio, dalla democrazia al lavoro). Tornerò criticamente sul termine “sinistra”,ma mi pare che intanto esprima abbastanza bene quella parte dell’elettorato cheha combattuto per quegli obiettivi.
Una larga porzione di questo popolo si è staccato dallapolitica, non ha più votato. Le ragioni sono evidenti, e sono implicite nellaproposta di Anna e Tomaso: sono nella degradazione della politica che èavvenuta per effetto, e nel quadro, dell’egemonia conquistata dal capitalismonella sua fase più recente. La politica del renzismo ne è l’epitome.
La perplessità
Esposte le ragioni per cui ho fin dall’inizio condiviso laproposta di Anna e Tomaso vorrei esprimere la mia perplessità su un punto: nonsul piano della strategia ma su quello della tattica. Mi riferisco allaquestione del difficile equilibrio tra due esigenze: quella della definizionedi una identità “di parte”,radicalmente diversa dalle altre identità che si sono affermate nella storiadel nostro paese, e quella dell’efficacia nell’immediato.
Più d’un commentatore si è riferito a questo punto. Ma lamaggioranza (cito ad esempio Norma Rangeri e Luciana Castellina, che sulcomplesso dell’iniziativa pur si sono espresse in modo molto diverso) criticandol’insufficiente attenzione a quella vasta porzione della vecchia “sinistra” cheè (ancora) fuori e magari lontana dalla “parte” di Anna e Tomaso. La miapersonale opinione è che, nell’immediato, far prevalere la ricerca dell’efficaciaimmediata (e quindi proporre una “lista unica della sinistra”) costringa adannebbiare il messaggio di rottura col passato che è la forza della proposta.Prima affermare, rendere evidente e compiuta, la propria identità/diversità,poi stabilire le alleanze necessarie per raggiungere gradualmente gli obiettivinella pratica politica: questo mi sembrerebbe il percorso preferibile.
La parola “sinistra"
Ciò detto, credo che un approfondimento serio vada fatto sulsignificato del termine “sinistra” oggi. Tutto è mutato radicalmente attorno anoi, a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, ma le linee guida del cambiamentoerano state tracciate all’indomani stesso della vittoria del fronteantifascista. Colpa grave della sinistra novecentesca non essersene accorta pertempo (salvo pochi e isolati gruppi e persone). Ciò ammesso, che cosa fareoggi? Che cosa recuperare del grande patrimonio e dall’insegnamento della “vecchia”sinistra”, e come inverarli nelle nuove sfide?
Io credo che una delle domande da porsi, per cominciare, sia“chi erano gli sfruttati e chi gli sfruttatori ieri, e chi sono gli sfruttati egli sfruttatori oggi”. Ovviamente, nonassumendo come campo di ricerca soltanto l’Italia né l’Europa, né il mondoNordatlantico oggi, ma l’intero pianeta Terra.
A quel punto ci accorgeremo che una parte estremamenteconsistente degli sfruttati di oggi sono stati prodotti da un’ideologia e unaprassi fortemente condivisa dalla “vecchia sinistra”: la “credenza” dellosviluppo, che è ancora parte dell’ideologia
dominante. Ci accorgeremo che la grande massa degli sfruttati di oggi è costituita proprio dagli
"sfruttati dallo sviluppo", come ha scritto Ilaria Boniburini sulla base di una letteratura vasta e poco nota. E ci accorgeremo infine che
sfruttati e sfruttatori sono molto vicini,molto spesso nella stessa persona. Allora dalla politica saremo costretti a rivolgerciverso altri saperi.
 ».
».
il manifesto, 22 giugno 2017 (c.m.c.)
Ci sono alcune buone ragioni, tanto soggettive quanto di contesto, che spingono a guardare con fiducia e speranza all’iniziativa avviata da Anna Falcone e Tomaso Montanari il 18 giugno scorso al teatro Brancaccio di Roma.
Soggettive, perché la relazione di Montanari ha rivelato una maturità politica non comune, sia per la profondità dell’analisi storica e attuale, sia per l’equilibrio, la coscienza delle difficoltà, con cui ha prospettato il percorso possibile da sperimentare.Ci sono almeno due punti che vorrei sottolineare – a parte gli elementi programmatici – di quella relazione, che ha messo in equilibrio radicalità di proposta e ancoraggio realistico alle possibilità concrete offerte oggi dalla situazione italiana ed europea.
Il primo riguarda il giudizio sull’esperienza storica del centro-sinistra. La riflessione di Montanari non era un saggio scientifico, così come il mio non è che un articolo di riflessione politica. Ma la critica alle iniziative caratterizzanti del centro-sinistra prima di Renzi, dalla modifica del Titolo Quinto della Costituzione, passando per la legge Treu sul mercato del lavoro, sino alla riforma universitaria di Luigi Berlinguer, costituisce un passaggio obbligato per capire almeno un aspetto della storia degli ultimi 20 anni: la dissoluzione progressiva di ogni fede nell’animo del popolo della sinistra, la diserzione dall’impegno e dalla lotta.
Chi vuole trovare ragioni all’astensione elettorale in questo campo le trova tutte qui. Perché non c’è risentimento più profondo di quello che nasce dal sentirsi traditi dalla propria parte. Renzi è stato solo la degenerazione virulenta della malattia neoliberista che aveva già corroso la sinistra.Questo giudizio d’insieme, che può apparire sommario, non deve tuttavia pregiudicare il contributo di chi è stato dentro quella esperienza e vuol voltare pagina.
Nessuna richiesta di pentimento, né processi sommari. Ad ora non si ha notizia di tribunali speciali per quella vicenda. Ma certamente è richiesta una netta discontinuità con quel passato. Questa è una linea dirimente che Montanari ha tracciato con intransigenza, ma senza iattanza: opportunamente ripresa da Nicola Fratoianni e Pippo Civati che hanno aderito all’inziativa.
L’altro punto riguarda la capacità di Montanari di far rivivere alcuni punti della nostra Costituzione, come l’art. 3, quali elementi programmatici di una politica di superamento della democrazia formale.
Una interpretazione che negli ultimi anni ha trovato, per la verità, espressione negli scritti dei nostri migliori costituzionalisti. Ma Montanari ha mostrato sinteticamente come una forza politica che affonda le radici della propria azione nella carta fondativa della Repubblica, possiede una forza ideale straordinaria, una capacità egemonica ancora poco utilizzata nei suoi radicali presupposti egalitari.La situazione di contesto che dà speranza all’esperimento avviato è la non immediata scadenza elettorale.
Se una forza politica nascente è costretta, come sua prima iniziativa, alla corsa per le candidature, ormai lo sappiamo bene, è spacciata. C’è dunque tempo per ragionare e per affrontare le difficoltà gigantesche che si parano davanti. Magari pensando a una Costituente della sinistra, come propone Asor Rosa.
Ora, non c’è dubbio che i maggiori ostacoli vengono, a parte i vari aspetti tecnici e organizzativi, dal seguente problema: come far confluire le forze politiche organizzate, i partiti, come Sinistra Italiana e Rifondazione comunista, dentro il corso, certamente vitale, ma frammentato e magmatico, dei movimenti.
Questi partiti, sprezzantemente definiti “cespugli” dai nostri dottissimi media e da qualche politico altrettanto dotto, non sono ridotte di nostalgici. Benché non esenti da chiusure e settarismi, hanno una storia, talora radicamenti territoriali, sono frutto del lavoro volontario di migliaia di donne e di uomini che li fanno ancora vivere.
E’ giusto avere attenzione alle loro preoccupazioni di rischiare di scomparire in cambio di nulla. E’ giusto immaginare il riconoscimento del loro peso nella nuova organizzazione che dovrà nascere. Ma i loro dirigenti devono avere il coraggio di affrontare la sfida di un progetto indifferibile, senza il quale c’è forse la sopravvivenza di qualcuno, ma di certo la sconfitta di tutti: l’unificazione della sinistra in un nuovo organismo.
Provando a fare della presente debolezza – l’assenza di un leader massimo – un elemento di originalità: un partito-movimento diretto da un collettivo e coordinato da un portavoce che cambia a rotazione. Sarebbe una innovazione straordinaria, perché, diciamolo da storici, partito e democrazia non sono stati molto amici nel corso dell’ età contemporanea.
Infine, l’ambizione del tentativo è condizione del suo possibile successo. Non si tratta di costruire l’ennesimo cartello elettorale.Un orizzonte così limitato mostrerebbe l’irrimediabile strumentalità dell’operazione e allontanerebbe per sempre il popolo che vuole richiamare.
E’ il rischio di cui non si accorge Pisapia.
I lavoratori, i giovani, le donne, gli studenti, il ceto medio impoverito, il popolo delle periferie cerca donne e uomini che non solo li rappresentino in Parlamento, ma che condividano le loro lotte e bisogni, che stiano dalla loro parte, non solo nel momento della competizione elettorale, ma costantemente e all’interno di un progetto di lunga lena per cambiare la società italiana.

«vocidall'estero, 20 giugno 2017 (c.m.c.)
Il consolidarsi dei risultati del secondo turno delle elezioni legislative mostra ancora di più l’ampiezza con cui si è manifestato il rifiuto del voto. Se si sommano astensione, schede bianche e schede nulle – voti, questi ultimi, in forte aumento dal primo al secondo turno (da 500.000 a 2 milioni) – si supera il 61,5%, cifra data dal 57,36% delle astensioni più il 4,20% di schede bianche o nulle. Questo significa che appena il 38,5% degli elettori aventi diritto (ossia 18,31 milioni su 47,58 milioni) ha espresso effettivamente un voto al secondo turno. L’ampiezza del rifiuto del voto, a prescindere da quale forma abbia assunto, spinge a porsi alcune domande sul senso stesso di queste elezioni.
Paese “legale” contro paese “reale”?
Se non avessimo già abusato della contrapposizione maraussiana tra “paese legale” e “paese reale”, dovremmo utilizzarla proprio per descrivere la situazione attuale. Certo, la situazione non è assimilabile a quella in cui Charles Maurras aveva espresso questa dicotomia. Essa indicava aspetti diversi e non può essere ridotta alla sola cifra dei non-votanti. Eppure oggi abbiamo un “paese legale” nel quale il movimento “Republique en Marche” ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi all’Assemblea Nazionale tramite l’ultima tornata di elezioni, di cui nessuno contesta la legalità, ma questa maggioranza assoluta di deputati non può far dimenticare la maggioranza, questa volta davvero schiacciante al confronto, di francesi che non hanno votato o che hanno rifiutato di esprimere una scelta nel momento in cui hanno compilato la scheda di voto. È questa la discrepanza che giustifica, nonostante le remore storiche e politiche, il riutilizzo della dicotomia tra “paese legale” e “paese reale”. L’Assemblea Nazionale, per quanto sia legalmente autorizzata, ha un enorme problema di legittimità.
Una conseguenza di questo è che non c’è alcuna onda di consensi dietro al presidente e al suo partito. Il sistema elettorale francese, come sappiamo e abbiamo ripetuto a sufficienza, non fa altro che amplificare i risultati di una singola elezione. Tuttavia, nel 1981, durante la famosa “onda rosa”, l’astensione era stata solo del 24,9% (al secondo turno). Analogamente, nel 1993 durante “l’onda blu” ci fu un’astensione del 32,4%. Ora siamo in una situazione ben diversa. Ed è questa la situazione che dobbiamo considerare, al di là dei successi degli uni e dei fallimenti degli altri.
Crisi di legittimità e fratture politiche
Se anche – per miracolo – l’elezione fosse avvenuta secondo le regole del sistema proporzionale, – e allora, vorrei ricordare, “France Insoumise” avrebbe ottenuto 84 deputati (anziché solo 19) e il “Front National” ne avrebbe ottenuti 80 (anziché appena 8) – la legittimità dell’Assemblea Nazionale sarebbe stata comunque fragile. Naturalmente si può sempre dire che, in caso di rappresentanza proporzionale, l’astensione sarebbe stata meno marcata. Questo è possibile, ma è da dimostrare. È quindi necessario distinguere il problema della rappresentanza delle forze politiche all’interno dell’Assemblea Nazionale -problema che riguarda ovviamente la rappresentanza delle due forze di opposizione reale, e che potrebbe essere ridotto da un sistema elettorale un po’ diverso – dal problema della legittimità complessiva dell’Assemblea Nazionale, che deriva dall’ampiezza dell’effettivo “sciopero del voto” a cui abbiamo assistito da parte degli elettori francesi.
Questo “sciopero del voto”, che ha coinvolto il 61,5% degli iscritti, dimostra che la crisi politica in Francia, crisi che covava già dal 2012 e dalla rinnegazione europeista di François Hollande, e poi diventata crisi aperta dal 2013, non è ancora terminata. Gli incensatori di Emmanuel Macron e i propagandisti al soldo di “Republique en Marche” possono pure strombazzare in giro che con questa elezione si apre una nuova era. Ma sappiamo tutti che non è così. La società francese resta ancora spaccata in modo duraturo, a causa della disoccupazione, della disuguaglianza, del peso degli interessi delle grandi imprese e delle banche sugli ambienti politici e mediatici, ma anche a causa della crisi della scuola repubblicana, del modello di integrazione francese e del rischio terroristico. Di queste fratture ci ha dato un quadro più attendibile il primo turno delle elezioni presidenziali, che ha dimostrato come di fronte al campo del capitale – un campo che oggi si confonde con quello degli interessi “europeisti” – le diverse forze sovraniste nell’insieme potevano fare il loro gioco e ottenere la maggioranza.
Che futuro si prospetta?
Il grande rischio è di vedere il “paese legale” convincersi di avere tutti i diritti, e mettere in atto le riforme e le misure che aggraverebbero le fratture della società francese. Nei fatti questo rischio può assumere forme concrete differenti. La prima riguarda l’anomia, con una società che si disferebbe progressivamente sotto i colpi sempre più violenti che le vengono inferti, e frammenti di questa società che ricorrono alla violenza per cercare di far valere i propri diritti. Entreremmo allora in un mondo come quello di cui parla Hobbes, il mondo di una “guerra di tutti contro tutti”, con il più grande vantaggio – e la più grande felicità, si è costretti ad aggiungere – di quell’1% che ci comanda. La seconda strada, decisamente preferibile, vedrebbe i francesi unire le proprie forze contro le istituzioni occupate da una minoranza priva di legittimità, per far valere le proprie richieste. È stato questo l’appello rivolto domenica sera ai francesi da Jean-Luc Mélenchon.
Verso quale delle due forme di reazione penderà la bilancia è della più grande importanza. Ciò determinerà il nostro futuro. Bisogna quindi che le forze di opposizione, nel loro insieme, capiscano che non c’è soluzione possibile alla crisi politica se non nelle lotte collettive all’interno delle quali dovrà emergere, ancora una volta, l’idea del bene comune. Perché, e questo deve essere compreso da tutti, il “bene comune” non esiste al di sopra e al di là delle lotte sociali. Il bene comune va costruito all’interno di esse. Pertanto la nostra partecipazione alle lotte collettive sarà importante per definire il futuro che ci attende.
Allora e solo allora potrà essere trovata una soluzione alternativa a quello che alcuni colleghi hanno chiamato giustamente il “blocco borghese” o, più precisamente, il “blocco liberale”. Queste forze, senza rinunciare a ciò che costituisce la loro identità politica, dovranno capire che forme di unità sono necessarie, se un giorno vogliono veder trionfare le proprie idee.
Articolare “il” politico e “la” politica.
Questo implica una riflessione seria sui campi del politico e della politica. Il politico, come sappiamo, si definisce attraverso la contrapposizione tra amico e nemico. È lo spazio dei confronti antagonistici. Ma avere più avversari alla volta implica assumersi il rischio di essere sconfitti, soprattutto quando gli avversari sono a conoscenza del problema. La politica è invece lo spazio dei conflitti non-antagonistici, delle opposizioni e delle divergenze che possono legittimamente emergere tra le forze politiche, e che ad un certo punto dovranno essere risolte, ma la cui soluzione può passare temporaneamente in secondo piano rispetto ai confronti antagonistici prima menzionati. Chantal Mouffe ha definito questo lo spazio del “confronto agonistico”, secondo una distinzione che molti di quelli che si riferiscono al suo pensiero, ma evidentemente non lo hanno letto, farebbero bene a meditare.
Così, ci sono differenze importanti, persino radicali, tra i vari sovranisti, ma questo non dovrebbe impedire ai sovranisti di formare un fronte comune contro lo stesso avversario. È comprensibile che ci siano molti punti che in questi anni hanno contrapposto i militanti del Front National agli attivisti saldamente radicati nella sinistra di France Insoumise. Ci sono differenze nei punti di vista e nell’identità politica. Queste differenze continueranno a esserci anche nelle battaglie che si dovranno condurre. Ma gli uni e gli altri devono capire che queste differenze potranno essere espresse solo quando la sovranità del popolo, cioè la sovranità della Francia, sarà stata ripristinata. Ciò non implica affatto che le contrapposizioni che ci sono tra loro siano superficiali o poco importanti. Non lo sono, se si considera il campo economico, per esempio la questione fiscale.
Queste contrapposizioni ci sono, devono essere rispettate e sono legittime, in quanto rappresentano posizioni sociali differenti. Ma queste contrapposizioni non devono oscurare quella, al contrario irriducibile, tra i sovranisti e i loro avversari. Questo lo aveva capito Eric Dillies, candidato perdente del Front National per la circoscrizione Nord, dove è stato recentemente eletto Adrien Quatennens, candidato di France Insoumise. Eric Dillies aveva dichiarato a un giornale locale, la “Voce del Nord”: “Voterò per lui e ho invitato i miei elettori a seguire il mio esempio (…). Ho incontrato Adrien Quatennens ed è una brava persona. Di fronte a una maggioranza strabordante lui difenderà il popolo, non sarà uno yes-man” [1]. Eric Dillies è stato ascoltato dai suoi elettori e questo può aver contribuito al successo di Quatennens. Questo è un esempio di realizzazione della distinzione tra “il politico” e “la politica”, che i sovranisti dovranno imperativamente mettere in atto in futuro, se vorranno sperare di prevalere.
[1] http://www.lavoixdunord.fr/177015/article/2017-06-12/le-front-national-appelle-voter-pour-l-insoumis-adrien-quatennens

il manifesto,
21 giugno 2017 (c.m.c.)
Se ci fosse stato ancora bisogno di dimostrare che i grandi giornali hanno smesso di raccontare quello che succede per dar spazio solo ai dettagli che servono a corroborare la loro linea politica, l’assemblea del Brancaccio rappresenterebbe la migliore prova. Qualche migliaio di persone, protagonisti molti giovani (di per sé una notizia), 40.000 che seguono in streaming, decine di interventi che raccontano l’Italia invisibile alla vecchia politica ufficiale ma che esiste ed è ricca.
La vera salvezza di una democrazia altrimenti ridotta a povera cosa: comitati di base che si occupano di ambiente, migranti, scuola, solidarietà, lavoro, guerre. Questo è stato soprattutto l’assemblea di domenica, e di questo non una parola è comparsa sui quotidiani. Chi ha accennato all’evento è stato solo per misurare la distanza fra il teatro Brancaccio e Pisapia, che – diciamo la verità – non è “odiato” perché vuole unire, ma perché nessuno sa ancora chi rappres+enta e cosa vuole. (Non basta aver fatto bene il sindaco di Milano per proporsi come leader di una nuova sinistra).
Non è una lamentela , è l’ennesima drammatica prova che in Italia chi gestisce il potere, istituzionale e mediatico, non ha capito che qualcosa di grave è accaduto in questi ultimi decenni: la perdita di credibilità dei partiti e dei tradizionali corpi intermedi, ormai largamente incapaci di rappresentanza sociale e privi del loro tradizionale ruolo di organizzatori della partecipazione, ha prodotto una disaffezione per la democrazia gravida di possibili nefaste conseguenze.
La prima delle quali è il deliberato tentativo di sostituirla con l’accentramento del potere decisionale nelle mani di una governance che si vorrebbe neutrale (questa era la sostanza della posta in gioco del referendum costituzionale, e questa la principale ragione dell’opposizione al Pd di Renzi). Ebbene l’iniziativa di Falcone e Montanari prende le mosse da questa realtà per cercare di rigenerare la politica, e dunque la democrazia, ripartendo da quanto c’è di vivo: quelle forme di “cittadinanza attiva” che hanno dato vita ai tanti comitati di lotta sul territorio e, ultimamente, a coalizioni che le hanno raccolte a livello cittadino per tentare un nuovo tipo di presenza nelle istituzioni.
Rappresentano di per sé una compiuta alternativa di governo? Certo che no, ma indicano che ci sono forze che stanno costruendo le condizioni per ricostruire una rappresentanza democratica e così ridare legittimità alle istituzioni. Il dialogo con le aggregazioni che sono nate dallo sfaldamento del Pd si fa su questo, evitando le scorciatoie del leaderismo (un “grimaldello” cui abbocca anche qualche pezzo della sinistra); così come la sacralizzazione di una società civile buona e innocente e la demonizzazione dei partiti.
Su questi punti Montanari è stato chiarissimo: senza i partiti non c’è democrazia, la nostra Costituzione resterebbe monca. E chiarissima è stata Marta Nalin, la rappresentante della coalizione civica di Padova (23 % alle ultime comunali): «Reinventare i corpi intermedi, senza demonizzare i partiti e senza santificare la società civile».
Falcone e Montanari un percorso, non ancora la fondazione di un nuovo partito: questa è stata la loro sfida coraggiosa e intelligente. Fra i partiti esistenti ha raccolto l’adesione impegnata di Sinistra Italiana, ma, nonostante le sue consuete recriminazioni e diffidenze, anche di Rifondazione. E ha ricevuto attenzione anche da Articolo 1, sia pure, come è ovvio, ancora titubante. Perché, sia pure in modi diversi, tutti si rendono conto che siamo in una fase di trasformazione epocale e lontani ancora dall’aver raggiunto la maturità politica e culturale per indicare una compiuta strategia all’altezza dei problemi posti dal nuovo mondo.
Il Brancaccio registra la consapevolezza di questa insufficienza, salva i partiti esistenti come essenziali laboratori politici per forze che hanno già riscontrato una propria omogeneità di ispirazione e che però, per ora, si propongono di lanciare la sola sfida possibile in questa fase di transizione: quella di una risposta unitaria nelle prossime scadenze di lotta e istituzionali, una «Alleanza – come è stato detto – per l’uguaglianza e la democrazia».
Grazie dunque alla buona volontà di Anna e Tomaso, come sono stati ormai amichevolmente chiamati da tutti. Hanno avuto il merito di non farsi risucchiare, come purtroppo ancora tanti, dal «non c’è niente da fare», come se stando a casa, ognuno per conto proprio, se ne potesse poi uscire con una soluzione. Già declinare il “noi” e riprendere a riflettere assieme è una conquista.
Non pochi degli abituali pessimisti pessimisti (gli anziani, i giovani per fortuna non sono reduci di tante sconfitte) hanno osservato che di belle assemblee unitarie come questa del Brancaccio ce ne sono state tante negli ultimi 20 anni. E’ vero. Ma c’è un dato fondamentale che i promotori dell’iniziativa hanno capito: che il tempo attuale è molto diverso. Più pericoloso ma anche più consapevole dell’urgenza di una svolta rispetto a quanto è stato fatto in questi anni da chi ha governato e da chi è stato all’opposizione. Questa è la ragione per cui oggi si può ricominciare a proporsi un’alternativa.
I fischi, non tantissimi, , anche se deprecabili) a Gotor sono un segno delle diffidenze che questi difficili decenni che ci stanno alle spalle hanno creato. Non ci si può illudere che settarismi e estremismi, di cui anche il Brancaccio ha dato prova, potranno esser superati facilmente. Tocca a tutti ripensare se stessi e la propria parabola di questi anni: l’unità non si fa a partire da quel che siamo, ma da quello che ci si propone di diventare, ed è su questo che ci si confronta, se necessario anche duramente.
Mai col Pd, come ha detto Montanari? Ecco, su questo, solo su questo, un dubbio, ma forse siamo in realtà d’accordo: per quanto esangue, io credo ci sia ancora un corpo storico che viene dall’ormai dimenticato Pci, non solo vecchi ma anche una memoria, certo un po’ sbiadita, che coinvolge anche più giovani. Io credo che non dobbiamo ignorarli.
Ultimo problema, come si prosegue ora? Spero che nessuno si immagini che ci sarà un fantastico centro promotore di organizzazione dalle Alpi alla Sicilia. Bisognerà cercare di crearlo, ma questa nostra nuova sinistra deve soprattutto imparare a “fare da se”: ad ogni singolo militante in ogni singolo territorio l’onere e l’onore di promuovere l'”Alleanza”, e ogni altra forma di partecipazione che consenta a chi se la sente di costruirla. Reimparando a confrontarci, passo per passo, con gli altri compagni dell’avventura collettiva che abbiamo deciso di correre. Ripartire dai territori non vuol dire tornare all’Italia dei Comuni, ma all’Europa.

una straripante partecipazione, molto importante per l’avvio dell’impegnativo cammino, sono emersi tuttavia forti accenti identitari, una scarsa propensione all’unità». il manifesto, 20 giugno 2017
Non è che l’inizio,l’inizio di una perigliosa navigazione, però l’affollata assembleadi domenica al teatro Brancaccio hariunito le isole dell’arcipelago della sinistra, quelle che nel referendum del4 dicembre hanno vissuto e condiviso la felice battaglia per la Costituzione.
Accanto a una straripantepartecipazione, molto importante per l’avvio dell’impegnativo cammino, sonoemersi tuttavia forti accenti identitari, una scarsa propensione all’unità. Anzi,di più: l’impressione netta è che per il momento i carri della carovana dellasinistra in costruzione siano due. Orientati verso direzioni diverse edistinte.
Forse potrebberoincontrarsi per strada, ogni tanto, per convergere su alcune battagliepolitiche e sociali comuni. Ma se si votasse domani la spinta prevalentesarebbe a favore di due liste separate, il contrario di quel che i duepromotori, Anna Falcone e Tomaso Montanari, intendono perseguire con la lorocoraggiosa iniziativa. Sarebbe un esito molto negativo.
Naturalmente non per chipensa che venti deputati e un bottino elettorale del 3% siano l’obiettivo daraggiungere, ma sicuramente per chi ancora spera in un’aggregazione larga, conl’ambizione di oltrepassare i confini fin qui tracciati dagli attori rimasti incampo negli ultimi, drammatici anni della crisi.
L’elenco dei presentiall’incontro fa capire che le «isole» sono tantissime. I promotori Montanari eFalcone di Alleanza popolare per la democrazia e l’uguaglianza, SinistraItaliana, i Rifondaroli, i fuorusciti dal Pd e ora Art.1- Mdp (pochissimi), eD’Alema, Castellina, Civati, Ingroia, de Magistris (Claudio). Storie e vitepolitiche molto diverse tra di loro, ma non per questo meno animate da una vivae giusta convinzione: che c’è un mondo – piccolo, medio o grande che sia –oltre il Partito democratico.
Però quello che si notavadi più era proprio l’assenza dei tanti che in questa lunga traversata neldeserto della crisi, hanno voltato le spalle alla sinistra decidendo di nonvotare. Anche se c’erano esempi, esperienze portate al microfono da nuovegenerazioni, ragazze e ragazzi dei movimenti sociali.
E però nel rosso teatroviveva un terzo elemento, che si è mostrato ai presenti platealmente. Lacontestazione. Il rifiuto. Tangibile quando ha parlato il senatore MiguelGotor, uscito dal Pd con Bersani: le sue parole sono state coperte dalla salarumoreggiante, contenuta a fatica dagli organizzatori. L’episodio ha messo inrilievo il sentimento prevalente della riunione: mai un centrosinistra conRenzi, tenere alla larga quelli del Pd perché hanno contratto un «virus».
Ma se un ex, un fuoriuscitodal Pd viene a dire che si riconosce nei valori e nei contenuti dell’assemblea,non dovrebbe essere considerato come un nemico del popolo. Quindi un ostacoloin più. Bensì il segno tangibile di un meritato consenso.
L’immagine offerta alBrancaccio dalla platea e dagli intervenuti al dibattito, fa dunque risaltare,insieme alla vivacità e ai colori di una radicata presenza nella società,insieme all’orgoglio di una militanza tanto preziosa, i punti più deboli di una«alternativa» (non di governo) di sinistra: la mancanza di una reale unità; loscarso interesse verso chi negli ultimi anni ha deciso di non impegnarsi,perché disilluso e poco attratto dalle «minestre riscaldate»; la prevalenza diquelli convinti di avere la «giusta» linea.
E quindi comeuscirne? Non avendo la bacchetta magica possiamo solo avanzare qualchesuggerimento, sul filo dei discorsi fatti in passato sostenendo che «c’è vita asinistra».
Innanzitutto non dovrebberoprevalere atteggiamenti divisori, perché se è corretto sostenere che con Renzinon c’è futuro a sinistra, è sbagliato invece porre paletti o veti neiconfronti di chi ha rotto, con dolore e con fatica, con il proprio passato(penso a Bersani e ai bersaniani).
Poi ognuno dei «costruttoriper l’alternativa», dovrebbe essere in grado di dire, innanzitutto a se stesso,che non esistono questioni politiche irrinunciabili (tranne quelle legate aivalori e ai principi) e anche a questo serve una piattaforma programmatica.
Terzo punto, diconseguenza, bisognerebbe elaborare un programma politico economico e socialeper il Paese, sia sul breve che sul lungo periodo.
E, infine, last but notleast, identificare una leadership, un punto di riferimento,preferibilmente femminile, capace di unire, mettere insieme, essereprotagonista. La presenza dei leader è servita alla sinistra inglese eamericana per riunire le forze sparse alternative, di sinistra, democratiche,riformiste. Va preso atto che oggi la politica, in Italia e nel mondo, si fondaanche sul leaderismo. Che non significa avere una persona sola al comando, comeRenzi, Grillo, Berlusconi, Salvini.
La fantasia al potereè uno slogan che l’anno prossimo compie cinquant’anni, quanti ne sono passatidal 1968. Di quella fantasia ne abbiamo ancora un discreto bisogno, anche sulterreno della leadership che deve rappresentare un contenuto altrettantoforte e radicale.
Alla fine dell’estatequesta perigliosa navigazione dovrebbe trovare l’approdo in una Costituente,come suggeriva su queste pagine AlbertoAsor Rosa. Ovvero il risultato,l’approdo di un processo largo e democratico che discute le forme, il nome, ilsimbolo di una forza, di una Nuova Sinistra. Una prospettiva per la qualelavoreremo per aiutare un esito felice di questo processo.

il manifesto, 18 giugno 2017 (c.m.c)
Il rapporto del Gruppo interdisciplinare sulla medicina basata sulle evidenze (Gimbe) ha riaperto una discussione ciclica sul costo della sanità italiana. La spesa sanitaria italiana è poco inferiore alla media europea, e in percentuale sul Pil dovrebbe scendere ulteriormente al 6,5% nel 2019. Tuttavia, secondo il rapporto Gimbe, ci sono ancora sprechi e inefficienze, calcolabili nel 20% circa della spesa sanitaria totale. Di norma, dibattiti di questo tenore preludono a nuovi tagli in nome della razionalizzazione.
L’esperienza, però, suggerisce che malgrado la pesante riduzione di spesa, l’efficienza del sistema sanitario non sia migliorata, anzi. L’impressione è che i tagli favoriscano la parte malata del sistema sanitario, dove proliferano sprechi, clientele e frodi, a danno del servizio sanitario pubblico. Dal canto suo, quest’ultimo invece ottiene regolarmente riconoscimenti internazionale, per la capacità di coniugare l’accesso a tutte le fasce sociali con un livello elevato di qualità delle prestazioni. L’equilibrio però è sempre più precario: la spesa sanitaria alimenta gli sprechi, ma riducendola si lede il diritto sociale alla cura. In entrambi i casi, il vero sconfitto è il paziente.
Una delle cause principali degli sprechi è il grande numero di prescrizioni sanitarie inutili. Secondo le stime, circa tredici miliardi di euro si volatilizzano in esami medici inutili, prescritti con leggerezza sia dai medici di base che nei reparti di ospedale. Proprio per restituire sobrietà al sistema sanitario, senza pregiudicarne il carattere universale e pubblico, è nata l’associazione Slow Medicine. E il riferimento a Slow Food non è affatto casuale. Oggi, infatti, troppo spesso si va dal medico a chiedere esami specialistici come a un supermercato per fare la spesa. Tra i fondatori di Slow Medicine, figurano medici, ma anche scienziati, economisti studiosi di comunicazione, tutti uniti dalla promozione di una medicina «sobria, rispettosa e giusta». Per capire come migliorare la sanità italiana, abbiamo parlato con il suo presidente Antonio Bonaldi. 65 anni, bergamasco, ha diretto diverse Aziende Sanitarie Locali del nord Italia, e conosce dunque da vicino la sanità pubblica e i suoi problemi.
La sanità italiana non è già abbastanza «slow»? Per un’ecografia bisogna aspettare molti mesi…Il nome si presta a interpretazioni maliziose, ma per noi «slow» vuol dire «agire senza fretta», o «prendersi il tempo». Invece spesso si agisce senza riflettere: per esempio si prescrivono esami medici illudendosi che «più» significhi «meglio». I greci avevano due termini per il tempo, chronos e kairos. Noi stiamo con kairos.
Si spieghi meglio.Il primo indica la sequenza degli eventi. Il secondo è il tempo giusto per fare le cose, dunque l’evento nella sua relazione con il contesto. Per noi «slow» significa questo, anche in medicina. Il dialogo e la relazione con il paziente sono un elemento fondamentale. Instaurare un rapporto con il paziente serve a spiegare che certi problemi medici non hanno una soluzione immediata. Invece ci si preferisce prescrivere esami o terapie inutili. Ma troppi esami non sono solo inutili: sono dannosi. Si arriva al paradosso di una medicina che ammala, invece di guarire.
Però il paziente è più soddisfatto…Soprattutto, si evitano contenziosi. Perché quando l’esito di una malattia è negativo, spesso nascono cause legali e si dà la colpa al dottore. Perciò, il dottore prescrive qualunque esame per dare l’impressione che si stia facendo tutto il possibile. Ci costa 10 miliardi di euro l’anno, e vale il 10% dell’intera spesa. Quasi l’80% dei medici ci casca. Ma così il paziente si illude che la medicina sia una scienza esatta e che la tecnologia fornisca la soluzione per ogni problema, perciò aspettative e contenziosi aumentano ulteriormente.
I contenziosi legali si evitano instaurando un dialogo con l’ammalato. Infatti, le cause si concentrano nella medicina ospedaliera, non riguardano il medico di base che conosce meglio i suoi pazienti.
Il decreto Lorenzin sull’«appropriatezza prescrittiva» del 2015 voleva porre un freno a questo fenomeno.
Ma non funzionava, e infatti è stato abrogato nelle sue linee sostanziali. Il decreto aumentava i controlli sulle prescrizioni dei medici, ma l’appropriatezza non si può raggiungere a colpi di decreto. Quando tra dottore e paziente si inserisce la legge, viene meno il patto che li lega. Il dottore non prescrive esami che ritiene necessari per paura di controlli, mentre il malato crede che per ragioni di risparmio economico gli sia negato un diritto fondamentale come il diritto di essere curati. Due figure che dovrebbero collaborare, il malato e il paziente, vengono messe l’una contro l’altra. Bisognerebbe invece intervenire sulle cause a monte, sugli interessi anche economici che spingono a prescrivere troppo.
Può essere più preciso?
La ricerca medica è guidata dall’industria, che persegue il profitto. Troppi dispositivi medici sono introdotti sul mercato senza che la loro efficacia sia provata da ricerche serie, ma da articoli sponsorizzati dalla stessa industria. Si pensi alla moda degli integratori vitaminici, del tutto inutili ma diffusissimi.
Anche la sanità italiana però qualche colpa ce l’ha, o no?
Certo, l’eccesso di prescrizioni e la cattiva gestione vanno di pari passo. Basta controllare i dati forniti sul web dal Programma Nazionale Esiti per capirlo.
Per esempio?
Le fratture al femore vanno operate entro 48 ore, altrimenti si rischia di morire. Però, il Piano nazionale esiti ci dice che, per mancanza di ortopedici, solo il 60% dei pazienti viene operato in tempo. D’altra parte, in Italia si fanno duecentomila interventi in artroscopia l’anno. In gran parte, per curare l’osteoartrosi. Ma come conferma anche un recente articolo del British Medical Journal, contro l’artrosi la fisioterapia ha la stessa efficacia della chirurgia, a costi molto inferiori. Se si facessero meno interventi in artroscopia, si libererebbero ortopedici per interventi necessari come quelli al femore.
Quali consigli darebbe al ministro per rendere più efficiente il sistema sanitario?Ripeterei quello che consiglia un recente rapporto dell’Ocse intitolato «Tackling wasteful spending on health». Innanzitutto, agire sulle prestazioni inutili. In secondo luogo, a parità di efficacia, privilegiare le alternative terapeutiche meno costose. Infine, per ordine di impatto economico, intervenire su frodi, inefficienze e ridondanze.
Non sarebbe utile investire maggiormente in prevenzione?
Certo, a patto che non si scambi il concetto di «prevenzione» con quello di «diagnosi precoce», perché in quel caso si aumenterebbe ancora di più il numero delle prescrizioni. Per prevenire occorre agire sul contesto o, come diciamo noi, «coltivare la salute« nei vari settori: l’ambiente, l’alimentazione, la sicurezza sul lavoro, i vaccini.
Quindi la nuova norma sui vaccini vi trova d’accordo.
No, l’approccio del ministro Lorenzin è di nuovo sbagliato. Lo abbiamo spiegato in un documento stilato insieme alle trenta associazioni della rete «Sostenibilità e salute». Intendiamoci, i vaccini sono importantissimi. Ho diretto per molti anni un’azienda sanitaria locale e io stesso ne ho prescritti a migliaia. Ma i vaccini non si impongono per legge, con pene severe per chi non la rispetta. Dodici, per giunta. I vaccini vanno prescritti caso per caso, secondo le esigenze di ciascuno, perché si tratta comunque di farmaci. Con i genitori bisogna parlare e convincerli. Non ha senso dividerli tra chi è «per» e chi è «contro» i vaccini. Sarebbe come dividersi tra chi è «contro» o «a favore» dei farmaci. E quando si creano fazioni contrapposte, le persone smettono di ragionare. E a quel punto diventa difficilissimo convincerle.
 Una breve cronaca dell'evento e l'intervento di Tomaso Montanari.
Una breve cronaca dell'evento e l'intervento di Tomaso Montanari.
libertaegiustizia.it, 19 giugno 2017 (p.d.)
FALCONE E MONTANARI,
PER LA SINISTRA
UNA NUOVA SPERANZA
di Rossella Guadagnini
L’esordio è esplicito: “Vogliamo costruire una grande coalizione civica di sinistra, alternativa al Pd, capace di portare in Parlamento quella metà del Paese che non vuole andare a votare”. Comincia così l’intervento di Tomaso Montanari che apre la giornata del 18 giugno al Teatro Brancaccio di Roma. Lo storico dell’arte inaugura i lavori dell’assemblea insieme ad Anna Falcone, avvocata e vice presidente del Comitato del No al Referendum costituzionale, che li chiuderà sei ore dopo. Insieme hanno lanciato un appello, “Alleanza popolare per la democrazia e l’uguaglianza” a cui oggi hanno risposto in oltre 1500. Più i 50mila contatti delle visualizzazioni in video. Sono presenti le varie anime della sinistra, dagli esponenti politici agli attivisti di movimenti sociali e agli ambientalisti; dagli studenti (il più giovane che interviene ha 18 anni) ai sindacalisti.
“L’obiettivo finale -prosegue Montanari- è una sola lista a sinistra e, da domani, può partire il passaggio costituente: non c’è un nome, non c’è un programma, non c’è una leadership. Vorremmo portare in Parlamento un’alleanza fra cittadini, associazioni e partiti. In autunno si farà una grande assemblea nazionale, per definire un nome, un simbolo, i criteri per le candidature”. Applausi, poi iniziano le considerazioni. “La stagione del centrosinistra è finita -afferma lo storico dell’arte- Non c’è alcuna esclusione, ma deve essere chiaro che chi è qui la Costituzione la vuole attuare, non rottamare. E’ il futuro che ci sta a cuore, non la resa dei conti col passato. Pisapia lo abbiamo invitato: ha risposto che ‘non ci sono le condizioni perché io venga’. Non è un buon inizio, ma ha almeno il pregio della realtà: il 1 luglio ci aspettiamo una risposta chiara su cosa pensa del Jobs Act, della buona scuola…”. Quindi conclude: “Noi puntiamo a percentuali a due cifre, una nuova lista Arcobaleno non serve a niente”.
Qualche polemica per Miguel Gotor, senatore di Articolo 1-Mdp, specie quando cita il nome di Pisapia in un richiamo all’unità politica. Apprezzato invece Pippo Civati di Possibile: “Dobbiamo essere uniti, ma se qualcuno insiste per andare con Renzi non lo trattiene nessuno”. E Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana: “L’unità è un valore, ma all’unità non si può sacrificare la credibilità” e accende la platea con la richiesta di “uscire dalle formule astratte, una discussione che non parla più alla vita delle persone”. Sul tema del lavoro, che serpeggia per tutta la giornata, il leader di SI ricorda: “E’ stato detto che in Italia si lavora poco: non è vero. Con una media di 1800 ore l’anno, lavoriamo di più. E’ venuto il momento di ridurre l’orario di lavoro”. Molto apprezzato anche Maurizio Acerbo, nuovo segretario di Rifondazione Comunista, che ha raccontato: “Al telefono un impiegato di un call center mi ha detto: lei è comunista? Ma se i comunisti non ci sono più”.
Seduti in prima fila, in platea, l’uno accanto all’altro, Massimo D’Alema e Nichi Vendola. Poi c’era Antonio Ingroia di Rivoluzione civile, che però non ha avuto la parola ed è andato via con la scorta, e decine di parlamentari delle formazioni presenti e passate della sinistra. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, Corradino Mineo, Vincenzo Vita, Raniero La Valle, Alfonso Gianni, Roberto Speranza, Stefano Fassina, Eleonora Forenza e l’Altra Europa con Tsipras.
E i giornalisti: Norma Rangeri, direttrice de il manifesto, Paolo Flores d’Arcais direttore di MicroMega, Massimo Bordin di Radio Radicale, Roberto Natale. Sul palco, invece, è salito Paolo Foschi del Corriere della Sera, che ha fatto il punto sullo stato dell’informazione in Italia, sui nuovi “servi di redazione”, giornalisti precari e collaboratori, sottopagati e minacciati. Si è parlato di donne con Francesca Koch della Casa internazionale delle donne e di scuola con Marina Boscaino. Di welfare e di salute. Infine i magistrati, Paolo Maddalena e Livio Pepino: il primo, già presidente della Corte Costituzionale, ha sottolineato i mali economici di un Paese come il nostro che, continuando con le attuali politiche, rischia di depauperare anche il proprio patrimonio di imprese, oltre a quello artistico e paesistico. Il secondo ha esortato la nuova forza nascente a non commettere gli errori del passato.
“La terza via ha fallito l’intento, dunque perché ripeterne gli sbagli?” ha ribadito a sua volta Anna Falcone nel prendere la parola per l’intervento conclusivo. “Si parla di una sinistra rancorosa, noi invece vogliamo una sinistra felice. I giovani sono importanti, purché siano con noi non solo per protestare, ma per costruire uno spazio nuovo. I cittadini italiani non hanno più tempo: il nostro obiettivo è operativo, individuare i punti che ci uniscono per presentarci alle prossimi elezioni e costituire una nuova speranza per chi si è disaffezionato alla politica, è deluso e si sente demotivato. Sulla scheda che è stata distribuita all’ingresso sono espresse due questioni cruciali su cui si chiede ai partecipanti dell’assemblea di esprimersi: le priorità di un programma condiviso e la vostra idea in più per un progetto coraggioso e innovativo. Dobbiamo operare un taglio netto con il passato per essere credibili, una discontinuità. Tutti devono fare un passo indietro per poterne fare uno in avanti. Dobbiamo offrire soluzioni praticabili per un reale rinnovamento, per una politica che rimetta al centro un ideale condiviso di società e faccia battere il cuore”.
“I nostri punti fermi -riassume Falcone- sono lavoro, reddito minimo di cittadinanza, ambiente e riconversione energetica, scuola, formazione e ricerca, sanità pubblica, sovranità popolare. Noi vogliamo una democrazia realmente partecipata, in cui uno vale uno; un’informazione libera e corretta. E vogliamo tempo, tempo per la nostra vita, per la cose che ci appassionano, per i nostri figli. Vogliamo equità fiscale, assistenza e inclusione sociale sui migranti. E un’economia sostenibile. La Costituzione è di tutti, va solo attuata. Il voto è utile se ti rappresenta e noi vogliamo costruire uno spazio che finalmente ci rappresenti. Siamo qui per tornare a combattere”.
UN PROGETTO DI
GIUSTIZIA E UGUAGLIANZA
di Tomaso Montanari
Pubblichiamo l’intervento di Tomaso Montanari pronunciato all’assemblea di Alleanza Popolare per la Democrazie e l’Uguaglianza, che si è svolta al Teatro Brancaccio di Roma, il 18 giugno 2017. Il presidente di Libertà e Giustizia ha scritto questo intervento e ha partecipato all’assemblea di cui è stato promotore, insieme a Anna Falcone, come privato cittadino e non nelle vesti associative.
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
L’articolo 3 della Costituzione della Repubblica. Il cuore del progetto che uscì dall’antifascismo e dalla Resistenza. Ecco il nostro punto di partenza. Ma è anche il nostro punto di arrivo: l’attuazione dell’eguaglianza sostanziale, l’inclusione, la persona umana come misura di tutte le cose. Questa la bussola, questa la mèta. Questo il metro per costruire una vera coalizione civica di sinistra.
L’inclusione è una prospettiva rivoluzionaria, in una Italia in cui imputiamo ai migranti come una colpa, addirittura come un reato, l’essere nati altrove. Abbiamo ridotto ad un problema contabile – di quote e flussi – la questione centrale di questo tempo: una migrazione di massa che ci interpella senza sosta circa la qualità della nostra democrazia, circa la realtà della nostra Costituzione, e anzi circa la nostra stessa umanità. È a Lampedusa, è nel disastro umano e democratico di Ventimiglia – non qua a Roma – che si capisce cosa vuol dire essere eguali, o non esserlo.
Partiamo dalla Costituzione perché – lo sappiamo tutti – non saremmo oggi qua senza la lunga battaglia culminata nella straordinaria vittoria del No, lo scorso 4 dicembre. Ma bisogna essere molto chiari. Ci è stato spesso rimproverato che il No non fosse un progetto politico. E oggi ci si dice che non esiste un popolo del No. È vero. Hanno ragione: non esiste un popolo del No, esiste un popolo della Costituzione. Un popolo che sente proprio, e urgente, il progetto della Costituzione. E che ora vuole attuarlo. Abbiamo capito che con quella riforma costituzionale non erano in gioco solo singoli articoli. Era revocato in dubbio un intero progetto. Erano messi in discussione i principi fondamentali della Carta. Abbiamo detto no ad una oligarchia. Abbiamo detto no alla formalizzazione della oligarchia della finanza e delle banche. E abbiamo detto no perché volevamo dire un grande Sì: un Sì alla democrazia.
E la nostra idea di democrazia è quella che Michel Foucault leggeva in Aristotele: «La risposta di Aristotele (una risposta estremamente interessante, fondamentale, che entro certi limiti rischia forse di provocare un ribaltamento di tutto il pensiero politico greco): è che è il potere dei più poveri a caratterizzare la democrazia». Ebbene, oggi è vero il contrario. Il potere è saldamente nelle mani dei più ricchi. E, come ha scritto Tony Judt, «i ricchi non vogliono le stesse cose che vogliono i poveri. Chi dipende dal posto di lavoro per la propria sussistenza non vuole le stesse cose di chi vive di investimenti e dividendi. Chi non ha bisogno di servizi pubblici (perché può comprare trasporti, istruzione, e protezione sul mercato privato) non cerca le stesse cose di chi dipende esclusivamente dal settore pubblico. … Le società sono organismi complessi, composti da interessi in conflitto fra di loro. Dire il contrario (negare le distinzioni di classe, di ricchezza, o di influenza) è solo un modo per favorire un insieme di interessi a discapito di un altro».
Oggi tutto il sistema serve a perpetuare una radicale negazione della democrazia, bloccandoci in gated communities: gruppi divisi per censo e ben recintati, culturalmente, socialmente e materialmente. Gruppi dai quali è impossibile evadere. Oggi si parla di una Sinistra rancorosa. Se ci si riferisce ai regolamenti interni di un ceto politico autoreferenziale e rissoso, sono d’accordo. Non sono d’accordo, invece, se ci si riferisce alla sacrosanta rabbia che in molti proviamo per questo stato delle cose. Una indignazione che è la molla fondamentale per ridiscutere i fondamentali di una politica profondamente corrotta, in tutti i sensi.
Occorre rovesciare il tavolo della sinistra, per tornare a guardare le cose dal punto di vista di chi è caduto a terra: non da quello di chi è garantito. Noi oggi siamo qua per fare nostro questo punto di vista. Il punto di vista di chi è caduto, di chi non si è mai alzato. Quando è stato chiaro che ciò che pure si continua a chiamare ‘sinistra’ sarebbe stata sotto il controllo di una oligarchia senza alcuna legittimazione dal basso, e intimamente legata al sistema, abbiamo detto: ‘basta’. Se l’unica prospettiva della sinistra era tornare ad allearsi, in qualunque forma, al Pd di Matteo Renzi, ebbene noi non avremmo nemmeno votato.
Io ed Anna Falcone abbiamo deciso di invitarvi a venire qua oggi, quando l’ennesimo amico ci ha detto che alle prossime elezioni politiche non avrebbe votato. Quando noi stessi ci siamo confessati un identico stato d’animo. Milioni di persone – tra cui moltissimi giovani – che il 4 dicembre erano andati ai seggi per dire no a quel progetto di oligarchia, ora non vedono niente a cui dire sì con un voto. Nessun progetto di giustizia ed eguaglianza. Solo giochi di potere: autoreferenziali, incomprensibili. Senza futuro: morti. E «lasciate che i morti seppelliscano i morti», dice il Vangelo. Tutti questi giochi sono basati su un assunto, un dogma, una certezza: che ormai in Italia voti solo il 50% dei cittadini. E sulla cinica consapevolezza che quel 50% che vota è la metà più garantita, più protetta. Quella che ha qualcosa da perdere. E che, invece, nel 50% che non vota ci sono i sommersi. I disperati. I disillusi. Gli scartati, di cui nessuno si cura.
Ebbene, l’idea che ci ha condotti oggi qua è molto semplice: costruire una grande coalizione civica nazionale e di sinistra capace di portare in Parlamento questa metà di Italia. Con il suo dolore, le sue ferite, le ingiustizie patite. Ma anche con il suo progetto, la sua voglia di riscatto, la sua fame di futuro. La sua fantasia. Abbiamo difeso con i denti una Repubblica parlamentare. Abbiamo rigettato il disegno di uno strapotere del potere esecutivo. Ebbene, siamo coerenti: è il Parlamento il centro della vita democratica. Una delle ragioni della decadenza della nostra democrazia è l’umiliazione perpetua del Parlamento, cristallizzata in sistemi elettorali che l’hanno consegnato alla cieca fedeltà a pochi capi. E allora: è venuto il momento di lavorare sulla rappresentanza, non sul feticcio della governabilità. In questi giorni siamo stati rimproverati perché non pensiamo ad una sinistra di governo. Vorrei rispondere con chiarezza e con forza. In questi ultimi vent’anni la sinistra italiana ha scambiato i fini con i mezzi: il governo è diventato un fine, e ci siamo dimenticati a cosa serviva, governare. E invece il governo è un mezzo, è uno strumento, per attuare un progetto: e noi oggi vogliamo lavorare al progetto, portando in Parlamento l’energia, la sofferenza, la visione di questo Paese. È questo l’unico voto veramente utile: quello che costruisce rappresentanza democratica, portando in Parlamento l’altra metà dell’Italia. Un grande progetto di inclusione e di attuazione della sovranità.
Sia chiaro. Sappiamo bene che è nelle città che si gioca la partita più carica di futuro. La distruzione delle economie dei comuni, la verticalizzazione elettorale delle figure dei sindaci, l’alienazione dello spazio pubblico, il massacro dei tessuti urbani hanno fatto delle cento città italiane altrettante fabbriche della diseguaglianza e della infelicità. Ma dove è il pericolo, là si trova anche il rimedio: ed è da quelle stesse città che sono partite mille esperienze di rinnovamento: molte delle quali oggi sono rappresentate tra noi. Si tratta di esperienze cruciali, la vera novità della scena politica italiana. Penso – per esempio – all’esperienza delle coalizioni civiche di sinistra di Padova e di Catanzaro. Quel che conta in questi esempi è la qualità di una partecipazione intensa e lucida, che ha tenuto insieme partiti, associazioni e cittadini. Tanti cittadini: cittadini che avevano da anni rinunciato alla politica. Ecco il punto: riunire, federare, far dialogare, mettere insieme, cucire tutte queste esperienze di partecipazione civica, facendole sfociare in Parlamento, centro della comunità civile italiana.
Basta guardare a queste esperienze sparse per tutta Italia per comprendere che siamo di fronte ad una rottura con la formula del centro-sinistra. Ma non è questione di sigle, né tantomeno si tratta di escludere un’area politica. È questione di storia, di fatti. È ai governi di centro sinistra che dobbiamo lo smontaggio sistematico del progetto della Costituzione. La prima riforma costituzionale votata dalla sola maggioranza parlamentare è stata la riforma del Titolo V della Costituzione sul finire della prima legislatura dell’Ulivo. È stato un governo di centro sinistra a decidere una guerra illegittima sia per la Carta dell’Onu, sia per la nostra Costituzione. L’approccio restrittivo all’immigrazione è stato introdotto dalla legge Turco-Napolitano. L’avvio della precarizzazione dei rapporti di lavoro la dobbiamo alla riforma Treu. L’abbandono del ruolo dello Stato nell’economia (e dunque nella vita dei cittadini) è avvenuto in forza delle privatizzazioni incontrollate e delle spesso altrettanto incontrollate liberalizzazioni volute da governi di centro sinistra. La mancanza di una seria legge contro la concentrazione dei mezzi di informazione è frutto di scelte compiute durante la prima legislatura dell’Ulivo. Il colpo finale alla progressività fiscale è venuto dalla stessa area politica. La “federalizzazione” dei diritti, che oggi ne impedisce l’uguale attuazione su tutto il territorio nazionale (pensiamo alla sanità!), è iniziata con le riforme di Franco Bassanini. L’infinita stagione della distruzione della scuola e della aziendalizzazione dell’università porta anche la firma di Luigi Berlinguer. E l’espianto di fatto dell’articolo 9 della Costituzione – quello che protegge ambiente e patrimonio culturale – non lo si deve a Lunardi o a Bondi, ma ai governi Renzi e Gentiloni, con lo Sblocca Italia e la riforma Franceschini.
Infine, il completo abbandono del Mezzogiorno d’Italia a se stesso: una delle macro-diseguaglianze più atroci e insopportabili. Un abbandono sancito dalla cinica alleanza tra il Pd e il peggio dei governi regionali del Sud: basti pensare allo scandalo della Campania. Quando noi diciamo che è finita la stagione del centro sinistra, diciamo che bisogna rompere con tutto questo: bisogna rompere con una sinistra alla Tony Blair, che fa il lavoro della destra. Con un Renzi indistinguibile da Berlusconi.
Bisogna finirla con un centro sinistra che ha sostanzialmente privatizzato il rapporto tra il cittadino e i suoi diritti, sterilizzando e di fatto abrogando i principi fondamentali della Costituzione. Come ha scritto Luciano Gallino, la «“costituzione” non scritta, ma applicata da decenni con maggior rigore di molte Costituzioni formali, … [è] volta a cancellare le conquiste che la classe lavoratrice e le classi medie avevano ottenuto nei primi trenta o quarant’anni dopo la guerra». Gallino ha spiegato che il primo articolo di questa legge – virtuale, ma ferrea – fatta propria in Italia dal centro sinistra dice che «lo Stato provvede da sé a eliminare il proprio intervento o quantomeno a ridurlo al minimo, in ogni settore della società: finanza, economia, previdenza sociale, scuola, istruzione superiore, uso del territorio».
Alcune personalità politiche che hanno contribuito a questo smontaggio dello Stato oggi non stanno con il Partito Democratico di Matteo Renzi (erede naturale di quelle politiche), ma dicono di voler partecipare ad un processo unitario a sinistra. «Ci siamo dimenticati dell’uguaglianza», ammette Romano Prodi nel suo ultimo libro: chi la pensa così, è benvenuto. Non c’è alcun bando, alcuna proscrizione, alcuna esclusione. Ma deve essere chiaro che la rotta è invertita. Che la rotta è diametralmente opposta a tutto questo. Non chiediamo un’abiura rispetto al passato (e come potremmo? a che titolo?): ma dev’essere chiaro che qua vogliamo costruire un futuro diverso. Lo stesso vale, sia chiaro, per le posizioni espresse al referendum del 4 dicembre. Nessuno è bandito perché ha votato sì. Ma nel momento in cui il Pd e Forza Italia annunciano che nella prossima legislatura riproveranno a manomettere la Costituzione, bisogna che ci sia un impegno esplicito e non derogabile: chi sta da questa parte la Costituzione vuole attuarla, non rottamarla.
È il futuro che ci sta a cuore: non la resa dei conti con il passato. E, allora, cosa vogliamo per il futuro? Provo a dire tre cose concrete, che indicano la direzione. Vogliamo applicare l’articolo 53 della Costituzione, quello che impone la progressività fiscale: sia per i redditi, che per i patrimoni.
Negli ultimi decenni sono state aumentate le tasse ai poveri per poterle diminuire ai ricchi. Occorre invertire la tendenza. Le tasse vanno ridotte a chi ne paga troppe: ai redditi bassi e ai redditi medi; vanno aumentate a chi ne paga poche: ai redditi alti e altissimi. Solo allora una lotta senza quartiere all’evasione fiscale potrà avere successo. Ci vuole una seria imposizione patrimoniale. E occorre ripristinare una seria imposta di successione. Perché una seria progressività fiscale realizza due obiettivi: consente di raccogliere le risorse necessarie a sostenere e incrementare lo stato sociale e opera una redistribuzione della ricchezza. Come ben sappiamo, la Costituzione è fondata sul lavoro, nel senso che indica una precisa prospettiva di trasformazione della società. È la rivoluzione promessa di cui parlava Piero Calamandrei. Ed è per questo che la disoccupazione sfigura le vite delle persone e contemporaneamente mina la tenuta della democrazia. Per questo la Costituzione non sarà attuata finché non ci sarà parità di retribuzione tra uomini e donne.
Solo ieri siamo scesi in piazza, con la CGIL, per denunciare il vero e proprio inganno costituzionale compiuto dal governo Gentiloni sui voucher: un atto grave nel merito, e ancor più grave perché aggirando e contraddicendo un referendum già convocato distrugge, dall’alto e dall’interno delle istituzioni, quel rispetto della legalità costituzionale che è il presupposto minimo per il funzionamento della nostra democrazia. La Costituzione costruisce i rapporti economici su un equilibrio tra capitale e lavoro. Ma oggi il capitale spadroneggia sul lavoro. Lo Stato per primo abusa del precariato (nella scuola, negli ospedali, nelle biblioteche, nei musei). Bisogna tornare a un rapporto più equilibrato. La prima cosa da fare è reintrodurre una disciplina il più possibile unitaria dei rapporti di lavoro: bisogna tornare a un contratto, tendenzialmente unico, a tempo indeterminato. A tutele uguali per tutti.
E poi l’ambiente: come ha detto con forza Barack Obama, siamo probabilmente l’ultima generazione che può ancora fermare l’autodistruzione del genere umano. L’Italia non l’ha capito. La media del nostro consumo di suolo è del 7% annuo, contro il 4,1 medio dell’Unione Europea. Matteo Renzi e Maurizio Lupi, con lo Sblocca Italia, hanno slegato le mani ai signori del cemento e delle grandi opere (dal Tav in Val di Susa al fantasma ricorrente del Ponte sullo Stretto), con un’idea di sviluppo distruttiva e tremendamente vecchia. Invece, l’unica vera opzione è UGO: l’Unica Grande Opera utile, e cioè il risanamento del territorio italiano. La prevenzione antisismica, la cura idrogeologica, la conservazione programmata del patrimonio culturale, che con il territorio è indissolubilmente fuso. Una vera spending review dei conti pubblici, ma orientata sui valori fondamentali della Costituzione (e dunque in primis rivolta a comprimere una sempre crescente spesa militare), è la premessa necessaria per finanziare questa immensa opera: capace di dare lavoro a centinaia di migliaia di persone, e di farci risparmiare i miliardi che buttiamo per riparare alle continue catastrofi ambientali in gran parte provocate da noi stessi.
È venuto il momento di ricostruire lo Stato, e il suo ruolo. Uno stato capace di fare l’interesse di tutti. Bisogna mettere fine “al sistematico sacrificio degli interessi pubblici più sacrosanti (la salute, la difesa del paesaggio e del patrimonio artistico, l’ordinato sviluppo urbanistico, l’onesto rispetto della legge e dell’equità) agli interessi privati, di parte, di corrente, di gruppi e uomini nella lotta per il potere”: sono parole di Enrico Berlinguer, pronunciate nel 1974.
Oggi l’interesse pubblico – anzi direi la possibile felicità pubblica – parte dalla scuola, dalla conoscenza, dalla cultura. Uno dei tratti più torvi del potere berlusconiano e renziano è stato, ed è, il disprezzo per la conoscenza, e il connesso travisamento del ruolo della scuola. La scuola ha un unico compito: formare il cittadino sovrano di domani, e creare uguaglianza. Non produrre clienti, consumatori o schiavi. E ogni bambino perduto è un cittadino perduto. L’ultima rilevazione dell’Istat dà la dispersione scolastica al 14,7%, con picchi del 24% in Sicilia o in Sardegna. La media europea è dell’11%, l’obiettivo per il 2020 è del 10%. Di fatto oggi in Europa percentuali più alte ci sono solo in Spagna e Portogallo, Malta e Romania. Nell’Italia di oggi l’analfabetismo funzionale (cioè la condizione di chi avendo letto un testo, non è in grado di riferirne correttamente i contenuti) è al 47%.
La Costituzione impone alla Repubblica di promuovere «lo sviluppo della cultura e la ricerca»: il progetto è quello di una redistribuzione di massa di una conoscenza continuamente rinnovata dalla ricerca, l’obiettivo è formare un cittadino consapevole, attivo, critico. Una società critica, una società del dissenso non è un ostacolo allo sviluppo: è una condizione essenziale per la democrazia. Ma le politiche degli ultimi decenni, con un’accelerazione finale, sono andate in direzione diametralmente opposta. La cosiddetta cultura, e con essa il patrimonio culturale e la ‘buona’ scuola: tutto è stato messo al servizio di una generale de-intellettualizzazione del Paese, al servizio di un assopimento collettivo della coscienza critica, al servizio di una nostra radicale metamorfosi da cittadini in clienti, consumatori, spettatori. Invertire la rotta è la prima condizione per cambiare lo stato delle cose: anzi per immaginare che cambiarlo sia possibile.
Sappiamo bene che perché lo Stato italiano provi ad attuare il progetto della sua Costituzione bisogna ridiscutere i fondamenti dell’Unione Europea. Non c’è dubbio che gli obiettivi dei trattati europei divergano in modo anche radicale da quelli che la nostra Costituzione ci impone. Questo oggettivo scontro finora ha piegato la Costituzione: fino al punto da farci inserire il pareggio di bilancio nell’articolo 81. Ebbene, anche su questo è ora di invertire la rotta. L’Italia è il più autorevole di un grande gruppo di paesi che può e deve chiedere una profonda revisione dei trattati. Mentre da subito bisogna attuare i punti più avanzati dei trattati attuali: per esempio l’articolo 3 del Trattato di Lisbona, che mette tra gli obiettivi dell’Unione la piena occupazione. Per far questo occorre costruire una sovranità europea, una vera politica europea. È questo l’unico europeismo che può darci ancora Europa e, domani, più Europa. Perché, sia chiaro, l’Italia non ha futuro fuori dall’Unione Europea. Ma questa Unione Europea va cambiata dalle fondamenta.
È su tutto questo, e su molto altro ancora, che dobbiamo e vogliamo discutere insieme, da oggi in poi. Ed è importante, anzi decisivo, decidere come farlo. Se le idee, i nodi, le prospettive che oggi proveremo a delineare vi sembreranno quelli essenziali, vitali, da domani può partire un vero processo costituente, dal basso. Non c’è nulla di stabilito, di deciso. Non un nome (alleanza popolare per la democrazia e l’eguaglianza è solo una didascalia esplicativa di un progetto), non un programma, non una leadership, non candidature. Ciò che vorremmo è un’alleanza capace di portare in Parlamento la parte sommersa di questo Paese. Un’alleanza tra cittadini, associazioni, comitati e partiti. Su questo punto bisogna essere chiari. Un vento impetuoso soffia oggi in Italia contro l’idea stessa di partito. Noi non siamo d’accordo. Non crediamo alla favola che oppone una società buona ai partiti cattivi. Sentiamo invece il dovere di distinguere: tra partito e partito, e nella società stessa. Sappiamo quanto i partiti in sé siano cruciali nel funzionamento del sistema disegnato dalla nostra Costituzione.
Pensiamo che il Partito Democratico di Renzi sia ormai un pezzo della destra. Perché fa politiche di destra: e di destra non sempre moderata. Lo diciamo con grande dolore, e con profondo rispetto per una gran parte dei suoi militanti. Ma dove dovremmo collocare un partito che lavora per aumentare la diseguaglianza (si pensi al Job’s act)? Lo diciamo una volta per tutte: chi partecipa a questo processo costituente di una nuova sinistra partecipa alla costruzione di una forza radicalmente alternativa al PD.
Pensiamo che il Movimento 5 Stelle sia prigioniero di un’oligarchia imperscrutabile. E vediamo che nella sua agenda – sempre più spostata a destra, con tratti preoccupanti di xenofobia e intolleranza – non c’è posto per la parola eguaglianza.
Ma vediamo anche che ci sono partiti diversi. Possibile e Sinistra Italiana hanno subito risposto a questo appello. La loro adesione non ci ha sorpreso: eravamo stati accanto in mille battaglie, non da ultimo in quella per il No. E hanno risposto anche Rifondazione Comunista, e tante esperienze politiche di partecipazione, tra cui per esempio Dema, l’Altra europa per Tsipras e molte altre.
Naturalmente se fossimo convinti che la forma partito è sufficiente, oggi non saremmo qua: non si tratta di rifare una lista arcobaleno con una spruzzata di società civile. C’è forte l’esigenza di qualcosa di nuovo, e di qualcosa di più grande. Lo dico con le parole di Gustavo Zagrebelsky: è necessaria la «più vasta possibile unione che sorga fuori dei confini dei partiti tradizionali tra persone che avvertano l’urgenza del momento e non siano mosse da interessi, né tantomeno, da risentimenti personali: come servizio nei confronti dei tanti sfiduciati nella politica e nella democrazia».
Altri partiti non hanno ancora deciso se partecipare. Articolo 1-Movimento Democratico Progressista ci ha chiesto di parlare: ascolteremo tra poco, e con grande attenzione, il senatore Miguel Gotor. Abbiamo invitato Giuliano Pisapia, e il suo Campo progressista: la risposta è stata che «non ci sono le condizioni». Non ci pare un buon inizio. Ma è una risposta che aiuta a spiegare perché oggi siamo qua: perché temiamo che nessun’altro voglia parlare alla metà del Paese che non vota.
Il nostro obiettivo finale rimane una sola lista a sinistra: e aspettiamo, il primo luglio, una risposta chiara. Una risposta sulle cose, non sulle formule. In questi giorni, le migliaia di persone che hanno aderito a questo invito hanno espresso due sentimenti contraddittori: entusiasmo e paura. L’entusiasmo di chi diceva: «Sono felice di poter tornare a votare!». La paura di chi teme che anche questo tentativo fallisca, come tutti quelli – generosi e coraggiosi – che l’hanno preceduto. Non li elenco: tutti li conoscete, molti di voi ne portano ancora le cicatrici. C’è chi teme che questo mondo sia troppo magmatico per unirsi anche solo in una lista. C’è chi teme che i partiti controllino questo processo, come burattinai da dietro le quinte. Entrambi questi rischi esistono. E l’esito di questo processo dipende tutto da quanti saremo, e da quanto determinati saremo.
Vogliamo costruire una vera ‘azione popolare’, come direbbe Salvatore Settis. Ma ci riusciremo solo se la partecipazione senza tessere sarà così ampia da superare di molte volte quella degli iscritti ai partiti. Una lista di cittadinanza a sinistra: questo vogliamo costruire. Qualcosa ci assicura che anche questa volta non finirà male? No, niente ce l’assicura: se non il nostro impegno. In una politica che si fonda sull’esibizione della forza, sull’arroganza e sul marketing del nulla noi diciamo al Paese: siamo poveri, siamo piccoli, siamo a mani nude, siamo pieni di limiti e avviati su un sentiero irto di ostacoli. Ma vogliamo mettere insieme tutte queste nostre debolezze: perché sappiamo che Davide può rovesciare Golia. Anche questo abbiamo imparato, il 4 dicembre. In una sinistra gremita da leaders senza popolo, noi siamo un popolo che non cerca un leader, ma partecipazione e condivisione. Sappiamo, sentiamo che ci dobbiamo provare: che non possiamo rassegnarci all’astensione. Che rimarrebbe, dopo un fallimento, l’unica possibilità. Ma non vogliamo rassegnarci ad una passione politica che escluda a priori il tema della rappresentanza parlamentare. Se vogliamo che il mondo cambi, dobbiamo portare in Parlamento chi vuole cambiare il mondo.
Da oggi dobbiamo costruire luoghi per decidere. Questo mare di idee, sofferenze, speranze, conoscenze deve sapersi organizzare. Deve saper decidere, dal basso e in modo trasparente: scegliendo un programma chiaro e forte, in dieci punti. In pratica, dobbiamo da domani avviare un percorso sul territorio, con assemblee che consentano il censimento e la raccolta delle energie disponibili e una sorta di carovana che attraversi l’Italia definendo i nodi del programma. Chi sottoscrive questo progetto dovrà riunirsi in assemblee territoriali capaci di eleggere una assemblea nazionale che definisca progetto, nome, simbolo e struttura organizzativa di questa coalizione. E un regolamento e dei criteri per far emergere le candidature. Io credo che queste ultime andranno scelte non al centro, ma collegio per collegio, circoscrizione per circoscrizione. Non con la truffa delle primarie aperte a chi passa, né con manovre occulte di centri organizzati di potere: ma in modo partecipato e veramente democratico.
Dobbiamo decidere con un processo in cui ogni cittadino conti a prescindere dalle tessere che ha o non ha in tasca. Un percorso che dovrebbe portare – lo ripeto – ad una grande lista civica nazionale, di sinistra e per l’attuazione della Costituzione. Se vogliamo che un processo come questo giunga in porto, ci sarà bisogno di una partecipazione più larga, e anche di una partecipazione nuova, di un altro modo di fare politica. Non basato sul leaderismo, ma sulla comunità. È per questo che io, personalmente, non mi candiderò a nulla. E mi auguro che saremo in tanti, ad impegnarci fino in fondo, ma senza candidarci. È infatti vitale che esista una cerchia di cittadini attivi e partecipanti, ma capaci di tenere alto il senso critico. Prendendo parte, anche appassionatamente, ma senza smorzare la critica.
Lo dico oggi per bloccare sul nascere un prevedibile tormentone. Ieri la Stampa ha, per esempio, scritto che «Tomaso Montanari e Anna Falcone … si candidano a diventare la faccia fresca e “presentabile” della sinistra radicale, quella che dalla sconfitta della Sinistra Arcobaleno del 2008, ha cambiato più volte sigle ma non le percentuali elettorali, sempre ferme al 3 per cento». Ecco, è esattamente il contrario. Non solo perché le nostre facce non rappresentano e non contano nulla. Ma perché questa ‘cosa’ nasce per ambire a percentuali a due cifre: perché ambisce a recuperare una parte dell’astensione di sinistra. E se dovesse ridursi a una lista arcobaleno con davanti le sagome della cosiddetta ‘società civile’ sarò il primo a dire che il tentativo è fallito. Riuscirà se ci sarà una travolgente azione popolare. Così travolgente da non aver bisogno né di narrazione né dell’attenzione dei giornali: perché sarà un realtà. E così plurale da avere tanti volti da rendere impossibile isolarne alcuni. Se oggi siamo qua è perché crediamo che questa azione popolare possa prendere vita: perché è l’unico mezzo per uscire da questo gorgo di infelicità. Perché – lo ha detto don Lorenzo Milani – «sortirne da soli è avarizia, sortirne tutti insieme è politica».
Un amico, militante del Movimento 5 Stelle, mi ha sorpreso in questi giorni, scrivendomi: «Una volta – molto tempo fa – chiesero a Vittorio Foa cosa desiderasse per Natale: la risposta fu” una destra democratica”. A noi grillini non farebbe schifo una sinistra fedele ai suoi ideali e alla Costituzione, tanto per cambiare…». Una sinistra fedele ai suoi ideali, e alla Costituzione: ecco, è proprio quella che da oggi vogliamo provare a costruire. Tutti insieme.
 Un buon esempio di ipocrisia applicata a un tema che tocca l'essenza profonda della democrazia: quello dell'uguaglianza tra gli esseri umani.
Un buon esempio di ipocrisia applicata a un tema che tocca l'essenza profonda della democrazia: quello dell'uguaglianza tra gli esseri umani.
Corriere della sera, 18 giugno 2017, con postilla
Pur essendo favorevole in linea generale alla nuova legge sulla nazionalità in discussione al Senato, trovo che le si possono egualmente muovere alcune ragionevoli critiche. Principalmente due. La prima è che nella concessione automatica della cittadinanza prevista per coloro che sono nati in Italia da genitori di cui almeno uno con regolare permesso di soggiorno da cinque anni come minimo, non si prevede però alcun accertamento preliminare circa la conoscenza né della nostra lingua, né dei costumi, né delle regole, né di niente della società italiana.
Si tratta appunto di una concessione automatica che tra l’altro, per il solo fatto di essere tale, viene privata di quel forte rilievo simbolico che invece sarebbe stato giusto conferirle. Bisogna sempre ricordare, infatti, che tutto quanto viene dato senza alcun corrispettivo perde per ciò stesso d’importanza. Il secondo punto su cui mi sentirei di dissentire riguarda il divieto di doppia cittadinanza, che secondo me sarebbe stato opportuno introdurre in ogni caso e che invece è assente. Mi rendo conto delle possibili obiezioni, probabilmente anche di carattere costituzionale. Ma anche in questo caso era comunque necessario, ne sono convinto, pensare a un modo per conferire alla concessione della cittadinanza un carattere di cesura simbolicamente irrevocabile, di frattura definitiva, rispetto a qualsiasi altra appartenenza.
Bisognava far capire insomma che la concessione della cittadinanza esclude in modo assoluto qualunque eventuale doppia fedeltà. Così come sarebbe stato forse utile considerare l’ipotesi di accrescere i motivi per i quali la cittadinanza, una volta acquistata, la si può anche perdere. Proprio in relazione a questi ragionevoli dubbi mi pare per nulla campata in aria la preoccupazione che l’immissione di nuovi cittadini provenienti da contesti radicalmente differenti dal nostro possa finire per alterare l’identità storico-culturale del Paese.
La Repubblica, con la sua Costituzione, le sue regole le sue leggi, non è nata dal nulla, infatti, e non vive nel nulla, non discende dall’empireo giuridico-formale dei «Diritti». Per mille tramiti essa scaturisce e si alimenta ogni giorno, invece, di una storia - che è anche una complessa storia di valori - la quale, si provi qualcuno a dimostrare il contrario, si colloca nel tempo e nello spazio e ha un nome e un cognome. Si chiama Italia. Sollevare questioni del genere è semplice buon senso, non ha niente di xenofobico né di razzista. E un Paese serio che si trova davanti un problema esplosivo come quello di una immigrazione apparentemente incontrollabile ne dovrebbe discutere in modo serio.
Ma da noi questo si rivela sempre difficile. Presentando la proposta di legge di cui stiamo dicendo la Sinistra, ad esempio, ha avuto l’indubbio merito di porre il problema in modo concreto, indicando comunque una soluzione concreta, ed è del merito di questa che si dovrebbe parlare. Che bisogno c’è allora che essa ricorra al sentimentalismo un po’ dolciastro di pubblicare teneri visini di bimbi extra-comunitari dagli occhi spalancati, che - si dice per convincerci - «sono nati qui»?
È un sentimentalismo, va subito aggiunto, che però ha un’attenuante. Una sola ma politicamente decisiva, dal momento che anche in politica la moneta cattiva è destinata a scacciare sempre quella buona. E cioè il fatto di rispondere al «cattivismo» programmatico e apocalittico di buona parte della Destra. Alla quale, come se non bastasse si è aggiunto ora anche il Movimento Cinque Stelle (dopo essersi astenuto alla Camera). Gli argomenti messi in campo dagli oppositori si sono distinti infatti per la loro sgangherata demagogia. Abbiamo sentito e letto di tutto tranne che qualche proposta in positivo. Dal «non si fa nulla per gli italiani» (che non si capisce che cosa c’entri, essendo che gli italiani una cittadinanza fino a prova contraria già ce l’hanno) alla denuncia per gli affari sporchi connessi al traffico e all’accoglienza degli immigrati (tutto vero, ma realmente si pensa che eliminando il «business» dell’immigrazione magari si elimina anche l’immigrazione?), all’allarme diffuso per le terribili malattie che gli immigrati importerebbero (anche qui: ma che cosa c’entra con la nazionalità?).
Su tutto aleggia poi una sorta di furibonda paranoia identitaria nonché l’idea, non saprei dire se più ingenua o più bizzarra, che senza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di una legge sulla concessione della nazionalità, milioni di africani se ne starebbero tranquilli a morire di fame rinunciando a intraprendere il loro disperato viaggio verso l’Europa. Invece, se una cosa è certa è l’impeto ininterrotto e di difficilissimo contenimento del fenomeno migratorio da cui siamo investiti. Si tratta di una vera e propria emergenza nazionale che richiederebbe alle forze politiche d’opposizione, ma in modo tutto particolare a quelle della Destra, il perseguimento degli interessi vitali del Paese, non la ricerca a tutti i costi di un qualche possibile guadagno elettorale.
La cultura della nazione, il patriottismo, quello vero, significa tra le altre cose anche questo: capire quando bisogna rinunciare agli interessi della propria parte in nome di un interesse generale. Oggi tale interesse si sostanzia in due obiettivi assolutamente prioritari. All’interno, evitare da un lato l’apartheid di fatto e dall’altro il comunitarismo multiculturale, assicurando nel modo più rigoroso la legalità e la sicurezza; all’esterno utilizzare tutte le risorse politiche e diplomatiche (il ricatto compreso, caro presidente Gentiloni, il ricatto compreso!) per obbligare i nostri soci europei a non lasciarci da soli nelle peste alle prese con un problema che è anche il loro problema. Chiunque dia comunque una mano per raggiungere uno di questi obiettivi, a qualunque partito appartenga, è un benemerito del nostro Paese.
postilla
Sono nato da genitori entrambi italiani, da molte generazioni (sebbene i miei avi paterni fossero di ispanica prosapia). Lo giuro, e posso documentarlo in modo ineccepibile. Quindi ho il pieno diritto di essere considerato italiano per jus sanguinis: ho certamente tutti quei requisiti che, secondo Ernesto Galli della Loggia, devono essere posseduti da chi voglia avere il brand di cittadino italiano Secondo lo jus sanguinis. E infatti, la legge mi ha riconosciuto tale.
Eppure devo ammettere, che, quando nacqui cittadino italiano non possedevo affatto quei requisiti, conoscenze, consapevolezze, innate capacità che, secondo Galli Della Loggia, sono indispensabili per essere catalogati con l’etichetta di “cittadino italiano”. Quando uscii, suppongo strillando, dal corpo di mia mamma non possedevo «alcuna conoscenza né della nostra lingua, né dei costumi, né delle regole, né di niente della società italiana». Purtroppo mia mamma non c’è più né alcuna delle altre persone che assistettero a quel lontano episodio, quindi il lettore dovrà accontentarsi della mia parola. Quindi secondo il conto elzevirista del Corriere
non ho il diritto di essere “cittadino italiano.
Su molti altri punti e affermazioni di Galli Della Loggia sono in profondo disaccordo, ma soprattutto con i molti veli d’ipocrisia che avvolgono il suo nazionalismo spinto fino ai margini della xenofobia e del razzismo. Ma ciò che particolarmente mi ha irritato è il non assumere esplicitamente, da parte dell'autore, una posizione netta e dire, semplicemente e schiettamente: sono contrario allo jus soli e non mi distinguo affatto né dai Di Maio né dai Salvini. (e.s.)
 « il manifesto, 30 giugno 2017 (c.m.c.)
« il manifesto, 30 giugno 2017 (c.m.c.)


 «A tanta potenzialità desiderata, espressa o in formazione corrisponde una straordinaria povertà di politica pragmaticamente propositiva».
«A tanta potenzialità desiderata, espressa o in formazione corrisponde una straordinaria povertà di politica pragmaticamente propositiva».  «È possibile combattere la miseria senza combattere i meccanismi che la producono? No. Eppure è ciò che facciamo se non affrontiamo il tema del debito pubblico».
«È possibile combattere la miseria senza combattere i meccanismi che la producono? No. Eppure è ciò che facciamo se non affrontiamo il tema del debito pubblico».  Il modo in cui le reti delle donne stanno andando fuori dalle strutture dello Stato e si mettono in relazione con le organizzazioni per i diritti umani, è una mobilitazione che è oltre e contro lo Stato ed è transnazionale».
Il modo in cui le reti delle donne stanno andando fuori dalle strutture dello Stato e si mettono in relazione con le organizzazioni per i diritti umani, è una mobilitazione che è oltre e contro lo Stato ed è transnazionale». 




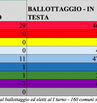






 ».
».




