 «Per lo storico Geert Mak l’assetto istituzionale attuale non sopravviverà oltre il prossimo decennio: o è svolta o disintegrazione
«Per lo storico Geert Mak l’assetto istituzionale attuale non sopravviverà oltre il prossimo decennio: o è svolta o disintegrazione
». Il Sole 24 ore, 8 maggio 2016 (c.m.c.)
In questo inizio di primavera, Amsterdam non delude le attese. Il primo sole dell’anno induce a sfidare le folate di vento freddo provenienti dal Mar del Nord, accomodandosi ai tavolini all’aperto, mentre tra le dimore seicentesche si fanno strada le consuete biciclette scampanellanti. In un cielo attraversato da nuvole minacciose, la luce è tersa. La capitale olandese non tradisce il letterato Gregorio Leti che nel 1690 reputava Amsterdam «la più libera e la meglio regolata» delle città. Eppure, la metropoli sta attraversando un periodo tormentato: come in altre occasioni, il futuro dell’Europa passa anche dall’Olanda.
Il Paese di Pim Fortuyn e di Geert Wilders è nuovamente alle prese con dubbi e angosce. In aprile, gli olandesi hanno colto l’occasione di un voto sul futuro accordo di associazione tra l’Unione e l’Ucraina per esprimere nuova e profonda disaffezione per l’Europa. «I Paesi Bassi sono sempre stati divisi tra un Ovest più cosmopolita e moderno, e un Est, oltre la città di Utrecht, più conservatore e provinciale – spiega Geert Mak –. In questa fase sembra purtroppo prevalere la seconda delle due tendenze. D’altro canto in quasi tutti i Paesi assistiamo a un ritorno del nazionalismo».
Mentre l’Europa aspetta con timore l’esito del referendum inglese di giugno, dedicato alla permanenza del Paese nell’Unione, le pessimistiche impressioni di Mak sono utili per capire i sentimenti che segnano l’intellighentsia del Nord Europa in una fase in cui il continente affronta come non mai il rischio della disintegrazione. Giornalista, storico, documentarista, Mak, 69 anni, è una delle voci più ascoltate della pubblicistica olandese, una specie di A.J.P. Taylor di lingua fiamminga. Mentre passeggiamo per il centro di Amsterdam alla ricerca di un locale, i passanti accennano un saluto discreto.
Nel 1999, il nostro interlocutore fece un lungo viaggio attraverso l’Europa per raccontare il secolo che stava per concludersi. Per un anno pubblicò tutti i giorni le sue impressioni nel giornale «NRC Handelsblad». Nel 2004, trasse dalla sua rubrica quotidiana un libro venduto in oltre 400mila copie e tradotto in una ventina di lingue - in Italia da Fazi con il titolo In Europa. «Stiamo inciampando – dice oggi – da una crisi all’altra, in mezzo alla tempesta. Dobbiamo fermarci in un porto e riparare la nave. Vorrei essere ottimista, ma non riesco ad esserlo…».
Agli occhi di Geert Mak, le risposte alle diverse crisi affrontate dall’Europa in questo ultimo decennio – quella finanziaria, poi economica, poi ancora debitoria, ora terroristica e migratoria – non sono state convincenti. «Guardate alla politica monetaria ultra accomodante della Banca centrale europea o al discusso accordo dei Ventotto con la Turchia: su entrambi i fronti sembra prevalere il panico. Sono molto preoccupato per il futuro dell’Europa».
Se i partiti più radicali stanno mettendo radici a livello nazionale – nei Paesi Bassi, in Francia, Italia, Austria e anche in Germania - non è solo per la perdurante crisi economica. «L’attuale assetto europeo è a metà federale e a metà confederale. L’Unione è nata per trovare soluzioni tecniche, non politiche. Il populismo è anche una reazione al modo in cui vengono ideate e applicate le politiche europee. Gli elettori hanno l’impressione che la classe politica non abbia il controllo della situazione, e quindi si stanno affidando sempre più a chi offre loro soluzioni prettamente nazionali».
Secondo lo storico olandese, l’emergenza provocata dall’arrivo di milioni di migranti in fuga dal Vicino Oriente o dal Nord Africa rischia di rivelarsi per l’Europa ciò che fu il disastro di Tchernobyl per l’Urss: un campanello d’allarme dalle conseguenze imprevedibili. «I sovietici scoprirono all’improvviso le enormi deficienze del sistema politico. Così sta avvenendo oggi in Europa. L’Unione non è neanche capace di inviare nelle isole greche i funzionari necessari per gestire in modo rapido ed efficiente lo sbarco dei rifugiati. Gli europei stanno scoprendo le gravissime debolezze della costruzione comunitaria».
Seduto in un animato e rumoroso caffè di Amsterdam, Mak non ha nulla dell’intellettuale estremista. Anzi, il sorriso caloroso, i capelli arruffati, i modi simpatici gli danno un’aria rassicurante e bonaria. Prima di iniziare la nostra conversazione, aveva premesso di sentirsi «più un europeo che un olandese». Eppure, oggi non riesce a essere fiducioso: «Mi sembra impossibile che l’attuale assetto istituzionale possa sopravvivere al prossimo decennio. Non funziona e non gode di sufficiente legittimità. Sto dicendo questo con il cuore affranto».
Ammette di essere d’accordo con la cancelliera tedesca Angela Merkel che qualche mese fa, riprendendo il titolo di un famoso libro dello storico Christopher Clark, ha definito i dirigenti politici europei dei «sonnanbuli», diretti inconsapevolmente, come all’inizio del Novecento, verso una catastrofe. «Lo sconquasso della moneta unica così come la crisi dell’Ucraina hanno dimostrato che c’è bisogno di un profilo politico, e non solo tecnico. L’Europa deve pensare il proprio ruolo geopolitico. È destinata ad affrontare nuove grandi crisi. Per questo, mi aspetto una sua disintegrazione, e una sua ricostruzione su basi più piccole». Cosa intende per grande crisi: c’è il rischio di una guerra? La risposta tarda ad arrivare. Finalmente, dopo un lungo silenzio di riflessione, Mak risponde: «Siamo in bilico tra pace e guerra. Le fratture potrebbero rimarginarsi, oppure peggiorare drammaticamente.
Vi sono per esempio molti fattori che in Crimea potrebbero portare a un conflitto aperto. Altri focolai sono l’Egitto e la Libia, che non sono più un baluardo a difesa dell’Europa contro l’arrivo di milioni di migranti dall’Africa. La Turchia, poi, è un Paese sull’orlo della guerra civile, fosse solo per la presenza della folta minoranza curda». Alla ricerca di un confronto storico sull’attuale stato dell’Europa, trova un esempio nella repubblica confederale che governò le Province Unite tra il 1581 e il 1795.
«In parte, la fine del Secolo d’Oro fu determinata dalla difficoltà a creare un potere centrale. I federalisti americani videro nel caso olandese la ragione per puntare con decisione verso un assetto federalista». Torna alla mente James Madison in Il Federalista: la repubblica olandese, scrisse nel 1787, mostra «l’imbecillità nel governo, il disaccordo tra le province, l’indegna influenza straniera, una precaria esistenza in tempo di pace e calamità in tempo di guerra».
Le parole dell’uomo che da lì a poco sarebbe diventato il quarto presidente degli Stati Uniti suonano attuali, se riferite a una Europa che continua tra le altre cose a ospitare truppe americane sul suo territorio. Simbolica delle differenze europee, l’Olanda è al tempo stesso proiettata oltre Atlantico e al centro del continente europeo. Tornando alla descrizione di Gregorio Leti, appare permissiva quando si tratta di omosessualità e droghe leggere; rigorosa quando bisogna risanare i conti pubblici o applicare le regole. Gli olandesi usano spesso nelle loro risposte l’espressione moet kunnen che si traduce liberamente con «E perché no!». L’esclamazione riflette tolleranza e pragmatismo. Rileggendola alla luce del pessimismo di Geert Mak, sembra quasi autorizzare l’impensabile.

«Repubblica
e un testo inedito che spiega come l’uscita dall’Euro possa essere una scelta progressista e non populista». La Repubblica
Uscire dall’euro per abbandonare le ricette neoliberiste che lo hanno governato negli ultimi anni. Uscire dall’euro ma non rinunciare all’idea di Europa. Dunque rimanere nella Ue riprendendo la nostra moneta nazionale per tornare ad essere liberi nelle scelte politiche ed economiche.
Il saggio di Luciano Gallino che conclude la raccolta dei suoi articoli comparsi su Repubblica è un testo inedito, scritto un mese prima della scomparsa del professore. Una sorta di testamento intellettuale dunque, il tentativo di ragionare con lucida e spietata semplicità su quello che a sinistra è rimasto un tabù per molti anni prima che la crisi greca mescolasse definitivamene le carte in tavola. L’idea cioè che si potesse uscire dalla moneta unica in nome di una posizione né nazionalista né populista ma anzi progressista, per essere più aderenti all’idea orginaria dei padri fondatori dell’Europa, non certo per rifiutarla. Una posizione che si porta implicitamente dietro l’affermazione del tradimento dello spirito originario della costruzione europea.
Negli articoli che precedono l’inedito e che sono già stati pubblicati, Gallino ricostruisce la genesi di quel tradimento. Che non deriva solo dal pervasivo diffondersi dell’ideologia neoliberista di quà e di là dell’Atlantico ma anche dalla scelta di trasferire il debito dai privati e dalle banche agli Stati e dalla folgorante vittoria tedesca nelle trattative per stabilire il valore dell’euro, una moneta, sostiene Gallino, «costruita a misura di marco». Premesse che non facevano prevedere nulla di buono.
Gallino arriva addirittura a citare la fosca e purtroppo azzeccata previsione del giovane Keynes sulle conseguenze disastrose per l’intera Europa del trattato di pace vessatorio per i tedeschi che concluse la prima guerra mondiale. Se quel giudizio valeva allora per la Germania perché non avrebbe dovuto valere nel 2013 per la Grecia prona di fronte ai dettami della Troika?
Oggi, a pochi mesi di distanza dal saggio di Gallino, l’idea che si possa tornare indietro nella costruzione progressiva dell’Europa sta diventando di stringente attualità. In Gran Bretagna, dove l’adesione all’eurozona non è mai stata accettata, un referendum propone ora di uscire addirittura dall’Unione. Così, ancora una volta, le proposte di Gallino che a prima vista apparivano non di rado radicali, si dimostrano in realtà animate da un insospettato riformismo di fondo.
Solo chi ha seguito negli anni il professore sa che quella del riformismo radicale non è una scoperta tardiva ma è stata la cifra della sua attività di studioso. Il saggio di Gallino si presenta come un vero e proprio manuale giuridico per capire quali sono le leggi e gli articoli che possono consentire il recesso dall’euro. Questione che non basta il ritorno alla normalità dello spread a considerare definitivamente archiviata.

. Il Fatto Quotidiano, 7 maggio 2016
Viva Gramsci, in questi tempi cupi e senza bussola. Una stanza buia o quasi e solo le pareti illuminate, con la luce a illuminare quella grafia minuta, priva di sbavature. E poi le copertine. Le copertine di trentatré Quaderni che hanno fatto la storia del pensiero politico e filosofico.
Al prossimo Salone del Libro di Torino, dal 12 al 16 maggio, uno degli eventi clou sarà la mostra dedicata ai Quaderni gramsciani dal carcere, cominciati nel 1929 nella casa penale di Turi di Bari e terminati a Roma nell’estate del 1935. La mostra è organizzata dalla Fondazione Istituto Gramsci ed è l’inizio di una sorta di grand tour del pensatore italiano più studiato all’estero nonché fondatore, segretario e deputato del partito comunista. I Quaderni, infatti, dal 20 maggio saranno a Milano, alle Gallerie d’Italia in piazza Scala, fino al 17 luglio e infine torneranno a Roma per un’altra mostra a novembre.
A Milano, si aggiungerà il sostegno significativo dell’Associazione Enrico Berlinguer, che gestisce il patrimonio del Pci-Psd-Ds ed è presieduta da Ugo Sposetti, senatore del Pd non propriamente renziano. L’associazione per l’occasione metterà a disposizione due celebri dipinti di Renato Guttuso: La battaglia di Ponte dell’Ammiraglio (1955) e I funerali di Togliatti (1972). È come se quel pezzo grande e consistente di sinistra che non si riconosce nel conformismo del Pd odierno ripartisse dalle origini. Sostiene Francesco Giasi, vicedirettore dell’Istituto Gramsci: “I Quaderni, al completo, furono esposti per la prima volta a Roma nel 2011 e rimanemmo colpiti dall’affluenza. Il pubblico manifestava allo stesso tempo sorpresa e voglia di vederli”. Nel 2017, poi, saranno ottant’anni della morte di Gramsci e i Quaderni faranno un ulteriore giro per l’Italia. In essi c’è tutto quello che costituisce il gramscismo.
Era un Politico con la maiuscola, Gramsci, che con gli occhiali del materialismo [storico] analizzava e studiava la molteplicità del reale. Dalla filosofia di Benedetto Croce al Risorgimento, da Machiavelli al fordismo. Nel quaderno numero 4, per esempio, i paragrafi sul Canto decimo dell’Inferno incrociano la svolta stalinista del Pcd’I nel 1930. Storia, letteratura e filosofia e un’elaborazione densa che, come osserva giustamente Giasi, “non ha bisogno di alcuna forzatura per essere attualizzata”. I Quaderni parlano ancora da soli, come dimostrano alcuni concetti rimasti nel nostro lessico, dall’egemonia culturale all’ampia categoria del nazionalpopolare, talune volte travisata se non deformata. Ed è per questo che nessun autore italiano ha mai avuto, come lui, ben tre edizioni complete delle sue opere. Non solo: l’intera bibliografia gramsciana vanta 20 mila titoli in ben 41 lingue diverse. Oggi i Paesi in cui il suo pensiero viene studiato di più sono Gran Bretagna, Francia, Messico, Argentina e Brasile. Il gramscismo è noto anche tra gli arabi, in primis Libano ed Egitto.
Gramsci era segretario del partito comunista quando venne arrestato a Roma l’8 novembre 1926. Il regime fascista lo condannò e incarcerò nonostante l’immunità parlamentare. Il permesso di scrivere gli fu accordato solo nel 1929, quando si trovava in Puglia. Nel 1933, per motivi di salute, fu trasferito a Formia, in clinica, e di qui a Roma, nella clinica Quisisana. Morì a 46 anni il 27 aprile 1937, pochi giorni dopo essere tornato libero. I 33 Quaderni (altri due rimasero bianchi) furono presi in consegna dalla cognata Tatiana Schucht e spediti a Mosca dove vivevano la moglie e i figli di Gramsci. La cognata li numerò senza alcun criterio scientifico coi numeri romani e questo, qualche anno fa, ha generato un giallo storico su un presunto diario mancante in cui Gramsci si sarebbe convertito al liberalismo.
Dice Giasi, sorridendo: “Abbiamo fatto tutte le indagini possibili e sotto le etichette non c’è nulla, nessun sbaglio o errore o quaderno-bis che manca. Per come lavorava Gramsci c’è tutto”. Oggi i Quaderni sono numerati da 1 a 29 e i restanti quattro, costituiti da traduzioni, sono indicati con A, B, C e D. Preziosi e fragili, sarà possibile sfogliarli e consultarli in edizione digitale. Il grand tour gramsciano va a cominciare.
Riferimenti
Numerosi scritti su Antonio Gramsci sono raccolti negli archivi di eddyburg, sia qui nel nuovo sia (e in maggior numero) qui nel vecchio

Il Fatto Quotidiano, 7 maggio 2016 (p.d.)
Enrico Piovesana, giornalista di grande esperienza (oltre ad aver lavorato per anni in Afghanistan come inviato di PeaceReporter è stato in Pakistan, Cecenia, Nord Ossezia, Bosnia, Georgia, Sri Lanka, Birmania e Filippine) ha scritto un libro Afghanistan 2001-2016. La nuova guerra dell’oppio pubblicato dalla Casa Editrice Arianna, coraggiosa ma sufficientemente piccola perché questo libro possa passare quasi inosservato. Contiene infatti informazioni, puntualmente documentate, che dovrebbero far arrossire di vergogna i Paesi che hanno invaso l’Afghanistan e ancora lo occupano dopo oltre 14 anni di guerra.
Nel luglio del 2001 il Mullah Omar proibì la coltivazione del papavero, da cui si ricava l’oppio e poi, raffinato, l’eroina, un provvedimento che è noto a tutti gli addetti ai lavori ma che sui giornali occidentali e in particolare su quelli italiani è sempre stato ignorato o trattato di sfuggita (per quello che riguarda l’Italia mi ricordo solo un timido e anche un po’contorto accenno di Sergio Romano sul Corriere).
Da quando aveva preso il potere nel 1996 il Mullah Omar, interprete rigoroso del Corano, aveva dato una speciale licenza temporanea non per l’uso dell’oppio in Afghanistan, ma per la sua esportazione all’estero. Il ricavato serviva infatti al governo talebano per comprare generi di prima necessità dal Pakistan in un Paese che era stato impoverito da dieci anni di occupazione sovietica e dai quattro anni di conflitto civile cui gli stessi talebani avevano posto fine nel 1996 cacciando oltre confine i “signori della guerra” cioè i vari Massud, Dostum, Ismail Khan e compagnia cantante. Ma riassestato un po’ il Paese Omar aveva deciso di farla finita col traffico dell’oppio di cui il Corano proibisce sia l’uso che lo smercio. Per Omar questa decisione era difficilissima perché colpiva soprattutto la base del suo regime cioè i contadini, cui andava peraltro solo l’1 per cento del ricavo del traffico e gli autotrasportatori. Però il grande prestigio di cui godeva in Afghanistan gli permise di prendere questa misura e di convincere i contadini, a volte con azioni assai spicce, a convertire la coltivazione del papavero con altre coltivazioni.
Fatto sta che nel 2002 (anno in cui rileva la decisione del 2001) la produzione di oppio in Afghanistan crollò a 185 tonnellate. Oggi ci sono punte di 5.000, 6.000, 7.000 tonnellate l’anno e l’Afghanistan produce il 93% dell’oppio mondiale. Come mai visto che fra gli obiettivi della coalizione Isaf, oltre a portare la democrazia, “liberare” le donne, eccetera, c’era quello di sradicare il traffico di stupefacenti, cosa a cui peraltro, come abbiamo detto, aveva già provveduto il Mullah Omar?
Le ragioni sono principalmente due. La prima è che per combattere i talebani i contingenti Nato (soprattutto americani, inglesi, canadesi) non bastandogli l’enorme superiorità militare (aerei, droni, bombe all’uranio impoverito e sofisticatissimi strumenti tecnologici) si sono alleati con i “signori della droga” che il governo di Omar aveva cacciato dal Paese o innocuizzato, così come aveva fatto con le bande di predoni che durante la guerra civile avevano infestato l’Afghanistan (come mi ha raccontato Gino Strada nell’Afghanistan talebano si poteva girare tranquillamente anche di notte, bastava rispettare, com’è, o come dovrebbe essere, in ogni Paese, la legge).
La seconda, anche più grave, è che sono gli stessi militari Nato i protagonisti di buona parte di questo traffico di droga. I militari, insieme ai soldati del cosiddetto esercito “regolare”e la corrottissima polizia (del resto tutto l’apparato istituzionale afghano oggi è corrotto, dal governo, ai ministri, ai governatori, ai magistrati giù giù fino all’ultimo funzionario) entrano nelle case e nei terreni dei contadini poveri, gli portano via l’oppio (unica risorsa rimasta a questi disgraziati) con la violenza, ma con la scusa che stanno facendo la lotta al traffico di stupefacenti, e poi vanno a raffinarlo in eroina nelle raffinerie che un tempo erano oltre confine e oggi sono a decine nello stesso Afghanistan. L’agenzia Fars News Agency ha dichiarato: “Nella sola provincia di Helmand è pieno di laboratori per la produzione di eroina, che prima dell’intervento americano non esistevano e che ora lavorano alla luce del sole”.
Naturalmente nella vulgata l’esponenziale aumento del traffico di droga è addebitato ai guerriglieri talebani. Certo, anche i talebani, oggi partecipano al traffico della droga per procurarsi armi e mezzi di sostentamento, ma la loro partecipazione al traffico globale di stupefacenti in Afghanistan è del 2%. C’è poi la famigerata Kandahar Strike Force, la milizia paramilitare addestrata e armata dalle forze speciali Usa che ha sede nell’ex palazzo del Mullah Omar alla periferia di Kandahar e che dà la caccia ai talebani seminando il terrore tra la popolazione con rapimenti, torture, omicidi e stupri. Naturalmente anche questi “rapimenti, torture, omicidi e stupri”vengono addebitati dai media occidentali ai talebani.
Enrico Piovesana ha focalizzato il suo libro su quanto è successo in Afghanistan dopo il 2001 solo sul traffico di droga. Questo era il suo obiettivo. Ma naturalmente in un reportage più ampio ci sarebbero da documentare le centinaia di migliaia di civili uccisi sotto i bombardamenti Nato, le migliaia di afghani che si sono ammalati di cancro a causa dell’uranio impoverito e le altre migliaia di bambini nati focomelici.
Nel suo reportage Piovesana, forse per carità di patria, non ci dice se anche il contingente italiano partecipa a questo turpe commercio. Però cita un episodio che fa pensare che noi italiani non si sia affatto estranei. Nel 2011 le accuse dell’ex caporalmaggiore Alessandra Gabrieli “non solo rivelano l’uso di droghe tra i militari italiani di ritorno dal fronte, ma adombrano addirittura il loro coinvolgimento nel traffico di eroina dall’Afghanistan, l’imbarazzo della Difesa è forte, e l’allora ministro Ignazio La Russa, preferisce non rilasciare commenti, in attesa dello sviluppo delle indagini”. Di cui non si saprà più nulla.
Questa è la situazione dell’Afghanistan dopo 14 anni di guerra di “liberazione”. Noi l’abbiamo denunciata tante volte, in un libro (Il Mullah Omar, del 2011), in articoli sul Fatto e su altri giornali, ma preferiamo lasciare le conclusioni al giornalista americano Eric Margolis dell’Huffington Post: “Quando verrà scritta la storia di questa guerra in Afghanistan, il sordido coinvolgimento di Washington nel traffico di eroina e la sua alleanza con i signori della droga sarà uno dei capitoli più vergognosi”.

Il Fatto Quotidiano, 7 maggio 2016 (p.d.)
Sarà forse la giustizia penale a far luce sull’ultimo tassello, o meglio il primo, della crisi dello spread che avvolse l’Italia nel 2011, causando la fine prematura del governo Berlusconi. E l’attore è sempre lo stesso: la Procura di Trani. Deutsche Bank è infatti indagata per manipolazione del mercato per la “massiccia” vendita “nel brevissimo termine”, di 7 degli 8 miliardi di euro di titoli di Stato italiani che deteneva all’inizio del 2011. Sotto inchiesta sono finiti gli ex vertici del primo istituto tedesco: l’ex presidente Josef Ackermann, gli ex co-ad Anshuman Jain e Jürgen Fitschen (quest’ultimo è co-amministratore delegato uscente della Banca), l’ex capo dell’ufficio rischi Hugo Banziger, e Stefan Krause, ex direttore finanziario ed ex membro del board.
Le indagini sono coordinate dal pm Michele Ruggiero, che nei giorni scorsi ha fatto perquisire, sequestrando atti e mail, la sede milanese della banca, ascoltando come testimone il responsabile per l’Italia, Flavio Valeri, estraneo alla vicenda. Poi toccherà a Romano Prodi e all’allora ministro dell’Economia Giulio Tremonti essere sentiti come testimoni. Fu Prodi, infatti, il primo ad avanzare l’ardita ipotesi che fu quell’operazione ad avviare la tempesta sull’Italia.
Secondo l’accusa, gli ex vertici, mentre a febbraio e marzo comunicavano ai mercati che il debito italiano era sostenibile, nascondevano, anche al Tesoro italiano, che si stavano liberando e in fretta dell’esposizione sui mercati non regolamentati. Per Ruggiero, la vendita fu poi “falsamente” giustificata a posteriori con la necessità di ridurre la sovraesposizione sull’Italia dopo l’acquisto di PostBank. In quel periodo Deutsche Bank acquistò anche 1,4 miliardi di Credit default swap (Cds), cioè assicurazioni sul rischio di perdite. Secondo Ruggiero, mentre la banca rassicurava i mercati, si copriva e vendeva a mani basse, e questo ha alterato la formazione del prezzo dei titoli sia prima - quando il mercato sarebbe stato all’oscuro - sia dopo, lanciando “un chiaro segnale di sfiducia del gruppo nei confronti della tenuta del debito italiano”. È l’ultimo atto della procura tranese che ha già trascinato a processo per manipolazione del mercato le agenzie di rating Fitch e Standard & Poor’s per il declassamento del rating dell’Italia tra il 2011 e il 2012.
Per la banca si tratta di “un’indagine priva di fondamento”, ma la notizia ha scatenato ovvie reazioni. Per Renato Brunetta (Fi) “avevamo ragione: fu un complotto. È assordante il silenzio di Renzi. Serve una commissione d’inchiesta”. Stessa tesi di Adusbef e Federconsumatori. Abbraccio e baci tra Renzi e Merkel mi hanno fatto schifo”, ha attaccato Matteo Salvini. Stando a quanto apprende il Fatto, la vicenda è connessa alle indagini - poi trasmesse a Roma - sui derivati di Stato, sottoscritti anche da Detusche Bank.
Vicenda complessa. Il 26 giugno 2011, la banca rivelò di essere passata in 6 mesi da 8 miliardi a 997 milioni di euro di titoli italiani (-87,5%). Krause spiegò agli analisti che questo era avvenuto perché l’istituto aveva consolidato a bilancio anche l’esposizione di Postbank, acquistata nel novembre 2010. Fece lo stesso anche con altri Paesi periferici ma in misura molto più ridotta. La cosa colpì il Tesoro perché la banca era una specialista di titoli di Stato italiani di cui contribuiva a farne il prezzo nelle aste. Stando ai bilanci, Postbank era esposta per 4,6 miliardi nel 2010, cifra che però rimane uguale nel 2011, per poi scendere a 3,4 miliardi nel 2012. DB, invece, passa nel 2011 da 8 a 1,7 miliardi. Fino al 2012, il valore teorico dell’esposizione è negativo (3,9 miliardi), ma viene compensato in parte da quello in “derivati” verso l’Italia che però cresce nel tempo (+2,3 e +3,2 miliardi) fino diventare positivo nel 2013 (3,8 miliardi nel 2014). Probabile che la copertura dei Cds abbia ben più che attutito l’urto, e forse la banca con una mano ha venduto e con l’altra ha acquistato, guadagnandoci.
In questo meccanismo l’Italia è finita stritolata. Da luglio lo spread inizierà la sua cavalcata da 183 agli oltre 500 punti di novembre 2011, quando cadde Berlusconi. Sono mesi in cui il premier - spalleggiato anche da Brunetta - litigava con Tremonti, contrario ad allentare il rigore, screditando l’Italia. Ma le turbolenze iniziarono al vertice di Deauville dell’ottobre 2010, dove Francia e Germania dichiararono che i debiti sovrani dell’Eurozona potevano fare default. La successiva rottura dell’asse franco-tedesco spinse le banche a vendere i titoli dei Paesi periferici. Deutsche Bank ci andò giù pesante. Chi visse quel periodo ai massimi vertici del Tesoro rivela: “Il problema era ed è sempre stato la Grecia. L’Italia si oppose a usare il fondo Salva Stati per salvare Atene in una modalità che avrebbe aiutato le banche tedesche e francesi, pesantemente esposte. In quel caso, i contributi al Fondo dovevano essere calcolati non sul Pil ma sul rischio delle banche. Lì inizio la fine del governo. E l’operazione Deustche fu forse solo uno dei sistemi di pressione, culminati con la lettera della Bce di Agosto. Poi arrivò Monti e diede l’ok”.
 «L'accordo Europa-Turchia ha fatto crollare il numero degli arrivi, ma ha anche peggiorato le condizioni di chi viene trattenuto nei centri. "Siamo saltati dalla guerra alla prigione"».
«L'accordo Europa-Turchia ha fatto crollare il numero degli arrivi, ma ha anche peggiorato le condizioni di chi viene trattenuto nei centri. "Siamo saltati dalla guerra alla prigione"».
Il Fatto quotidiano online, 7 maggio 2016 (p.d.)
I giubbetti di salvataggio sono ancora appesi al muro, la barchetta a motore pronta a salpare. Di migranti in mare non se ne vedono da un po’ a Skala Sikamias, villaggio sulla punta nord dell’isola di Lesbo, da cui si vede sfumato il profilo della Turchia. Ma l’accampamento per il primo soccorso allestito dai volontari, ormai un anno fa, rimane attivo 24 ore su 24. “Aspettiamo di vedere cosa succede nei prossimi mesi”, dice Sara Santoro, 29 anni, volontaria. “L’ultimo gommone – continua – è arrivato dieci giorni fa, potrebbero arrivarne altri. E noi aspettiamo”. Era questo, prima dell’accordo tra l’Ue e la Turchia, una delle porte dei migranti per l’Europa. Ogni giorno arrivavano dalle 30 alle 60 barche stracolme di migranti fradici, stremati, mezzi morti. Ogni giorno si sentivano le grida di disperazione, le richieste di aiuto, i pianti dei neonati sopravvissuti al viaggio chissà come. Adesso solo lo strillo dei gabbiani interrompe il mormorio delle onde ancora macchiate di sangue. “A volte capitava di uscire anche venti volte al giorno per operazioni di salvataggio – ricorda Sara – Magari il gommone si bucava e finivano la benzina. Il trafficante spesso non era nemmeno a bordo e li lasciavano navigare a vuoto in mare”.
Ma non solo Skala Sikamias. I migranti sbarcavano un po’ ovunque a Lesbo. Centinaia di sbarchi ogni giorno, migliaia di persone. Arrivavano, si riprendevano dal viaggio e poi via di nuovo verso la terraferma come uccelli migratori alla ricerca della primavera. Proprio come negli anni Venti quando oltre un milione di cristiani in fuga dal genocidio in Turchia si rifugiò sull’isola prima di arrivare in Grecia. Deve avercelo scritto nel destino, Lesbo, di essere l’isola di rifugiati.
Nel 2015, secondo i dati forniti dall’Unhcr, sono arrivate in Europa attraverso la rotta balcanica circa un milione di persone, di cui la metà transitate da Lesbo. Solo dall’inizio del 2016 ne sono passate circa 90mila dall’isola, quasi tutte prima del 20 marzo, giorno dell’entrata in vigore dell’accordo Ue-Turchia. Da allora il mar Egeo è diventato un altro muro innalzato in Europa per fermare le migrazioni. La guardia costiera e gli agenti di Frontex sorvegliano costantemente le acque turche e respingono le imbarcazioni in partenza. Qualcuna riesce a passare lo stesso, di notte, in una rotta che non è mai la stessa. “A febbraio – spiega a IlFattoQuotidiano.it Boris Cheshirkov, portavoce di Unhcr a Lesbo – arrivavano nell’isoladalle 500 alle 2mila persone al giorno; a ottobre anche 5mila in una sola giornata. L’isola era piena di migranti. Adesso si respira tutta un’altra aria. Arriva un’imbarcazione ogni cinque o sei giorni. Quello che non funziona è il sistema di detenzione in cui sono costretti a vivere i migranti”.
Lesbo, da terra di speranza a terra di prigionia. Dal 20 marzo i migranti richiedenti asilo sono stati trasferiti nel campo profughi di Kara Tepe, a Mitelene. In attesa di sapere se la domanda verrà accettata, possono muoversi solo per l’isola. Tutti gli altri invece sono stati rinchiusi nel hotspot di Moira, sulle colline della città, da cui non possono uscire senza autorizzazione. E quella si ottiene non prima di un mese (e in ogni caso serve solo per circolare nei dintorni). È un vero e proprio centro di detenzione, circondato da un muro alto cinque metri e filo spinato, da cui anche le ong se ne sono andate per “non sentirsi complici”, come aveva dichiarato al momento della firma dell’accordo Medici senza frontiere.
Nei container del campo sono ammassate adesso 4mila persone. Ne potrebbero contenere giusto la metà. I minorenni sono circa mille, di cui duecento non accompagnati. “Le condizioni igieniche stanno deteriorando – fa sapere al Fatto.it Sacha Myers, responsabile della comunicazione per Save the children Grecia – Stanno aumentando i casi di bronchiti e di infezioni per complicazioni della febbre. Siamo anche preoccupati per la sicurezza dei bambini, dal momento che la tensione aumenta di giorno in giorno e si stanno verificando casi di violenza”.
Poco dopo la visita del Papa, un gruppo di minorenni ha incendiato cassonetti, letti, spaccato a calci e pugni le catene. Volevano solo essere liberi, nient’altro. E sopra il filo spinato che scorre sul muro si vedono ancora i segni della loro ricerca di libertà: le scarpe e i vestiti impigliati, le coperte abbandonate sulla doppia recinzione. Una fuga mai riuscita, perché da lì non si scappa.
Save the Children ha chiesto al governo greco che almeno i bambini non accompagnati vengano tolti da quell’inferno, ma per il momento è solo una speranza. E in ogni caso anche fuori dovrebbero fare i conti con gli spazi. Che non ci sono. Con la chiusura della frontiera macedone sono rimasti bloccati in Grecia infatti circa 2mila minori che hanno viaggiato da soli o perso le famiglie lungo la strada. I posti di accoglienza disponibili in tutto il Paese però sono solo 477. “Questi rifugi – spiega la ong – sono stati pieni per settimane. I bimbi sono rimasti a lungo nei centri di detenzione o nelle celle di polizia e questo mette i bambini vulnerabili e traumatizzati a rischio di abuso, sfruttamento da parte di trafficanti di esseri umani, malattie e disagio psicologico”.
Fuori dal campo di Moira due giovani afghani si allontanano sventolando un foglio. “Freedom, freedom”, gridano. Sembrano trentenni, ma hanno solo sedici e vent’anni. Si chiamano Shikhali e Rebaz. Uno di loro zoppica: ha una protesi alla gamba destra. “Me l’hanno fatta saltare in aria i talebanil’anno scorso”, racconta Shikhali. È il loro primo giorno di libertà dopo quaranta giorni di detenzione. “Cosa faremo oggi? – dicono – Torneremo il più tardi possibile dentro quel carcere”. Sono in attesa di capire che ne sarà di loro, come tutti gli altri. Se verranno rimpatriati o chissà. “Se mi rimpatriano, mi taglio anche l’altra gamba”, dice Shikhali. “Non abbiamo fatto tutto questo viaggio per essere rispediti indietro come pacchi postali”, aggiunge Rebaz.
Dal primo aprile ad oggi sono state rimpatriate circa 400 persone dalle isole greche nell’Egeo, di cui circa la metà da Lesbo. Alcune di loro erano siriane. Eppure le ricollocazioni previste dall’accordo (per ogni siriano rimpatriato in Turchia, un siriano deve essere ricollocato dal Paese in un paese membro Ue) vanno parecchio a rilento. “Il tema delle ricollocazioni è un altro su cui l’Europa sta facendo ben poco, lasciando di fatto la Grecia abbandonata a se stessa – spiega Cheshirkov – Dal settembre del 2015 a oggi hanno lasciato la Grecia solo 600 persone delle 66mila e 400 previste dai vecchi accordi. Dalla Turchia non abbiamo un numero preciso di quante persone siano state ricollocate. Ma sono sicuramente poche”.
E nel frattempo i migranti rimangono lì, bloccati sull’isola, dentro un labirinto di solitudine e tristezza. “Siamo saltati dalla guerra alla prigione”, racconta Fwad, curdo dell’Iraq, seduto su un muretto in riva al mare poco, distante dal campo profughi Kara Tepe. Beve una birra e fissa il mare. Le onde coprono e scoprono vecchi giubbotti di salvataggio incastrati tra gli scogli. “Sono venuto da là”, continua e indica la Turchia, che adesso si vede nitida. “Guarda cosa mi ha fatto il Daesh”. E mostra la sua cicatrice spessa un dito che gli attraversa la testa da parte a parte. “Mi è piovuta una bomba addosso”, continua. Fa una pausa e riprende. “Sono scappato dal Daesh, ho attraversato la Turchia, sono riuscito ad attraversare il mare. E ora sono in prigione”.
 Recensione (un po' ipertrofica) di un bel film di Roberto Andò. Dai greci a Shakespeare nel film scorre un vizio secolare, ciò però non lo giustifica, né tanto meno lo sdogana, In filigrana il suicidio del capitalismo
Recensione (un po' ipertrofica) di un bel film di Roberto Andò. Dai greci a Shakespeare nel film scorre un vizio secolare, ciò però non lo giustifica, né tanto meno lo sdogana, In filigrana il suicidio del capitalismo
. La Repubblica, 7 maggio 2016
Domenica scorsa tra i vari temi che ho esaminato e che gravi, anzi gravissimi, affliggono il nostro Paese ma anche l’Europa, ho indicato la corruzione. Oggi ritorno su questo argomento da un altro punto di vista, quello dell’arte e della cultura: non da millenni i romanzi, il teatro, la filosofia, il cinema da quando esiste, hanno creato personaggi dominati dalla corruzione e questo dimostra che non si tratta di cose occasionali, dovute soltanto a istituzioni difettose, mancanza di controlli, strutture politiche e giudiziarie mal fatte che la rendono più diffusa o addirittura ne stimolano l’esistenza.
La carenza di controlli certamente rende più facile quel malanno sociale, ma esso è intrinseco all’anima degli individui di tutte le epoche e di tutti i luoghi. Se così non fosse gli autori delle più varie opere non ci racconterebbero le gesta di corrotti e di corruttori che hanno storicamente pervaso la società in tutto il mondo.
Dai tragici greci a Manzoni, da Dante a Shakespeare. Fino a Le confessioni di Roberto Andò con Toni Servillo. Ecco perché siamo destinati alla “caduta”.La tragedia greca ritrae la corruzione come uno degli elementi portanti dei protagonisti — Euripide, Sofocle e Aristofane in particolare. E altrettanto è accaduto nell’antica Roma e basta leggere Cicerone e Ovidio e Virgilio per cogliere questo fenomeno in tutta la sua dimensione. E se vogliamo osservare altre epoche ed altri autori vediamo la corruzione perfino alla corte di re Artù e poi nell’Eneide di Virgilio, nelle opere di Agostino, nella patristica cristiana.
Montaigne dedica ad essa molte pagine degli Essais, La Fontaine ne parla in parecchie delle sue poesie, La Rochefoucauld nelle sue Massime. Nell’ Inferno dantesco i corrotti affollano le Bolge. Ma l’autore centrale che descrive e stigmatizza corrotti e corruttori è Shakespeare.In Italia dopo Dante, Boccaccio, Savonarola, Ariosto, ecco Manzoni quanto e forse più di Shakespeare. Leopardi nelle Operette morali e nello Zibaldone.
Quindi Voltaire, Rousseau, Diderot, Victor Hugo, Stendhal, Pareto, Mazzini. Carlo Marx ne ha fatto addirittura elemento principale del capitalismo.L’elenco insomma è interminabile, i nomi che ho qui disordinatamente menzionato sono soltanto alcuni.
Ma se veniamo ai tempi nostri direi che la corruzione è sempre di più l’elemento centrale di moltissimi autori nel romanzo, nella saggistica, nello spettacolo teatrale e cinematografico. I nomi si rincorrono e si moltiplicano. Verga, I Viceré, Pirandello, Sciascia, Carducci, D’Annunzio, Pasolini, Ettore Scola, Umberto Eco, Saviano e la sua Gomorra.
Quanto al cinema americano, basterebbe il nome di alcuni attori che hanno impersonato di volta in volta i corrotti, i corruttori e quelli che rappresentano la lotta contro la corruzione — compito essenziale della loro vita: da Charlie Chaplin a Clark Gable a Michael Douglas a Robert Redford e soprattutto Burt Lancaster e Humphrey Bogart, protagonisti di film nei quali la corruzione e se necessario la violenza sono dominanti. Perfino Il Gattopardo ne è un esempio.
Il più recente dei film italiani che ne è una sorta di breviario dove la corruzione diventa addirittura omicidio è Le confessioni di Roberto Andò, con protagonista Toni Servillo travestito da monaco certosino. Si svolge in un elegante albergo in Svizzera dove si radunano i capi delle multinazionali che dominano il capitalismo, riuniti a congresso dal loro presidente. Alla riunione partecipa anche il monaco certosino che ha studiato a fondo il tema della corruzione, alla quale gli uomini d’affari lì riuniti si dichiarano non solo estranei ma addirittura mobilitati in nome d’un capitalismo robusto e sano, dedito a produrre profitti attraverso il lavoro socialmente utile e opere socialmente benefiche.
Il presidente di quel congresso tuttavia sente dentro di sé una sorta di rimorso che lo induce a confessarsi, spinto anche dalle esortazioni del monaco. Alla fine viene ucciso. L’ultimo che l’ha incontrato è il monaco ed è quindi su di lui che cadono i sospetti e un processo promosso da giudici anch’essi corrotti. Nel frattempo altri omicidi vengono commessi dai convenuti che si eliminano tra loro, i più forti contro i deboli per accentrare le risorse in poche mani. In conclusione sono tutti arrestati ed anche il monaco che però riesce a fuggire.
Il significato del film, reso benissimo da Toni Servillo, dimostra che la corruzione è un elemento che caratterizza la natura della nostra specie in ogni tempo, connesso con la ricerca altrettanto indefessa del potere e della guerra per ottenerlo. Merita d’esser visto quel film, con la speranza che riesca a curarci e guarirci (?) da una natura così perversa e ampiamente diffusa.
 . La Repubblica, 7 maggio 2016 (c.m.c.)
. La Repubblica, 7 maggio 2016 (c.m.c.)
Papa Francesco, allergico alle formalità, ha accettato ieri il premio Carlo Magno. Più che un premio era un appello. Il disorientamento intellettuale del Continente è andato a chiedere a Bergoglio di essere scosso: ha avuto quel che cercava. In un discorso come sempre denso di riferimenti teologici impliciti e segnato da un finale severamente profetico: «Sogno un’Europa di cui non si possa dire che il suo impegno per i diritti umani è stata la sua ultima utopia».
Nato nel 1949 ad Aachen, il premio Carlo Magno esprimeva un europeismo occidentalista, atlantico, anticomunista, secondo quella che era la cultura politica di un industriale, oppositore delle leggi razziste, come Kurt Pfeiffer. Ma in quell’europeismo, che parlava in tedesco e pensava in cattolico, inseguendo l’utopia di una Europa cristiana, è stata generata una Europa di pace, di cui il premio ha seguito le movenze. Il Carlo Magno è stato attribuito a varie figure ora politiche ora spirituali, come frère Roger di Taizé o Giovanni Paolo II che avevano dato un apporto effettivo alla costruzione europea.
Francesco non lo poteva ricevere allo stesso titolo. Il suo europeismo non pensa politicamente e culturalmente in termini est-ovest. Su quella linea lui vede correre un’altra istanza, quella ecumenica: che mette davanti alla chiesa latina (cattolici, luterani, ecc.) e alla chiesa d’oriente (greci, russi, ecc.) lo scandalo della divisione e la vocazione all’unità. Lo ha ripetuto ieri ponendo l’ecumenismo come “segno dei tempi” e citando le lezioni sulla “Idea d’Europa” come terra di diversità, lette alla radio tedesca nel secondo dopoguerra da uno dei più grandi teologi del Novecento a cui fa frequente riferimento, Erich Przywara.
E da lì Francesco ricava l’idea che tutte e solo le differenze integrate culturalmente sono la ricchezza europea, letta lungo un asse nord-sud, alto-basso, profitto-giustizia, liquidità-socialità, spiazzante rispetto alle filastrocche della crescita, del rigore e dell’innovazione.
Il Papa ha ieri invertito il principio-guida dell’europeismo wojtyliano: non ha mai citato le “radici cristiane” (o giudeo- cristiane come diceva il ritornello inconsapevole che in quell’assorbimento c’è il seme dell’antisemitismo) ricordate come matrice di cose meravigliose e dimenticandone le atrocità. Ha invece citato le “radici” plurali di un’Europa dei diritti umani, che il vangelo (il vangelo!) può “annaffiare”, portando i frutti di pace e di giustizia che i cristiani producono solo nella loro fedeltà al vangelo stesso.
Al posto della faglia otto-novecentesca fra credenti e non credenti, pone quella pluralisti e indifferenti: mette così in fuori gioco il secolarismo low-cost che ha impoverito l’Europa pensando che siano capi religiosi gentili e non teste pensanti che alimentano la cultura del dialogo. Non ha chiesto perciò un’ora di religioni, ma un’ora di “cultura del dialogo” che scardina il laicismo fobico e il clericalismo furbo.
Mentre l’analfabetismo religioso concima i fondamentalismi e dissecca la sorgente della riforma teologica delle chiese e delle fedi, Francesco ha chiesto agli europei di tornare al “logos” non come “ragione”, ma come “racconto” capace di un risultato. Chiedendo alla Europa: “cosa ti è successo?”, le ha aperto una porta lasciando che la paziente decida se e come varcarla.
Ha evocato la diversità di tre millenni davanti gli esponenti di una classe dirigente che ha espulso la storia dal proprio pensare per appiattirsi su un sapere fatto di intellettuali di corte, pronti a fornire costose soluzioni precotte a “decision makers” che spesso son solo dei consumatori di sondaggi, inconsapevoli della gravità dei problemi che li sovrastano.
Il triplice appello del Papa a dialogare, integrare e generare non è detto che troverà ascolto. La capacità europea di cogliere queste dimensioni è modesta: lo si vede nelle commemorazioni della Grande Guerra, sbriciolate in festicciole turistico- nazionali che hanno alzato muri in una memoria comune. Ma nella conclusione cupa e profetica del discorso di Francesco appare anche un segnale importante.
Dire che i diritti umani (non i valori, non le identità), potrebbero essere l’ultima utopia che finirà con l’Europa coglie il problema dei problemi. Dopo la libera circolazione, dopo i legami oggi vissuti come legacci non c’è un male: c’è il peggio: il peggio che ha già devastato l’Europa (e annichilito la Germania) almeno due volte in cent’anni.
La cosa tocca da vicino il cattolicesimo. C’è infatti un vento gelido e leggero che percorre l’Europa e interpella il Papa di Roma. Sono gli alisei dell’odio e della chiusura, che mescolano autoritarismo, antisemitismo e xenofobia in dosi variabili. Soffiano su molti Paesi, ma per una coincidenza singolare percorrono quella che un tempo si sarebbe detta l’Europa cattolica: spira dalla Polonia, scende nella Slovacchia, si rafforza in Ungheria e ora torna verso l’Austria. Disegna una antica geografia asburgica: poi affonda nel Lombardo-Veneto; tocca la Francia in cui il cattolicesimo tradizionalista si salda col lepenismo; e aleggia su una Italia in cui la chiesa è stata argine antileghista e che qualche schematismo elettoralistico vorrebbe ricattare puntando il disastro possibile alla tempia dei riluttanti.
Di questo vento Francesco sa di essere e dover essere al tempo stesso l’argine e l’esorcista. Il suo gesto di rimettere l’esigenza del vangelo davanti alla politica, ha un valore politico perché antepone effettivamente le istanze del vangelo come tale. La sua condanna della subcultura dei muri, fa stridere i denti al demone autodistruttivo del nazionalismo, che come nei racconti evangelici, strepita quando l’irruzione messianica scintilla dentro le mediocrità dei credenti.
E così il Papa non Europeo chiede all’Europa di liberarsi dalla dicotomia fra credenti- non credenti, e passare a quella fra pontieri e “muristi”, fra “fidenti” e indifferenti, da cui dipende il destino di questa utopia-Europa e la pace che chi la abita potrà o godere ancora un po’ o rimpiangere a lungo.

L«»Il granello di sabbia online, 6 maggio 2016
In una recente intervista a la Repubblica, Heinz-Christian Strache, l’uomo forte e potente della destra austriaca, erede di Joerg Haider, che a capo della FPO tira la volata a Norbert Steger _ tra non molti giorni in ballottaggio per la presidenza della repubblica, ha addirittura definito la Merkel e Renzi “scafisti di stato”, perché colpevoli, secondo lui, di una politica di accoglienza degli immigrati. Cosa abbiano fatto la cancelliera tedesca e il nostrano presidente del consiglio per meritarsi un’accusa così pesante non ci risulta chiaro. Soprattutto non si è vista tutta questa benevolenza da parte del governo tedesco e neppure di quello italiano.
Ma proprio la sproporzione tra fatti, comportamenti e giudizi rileva ancora una volta come la questione dei migranti sia il punto focale della politica europea. La mina su cui l’Europa può esplodere e su cui le piccole patrie di matrice apertamente xenofoba, razzista e fascista possono tornare a prosperare. Almeno nelle loro intenzioni. La sospensione di Schengen e l’invio delle truppe al Brennero non ne sono che la fosca avvisaglia.
Sarebbe sciocco prendere sotto gamba simili dichiarazioni, per quanto ci appaiono deliranti. L’Europa ha già conosciuto la tragedia reale del fascismo e del nazismo – il peggio è nato qui, nel nostro civilissimo continente -, anche se i discorsi di Mussolini e di Hitler potevano anche allora apparire tanto tronfi quanto ridicoli. Nello stesso tempo un conto sono Strache o l’ungherese Orban e un altro, malgrado tutto, la Merkel e lo stesso Renzi; ma è soprattutto vero che l’orientamento complessivo della Ue sul fronte delle migrazioni sta rapidamente volgendo al peggio, come dimostra l’accordo sulla deportazione dei migranti con la Turchia.
Ma se gettiamo un occhio su quanto avviene nella campagna presidenziale americana, con la cavalcata, fin qui vincente in ambito repubblicano – e speriamo che non tracimi da lì -, di Donald Trump e al senso comune che questi esprime ed esalta, ci rendiamo facilmente conto che la questione delle migrazioni domina la politica mondiale, non solo quella del vecchio continente. E lo farà ancora per molti anni a venire, diventando uno dei principali spartiacque che dividono le forze politiche e sociali, lungo una linea che spazza le tradizionali separazioni fra destra e sinistra, così come le abbiamo conosciute, penetra dentro di queste e ridisegna quindi il quadro e le geografie politiche.
Le cause sono profonde e diverse, ma tutte riconducibili agli effetti della globalizzazione capitalistica che ha dominato il mondo negli ultimi decenni. La vertiginosa crescita delle diseguaglianze sociali – mai conosciuta nella storia dell’umanità in simili proporzioni – è una delle conseguenze principali del moderno processo di globalizzazione. Come si sa il fenomeno è stato studiato molto approfonditamente. Non si può certo dire che manchi a livello diffuso la consapevolezza del problema. Ciò che manca è la volontà politica di invertire la rotta.
Il successo mondiale di un libro come quello di Thomas Picketty, lo sta a dimostrare in modo eloquente. Il rapporto di Oxfam (Working for the few: Political capture and economic Inequality, 2014) ci dice che quasi metà della ricchezza mondiale sta nelle mani dell’1% della popolazione (ha ragione lo slogan di Occupy Wall Street), ammonta a 110 trilioni di dollari, pari a 65 volte la ricchezza totale della metà più povera della popolazione del pianeta. Sette persone su dieci vivono in paesi entro i quali la disparità economica è aumentata negli ultimi 30 anni. Negli States, ad esempio, il 95% della crescita successiva alla crisi finanziaria scoppiata nel 2007, è andato a favore di quell’1% più ricco, mentre circa il 90% della popolazione si è sensibilmente impoverita. In Europa la concentrazione dei redditi sta galoppando; il 10% delle famiglie detiene il 60% della ricchezza del continente. Il grande compromesso sociale basato sul welfare state europeo è stato abbattuto. Le diseguaglianze si sono quindi allargate a dismisura tanto tra i paesi più ricchi e quelli più poveri, quanto all’interno in particolare dei primi.
In un quadro di questo genere, tenendo anche conto dell’incremento demografico nei paesi poveri e del fenomeno contrario in quelli più ricchi, il fenomeno migratorio è destinato a segnare la storia del pianeta per i prossimi decenni. Il problema è come governarlo sul piano del soddisfacimento dei diritti, non come combatterlo con muri, filo spinato o flotte armate.
A questo quadro si aggiungono le devastazioni ambientali e le guerre, anch’esse frutto dello stesso sistema. Dopo la seconda guerra mondiale l’Europa ha conosciuto un lungo periodo di pace, almeno nei confini della Ue. Ma la “pace perpetua” che sognava Kant rimane un’utopia irrealizzata. Infatti, come scrisse uno storico americano, James J. Sheenan, quei confini sarebbero stati presto minacciati, anche a causa di politiche di miope e egoistica austerità, da minacce e insidie che si accumulavano alle frontiere della Ue, lungo le quali “ricchezza e povertà, diritto e violenza, pace e guerra si incontrano continuamente”. Né ci si può salvare spostando in avanti, verso il Mediterraneo, quei confini, con i pattugliamenti marini, o arretrandoli, rimpicciolendo l’Europa. Tantomeno dando vita a una sorta di politica concentrazionaria globale, finanziando e sorvegliando militarmente lager nei paesi africani-mediterranei, di cui gli hotspot in Grecia o in Italia, cioè nei paesi della sponda Nord del Mare Nostrum sarebbero solo le anticamere.
Insomma “Fortezza Europa” è un’opzione che non sta in piedi da nessun punto di vista. “Chi ferma chi?” si è chiesto giustamente Etienne Balibar. “Chi è, per l’altro, la sua guardia di frontiera?” Così, oltre che con il ricatto sul debito, stanno strangolando la Grecia. In realtà le vecchie “naturali” frontiere non esistono più. Anche questo è un effetto della globalizzazione. L’Europa stessa può essere considerata non più la “capitale del mondo”, ma una zona in cui viene tentata una impossibile demarcazione fra Nord e Sud del mondo. Una linea di separazione che è contraddetta continuamente e quotidianamente dai flussi multidirezionali dei capitali per un verso e per un altro ridisegnata nel rapporto fra paesi creditori e paesi debitori che non rispecchia la vecchia geografia.
Per questo appare difficile – a differenza di quanto disse il Presidente Mattarella nel suo scialbo primo messaggio di fine anno - una distinzione tassonomica fra le diverse categorie di migranti. Certo, chi fugge da una guerra guerreggiata nel proprio paese ha più urgenze e bisogni basici e immediati di chi migra per ragioni di lavoro. Ma tutti hanno lo stesso diritto, basato sul principio della libera circolazione delle persone, che la globalizzazione vorrebbe circoscrivere ai capitali e alle armi. La politica delle piccole patrie; il richiamo alle vecchie forme di sovranità; lo stato di eccezione proclamato utilizzando la paura del terrorismo non fanno che aggravare il problema, rendendolo umanamente e socialmente più esplosivo e ingovernabile.
Che la vecchia Europa abbia bisogno di nuove menti e nuove braccia anche per la sua economia è una constatazione che qualunque economista serio e demografo scrupoloso non può negare. Oltre che il diritto delle persone a circolare e a scegliere dove vivere, vi è anche la convenienza ad accoglierle, se solo si guardasse la questione con razionalità. Non di stati d’eccezione, come quello proclamato in Francia, avremmo bisogno, ma, per dirla sempre con Balibar, di uno “stato di urgenza umanitario” allargato alla dimensione europea. Bloccare militarmente l’immigrazione è il suicidio dell’Europa. Nello stesso tempo il fenomeno è talmente grande che nessun paese può risolverlo da solo. Quindi, fosse solo per questo, di Europa c’è bisogno. Ma certo non di questa Europa, ancora tenacemente avvinghiata a politiche neoliberiste il cui fallimento è oramai conclamato, squassata da rigurgiti di nazionalismo e sciovinismo, percorsa da oscure paure che covano il peggio, pronta a privare un’intera generazione di un futuro. Dove lo Strache di turno può permettersi di ergersi a guardiano di frontiere immaginarie.
Il motto sull'icona, "Wir für Euch", "Noi per Noi", è uno degli slogan del FPO (Partito Liberale Austriaco), di cui Norbert Steger è candidato alle imminenti elezioni per il Presidente della Repubblica
 Un'analisi attenta al modo in cui, sotto la retorica dell'Universalismo, vengono camuffati i nazionalismi, razzismi, e le altre perversioni del pensiero e violazioni dei diritti, nel mondo di oggi (e soprattutto nell'Europa).
Un'analisi attenta al modo in cui, sotto la retorica dell'Universalismo, vengono camuffati i nazionalismi, razzismi, e le altre perversioni del pensiero e violazioni dei diritti, nel mondo di oggi (e soprattutto nell'Europa).
Il Fatto Quotidiano online, 5 maggio 2016 (c.m.c.)
Gli Stati-nazione e la loro ideologia di governo, il nazionalismo, compaiono grosso modo contemporaneamente al credo del valore universale dell’Umanità.
Si potrebbe dire che se c’è una prova dell’essenza ipocrita dell’universalismo, questa è la prova perfetta. Probabilmente nel corso della storia non ci sono mai state così tante persone assassinate dal nazionalismo, dal razzismo e dalle altre ideologie come nel XX secolo sotto il sole universale dell’Umanesimo. Si potrebbe replicare che se il genocidio è diventato per noi il male assoluto è proprio grazie alla validità dei valori universali. Dopo tutto la letteratura inizia con il genocidio. Troia fu distrutta, tutti gli uomini vennero uccisi e le donne prese come schiave, ma per molte generazioni questa è stata solo una bella storia da leggere. Cartagine fu arata e cosparsa di sale; vero o meno che fosse, sta di fatto che i Romani se ne vantavano.
Cosa è cambiato? Ci sono delle alternative. Molti giudizi negativi sulle altre razze, religioni non vengono più dati per scontati, ma respinti come pregiudizi. Mentre gli antichi conquistatori erano fieri di definirsi conquistatori, oggi preferiscono chiamarsi liberatori. E’ ipocrita? Per lo più sì. La creazione di molte istituzioni internazionali, in primo luogo le Nazioni Uniti, incorpora (almeno apparentemente) il concetto di universalità. Non siamo estranei e ancor meno nemici, siamo nazioni diverse di un pianeta comune. E’ ipocrita? Per lo più sì.
E’ ipocrita in primo luogo perché l’universalismo nulla significa per molte culture, con la sola eccezione della scienza e della tecnologia. Sebbene quasi tutti gli Stati del mondo abbiano firmato la Dichiarazione universale delle Nazioni Unite, tale firma ha o può avere conseguenze pratiche solamente nelle democrazie liberali. Se ricordo la contraddizione o solo la tensione tra valori universali e la posizione antropologica fondamentale, ho in mente soltanto le democrazie liberali. Non solo gli Stati totalitari, ma anche le autocrazie ricorrono ai pregiudizi contro l’Altro come arma per garantirsi l’appoggio popolare.
Al tempo stesso il rapporto con l’”Altro” diventa selettivo. I pregiudizi nazionali, razziali, religiosi, sessuali rimangono vivi, anche se a volta nascosti, se confermano la posizione antropologica fondamentale, la convinzione che “noi” siamo il centro dell’universo, la sensazione di sicurezza. Per molti altri aspetti, tuttavia, la curiosità e l’interesse per l’Altro hanno guadagnato terreno. La Cina, l’Africa nera, lo yoga, il buddismo, la religione Krishna vanno di moda. I ristoranti offrono cucine di ogni parte del mondo. Nelle sale da concerto, nelle gallerie, alla televisione non c’è quasi più un “noi” e un “loro”.
La scena cambia completamente quando l’”estraneo” si stabilisce permanentemente tra “noi”.
La tensione tra posizione naturale e universalità non ha il medesimo significato in tutte le democrazie liberali. A questo punto c’è una sostanziale differenza tra Stati-nazione e altri Stati moderni, una differenza tra Europa e il cosiddetto “nuovo mondo”.
Parlo dell’attuale Europa, di Stati nei quali la “nazione” è diventata una identità onnicomprensiva nella quale tutti i bambini imparano a scuola o dai genitori quanto la loro nazione sia superiore. In queste nazioni i bambini vengono allattati al seno con le leggende del passato nazionale, con le storie sulla grandezza della loro nazione e su come fu tradita. Si fondono insieme identità etnica, politica, culturale, tradizionale e talvolta persino religiosa. Per definizione si esclude la doppia identità. Nel nuovo mondo si può essere “irlandesi americani”, “afro-americani”, “cino-americani” “Italo-americani” ecc., in Europa no. I francesi sono solo francesi, i tedeschi solo tedeschi, gli ungheresi solo ungheresi. In uno Stato-nazione l’”estraneo” non si sarebbe potuto integrare senza essere assimilato. L’assimilazione comporta la totale identificazione con la nazione ospite, l’abbandono della cultura, della religione, del modo di vestire, delle leggende, del passato tradizionale dei migranti. Chi non riesce ad assimilarsi rimane un paria. Al contrario del “nuovo mondo”, l’emancipazione politica, vale a dire l’aspetto principale dell’integrazione, significa poco o nulla in uno Stato-nazione.
Il carattere escludente degli Stati-nazione è chiarito nel migliore dei modi possibili dalla storia degli ebrei europei nel XIX e XX secolo e dalla storia di due guerre mondiali. Il moderno antisemitismo (al contrario dell’originario anti-ebraismo) è stato il prodotto degli Stati-nazione. La trasformazione del nazionalismo in razzismo non è stato un mero caso in quanto il nazionalismo etnico contiene in sé un elemento di razzismo. Ho detto in precedenza che la prima guerra mondiale è stata una guerra europea, la vittoria degli Stati-nazione contro l’internazionalismo e il cosmopolitismo. Allo stesso modo in cui l’intreccio tra etnia e razza è stato la motivazione (almeno da parte tedesca) della seconda guerra mondiale.
Dopo la devastazione della seconda guerra mondiale, alcuni Stati europei tirarono le conseguenze in ordine al lato oscuro degli Stati-nazione e crearono l’Unione Europea. Non bisogna sottovalutare il significato di questo grande progetto. Gli Stati membri dell’Unione Europea si sono impegnati a non iniziare mai più una guerra gli uni contro gli altri. Non di meno a tutt’oggi nessun sentimento identitario europeo ha conquistato la stessa forza o lo stesso significato delle identità nazionali degli Stati membri. Se chiedessi ad un qualunque bambino di un qualunque Paese dell’Unione Europea: “cosa significa per te essere europeo?”, dubito che sarebbero in molti a rispondere o a capire il senso della domanda. Il problema non va individuato nei conflitti di interesse, ma nei conflitti in ordine al significato di appartenenza, al problema dell’identità e della legittimazione generali, se non universali.
E tuttavia gli europei non sono più “estranei” per gli altri europei. Un francese non è estraneo per un tedesco, uno slovacco o un ungherese. L’ideologia nazionalista, i miti e le leggende nazionali mobilitano ancora popolazioni frustrate e, quanto più frustrate sono tanto più efficaci sono i vecchi miti. Oggi, tuttavia, il vero estraneo non è più l’altro europeo, ma il migrante. I migranti sono gli estranei che arrivano tra noi da chissà dove, hanno costumi e religioni diversi, hanno tradizioni, leggende, punti di vista diversi su ciò che e vero e ciò che è falso. Sono terroristi, occupano la nostra terra e la distruggono. Il pericolo intrinseco nello Stato-nazione si ripresenta. L’estraneo deve assimilarsi o scomparire completamente.
Da un lato l’Europa ha un tasso di natalità insufficiente e ha bisogno dei migranti. Nell’arco di circa 60 anni gli europei hanno ucciso cento milioni di europei. Mancano non soli i figli, i genitori, i nonni, i bisnonni. I peccati dei padri e dei nonni vanno espiati.
Dall’altro lato, gli europei sono pronti sono disposti ad accettare i migranti solo se sono disposti ad assimilarsi. Assimilarsi non all’Europa (che non ha una memoria tradizionale e culturale comune né una medesima lingua), ma a questo o a quello Stato-nazione.
I rifugiati provenienti da zone di guerra dell’Asia o dell’Africa, oggi si rifanno alla dichiarazione universale: “voi europei avete inventato che tutti gli uomini nascono ugualmente liberi, quindi noi siamo come voi. Di conseguenza dovete trattarci come esseri umani con pari diritti e lasciarci vivere con voi nel vostro pacifico, abbondante e piccolo continente”. Gli europei rispondono: “è vero, tutti gli uomini nascono ugualmente liberi e noi siamo tutti uguali, ma la maggior parte degli uomini debbono rimanere dove si trovano. Noi abbiamo lavorato per le nostre ricchezze che sono comunque a rischio in quanto dobbiamo sfamare la nostra popolazione povera. Abbiamo dei diritti sulla nostra terra e siamo noi a decidere che può vivere qui. Chi possiede una casa, detta le regole. Anche i parenti prossimi che vengono a trovarci e sono nostri ospiti a Natale debbono rispettare le nostre regole”. L’estraneo chiede: “avete bisogno di regole per potere salvare da morte certa chi si trova in una casa in fiamme? Se non è così, perché non consentite ai rifugiati di entrare in casa vostra senza alcuna condizione?”. Gli europei rispondono: “accogliamo i rifugiati senza condizioni e li ospitiamo nei campi profughi fin quando non potranno tornare da dove sono venuti senza correre pericoli. Ma debbono comunque rispettare delle regole. Le stesse regole della casa? O altre regole? Che regole sono le regole della casa?”.
Un americano risponderebbe: “le regole della casa sono le regole dello Stato. Tutti debbono osservare le leggi dello Stato sia che riguardino il comportamento verso gli altri sia che riguardino il comportamento da tenere tra voi o nei confronti di vostra moglie o dei vostri figli”. “Questo può essere accettabile”, risponderebbe l’estraneo “ma alcune regole della nostra religione non ci consentono di onorare sempre le leggi dello Stato”. “Mi spiace”, risponderebbe l’americano. “In tal caso non potete sistemarvi in casa mia”. Ma io non sono americano, io sono europeo, cittadino di uno Stato-nazione…nei nostri Stati-nazione ci sono molte più regole della casa rispetto al nuovo mondo. Dovete imparare la lingua dello Stato, la tradizione della nazione, osservarne i costumi, adottarne il comportamento pubblico e privato e considerarvi membri di quella particolare nazionale”. “E se non lo faccio?” “Sarai un emarginato, non troverai un lavoro decente, i tuoi figli non avranno la possibilità di salire la scala sociale”. “Ci chiedete troppo”, protesta l’estraneo. “Sì, lo so, ma dovete capire che abbiamo le nostra tradizione. A lungo ci siamo considerati caucasici rispetto alle persone di colore e questo genere di razzismo sfortunatamente è importante per molti nostri compatrioti. Ci siamo considerati il continente cristiano e non è facile abbandonare questa tradizione. Ci siamo considerati progressisti, non solo nel campo dell’hi tech, ma anche in quanto democratici liberali in molti aspetti della vita di tutti i giorni”. “Siete gente molto strana”, sottolinea l’estraneo.
Riferimenti
la lectio magistralis della filosofa Agnes Heller si terrà il 6 maggio al Bergamo Festival “Fare la pace” (5-15 maggio).

« Il manifesto, 6 maggio 2016 (c.m.c.)
La recente pubblicazione di alcuni documenti sui negoziati in corso sul Ttip effettuata da Greenpeace ha riportato sui media il trattato di libero commercio tra Usa ed Europa. Tranne in alcuni momenti – in Italia solo quando sembra poter diventare una discussione che riporta al cortile di casa – tutto quanto sta accadendo intorno al Ttip non trova granché spazio nella discussione pubblica e politica.
L’argomento, in effetti, non è dei più semplici perché la volontà dei negoziatori (in primo luogo gli statunitensi) è quella di regolare il commercio del mondo occidentale all’interno di standard che da quel momento in poi saranno da considerarsi universali. O almeno in grado di regolare i rapporti tra quasi tutti gli Stati tranne, dicono i maligni, Cina e Russia, escluse, guarda il caso, da tutto questo movimento internazionale desideroso di «liberalizzazioni». Ci sono molti aspetti, inoltre, da cui discendono dei «no» talmente forti al trattato da aver coinvolto centinaia di associazioni e organizzazioni in mobilitazioni che trovano sfogo nelle piazze di molti paesi.
In Italia sabato 7 maggio ci sarà una manifestazione nazionale e per capire tutte le ragioni dei «no» e i motivi delle campagna di «Stop Ttip» sabato, in occasione delle proteste, sul manifesto ci sarà un inserto ad hoc di otto pagine. Nel frattempo è bene segnalare la letteratura che esiste circa le argomentazioni contro «i metodi» con i quali il trattato si sta portando avanti, oltre che contro il trattato stesso (se mai arriverà a compimento). In Ttip – L’accordo di libero scambio transatlantico, quando lo conosci lo eviti (Derive e Approdi, 13 euro), Paolo Ferrero, Elena Mazzoni e Monica Di Sisto, affrontano tutto quanto riguarda le ricadute economiche, sociali e politiche del Ttip. Partendo proprio dalla domanda di partenza: qual è l’obiettivo dichiarato del Ttip?
Gli autori del volume spiegano che il fine è «abbattere le differenze di normative tra le parti, differenze che sono considerate barriere non tariffarie al commercio e agli investimenti: l’idea chiave è che, riducendo queste differenze di regolamentazione, il commercio e gli investimenti aumenteranno con conseguente crescita economica». La prima constatazione è la convenienza di un percorso simile: a chi porterà dei vantaggi? «Un percorso simile potrebbe sfociare in un’enorme ingerenza sulla capacità degli Stati di legiferare nell’interesse dei cittadini, perché il Trattato crea delle costrizioni internazionali che, in modo evidente, vanno a influire sull’autonomia normativa delle parti».
Su questo la posizione dell’Europa – che in realtà qualche dubbio lo ha – non ha alcun tentennamento, come dimostrato dalla Commissaria al Commercio Ue, Cecilia Malmstrom quando ha specificato che «i due contraenti si impegnano, con l’accordo in fase di negoziazione, a eliminare le normative che impediscono al mercato transatlantico di essere armonioso».
Al di là dell’ironia dell’utilizzo della parola «armonia» (usata da Pechino per indicare la necessità di una società sottoposta al volere del Partito comunista), le parole di Malmostrom indicano una chiara volontà dell’Ue di appoggiare i piani tanto degli Usa quanto delle multinazionali, in favore dell’abbassamento di standard di qualità che finiscono poi per ripercuotersi in molti settori delle nostre vite future. In ballo non c’è tanto e solo la sovranità di uno stato, quanto le conquiste fatte nel corso del tempo in tema di diritti ambientali, del lavoro, dell’alimentazione. E soprattutto c’è la volontà di negoziare – come dimostrato dai leaks resi pubblici da Greenpeace – senza che la società civile sappia di cosa si sta discutendo, salvo poi assistere alla farsa dell’eventuale ratifica dei parlamenti nazionali completamente esclusi del resto dalle trattative. Gli autori del volume, in ogni caso, vanno oltre.
Mettiamo, sembrano dire, che tutto questo insieme di elementi generali (compreso quello che riguarda la risoluzione delle controversie tra Stati e aziende) non sia sufficiente per un «no» energico al progetto di Ttip, vediamo allora cosa succede nell’ambito numerico, economico, puramente di guadagno. Se il Ttip, ad esempio, portasse all’azzeramento «delle tariffe doganali e dei contingenti tariffari, le esportazioni agroalimentari degli Usa verso l’Ue aumenterebbero di 5,5 miliardi di dollari rispetto all’anno di riferimento (2011), mentre i livelli di esportazioni europee verso gli Stati uniti crescerebbero di 0,8 miliardi».
Questo accade perché l’Ue «attualmente impone barriere tariffarie più alte sulle importazioni di quanto non facciano gli Usa», ma se «oltre ai dazi, si rimuovono dal commercio transatlantico alcune specifiche misure non tariffarie, la situazione è destinata a cambiare di molto».
Ovvero, carne, colture, frutta e verdura: sono questi «gli ambiti più interessati da misure non tariffarie restrittive, e rimuoverle si tradurrebbe in un aumento delle esportazioni degli Usa verso l’Europa di ulteriori 4,1 miliardi». La crescita di esportazioni complessive degli Usa diventerebbero quindi di quasi 10 miliardi di dollari. Per l’Europa la rimozione delle misure non tariffarie si tradurrebbe in un guadagno di 1,2 miliardi. E al di là di questo: chi quantificherà i danni per la salute?

Il Fatto Quotidiano, 5 maggio 2016 (p.d.)
I politici non hanno smesso di rubare, hanno solo smesso di vergognarsi”. L’ha detto Piercamillo Davigo in un’intervista al Corriere della Sera, ripetendo una frase che è stata un grande classico in tanti suoi interventi pubblici negli ultimi anni. Si sono indignati i politici, ma non i cittadini. E comunque la cronaca sembra dargli ragione.
In una settimana abbiamo dovuto raccontare ai lettori de ll’arresto del sindaco di Lodi Simone Uggetti (Pd) per turbativa d’asta; dell’arresto di Antonio Bonafede, consigliere comunale del Pd a Siracusa, mentre stava per imbarcarsi su traghetto con 20 chili di droga; dell’indagine per concorso esterno in associazione mafiosa a carico del consigliere regionale e presidente del Pd in Campania, Stefano Graziano; dell’incredibile vicenda del Consiglio regionale della Sardegna, dove in cella si sono incontrati il vicepresidente del Consiglio regionale Antonello Peru (Forza Italia), arrestato per una vicenda di presunti appalti truccati, e Giovanni Satta (centristi) che quando è stato fermato pertraffico internazionale di stupefacenti ancora non era consigliere regionale. Lo è diventato – da detenuto – dopo che a seguito di vari ricorsi, l’ufficio elettorale della Regione gli aveva assegnato il seggio.
La questione morale incombe, è un’emergenza ormai cronica. Abbiamo chiesto a Gustavo Zagrebelsky com’è possibile che quelle affermazioni di Enrico Berlinguer (“I partiti sono soprattutto macchine di potere e di clientela. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune”), 35 anni dopo suonino così attuali.
Dalla politica ci dicono che la responsabilità penale è personale, che bisogna essere garantisti: i corrotti sono casi isolati, cioè singole mele marce. Cosa ne pensa?
La responsabilità penale è personale, ma la corruzione non è semplice illegalità individuale. Coinvolge necessariamente più soggetti, come dice la parola: la corruzione implica una cooperazione. I giuristi parlano di reato plurisoggettivo. Per vivere deve necessariamente allargarsi: i corruttori sono indotti a estendere progressivamente il raggio della corruttela per ottenere coperture e per questo moltiplicano le complicità dei corrotti che, a loro volta, diventano corruttori. C’è una forza diffusiva che la semplice illegalità di per sé non possiede. La corruzione è un sistema, non è la somma di singole illegalità. Esempio: se un contribuente fa una dichiarazione fiscale falsa, siamo di fronte a un’illegalità, che si può colpire processando l’evasore. Ma se il contribuente si mette d’accordo con il suo consulente fiscale, che si mette a sua volta d’accordo con la Guardia di Finanza e con l’Agenzia delle Entrate, tutto questo crea un sistema diffuso di corruzione.
Come le associazioni criminali.
Infatti. A differenza dell’illegalità, la corruzione crea ordinamenti alternativi a quelli legali. Per questo, mi pare riduttivo parlare di “questione morale”: siamo di fronte a una “questione istituzionale”. La mafia, per esempio, è una istituzione con regole interne, autorità di governo, agenti esecutivi e perfino tribunali. C’è una legittimità mafiosa che si contrappone alla legittimità dello Stato. Bisogna partire dal presupposto che si tratta di conflitti tra ordinamenti. È illusorio pensare che si possa sconfiggere la corruzione esclusivamente con processi che necessariamente perseguono i singoli. Come se si volesse vincere una guerra eliminando, uno ad uno, i combattenti dell’al traparte, mentre i caduti sono sostituiti da nuove leve e i ranghi si rigenerano. Gli ordinamenti si sconfiggono con guerre d’altro tipo; innanzitutto stabilendo una linea di demarcazione netta, un fronte, tra chi sta di qua e chi di là, cioè combattendo la “zona grigia”di chi sta un po’di qua e un po’di là.
Però la selezione della classe dirigente è affidata, non da oggi, al diritto penale. Ma la verifica penale non ha questa finalità, né il giudice è un’autorità morale.
I giudici svolgono i loro compiti con riguardo a singoli fatti e singoli autori dei fatti. Il conflitto tra ordinamenti non può accontentarsi d’una delega ai giudici. Coloro che si richiamano non ipocritamente alla legalità devono innanzitutto selezionare una classe politica priva di commistioni con l’altro ordinamento, mettendo confini invalicabili tra vita e malavita. Questo non può farlo la magistratura. Soprattutto in un momento come questo in cui tutti gli indizi portano a dire che il mondo della politica è estesamente penetrato dalla corruzione: significa che tra questi due opposti ordinamenti oggi non c’è conflitto, ma connivenza. O, addirittura, che s’è creato un meta-ordinamento diffuso, basato sulla convivenza.
Quali sono, allora, i rimedi?
Non possono essere solo le armi giudiziarie. Che ci devono essere, ma non sono risolutive. Mi chiedo, poi, se esiste davvero la volontà di combatterla, la corruzione. Scoppia uno scandalo e qual è la reazione? Se pur non si accusa la “giustizia a orologeria”, si esprime “piena fiducia nella magistratura”; ci si trincera dietro al “fino alla condanna definitiva nessuno può considerarsi colpevole”; si ritorce l’accusa: anche voi avete i vostri corrotti. Tutto ciò mi pare dimostri una fondamentale ambiguità ai limiti dell’a cquiescenza. La delega ai giudici è uno sfuggire alle proprie responsabilità; la ritorsione dell’accusa significa considerare la corruzione non un problema di integrità di sistema ma un’occasione per una gara a chi è più o meno corrotto. Così, si finisce per adagiarsi. Il vecchio discorso “tutti colpevoli, nessun colpevole”significa “siamo tutti sulla stessa barca”. Per non affondare tutti insieme, dobbiamo darci una mano ed essere tolleranti, gli uni verso gli altri. Mi chiedo se i nostri politici che usano questi argomenti si rendano conto del senso di quello che dicono. Credo di no.
Nel 2014 su 1100 consiglieri regionali, 521 erano sotto inchiesta; per 300 era stato chiesto il giudizio per spese pazze con i fondi ai gruppi.
Spesso sono quisquilie, disgustose ma quisquilie per le quali ben venga la repressione penale. Più preoccupanti sono le reti di connivenze che fanno capo a faccendieri e lobbisti vari, massoneria affaristica, finanza laica e vaticana, giornalismo al soldo, ecc. Questa è la potentissima rete della corruzione che tocca interessi finanziari, industriali, della comunicazione, degli armamenti, nazionali e internazionali. Che cosa c’è dietro, per esempio, al fatto che in Parlamento non si è potuto discutere dell’acquisto degli F-35? In una parola, la corruzione alligna nelle oligarchie. Per combatterla davvero, ci vuole democrazia.
Vero, ma la riforma costituzionale non va in direzione opposta, garantendo immunità a politici regionali tutt’altro che insospettabili e promossi senatori?
Il Senato dei 100 è un pasticcio in sé e una catastrofe funzionale: altro che semplificazione. L’immunità parlamentare nella storia della Repubblica ha subìto un rovesciamento. In origine proteggeva la libertà della funzione parlamentare. Oggi, spesso serve a proteggere il parlamentare. Cioè: mentre una volta si era protetti perché ci si dava alla politica, oggi ci si dà alla politica perché si vuole essere protetti. Insomma, in diversi casi il titolo preferenziale per essere messo in lista è stato avere grane con la giustizia. Sarà così anche per i nuovi senatori?
Il presidente emerito Napolitano ha citato voi “professori del no” in un’intervista al Corriere: “Vedo tre diverse attitudini. Quella conservatrice: la Costituzione è intoccabile. Quella politica e strumentale: si colpisce la riforma per colpire Renzi. E quella dottrinaria ‘per fezionista’. Dubito che tutti i 56 costituzionalisti e giuristi che hanno firmato il manifesto contro siano d’accordo su come si sarebbe dovuta fare la riforma. Ma è una posizione insostenibile: perché il No comporterebbe la paralisi definitiva”. Vuole rispondere?
Vincenzo Cuoco – commentatore della rivoluzione napoletana del 1799 – diceva che le Costituzioni sono abiti che devono essere indossati da un corpo. Questo corpo è ciò che chiamiamo la Costituzione materiale, fatta di convinzioni politiche, tradizioni, comportamenti, rapporti e anche di corruzioni. Le costituzioni non sono belle o brutte in sé, ma sono adatte o inadatte al corpo che deve indossarle. Se il corpo è quello della statua modellaria di Prassitele – diceva Cuoco –la Costituzione indossata farà una bella figura. Ma se il corpo è deforme, l’abito servirà soltanto a coprire le deformità. Non si corregge il corpo con la veste. A differenza del presidente Napolitano, penso che, parlando di conservatori, perfezionisti e innovatori, si finisce per perdere di vista la vera posta in gioco: le degenerazioni della vita politica materiale, degenerazioni che non si combattono, ma si occultano soltanto mettendo loro sopra una veste nuova. Il cosiddetto “combinato disposto” della legge elettorale e della riforma costituzionale è per l’appunto questa veste nuova, sotto la quale si nascondono tendenze, da tempo in atto, a separare la politica dalla partecipazione dei cittadini e ad accentrarla in centri di potere sospesi per aria o appesi in alto. La chiamano democrazia perché ogni cinque anni ci faranno votare? Ma votare su che?
In verità lei una proposta di riforma l’ha formulata.
Sì. L’ho inviata alla ministra Boschi, come si era concordato. Ma è sparita. Anche il presidente Napolitano l’ha ricevuta, ma era assai diversa da quella ch’egli sosteneva e sostiene. Così è stato un buco nell’acqua. Solo mi dispiace che si dica che chi è contrario a questa riforma non ha saputo e non sa proporre nulla di alternativo. È vero il contrario. Per onore della verità.

». Il manifesto, 5 maggio 2016 (c.m.c.)
Il 20 aprile in Italia i metalmeccanici hanno scioperato per il contratto nazionale. Il 25 aprile, inaugurando la fiera di Hannover ,la cancelliera Merkel e il presidente Obama hanno dato il loro sostegno politico al programma “Industry 4.0”. Sono due momenti del grande processo di trasformazione del modo di produrre, al cui centro non sono solo le tecnologie, ma il ruolo dei lavoratori , se autonomo o subalterno a questo cambiamento.
Superato l’arcigno ammonimento di Taylor “non siete pagati per pensare”, ora nella fase della grande innovazione del Toyota Production System, il TPS, ai lavoratori si dice “la qualità dipende da voi”, perché siete il sistema nevoso di un “ un processo di miglioramento continuo “ dei metodi di lavoro e dei prodotti.
E’ il kaizen , che sta alla base della riorganizzazione di un migliaio di grande e medie imprese italiane, in gran parte manifatturiere . Di esse quella di Fabio Storchi, il presidente di Federmeccanica ,è considerata una buona pratica da Masaaki Imai, uno degli ingegneri giapponesi che si sono assunti il compito di diffondere il TPS nel mondo e che opera da più di in decennio in Italia attraverso il “Kaizen Institute” di Bologna. Avere una produzione con zero sprechi, zero difetti, in tempi certi richiede ai lavoratori energia, inventiva, ma anche tanta fatica.
Non a caso , per la loro lunga esperienza, gli operai giapponesi definiscono il kaizen come “ uno strizzare acqua da un asciugamano asciutto”. Questo impegno, per essere sostenibile, deve essere riconosciuto e pagato , ma come parte del processo di costruzione della “comunità aziendale”, di cui i lavoratori devono sentire di appartenere , avendo in cambio una promessa di lavoro stabile e i benefici del welfare aziendale.
L’aziendalismo è la cifra del TPS ,che per questo ritiene un intralcio il contratto nazionale con i suoi diritti e le sue garanzie per tutti. Fabio Storchi ha dietro le spalle questa cultura e questa pratica quando propone come centrali nel rinnovo contrattuale il welfare e il salario contratti in azienda, cioè l’eutanasia del contratto nazionale.
L’obiettivo è un sindacato collaborativo o marginale, senza potere contrattuale sulle concrete condizioni di lavoro lasciate al governo dell’impresa, che interviene attraverso i team leader, lavoratori con competenze specialistiche e trasversali che su mandato dell’azienda coordinano un piccolo gruppo di compagni . E‘ una estesa rete di consenso alle politiche ed ai valori aziendali, rispetto alla quale i rappresentanti sindacali sono in grande svantaggio , anche numerico: in media sono uno contro dieci.
“Industry 4.0” deve essere un ulteriore avanzamento in questa direzione: più internet, più robotica, più stampanti 3D; pianificazione della produzione via rete integrandovi il cliente come partner e governando così la turbolenza dei mercati; logistiche adattabili perché continuerà a crescere la rete della fornitura . Il mercato richiede personalizzazione, flessibilità, velocità. Per questo non basta la tecnologia. Servono figure professionali poliedriche e competenti che sappiano gestire la complessità e risolvere problemi, . I teorici di “ Industry 4.0 “puntano sull’ operaio “aumentato”, più versatile di in robot, nervo della lean production.
Avrà, comunque, sempre il difetto di fare domande sulla sua condizione. Finora il TPS è sembrato avere le risposte, puntando sulle culture aziendali e sulla partecipazione in via gerarchica per i lavoratori al centro del processo produttivo e disperdendo tutti gli altri nel vasto mare del precariato, dagli immigrati che fanno funzionare la logistica ai nuovi lavoratori autonomi iper-laureati dei moderni servizi alle imprese.
Non è detto che sia sempre così e che non sia possibile una ripresa di iniziativa sindacale, di cui i contratti nazionali sono aspetto importante. Occorre, però, aprire una discussione intorno al ruolo dei lavoratori nei processi di innovazione tecnologica e di cambiamento sociale. E’ positivo che nel documento di CGIL-CISL-Uil per un moderno sistema di relazioni industriali si accetti la sfida sulla questione della partecipazione toglendola dal chiuso recinto dell’aziendalismo e della dipendenza gerarchica e riproponendola come “ valore fondamentale per la crescita democratica, politica e sociale dell’ intera collettività nazionale” come è giusta la scelta della contrattazione “inclusiva” come strumento per unire quanto il TPS tiene diviso.
Condizione di tutto ciò è un sindacato colto e combattivo, capace di proposta e di conflitto. Con questo si deve cimentare la nuova generazione di quadri sindacali per uscire dalle trappole del “nuovismo “e del burocratismo.

«». Il Fatto Quotidiano online,
La riforma della Costituzione, che sarà a breve sottoposta al vaglio di un referendum, è soltanto l’ultima (per ora) convulsione di una politica tutta italiana, che riforma l’esistente per l’incapacità di gestirlo, o di gestirlo nel modo voluto. E’ il prodotto della stessa violenta immaturità politica per la quale non esiste in questo paese un partito che abbia il coraggio di definirsi conservatore. Possibile che non ci sia nulla da conservare della storia politica del paese? Nessuna conquista del passato che valga la pena di mantenere? Come insegna il Gattopardo cambiare continuamente tutto è un modo di conservare, ma non di conservare il meglio o il buono: di conservare il potere, a costo della distruzione del sistema.
Ovviamente perché la strategia della riforma continua, funzionale alla conservazione del potere anziché all’interesse del cittadino – elettore, funzioni è necessario che la politica sia in grado di convincere il cittadino che dopo tutto riformare, se non addirittura rivoluzionare, il sistema sia nel suo interesse. La riforma della Costituzione è la madre di tutte le riforme: cambia i meccanismi decisionali e i rapporti di potere al più alto livello politico e consente quindi potenzialmente qualunque ulteriore riforma dell’ordinamento dello Stato e dei suoi servizi.
E’ quindi importante analizzare il meccanismo attraverso il quale l’elettore viene imbrogliato e convinto la politica faccia l’interesse dei cittadini anziché il proprio.Uno strumento molto importante dell’imbroglio è la denigrazione dell’esistente: almeno dai tempi di Berlusconi, se non da prima ancora, è in corso l’esperimento politico di creare consenso elettorale attraverso la (presunta) denuncia dei difetti del sistema, anziché attraverso la pubblicizzazione dei suoi meriti.
Denigrare è sempre più facile che lodare: basta infatti riferirsi ad una idealità della cui realizzabilità pratica non c’è traccia. Con l’aiuto di giornalisti compiacenti, sarà sempre possibile trovare un giudice che indossa calzini azzurri, a dimostrazione e vituperio dei difetti della giustizia; o un caso di malasanità, a dimostrazione che un Servizio Sanitario Nazionale valutato dall’Oms il secondo migliore del mondo, sia un disastro e una vergogna. Sarà sempre possibile additare al pubblico disprezzo un sistema della ricerca che è ottavo nelle graduatorie internazionali o una università pubblica che si classifica duecentesima nel mondo? Ciò che deve essere nascosto (e basta non riferirlo) è che la duecentesima università del mondo, rispetto al numero delle università valutate, si classifica al 97mo percentile: su 99 università scelte a caso, la duecentesima del mondo è peggiore di tre e migliore delle rimanenti novantasei; allo stesso modo, basta non riferire che il Servizio Sanitario Nazionale nel quale un paziente è morto in corso di intervento chirurgico salva ogni giorno la vita di mezzo milione di pazienti diabetici.
Una volta che il cittadino è stato convinto da una propaganda martellante che i servizi pubblici che paga con le sue tasse ed ai quali ha accesso sono pessimi, e che quindi qualunque riforma sia preferibile allo status quo, la strada del consenso è aperta e qualunque saltimbanco può costruirsi una carriera politica sulla semplice promessa di “cambiare” qualcosa. Berlusconi ha promesso cambiamenti per vent’anni, Renzi segue l’esempio, Beppe Grillo pure.
Ovviamente domani saremo insoddisfatti delle riforme di Renzi, come pure di quelle di Beppe Grillo (o chi per lui): perché riformare il secondo miglior Servizio Sanitario Nazionale del mondo, o l’ottavo sistema della ricerca, comporta il grosso rischio di renderli peggiori anziché migliori: date le condizioni di partenza c’è molto più margine per il peggioramento che per il miglioramento, tanto più se lo scopo della riforma non è il miglioramento del sistema ma il controllo del potere.Un consiglio Opporsi alle ipotesi di riforma (Costituzionale o altre) se proposte da gruppi di potere che mancano di riconoscere i pregi del sistema che intendono riformare: perché quei pregi li distruggeranno, senza dare garanzia del miglioramento promesso.

«
L’EUROPA è nata sul diritto di movimento. È stata voluta da ex-nemici mortali che si impegnarono a garantire la libertà di movimento ai loro concittadini, per rendere i confini porosi e infine, con il Trattato di Schengen, aperti agli europei e, seppure con minore certezza, agli immigrati col permesso di soggiorno dei rispettivi Paesi. Il Trattato di Roma, di cui si celebrerà il sessantesimo anniversario nel 2017, è il documento con il quale si riconobbe esplicitamente che i confini nazionali sono all’origine delle guerre.
I Paesi che avevano fatto dell’Europa un mattatoio ricostruirono la pace partendo proprio dal diritto più prossimo alla condizione umana: quello di cui secondo la bella intuizione kantiana ciascuno ha bisogno per poter essere libero di uscire dal proprio stato portando con sé le proprie radici.
Il diritto di visita era per il grande illuminista tedesco una protezione giuridica coerente alla nostra condizione che ci porta per le più svariate ragioni, per sopravvivere o per crescere, a muoverci per il mondo, a decidere di andare altrove. I confini sono artifici che devono poter essere relativizzati e la loro chiusura giustificata — ecco il senso dell’argomento del diritto contro la forza degli stati su cui i trattati europei e gli accordi internazionali per i rifugiati e i richiedenti asilo si fondano.
Le ideologie nazionaliste sono andate di pari passo con la cultura del diritto di movimento, anch’esse nate sull’onda delle Rivoluzioni del Settecento e con il proposito di contenere e rovesciare, se necessario, la logica di quel diritto. La religione della nazione ha cercato di far passare come naturale la nazione e tutto quel che ad essa consegue: i caratteri etnici, la religione, la lingua, infine i confini che tutto questo sigillano, celebrati anche come “sacri”.
Dalla radicalizzazione di queste premesse nazionaliste sono nati i mostri del Ventesimo secolo, come Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann avevano scritto nel Manifesto di Ventotene: il militarismo, il colonialismo, le guerre europee, le politiche di sterminio nel nome della purezza della razza. Conosciamo questa storia. Ma non la ricordiamo più così bene, a quanto pare, vista la rinascita prepotente dei muri e del filo spinato tra l’Austria e noi, tra l’Ungheria e i Balcani e in altri luoghi ancora. Diceva Benedetto Croce che la storia non è maestra di vita.
Ogni generazione rivendica il diritto di fare gli stessi errori degli antenati, con la giustificazione del contesto storico che cambia, per cui non ci sono mai gli stessi errori. È proprio contro il relativismo del contesto che la pratica dei diritti ha cercato di fare breccia — a che servirebbe firmare trattati se non si presume che le condizioni storiche anche se diverse possano comunque essere governate da noi, dalla nostra “buona volontà”? I Paesi europei, quelli che hanno sottoscritto o aderito al Patto di Roma e ai trattati che ne sono seguiti, sembrano aver dimenticato sia la storia recente che la logica del diritto. E mettono fili spinati lungo le linee invisibili che separano gli uni dagli altri proprio mentre credono di tener fuori in non europei.
Non è dato sapere se i cittadini di questi Paesi siano informati sulle conseguenze che quel filo spinato avrà sulla loro libertà di movimento. Avranno gli austriaci o gli ungheresi consapevolezza che il filo spinato li chiude dentro proprio mentre tiene fuori i rifugiati? L’opinione pubblica dovrebbe, se non altro, chiarire che il diritto di movimento ha due direzioni, non una: è entrare ed uscire. E l’uscire impone ad un altro stato di accettare chi esce. I muri, fisici e amministrativi, sono purtroppo nascosti sotto una montagna di propaganda nazionalista che fa vedere solo un lato della storia. Se il muro di Berlino doveva bloccare il diritto di uscita ai sudditi della Germania comunista, questi nuovi muri protezionistici dovrebbero ostruire l´entrata ai migranti.
I muri anti-immigrazione che nascono nel cuore dell’Europa sono un modo molto concreto di dire che coloro che li innalzano pensano che potranno preservare i loro piccoli privilegi se e fino a quando solo loro ne godranno. Mettono in evidenza una delle più stridenti contraddizioni che affliggono le società globali: quella tra una cultura raffinata che condivide valori universali e cosmopoliti e che resta comunque minoritaria, e una diffusa cultura popolare che mentre si appaga del consumismo globale è atterrita dalla globalizzazione, teme fortemente l´incertezza economica e può sviluppare, con l’aiuto di demagoghi astuti, un attaccamento parossistico ad un benessere che appare sempre più risicato, fragile e temporaneo.
Le nuove destre populiste europee tengono insieme due ordini di discorso: gli interessi economici della loro classe media e lavoratrice (che il decurtamento delle politiche sociali e l’austerità imposta dal patto europeo di stabilità hanno reso più esposti alla crisi) e il linguaggio della comunità nazionale (che le coordinate tradizionali della politica, certo la sovranità, non sono più in grado di rappresentare soddisfacentemente).
Il nuovo collante che giustifica la costruzione dei muri di filo spinato — questo è il segno della destra populista e nazionalista — è nuovo e recente: il cospirazionismo, la cultura del complotto internazionale alimentato sia dagli attentati terroristici e dalla propaganda dell’Is che dal dominio della finanza globale sulle scelte nazionali. Questi ingredienti di vecchio e nuovo conio sconvolgono alla radice le ragioni dell’Europa e i propositi del Trattato di Roma, la cultura della libertà di movimento.

Il Fatto Quotidiano, 4 maggio 2016 (p.d.)
Nei giorni scorsi ai capigruppo del Pd e, via loro, agli esperti legislativi è arrivata da Palazzo Chigi una richiesta un po’strana: c’è modo di anticipare il referendum costituzionale dalla fine all’inizio di ottobre? Come vedremo è possibile, ma non è così scontato che ci si riesca. Ma il motivo della richiesta arrivata da Renzi qual è? È in una frase pronunciata dal presidente della Consulta Paolo Grossi –curiosamente a Firenze - a proposito del ricorso sull’Italicum: “Lo esamineremo martedì 4 ottobre”. Non è detto che venga accolto, ma il rischio c’è.
Questa uscita, però, al di là dei particolari tecnici, è suonata come un allarme alla presidenza del Consiglio. Il cortocircuito è evidente: se va molto male, le ultime due settimane di campagna elettorale si faranno sulle critiche della Consulta alla legge elettorale renziana. Il referendum sul ddl Boschi –quello in cui il premier si gioca tutto, come ripete ogni volta che può – era infatti programmato per la seconda metà di ottobre: domenica 23 la data più gettonata. E allora? Potrebbe domandarsi il lettore. Ebbene, persino a Palazzo Chigi e dentro il Pd ritengono che la legge elettorale iper-maggioritaria appena approvata dal Parlamento sia borderline quanto a costituzionalità, soprattutto alla luce della sentenza sul Porcellum.
Anche volendo immaginare che la Consulta salvi il premio di maggioranza abnorme, è data praticamente per scontata la censura sulle cosiddette “candidature multiple”: ’intende l’abitudine di capi e capetti politici di candidarsi in diversi collegi e scegliere solo dopo in quale risultare eletti, avendo così potere di vita e di morte su chi li segue in lista. Come si evince dalla sentenza della Consulta sul Porcellum, questo viola il principio della conoscibilità dell’eletto da parte del cittadino. Insomma, secondo lo stesso Pd i giudici delle leggi dichiareranno incostituzionale almeno questa parte. Non che Renzi o i dem ne farebbero un dramma: furono Angelino Alfano e Silvio Berlusconi – si era ancora ai tempi degli incontri del Nazareno – a chiedere le candidature multiple, ma la figuraccia costituzionale mentre si tenta di vendere agli italiani una nuova Costituzione non sarebbe un bel biglietto da visita.
È così, insomma, che è saltata fuori la richiesta di Matteo Renzi ai suoi tecnici: vedete se c’è il modo di spostare il referendum e schivare la Consulta. La data buona, in questo senso, è domenica 2 ottobre, due giorni prima che l’Italicum finisca davanti ai giudici delle leggi. La risposta degli uffici legislativi è arrivata, ma non è risolutiva. In sostanza è: è possibile, ma forse no.
Breve spiegazione. La legge prevede al l’ingrosso questo: dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della riforma costituzionale, che nel caso della Carta Boschi/Renzi è il 15 aprile, chi volesse sottoporla a referendum deve presentare la richiesta entro tre mesi (cioè il 15 luglio). E chi può farlo? Un quinto dei membri di una Camera, cinque consigli regionali o i cittadini che raccogliessero 500 mila firme, esattamente quel che stanno facendo i costituzionalisti per il No o “professoroni” in renzese. Sono loro che rischiano di impedire al premier l’anticipo del referendum.
Motivo. A decidere sulla legittimità del referendum è la Cassazione, che allo scopo ha 30 giorni (più altri 7 per eventuali ricorsi): questo tempo viene in genere utilizzato quasi tutto in caso di referendum indetto con raccolta firme per verificarne il numero e la veridicità. Diciamo 10-15 agosto: a quel punto il presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, può indire il referendum tra i 50 e i 70 giorni successivi. Così per il 2 ottobre siamo sul filo o anche oltre, senza contare l’evidente forzatura istituzionale: se invece non ci fossero le 500mila firme, ma solo la richiesta dei parlamentari, il via libera della Cassazione sarebbe rapido e votare prima della possibile figuraccia alla Consulta non sarebbe un miraggio.
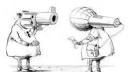
Il manifesto, 4 maggio 2016 (p.d.)
Ieri si celebrava la Giornata Mondiale per la Libertà di Stampa, occasione per buttare un occhio all’ultimo rapporto di Reporter Senza Frontiere. Pubblicato 10 giorni fa, il World Press Freedom Index regala all’Italia uno schiaffo in faccia: siamo messi peggio della Moldavia, scivolati in un anno dal 73° al 77° posto della classifica mondiale. In Europa facciamo meglio solo di Bulgaria, Grecia e Cipro.
Ai primi posti stanno i soliti noti: Finlandia, Olanda e Norvegia. In fondo Turkmenistan, Corea del Nord e Eritrea. Vanno male i paesi in conflitto, che si tratti di guerre civili come la siriana o la yemenita, in cui le informazioni si confondono con la propaganda, o di avanzate di gruppi terroristici, Boko Haram in Nigeria e al Shabaab in Somalia tra gli altri; e i governi che spiano imperterriti i propri cittadini, Russia e Stati Uniti.
E vanno male quelli che in questo periodo sono sotto i riflettori del Vecchio Continente: la Turchia del presidente-sultano Erdogan che tiene dietro le sbarre oltre 30 reporter (per lo più kurdi) e l’Egitto del golpista al-Sisi che mette a tacere le voci critiche con la consolidata pratica delle sparizioni forzate. Non a caso i redattori del quotidiano turco Cumhuriyet Dundar e Gul e il giornalista egiziano Shawkan (per la cui scarcerazione si è mossa anche la famiglia Regeni) sono tra i 9 reporter che ieri Amnesty International ha preso a modello delle abusi contro la stampa.
In generale, registra Rsf, la situazione peggiora ovunque: «Tutti gli indicatori della classifica mostrano un deterioramento – spiega il segretario generale Deloire – Molte autorità temono che il dibattito pubblico sia troppo aperto». Nel caso italiano, le ragioni dell’arretramento le spiega lo stesso Rsf: il caso Vatileaks e le conseguenze giudiziarie subite dai giornalisti Nuzzi ed Fittipaldi che hanno reso note informazioni nascoste dietro il portone di San Pietro.
Si potrebbe scorrere tutto l’indice, arrovellarsi per capire perché El Salvador e Burkina Faso occupano posizioni sicuramente più prestigiose (38° e 42° posto). Si potrebbe studiare il meccanismo dietro l’indice di Reporter Senza Frontiere, giudicato poco veritiero perché per l’80% fondato su percezioni soggettive più che su dati assoluti.
C’è del vero dietro il giudizio tranchant di alcuni media che nei giorni scorsi hanno pubblicato il rapporto. Si parte da un questionario compilato da associazioni e giornalisti chiamati a dare un punteggio da 1 a 10 su legislatura, autocensura, pluralismo, indipendenza, trasparenza e infrastrutture. I voti vengono poi calcolati sulla base di una particolare formula matematica. Poi si utilizzano dati assoluti: numero di giornalisti arrestati, minacciati, licenziati, uccisi. Valori che pesano meno dei giudizi personali, spesso prodotto del contesto nazionale.
In Italia, però, si potrebbe anche fare autocritica. E dirci che se siamo tra i paesi occidentali meno liberi in campo mediatico forse un motivo c’è. Da noi del resto la condizione di lavoro di migliaia di giornalisti è senza contratto, freelance che spesso freelance non sono perché lavorano nelle redazioni, siedono a fianco dei colleghi contrattualizzati, fanno lo stesso mestiere, a volte seguono un intero settore.
Sono tanti: secondo i dati 2014 dell’Lsdi, oltre il 62% dei giornalisti attivi sono autonomi, 31mila contro 18mila subordinati. Il restante 38%, da dipendente, può guadagnare 5 volte più di un freelance. Sono tanti e di tanti tipi: dai giovani disposti ad accettare retribuzioni basse o collaborazioni gratuite a chi ha esperienza di decenni ma si ritrova disoccupato per la chiusura del proprio giornale. Secondo la Federstampa, la gran parte dei precari (il 75%) non supera il traguardo dei 10mila euro l’anno. Di questi il 62% è sotto la soglia dei 5mila.
Forse scendiamo nella classifica perché è difficile parlare di informazione libera e indipendente quando chi lavora nelle redazioni – che siano quotidiani, tv, radio o agenzie web – è sottopagato e spogliato dei propri diritti. Quindi ricattabile. A uscirne malconcio è un intero sistema che si fonda su giornalisti che mettono insieme uno stipendio – o no – a seconda degli articoli pubblicati ogni mese. Ed è ovvio che di tempo per inchieste, per il mito del giornalismo investigativo, per chiedere diritti ne resta poco.
 «Inviata per "errore" una mail contenenti le strategie del Ministero degli Interni per difendersi dalle proteste dei giornalisti.
«Inviata per "errore" una mail contenenti le strategie del Ministero degli Interni per difendersi dalle proteste dei giornalisti.
Daily New Egypt: in meno di un anno 8 i casi di censura». Il manifesto, 4 maggio 2016 (p.d.)
Censura sul caso Regeni e gamba tesa contro la stampa egiziana in rivolta: è il contenuto, in breve, delle istruzioni a uso interno che per errore il Ministero degli Interni ha inviato ai media dal proprio indirizzo mail. Ufficialmente per errore: dopo l’invio, il dicastero ha parlato di «malfunzionamento tecnico», ma nei corridoi si rincorrono voci diverse. C’è chi parla di un hackeraggio, chi di atto volontario da parte di qualcuno interessato a ostacolare l’uscita dal tunnel in cui il regime di al-Sisi si è infilato.
Il presidente appare indebolito: la campagna di repressione di società civile e stampa è così brutale da avere prodotto l’effetto opposto, almeno all’interno dei confini nazionali. Se fuori la comunità internazionale continua a coccolare Il Cairo, in casa la gente esprime una rabbia crescente. Il governo, dice quel documento diffuso per errore, corre ai ripari ed indica le linee guida per zittire le proteste, quella che viene definita «un’escalation deliberata» ordita dai leader sindacali che puntano ad ottenere vantaggi politici. «C’è da aspettarsi – si legge – una feroce campagna mediatica da parte di tutta la stampa in solidarietà con il sindacato», violato domenica scorsa dal raid della polizia e dall’arresto di due giornalisti.
Per questo, ordina il Ministero, si deve rimanere fermi nelle propri posizioni e «coordinarsi con programmi tv, esperti e generali in pensione per invitarli a parlare a favore del Ministero»: «Non possiamo fare un passo indietro ora: una retromarcia significherebbe ammettere di aver fatto un errore. E se c’è un errore, chi è il responsabile?». Di certo ieri uno sbaglio, volontario o meno, è stato commesso e il Ministero ha già fatto sapere di aver avviato indagini interne per risolvere il mistero della mail incontrollabile.
Ad emergere, però, da quelle righe è anche una pratica spesso utilizzata dal governo cariota: la censura su fatti sensibili e potenzialmente distruttivi. Come il caso Regeni: alla procura generale (quella che dovrebbe collaborare con gli investigatori di Roma) è stato chiesto di imporre il silenzio sull’omicidio del ricercatore. Non è la prima volta: secondo quanto riportato dal Daily News Egypt, dal 29 giugno 2015 alle proteste di massa del 25 aprile, sono stati almeno 8 i casi di censura su fatti interni.
Quel giorno di un anno fa veniva ucciso l’ex procuratore generale Hisham Barakat, omicidio che ha dato il via ad un’ondata di divieti per la stampa: è successo con il caso dei fondi esteri alle Ong egiziane; con la denuncia di corruzione mossa da Hisham Geneina, presidente (poi licenziato) dell’istituto Central Auditing Organization che dal 1942 monitora i casi di corruzione; con le mazzette ricevute da funzionari del Ministero dell’Agricoltura. L’obiettivo è palese: impedire ai giornalisti di investigare, alla gente di discuterne.
Ma ieri, nella Giornata Internazionale per la Libertà di Stampa, i giornalisti egiziani hanno continuato a manifestare. Di fronte alla sede del Sindacato della stampa, proseguono nel sit-in indetto per costringere il ministro degli Interni Ghaffar alle dimissioni e per ottenere il rilascio dei due giornalisti di January Gate, Amr Badr e Mahmoud el-Sakka. I due lunedì si sono visti allungare l’ordine di detenzione di due settimane, con l’accusa di aver diffuso notizie false e aver incitato al colpo di Stato.
Sopra l’edificio la bandiera del sindacato è stata sostituita da bandiere nere, listate a lutto per ricordare le condizioni di lavoro dei giornalisti egiziani. Oggi si terrà un’assemblea generale durante la quale il sindacato annuncerà le prossime mosse. Per ora hanno ottenuto un sostegno inatteso: la mano tesa del giornale governativo al-Ahram. In un editoriale definito in Egitto «senza precedenti», il quotidiano di proprietà dell’esecutivo del Cairo si fa carico indirettamente delle stesse richieste dei colleghi: le dimissioni del ministro Ghaffar.
Il raid contro il sindacato della stampa, scrive al-Ahram, è «una mossa inaccettabile» da parte di un Ministero che «ha commesso tanti errori nell’ultimo periodo, concludendo con il suo infelice comportamento nei confronti dei diritti dei giornalisti e dei lavoratori dell’informazione».
Eppure, aggiunge il quotidiano, Ghaffar «non riuscirà nel suo pernicioso obiettivo di chiudere le bocche e reprimere le libertà di espressione e opinione». Un affondo durissimo che dà la misura delle crepe che si stanno moltiplicando nel monolitico blocco del potere del presidente golpista.
 «La democrazia negata si può restaurare proprio a colpi di democrazia: ovvero di informazione e di spazi di confronto. Come quello che si aprirà a Roma il 7 maggio.».
«La democrazia negata si può restaurare proprio a colpi di democrazia: ovvero di informazione e di spazi di confronto. Come quello che si aprirà a Roma il 7 maggio.».
LaRepubblica, 4 maggio 2016 (c.m.c.)
Il Ttip è nudo! Qualcuno è riuscito a pubblicare quasi tutte le carte di un trattato importante tra due continenti che pochi tecnocrati, con appoggi governativi, cercavano di nascondere nelle segrete stanze. Finalmente sappiamo di che stiamo parlando e la realtà è ben peggiore delle peggiori previsioni. Le turbolente vicende relative ai negoziati sul Ttip confermano alcuni segnali poco consolanti, ma ci danno anche qualche speranza.
Le brutte notizie, a dire il vero, già le conoscevamo:
1) I cittadini, a volte, devono difendersi dalle istituzioni: questo non era nell’idea di democrazia. Non era nei patti che una Commissione Europea di “nominati” si svincolasse dichiaratamente dalla volontà dei cittadini che eleggono il Parlamento Europeo, arrivando ad accettare modalità di negoziazione che ostacolano l’accesso dei parlamentari ai documenti. Così ci hanno pensato i cittadini, e nella fattispecie Greenpeace, a pubblicare il testo di quel trattato segreto. Non è così che dovrebbe funzionare.
2) L’arroganza del mercato e dei suoi alfieri si concentra su velocità e facilità degli scambi trascurando l’oggetto: armi, pane o informazioni, è uguale, purché sia tutto rapido e uniforme. Questo è di una stupidità straordinaria, è la vecchia metafora del treno che va sempre più veloce senza che i passeggeri possano sapere dove vanno e chi sta guidando, né chi li ha messi su quel treno. Con il Ttip questa logica ha raggiunto il suo massimo splendore: “armonizziamo” gli standard, ci dicono, così gli scambi aumenteranno, di ritmo e di numero.
“Abbassiamo le barriere non tariffarie” così facilitiamo il commercio tra Europa e Stati Uniti. Ma il commercio di cosa? Con quali benefici pratici per le comunità? Fa lo stesso: l’importante è che le merci corrano per il pianeta senza intralci che si chiamano “normative”. Che fastidio dover pianificare gli affari evitando di calpestare i diritti, di ammalare le persone e di inquinare l’universo.
3) L’intralcio principale è, in fin dei conti, il sistema democratico. Che prevede che i rappresentanti eletti dalle popolazioni coinvolte dicano la loro in situazioni come queste. Ma se si fa così non si va avanti, avranno pensato i tecnici ai quali è stato affidato (da chi?) il compito di scrivere il trattato. Invece la democrazia si costruisce poco alla volta, si riconsolida ad ogni passaggio. La democrazia europea tra mille difficoltà, ha costruito le normative che ora paiono d’intralcio alle multinazionali. Perché, come ci diceva il buon Pericle cinque secoli fa «il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: e per questo viene chiamato democrazia». Le multinazionali sono poche. I cittadini sono molti.E veniamo alle buone notizie.
1) Non è vero che gli interessi degli statunitensi sono diversi da quelli degli europei. Di più: non è vero che gli imprenditori, e in particolare quelli agricoli, degli Usa sono tutti di grande scala e dediti alle monoproduzione, mentre quelli europei sono tutti piccoli e multifunzionali. La differenza semmai sta nell’interesse alle esportazioni intercontinentali. Ma attenzione: quando si parla di cibo e di vino di qualità, si fanno affari oltreoceano anche restando piccoli; l’importante è mantenere alta la qualità. La quale è tutelata dalle normative- intralcio.
2) Lo stesso senso di condivisione pervade i consumatori, da entrambe le parti dell’oceano. Sembra proprio che, grazie a questo tentativo di patto scellerato, finalmente le popolazioni si riscoprono parte della medesima comunità di destino, parte di un sistema planetario che deve innanzitutto difendere la qualità della propria vita.
3) Infine la migliore di tutte: nonostante gli spudorati tentativi di tenere il dibattito il più lontano possibile non dico dalle piazze, ma addirittura dai Parlamenti legittimamente in carica, le parrocchie, le librerie, le università, le associazioni si son fatte sentire e stanno cambiando di fatto gli equilibri: per quanto ancora verranno ignorate?
La democrazia negata si può restaurare proprio a colpi di democrazia: ovvero di informazione e di spazi di confronto. Come quello che si aprirà a Roma il 7 maggio. Spero che sia una manifestazione che si realizzerà in una grande partecipazione dei cittadini italiani perché siamo tutti cittadini del mondo e gli “uomini di buona volontà”, quelli che lavorano per il bene comune, sono dappertutto, e parlano la stessa lingua.

greenMe.it, rilanciato da Comune-info, 03 maggio 2016 (p.d.)
Saber Hosseini è un maestro di scuola che vive in Afghanistan nella località di Bamyan. I bambini che vivono nelle aree più remote del Paese non hanno la possibilità di andare a scuola né di accedere alla cultura, all’istruzione o a una biblioteca.
Ecco allora che questo maestro che ha davvero a cuore i bambini ha deciso di raggiungere in bici le località più povere dell’Afghanistan per portare dei libri da leggere ai bambini. Durante la settimana il maestro lavora in una scuola mentre nel weekend raggiunge i bambini che non possono frequentarla per dare loro in prestito dei libri.
All’incontro successivo i bambini possono restituire i libri già letti e prenderne in prestito degli altri, In questo modo la cultura entra in circolazione gratuitamente tra i più poveri. L’impegno del maestro è ormai ben noto in Afghanistan e la sua iniziativa è molto apprezzata soprattutto da chi non avrebbe mai la possibilità di acquistare un libro.
Esistono diversi modi per mostrare solidarietà ai bambini e alle persone in difficoltà. Grazie alla sua iniziativa il maestro ha distribuito centinaia di libri per rendere felici i bambini e per fare in modo che potessero accedere alla lettura.
Non tutti purtroppo nel mondo hanno questa opportunità e dobbiamo ritenerci davvero fortunati nell’avere sempre a disposizione dei libri da prendere in prestito nelle biblioteche o da acquistare nelle librerie.
Il maestro ha scelto la bicicletta e i libri come un vero e proprio simbolo per dimostrare che possiamo sostituire la violenza con la cultura. La produzione di libri in Afghanistan è molto limitata dunque quelli distribuiti dal maestro di solito sono importati dall’Iran. Si tratta soprattutto di versioni semplificate delle opere di Victor Hugo, Jack London, Saint-Exupery e di poesie e racconti di scrittori iraniani.
Ogni volta che il maestro porta dei libri ai bambini cerca di parlare con loro e di proporre un argomento che può essere utile per la loro istruzione. Quando arriva nei villaggi trova sempre un gruppo di bambini pronto ad ascoltare una lettura o una piccola lezione.
Siamo davvero colpiti dall’impegno del maestro che gratuitamente porta cultura, libri e un raggio di speranza ai bambini che si trovano in difficoltà. Servirebbero più persone così anche in altre zone del mondo.
Guardate il video per approfondire la sua storia.

Comune-info, 3 maggio 2016 (p.d.)
Il Trattato di libero scambio transatlantico (Ttip) è stato uno dei temi centrali affrontati all’incontro di Hanover (Germania) del 25 aprile tra la Merkel, Obama, Hollande e Renzi. “Da un punto di vista europeo – ha detto Angela Merkel – il Ttip è assolutamente utile per far crescere la nostra economia. È un bene per quella tedesca e per tutta l’Europa. Dobbiamo far presto”. È questo il pensiero non solo di Merkel, ma anche di Obama e di Renzi, che vorrebbero che il Trattato fosse firmato entro l’estate.
Il Ttip è conosciuto come “il più grande trattato della storia”, perché se verrà approvato, legherà gli Usa e l’Unione europea coinvolgendo circa 820 milioni di persone e abbracciando un’area che produce circa il 45 per cento del Pil mondiale. E costituirebbe la più grande area mondiale di libero scambio. Le trattative per creare il Ttip sono partite in tutta segretezza nel luglio 2013 a Washington e sono condotte da pochi esperti della Commissione europea e del ministero del Commercio Usa: è un negoziato stipulato senza la partecipazione dei cittadini. È un vero e proprio golpe da parte dei poteri economico-finanziari che governano il mondo.
Infatti il Trattato indebolisce il “principio di precauzione” vigente in Europa , in relazione ai nuovi prodotti, elimina le sanzioni in caso di abusi relativi ai diritti sociali e ambientali e mira a una progressiva privatizzazione di tutti i servizi pubblici (il Ttip, infatti spiana la strada per l’altro trattato in arrivo, il Tisa – Accordo sul commercio dei servizi -, che vuole privatizzare tutti i servizi pubblici). Ancora più grave è il fatto che il Ttip introduca le corti arbitrali private per le dispute investitori-stati (il cosidetto Isds): un meccanismo che – seppure nelle correzioni addotte come compromesso al ribasso del gruppo socialista nel Parlamento Europeo – subordina tuttora i diritti umani alla prevalenza delle imprese e del mercato (Francesco Martone)”.
Il Ttip avrà inoltre pesanti ricadute sul mondo del lavoro aggirando le norme dei diritti dei lavoratori, svuotandone le normative per la loro protezione, ma anche ridimensionando il diritto di contrattazione collettiva. Il Trattato mina poi alla base il “principio di precauzione” aumentando i rischi per la salute alimentare. "Il Ttip – dice Susan George – è un assalto alla democrazia, alla classe lavoratrice, all’ambiente. L’unica risposta possibile dinanzi a questo attacco è alzarsi dal tavolo, chiudere le porte e lasciare la sedia vuota".
Infatti ci sono mobilitazioni contro il Ttip in tutta Europa e negli Usa: il 24 aprile ben novantamila persone sono scese in piazza ad Hanover. Sono molti i sindaci e i governatori di regioni che in Europa, come anche in Italia, hanno aderito alla campagna: "Fuori Ttip dalla mia città".
 «Le Costituzioni vanno pensate “per sempre”: come quella americana, che dal 1789 ha avuto solo 27 emendamenti, Ma l’equivoco del plebiscito oscura la sostanza dei problemi, spinge a trattare il tema come una competizione sportiva e non come una discussione sul merito, da valere nei tempi lunghi».
«Le Costituzioni vanno pensate “per sempre”: come quella americana, che dal 1789 ha avuto solo 27 emendamenti, Ma l’equivoco del plebiscito oscura la sostanza dei problemi, spinge a trattare il tema come una competizione sportiva e non come una discussione sul merito, da valere nei tempi lunghi». LaRepubblica
, 3 maggio 2016 (c.m.c.)
Chiunque intenda il referendum d’autunno sulla Costituzione come un plebiscito pro o contro il governo fa un errore di grammatica istituzionale. La Costituzione non è un regolamento condominiale.
Non si riforma per comodo di chi governa, né si respinge se l’attuale governo non ci piace. Le Costituzioni vanno pensate “per sempre”: come quella americana, che dal 1789 ha avuto solo 27 emendamenti, dei quali dieci tutti insieme, e dal 1992 nessuno. Ma l’equivoco del plebiscito oscura la sostanza dei problemi, spinge a trattare il tema come una competizione sportiva e non come una discussione sul merito, da valere nei tempi lunghi. Dimenticando che dalla tenuta della Costituzione dipende la vita della democrazia, anzi della Repubblica.
Certo, non è facile discutere nel merito una riforma che modifica in un sol colpo 47 articoli della Carta; mentre dal 1948 ad oggi si erano cambiati 43 articoli, a uno a uno, seguendo l’aureo principio secondo cui le revisioni della Costituzione devono essere «puntuali e circoscritte, con una specifica legge costituzionale per ogni singolo emendamento» (Pizzorusso).
Nonostante questa valanga di modifiche, è assolutamente necessario entrare nel merito. Con un intervento tanto invasivo, è statisticamente improbabile che vada tutto bene o tutto male. Proverò a indicare due punti che ritengo accettabili e due che mi paiono da respingere. Va bene aggiungere la “trasparenza” tra i requisiti dei pubblici uffici (art. 97). La parola non era nel linguaggio politico del 1948, lo è adesso. Forse non è proprio la Costituzione il luogo per dirlo, ma in fondo perché no? Altro punto su cui si può esser d’accordo, la restrizione del potere del governo di emanare decreti legge (art. 77).
Ma punti ancor più importanti suscitano gravi preoccupazioni. Ne indico solo due. L’art. 67 della Costituzione vigente dice: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato» (ossia senza obbligo di ubbidienza verso il partito, ma con piena responsabilità personale). Questo principio è stato già svilito dall’indecorosa migrazione di parlamentari da un partito all’altro (a fine gennaio 2016 si contavano 325 metamorfosi dei voltagabbana di questa legislatura). Ma nella proposta di riforma costituzionale il testo vigente, breve e chiaro, viene smembrato e disfatto. Il nuovo articolo 67 direbbe infatti: «I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato ».
Scompaiono le parole «rappresenta la Nazione», trapiantate (depotenziandole) nell’art. 55, da cui risulta che «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione». Avremo dunque un Senato i cui membri non rappresentano piú la Nazione, perché «il mandato dei membri del Senato è connesso alla carica ricoperta a livello regionale o locale» (cosí la relazione esplicativa). Ma siccome gli ex Presidenti della Repubblica saranno senatori a vita, avremo l’assoluta meraviglia di Presidenti come Ciampi e Napolitano che non rappresenteranno più la Nazione, bensì le istanze locali.
Ma come verrà eletto, secondo la riforma, il Presidente della Repubblica? Lo faranno deputati e senatori, come ora (art. 83). Ma con una differenza importante. Oggi il Presidente è eletto con una maggioranza di due terzi dell’assemblea nei primi tre scrutini (così nel caso di Ciampi, 1999), con la maggioranza assoluta dal quarto in poi (così Napolitano, 2006). In futuro, se la riforma sarà approvata nel referendum, non sarà più così. Nei primi tre scrutini resta valida la maggioranza di due terzi dell’assemblea, dal quarto in poi si passa ai tre quinti dell’assemblea; ma la vera novità della riforma scatta a partire dal settimo scrutinio: da questo momento in poi basterà la maggioranza assoluta non più dell’assemblea, bensì dei votanti.
In altri termini, se al settimo scrutinio dovessero votare solo 20 fra deputati e senatori, a eleggere il Presidente basteranno 11 voti. Gli assenti dall’aula avranno sempre torto. Si aprirebbe così la gara a colpi di mano, delegittimazioni, conflitti procedurali. Un Presidente eletto cosí, certo, non «rappresenta la Nazione» nemmeno quando è in carica, figurarsi da senatore a vita. Chi ha votato questo articolo in aula doveva essere davvero assai distratto.
Nel merito bisogna entrare (non lo farò ora) anche sul neo-bicameralismo che nasce dal nuovo Senato non elettivo. E’ difficile, è vero, render conto dell’intrico di competenze fra le due Camere quale risulta dall’ammucchiata verbale della riforma (l’art. 70, nove parole nella Costituzione vigente, ne conta 434 nel nuovo). Ma è importante parlarne nel merito: perché criticare il “bicameralismo perfetto” della Costituzione vigente non vuol dire necessariamente sottoscrivere un testo che «non funzionerà mai e complicherà in modo incredibile i lavori del Parlamento» (Ugo De Siervo).
Davanti a enormità come quelle degli artt. 67 e 83 (e non sono le sole), c’è da chiedersi perché mai l’elettore debba essere obbligato a votare in blocco con un SI’ a tutto (comprese le modifiche che detesta) o con un NO a tutto (comprese quelle su cui è d’accordo). E’ stato uno svarione istituzionale cucinare in un unico testo una riforma tanto estensiva; ma è ancora possibile rimediare in parte segmentando i quesiti referendari in più punti, come propone il documento firmato da 56 costituzionalisti, fra cui 11 presidenti emeriti della Corte Costituzionale. Sarebbe più rispettoso della Costituzione, degli elettori, della democrazia. Ma il governo avrà il coraggio di farlo?

«» Il manifesto, 3 maggio 2016
Renzi ci informa che nel giorno del ringraziamento i tacchini sono felici. Gli crediamo sulla parola. E forse, per come sono andate le cose, possiamo accettare anche l’idea che i senatori in carica siano tacchini. Ma che fossero felici nel cancellare il senato, dubitiamo assai. Il lancio della campagna per il sì nel referendum costituzionale ci ha dato un discorso in puro stile renziano, fatto di omissioni, bugie, pubblicità ingannevole, battute.
È omissione celebrare un parlamento che si è messo a correre. Renzi omette di ricordare che ha corso una maggioranza drogata dai numeri posticci di un sistema elettorale fulminato da una dichiarazione di illegittimità costituzionale. Che solo grazie a quei numeri le sue riforme hanno visto la luce. Che una minima decenza costituzionale avrebbe richiesto nuove elezioni con una legge depurata da quelle illegittimità. Che nonostante tutto questo solo il rinforzo dei voltagabbana ha consentito alla fine di radunare per le riforme una maggioranza occasionale e raccogliticcia. Che se anche vincesse il referendum, questo potrebbe consolidare lui nella poltrona di palazzo Chigi, ma non consoliderebbe una Costituzione delegittimata e divisiva per il paese.
È bugia prospettare la riforma come necessaria per superare un bicameralismo paritario che nemmeno i costituenti del 1948 volevano. Al contrario, quella fu una scelta consapevole, che esprimeva gli equilibri del tempo. E in ogni caso il punto di contrasto vero nel dibattito odierno non è mai stato il bicameralismo differenziato, ma la natura non direttamente elettiva del nuovo senato. Si censura in specie la scelta di iniettare nel massimo livello di rappresentanza nazionale un ceto politico di bassa qualità, segnato da clientele, corruzione, relazioni pericolose. Basta pensare che, se non fosse scoppiato il caso giudiziario e mediatico a tutti noto, un Graziano sarebbe stato probabilmente il tipico candidato in pole position per un seggio senatoriale. Con tutte le prerogative connesse alla carica, tra cui in primis la tutela costituzionale per arresti, perquisizioni, intercettazioni. Con quali conseguenze sulle inchieste è facile immaginare.
È pubblicità ingannevole affermare di essere arrivato a Palazzo Chigi attraverso una grande esperienza di popolo. Sembra suggerire un’onda di irresistibile consenso elettorale. Più modestamente, c’è arrivato attraverso le primarie con cui ha messo in minoranza gli iscritti al PD con il voto dei non iscritti. Ha così creato le premesse per chiudere nell’angolo la minoranza interna, e per attuare la manovra di palazzo che ha politicamente ucciso il governo Letta.
È ancora pubblicità ingannevole che il paese esca dalla palude. Le cifre della crisi infinita rimangono incerte, come la deflazione o i balletti sui posti di lavoro ampiamente dimostrano. La qualità di servizi fondamentali come l’istruzione o la sanità cala. Le diseguaglianze territoriali aumentano, e a nulla valgono gli spot preelettorali di Renzi. La corruzione dilaga, e sul governo pesa la resistenza di chi proprio non vuole saperne di mandare i corrotti in galera e di tenerceli. Mentre l’arte del governare viene ricondotta – come negli anni della peggiore DC, e con poche eccezioni – alla sapiente scelta di sodali, amici, sostenitori, fiancheggiatori a vario titolo.
Tuttavia, anche i Renzi passano. Il problema vero è ridurre i danni che prima di andarsene avrà prodotto. Tra questi, la riforma costituzionale è tra i più gravi, e difficili da riparare. Renzi chiede un paese che dice sì, ma in realtà vuole un popolo di yes men, a partire dal referendum. Bisognerà dimostrargli col voto che la richiesta è irricevibile.

 «Per lo storico Geert Mak l’assetto istituzionale attuale non sopravviverà oltre il prossimo decennio: o è svolta o disintegrazione
«Per lo storico Geert Mak l’assetto istituzionale attuale non sopravviverà oltre il prossimo decennio: o è svolta o disintegrazione














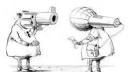

 «La democrazia negata si può restaurare proprio a colpi di democrazia: ovvero di informazione e di spazi di confronto. Come quello che si aprirà a Roma il 7 maggio.».
«La democrazia negata si può restaurare proprio a colpi di democrazia: ovvero di informazione e di spazi di confronto. Come quello che si aprirà a Roma il 7 maggio.». 


