

 Ecco i nuovi padroni, ecco il Mercato: è il finanzcapitalismo, baby. Lui è globale, noi ci guardiamo piangere da un recinto all’altro.
Ecco i nuovi padroni, ecco il Mercato: è il finanzcapitalismo, baby. Lui è globale, noi ci guardiamo piangere da un recinto all’altro.
La Repubblica, 19 maggio 2014
La Borsa tricolore è stata per quarant’anni una riserva di caccia con due soli protagonisti: i salotti buoni — un groviglio di patti di sindacato e partecipazioni incrociate tra banche e famiglie incaricato di gestire gli affari dei soliti noti — e le aziende di Stato. Oggi il vento è cambiato. Gli ex-poteri forti, fiaccati dallo sfarinamento delle dinastie industriali, dai prestiti in sofferenza e dalla crisi, sono a corto di quattrini. E in virtù dell’aurea legge (“Articolo quinto, chi ha i soldi ha vinto”) coniata da Enrico Cuccia, il deus ex machina di questo mondo, il listino milanese ha trovato il suo nuovo padrone: i grandi fondi esteri. Un universo magmatico a molti volti — tra cui quello delle mitiche Scottish Widows, i fondi delle parrocchie presbiteriane e i gestori dei risparmi dei professori dell’Illinois — che in un mese, con un uno-due violento quanto inatteso, ha spazzato via i cocci del capitalismo di relazione tricolore e ha messo ko all’assemblea dell’Eni e di Finmeccanica il Tesoro italiano.
La Waterloo dei salotti buoni ha una data e un luogo preciso: l’assemblea di Telecom Italia a Rozzano, 16 aprile 2014. Il copione, lo stesso degli ultimi sette anni, era in teoria già scritto:
Telco - la holding partecipata da Generali, Mediobanca e Intesa San Paolo, uno degli ultimi residuati dei salotti buoni - avrebbe voluto nominare con il 22,8% del capitale un nuovo cda a sua immagine e somiglianza. Facendo ratificare al mercato le decisioni prese nelle segrete stanze del miglio quadrato attorno a Piazzetta Cuccia. Non è andata così. Alla conta dei voti, è arrivata la sorpresa: i grandi investitori internazionali hanno battuto i vecchi padroni di Piazza Affari, nominando tre loro rappresentanti in consiglio.
Un eccezione? No, la nuova regola. La presenza dei fondi nelle assemblee delle società italiane è raddoppiata in due anni dall’11,6% al 21,6% del capitale rappresentato, dice uno studio della Fondazione Bruno Visentini. Oggi con 200 miliardi di investimenti hanno in portafoglio il 38% di Piazza Affari. Sono loro il primo azionista delle Generali (all’ultima assemblea avevano il 15,2%), di Unicredit e Intesa Sanpaolo con quote attorno al 30% e di molte altre blue chip. E dopo anni vissuti da minoranza silenziosa hanno iniziato a far sentire la loro voce nella foresta pietrificata della finanza tricolore. Ne ha dovuto prendere atto, obtorto collo, anche il governo Renzi. Palazzo Chigi e il Tesoro hanno passato giornate a limare i nuovi requisiti di onorabilità da proporre alle assemblee di Eni, Finmeccanica ed Enel. Convinti di farli approvare senza problemi. Anche loro hanno fatto i conti senza l’oste. Quando il rappresentante di via XX settembre ha messo ai voti il piano all’assemblea Eni, i grandi fondi esteri — allergici alle intrusioni dello Stato — si sono messi di traverso e la norma non è passata. Confermando così che l’Italia ha perso il controllo della maggiore (e più strategica) impresa nazionale. Lo stesso è accaduto in Finmeccanica.
L’identikit dei nuovi padroni di Piazza Affari è un’immagine insieme semplice e complessa. Semplice perché sono i gestori di quella valanga di liquidità ammucchiata negli ultimi anni (o pompata dalle banche centrali) che muove gli equilibri geopolitici del mondo, spostando masse enormi di denaro dalle star-up di Internet ai laboratori biotech, dai derivati ai titoli di stato, dai dollari all’euro, magari affondando - salvo poi reinnamorarsene in questi mesi - i paesi in odore di crisi. Complessa perché in questo mare magnum ci sono mille realtà finanziarie diverse: fondi a lungo termine, attivisti, hedge che muovono quattrini ai ritmi frenetici dei millesimi di secondo dettati dai programmi computerizzati del listini.
Speculatori? Tutt’altro, dicono loro. «Il 50% dei nostri sottoscrittori sono famiglie, tra cui migliaia di italiani, magari con solo 10mila euro da investire. Non mi pare che questi siano i fantomatici raider di cui si parla», è il mantra di Andrea Viganò, country head del fondo Blackrock, il colosso Usa che gestisce 4.300 miliardi di patrimonio (il doppio del Pil tricolore, 10 volte il valore dell’intero listino tricolore) e che negli ultimi mesi si è messo in tasca il 6% di Intesa e Unicredit, il 5% di Bpm, il 3,7% di Mps oltre a quote importanti in Generali, Fiat, Atlantia e Mediaset.
Il loro sbarco in Italia coincide, non a casa, con l’implosione del sistema dei salotti buoni. Mediobanca, fiutato il vento, ha da tempo iniziato a smontare il suo reticolo di partecipazioni per concentrarsi sul core business della banca d’affari, In pochi mesi si sono sciolti come neve al sole patti di sindacato storici e inossidabili come quelli di Pirelli, Rcs e Benetton. Oggi a questo piccolo mondo antico — che non a caso ha messo in vendita 4 miliardi delle sue quote incrociate — è venuto a mancare il collante che lo teneva unito: i soldi (spesso degli altri). «Le vecchie famiglie non li hanno. Le banche di riferimento nemmeno. Il meccanismo del do ut des, delle operazioni gestite chiamando a raccolta un gruppo ristretto di amici si è inceppato. Le aziende per crescere o per non morire sono costrette a cercarli dove ci sono: dal mercato e dai fondi», spiega Dario Trevisan, il legale milanese che da anni rappresenta i nuovi poteri forti di Piazza Affari alle assemblee delle aziende quotate. Trevisan non è un Agnelli né un Berlusconi. Eppure si è presentato all’assemblea di Generali con il 15% dei voti, in quella di Telecom con il 27% e all’Eni con il 30%, più dello Stato. «E’ un bene? Sì - sostiene lui- . I fondi non sposano interessi e non hanno miopi visioni locali».
Il rischio, dicono i critici, è che i grandi fondi seguano logiche finanziare di breve respiro. «Mi sento di dire che non è così — assicura Valerio Battista, ad di quella Prysmian che uscendo da Pirelli è diventata la prima grande public-company italiana gestita dai grandi investitori istituzionali — : la maggioranza di quelli che stanno sbarcando ora sul mercato italiano è gente seria che investe sul lungo termine. Gente che non ha paura di mettere soldi su un buon progetto. Il loro problema è la remunerazione del capitale, non la diluizione delle quote». «In America il boom pluridecennale dell’hi-tech e delle biotecnologie è stato sostenuto proprio dai loro soldi. Il mercato su questo fronte è molto più efficiente di banche e famiglie», dice Umberto Mosetti, uno dei massimi esperti italiani di corporate governance che con il fondo Amber ha combattuto con successe alcune battaglie tra cui quelle contro la gestione Besnier in Parmalat. Qualcuno, dopo il voto all’Eni, vede a rischio l’italianità del Belpaese Spa. «Rischio che non esiste - dice il “mercatista” Mosetti - visto che il totem della difesa dell’identità delle nostre aziende è stato utilizzato finora per arricchire singole persone e non nell’interesse della nazione».
Nessuno, per ora, pare aver intenzione di alzare barricate. Anche perché lo Tsunami dei fondi internazionali è stato uno dei fattori chiave per riportare lo spread italiano sotto quota 200. L’importante, dice l’esperienza del passato, è non sottovalutarne l’umoralità. Come arrivano, spesso vanno.. Alla stessa velocità. E se vogliono colpire duro, anche Vedove scozzesi, preti presbiteriani & Co. sono in grado di far male a chiunque: hanno fatto saltare i vertici di Hewlett Packard, costretto un colosso come Apple a rivedere la sua politica di dividendi, tagliato lo stipendio a un nume tutelare della pubblicità come Martin Sorrell. Il 30% di loro ha votato contro le super-buste paga dei manager italiani nell’ultima tornata di assemblee. Chi ha orecchi per intendere, intenda. La loro battaglia, nello stivale, è solo all’inizio.
«Domenica 25 si vota per il futuro dell'Ue. Tra euroscettici ed europeisti neoliberali, esiste una terza via: la proposta di un progetto europeo che offra un'alternativa al modello egemone, in preda a una gramsciana «crisi organica». Syriza può essere il collante dell'antagonismo».
Sbilanciamoci.info, newsletter n. 330, 19 maggio 2014
Le prossime elezioni europee dovrebbero essere considerate l'occasione per una competizione agonistica sul futuro dell'Unione. Una competizione, che oggi è assolutamente fondamentale. Molti a sinistra cominciano a dubitare che si possa realizzare, all'interno dell'attuale costruzione europea, un'alternativa al modello neoliberale di globalizzazione. E l'Unione europea è sempre più percepita come un progetto intrinsecamente neoliberale che non può essere riformato. In tal senso, appare inutile provare a trasformare le sue istituzioni, e l'unica strada possibile è quella dell'uscita.
Ma questa visione pessimistica deriva indubbiamente dal fatto che tutti i tentativi di contrastare le regole neoliberali dominanti vengano sistematicamente presentati come la mera espressione di attacchi anti-europei contro l'esistenza stessa dell'Unione. Non può certo sorprendere che un numero crescente di cittadini, privati della possibilità di avanzare legittime critiche alle politiche neoliberali, sia diventato euroscettico. Essi credono che il progetto europeo sia proprio la causa della condizione di emergenza che stiamo vivendo e temono che una maggiore integrazione comunitaria porti soltanto al rafforzamento dell'egemonia neoliberale.
Questa posizione minaccia la sopravvivenza del progetto europeo e l'unico modo per arrestare la sua diffusione consiste nel creare le condizioni per una contestazione democratica all'interno dell'Unione europea. Dal mio punto di vista, alla base della disaffezione nei confronti della Ue vi è la mancanza di un progetto che favorisca una forte identificazione tra i suoi cittadini e fornisca un obiettivo per mobilitare democraticamente le loro passioni politiche. La Ue è formata da consumatori, non da cittadini: è stata costruita essenzialmente intorno a un mercato comune e non ha mai creato una volontà comune. Nessuna sorpresa, quindi, se in tempi di crisi economica e di politiche di austerità più di qualcuno inizi a mettere in dubbio la sua utilità, dimenticando che l'Unione europea ha contribuito in modo decisivo alla pacificazione del continente. Ciò che serve in questa congiuntura è rafforzare il consenso popolare nei confronti dell'Unione grazie all'elaborazione di un progetto socio-politico finalizzato ad offrire un'alternativa al modello neoliberale che ha prevalso negli ultimi decenni: quel modello è ora in crisi, ma un altro ancora non esiste. Si potrebbe dire, sulle orme di Gramsci, che stiamo assistendo a una «crisi organica» in cui il vecchio modello non può più durare, mentre il nuovo modello non è ancora nato.
Purtroppo la sinistra non è in grado di trarre vantaggi da questa situazione, perché ha accettato per troppo tempo l'idea che alla globalizzazione neoliberale non vi sia alternativa. In molti paesi, i governi di centro-sinistra hanno giocato un ruolo fondamentale nel processo di deregolamentazione e privatizzazione che ha contribuito a consolidare l'egemonia neoliberale. E non si può negare che le istituzioni europee abbiano la loro parte di responsabilità nella crisi attuale. È un errore, però, concepire questa crisi come una crisi del progetto europeo. Si tratta piuttosto di una crisi della sua incarnazione neoliberale, ed è per questo che i tentativi di risolverla somministrando una dose ancora più forte di politiche neoliberali non può avere alcun successo. Per combattere il dilagare di sentimenti anti-europei e fermare la crescita dei partiti della destra populista che eccitano tali sentimenti, è urgente offrire ai cittadini europei un progetto politico che possa dar loro la speranza di un futuro diverso, più democratico.
Fortunatamente in molti paesi d'Europa sono nati partiti che si pongono a sinistra delle socialdemocrazie e che sfidano il loro centrismo. Organizzati nel Partito della Sinistra europea, lavorano per un'alternativa all'egemonia neoliberale e hanno deciso di lanciare un'offensiva a livello continentale. Così, in occasione del quarto Congresso che si è tenuto a Madrid dal 13 al 15 dicembre 2013, hanno scelto di candidare il leader di Syriza in Grecia, Alexis Tsipras, alla presidenza della Commissione europea con l'obiettivo di proporre un altro modello per l'Unione. Syriza è una coalizione di partiti e movimenti sociali, e da questo connubio può istituirsi lo spazio per mobilitare la vasta costellazione di forze sociali che si oppongono alle attuali politiche della Ue. In molti paesi i movimenti sociali hanno risposto positivamente all'appello del Partito della Sinistra europea a sostegno della candidatura di Tsipras, e sono ora impegnati a organizzare la loro partecipazione alla campagna politica. In Italia, per esempio, hanno dato vita a una Lista Tsipras per sostenere il programma che Tsipras ha presentato accettando la sua candidatura alle elezioni europee. Si tratta di uno sviluppo molto promettente, perché soltanto sulla base di una sinergia a livello europeo tra partiti della sinistra e movimenti sociali è possibile costruire una soggettività in grado di portare a una trasformazione radicale dell'attuale ordine neoliberale.
«Dai social forum agli Indignados, la protesta si è spostata nelle piazze. Ma i movimenti soffrono la mancanza di un coordinamento europeo». Non solo di questo soffrono, ma ne riparleremo: la discussione è già aperta.
Sbilanciamoci.info, newsletter n. 330, 19 maggio 2014
Le elezioni europee saranno le prime ad avere luogo nel pieno della Grande Recessione. I sondaggi - inclusi quelli promossi dalla Commissione Europea per mezzo di Eurobarometer - mostrano chiaramente gli effetti che la crisi finanziaria ha avuto sulla fiducia dei cittadini europei nei confronti delle istituzioni europee. Fiducia che ha subìto un calo drammatico, passando dal 57% della primavera del 2007 al 31% dell'autunno dell'anno scorso.
La crescente sfiducia nell'Ue va di pari passo con un aumento drammatico nella percentuale di cittadini nei quali l'Ue suscita un'immagine negativa, che è addirittura raddoppiata (dal 15 al 28%), mentre la percentuale di coloro nei quali suscita un'immagine positiva è crollata (passando dal 52 al 31%). Nel frattempo, la porzione della popolazione che si dichiara ottimista nei confronti degli sviluppi futuri dell'Ue è scesa da 2/3 alla metà del totale, mentre la porzione che si dichiara pessimista ha raggiunto i 2/3 del totale in Portogallo, Grecia e Cipro. I sondaggi ci rivelano anche quanto il tracollo di legittimità politica delle istituzioni sia legato alla crisi finanziaria e in particolare alle politiche di austerità. La metà degli intervistati (e i 2/3 in Spagna, Grecia, Portogallo, Irlanda e Cipro) pone la disoccupazione in cima alle proprie preoccupazioni, seguita dalla situazione economica. Solo il 14% considera il debito pubblico un problema. Il calo di fiducia va di paro passo col mutato giudizio nei confronti della situazione economica nazionale, che registra un aumento significativo nella percentuale - pari quasi al 100% nei paesi del Sud Europa - di coloro che la considerano totalmente negativa. È in rapido aumento anche la percentuale di intervistati (2/3) che ritiene di non avere voce in capitolo in merito alle decisioni prese dall'Ue; percentuale che aumenta drammaticamente (fino a 4/5) nei paesi dell'Est e del Sud Europa.
L'impatto degenerativo dell'«Europa del mercato» in termini di benessere economico e dell'«Europeizzazione dall'alto» in termini di consenso politico è oggetto di dibattitto tra i movimenti sin dai tempi del primo Forum Social Europeo, tenutosi a Firenze nel 2002. La speranza di riuscire a contribuire alla creazione di un'Europa più giusta e inclusiva è però andata in frantumi nel corso di quel decennio, in cui la crisi finanziaria ha dimostrato sia il radicamento delle idee neoliberiste all'interno delle istituzioni Ue che la l'incapacità di queste ultime di tenere fede alle loro promesse. La crisi finanziaria globale ha infatti accentuato gli effetti divergenti della moneta unica in termini di disuguaglianze territoriali. L'assenza di investimenti finalizzati al miglioramento delle loro infrastrutture socioeconomiche ha reso le periferie dell'Ue non solo più vulnerabili alla crisi, ma anche più dipendenti. Le politiche monetarie (del tutto insufficienti) messe in atto in seguito alla crisi finanziaria hanno dimostrato l'influenza dell'ideologia neoliberista sull'Ue in generale, e sulla Bce in particolare. L'illusione della federazione, e del riconoscimento dei diritti degli stati più deboli, è svanita di fronte alle pesanti conditionalities imposte ai paesi più colpiti dalla crisi economica, che sono stati costretti a sacrificare quel poco di sovranità nazionale rimasta in cambio di aiuti materiali. Questi mutamenti nelle istituzioni dell'Ue si riflettono nell'atteggiamento assunto dai movimenti progressisti nei loro confronti.
Laddove all'inizio del millennio il lavoro dei movimenti per la giustizia globale si era concentrato sull'elaborazione di una visione critica dell'Europa, oggi le proteste anti- austerity sembrano improntate alla difesa di ciò che è rimasto delle sovranità nazionali, perlomeno nelle economie più deboli. L'europeismo critico esiste ancora, ma la fiducia nella riformabilità delle istituzioni europee, e nella possibilità di influenzare le politiche europee per mezzo delle attività di lobbying e di consultazione, è stata messa a dura prova. Alla base di molte delle proteste anti- austerity, infatti, soggiace l'idea che la democrazia rappresentativa sia stata irrimediabilmente corrotta dall'intreccio tra potere economico e politico. Il fatto che le istituzioni sono considerate non-rappresentative si riflette negli studi che indicano che coloro che partecipano alle proteste hanno sempre meno fiducia nelle istituzioni democratiche, a tutti i livelli territoriali.
Se compariamo, per esempio, le risposte date al questionario sottoposto ai partecipanti del Forum Sociale Europeo del 2002 con quelle date allo stesso questionario dieci anni dopo, in occasione del forum Firenze 10+10, notiamo un calo drammatico nella percentuale di coloro che dichiarano di avere fiducia nei parlamenti, nei partiti e nei sindacati nazionale, ma anche nell'Ue e nelle Nazioni Unite. Allo stesso tempo, notiamo un aumento nella percentuale di persone che ritengono che, per raggiungere gli obiettivi del movimento, sia necessario aumentare i poteri dei governi nazionali. Questa sembra essere una reazione diffusa all'usurpamento di sovranità nazionale prodotto dalla crisi, in particolare nei paesi della periferia europea. Le modalità di mobilitazione e di azione dei movimenti anti- austerity riflettono questo cambiamento. I contro-summit e i Forum sociali europei sono stati rimpiazzati dalle occupazioni delle piazze pubbliche, in cui gli occupanti puntano a ricostruire i processi democratici - dal basso e a livello locale. Le acampadas degli indignados e dei movimenti Occupy possono essere considerate una forma di politica prefigurativa, orientata a incarnare i processi democratici in prima persona piuttosto che a relazionarsi con un sistema considerato ormai incapace di implementare la democrazia. Se compariamo i forum sociali con le più recenti proteste contro le politiche di austerità, possiamo cogliere delle similitudini nella critica della visione neoliberista della democrazia rappresentativa, ma anche delle differenze. In particolare, le tensioni nel rapporto con i partiti politici (e le istituzioni democratiche in generale), che erano già presenti nei forum, nelle ondate successive di protesta si sono fortemente radicalizzate, caratterizzandosi per un rifiuto diffuso di stringere alleanze con i partiti e persino con le associazioni politiche, considerati strumenti (corrotti) di dominio. Parallelamente, se è vero che gli appelli per un'altra Europa sono ancora udibili, le crescenti disuguaglianze territoriali, e l'asimmetria degli impatti della crisi globale, rendono più difficile il coordinamento a livello europeo. I tentativi di stringere alleanze di movimento a livello transnazionale rimangono sporadici e soffrono della mancanza di eventi catalizzatori, quali summit anti-Ue e Forum sociali europei.
Il nuovo contesto politico ci costringe a ripensare molte delle strategie per lo sviluppo democratico delle istituzioni dell'Ue e pone l'accento sulla necessità di elaborare una strategia di lotta multilivello se vogliamo incidere su un piano istituzionale che si è dimostrato sempre più impermeabile alle forme di pressione sperimentate in passato.
«»
Il manifesto, 18 maggio 2014 (m.p.r.)
Nel giorno in cui Beppe Grillo ha conquistato i palcoscenici mediatici tanto odiati con qualche battuta a effetto su Hitler, Stalin, Schulz e Angela Merkel, mentre Silvio Berlusconi gli contendeva invano la «marcia su Roma», la piazza romana dei movimenti è apparsa, al confronto, un’oasi di tranquillità e buonsenso. Non sfonderà per questo gli schermi e le prime pagine dei giornali, eppure è stata l’unica, nel linguaggio sopra le righe della campagna elettorale, ad avanzare richieste precise e porre le domande giuste ai palazzi sempre più chiusi e autocentrati della politica: che ne sarà del referendum sull’acqua pubblica e i beni comuni con la nuova ondata di privatizzazioni alle porte? Cosa accadrà alle migliaia di persone costrette giocoforza a occupare una casa una volta che sarà approvato l’articolo 5 della legge Lupi che proibisce loro di allacciare l’acqua e l’energia elettrica? Su cosa punterà le sue risorse il governo Renzi, sulle trivellazioni petrolifere o sulle energie rinnovabili? È possibile una politica dei rifiuti che non contempli sempre e solo inceneritori?
Questioni concrete, ambientali e sociali, che incidono direttamente sulle vite delle persone e coinvolgono territori già devastati da decenni di incuria e speculazioni, ma fuori da un’agenda politica che ormai da anni non tiene conto degli umori delle piazze e delle richieste dei movimenti, persino le più ragionevoli. Anche la manifestazione di ieri rischia di rimanere inascoltata. Nella migliore delle ipotesi, sarà consegnata al folklore mediatico dei cortei pacifici e colorati, lo specchio rovesciato di quello dello scorso 12 aprile, che ha conquistato gli onori delle cronache per gli scontri nelle vie della Dolce vita e una ragazza calpestata come uno zainetto senza per questo che, ancora una volta, si discutessero le questioni che poneva: ancora una volta la casa, e poi le grandi opere e lo sfruttamento del lavoro, questione centrale oggi in Italia e in Europa.
C’è poi una questione più generale: l’austerità che sta strangolando il sud del continente. Su questo le forze politiche che si oppongono ad essa hanno l’obbligo di dimostrare che fanno sul serio. È questo il loro compito principale ed è su questo terreno che si gioca il loro consenso.
«Bell'ambiente. La molteplicità dell’opposizione sociale: lotte ambientali, teatri occupati, studenti, centri sociali, Cobas, Usb e la Fiom, il diritto all’abitare. ma è necessario un salto di qualità nella costruzione di una rete tra i movimenti che si battono per i beni comuni utile a rafforzare anche le singole vertenze sui territori».
Il manifesto, 18 maggio 2014
Ogni giorno ti svegli e sai che troverai degli ostacoli, che dovrai oltrepassare i limiti e dovrai esporti. Sono le scritte che appaiono in alcuni video diffusi in rete dal teatro Valle occupato per lanciare la manifestazione per i beni comuni e contro le privatizzazioni e le grandi opere che ieri ha visto sfilare decine di migliaia di persone (50 mila per gli organizzatori) da piazza Repubblica a piazza Navona a Roma.
Nei video si vede una nuotatrice, una pallavolista, un tennista e un corridore impegnati a battersi contro gli ostacoli al diritto alla città e al trasporto, all’accesso ai beni comuni e alla cultura, agli spazi pubblici in dismissione e da rigenerare per esigenze abitative. «Il movimento fa bene» è il titolo di una campagna che ieri ha spinto molte persone a sfilare in tenuta da podista.
La nuotatrice invita ad immergersi nella città tuffandosi in una fontana. Con questo vuole invitare a mantenere il diritto al dissenso e a non temere il ministro degli interni Alfano vuole chiudere il centro di Roma alle manifestazioni per «evitare saccheggi» che non ci sono mai stati. In un altro video la pallavolista schiaccia la palla contro uno stendardo dell’Expo 2015 a Milano e segna un punto contro il sistema dei grandi eventi, e delle grandi opere che devastano i territori, assorbono milioni di euro in un modello di sviluppo che non redistribuisce ricchezza e amplifica il sistema della corruzione. Il tennista lancia la sua palla contro il muro invalicabile di una caserma, molte delle quali verranno dismesse, e chiede che siano usate come «patrimonio comune», affidate cioè ai comitati e ai movimenti che si stanno auto-organizzando in tutto il paese per gestire edifici, casali, territori, isole come Poveglia a Venezia e la sua laguna contro il passaggio di quei mostri galleggianti che sono le navi crociere.
Dalla Sicilia con il movimento No Muos alla Valle di Susa con i No Tav, dalle reti campane di «Stop Biocidio» alla campagna contro il partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti (Ttip ) dalla lista «L’Altra Europa con Tsipras» al Forum dell’Acqua pubblica passando per la Fiom, l’Unione Sindacale di Base, i Cobas e gli studenti di Link e dell’Uds, ieri a Roma è sfilato un corteo gioioso e colorato che ha mostrato la complessa articolazione delle questioni sociali, ambientali, abitative o economiche attorno alle quali si è riorganizzata l’opposizione sociale nel nostro paese. Dal palco improvvisato su un camion per i comizi finali gli organizzatori della manifestazione hanno più volte invitato ad un «salto di qualità nella costruzione di una rete tra i movimenti che si battono per i beni comuni utile a rafforzare anche le singole vertenze sui territori».
Una richiesta che nasce dall’esigenza di non restare isolati in un contesto dove il dibattito pubblico è ancora saldamente ispirato dai parametri della cosiddetta «austerità espansiva»: il pareggio di bilancio; i tagli alla spesa pubblica per finanziare uno stentato rilancio dei consumi; il taglio del debito pubblico anche attraverso dismissioni e privatizzazioni.
In queste condizioni, come ha ricordato Luca Fagiano del coordinamento romano di lotta della Casa, lo spazio per il dissenso, come per un modello alternativo di società o sviluppo, viene cancellato insieme ad ogni possibilità di mediazione. Sgomberi violenti, divieti a manifestare, l’attacco vendicativo alle occupazioni delle case rappresentato dall’articolo 5 del «piano Lupi» sull’emergenza abitativa sul quale il governo chiederà la fiducia alla Camera lunedì prossimo, l’espropriazione dei beni comuni e culturali non sembrano offrire spazio per il possibile. Contro questa tendenza ieri è stata riconfermata l’esigenza di auto-organizzazione su base locale e nazionale tanto più viva quanto più avanza l’impoverimento di ampie fasce della popolazione, sottoposte a perdita del lavoro, del reddito, della possibilità di accesso ai servizi, ai danni ambientali.
«È stata una grande manifestazione molto partecipata — ha detto Paolo Carsetti del movimento per l’acqua — decine di realtà sono scese in piazza per ribadire il rifiuto alle privatizzazioni, nonostante i divieti della prefettura ad alcuni passaggi simbolici come quello in via Goito sotto la Cassa Depositi e Prestiti o in via XX settembre al ministero dell’Economia su diktat del ministro Alfano». Continua ad essere molto sentita la polemica sui numeri identificative delle forze dell’ordine in servizio. Si è parlato in questi giorni di fantomatiche micro-camere indossate dagli agenti in piazza, oppure dai loro caposquadra, per identificare presunti manifestanti violenti. Dopo un’accurata ricerca, svolta da parecchi manifestanti, nessuno le ha trovate addosso agli agenti schierati in gran numero per bloccare tutti gli accessi a Piazza Venezia, come in tutto il centro storico di Roma dove sono spuntate decine di camionette, anche con gli idranti, fino a piazza Navona.
In compenso sono state notate le 350 pettorine indossate da altrettanti manifestanti. Sono state diffuse dal teatro Valle e dall’Angelo Mai in corteo nello spezzone «united commoners of europe rise up!» composto anche da studenti e precari. Ciascuna aveva stampato il nome di un musicista, di un filosofo, di un artista o un attore con il quale essere identificati. Da Marylin Monroe a Christo, da David Bowie fino a Nino Manfredi, un popolo di personaggi è sfilato ieri a Roma chiedendo di essere identificato per il valore singolare che ciascuno possiede.
Un minuto di silenzio è stato osservato in piazza Navona in memoria di Nicola Darcante, un operaio dell’Ilva di Taranto di 38 anni, padre di due bambini, morto per un tumore alla gola. Insieme a lui sono stati ricordati i 100 minatori morti in Turchia e le lotte contro il governo Erdogan e l’attivista zapatista Galeano ucciso dall’esercito messicano pochi giorni fa. Il movimento della casa tornerà a Montecitorio alle 16 di lunedì ancora una volta per protestare contro l’approvazione del «piano Lupi»
 Generosi e intelligenti sforzi per rimediare, almeno in parte, all'inaudito oscuramento mediatico subìto dalla lista "L'altra Europa con Tsipras.
Generosi e intelligenti sforzi per rimediare, almeno in parte, all'inaudito oscuramento mediatico subìto dalla lista "L'altra Europa con Tsipras.
Il Fatto quotidiano online, 18 maggio 2014
Gli argomenti, giocati con ironia e con un rovesciamento finale, sono la disoccupazione, il disastro scolastico, il crescente ricorso alle mense dei poveri e l’erosione dell’assistenza sanitaria per i più deboli. Non sono argomenti scelti a caso, perché figurano tra i maggiori parametri utilizzati dagli specialisti per stabilire quando ci si trova di fronte a una crisi umanitaria. La novità inaudita dell’Europa delle tecnocrazie – dapprima in Grecia, e sempre più anche in Italia – è che lo scenario di bisogno e abbandono che si era soliti collocare nel cosiddetto Terzo mondo, sempre più ci riguarda e ci interroga. E non in conseguenza di sciagure naturali, epidemie o guerre civili, ma di politiche economiche scientemente decise e imposte da un potere sovranazionale cui i governi democratici si assoggettano.
Tra i parametri con cui – secondo i dati elaborati due anni fa da Amnesty International – si stabilisce che un paese fronteggia una crisi umanitaria, vi è la crescita percentuale del numero di persone “autoctone” che chiedono pacchi viveri e necessitano di rivolgersi alle mense pubbliche per mangiare; la crescita percentuale delle persone che si rivolgono ai presidi sanitari delle Ong per gli immigrati (è il caso delle strutture di Emergency, soprattutto nel sud d’Italia, alle quali chiedono assistenza sempre più italiani che non riescono a pagare il ticket delle prestazioni mediche e dei medicinali); la crescita percentuale della disoccupazione giovanile e delle persone che perdono l’impiego e non riescono più ad accedere a un’occupazione stabile; il decadimento crescente dell’istruzione pubblica, in qualità e strutture.
I primi tre video sono su YouTube, con nomi provvisori: quelli definitivi saranno decisi dal web. Il quarto video è in fase di lavorazione e uscirà a breve.
 «Il populismo è il confine estremo della democrazia rappresentativa. Quando il populismo diventa potere di governo si corre il rischio di un’uscita dalla democrazia e dall’ordine costituzionale. Il populismo mette a rischio l’uguaglianza formale che le regole costituzionali hanno il compito di proteggere».
«Il populismo è il confine estremo della democrazia rappresentativa. Quando il populismo diventa potere di governo si corre il rischio di un’uscita dalla democrazia e dall’ordine costituzionale. Il populismo mette a rischio l’uguaglianza formale che le regole costituzionali hanno il compito di proteggere».
Micromega, 16 maggio 2014
L’ambiguità del termine è confermata anche dai contributi precedentemente pubblicati su Micromega e rispetto ai quali propongo questa riflessione: John McCormick (Sulla distinzione tra democrazia e populismo) propone di leggere il populismo come “grido di dolore” della democrazia rappresentativa, un grido che può mobilitare tanto la destra quanto la sinistra (tornerò su questa immagine durkheimiana più avanti); Lorenzo Del Savio e Matteo Mameli (Sulla democrazia machiavelliana di McCormick: perché il populismo può essere democratico) sostengono che la distinzione più convincente per comprendere il ruolo del populismo nelle democrazie moderne è tra populismi solidaristici e populismi razzisti; quando e se solidaristici, i populismi possono avere “potenzialità” democratiche. Come rendere conto dell’ambiguità nell’uso di un termine tra l’altro così frequentemente usato, il fatto cioè che il populismo possa rappresentare tutto e il contrario di tutto?
Il termine populismo designa un fenomeno complesso e ambiguo. Più che un regime, esso è un determinato stile politico o un insieme di tropi e figure retoriche che possono emergere all’interno di governi democratici rappresentativi. La prima distinzione da fare quindi è tra movimento popolare e potere ovvero governo populista. È Occupy Wall Street un movimento populista o un movimento popolare di protesta? La risposta a questa domanda è sintomatica di questa distinzione. Alla fine del presente contributo emergerà perché Occupy Wall Street non è stato un movimento populista e perché il populismo è altra cosa dalla partecipazione democratica nelle forme e nelle procedure stabilite da una costituzione: libere elezioni a suffragio universale con voto segreto per eleggere rappresentanti, libertà di stampa, parole e associazione al fine di partecipare alla costruzione di opzioni politiche, conta dei voti secondo regola di maggioranza e quindi riconoscimento della minoranza (opposizione) come essenziale al gioco democratico (che non è né unanimità né consenso senza libera espressione del dissenso, di qualunque dissenso anche su questioni che la maggioranza ritiene buone e giuste).
Ora, dato il contesto di democrazia rappresentativa e costituzionale, è prevedibile che il tema del contendere è proprio la rappresentazione del popolo (l’ideologia del popolo) nella sua unità politica sovrana; per il populismo il popolo è definito sempre contro un’altra parte che al popolo appartiene formalmente ma non socialmente in quanto detentrice di un potere economico che è in eccesso rispetto a quello degli ordinari cittadini (la soglia che designa l’eccesso è un oggetto stesso del contendere, intraducibile in norma certa). “Popolo” e “grandi”, ci ricorda McCormick, è la classica e mai superata contrapposizione repubblicana che sta alla radice del populismo, e che McCormick rende come tensione tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. Dunque, il populismo non è il popolo ma una sua rappresentazione coniata o promossa da un leader o un partito-leader. Il populismo quindi può essere più di un semplice movimento politico dei molti se i suoi leader riescono a conquistare il potere dello Stato. Come anche McCormick mette in luce, il populismo è impaziente con le regole e le procedure di una democrazia rappresentativa parlamentare perché impaziente con la formalità del diritto: l’eguaglianza politica e per legge ovvero la libertà nel diritto sono categorie che il populismo contesta nel nome di una eguaglianza sostanziale. L’obiettivo polemico del populismo è una lettura giuridica e costituzionale della democrazia, quella appunto che sta alla base del sistema rappresentativo.
Come si è visto con l’approvazione della nuova costituzione ungherese (11 marzo 2013), l’aspetto inquietante del populismo emerge qualora esso abbia l’opportunità di passare da movimento (politico o di opinione) a potere di governo. Infatti, l’esito delle decisioni di un governo populista sarà verosimilmente quello di piegare lo Stato agli interessi del “popolo”, ovvero della sua parte maggioritaria contro quell’altra parte che è minoranza (sia essa economica o culturale o religiosa o etnica). Si potrebbe obiettare che essere contro la minoranza economica non è la stessa cosa che essere contro la minoranza religiosa o civile; si tratta però di un’obiezione debole perché chi ha il potere di decidere chi sia minoranza buona o cattiva ha un potere che è esorbitante e quindi insicuro per tutti. Il populismo ha impazienza verso i principi della democrazia costituzionale, a partire dai diritti individuali (e che proteggono tutte minoranze, anche quelle che possono nascere all’interno del gruppo maggioritario), alla divisione dei poteri e al sistema pluripartitico: insomma a quel che è la democrazia rappresentativa.
Come si intuisce, l’ideologia del “popolo” è centrale. Se per democrazia noi intendiamo il governo del popolo e per popolo intendiamo la volontà politica di “un gruppo sufficientemente esteso” di persone che sono unite da qualcosa di “sostanziale” – reddito, religione, cultura, ecc. – possiamo pensare, con McCormick, che il populismo sia la forma più completa di democrazia, in quanto esso è attento appunto a rappresentare il popolo nella sua totalità, come massa unita da un’equivalenza valoriale che, anche se non interpreta esattamente tutte le sue parti, le unisce in un’omogeneità superiore alle parti stesse (questa è l’idea di populismo come processo di costruzione dell’unità egemonica del popolo che ci ha proposto Ernesto Laclau). Ora, in questo caso, la qualità del populismo dipende da “che cosa” viene usato come termine di equivalenza che unisce le varie componenti di un popolo: se è la condizione economica dei meno abbienti, allora il populismo prenderà l’aspetto di una politica di giustizia sociale e di lotta per l’eguaglianza, mentre se è l’identità culturale, etnica e religiosa a costruire l’egemonia popolare, allora sarà più probabile che il potere populista prenda forme inquietanti di nazionalismo e razzismo. Ecco allora che la distinzione di McCormick e quella di Del Savio e Mameli si sovrappongono: gli uni e gli altri proponendo un’interpretazione di populismo che si identifica con la parte meno negativa di quel che può unificare una massa. Ma con quale criterio viene deciso il “buono” e il “cattivo” populismo se è il contesto a dettare la definizione? Ovvero come uscire dal contingentismo se la dimensione sociologica prende il sopravvento su quella giuridica e delle procedure?
Come si può intuire, la differenza tra le due possibilità – populismo di destra o di sinistra, populismo solidaristico e esclusionario – è soltanto ideologica: dipende cioè dalla narrativa o retorica che viene adottata. Dipende per esempio dal fatto che la destra europea razzista e populista oppure la sinistra europea solidarista e populista abbiano o non abbiano leader capaci; e dipende poi, secondo Del Savio e Mameli, dalle decisione prese dai governi o, come nel caso europeo, dall’Unione Europea, poiché se queste decisioni sono punitive per i molti c’è da aspettarsi che questi ultimi si mobilitino in forme populiste e giustamente reclamino politiche di giustizia sociale. La prima delle due possibilità è connaturata alla lotta politica nelle democrazie elettorali e soprattutto alla politica plebiscitaria con la quale i leader sono incoronati dalle masse. La seconda è decisamente priva di evidenza: non è per nulla scontato che una politica inegualitaria generi politiche populiste di sinistra. Come insegna la storia antica e recente, i pochi che dovrebbero pagare di più in proporzione a quel che pagano i molti, non se ne stanno con le mani in mano e dovendo cercare il consenso della maggioranza a politiche che sono in effetti contro gli interessi della maggioranza, non tardano a creare delle ideologie populiste che unificano il discorso e le masse intorno a temi altrettanto populisti ma capaci di neutralizzare le politiche redistributive: useranno, per esempio, il classico argomento della lotta contro gli immigrati, i comunisti e gli zingari (facendo delle minorante capri espiatori di problemi la cui causa è economica). Insomma dire che il populismo dipende dal contesto nel quale si sviluppa, e che quindi può essere di destra o di sinistra, non aiuta a capire che cosa esso sia né a giudicarlo alla luce di criteri normativi democratici.
Il populismo nasce all’interno della cornice della democrazia costituzionale, un’arena politica fondata sulle elezioni, il pluripartitismo e la regola di maggioranza (ovvero la libertà di poter propagandare le proprie idee senza rischio della propria sicurezza e per conquistare consenso). Il populismo può sorgere solo in questa cornice di libertà politica e civile, non dove non c’è democrazia (a meno che non si voglia rubricare come populista tutto quel che accade nell’universo politico, quindi anche i movimenti di rivolta, le rivoluzioni e le ribellioni). Proprio per evitare il rischio onnivoro che un termine impreciso contiene, quel che si dovrebbe tentare di fare è capire: a) se, una volta acquistato il potere di prendere decisioni, la maggioranza populista rispetterà le regole che le hanno permesso di vincere ovvero se vorrà accettare il rischio di perdere; b) se si asterrà dall’usare il sistema statale per favorire la sua parte contro l’opposizione sconfitta così da crearsi le condizioni per una rielezione assicurata; c) se non gestirà le nomine delle cariche dello Stato favorendo solo la sua parte; d) se non riscriverà la costituzione allo scopo di restare al potere più a lungo; e) se non userà il potere fuori dalle regole e contro i limiti stabiliti dalla costituzione. Siccome il populismo è critico della democrazia costituzionale e rappresentativa, mettere in conto che potrebbe operare in modo non legittimo è quanto meno doveroso.
Quindi delle due l’una: o il governo retto da una maggioranza populista non opererà contro le regole costituzionali e allora questo non sarà altro che un nuovo governo, un caso cioè di normalità o politica ordinaria; oppure il governo populista cambierà la connotazione del regime costituzionale, dando luogo a una dittatura o una forma autocratica di regime. In questo secondo caso, chiamarlo populismo sarebbe inappropriato, perché si tratterebbe di una dittatura o autocrazia. L’uso delle regole da parte di un partito populista che ha conquistato la maggioranza è un elemento di giudizio molto importante proprio perché il populismo (di destra o di sinistra, solidaristico o esclusionario) si afferma criticando la struttura del sistema politico rappresentativo e costituzionale. Come ha scritto Benjamin Arditi, esso è la periferia estrema del regime democratico, oltre la quale c’è un altro regime, quello per esempio dittatoriale. Ecco dunque un importante tassello interpretativo: il populismo è un possibile modo di essere della politica praticata in una democrazia rappresentativa, un modo di interpretare il “popolo”, di unificare le varie esigenze interne a un popolo plurale intorno a un tema comune: questa è l’azione di un movimento populista che opera e continua a operare dentro le regole democratiche.
Ma se questa interpretazione ha un senso, allora non è per nulla chiaro come facciamo a distinguere questo processo di normalità politica da altri processi e movimenti peculiari alla normale dialettica politica democratica. Un esempio: anche i partiti socialisti e comunisti occidentali del Secondo dopo guerra conducevano una politica di unificazione dei vari interessi esistenti nel popolo per unirli intorno a un interesse comune: questa fu, per esempio, la politica dell’alleanza nazionale lanciata da Palmiro Togliatti (e che ha ispirato Laclau nella sua teorizzazione della costruzione egemonica populista); eppure sarebbe sbagliato sostenere che il Partito Comunista fosse un partito populista. Evidentemente questo processo politico di unificazione del popolo non è sufficiente a denotare il populismo, a meno che tutta la politica democratica non sia intesa come populista (questa è l’identificazione che propone Laclau, per il quale infatti populismo, politica e democrazia diventano una sola cosa). Ma questa equivalenza di termini è fallace proprio perché azzera le differenze nell’intento di spiegarle. Quindi identificare il populismo con la normalità della lotta ideologica in una democrazia non aggiunge nulla alla nostra conoscenza e non ci dice ancora che cosa sia il populismo.
Il populismo deve essere qualche cosa di diverso dalla politica democratica e dalla democrazia (ovvero dalla pratica ideologica normale di unificazione degli interessi di un popolo) e quindi dalla costruzione del consenso politico in vista di conquistare la maggioranza. A meno che non usiamo la parola populismo per descrivere la realtà effettuale, ma in questo caso tutto può essere incluso: populismi di destra o di sinistra, solidaristi o identitario, e così via. Se vogliamo elevarci dal discorso ideologico e cercare di capire un fenomeno politico allora dobbiamo cercare per quanto è possibile di estrarre dalle varie esperienze quelle specificità e costanti che ci consentono di dare un senso alla categoria “populismo”. Partendo da questa premessa ho cercato altrove di distinguere tra movimento popolare e populismo e per fare questo ho cercato di individuare alcune coordinate di orientamento (relative al populismo come potere, ovvero che aspira allo Stato): unificazione del popolo sotto un leader; trasformazione ideologica del conflitto in polarizzazione e quindi semplificazione della pluralità di interessi in opposizione binaria (“noi”/”loro”); e poi, quando e se il partito populista diventa partito di governo, se usa le risorse dello Stato per avvantaggiare la propria parte a danno dell’opposizione, quindi violando la divisione dei poteri (messa a repentaglio dell’autonomia del giudiziario) e dei diritti di libertà.
Si può quindi sostenere che il populismo vada oltre la “potenzialità democratica” dei movimenti. Tutti i movimenti possono o non possono avere potenzialità democratiche, e in questo senso il concetto di “potenzialità” è troppo lasco. Altrettanto insoddisfacente è appellarsi alla famosa espressione che Durkheim usò per il socialismo, ovvero il populismo come “grido di dolore” delle società democratiche rappresentative. In quanto “grido di dolore” il populismo non ci dice nulla su quale sia la ragione del dolore, né ci consegna una diagnosi, quindi non ci dice quale debba essere il movimento per correggere quel dolore. Il “grido” è un’indicazione della sofferenza, niente altro. E infatti, vi è una componente di dolore (come insoddisfazione e scontento) nel moto socialista come in quello populista, eppure sarebbe improprio dire che socialismo e populismo sono uguali in quanto gridi di dolore. A chi spetta la diagnostica e la cura? Diagnostica e cura mettono in moto competenze e azioni che sono esterne al “grido di dolore” e rispetto alle quali il popolo gioca il ruolo non dell’attore ma del paziente che consente ai leader di fare la diagnosi e di intraprendere la cura. Allora, perché criticare la democrazia elettorale di espropriare il popolo della sua voce se lo stesso appello al popolo del populismo lascia tanta latitudine di delega ai leader o ai tecnici dell’ideologia sulla diagnosi e la cura? Se il popolo grida, esso ha comunque bisogno di qualcuno che interpreti le sue grida. Per questo, viene il dubbio che la differenza tra populismi non sia altro che una differenza tra leader e le loro rispettive ideologie. È lo stesso McCormick che alimenta questo dubbio quando ci ricorda con buoni argomenti che la storia delle democrazie ha registrato demagoghi amici del popolo e demagoghi tiranni: dunque, la differenza tra populismo buono e populismo cattivo sta nella leadership, nel capo che rappresenta il “grido di dolore” del popolo paziente.
Abbiamo aggiunto così un importante tassello alla nostra conoscenza del fenomeno populista: il bisogno di un leader che unifichi o dia il senso ideologico di ciò che unisce il popolo. Senza questa leadership, senza l’apice cesarista (quella che ho altrove chiamato correzione mono-archica della democrazia) il movimento populista resta un movimento popolare come ce ne sono, e giustamente, tanti in un regime democratico: Occupy Wall Street o il movimento degli “indignados” sono casi di movimenti popolari di denuncia e di protesta ma non movimenti populisti. Occupy Wall Street rifiutò anzi ogni rappresentanza per mezzo di un leader e volle essere solo un’espressione di critica pubblica nel nome di un valore, quello dell’eguaglianza, che le società democratiche pretendono di incorporare. Chiamare questo tipo di movimenti “populisti” è sbagliato per la semplice ragione che, in questo caso, tutto sarebbe populista in democrazia. E allora che senso avrebbe usare il termine? Il fatto è che il populismo non presume solo e semplicemente l’esistenza di una massa di poveri o disoccupati; non basta il “grido di dolore” per denotarlo; esso presuppone un leader, e una macchina che produca un’ideologia che dia a quel grido un’unità rappresentativa finalizzata a uno scopo: la conquista del consenso per raggiungere il governo e prendere decisioni.
Vediamo dunque di capire perché il populismo è molto di più di un movimento popolare e perché ha senso temerlo. A questo fine torniamo al “grido di dolore” di un popolo che soffre. Dice McCormick: “Durkheim disse una volta che il socialismo è il grido di dolore della società moderna. Il populismo è ilgrido di dolore delle moderne democrazie rappresentative. Il populismo è inevitabile nei regimi politici che aderiscono formalmente ai principi democratici ma di fatto escludono il popolo dal governo”. Ecco dunque: il populismo non ha come punto fondante questioni di redistribuzione economica o di giustizia sociale, ma questioni di gestione del potere politico: è dunque una contestazione radicale alla democrazia rappresentativa in vista di una gestione diretta del governo da parte del popolo. Il quale se è economicamente oppresso dai pochi è perché non prende decisioni direttamente ma attraverso quei pochi che elegge. Quindi: il populismo si manifesta quando il popolo come entità sovrana c’è già e chiede che la sua autorità sia esercitata in maniera non indiretta. Per McCormick dunque populismo si identifica con la democrazia diretta (ovvero assemblea aperta a tutti i cittadini; lotteria per selezionare i magistrati; tribunali composti da cittadini comuni) in un contesto in cui questa non c’è più. Siccome nel nostro tempo questa forma di governo non può essere attuata come nell’Atene classica, è stata adottata la rappresentanza la quale, come Carl Schmitt e poi Bernard Manin hanno sostenuto (entrambi seguendo Montesquieu), è sinonimo di governo “aristocratico” o “oligarchico” ovvero dei pochi, in quanto fondato sulle elezioni. In sostanza, ci dice McCormick, in una democrazia rappresentativa è fatale che sorga il populismo: il quale “è l’altra faccia della medaglia della normalità politica nelle repubbliche elettorali”. Ecco che siamo tornati a quanto sosteneva anche Laclau: il populismo si indentifica con la politica e con la democrazia nei governi rappresentativi. Delle due l’una: o la politica è ordinaria routine (politica dei pochi con il consenso dei molti) oppure è l’opposto e cioè populista (politica dei molti contri i pochi, con o senza il loro consenso visto che i molti hanno la maggioranza comunque).
Ora, se la politica ordinaria opera secondo le norme formali (che garantiscono “l’uguaglianza politica formale” senza doverla tradurre in “eguaglianza socio-economica”), il sistema non ha scossoni. Ma quando la questione economica si fa pressante (il “grido di dolore”), allora l’uguaglianza formale (come la democrazia rappresentativa che si regge su di essa) mostra i suoi limiti. A questo punto, al popolo non resta che impossessarsi del potere per riportare equilibrio tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. Ciò che non è chiaro – e McCormick non aiuta a chiarire – è come si possa giungere a questo riequilibrio senza decisioni che limitano l’uguaglianza formale, ovvero senza violare i principi costituzionali e usare mezzi eccezionali per giungere alla realizzazione del fine desiderato (uguaglianza sostanziale). Ma a questo punto, la democrazia populista sarebbe un’uscita dalla democrazia costituzionale: mezzi e fini si separerebbero e con lo scopo di raggiungere il fine buono (uguaglianza sostanziale) il mezzo (violazione della legge) viene ad essere giustificato. Che sia Marx o Schmitt l’ispiratore di questa visione, è evidente che il populismo diventa a questo punto esterno alla democrazia costituzionale; non una forma politica interna alla democrazia, ma una trasformazione del regime da sistema nel quale gli attori politici prendono decisioni con la regola di maggioranza a sistema che dichiara essere il governo della maggioranza contro la minoranza (per ragioni “buone” come l’eguaglianza sostanziale). Il confine della democrazia è a questo punto oltrepassato.
In conclusione, possiamo dire che o il populismo non è altro che un movimento politico popolare, sacrosanto movimento di protesta (Del Savio e Mameli), per cui non è chiaro perché chiamarlo populismo; oppure è più di un movimento (McCormick) e in effetti una estrema tensione della democrazia rappresentativa verso una soluzione che rischia un’uscita dall’ordine costituzionale.
Qui il testo dell’articolo scaricabile in formato .pdf

Il manifesto, 17 maggio 2014
La mappatura del Genoma umano non sarebbe infatti stata immaginabile, negli Stati Uniti, senza l’intervento del National Institute of Health (Nih), che oltre a finanziare il progetto di ricerca di base continua a investire centinaia di miliardi di dollari per la ricerca applicata allo sviluppo dei cosiddetti «farmaci orfani», destinati alla cura di malattie rare, che coinvolgono risibili minoranze della popolazione, ma che sono venduti dalle multinazionali farmaceutiche a prezzi stratosferici. Allo stesso tempo è proprio il Nih che ormai «innova» farmaci consolidati, basandosi però sulle conoscenze che vengono dalla genomica. Infine, un altro settore ritenuto «strategico» nello sviluppo economico, le energie rinnovabili, non riuscirà a decollare se lo Stato non continuerà ad investire nella ricerca, come testimoniano i progetti pubblici di sviluppo in Cina e in Brasile.
Produttore di futuro
È questo il punto di partenza di un volume intelligentemente provocatorio e meritoriamente tradotto da Fabio Galimberti per la casa editrice Laterza. A scriverlo è Mariana Mazzucato, economista italiana, naturalizzata americana (i suoi genitori erano «cervelli in fuga» negli anni Cinquanta) e attualmente docente, in Inghilterra, presso l’University of Sussex. Lo stato innovatore (pp. 378, euro 18), questo il titolo, presenta una tesi controcorrente rispetto l’ideologia dominante neoliberista. Per l’autrice, lo Stato è un soggetto politico fondamentale nel favorire lo sviluppo economico, perché è il luogo dove vengono definite le norme che non solo regolano, ma producono il mercato. Svolge cioè un ruolo performativo dei comportamentii funzionali allo sviluppo capitalistico.
È questo il contesto dove, teoricamente, Karl Polany incontra Lord Keynes, Joseph Shumpeter e, ma l’autrice non ne fa mai menzione, anche il Michel Foucault storico dell’ordoliberismo austriaco e della biopolitica. Marina Mazzucato non è però interessata alle genealogie teoriche delle sue tesi. Il suo obiettivo è far emergere ciò che rimane in ombra nella discussione pubblica segnata dall’egemonia liberista, cioè che gran parte delle tecnologie sviluppate al processo economico sono «effetti» degli investimenti dello Stato, in epoca moderna, nel campo della formazione e della ricerca scientifica. Investimenti che non sempre prefigurano immediate ricadute produttive e economiche. Quel che si deve infatti chiedere allo Stato è una vision del presente e del futuro senza asficciti e algidi vincoli di bilancio.
Si investe in ricerca e formazione perché, nei tempi lunghi, l’intero «ecosistema» se ne avvantaggerà, grazie alla presenza di un elevato numero di ricercatori, di forza-lavoro qualificata e dalla traduzione operativa (la ricerca applicata) di conoscenze sviluppate in anni e anni di lavoro in qualche laboratorio senza l’ansia e l’incubo di doversi spostare da un mecenate all’altro nella speranza di raccogliere i fondi necessari per andare avanti nelle ricerche.
In nome dello statalismo
Nell’esporre la sua tesi Mariana Mazzucato non nasconde dunque la sua propensione «statalista» per quanto riguarda il necessario interventismo pubblico nella formazione e nella ricerca scientifica. Non è quindi un caso che si applica con convincente convinzione alla demolizione di un altro mito che ha accompagnato lo sviluppo della computer science e della new economy. Imprese come Google, Facebook, Intel, Apple non sono diventate quel che sono – cioè imprese globali fondamentali nello sviluppo capitalistico – grazie a intraprendenti e spericolati venture capitalist: il capitale di rischio, scrive l’autrice, più che favorire l’innovazione, la rallentano, anzi la mettono in pericolo. Chi investe in una start-up, infatti, non è interessato a finanziare l’innovazione tecnologica, bensì a far crescere quel poco un impresa per poi collocarla in borsa o venderla a un’altra società per ripagare l’investimento iniziale con l’aggiunta di una percentuale (generalmente molto alta) di profitti.
Lo Stato innovatore è una miniera di informazioni per quanto riguarda la ricostruzione delle fortune di Apple, di Google e delle altre imprese simbolo della new economy. L’esisto è una controstoria dello sviluppo tecnologico e economico degli ultimi cinquant’anni. Da questo punto di vista, Mariana Mazzucato fa sue molte delle analisi che hanno individuato nel Pentagono la fonte economica e finanziaria dell’innovazione tecnologica. Non solo i progetti per la costruzione di una rete di comunicazione che potesse «sopravvivere» a un attacco nucleare è stata finanziata dai militari attraverso il Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency ), ma è stato sempre il Pentagono, assieme al Ministero del commercio, che ha definito le regole affinché i risultati delle ricerche potessero essere diffuse sull’insieme delle attività produttive statunitensi. Internet è nata così. Ma questa è storia nota.
Il pregio del volume sta semmai nel ripercorrere tutti i passaggi che hanno portato ai successivi programmi di ricerca degli anni Settanta e Ottanta (il Gps, le nanotencologie, gli schermi lcd, il finger work, cioè gli schermi tattili) senza i quali non ci sarebbero stati l’iPod, l’iPhone e l’iPad.
Il sole che ride
Il famoso motto di Steve Jobs (stay hungry, stay foolish) usato per indicare la condizione necessaria per il successo imprenditoriale nasconde l’ipocrisia di chi è stato sfamato grazie al fatto che ha sfruttato, certo creativamente, la creatività manifestatasi nei laboratori di ricerca e nelle università lautamente finanziati dallo Stato attraverso il Pentagono o il programma Atp dell’Istituto nazionale per le norme e la tecnologia o dai progetti relativi all’innovazione per quanto riguarda le piccole e medie imprese.
Eguale rilevanza informativa è data allo sviluppo delle energie rinnovabili. In questo caso, gli Stati Uniti hanno scelto di costituire una agenzia federale apposita (l’Arpa-e) che dovrebbe svolgere nelle energie rinnovabili lo stesso ruolo svolto dal Darpa nella computer science e dal Nih nelle biotecnologie. Tuttavia, la strada migliore è quella tratteggiata da Cina e Brasile. In Cina lo stato ha investito e sta investendo centinaia di miliardi di dollari per favorire la ricerca e lo sviluppo di energia rinnovabile attraverso l’eolico, il fotovoltaico e il solare. In Brasile, invece, le banche per lo sviluppo definiscono e finanziano programmi che consentano al paese latinoamericano non solo di essere, nel futuro, indipendente dal punto di vista energetico, ma di vendere l’energia pulita prodotta. Cina e il Brasile sono diventati paesi all’avanguardia della green-economy, come la Germania, mentre gli Stati Uniti hanno perso terreno prezioso.
Nel Novecento la Ricerca scientifica statunitense è stata prevalentemente finanziata dallo Stato, anche se l’autrice non nasconde che gran parte dei risultati conseguiti sono stati poi acquisiti dalle imprese private e usati per innovare i prodotti e i processi lavorativi. Inoltre, negli Usa, lo Stato ha definito norme, definito i processi e le procedure affinché le conoscenze tecniche scientifiche potessero essere socializzate, favorendo così la crescita di nuovi mercati, facendo leva, ad esempio, sulle norme della proprietà intellettuale. Da qui il pendolo statunitense che oscilla dalla scelta a favore del public domain alla possibilità concessa alle università di poter brevettare le scoperte scientifiche avvenute all’interno di progetti di ricerca finanziati dallo Stato.
Governance di sistema
Mariana Mazzucato non è una economista radicale anticapitalista. La tensione polemica presente nel volume è semmai rivolta contro l’ideologia neoliberista, che vede nel mercato il deus ex machina dell’innovazione. Il capitale di rischio non rischia, afferma l’autrice, vuole vincere in partite facili, dove certo c’è incertezza, ma il rischio è minimo. Un atteggiamento parassitario che lo Stato ha per troppo tempo favorito e incentivato. Per l’autrice, l’intervento statale va salvaguardato perché è il solo soggetto politico che può creare un «ecosistema simbiotico» tra pubblico e privato. Lo stato tuttavia deve creare le condizioni affinché si manifesti al meglio l’indispensabile serendipity che favorisce l’innovazione e la ricerca scientifica. Per fare questo, vanno messe in campo misure che, ad esempio, recuperino parte dei finanziamenti statali attraverso un articolato sistema di governance della conoscenza. Può dunque essere istituita una golden share sui diritti di proprietà intellettuale, in maniera tale che una parte delle royalties vadano a finire nelle casse dello Stato; oppure va attuata una riforma fiscale che scoraggi l’elusione nel pagamento delle tasse da parte di imprese che si sono avvantaggiate dalla ricerche scientifiche finanziate dallo Stato, come invece accade adesso per gran parte dei colossi della new-economy e delle biotecnologie, che stabiliscono le loro sedi nei paradisi fiscali o in regioni tax free. Tutto ciò per continuare, anzi aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo
Il capitalismo può dunque essere salvato con un rinnovato protagonismo dello Stato, senza il quale è destinato a implodere nelle sue contraddizioni. Perché una delle regole auree del neolibierismo («socializzazione dei costi e privatizzazione dei profitti») ha portato il capitalismo sul ciclo del burrone. Solo con lo presenza di uno Stato che investe molto e che crei le condizioni per un ecosistema simbiotico tra pubblico e privato, chiosa alla fine l’autrice, è possibile pensare non solo alla sua sopravvivenza, ma a un suo duraturo sviluppo. Conclusioni modeste, si può dire, per un libro che invece ha una sua potenza analitica che funziona come un salutare antidoto a quel neoliberismo che con la sua crisi sta impoverendo la maggioranza della popolazione

Kermesse di musica con Nicola Piovani, attori e ’sorprese’ invece nella serata di Bologna, condotta da Moni Ovadia — che è anche candidato — e la giovane autrice satirica Francesca Fornario (suoi due spassosi spot per la campagna elettorale della lista). A quell’ora saranno noti i risultati del primo turno delle amministrative greche, che si svolgono domenica 18. Un risultato cruciale per la corsa verso il voto anticipato ad Atene, ma anche un (auspicabile) trampolino per le europee del 25 maggio. Per l’occasione Bologna cambia toponomastica, almeno nelle indicazioni degli organizzatori: «Largo al reddito di cittadinanza» e «Largo all’Europa sociale», «Via l’Austerity», «Via il Fiscal Compact», così saranno ribattezzate altrettante vie intorno a piazza Maggiore, che ovviamente sarà «Piazza dell’Altra Europa».
Intanto ieri a Roma è stato presentato l’appello di molti autori del mondo della cultura a sostegno della lista per Tsipras. Un’iniziativa analoga la scorsa settimana era stata presentata in Grecia. «Siamo convinti che tra le disuguaglianze sociali c’è anche l’accesso ai saperi e alla conoscenza», scrivono a Tsipras, «È anche in questo senso che alcune forze intellettuali e politiche si battono per un’altra Europa», «un’Europa legata alle necessità e allo sviluppo dei popoli, che riconosca i diritti dei lavoratori della cultura, che difenda e sostenga i luoghi della produzione e diffusione culturale, che consideri la cultura, la conoscenza e la ricerca come bene pubblico e diritto inalienabile». «Serve che la sinistra metta questi temi al centro della sua interpretazione della realtà», che lavori «per un nuovo umanesimo che si opponga ai processo distruttivi che rischiamo di percorrere» dopo gli anni di Berlusconi che «hanno costruito un senso comune cui nemmeno una parte rilevante della sinistra (o meglio del centro-sinistra) si è sottratta».
Promuove l’appello il regista Citto Maselli. Tra gli altri aderiscono il pittore Enzo Apicella, il musicista Piero Arcangeli, il professor Mino Argentieri, l’urbanista Paolo Berdini, lo storico Piero Bevilacqua, il costituzionalista Gianni Ferrara, l’attrice e autrice Sabina Guzzanti, la storica Francesca Koch, lo scrittore Felice Laudadio. E anche Lucio Manisco, Ivano Marescotti, Paolo Pietrangeli, Antonio Veneziano, Edoardo Salzano e lo scrittore Ermanno Rea (che è anche candidato).
Ma tra i moltissimi firmatari spicca il nome di Andrea Camilleri, ’padre’ del popolare Commissario Montalbano. Lo scrittore era stato fra i primi a promuovere la lista per Tsipras, ma poi non aveva accettato - con qualche polemica - di far parte del comitato dei garanti. Ora torna della partita. A tutti loro Tsipras si rivolgerà lunedì sera dal palco di Bologna
Daniela Preziosi ntervista Barbara Spinelli: «giusto imporre il voto su Genovese, rischiavamo di essere complici dei rinvii del Pd. Su molti temi siamo vicini al M5S. Ma senza alleati nel parlamento europeo loro si condannano al limbo della testimonianza». «La provocazione del bikini? Si è trasformata in sberleffo che ha oscurato il progetto».
Il manifesto, 16 maggio 2014
«I fermi di ieri a Bruxelles sono una cosa grave. Non c’era stata alcun tipo di violenza da parte dei manifestanti. Mi torna in mente il rapporto della JP Morgan del 2013, dove si sostiene che le Costituzioni più influenzate dall’antifascismo vanno smantellate perché difendono diritti troppo avanzati, compreso il diritto di protesta. La polizia di Bruxelles si è già adeguata?». La prima telefonata con Barbara Spinelli, capolista di L’Altra Europa con Tsipras, è al mattino mentre da Bruxelles arrivano le notizie di 249 fermati fra i manifestanti contro il summit delle Confindustrie. Fra loro un altro candidato, Luca Casarini. Proviamo a scherzare: era per cose come queste che qualcuno dei promotori della lista non voleva Casarini? La risposta è seria: «Stavano solo manifestando. Comunque le condanne per disobbedienza civile non sono un motivo di escludere qualcuno dalle nostre liste». Nel pomeriggio, per fortuna, saranno tutti rilasciati.
Il candidato del Pse Martin Schulz dichiara a Repubblica: «Se vince la destra ci saranno altri cinque anni di austerità». Se vince il Pse l’austerità sarà cancellata?
Questa dichiarazione è una vera beffa agli elettori. Gli anni di austerità li abbiamo avuti grazie alle intese fra socialisti e popolari. In Germania l’accordo sulla Grande Coalizione è stato negoziato fra Angela Merkel e Schulz, per la parte europea. Il risultato è stato che la Spd ha rinunciato a ogni critica dell’austerità, all’idea del piano Marshall che pure aveva difeso in campagna elettorale e ha ’dimenticato’ gli eurobond. Insomma sull’Europa ha ceduto su tutto. Le parole di Schulz non corrispondono a quello che i socialdemocratici hanno fatto negli anni di crisi.
Schulz non esclude larghe intese future con il Ppe. Dice: «Prima del voto non è il tempo di parlare di accordi».
Questo non è leale verso l’elettorato. In realtà si prepara alle larghe intese senza dirlo. Schulz sa bene che se il Pse diventa il primo gruppo e se lui vuol fare il presidente della Commissione avrà bisogno dell’appoggio del Ppe.
Invece voi cosa farete? Farete pesare i vostri voti, eventualmente, nell’elezione di Schulz? E innanzitutto: quando dico ‘voi’ dico la ‘Sinistra europea’?
Non è detto che il futuro gruppo si identifichi tutto con il Gue. Si è impegnato comunque a «stare con Tsipras», cioè a non entrare in altri gruppi. In ogni caso peserà molto perché, quale che sia il risultato italiano, è una formazione che aumenterà notevolmente. In Francia, Spagna, Germania la sinistra non socialista è in aumento.
Tsipras dice: «Saremo la terza forza».
È possibile. Spero che la lista per Tsipras abbia la forza e l’indipendenza di giudizio per aprire un dialogo con i 5 stelle e decidere su punti specifici politiche concordate. Ci sono molte cose in comune. Per esempio l’idea della conferenza che riduca e comunitarizzi il debito è una nostra idea che il M5S ha fatto propria. Ora Tsipras ha approvato il ‘New Deal 4 Europe’ dei federalisti: è un’iniziativa cittadina che sta raccogliendo firme in tutta l’Unione per un grande piano comune di investimento. Sarebbe interessante sapere cosa nel pensa il M5S.
Per la verità Grillo sembra più interessato alla campagna forsennata contro il Pd.
Ci sono molte posizioni di Grillo completamente condivisibili, e fra l’altro simili se non identiche alle nostre. M5S potrebbe svolgere un ruolo molto importante. Mi chiedo però cosa faranno i suoi eletti, nel parlamento europeo. Se non si alleano con altri dovranno entrare nel gruppo dei non iscritti, una sorta di gruppo misto. Saranno condannati ad un ruolo di testimonianza. A un limbo.
In Italia però siete in competizione con loro. L’ultimo scontro è di ieri, alla camera, fra Sel che fa ostruzionismo contro il decreto Poletti e il M5S che ci ripensa per anticipare il voto sull’arresto di Genovese.
Il decreto Poletti sarebbe passato comunque, l’ostruzionismo era ormai simbolico. Condivido la linea del M5S: il voto su Genovese era l’emergenza. È stato giusto mettere il Pd di fronte alle sue responsabilità e costringerlo a votare sull’arresto. Il reato di cui è accusato Genovese è gravissimo. Si rischiava di essere complici di una strategia del rinvio, accarezzata nel Pd.
Renzi ha tagliato il nodo imponendo il voto subito.
Ma è stato possibile solo grazie alle pressioni di M5S.
Torno al voto. Tsipras è ancora poco conosciuto.
Cerchiamo in tutti i modi di spiegare perché la Grecia è un caso paradigmatico, e che Tsipras sta inventando un modo di fare sinistra totalmente nuovo. Ma è una strada in salita
Le tv non vi aiutano.
Spesso ci boicottano addirittura. Rispetto a noi hanno più spazio sia Fratelli d’Italia sia la Lega. Un po’ perché nessuno vuole più avere a che fare con le sinistre radicali. Ma soprattutto perché il nostro potenziale elettorato porta via voti al Pd.
Per questo avete preso anche iniziative provocatorie, come quella del bikini?
Non è una strategia della lista. È una mossa provocatoria nata all’interno del gruppo comunicazione, dannosa per il nostro progetto e per molti candidati: per giorni lo sberleffo ha oscurato il programma. Non so dirle perché sia nata; so solo che si tende a trasformarla in un’offensiva ideologica contro il femminismo, e anche contro la mia candidatura. Per quanto mi riguarda, considero la diatriba del tutto assurda: non ho mai fatto parte né del movimento «Se non ora quando», né di altri movimenti femministi.
Renzi dice che le europee non debbono essere un referendum sul suo governo.
Renzi ha una singolare politica sull’Europa. Attribuisce tutti i suoi mali alla ‘burocrazia’ di Bruxelles. Ma è una vecchia strategia, risale ai tempi della Thatcher: è un alibi dietro il quale si nascondono i governi, che invece sono i veri esecutori delle politiche europee. Non esiste la Federazione europea, purtroppo. Se esistesse, l’Europa sarebbe più solidale. Ma la responsabilità delle politiche è dei governi. Quindi è inevitabile che nel voto europeo si parli dei governi.
Lei fermerebbe l’Expo di Milano, come dice Grillo, o la farebbe andare avanti per dimostrare di avere uno stato più forte dei ladroni, come dice Renzi?
È difficile fermare le macchine ora. Iniziative di questo genere in una crisi così profonda è meglio non farle. In Italia poi tutte le grandi opere sono infiltrate dalle mafie: non siamo di fronte a una nuova Tangentopoli, ma alla prosecuzione di quella dei primi anni 90.
Lo scandalo favorirà Grillo nelle urne?
Direi di sì. Potrebbe anche favorire noi, che diciamo cose analoghe su corruzione e mafia.
C’è chi sospetta del tempismo dei pm.
In Italia la corruzione c’è da lungo tempo. Ogni tanto ci sono degli arresti. Siccome siamo una democrazia con continue elezioni dobbiamo dire che ogni volta il tempismo è sbagliato? Allora decidiamo che la magistratura non faccia più niente. Un modo per evitare gli arresti in campagna elettorale c’è: la politica e le classi dirigenti evitino la corruzione prima che intervenga la magistratura. In democrazia non c’è un momento buono per un arresto: c’è nei regimi autoritari dove la giustizia è al servizio della politica.
Un'ulteriore stretta di vite del Finanzcapitalismo contro gli abitanti del pianeta Terra. Il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), l'accordo intercommerciale, in discussione tra Usa e Ue, comporterà l'istituzione di un tribunale che tutela solo i privati nelle dispute tra investitore estero e Stato.
Il manifesto, 16 maggio 2014
Dopo il disastro di Fukushima, la Germania decide di uscire dal nucleare. Pochi mesi dopo, basandosi su un accordo internazionale sugli investimenti in ambito energetico, il colosso dell’energia Vattenfall chiede allo stato tedesco una compensazione di 3,5 miliardi di euro. L’anno prima la Philip Morris cita l’Australia, sostenendo che la nuova legge pensata per limitare il consumo di sigarette deprime il valore dei suoi investimenti nel Paese e ne “compromette irragionevolmente il pieno uso e godimento”.
Benvenuti nel mondo delle dispute tra investitore e Stato, o Investor-State Dispute Settlement (Isds). Semplificando, una sorta di tribunale in cui le imprese private possono direttamente citare in giudizio gli Stati, quando questi dovessero introdurre delle legislazioni con impatti negativi sugli investimenti realizzati e persino sui potenziali profitti futuri. Legislazioni in ambito ambientale, del diritto del lavoro, della tutela dei consumatori, sulla sicurezza e chi più ne ha più ne metta.
Tali «tribunali» sono parte integrante di diversi accordi commerciali o sugli investimenti, come nel caso del Nafta, siglato tra Canada, Usa e Messico. È così che la statunitense Metalclad si è vista riconoscere un rimborso di oltre 15 milioni di dollari quando un Comune messicano ha revocato l’autorizzazione a costruire una discarica di rifiuti pericolosi sul proprio territorio; o ancora che la Lone Pine Resources ha chiesto 250 milioni di dollari al Canada a causa della moratoria approvata dal Quebec sulle attività di fracking — una pratica di estrazione di petrolio dalle rocce con enormi rischi ambientali.
Tutto questo potrebbe diventare la norma nei prossimi anni anche in Italia e in tutta Europa, se passasse il Ttip o Transatlantic Trade and Investment Partnership in discussione tra Ue e Usa. Se da una parte già si moltiplicano studi e ricerche che magnificano i presunti vantaggi di una completa liberalizzazione di commercio e investimenti, dall’altra fino a oggi i contenuti dell’accordo filtrano dalla Commissione europea e dai governi con il contagocce. Quello che sembra però confermato è che uno dei pilastri del Ttip dovrebbe essere proprio l’istituzione di un meccanismo di risoluzione delle dispute tra investitori e Stati.
Tralasciando i pur enormi potenziali impatti di tale accordo in ogni attività immaginabile, per quale motivo gli investitori esteri che si sentissero penalizzati non dovrebbero rivolgersi ai tribunali esistenti tanto in Usa quanto in Ue, come un qualsiasi cittadino o impresa locale? Secondo la Commissione «alcuni investitori potrebbero pensare che i tribunali nazionali sono prevenuti». Fa piacere sapere che la Commissione si preoccupa per quello che alcuni investitori esteri potrebbero pensare più che dei cittadini che dovrebbe rappresentare. Tenendo poi conto che un singolo non può rivolgersi a tali tribunali nel caso in cui fosse danneggiato dal comportamento di un investitore estero, che giustizia è quella in cui unicamente una delle due parti può intentare causa all’altra? Ancora prima, nel momento in cui si sancisce un diverso trattamento tra imprese locali e investitori esteri, ha ancora senso affermare che «la legge è uguale per tutti»?
Con tali meccanismi si rischia di minare le stesse fondamenta della sovranità democratica. Non vi è appello possibile, così come non c’è nessuna trasparenza sulle decisioni di tre «esperti» che si riuniscono e decidono a porte chiuse, nel nome della «confidenzialità commerciale», ma che di fatto possono influenzare, pesantemente, le legislazioni di Stati sovrani.
Spesso non è nemmeno necessario arrivare a giudizio: la semplice minaccia di una disputa basta a bloccare o indebolire una nuova legislazione. In parte per il costo di tali procedimenti, in parte per il rischio di dovere poi pagare multe che possono arrivare a miliardi di euro, ma anche per un altro aspetto: un governo che dovesse incorrere in diverse dispute dimostrerebbe di essere poco incline agli investimenti internazionali. In un mondo che ha fatto della competitività il proprio faro e che si è lanciato in una corsa verso il fondo in materia ambientale, sociale, fiscale, sui diritti del lavoro pur di attrarre i capitali esteri, l’introduzione di leggi «eccessive» e l’essere citato in giudizio in un Investor-State Dispute Settlement diventano macchie inaccettabili.
O forse, al contrario, è semplicemente inaccettabile un mondo in cui la tutela dei profitti delle imprese ha definitivamente il sopravvento sui diritti delle persone. Come sostiene la campagna promossa anche in Italia da decine di organizzazioni — http:// stop -ttip -ita lia .net -, a essere inaccettabile è il Ttip nel suo insieme. E non è probabilmente necessario il giudizio di un tribunale internazionale per capire da che parte stare
La verde Ska Keller la migliore, il democristiano Jean-Claude Juncker il peggiore. Il primo, storico, dibattito in diretta televisiva fra candidati alla presidenza della Commissione Ue finisce con una chiara vincitrice – la giovane e brillante eurodeputata tedesca – e un chiaro sconfitto – il veterano ex premier del Lussemburgo. Buona la performance di Alexis Tsipras della Sinistra europea, al di sotto delle attese l’esperto socialdemocratico Martin Schulz e il liberale Guy Verhofstadt: troppo compassato il primo, eccessivamente esagitato il secondo.
Nell’aula dell’Europarlamento trasformata in studio televisivo è andato in scena un evento a suo modo epocale: mai prima d’ora una discussione politica aveva riguardato contemporaneamente tutti i cittadini dei 28 Paesi dell’Ue. Conduzione affidata all’italiana Monica Maggioni (direttrice di Rainews), format tipico di questo genere di dibattiti: domanda uguale per tutti e ciclo di risposte brevi, con tre jolly da giocarsi per eventuali repliche. Ormai ci siamo abituati, ma l’impressione è che gli interventi concessi ai candidati siano stati troppo brevi: 1 minuto a risposta e 30 secondi per possibili repliche appaiono francamente poco. Difficilmente si riesce ad articolare qualcosa che vada oltre uno slogan o un’allusione: e manca persino il tempo per polemizzare davvero.
Nonostante la rigidità del formato, sono comunque emerse le differenze. Il democristiano Juncker (Ppe, in Italia sono Forza Italia e il Nuovo centrodestra) ha difeso l’austerità contro la quale si sono invece scagliati, con pari veemenza, sia la verde Keller che Tsipras. Schulz e Verhofstadt hanno assunto posizioni intermedie: la disciplina di bilancio è necessaria, ma l’eccesso di rigore può fare danni. Punti di vista diversi sulla crisi ucraina, con Juncker e Tsipras agli antipodi: il primo a insistere sull’inasprimento delle sanzioni contro il presidente russo Vladimir Putin e il secondo a denunciare lo scandalo della presenza di neonazisti nel nuovo governo di Kiev. Unanimità fra i candidati in un solo caso: tutti pensano che il prossimo capo della Commissione debba essere uno di loro, e non qualcuno che venga «concepito» nelle segrete stanze del Consiglio dei capi di stato e governo (come sembrerebbe preferire invece la cancelliera tedesca Angela Merkel).
All’ecologista Keller va il merito di avere citato il negoziato sul Ttip, il trattato di libero scambio Ue-Usa che mette a repentaglio i diritti di lavoratori e consumatori, e le proteste contro di esso, comprese quelle di ieri a Bruxelles. Tsipras ha certamente colto nel segno nel citare, nel corso del dibattito, sia lo scandalo del tentativo di contro-riforma dell’aborto in Spagna sia, a proposito del tema corruzione, gli intrecci tra mafia e politica in Italia. Il momento migliore di Verhofstadt è stato nel passaggio sulla vicenda di Edward Snowden, che per il leader liberale dimostra la necessità di difendere meglio la privacy dei cittadini europei, mentre a Schulz è mancato un colpo ad effetto. Il socialdemocratico, che molti vedono come presidente in pectore, è apparso troppo compassato, quasi si sentisse in dovere di assumere una posa «istituzionale». Keller e Tsipras decisamente i più sciolti.
Il dibattito visto sugli schermi di Rainews 24 risultava certamente appesantito della traduzione simultanea, che, peraltro, non sempre è apparsa impeccabile. E tuttavia, non c’era alternativa: per rendere l’appuntamento fruibile a un pubblico vasto non poteva essere trasmesso in lingua originale (possibilità riservata a chi lo vedeva in streaming). Pur con molti limiti (compresi personalizzazione e spettacolarizzazione), il primo presidential debate della storia della Ue va considerato un passo nella direzione giusta: quella della creazione di un’opinione pubblica europea che riesca a contrastare il predominio dei governi nazionali nella determinazione del destino politico dell’Unione europea.
 La cronaca della protesta da New York a Milano e la lotta per portare la paga oraria a 15 dollari, di Antonio Sciotto e Joseph Giles.
La cronaca della protesta da New York a Milano e la lotta per portare la paga oraria a 15 dollari, di Antonio Sciotto e Joseph Giles.
Il manifesto, 15 maggio 2014
«Siamo noi il Quarto stato. Io vivo con 650 euro al mese ma allo sciopero non rinuncio». Giuseppe Augello, delegato milanese di McDonald’s è carico, pronto per incrociare le braccia insieme a tutti i suoi colleghi che nel mondo friggono panini e battono scontrini alla cassa. Cappellino e uniforme di ordinanza, i ragazzi degli archi dorati si preparano a cortei, volantinaggi e flash mob per rivendicare salari più alti, il diritto a un lavoro full time e ritmi umani.
Giuseppe è Rsa Filcams Cgil da cinque anni, da quando cioè ha cominciato a lavorare per la multinazionale del panino: da allora, McDonald’s lo ha spedito prima a Bergamo e poi in ben due locali destinati alla chiusura, pur di costringerlo ad andarsene («perché io rompo e metto i paletti»), ma lui ha resistito. Giuseppe ha citato l’azienda davanti al giudice, per contestare un apprendistato lungo tre anni ma senza formazione (il recente decreto Poletti suggerisce qualcosa?): McDo ha accettato di conciliare, ha dovuto assumerlo a tempo indeterminato e pagargli tutti gli arretrati. Giuseppe è solo un esempio, parla di un mondo di lavoratori che non si arrende. Per oggi la IUF (International Union Food, sindacato globale della ristorazione) ha indetto una giornata di iniziativa mondiale, la #FastFoodGlobal, a cui l’Italia aderisce – con lo sciopero di domani, che in realtà riunisce tutti i lavoratori del turismo.
«Il nostro contratto non è un menù», dice il volantino dei milanesi in sciopero. «Su Milano e in tante altre città porteremo i lavoratori in corteo», annuncia Giorgio Ortolani della Filcams. In effetti la mobilitazione italiana è stata indetta da Cgil, Cisl e Uil soprattutto per il contratto: perché la Fipe-Confcommercio – cui aderisce McDonald’s, con i suoi 16 mila dipendenti – ha disdetto il contratto nazionale, lanciando una sfida senza precedenti al sindacato. Il gesto della Fipe è davvero «rivoluzionario», visto che l’associazione che riunisce grossi marchi come Autogrill, MyChef, ChefExpress, vorrebbe idealmente passare al superamento del contratto nazionale, per applicare dei regolamenti aziendali unilaterali. Abbattendo gli scatti di anzianità, i permessi retribuiti, le maggiorazioni per notturni e festivi, la quattordicesima. «La disdetta ci era stata comunicata a partire dal primo maggio 2014 – spiega Cristian Sesena, segretario nazionale Filcams Cgil – Poi hanno deciso di prorogarla al 31 dicembre: forse adesso vogliono sedersi a un tavolo».
A minacciare i principali istituti contrattuali, anche se non hanno scelto di disdettare il contratto, anche gli albergatori aderenti a Confindustria e Confesercenti. Una situazione – quella di un contratto che non si riesce a rinnovare ormai da un anno (se si eccettuano Federalberghi e Faita campeggi, unici ad aver firmato) – che mette gli addetti ancora più in crisi, se già non bastassero condizioni di lavoro spesso precarie e al confine con la povertà.
Sesena di recente è stato a New York, dove ha partecipato al summit indetto dalla IUF per organizzare le mobilitazioni: «Il fatto positivo è che stiamo cercando di uscire dal localismo – spiega – McDonald’s ha un’organizzazione del lavoro simile in tutto il mondo, che si ripete un po’ nei 33 paesi che hanno aderito alla protesta. E uguali sono i metodi di formazione. È importante creare un coordinamento delle lotte globali: che però non deve essere fatto solo di azioni estemporanee, per guadagnare visibilità, pure fondamentale. Serve una strategia sindacale». Negli Usa, ad esempio, si chiede il raddoppio della paga oraria: da 7,25 dollari a 15 (tenendo conto che non è un netto: i lavoratori con questa cifra devono pagarci anche l’assicurazione sanitaria). Ecco il senso della campagna #fightfor15.
In Italia, seppure il tema del reddito sia importante – non solo sul piano del contratto nazionale, ma anche sulla obbligatorietà di fatto del part time – la vertenza va anche su altri temi: «Si deve parlare di orari, di conciliazione vita-lavoro, di tutela delle donne e delle mamme – dice Sesena – Non dimenticando che McDonald’s non ha mai voluto sedersi per discutere un integrativo». A Milano, tra l’altro, si parla anche di Expo: come lavoreranno nel 2015 gli addetti di ristoranti e alberghi se non avranno un contratto?
Quindi ecco le campagne che la Filcams Cgil ha lanciato per gli addetti dei fast food, spesso giovani e un po’ a digiuno di conoscenze sindacali, intercettabili però sui social network: la campagna «Faccia a faccia con la realtà» è diventata un blog (www.fastgeneration.it) dove i lavoratori si raccontano (su Twitter l’hashtag è #fastgeneration).
Articoli correlati su questo sito
Il pollo transgenico di McDonald’s che fa litigare Usa e Germania
«Regole giuridiche per gli appalti. La legge approvata nel 1994 che prese il nome dall’allora ministro Merloni era un provvedimento rigoroso e si trattava solo di sperimentarla e migliorarla. Si scelse la strada opposta. Fu subito accusata di rigidità e fu variata, emendata e stravolta: oggi siamo alla sua quarta stesura».
Il manifesto, 15 maggio 2014
Approvando nel 2001 la «legge obiettivo» che con il convinto sostegno del mondo delle maggiori imprese forniva semplificazioni per i grandi appalti. Ancora peggio fecero nel 2002 i decreti attuativi e fu possibile così sperimentare la macchina della Protezione civile di Guido Bertolaso. Tutti i grandi appalti venivano aggiudicati con un sistema palesemente discrezionale: lo scandalo che seguì aveva dunque radici salde nella mancanza di regole. Ma anche il settore degli appalti minori è rimasto indenne. Da anni i comuni italiani possono appaltare a trattativa semplificata — senza una vera gara di evidenza pubblica — lavori di importo fino a 500 mila euro. Nel 2011, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Avpc, denunciava inascoltata che il 28% degli appalti pubblici per un valore di 28 miliardi veniva appaltato senza gara. I grandi lavori hanno beneficiato di un terreno legislativo speciale mentre quelli minori sono stati lasciati nella discrezionalità.
Come meravigliarsi dunque dell’esplodere dell’ennesimo scandalo? Le radici stanno nell’assenza di regole: la politica affaristica tiene sotto controllo le imprese e le ruberie sono all’ordine del giorno, come denunciano la Corte dei Conti e la Trasparency International. Ha dunque ragione Livio Pepino che sulle pagine del manifesto di ieri affermava che «non siamo di fronte ad una corruzione nel sistema ma ad una ben più grave corruzione del sistema». La vera tragedia che stiamo vivendo sta però nel differente atteggiamento del legislatore e dei mezzi di comunicazione. Se vent’anni fa ci fu un innegabile scatto di dignità istituzionale, oggi siamo dentro ad un inaudito attacco alla «burocrazia» rea di ogni colpa.
Due giorni fa a Milano a discutere del futuro di Expo 2015 c’era il ministro per le infrastrutture Maurizio Lupi. Non è soltanto la presenza del suo nome nelle intercettazioni della cricca dell’Expo a suscitare preoccupazione (come noto egli ha smentito ogni legame con i detenuti) quanto un gravissimo annuncio reso pubblico nell’audizione da lui tenuta l’11 marzo scorso presso la commissione ambiente della Camera dei Deputati. In quella sede ha infatti espresso il parere di sciogliere l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e riportare tutte le competenze presso il ministero da lui diretto.
L’attacco è stato motivato dalla necessità di «snellire e sburocratizzare». La realtà è diversa. L’Avcp – che pure ha un dirigente coinvolto nell’affare Expo e non è immune da critiche– aveva negli anni scorsi denunciato alla Magistratura inquirente molti appalti sospetti. I casi più clamorosi hanno riguardato l’appalto per la sede dell’Agenzia spaziale italiana (l’ex presidente Saggese è in carcere per tangenti) e l’ispezione compiuta sull’appalto della Pedemontana lombarda, opera tanto cara al sistema di potere smascherato dall’inchiesta Expo. Troppo per i nostri liberisti. Così, forse anche per la presenza presso il suo ministero in qualità di Capo di Gabinetto di Giacomo Aiello che era stato capo dell’ufficio legislativo della Protezione civile di Bertolaso, Lupi vuole sciogliere quell’organismo indipendente.
La drammatica crisi di legalità che viviamo deriva dalla mancanza di organismi terzi indipendenti dalla politica e autorevoli sotto il profilo morale, delle competenze e della libertà di movimento. E invece il governo persegue la demolizione del residuo di legalità e di senso dello Stato che ancora non è stata spazzata via dal ventennio berlusconiano. Oltre a Lupi, anche il primo ministro Renzi sembra ossessionato dalla volontà di demolire quanto resta delle funzioni pubbliche, dalle Soprintendenze fino alla Magistratura.
«Il PNR (Programma nazionale di riforme) propone un set di obiettivi da raggiungere riguardo temi rispetto ai quali i cittadini sono molto più sensibili: occupazione, povertà, istruzione terziaria e abbandoni scolastici, spesa in ricerca e sviluppo, emissioni, efficienza energetica ed energie rinnovabili. Si tratta della strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, in arte "Europa2020"».
Sbilanciamoci.info, 13 maggio 2014 (m.p.r.)
Il Programma di Stabilità offre il quadro macroeconomico e stima l’impatto degli interventi previsti dal governo rispetto ai vincoli del patto di stabilità e alla finanza pubblica in generale. Il PNR presenta le misure che il governo intende introdurre, risponde alle osservazioni presentate dalla Commissione nell’Annual Growth Survey (il documento di partenza del “Semestre europeo”) e lo stato di avanzamento verso gli obiettivi di qualità della crescita fissati dalla strategia Europa 2020.
Ma che cos’è Europa 2020? Nel 2010, alla scadenza della precedente Strategia di Lisbona per la crescita e il lavoro, i governi dell’Unione hanno definito delle linee d’azione perché gli obiettivi di medio periodo della politica economica non siano limitati alla sola crescita economica ma estesi ad alcuni elementi fondamentali che caratterizzino il modello europeo. Nell’idea della Commissione si vuole “accrescere la competitività dell’Unione mantenendo il modello di economia sociale di mercato e migliorando l’uso efficiente delle risorse”.
|
|
Target IT
|
Target UE
|
|
Spesa in Ricerca e Sviluppo in % PIL
|
1,53
|
3
|
|
Quota di 30-34enni con istruzione terziaria
|
26%
|
40%
|
|
Abbandoni scolastici
|
16%
|
10%
|
|
Tasso occupazione 20-64enni
|
75%
|
75%
|
|
Riduzione della popolazione a rischio povertào esclusione rispetto al 2005
|
(-2.2 milioni)
|
-20 milioni
|
|
Riduzione delle emissioni gas serra rispetto al 1990
|
20%
|
20%
|
|
Quota di energia rinnovabile sul consumo finale interno lordo
|
17%
|
20%
|
|
Efficienza energetica (riduzione dei consumi di energia)
|
20%
|
20%
|
Con Europa2020 l’Europa si è dotata di un percorso di medio periodo da seguire in modo da realizzare, in qualche maniera, un’idea di Europa. Questo è stato fatto attraverso un accordo politico tra i 27 governi che si sono impegnati a rispettarne la realizzazione. Gli obiettivi politici di ampio respiro (crescita intelligente, inclusiva e sostenibile) sono stati declinati in indicatori misurabili, quindi monitorabili e con obiettivi numerici ben definiti, rendendo i governi “accountable” di fronte ai cittadini e alla Commissione. Il fatto che siano pochi rende chiare le prorità e facilmente comunicabile la strategia nel suo complesso. In più tali obiettivi sono inseriti all’interno del semestre europeo per cui ogni governo si impegna a fornirne il monitoraggio annuale e a dichiarare, proprio con il PNR, in che maniera si propone di raggiungere gli obiettivi. Tra i pro, è da notare anche il fatto che la strategia si inserisce in un dibattito che sta avendo molta risonanza su scala internazionale, sulla necessità di misurare il progresso delle società, e il benessere dei cittadini, attraverso misure che vadano “oltre il Pil”. In Italia la concretizzazione di questo movimento è l’iniziativa CNEL-Istat per la misurazione del BES, il Benessere Equo e Sostenibile (si veda www.misuredelbenessere.it). Europa2020 non è il migliore set di indicatori di misurazione del progresso di una società, ma è la formale presa di coscienza da parte delle istituzioni europee che la crescita del Pil da sola non basta e che deve necessariamente essere dotata di caratteristiche qualitative che la rendano più giusta e sostenibile.
I contra e le proposte di riforma.
Un’analisi critica della genesi ed attuazione della strategia può fare riferimento alle diverse fasi dell’intero processo:
1. la definizione degli obiettivi e degli indicatori proposti è criticabile tanto nel metodo, mettendo in discussione la legittimità politica di una decisione di medio periodo presa a porte chiuse dal Consiglio europeo, come nel merito: sono stati inclusi tutti gli elementi rilevanti? sono misurati nella maniera più opportuna?;
2. il tipo di procedure che sono attivate per il monitoraggio dei risultati e l’opportunità di avere processi di infrazione anche su obiettivi esterni al Patto di Stabilità;
3. infine sul processo di comunicazione da parte delle istituzioni comunitarie e nazionali che estenda il controllo sui governi anche all’opinione pubblica.
Iniziamo dalla questione della scelta degli obiettivi. È chiaro che la definizione di accordi intergovernativi sia nelle competenze dell’Unione, ma quando si tratta di definire obiettivi strategici di lungo periodo sarebbe opportuno ascoltare fasce più ampie della cittadinanza, al di fuori dei ministeri nazionali e della tecnocrazia europea. La crisi della rappresentanza democratica degli eletti è messa in discussione da tutti i fronti, e in tutti i paesi, e ancor di più lo è quella della dirigenza ministeriale e della Commissione Europea. Non a caso la Commissione cerca in tutte le occasioni di aprire consultazioni pubbliche sulle principali direttive proprio per supplire il suo evidente deficit democratico. Europa2020 è frutto di un accordo a porte chiuse che elude da qualsiasi reale legittimità democratica. La sua riforma dovrà necessariamente fare in modo (e sembra che questo sarà fatto nei prossimi mesi) di tenere conto delle opinioni e delle priorità dettate dalla società civile e delle parti sociali europee.
Come detto il monitoraggio degli indicatori di Europa2020 avviene nell’ambito del cosiddetto Semestre Europeo assieme a diverse altre procedure di monitoraggio. Quello che abbiamo imparato a vedere è che rispetto agli obiettivi che l’Europa si è data, quelli macroeconomici hanno completamente eclissato quelli sociali, anche quando questi sono stati presentati come indicatori di qualità della crescita. Sebbene attraverso la crisi l’occupazione crollasse e la povertà e l’esclusione sociale esplodessero, questi segnali non hanno mai dato adito, da parte della Commissione, di alcuna richiesta d’azione per invertire tali tendenze che le politiche d’austerità, attente ossessivamente al 3% di deficit, hanno chiaramente aggravato.
Chiudiamo con la questione della diffusione.
Nel nostro Paese, e non solo, la strategia Europa2020 appare nota solo agli addetti ai lavori. In Italia il 9 aprile, dopo la pubblicazione del DEF, tutti i giornali vi hanno dedicato almeno una notizia, se non molte pagine; in alcuni casi si è citato il PNR; nessuno mi risulta abbia parlato di Europa 2020 e mostrato gli effetti delle misure presentate dal Governo sui nostri 8 indicatori presentati dal Governo. Una ricerca di news su Google, l’11 aprile, mostra una differenza nel numero di uscite tra Governo+DEF, e Governo+”Europa 2020” da 44900 a 138. È naturale e giusto il grande interesse della stampa per il DEF e le misure in esso contenute, ma nella attuale organizzazione dei documenti del semestre è inevitabile che Europa2020 scompaia.
La presidenza italiana.
La revisione di Europa2020 avverrà nel prossimo anno a partire da ora: entro fine 2014, proprio durante il semestre di presidenza italiano, avverrà la consultazione dei cittadini e delle parti sociali, nella prima metà del 2015 avverrà invece la trattativa istituzionale. Il Governo italiano può quindi giocare un ruolo cruciale nella promozione di un dibattito europeo che dovrebbe rilanciare il modello economico e sociale europeo. Nell’ambito delle attività della presidenza, ad ottobre si terrà a Bruxelles una nuova conferenza “Beyond GDP” (dopo quella molto influente del 2007) che speriamo possa riportare il nostro governo su posizioni avanzate rispetto al modello di sviluppo che l’Europa sceglierà. Le recenti dichiarazioni del primo ministro Renzi riguardo a “crescita e occupazione come valori costitutivi dell’Unione”, sebbene comprensibili per far fronte al quadro di solo rigore in cui ci troviamo, non tengono conto delle imprescindibili garanzie di equità e sostenibilità [1].
[1] Di fatto tornando indietro ai principi della Strategia di Lisbona.
«Non c’è solo la povertà economica a rendere problematico il presente e il futuro di molti bambini in Italia. Esiste anche una più subdola povertà educativa. Un piano di
Save the Children per migliorare l’offerta di servizi e la partecipazione dei minori alle attività culturali ed educative». Lavoce.info, 13 maggio 2014 (m.p.r)
Un indice per la povertà educativa. In Italia, i minori a rischio di povertà economica e di esclusione sono il 34 per cento di bambini e adolescenti, una delle percentuali più elevate dell’Unione europea. (1) Oltre a quella economica c’è però anche una povertà meno visibile, ma ancora più insidiosa, perché capace di lasciare segni profondi, a volte non rimediabili nel futuro educativo, lavorativo, emotivo e sociale dei giovani: la povertà educativa. Per povertà educativa si intende la privazione della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare liberamente capacità, talenti e aspirazioni nei primi stadi del processo vitale, periodo in cui il capitale umano è più malleabile e recettivo.
Tabella 1 – Indice di povertà educativa per Regione
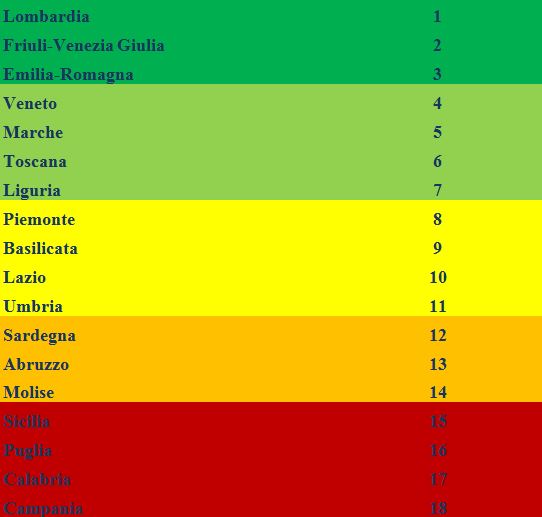
La tabella ci mostra che tra le prime tre Regioni ci sono il Friuli, la Lombardia e l’Emilia Romagna, mentre tra le ultime la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Il ranking conferma che nelle Regioni dove vive il più alto numero di bambini in povertà economica ci sono anche i livelli più alti di povertà educativa sia in termini di offerta di servizi che di partecipazione dei minori alle attività culturali ed educative.
Piano d'azione concreto. Come migliorare la situazione? Sono molte le cose che si possono fare e il rapporto di Save the Children le indica seguendo gli elementi della storia della lampada di Aladino, ma costituiscono obiettivi realizzabili. Il primo passo è “strofina l’anello: promuovi la conoscenza e la ricerca”. Significa raccogliere dati e indicatori più dettagliati sulla situazione educativa dei bambini, completare l’anagrafe scolastica e valutare gli interventi. Il secondo passo è “segui la luce”: è necessario iniziare da azioni basilari, come rifinanziare il piano nidi varato nel 2007 ma interrotto nel 2010, soprattutto nelle aree dove quasi non ne esistono, formare in modo continuo i docenti, intervenire contro la dispersione scolastica, pianificare per l’edilizia scolastica. Le ultime due mosse sono “strofina la lampada” e “libera il genio nei quartieri difficili”.
Il manifesto, 15 maggio 2014
La sentenza definitiva su Dell’Utri mette il sigillo finale ad una vicenda la cui sostanza e contorni erano già chiari da molti anni. Ora però è un dato incontrovertibile che l’operazione Berlusconi-Dell’Utri-Previti del 1994 aveva come fine quello di assicurarsi un rapporto biunivoco e funzionale tra sfera criminale e sfera politica. Da questo punto di vista l’operazione può considerarsi perfettamente riuscita. L’operazione è collettiva, ma il suo centro è Berlusconi. Previti corrompe per Berlusconi e con i soldi di Berlusconi. Dell’Utri è tramite e garante dell’accordo Berlusconi mafia. Berlusconi propone Previti come guardasigilli. Solo la decisa opposizione di Scalfaro fece sì che il corruttore fosse dirottato alla difesa. Non è una domanda illegittima chiedersi se Giorgio Napolitano, visto il teorizzato cinismo dei mezzi in vista di un buon fine (stabilità, riforme…), visto che allora Berlusconi si trovava in condizioni di assai maggiore legittimità rispetto ad oggi, si sarebbe comportato come Luigi Scalfaro.
Nel momento attuale il beneficiario principe di quel tipo di «discesa in politica» si propone ancora come «padre della patria». A di là dell’evidente forzatura propagandistica c’è un aspetto di verità in quell’affermazione. Il progetto di un’Italia davvero nuova, innervata dalla tensione costante verso forme sempre più avanzate di democrazia e contemporaneamente consapevole fino in fondo di quel principio liberale di civilizzazione della politica che consiste nella teoria e nella pratica della limitazione del potere, ha, con tutta evidenza, ben altri padri. Sono i Calamandrei, i De Gasperi, i Togliatti la cui riflessione nasce dalla necessità di una rottura netta sia con antiche e negative costanti della storia italiana, sia con le radici culturale e sociali del fascismo. Poi vi è l’Italia giunta allo «ultimo gradino di degradazione e decomposizione dello spirito pubblico nazionale» (P. Bevilacqua, il manifesto, 9 maggio). Di questa patria i Berlusconi, i Dell’Utri, i Previti possono, a buon diritto, considerarsi, padri.
Il fatto inquietante è che i padri di questa seconda patria, seppure, in modi diversi, alla fine del loro ciclo, hanno molte possibilità di entrare nel pantheon materiale della patria che si sta attualmente disegnando. Per ragioni di lungo periodo e per precise scelte contingenti. Scelte che sono state fatte in tutta libertà, scelte tra alternative diverse non giustificate da nessun stato di necessità.
Le ragioni dei vent’anni berlusconiani affondano profondamente nelle sfera sociale e in quella politica italiane. Non c’è stata nessuna invasione degli Hyksos. Se ne esce solo con lo spirito che aveva animato i primi padri della patria: una rottura netta sostanziata da una vera analisi del fenomeno. Le scelte contingenti di cui s’è detto confermano, invece, la persistenza delle lunghe continuità.
In questo momento, ad esempio, leggo un lancio di agenzia. Renzi proclama: «Fermiamo i delinquenti». Leggo anche un titolo sull’home page di Repubblica. Intima il direttore: «Politica, affari, illegalità. Renzi deve fare pulizia». Lodevole proposito, lodevole invito. Intanto Renzi dovrà esercitare, però, tutta sua arte retorica nell’impossibile tentativo di spiegare una contraddizione non componibile. In «profonda sintonia» con il delinquente principe, con il grande corruttore, si accinge, infatti, a cambiare aspetti strutturali del panorama istituzionale italiano. Una continuità evidente per metodo ed obiettivi con alcune delle logiche principali che hanno caratterizzato il ciclo aperto agli inizi degli anni Ottanta e rivelatosi con chiarezza in età berlusconiana.
Sul piano del metodo politico il periodo in questione rappresenta il livello estremo, quello più basso e degradato, del trionfo della «ragion cinica». Nel 1983 un filosofo tedesco, Peter Sloterdijk, ha scritto un importante libro di Critica della ragion cinica. La data non è casuale; sebbene la ragion cinica sia una costante anche della ragion politica, nel secondo dopoguerra cominciò a diventare elemento dominante di mistificazione in coincidenza con l’apertura dell’attuale ciclo di accumulazione. Sloterdijk ha argomentato con rigore il meccanismo tramite cui il cinismo dei mezzi giustificato con la nobiltà dei fini altro non sia che un mascheramento ideologico. Il cinismo dei mezzi ha come esito inevitabile il cinismo dei fini.
Se questa è politica…. potremmo chiederci parafrasando Primo Levi. Certamente questa è la politica, risponde in coro il consesso dei nuovi padri della patria. Dobbiamo augurarci che siano molti coloro che in questa patria non si riconoscono. Ed operare con un’altra politica per un’altra patria.
 Nella partita sul futuro dell'isola la palla passa alle Istituzioni. Commento e scheda dell'isola di Roberta de Rossi, cronaca dell'asta e presentazione dell'acquirente Luigi Brugnaro di Vera Mantegoli.
Nella partita sul futuro dell'isola la palla passa alle Istituzioni. Commento e scheda dell'isola di Roberta de Rossi, cronaca dell'asta e presentazione dell'acquirente Luigi Brugnaro di Vera Mantegoli.
La Nuova Venezia, 14 maggio 2014 con postilla
ABBANDONATA DA 46 ANNI C'ERA IL GERIATRICO
Roberta De Rossi
Tutti da decenni la vogliono, sinora l'ha avuta solo il degrado. La storia "recente" di abbandono di Poveglia ha inizio nel 1968, quando chiuse l'allora ospedale geriatrico: per anni lo Stato trattò con il Touring Club - che voleva farne un villaggio - trovando infine un partner nel Club Mediteranée, che evidentemente avrebbe spostato l'equilibrio verso quel turismo di lusso che è stato il marchio di gran parte delle conversioni delle isole della laguna. Nel 1985 si arrivò ad un'asta demaniale: Poveglia fu messa in vendita per appena 100 milioni di lire. Ma non se ne fece nulla. Nel 1997 sembrava cosa fatta: un progetto di turismo giovanile del Cts con la sponsorizzazione nientemeno che di Bill Gates. Restava da rispolverare il problema della cessione dal Demanio al Comune: un buco nell'acqua anche quella volta.
Sette ettari all' altezza di Malamocco, di Poveglia si hanno notizie storiche fin dall'anno 1000: l' isola - oggi pericolante negli immobili - ha un campanile del Cinquecento, numerosi edifici, alcune costruzioni rurali, due ville neogotiche, un patrimonio naturalistico prezioso (anche se vittima anch'esso del degrado): è stata la più importante stazione marittima sanitaria dell' Alto Adriatico e in seguito un ospedale geriatrico, fino all'abbandono nel 1968.
(Roberta De Rossi)
«Siamo di fronte alla crisi sistemica di un modello che, per poter proseguire, è necessitato ad aggredire i diritti sociali e del lavoro e ad impossessarsi dei beni comuni. Il Forum dei movimenti per l’acqua torna in piazza contro le politiche europee fondate su fiscal compact, pareggio di bilancio, svendita del patrimonio pubblico».
Il manifesto, 13 maggio 2014 (m.p.r.)
Tre anni fa, nel giugno 2011, la maggioranza assoluta del popolo italiano votò un referendum per dire che l’acqua e i beni comuni, essenziali alla vita delle persone e garanzia di diritti universali, dovevano essere sottratti alle regole del mercato e riconsegnati alla gestione partecipativa delle comunità locali. Si è trattato di una cesura storica contro la favola, da decenni imperante, del pensiero unico del mercato e della promessa di ricchezza prodotta dal suo libero dispiegarsi.
Venne allora decretata la fine del consenso all’ideologia del “privato è bello”, mentre la miriade di conflittualità sociali aperte sulla difesa dei beni comuni e dei territori suggerì la possibilità e l’urgenza di un altro modello sociale. Fu allora che, complice la crisi, artificialmente costruita attorno alla trappola del debito pubblico — in realtà una crisi del sistema bancario, scaricata sugli Stati e fatta pagare ai cittadini — venne proposto, con rinnovata forza e ferocia, il paradigma del “privato” che, anche se non più bello, va comunque accettato come “obbligatorio e ineluttabile”. L’obiettivo, tuttora in campo, è la consegna della società, della vita delle persone e della natura ai grandi capitali accumulatisi in trent’anni di speculazioni finanziarie, che, per uscire dal circolo vizioso di bolle che preparano altre bolle, necessitano di investimenti su asset nuovi e altamente profittevoli, beni comuni in primis.
Ed è esattamente nella facilitazione del raggiungimento di questo obiettivo che si colloca la strategia delle élite politico-finanziarie al comando dell’Unione europea e l’azione compulsiva del governo Renzi: privatizzazione di tutti i beni pubblici, siano essi patrimonio o servizi, deregolamentazione totale delle condizioni di lavoro, messa a valorizzazione finanziaria del territorio e della natura, piena libertà di movimento per i capitali finanziari e messa a disposizione degli stessi della ricchezza sociale e delle risorse a disposizione. In attesa che, con il Partenariato Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti (Ttip), in piena e segreta negoziazione fra Ue e Usa, si crei la più grande area di libero scambio del pianeta realizzando l’utopia delle multinazionali. Che tutto questo necessiti di una drastica riduzione della democrazia, appare evidente da diversi fattori di stretta attualità: le proposte di riforme istituzionali e di una nuova legge elettorale, tese all’azzeramento di ogni ruolo dell’attività parlamentare e al rafforzamento autoritario dei poteri degli esecutivi; l’attacco definitivo alla funzione pubblica e sociale degli enti locali, con l’obbligo, sotto la scure del patto di stabilità, della messa sul mercato di patrimonio, servizi e territorio; la repressione messa in campo contro i movimenti sociali, dalle assurde accuse di terrorismo per gli attivisti No Tav alla sconsiderata gestione dell’ordine pubblico nelle piazze di Roma e Torino.
Siamo di fronte alla crisi sistemica di un modello che, per poter proseguire, è necessitato ad aggredire i diritti sociali e del lavoro e ad impossessarsi dei beni comuni. Le conseguenze di questa perseveranza nelle politiche di austerità sono più che evidenti: un drammatico impoverimento di ampie fasce della popolazione, sottoposte a perdita del lavoro, del reddito, della possibilità di accesso ai servizi, ai danni ambientali e ai conseguenti impatti sulla salute, con preoccupanti segnali di diffusione di disperazione individuale e sociale.
Ma a tutto questo è giunto il momento di dire basta. In questi anni, dentro le conflittualità aperte in questo paese, sono maturate esperienze di lotta molteplici e variegate, tutte accomunate da un comune sentire: non vi sarà alcuna uscita dalla crisi che non passi attraverso una mobilitazione sociale diffusa per la riappropriazione sociale dei beni comuni, della gestione dei territori, della ricchezza sociale prodotta, di una nuova democrazia partecipativa. Sono esperienze che, mentre producono importantissime resistenze sui temi dell’acqua, dei beni comuni e della difesa del territorio, dell’autodeterminazione alimentare, del diritto all’istruzione, alla salute e all’abitare, del contrasto alla precarietà della vita e alla mercificazione della società, prefigurano la possibilità di una radicale inversione di rotta e la costruzione di un altro modello sociale e di democrazia.
Grazie ad una proposta avanzata dal Forum italiano dei movimenti per l’acqua, tutte queste esperienze si sono incontrate, si sono riconosciute e hanno giudicato maturo il tempo di prendere parola, per riaprire lo spazio pubblico della speranza e dell’alternativa, promuovendo tutte assieme una manifestazione nazionale a Roma per sabato 17 maggio. Un appuntamento collettivo — radicale nei contenuti, pacifico, colorato e partecipativo nelle pratiche — che chiama le donne e gli uomini di questo paese a dire, tutte e tutti assieme, come non vi sia alcuna uscita possibile dalla crisi, perseguendo le politiche di austerità dell’Unione europea e del governo Renzi, fatte di Fiscal Compact, patto di stabilità, pareggio di bilancio, svendita del patrimonio pubblico e dei territori, precarizzazione e privatizzazioni.
Una grande alleanza sociale dal basso, aperta e inclusiva, per riappropriarsi della possibilità di un futuro diverso, e per affermare come, tra la Borsa e la vita, abbiamo scelto la vita. Con l’allegria di chi vede l’orizzonte, con la determinazione di chi conosce l’insopportabilità del presente.
«Che cosa intendiamo per politiche tecnologiche e industriali? Sono le politiche che generano e stimolano innovazione tecnologica, che stimolano e favoriscono l'apprendimento e la produzione da parte di imprese private, e che creano e sostengono attività produttive pubbliche in settori e localizzazioni particolari. Oggi in Europa servono programmi pubblici finalizzati a precisi obiettivi tecnologici soprattutto nel campo dell'ambiente e della salute». Sbilanciamoci. infonewsletter n. 328, 12 maggio 2014 (m.p.r.)
Per una trentina d'anni, fino alla crisi del 2008, di politiche industriali e tecnologiche non si poteva parlare: erano brutte parole per tutta la gente per bene, inclusa la sinistra moderata e riformista, e non solo in Italia. Il mantra era – ed in buona parte è ancora – «la magìa del mercato», come la definì quel grande economista che era Ronald Reagan; una «magìa» che alimentava la retorica del «lasciar fare» e del «perché la politica dovrebbe saperne di più delle imprese?»
È il momento di spiegare invece che le politiche tecnologiche sono state cruciali, almeno dalla seconda guerra mondiale in poi, nella generazione della maggior parte delle innovazioni di cui oggi godiamo (o soffriamo) e che le politiche tecnologiche ed industriali sono sempre state cruciali nei processi di industrializzazione soprattutto nei paesi ritardatari – e si ricordi che due secoli fa anche Usa e Germania erano ritardatari rispetto all'Inghilterra.
Innanzi tutto, che cosa intendiamo per politiche tecnologiche e industriali? Ne voglio dare una definizione molto ampia: sono le politiche che generano e stimolano innovazione tecnologica, che stimolano e favoriscono l'apprendimento e la produzione da parte di imprese private, e che creano e sostengono attività produttive pubbliche in settori e localizzazioni particolari.
Partiamo dall'innovazione tecnologica. Come mostra il bel libro di Marianna Mazzucato Lo stato innovatore, di imminente pubblicazione per Laterza, senza le innovazioni generate nei grandi programmi pubblici di ricerca (come il Cern per la fisica) e nei programmi militari e spaziali oggi non avremmo internet, il microprocessore, il web, l'iPad e così via. Senza i grandi programmi pubblici del National Institute of Health negli Usa non avremmo nemmeno i (pochi) farmaci innovativi che le grandi imprese farmaceutiche ci offrono a carissimo prezzo. Come ironizzava il compianto Keith Pavitt, la leadership Usa è stata alimentata dalle paranoie americane del comunismo e del cancro.
Guardando al futuro, ciò di cui abbiamo bisogno oggi in Europa sono massicci programmi pubblici focalizzati, mission-oriented, cioè finalizzati a precisi obiettivi tecnologici – come nel passato sono stati mandare un uomo sulla luna o un grappolo di missili inter-continentali sull'Unione Sovietica – soprattutto nel campo delle tecnologie verdi e della sostenibilità ambientale, della medicina e della salute sociale più in generale. Invece buona parte del discorso politico mitologizza i garage degli Steve Jobs e Bill Gates senza considerare le fonti (pubbliche) della tecnologia che questi imprenditori hanno messo assieme. D'altro lato, invece, finanziamo mission altrui e pure fallimentari come i cacciabombardieri F-35 che, come sostiene un rapporto della Rand Corporation di qualche anno fa, «non combatte, non vira, non vola».
Perché servono anche politiche industriali ? La risposta è che in molte circostanze, specialmente nei paesi ritardatari – o in quelli, come l'Italia di oggi, che perdono terreno rispetto ai paesi più avanzati – le imprese private non hanno né le capacità organizzative, né gli incentivi di profitto per operare in aree magari molto promettenti dal punto di vista delle potenzialità innovative e di mercato, ma nelle quali esse hanno uno svantaggio comparato ed assoluto rispetto alla concorrenza internazionale.
Se due economie, una high tech e una dell'età della pietra, cominciano ad interagire, sicuramente gli operatori economici nella seconda avranno un incentivo a produrre e commerciare beni ad «alta intensità di pietre», ma la società nel suo complesso progredirebbe molto di più se si imparasse l'high tech, anche se si è meno efficienti dell'altro paese. Le politiche industriali comprendono tutte le misure appropriate all'accumulazione di conoscenze e capacità produttive nelle tecnologie più dinamiche e più promettenti. Alla fine dell'Ottocento si trattava della chimica e dell'elettromeccanica; oggi delle tecnologie dell'informazione, della bioingegneria, delle tecnologie ambientali. In effetti le politiche industriali sono state un ingrediente fondamentale nell'industrializzazione dagli Stati Uniti alla Germania, al Giappone, alla Corea, alla Cina (ne discutiamo in dettaglio nel volume curato da Cimoli, Dosi e Stiglitz, Industrial Policies and Development, Oxford, University Press). Incidentalmente gli Usa sono il paese che oggi ne pratica di più, senza parlarne.
Che cosa si fa oggi in Europa, e in particolare in Italia? Per lungo tempo, possiamo dire, sono state fatte politiche anti-industriali. È una storia antica, che comincia almeno dal rifiuto del governo italiano di sostenere lo sviluppo dei calcolatori Olivetti (quasi sicuramente su pressione americana) all'inizio degli anni sessanta. Continua con la dissennata politicizzazione e finanziarizzazione della Montedison, e poi la con la sua dissoluzione, che ha portato anche alla liquidazione di fatto di un piccolo gioiello nella farmaceutica come Farmitalia. Ha il momento cruciale nella liquidazione con "spezzatino" delle imprese a partecipazione statale, per ottenere nella crisi del 1993 entrate straordinarie: «pochi soldi, maledetti e subito». Con quale conseguenza? Una delle prime cose che hanno fatto i privati è stato chiudere le attività di ricerca e sviluppo (come in Telecom), o liquidare addirittura la produzione (come in Italtel). Tutto questo si è accompagnato per quasi un trentennio alla mitologia del "piccolo è bello", con il risultato di un quasi azzeramento della partecipazione italiana all'oligopolio internazionale della chimica, dell'acciaio, della farmaceutica, dell'elettronica, delle telecomunicazioni, del software e così via.
Che cosa fare? In Italia molte cose sono difficili da fare perché ormai i buoi sono scappati dalle stalle, ma è ancora possibile favorire l'emergere di attori tecnologicamente forti, italiani o quanto meno europei. E, per farlo, spesso è necessario l'intervento diretto dello Stato, per esempio via Cassa Depositi e Prestiti, che già un po' fa di queste cose, ma senza una strategia industriale seria, quasi con la paura di disturbare la "magìa" del mercato. Tante cose si possono fare a livello europeo, a condizione di abbandonare la frenesia mercatista. Un esempio recente per tutti: c'è qualcuno che crede che il governo americano starebbe a guardare se Alstom e Siemens si mettessero assieme e tentassero di acquisire General Electric, invece di quest'ultima che tenta di scalare Alstom?
Poi ci sono alcune cose che non bisogna assolutamente fare. Tra queste l'accordo di libero scambio transatlantico, che rappresenta essenzialmente una folle cessione di sovranità della politica, nazionale ed europea e l'assolutizzazione degli interessi degli investitori privati, indipendentemente dall'utilità sociale degli investimenti stessi.
 «Ci sentiamo dentro a un assurdo paradosso: dovremmo svenarci per poter comprare un bene demaniale, cioè statale, cioè nostro. I veneziani, quelli nati qui e quelli che lo sono diventati, adesso vogliono contare davvero». La
«Ci sentiamo dentro a un assurdo paradosso: dovremmo svenarci per poter comprare un bene demaniale, cioè statale, cioè nostro. I veneziani, quelli nati qui e quelli che lo sono diventati, adesso vogliono contare davvero». La
Repubblica, 13 maggio 2014 (m.p.r.)

«». Ecco le proposte concrete per uscire dalla crisi promuovendo il lavoro attraverso un forte intervento pubblico liberato dai "lacci e lacciuoli" del Mercato. Sbilanciamoci. info
La retorica dei governi insiste sulla ripresa. Ma la realtà dell'Europa è la stagnazione dei paesi «forti» e la depressione nella «periferia». Germania a parte, la crescita del Pil nel 2014 sarà sotto l'1% nei maggiori paesi dell'eurozona, l'Italia retrocessa allo 0,5%, la Grecia sempre sottozero.
Il senso di quello che sta succedendo ce lo dà l'industria: rispetto al 2008, l'Italia ha perso un quarto della produzione; Spagna, Grecia e Portogallo sono cadute ancora più in basso; gravi perdite si contano in Francia, Olanda, Finlandia e Irlanda. Questa distruzione di capacità produttiva in mezza Europa – il risvolto del successo tedesco – mette in discussione le fondamenta dell'integrazione europea più della crisi del debito o del salvataggio di qualche banca. Quale può essere l'interesse di un paese a «restare in Europa» quando le politiche europee cancellano un quarto delle fabbriche e dei posti di lavoro?
Se si vuole evitare questo deserto, è indispensabile un ritorno della politica industriale, che è stata essenziale nel novecento per la crescita dell'Europa e che trent'anni di neoliberismo hanno messo al bando in nome dell'efficienza del mercato. A mezza bocca l'ha capito anche Bruxelles, che parla di "Industrial Compact". In Francia il ministro Montebourg si sforza di limitare le delocalizzazioni e sostenere, con capitali pubblici e soci stranieri, imprese come la Peugeot. Ma le proposte più innovative pensano a una politica industriale a livello europeo, con risorse comuni investite soprattutto nei paesi in difficoltà. In questa direzione vanno le iniziative della Dgb, la confederazione sindacale tedesca e la versione un po' annacquata proposta dalla Confederazione europea dei sindacati.
Guarda più avanti la proposta di Sbilanciamoci! e EuroMemorandum di una ricostruzione della capacità produttiva a scala europea. Si potrebbe investire il 2% del Pil europeo per dieci anni in nuove produzioni – pubbliche e private – in tre settori prioritari: la conversione ecologica dell'economia, con abbattimento delle emissioni, energie rinnovabili e risparmio energetico; le tecnologie dell'informazione e le loro applicazioni; il sistema della salute, dell'assistenza e del welfare. Tre quarti degli investimenti potrebbero andare nella «periferia», il resto nelle regioni arretrate dei paesi del «centro». I fondi potrebbero venire dalla Bce, da Eurobond e dalla Bei, oppure da nuove entrate – una tassazione europea dei profitti, della ricchezza o delle transazioni finanziarie. A deliberare il piano il Parlamento europeo; a decidere su quali progetti spenderli un'Agenzia europea per gli investimenti dove non siedono banchieri, ma si raccolgono competenze economiche, organizzative, sociali e ambientali. A realizzare gli investimenti, imprese o soggetti pubblici locali, con uno stretto monitoraggio.
Un programma di questo tipo darebbe uno stimolo alla domanda e ci farebbe uscire dalla depressione. Porterebbe a nuove attività e posti di lavoro nei settori e nei luoghi «giusti». E ridarebbe un ruolo all'azione pubblica, rovesciando trent'anni di privatizzazioni che non hanno prodotto né sviluppo, né efficienza. Proprio qui sta il problema: si può davvero tornare a un forte intervento pubblico nell'economia? Fabrizio Barca, in queste pagine, sceglie ancora il mercato rispetto a una pubblica amministrazione incapace. Ma è sicuramente possibile avere un controllo democratico sulle scelte d'investimento senza regalare potere ai partiti. Organizzare lo sviluppo senza collusioni e corruzione. E, soprattutto, trovare una risposta più giusta alla domanda su che cosa produciamo, come, e per chi.

Probabilmente quello di ieri pomeriggio è stato il corteo Notav più massiccio di sempre, per dare un’idea i partecipanti sono stati almeno il doppio rispetto la recente manifestazione per il primo maggio. Torino ha dimostrato il suo sostegno morale e politico nei confronti dei quattro militanti incarcerati, lo ha fatto senza paura, nonostante un clima di intimidazione molto pesante che ha accompagnato i dimostranti, non meno di trentamila persone, lungo tutto il percorso. Alle due del pomeriggio, orario di concentramento in piazza Adriano la città appare deserta, avvolta in un coltre di paura data dalla scenografia da action movie, che prevede uno spiegamento di forze dell’ordine buono per i check point dell’Iraq ma non per la civile manifestazione annunciata. Così, circondati da un accampamento militare ambulante, i Notav hanno iniziato il loro cammino verso Piazza Castello, il cuore di Torino. Serrande abbassate, silenzio spettrale, vecchine affacciate dai balconi con facce sconvolte dalla paura ma incuriosite, ogni incrocio presidiato da carabinieri e polizia in assetto anti sommossa. Scudi alzati, caschi e manganelli.
Alle tre del pomeriggio la giornata per i Notav appare complicata perché Torino, medaglio d’oro per la Resistenza, si mostra nella sua faccia più gelida e indifferente. Apparentemente il corteo non sembra nemmeno troppo corposo ma, cammin facendo, la folla si ingrossa fino a diventare un fiume. La sfilata dei Notav davanti alla Stazione di Porta Susa, blindatissima oltre ogni buon senso, dura un’ora. Apre come al solito la banda della Val Susa e alcuni rappresentanti delle istituzioni locali; poi un fiume umano compatto, che va dai giovanissimi agli anzianissimi di ogni estrazione sociale. Ci sono accenti che testimoniano provenienze varie: romani, milanesi, veneti, napoletani. Ma soprattutto si è aggiunta una massa inattesa di torinesi. Un popolo che ha come unica rivendicazione il diritto al dissenso senza che questo debba essere trasformato, come sta accadendo nel caso dei quattro giovani incarcerati, nell’accusa di «attentato con finalità terroristiche». E, per tutto il pomeriggio, ad essere in secondo piamo è proprio il Tav, il cantiere, lo spreco di denaro, la ‘ndrangheta, gli appalti. L’unico pensiero dei manifestanti è rivolto alla libertà di dissenso messa sotto attacco.
Il fiume umano supera la stazione di Porta Susa e l’annessa caserma volante esposta in bella evidenza, e imbocca via Cernaia, la via dello shopping torinese. Qui si manifesta la chiave di volta di tutto il pomeriggio, perché i torinesi terrorizzati dai mezzi di comunicazione sull’arrivo delle orde barbariche si rendono conto che pericolo non c’è, e quindi la vita riprende normalmente. Negozi aperti, serrande rialzate, signore e signori a spasso che né solidarizzano, né si terrorizzano. Semplicemente vedono una manifestazione sì massiccia, ma normale. E fatta sorprendentemente da persone normali, nemmeno un terrorista. Una manifestazione come tante altre che in questi anni hanno costellato la vita del movimento.
Lo striscione portato dai ragazzi dei centro sociali di Torino recita: «Siamo tutti colpevoli di resistere. Libertà per i Notav». Un concetto ripreso da Nicoletta Dosio, tra le fondatrici del movimento oltre venti anni fa che dice: «Siamo qua per rivendicare il diritto al dissenso, alle libertà democratiche sono messe in crisi da un atteggiamento persecutorio verso chi prova a discostarsi dal pensiero unico. Oggi la nostra paura va ben al di là della costruzione del Tav, perché ci rendiamo conto che qualsiasi forma di diversità di pensiero potrebbe ricevere lo stesso trattamento riservato ai quattro ragazzi accusati di terrorismo».
Presente anche il magistrato Livio Pepino: «Una grande manifestazione che dimostra come il movimento Notav sia pacifico, di fronte a cui la militarizzazione della città è stata eccessiva. Un movimento che chiede dalle istituzioni un’apertura al dialogo. La risposta, purtroppo, continua ad essere la militarizzazione, come dimostra quanto accaduto oggi. Oggi abbiamo avuto una grande lezione di civiltà e capacità di stare insieme, che continua dimostrare quanto la repressione dura e pura non serva a nulla».
Atteso dagli organizzatori del Salone del Libro lo scrittore Erri de Luca ha preferito prendere parte al corteo dei Notav. Le sue parole: «Preferisco partecipare alla protesta in mezzo ai cittadini che solidarizzano verso quattro ragazzi accusati di terrorismo perché avrebbero incendiato un compressore». L’arrivo nella centrale piazza Castello ha quantificato la portata della manifestazione perché tutta la spianata è stata riempita, ed una notevole parte del corteo non è nemmeno riuscita ad entrare. La Questura ha quantificato tutto questo in duemila persone, poco più di una riunione di condominio ben riuscita.
Inspiegabilmente gli unici momenti di tensione si sono avuti durante i comizi conclusivi, quando una colonna di poliziotti in assetto anti sommossa si è avvicinata velocemente alla piazza ricolma di persone passando da una via laterale e fermandosi solo pochi metri prima di raggiungere il cuore della folla, che stava ascoltando pacificamente gli interventi. Alcuni momenti di tensione per la manovra apparentemente inspiegabile, e poi un ordine di dietrofront ha spento gli animi bollenti.
Ora, dopo il successo di questa manifestazione popolare, la palla passa allo Stato. Continuare ad usare la mano inflessibile della repressione o costruire un percorso comune che metta da parte ogni forma di estremismo.
Il monumentale tribunale vuoto, assolutamente vuoto, circondato dai blindati e dalle grate di ferro ancorate col cemento al suolo come la zona rossa di Genova nel 2001 - quasi lì dentro ci fosse l’oggetto del desiderio della folla che gli sfilava accanto -, è il simbolo dell’ottusità del potere. Della sua incapacità di capire e pensare, come accade, appunto, a ogni potere, quando perde la ragione del proprio agire, e resta appeso al proprio apparato della forza senza giustizia (che si rivela, appunto, violenza).
Guardando quella folla multicolore, che sfilava serena, a volto scoperto, davanti ai cordoni cupi, catafratti, chiusi dietro i propri scudi, che sigillavano il percorso con un muro nero blu e verde scuro (c’erano tutti i corpi dello Stato, carabinieri, polizia, guardia di finanza) era difficile immaginare come sui primi fosse possibile distendere l’ombra fosca del terrorismo e sui secondi appiccicare l’etichetta della legalità. Ai primi la violenza, agli altri la giustizia. Piuttosto, verrebbe da dire, il contrario.
Il Movimento No Tav ieri, come altre volte, ha vinto. Con una semplice marcia ha strappato di mano ai propri nemici ogni elemento di credibilità per sostenere l’assurda teoria – ma sarebbe meglio chiamarlo teorema – che tenta di riconfigurare le azioni di protesta di quella popolazione sotto il segno cruento dell’accusa di terrorismo. E nello stesso tempo ha mostrato l’isolamento, l’irragionevolezza, la povertà di argomenti di chi, per sostenere una causa razionalmente insostenibile, è costretto a ridurla a questione di ordine pubblico, in cui, come è noto, chi ha il manganello dalla parte del manico decide.
Da oggi, almeno qui, sull’asse che va da Piazza Castello alla Sagra di San Michele, quell’operazione si è infranta contro un materiale resistente e intelligente che sarà davvero difficile ignorare.
Le tre parole che hanno aperto la strada alla distruzione dello Stato: «secessione, federalismo, lotta contro la giustizia». il Rottamatore fiorentino è al colpo finale e proclama: "entrerò nella burocrazia (che è il corpo fisico dello Stato, ndr) con la ruspa”».
Il Fatto quotidiano, 11 maggio 2014
Ricordate la frase così spesso usata “non ti puoi fare giustizia da solo”? Sono poche parole che spiegano, anche se non c’è un costituzionalista in sala, che cosa è lo Stato. C’è una parola opposta e simmetrica: vendetta. Significa che qualunque gesto tu compia in proprio per far valere da solo un diritto negato o punire un’offesa, una ferita, un dolore deliberatamente inflitto, o presunta ingiustizia o la morte, stai violando il più sacro dei patti. Ti stai appropriando di un compito dello Stato. O meglio, neghi che lo Stato esista. E se non esiste, accetti il peso e il rischio di fare da solo. Per tanto tempo abbiamo detto che soltanto la malavita o un furore malato inducevano ad accamparsi fuori dello Stato e contro lo Stato.
Intanto, fin dall’inizio di questa potente rivoluzione strisciante di negazione dello Stato, si è formata una contrapposizione durissima al potere giudiziario. Una tale contrapposizione nega giudici, codici, autonomie e sentenze. Nega soprattutto l’indipendenza – inviolabile, nello Stato democratico – del sistema giudiziario e lavora alla sottomissione anche personale dei giudici. Ma una battaglia così estrema e così aperta non tanto al potere quanto al lavoro dei giudici e quindi alla loro esistenza, ha una sua causa che fa da perno a tutte le vicende e avventure dello Stato italiano: la corruzione.
DA MALE antico, come la tubercolosi, che costringeva a continue verifiche, la corruzione italiana si è trasformata in routine che sale dal basso degli infiniti “piccoli” abusi, considerati “necessari”. E piove dall’alto di immense vicende che diventano persino oggetto di ammirazione tanto sono grandi gli impossessamenti privati di parti della ricchezza comune. Come ci dimostrano eventi anche recentissimi in cui infatti da un lato ti meravigliano le dimensioni del furto, dall’altra ti annoia la ripetizione infinita, a un certo punto ti accorgi che la corruzione in Italia svuota lo Stato come una anemia profonda che toglie ogni difesa immunitaria.
Il Parlamento, che avrebbe potuto essere l’ultimo presidio di difesa dello Stato, ha ceduto su tutto alla volontà e ai capricci dei più svariati esecutivi, con leggi indecenti, con voti di fiducia ridicoli e con silenzi paurosi. E allora si è levato un vento furioso, detto “antipolitica” che vuole punire tutto, risalendo ai conti e alle responsabilità di questa e di ogni altra generazione politica. Entra in campo con furore e tensione la parola “vendetta”. Ma la vendetta, sia negli stadi sia in politica, non vuole tener conto dello Stato, non lo conosce e non lo riconosce. Nessuna obiezione a lasciarlo morire, da parte degli invasori di campo delle partite controllate in nome di interessi loschi, o in Parlamento, in nome di nuovi gruppi politici portatori, ci dicono, di un mondo nuovo e febbrile disposto ad amputare tutto pur di fare pulizia del prima, che è tutto corrotto.
INTANTO RENZI, titolare del nuovo esecutivo senza nostalgie e senza scrupoli, disprezza il Parlamento, immagina solo dipendenti obbedienti, e promette “entrerò nella burocrazia (che è il corpo fisico dello Stato, ndr) con la ruspa”. Uno dei corpi burocratici più esposti e più in vista del nostro vivere in comune, la polizia, viene spinto alla cieca contro gravi pericoli fisici che nessun politico ha voluto affrontare e trasformare in confronto politico. Questo corpo, lasciato solo, ha mostrato, alcune volte, la tendenza a vendicarsi su individui isolati che sono stati identificati (di nuovo, alla cieca) come il pericolo, e che vengono sacrificati a un dio della sicurezza, al fondo di un burrone di solitudine. Lo Stato, come una navicella spaziale frantumata, parla con voci incoerenti da punti diversi e scollegati dello spazio. Non è in grado di assicurare giustizia, di garantire equità, di provvedere ordinata continuità, di fabbricare lavoro. Ecco, noi siamo fermi qui, alla voce “corruzione”, alla voce “solitudine”, alla voce “vendetta”.