

«Una critica radicale al produttivismo e al consumismo che va alla radice del problema ambientale, un problema cche non si risolve nell'opposizione tra sopravvivenza della Natura e declino della civiltà». Ciò che ci sembra si stia comprendendo oggi, ieri era già stato scritto.
Leggere Ecologia e libertà (di Andrè Gorz può stupire. Sì, perché è difficile sospettare che un libro scritto da un utopista francese, comunista eterodosso, quarant'anni fa, sia in grado di regalarci delle riflessioni così profonde sul nostro futuro.
Certo, nell'introduzione a firma del curatore – Emanuele Leonardi, ricercatore dell'Università di Coimbra – viene sottolineato come il libro appaia datato su certe “previsioni” e prospettive. Gorz scrisse il libro nel 1977, nell'Europa divisa dalla cortina di ferro, ed il mondo era profondamente diverso da quello in cui viviamo oggi. È scontato che il testo in alcuni passaggi risenta profondamente dell'epoca in cui fu scritto.
Meno scontato è che il libro nei suoi cardini fondamentali sia ancora in grado di affrontare il nostro futuro, di suggerire risposte e avvertirci di rischi che sono d'attualità. Le città dove “l'intasamento dei trasporti [...] fa di 'tutti' quella pura quantità di umanità anonima che si oppone, per la sua stessa densità, all'avanzamento e al comfort di ciascuno” (p. 74), sono le stesse che viviamo oggi, caratterizzate da quell'isolamento rancoroso che porta ai ghetti e alle gated communities.
Del resto l'attualità del ragionamento di Gorz si può misurare anche nella capacità di cogliere la questione ambientale come nucleo centrale di una politica autenticamente di sinistra, come di nuovo suggerisce Leonardi.
L'ecologia, in sé e per sé, non è in grado di dare risposte definitive. La soluzione ai problemi di sostenibilità ambientale non è per forza emancipativa: il rischio è quello di un ecofascismo, di una soluzione autoritaria ai problemi ambientali – centralizzata e in sostanza incapace di superare il problema che si propone di affrontare. L'ecologia politica di Gorz non ha nulla dei tecnicismi apparentemente neutri della green economy e dello sviluppo sostenibile. Al contrario, è un anticapitalismo che contesta il produttivismo alla radice, travolgendo nella critica anche la razionalità industriale real-socialista dei capitalismi di Stato sovietici. Nemmeno il welfare state keyenesiano viene risparmiato, laddove “servizi mercificati [...] svolgono funzioni un tempo appannaggio della zia, dei nonni o dei vicini” (p. 74).
Sono considerazioni importanti, soprattutto dal punto di vista odierno, dove il tempo del lavoro e quello del consumo comprimono le nostre vite fino a reificare anche le relazioni di prossimità, i legami famigliari. E Gorz non è certo un conservatore nostalgico, non fa un peana della civiltà rurale tradizionale, ben conscio che anche questa lode è funzionale al mantenimento dello status quo.
Ecologia e libertà stupisce proprio perché propone una critica radicale al produttivismo e al consumismo e va alla radice del problema ambientale, un problema complesso che non si risolve nell'opposizione tra sopravvivenza della Natura e declino della civiltà. Al contrario, Gorz pone il tema ambientale nella trama dei conflitti sociali, come contraddizione centrale nel nostro mondo. E cerca coraggiosamente la risposta nel domani e non nel passato.
Una boccata d'aria fresca rispetto ad un dibattito politico incentrato sulle sfumature della governance, dove al cittadino si sostituisce un cliente che ha diritto di scegliere l'offerta politica che più gradisce, quasi un tifoso a cui è concesso di gridare il proprio sdegno o la propria gioia, ma che non può in alcun modo discutere le regole.
Gorz è estraneo a questa nuova visione della politica e della società e nel suo libro si pone esplicitamente il problema dell'alternativa al capitalismo consumista. E le risposte non sono i comodi modelli storici del movimento operaio, ma sono strade nuove e a tutt'oggi non battute. Produrre meno cose, di migliore qualità, con materiali rinnovabili e azzerando gli sprechi, in una prospettiva di controllo produttivo decentralizzato per permettere un controllo diretto delle piccole comunità. Insomma elementi di dibattito attuale sulla crisi ecologica che comincia a manifestarsi con coloriture sempre più drammatiche.
Il libro è chiaro, conciso, parla un linguaggio lineare, vuole far arrivare il messaggio non solo agli specialisti della materia, ma anche a quei cittadini che dovranno ben guardarsi dallo spettro del tecnofascismo, ossia la decrescita produttiva e di consumi senza che sia messa in discussione la struttura industriale e gestita da una élite di tecnocrati e burocrati che impongono scelte e decisioni, spesso gravide di conseguenze, ad una popolazione passiva. Un percorso che Gorz vedeva già intrapreso per metà mentre scriveva Ecologia e libertà. Quanta strada abbiamo percorso in questa direzione negli ultimi quarant'anni?
Le soluzioni proposte nel libro hanno un retrogusto ingenuo; forse, ancor più di fronte al cinismo rassegnato che imperversa oggi, fanno quasi sorridere. Eppure fanno riflettere sull'utopia speculare – (neo)liberale – che il libro contrasta fieramente, l'idea cioè di poter continuare a produrre, crescere, e “svilupparsi” all'infinito, senza porsi alcun problema e considerando normale e inevitabile la distruzione della vita in nome del profitto. Anzi, arrivando a considerare la natura, la vita, come un ostacolo.
E allora il monito di Gorz perde l'aura naive e diventa una chiamata alle armi: Convivialità o Tecnofascismo.
Una critica saggia a un libro (Franco La Cecla, Contro l’urbanistica, Einaudi) ricco di spunti acuti ma scritto per scandalizzare il lettore. Felicità futura, blog, 9 ottobre 2015, con postilla
Franco La Cecla è un viaggiatore instancabile, un osservatore attento e ricco di una “sapere nomade”, che forte di una sua “ideologia”, lui lo negherà, passa a setaccio gli argomenti che di volta in volta affronta, oggi tocca all'urbanistica, o per meglio dire a quella che egli crede sia l’urbanistica (nell'argomentazione, ed è un aspetto apprezzabile, la sua tentazione è scandalizzare). Questo insieme di virtù e di difetti fa si che i suoi testi sono interessanti anche se irritanti, e che spesso la sua vis polemica lo porta a sbandare.
Per quello che conta, sono d’accordo con lui che la città è le persone che ci vivono (i “corpi” cari all'autore), infatti gli urbanisti insegnano che fare urbanistica significa occuparsi delle uomini e donne che in una città o in un territorio vivono.
Sono ancora d’accordo che spesso i “cittadini”, soprattutto se giovani, riescono a mutare il segno e il senso di alcuni spazi codificati. E se il concetto di “non luogo” all'autore non piace, e sono anch'io della partita, e quindi gli pare importante il caso del “non luogo” paradigmatico, come un grande parcheggio, che viene nella notte quando deserto da automobili, densificato di musica, di relazioni, di amori, di bevute. Una appropriazione che modifica il senso di quel luogo. Come anche l’occupazione politica di spazi che produco reazione.
Ma se fosse così perché allora non guardare con lo stesso spirito i “centri commerciali”, che occupati da uomini e donne diventano luoghi di socialità, dove i bambini corrono, spesso in monopattino, lungo le “vie”, dove gruppi di famiglie si riuniscono, dove gruppi di giovani si danno appuntamento provenendo da parti tra di loro molto lontani del territorio o della città?
So l’obiezione: per i primi si tratta di una manifestazione di libertà, di una scelta non condizionata, mentre nei secondi il condizionamento è forte. Se i comportamenti di uomini e donne danno senso allo spazio questo deve valere sempre e in ogni caso non possiamo distinguere libertà e condizionamento, anche perché forme diverse di condizionamento sono presenti sempre. Non penseremo che i giovani che danno senso ad un parcheggio nella notte, con la loro presenza e musica, non siano condizionati a sentire una certa musica, a bere una certa bevanda, a fumare una certa erba, a tatuarsi non come rito di appartenenza ma per moda, perché è bello, in una processo di massificazione in cui ogni deviazione (i calzoni stracciati, gli scarponi, ecc.) diventano “comuni” e banali.
I comportamenti non possono essere solo osservati, classificati, descritti, ma anche interpretati. Ora mi pare che il modello interpretativo di La Cecla sia un pensiero anarchico che definirei ingenuo. La strada è la vita.
Del resto se fermiamo l’attenzione sulla questione delle periferie questo è molto evidente. Cito testualmente: “Le periferie sono il pensiero sbagliato di un’urbanistica che ha mitizzato la condizione operai e le ha negato però il centro della città. Queste roccaforti del sonno operaio sono diventate da subito l’incubo delle classi «subalterne» e oggi degli immigrati. Il loro carattere sbagliato non è formale, non c’entra nulla la dimensione del disegno la qualità degli edifici. C’entra l’errore concettuale del pensare che esistere una cosa come le periferie”.
Mi pare che l’autore rifiuti di considerare i processi, che gli sono ben noti, che hanno investito le città e della meccanica proprio della realizzazione della città. Affermare che sia stata l’urbanistica a negare ai ceti subalterni il centro della città, non può che essere considerata la tentazione dello scandalizzare. Sono sicuro che l’autore ha sentito parlare della rendita e del mercato. Non avere nel nostro paese voluta eliminare la rendita (un ministro che in parte ci ha tentato, Fiorentino Sullo, ci ha rimesso carriera politica e non solo), l’avere affidato il problema della casa e dell’abitare al mercato ha come conseguenza che quest’ultimo ha messo ciascuno la “posto giusto”, al posto che gli toccava in relazione alla propria capacità di pagare. Ma forse c’è anche altro.
La Cecla irride ad ogni interpretazione economica del processo urbano (il marxismo, vecchio e neo è inviso all’autore), eppure se non si va alla radice dei fenomeni economici e sociali della nostra società non solo non si comprende l’evoluzione della condizione urbana ma si rischia, come direbbe mia nonna, di pestare l’acqua nel mortaio.
Non c’è da meravigliarsi che negli slums si faccia società, che si costituisca una regolamentazione locale, che si faccia anche “economia” (informale e marginale, che questa possa essere il modello, non credo, per la verità non lo crede neanche La Cecla): fa parte dell’animus degli uomini e donne di fare società, ma non possiamo tralasciare quali siano state le cause della creazione degli slum, come delle periferie, e accontentarci del fatto che li si fa società dimenticando (La Cecla non lo fa) le condizioni in cui si fa società.
La città è un organismo sociale (questo insegnano la maggior parte degli urbanisti) ed esso va governato (termine che credo l’autore abborrisce), ma tale governo è una funzione politica che fa bene o male i conti con gli interessi esistenti, con le esigenze di corpi separati (vedi per esempio la funzione di polizia), con i desideri degli abitanti, con i loro comportamenti, con i conflitti (salutari) che possono manifestarsi. Il meccanismo economico-sociale, con le sue diseguaglianze, con le sue discriminazioni, con le sue violenze esercita una forte influenza sia sui processi che sul governo. Gli urbanisti, almeno quelli che conosco, non usando lo stesso linguaggio (ma la sostanza è la stessa) spiegano che l’urbanistica non può cambiare il meccanismo economico-sociale (non esiste una via urbanistica al socialismo, anche libertario), ma esiste un lavoro che cerchi di favorire la vita egli abitanti di un luogo, con particolare attenzione a chi è risultato più svantaggiato.
L’urbanistica ha che fare con donne e uomini, non solo con cifre e statistiche. Perché contrapporre la strada, l’andare per strada, alle statistiche, le quali se interrogati nel modo giusto dicono tante cose (i numeri parlano). Ma come non posso accontentarmi di come i “corpi” reagiscono ai cambiamenti, non posso essere indifferente a come il meccanismo economico-sociale marginalizza e segrega, anche se lì si fa società, anche se è il cibo di strada da l’impressione di condivisione e di apertura. Non sempre ci si riesce, l’urbanistica è spesso “sconfitta”, più che fallire, ma governare le trasformazione, nell'ambito dell’organizzazione della città, resta un compito gravoso e urgente.
Nonostante i precedenti appunti il libro di Franco La Cecla è interessante, e non solo nella parte in cui descrive singole città o condizioni urbane (ogni capitolo è dedicato ad un aspetto della contestata urbanistica ed è completato, per fare capire meglio al lettore l’assunto e la realtà, da una descrizione di una città o di un luogo visitato) ma anche nella parte più critica. Da ogni critica si apprende.
La lettura può essere irritante, ma i testi dei singoli capitoli sono ricchi di osservazioni spesso acute. Basta riferirsi ad alcuni titoli dei singoli capitoli per aver chiaro l’intenzione dell’autore: Che cosa c’è di sbagliato nell'urbanistica; Perché l’urbanistica non serve a capire la città; Perché l’urbanistica è in ritardo; ecc.
E’ un libro che mi sento di raccomandare ai colleghi urbanistica, la provocazione non può che essere salutare, spero solo che il lettore non specialista non si facci una idea sbagliata dell’urbanista.
postilla
A differenza di Indovina credo che moltissimi condividano l'idea dell'autore del libro che l'urbanista (e la sua disciplina) sia il protagonista della costruzione della città. A molti, troppi, sfugge che, come diceva Benevolo, "l'urbanistica è una parte della politica" e che, come ha detto Indovina, il piano urbanistico è "una scelta politica tecnicamente assistita. Si potranno dare mille colpe all'urbanista: di non aver potuto o saputo guidare correttamente il decisore, di non essersi adoperato abbastanza per far entrare nel novero dei decisori gli abitanti della città, di essersi messo troppe volte (soprattutto negli ultimi decenni) al servizio di chi stava costruendo la "città della rendita" e non quella dei cittadini. Ma parlare della città dimenticando che essa è il risultato di processi molto complessi, e non del sogno di un demiurgo mi sembra un errore grave per un intellettuale, e soprattutto per un antropologo.
Dove invece concordo più con La Cecla che col suo recensore è nel giudizio negativo sui "non luoghi". Uno spazio nel quale l'accesso sia limitato solo a chi sta viaggiando, o a chi può spendere, o a chi non indossa magliette criticabili dal senso comune mi sembra contraddire il principio che "la città è bella se è equa": e ciò vale a maggior ragione per lo spazio pubblico.
«Esperienze esemplari e ripetibili di trasformazione nei modi di produzione e nelle relazioni all’interno degli spazi in cui si svolge la vita delle comunità». Un nuovo libro liberamente disponibile di Luca Martinelli
Dall'inedita convivenza con animali strappati al classico ruolo di produttori di alimenti e servizi alle persone, alle produzioni agricole sostenibili e integrate al territorio, per il mercato ma secondo criteri innovativi e a mille miglia dalla logica agroindustriale, alle evoluzioni di pubblica utilità e legittimazione del classico guerrilla gardening conflittuale e molto altro, il mosaico pencola però pericolosamente nel vuoto. Non tanto per l’assenza di una visione complessiva, che c’è ed è pure evidente, ma quando ribadisce l’alterità rispetto allo stato attuale delle cose, quando afferma (come nell’intervista al vegano coerente a p. 14: «Abbiamo fatto una scelta anti-economica, dettata da una spinta etica». L’ex ministro Tremonti, a gran parte del mondo insieme a lui, qui potrebbe sibilare con qualche fondamento che «la spinta etica non si mangia». E infatti ogni pagina di questi spaccati biografici e di esperienze sottende la ricerca di sostegni esterni, prive come sono le esperienze di qualsiasi autosufficienza diversa da quella culturale ed etica.
Con aspetti anche vagamente surreali, come quando l’istituzionalizzazione del guerrilla gardening si scontra giusto all’interno dell’istituzione con altre più correnti strategie di classica città giardino, ovvero dove al massimo si persegue un ragionevole rapporto fra spazi aperti verdi e edificazione, ovvero valori immobiliari e ciò che ne consente e favorisce un portato sociale e collettivo. Fine del laboratorio-museo-parco eccetera? Probabilmente, e auspicabilmente, no, sempre che gli appoggi esterni istituzionali credano nelle potenzialità di questo tipo di esperienze etico-antieconomiche (almeno nella logica attuale), e invece di mirare ad assimilarle sappiano promuoverne lo spirito sperimentale e innovativo. Come quando uno degli intervistati osserva, raccontando la vita degli animali liberati dal giogo dell’utilitarismo spinto: «Nessuna facoltà di veterinaria si è mai occupata di studiare gli effetti degenerativi della vecchiaia sugli animali, si occupano solo del loro utilizzo». Cosa possono darci, in termini di conoscenze e contributi anche attivi al progresso, questi cugini vicini e lontani? Tutto da capire ancora, ma si intuisce quanto ricche possano essere le prospettive.
Luca Martinelli, Riconversione: (ri)facciamo la pace, Altreconomia-Associazione Sabrina Sganga (pdf liberamente scaricabile) 2015
Giorgio Nebbia, La contestazione ecologica. Storia, cronache e narrazioni, a cura di Nicola Capone, Napoli, La scuola di Pitagora, 2015, € 13
Grazie ai tipi della casa editrice La scuola di Pitagora la Società di Studi Politici di Napoli ha avviato la pubblicazione di due eleganti collane di “piccoli classici” dell’ambientalismo: “Pan-Paesaggio ambiente e natura” e “Qua.Ed.Am-Quaderni di educazione ambientale”.
La riedizione di questi due ultimi saggi, parallela peraltro alla pubblicazione di una più ampia antologia di scritti storici in forma digitale già segnalata su eddyburg”, è un’operazione meritoria e soprattutto utile. Si tratta in effetti di testi importanti nonostante la loro circolazione, al pari di alcuni altri scritti impegnativi di Nebbia, non sia stata all’altezza dei loro meriti.
Uno loro pregi principali è anzitutto la precocità, in quanto alla metà degli anni Novanta il panorama italiano di testi dedicati alla storia dell’ambientalismo era desolante. Nonostante tale filone di ricerca fosse ormai non solo consolidato ma addirittura istituzionalizzato sin dagli anni Sessanta negli Stati Uniti e dagli anni Settanta in Germania, nel 1994 in Italia si poteva contare solo qualche pionieristico saggio sull’attività protezionistica della Società Botanica Italiana di Franco Pedrotti e una buona storia di Pro Natura di Walter Giuliano mentre era in via di pubblicazione la bella tesi di Edgar Meyer sull’associazionismo italiano del secondo dopoguerra fino al 1970 (entrambe queste opere erano peraltro prefate proprio da Nebbia).
Rispetto a quanto era già uscito fino a quel momento nel nostro paese i due testi si segnalavano inoltre per ambiziosità, in due sensi.
Essi tentavano anzitutto di fornire una panoramica esaustiva (nel tempo, nello spazio e nelle tematiche) della contestazione ecologica e dei possibili oggetti della storia ambientale. Alla loro base stava infatti il desiderio di fornire un affresco quanto più completo e chiaro possibile. In secondo luogo, questo ampio sforzo descrittivo si appoggiava su un indispensabile lavoro tassonomico e teorico: un censimento, cioè, delle varie forme prese storicamente dalla contestazione ecologica nella storia e una ricognizione preliminare dei vari possibili oggetti della storia ambientale. Vista la solitudine in cui si muoveva Nebbia in Italia all’epoca ciò può apparire a prima vista straordinario, ma a uno sguardo più ravvicinato la cosa sorprende meno perché si era trattato in sostanza di mettere in ordine i tanti tasselli di una riflessione sui vari aspetti della storia dell’ambiente e dell’ambientalismo che era iniziata una trentina di anni prima ed era andata avanti alacremente nel mezzo di un intenso lavoro teorico, politico e giornalistico.
I due scritti si segnalano infine per originalità. Come per tutte le discipline quando noi parliamo di storia ambientale parliamo anzitutto di un canone: i libri che hanno impresso una direzione e uno stile alla disciplina, le tematiche, il linguaggio, gli approcci metodologici, contenuti e toni del dibattito mainstream. Alla fine degli anni Ottanta, quando Nebbia ha cominciato ad abbozzare questi due saggi, un canone del genere esisteva già a livello mondiale, in larga parte dominato dagli studiosi e dalle studiose statunitensi. Come la maggior parte di coloro che si sono occupati sino a tempi recenti di storia ambientale in Italia Nebbia non era uno storico, sapeva poco di quel canone e soprattutto aveva interesse a fare un discorso suo, coerente con certe premesse culturali e politiche ed efficace nei confronti di un pubblico di militanti e di opinione pubblica colta, non certo nei confronti dei colleghi italiani o stranieri appartenenti a uno specifico ambito disciplinare. Queste circostanze hanno contribuito a generare due testi che facevano un ampio uso di un’aggiornata bibliografia internazionale in larga parte sconosciuta in Italia ma la utilizzavano in maniera estremamente libera e creativa, incanalandola in un ragionamento poco accademico e molto politico. Mi viene da pensare che se mettessimo una laureanda o un laureando di oggi con un impeccabile bagaglio di letture di storia ambientale a confronto con questi testi essi rimarrebbero al tempo stesso disorientati e affascinati da una scrittura al contempo così ambiziosa e documentata e così fuori squadro rispetto al canone storiografico corrente (aggiungo peraltro che se insegnassi in un corso universitario di storia ambientale, ma anche in una scuola superiore, non esiterei ad adottarli come testi di primo orientamento).
Questa originalità si manifesta già nella terminologia scelta da Nebbia. Faccio un esempio che mi consentirà di focalizzare il mio intervento su un tema già trattato da Marco Armiero nell’introduzione.
A pochi sarebbe infatti venuto in mente a metà anni Novanta, e ad ancor meno verrebbe oggi, di utilizzare un’espressione come “contestazione ecologica”. Il termine “contestazione” appartiene infatti a un periodo ben circoscritto della storia recente, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, e si riferisce al tempo stesso a un insieme di movimenti sociali specifici (soprattutto studenteschi) e a un atteggiamento di rifiuto non solo politico ma anche e forse soprattutto culturale degli assetti di potere esistenti. La scelta di questa espressione è stata però quasi certamente consapevole ed è anzi a mio avviso molto felice in quanto definisce in modo preciso la scelta analitica di Nebbia.
Ciò che infatti Nebbia pone a oggetto della propria analisi è proprio una sequela storica di movimenti sociali che condividono una critica radicale ai guasti e all’ingiustizia di un assetto di potere specifico: quello del capitalismo industriale e finanziario. L’ambientalismo, e ancor prima la scienza ecologica che lo sottende (e Giorgio non ha mai smesso di sottolinearlo, come si vede bene dall’intervista di Sergio Messina che accompagna il testo), sono infatti intrinsecamente eversivi in quanto un’economia e una società realmente rispettosi degli equilibri ambientali non sono possibili rimanendo all’interno del ciclo denaro-merce-denaro, cioè della logica capitalistica globalmente dominante la cui unica finalità è un profitto che per definizione non conosce limiti. Non solo quindi i movimenti ambientalisti ma la logica stessa che sottende il sapere ecologico sono strutturalmente in contraddizione con il modo di produzione capitalista, e a maggior ragione con la sua attuale forma industriale avanzata, finanziarizzata e globalizzata.
Qui sta a mio avviso uno dei motivi che non solo non fa invecchiare questi testi pubblicati vent’anni fa ma al contrario li rende sempre più attuali. È vero infatti che progressivo trionfo del capitalismo - oggi sempre più finanziarizzato, sempre più globale e sempre più pervasivo anche della sfera politico-istituzionale - rende ancor più che in passato trasparente il fatto che l’unica logica che sottintende l’economia mondiale è la valorizzazione del capitale. Il che per l’ambiente costituisce una pessima notizia.
E questo è anche il motivo per cui l’ambientalismo, talvolta anche quello più rotondo e programmaticamente inoffensivo, è per lo più visto con sospetto e spesso aspramente combattuto dalla cultura e dalla politica mainstream.
Nebbia tutto questo lo sa bene, lo ha sperimentato in prima persona sin dai primi anni Settanta e non ha mai mancato di sottolinearlo, di studiarlo e di domandare che fosse studiato. Questo corpo a corpo (Nebbia lo ricorda anche nell’intervista a Sergio Messina) è stato risolto in genere con successo dall’establishment capitalista che è riuscito volta a volta a silenziare la contestazione ecologica oppure a far propri in modo solo apparente alcuni suoi obiettivi per depotenziarli e aggirarne così le eventuali conseguenze. È questa tutta la ricca e complessa storia di fenomeni come il negazionismo ambientale, il greenwashing, le tecniche di disinquinamento utilizzate come business che non impedisce il mantenimento delle stesse tecnologie inquinanti, l’uso strumentale e distorto o semplicemente propagandistico dei processi produttivi “sostenibili” che informa tra l’altro una parte cospicua dell’attuale “green economy”. Trattandosi dell’altra faccia della contestazione ecologica questa è una storia che Nebbia ha sempre cercato (coerentemente e pressoché in solitudine in Italia) di esplorare e che ha sempre invitato in modo pressante a esplorare, finora con scarso successo.
Partendo proprio da qui, cioè da questo continuo stimolo di Nebbia verso lo studio della storia dell’ambientalismo e dell’ambiente e dai risultati tutto sommati un po’ magri di questo sforzo, veniamo a un secondo punto: quello riguardante lo stato della storia ambientale in Italia.
Nebbia, come si è visto, fa parte di un ristretto manipolo di studiosi che hanno praticamente inventato la storia dell’ambientalismo in Italia senza esserne pressoché consapevoli in quanto non erano mossi da un interesse accademico-disciplinare e che hanno in seguito continuato a studiare, a scrivere e a pubblicare spinti essenzialmente da moventi politici e civili. È questa la storia di Nebbia, di Franco Pedrotti, di Valter Giuliano, di Edgar Meyer e di altri, ed è vero più in generale che tutte e tutti coloro che fanno ricerca nel campo della storia ambientale e dell’ambientalismo in Italia o fanno mestieri non accademici oppure insegnano discipline diverse: chi storia economica, chi storia contemporanea, chi botanica, chi merceologia, eccetera. Come se ciò non bastasse bisogna riconoscere che alcune delle persone che hanno provato con maggiore impegno e serietà a costruire una carriera accademica nel campo della storia ambientale alla fine hanno dovuto andar via dall’Italia.
Poco male, si potrebbe dire. Ma non è proprio così.
È vero infatti che non è necessario stare in cattedra in un preciso ambito disciplinare per scrivere cose buone in quell’ambito, e quanto ho detto finora credo lo dimostri, ed è anche vero che non basta stare in cattedra in un preciso ambito disciplinare per scrivere cose attendibili e solide. E tuttavia il fatto che non si sia riusciti a mettere efficacemente in rete tutte queste esperienze, a farle riconoscere reciprocamente, a farle fruttificare in modo più ampio, a trovare dei punti di coagulo che fossero riviste, cattedre o associazioni è stato dannoso, ha indebolito tutti: gli storici ambientali in quanto tali, gli studi sull’ambiente e sull’ambientalismo e quindi anche il loro possibile ruolo di ispiratori e di stimolatori del movimento ambientalista.
Certo, questo non può sorprendere in un paese in cui la presa della sensibilità e della cultura ambientale si è rivelata col tempo più superficiale che altrove, peraltro con un forte effetto retroattivo: ambientalismo debole > studi deboli e studi deboli > ambientalismo debole. Ma ci sono state anche responsabilità di tutti noi e potrei fare un malinconico elenco di fallimenti dovuti a scarsa visionarietà, a scarso dinamismo, a scarsa elasticità mentale, a un’attenzione eccessiva al proprio piccolo orto individuale o di gruppo: insomma a scarsa generosità.
Ma proprio a quest’ultimo proposito va precisato che Nebbia ha costituito sempre e continua a costituire un’eccezione, o una delle pochissime eccezioni: instancabile nello studio e nella scrittura, generoso e protettivo verso i giovani, stimolatore e promotore continuo di nuovi cantieri, disinteressato. Se dovessi indicare dove può stare il futuro degli studi di storia dell’ambiente e dell’ambiente in Italia lo indicherei proprio nell’esempio che continua a dare il suo esponente anagraficamente più anziano.
Ma, sempre per rimanere al “che fare”, io vedo anche come inaggirabile il tentativo, enunciato da Nicola Capone nell’introduzione al libro, di stimolare attivamente una convergenza delle culture protezioniste italiana di ispirazione paesaggista, ambientalista e di giustizia ambientale. Ciascuna di queste culture ha in Italia una sua storia (quale lunga, quale breve), un suo seguito (quale piccolo quale grande), un suo linguaggio e suoi obiettivi specifici, anche molto diversi tra loro, ma tutte hanno punti in comune e comuni avversari. Secondo me è quindi corretto pensare che dalla lunga crisi dell’ambientalismo italiano si può uscire soprattutto se queste ispirazioni e queste energie riescono a trovare la volontà e i mezzi per fare massa critica. Alcune condizioni perché ciò avvenga ci sono già oggi come ci sono già alcuni utili e intelligenti luoghi di aggregazione (penso, per fare un esempio che ho molto caro, al sito “eddyburg”) ma bisogna fare molto di più e ogni contributo ben intenzionato e ben impostato, anche se di nicchia, è assolutamente prezioso.
E la riedizione di questi due saggi di Nebbia, vecchi solo anagraficamente, arricchiti dalle introduzioni di Marco Armiero e di Nicola Capone e dall’intervista curata da Sergio Messina, è senz’altro un contributo di questo tipo.
Giorgio Nebbia, La contestazione ecologica. Storia, cronache e narrazioni, a cura di Nicola Capone, Napoli, La scuola di Pitagora, 2015, € 13
Rimpianto per l'epoca della ricostruzione, quando pareva ancora possibile che l'urbanistica si inserisse in un progetto sociale e politico più ampio per lo sviluppo del paese. Corriere della Sera, 25 febbraio 2015
Se Matera è stata scelta come capitale europea della Cultura per il 2019 lo deve ad Adriano Olivetti e alla pattuglia di intellettuali e professionisti che negli anni Cinquanta lo accompagnò nella realizzazione di un’apparente utopia: fare di Matera, la città considerata «la capitale dell’Italia contadina», un’altra Ivrea. Replicare, nel Mezzogiorno d’Italia, ma senza colonialismi né forzature, ciò che era avvenuto nel Canavese di Olivetti, cioè creare una «comunità di persone» che lavorano e vivono in armonia tra loro e con l’ambiente che li circonda, perché «ricostruite» anche moralmente ed «educate a pensare».
Era da poco finita la guerra, l’Italia viveva degli aiuti americani del Piano Marshall e negli Stati Uniti era esplosa la curiosità di conoscere il nostro Sud e, in particolare, le due facce di quella città, Matera, raccontata da Carlo Levi in Cristo si è fermato a Eboli come un unicum trogloditico (i Sassi) abbandonato alla miseria e all’arretratezza, ma anche come «una città bellissima, pittoresca e impressionante».
Olivetti era amico di Levi e durante i suoi viaggi negli Usa si rende conto dell’interesse suscitato anche lì dai temi di quel libro, che per lui erano stati illuminanti. Così nel 1947, diventato commissario dell’Unrra-Casas (l’organismo delle Nazioni Unite per la ricostruzione dei Paesi danneggiati dalla guerra e per il soccorso ai senzatetto), e poi nel 1950 presidente dell’Inu (l’Istituto nazionale di urbanistica), Olivetti «recluta» un giovane professore americano dell’Arkansas, Friedrich Friedmann, e gli affida la direzione di una commissione di studio sui Sassi. Nello stesso tempo, chiede a un gruppo di urbanisti, architetti e sociologi guidati da Ludovico Quaroni di progettare, alle porte di Matera, un villaggio modello che si chiamerà La Martella («l’altra Ivrea»), in cui sarebbero andati ad abitare una parte dei 16 mila contadini stipati nelle 3 mila grotte dei Sassi. Risanare i Sassi, dunque, per non abbandonarli al degrado. Ma dimezzarne la popolazione — costretta a vivere insieme con le bestie e a morire di malaria — trasferendo l’altra metà, assegnataria di terre coltivabili grazie alla Riforma agraria, a La Martella, dove avrebbe abitato case degne e ritrovato la dimensione comunitaria dei Sassi senza patirne i guasti.
Questa formidabile avventura, cominciata nel 1950, l’anno in cui Olivetti lancia la macchina per scrivere Lettera 22, è raccontata in un libro altrettanto formidabile, Matera e Adriano Olivetti. Conversazioni con Albino e Leonardo Sacco, di Federico Bilò e Ettore Vadini (edito dalla Fondazione Olivetti, pp. 278). Il volume è arricchito da una conversazione inedita tra la figlia di Adriano, Laura, e Friedmann, il quale, per far capire bene chi era e come ragionava Olivetti, racconta che «tra le cose che mi fecero una certa impressione a Ivrea, c’era un concorso mensile riservato agli operai, che dovevano recensire un libro: i vincitori venivano mandati a spese dell’azienda in una scuola di formazione tecnologica». Il libro di Bilò e Vadini è indispensabile per capire i Sassi, Matera, il Sud e l’entusiasmo di quei giovani, tra i quali i fratelli materani Albino e Leonardo Sacco, che vi si dedicarono con tutta l’anima.
Un'intera generazione di imprenditori e politici ha rinunciato a innovare, per campare di rendita, e i risultati saltano decisamente all'occhio. Recensione a: La Via del Nord, di Giuseppe Berta (il Mulino, 2015). Corriere della Sera, 18 febbraio 2015 (f.b.)
Se Giuseppe Berta non fosse uno storico, ma un’agenzia di rating, potremmo dire che il suo La via del Nord (Il Mulino) suona come un clamoroso downgrading dell’economia e dell’imprenditoria settentrionali. Nella prefazione, con grande onestà intellettuale, Berta spiega come in un recente passato il suo giudizio fosse stato più cauto — nonostante che le traiettorie del declino fossero già delineate — forse perché «ero più contiguo a qualche spezzone dell’establishment» ed «è bastato questo a farmi abdicare, pur senza averne la consapevolezza, all’attitudine al distacco critico che uno studioso dovrebbe salvaguardare in ogni circostanza». Rientrato in quello che definisce «lo spazio del cittadino comune», Berta sferra un durissimo attacco alle classi dirigenti del Nord, a coloro che avrebbero dovuto guidare la transizione dal vecchio e glorioso triangolo industriale (per il quale traspare profonda nostalgia) alla nuova economia moderna e terziarizzata.
Partiamo da Milano, fulcro di questo cambiamento. Lo storico imputa alle élite della città di aver gestito il passaggio dall’identità manifatturiera a quella neoterziaria «senza una discussione né un confronto pubblico», liquidando sbrigativamente il passato «senza remore e indugi». Moda e design saranno anche i nuovi simboli, ma Berta ne parla come di «un piatto di lenticchie» e rintraccia invece nell’edilizia la vera «forza ambigua» che ha mosso la nuova Milano. E in continuità con questo giudizio è «Salvatore Ligresti il protagonista della città che si terziarizza attraverso un’ininterrotta colata di cemento». È andata davvero così? Chi scrive nutre molti dubbi su una così radicale reductio ad unum . La terziarizzazione di Milano non si può dire certo che sia stata una clamorosa storia di successo, ma le dinamiche sono assai più complesse. Berta sembra racchiuderle in un mero spazio nazionale e così per certi versi finisce per sottostimare peso e valore del made in Italy (l’export è cresciuto negli anni della Grande Crisi!) e dall’altro non sembra vedere come Milano abbia perso il suo match soprattutto nei servizi professionali.
Con la sua Torino, Berta è ancora più tranchant , tanto da definirla «città opaca». «È venuta meno l’impronta industriale che la rendeva immediatamente identificabile senza però che sia stata sostituita da un segno e da una missione altrettanto robusti». A fallire è stata l’idea-guida di una Torino policentrica che, partendo dalle Olimpiadi, avrebbe dovuto convogliare investimenti nelle aree industriali dismesse e recuperare il centro storico, avrebbe poi dovuto orientare le competenze della città in direzione dell’economia della conoscenza e, infine, crescere come centro di cultura e intrattenimento. Ma come si fa a nutrire queste ambizioni — si chiede l’autore — se la provincia di Torino è al terzultimo posto delle aree metropolitane in Italia per numero di laureati in rapporto al numero di imprese? Per Berta quindi il bruco non è mai diventato una farfalla ed è rimasto una crisalide, le classe dirigenti hanno coltivato una bulimia progettuale che le ha portate a trascurare la direttrice più promettente, una Torino politecnica in forte continuità con la sua tradizione.
Sistemate le due maggiori città del Nord, Berta si rivolge ad analizzare i territori che vanno verso Nordest («la megalopoli insicura») e il pessimismo cresce. Lo storico vede «un’atmosfera intrisa di un senso di minaccia e di insicurezza che non può che esprimere una domanda di protezione». E chi è in grado di fornirla? Non le classi dirigenti miopi, ma «la malavita organizzata di stampo mafioso che si è incardinata nei circuiti economici settentrionali proprio durante gli anni della crisi». La camorra è il soggetto che sembra dare una risposta o un momentaneo sollievo alle angustie della crisi, attraverso un’offerta illecita di credito alle imprese, e se la criminalità organizzata ha allargato il suo perimetro di influenza «è perché la società settentrionale non ha più i suoi assi portanti di un tempo».
Nel volume del Mulino c’è molto di più di questa sintesi, c’è la storia di un capitalismo fondato sul lavoro e di una politica che fa contraddittoriamente i conti con la questione settentrionale, ma ciò che farà discutere delle tesi di Berta è lo schiaffo. Del resto i libri migliori non solo quelli che si condividono dalla prima all’ultima pagina, ma quelli che ci svegliano. E ci spingono a trovare argomentazioni, magari di segno contrario, ma all’altezza del confronto.
Pubblichiamo la bella introduzione del libro Documenti su vent'anni di utopia urbanistica a Siracusa Tra neoilluminismo e neoromanticismo, (La casa del nespolo Roma 2013). E' anche un augurio, per il prossimo novantesimo compleanno del nostro giovane amico Cenzi
Ora Vi racconto come è nata questa pubblicazione.
È venuto a trovarmi a studio il dott. Giuseppe Palermo, impegnato defensor del patrimonio culturale di Siracusa. Mi ha detto che aveva in mente di dar vita, per distinguere i fatti dalle opinioni, ad una collana destinata a pubblicare documenti del dibattito pubblico (articoli di giornali e riviste, delibere di Enti Pubblici etc.) relativi alla prima grande guerra sul Piano Regolatore di Siracusa (1952-1972): una parte con i testi del Cabianca, una con quelli di Luigi Bernabò Brea, un’altra con quelli di Michele Liistro, documenti che affiancano ed integrano una importante letteratura storico-critica relativa agli stessi anni, a partire da I guasti di Siracusa di S. L. Agnello e C. V. Giuliano.
Mi ha chiesto se avessi qualche altro documento oltre a quelli già da lui accuratamente raccolti e trascritti. Abbiamo verificato che, salvo l’introvabile relazione finale al primo Piano Regolatore Generale, lui aveva già tutto.
Mi ha chiesto di scrivergli una presentazione. Nell’accettare, mi sono ricordato dei versi studiati al liceo, la frase che Enea in riva al mare premette al racconto a Didone della caduta di Troia: “Infandum regina iubes renovare dolorem, troianas ut opes et lamentabile regnum eruerint Danai…”. Mi sono ricordato del disegno fatto da Enea con una canna sulla sabbia della topografia dell’antica Troia, degli accampamenti, degli Achei, dei luoghi delle battaglie e della frase finale, quando Enea dice a Didone: "Guarda, o regina, come un’onda del mare, in una volta sola, ha cancellato tutto, ha cancellato tanta gloria e tanta storia…”.
Questo pensiero mi ha richiamato al dovere e così ho molto ringraziato il dott. Palermo per il suo senso civico e ho scritto questa breve premessa ai documenti da lui raccolti.
La mia età si avvicina ai novant’anni. Ho vissuto, per quasi un secolo, illuministicamente, una vita che si illuminava nella progettazione, nel pensare strutturalmente processi, nel disegnare spazialmente piani che configuravano il cammino verso traguardi di assetti spaziali che, a loro volta, cercavano di rappresentare olograficamente obiettivi di evoluzione, di organicità complessiva. La storia, la cultura umanistica e quella scientifica confluivano nei colori dello zoning e dei tessuti per armonizzarsi progressivamente nella vita in un processo di futuro coevolutivo dell’uomo nella sfera biologica, ecologica e psicosociale dell’umanità.
Una visione che configurava utopia di assetto e di rapporto e di strutture a tutte le scale, de-duttivamente, da quelle continentali a quelle nazionali, regionali, territoriali, comunali, particolari, in un paesaggio di scenari caratterizzato dal passaggio di Zeitgeist, dalle religioni ancora e sempre alla ricerca di scorciatoie fideiste inventate e di postulati di comodo, ad un nuovo mondo governato dalla filosofia del piacere e dalla religione della conoscenza e dell’etica del metodo scien-tifico.
Ricordo che attendevamo sempre con ansia l’uscita del nuovo numero della rivista Urbanistica, con le immagini degli scenari di frontiera culturale urbanistica sui quali contendere e, rispetto ai quali, non essere mai in posizione arretrata. Tutto questo è svanito e la società ha subìto, assistendovi quasi senza opposizione, il compier-si lento di un tale tramonto dei valori del Pubblico, della Pianificazione, della Programmazione dell’Urbanistica, della Politica di Piano, in favore della navigazione a vista nello spazio finanziario, di rimedio in rimedio, in progressione negativa, che ora, nell’anno 2012, quasi debbo vin-cere un certo pudore che vorrebbe trattenermi mentre scrivo queste cose pensando alle certezze di allora. Oggi l’urbanistica è uscita dal calendario politico a tutti i livelli di governo, mentre l’economia è divenuta diseconomia che vive della deregulation generale.
Oggi la finanza ha contagiato e fortemente intaccato – se non ancora travolto – il mondo del lavoro e della ricerca dello Stato di diritto, delle certezze delle logiche dei piani che non hanno più quella meravigliosa centralità sulla quale si scrivevano e perseguivano le Costituzioni e le loro progressive attuazioni, mentre la speculazione non ha più nulla da temere da parte dell’urbanistica perché ridotta a un settore tecnico, senza ambizioni di governo degli interessi generali, perché l’urbanistica è diventata una parola vana, un atto formale per legalizzare a posteriori, con nuove denominazioni, nuove forme delle antiche “lottizzazioni convenzionate”.
L’urbanistica per me, allora, era un’urbanistica dello spazio e del tempo, era la componente e la proiezione territoriale di una pianificazione generale che cercava di essere come una sinfonia, un processo dialettico che aveva un traguardo di armonia spazio-temporale e socio-culturale generale indicato come riferimento al quale conformare gli interventi nel tempo.Era una dichiarazione d’amore per un territorio e per una società. Allora tutto in me era diverso.
L’incontro operativo con l’archeologia, la storia e, ad un tempo, con la geomorfologia significante della più vasta storia geologica, avvenuto subito dopo la laurea, in occasione della meravigliosa esperienza del concorso del 1952 per il Piano Regolatore di Siracusa, in un momento in cui cominciava a lievitare anche in Italia l’idea dell’advocacy planning, mi hanno acceso da allora nella mente un “epigenoma” particolare e determinante, un “genearchitetto” che mi fa gerarchizzare e privilegiare nel processo progettuale la matrice antica, il Dna storico-culturale, sotto le immagini delle città.
La partenza del ragionamento è questa: perché i Greci si erano insediati a Siracusa? Il Porto Grande era il miglior porto del Mediterraneo e in più aveva la preziosa “vasca di oscillazione” del Porto Piccolo, l’Ortigia e l’Epipoli erano la più difendibile fortezza naturale perimetrata dalle falesie marine sollevate dalla neotettonica pleistocenica, l’Epipoli era vasta e poteva, una volta fortificata, anche ospitare i pascoli per il bestiame per la popolazione in caso di assedio. Non c’era situazione migliore per un insediamento autarchico in caso di pericolo, il tutto al centro di un Mediterraneo, che era allora il grande mare centrale del mondo antico, al confine tra le aree d’influenza tra le due grandi civiltà in conflitto, tra l’impero persiano e il mondo greco con tutte le sue colonie che si sviluppavano fino oltre le Colonne d’Ercole.Vi erano poi altri motivi: la stratigrafia geologica portava l’acqua potabile a domicilio in forma artesiana fino all’Ortigia, un vero dono dagli Dei.
Queste fondamentali componenti hanno dato a Siracusa il ruolo straordinario che ha avuto nell’antichità, e ad un tempo costituiscono ancora le risorse dell’armatura culturale per un nuovo piano.
Un urbanista è un direttore d’orchestra o meglio un compositore che ha davanti a sé infiniti elementi da armonizzare tra la città di pietra, le città della storia e la città dell’uomo, con vincoli da trasformare in risorse, tra storia e progetto, e il piano disegnato è un’olografia nella quale la quarta dimensione del tempo, del futuro è olograficamente racchiusa nella semiologia bidimen-sionale della sua rappresentazione. Quell’epigenoma, quello spartito, quella ouverture sono stati un imprinting che ha generato una matrice da rappresentare subito, da evidenziare.
La morfologia del porto e del rapporto con il mare, da evidenziare con l’azzurro e i significati geomorfologici della geodinamica del territorio, a loro volta matrice della geostoria dell’insediamento umano. A terra, i “significanti” archeologici della città magnogreca, da evidenziare con il rosso, con il colore più evidente e semiologicamente più significativo della sua importanza gerarchica all’interno di un connettivo verde, di un fiume verde di distacco esaltante e gerarchizzante che ne indica una presenza a livello di alta sacralità, di uno “status” di santuario, di tesoro da custodire, di ritrovamento di tracce di un ordine superiore scritto dal comandamento fatale che si ripete: “antiquam exquirite matrem”.
Questa visione alla Winckelmann ha reso particolare il piano di Siracusa fin dalla sua prima formalizzazione. Nel piano di concorso aleggia uno Zeitgeist di neoclassicismo che il disincanto del tempo ha fortemente venato di romanticismo. Da questo discende il titolo, che vuole rappresentare la presenza nel piano di un neoromanticismo molto connotante con cui leggere il tutto e di un neoillu-minismo dal quale discende la forza di un imperativo categorico, etico ed estetico, del primato dei Beni Culturali nelle scelte del piano.
Un secondo elemento è infatti il neoilluminismo. Io sono un fanatico della semiologia e delle evocazioni simboliche delle forme urbane a tutte le scale. Come nel Castello dei destini incrociati di Calvino, vedo l’esistenza criptica di un secondo sistema sotto le cose, di segni simbolici forti e a volte configuranti; vedo nell’interpretazione la simbologia affiorante geomorfologica che anticipa i segni antropici dell’architettura e dell’urbanistica indotta dalla loro morfologia. Quindi il secondo elemento che sono portato ad enfatizzare in una terza dimensione è l’interpretazione geodinamica delle geomorfologie del paesaggio, alle quali si appoggia la morfologia del segno archeologico per via dell’economia dell’urbanistica antica sottostante. Un sistema insediativo molto coerente, molto appoggiato al sistema naturale, soprattutto nei sistemi difensivi. Sistemi difensivi che per la loro robustezza, estensione ed esposizione, sono spesso i segni archeologici più evidenti. Mi riferisco al sistema delle falesie di bordo dell’Ortigia, dell’Epipoli sollevate dall’uplift della neotettonica pleistocenica e del circuito delle mura dionigiane.
Nei lunghi periodi durante i quali sono arrivato a Siracusa e non più ripartito, ho vissuto nella foresteria del sottotetto della Soprintendenza, in una stanzetta con l’affaccio sul Porto Grande, con Erodoto e Tucidide sul comodino. Era la letteratura antica che mi dava la forza di combattere. L’ulteriore elemento è costituito dall’idea della democrazia di procedimento, di costruzione democratica del piano in dialogo con i cittadini attraverso la stampa, in colloquio continuo, con un invito al confronto e all’arricchimento delle idee e delle proposte.
Studiando Siracusa sotto tutti gli aspetti, integrati tra loro, da quelli storici a quelli geologici, da quelli fisici a quelli letterari ero divenuto Siracusano, profondamente, appassionatamente Siracusano.
Con queste tre dominanti, il modello di sviluppo urbano proposto dal P.R.G. – condizionato ulteriormente dal ruolo strategico molto rilevante del piano di industrializzazione del Mezzogiorno con fondi Casmez – ed il suo processo di formazione sono stati segnati dalla geomorfologia del porto e dalle falesie dell’Epipoli, dall’archeologia dell’impianto urbano classico al momento del suo massimo splendore – anch’esso fortemente coniugato con la base geomorfologica –, dalla convinta gestione della formazione del piano con un processo di confronto continuo col pubblico attraverso la stampa.
In quel primo periodo postbellico la risorsa più facile e la più diffusa per le economie locali era costituita dalle rendite edilizie parassitarie di posizione urbane in assenza dei piani regolatori da una parte e, dall’altra, e per la economia di livello superiore, dai grandi insediamenti industriali inquinanti dei semilavorati dell’industria del petrolio, con uno sviluppo basato sull’illusione dello sviluppo dei loro indotti, dalle industrie petrolchimiche, dalla mitologia di quelle siderurgiche e dalle fabbriche, molto concrete, del cemento. Tutto questo era un frattale della grande storia che avveniva nel mondo, e a livello nazionale era segnata dagli anni del Centrismo, e poi del Centro Sinistra e della politica di piano in un breve periodo di utopia della seconda metà del XX secolo.
È subito evidente quali fossero i termini delle conflittualità urbanistiche tenuto conto delle alleanze di sostegno politico-finanziarie fra proprietari dei suoli, partiti politici, Cassa per il Mezzogiorno; tra diversi supporti ideologici, guerra fredda, dominanza nazionale e locale della Dc, scelte politiche industriali sbagliate e molto influenzate dai finanziamenti ai partiti, assenza nel dibattito, fino all’inizio degli anni ‘70, della componente ecologica, dei Beni Culturali, ancora senza un proprio Ministero ed ancora legati a quello della Pubblica Istruzione, carenza di livelli di pianificazione strategica almeno sovracomunali etc., ministri che appena toccavano il tema della riforma urbanistica uscivano di scena come il povero Fiorentino Sullo.
Questa era la situazione nella quale il progetto di Piano Regolatore ha messo in campo negli anni ‘50, “spes contra spem”, una proposta di urbanistica basata sull’economia dei Beni Culturali, di armatura culturale del territorio, di difesa e sviluppo ecologico-culturale, di advocacy planning sulla stampa locale con invito alla popolazione ad esprimersi, valutare, proporre, per dare “gambe” al piano.
In quel periodo Astengo progettava il piano di Gubbio con la stessa matrice mentale, mentre la rivista “Urbanistica”, con valenza culturale e diffusione nazionale ed internazionale, supportava il nostro tentativo pubblicando ampiamente il piano, ambitissimo privilegio culturale per l’urbanistica di allora.
Non era ancora diffuso e all’ordine del giorno il concetto strutturale di “sostenibilità” tra fattibilità e automantenimento coevolutivo con il contesto, mentre il rischio di autodistruzione delle risorse era evidentissimo ed il progetto del Piano Regolatore era proprio volto prioritariamente ad un generale rafforzamento preventivo e permanente del sistema immunitario per una vasta tutela dei Beni Culturali di Siracusa.
I miei colleghi Lacava, Roscioli ed io avevamo la responsabilità, inizialmente collegiale, del piano di Siracusa, ma i tempi dei treni (a Catania finiva la trazione elettrica), i costi degli aerei, una situazione conflittuale nella quale per l’Amministrazione Comunale il Piano Regolatore era sostanzialmente un fastidioso obbligo di legge e un’occasione di contrattazione partitico-elettorale, ad un tempo altri importanti concorsi vinti, relativi ad altri Piani Regolatori, portarono alla decisione dello studio che fossi io ad assumere le responsabilità per Siracusa.
A Siracusa io avevo ricevuto l’incarico da parte della Soprintendenza alle Antichità e della Cassa per il Mezzogiorno – il sublime incarico – di sistemazione della Neapolis con il Teatro Greco, l’Ara di Jerone, l’Anfiteatro Romano, le favolose latomie, l’Orecchio di Dionigi… È chiaro che con simili presenze esemplari ed una tale occasione operativa, il modello generale del piano era ulteriormente volto alla centralità di ruolo e d’attenzione alla difesa dei Beni Culturali e Ambientali e, insieme, alla democrazia di procedimento per la sostenibilità dell’operazione che comportava grandi espropri, naturalmente osteggiati dalle forze politiche, dalla Cassa per il Mezzogiorno, da tutti.
Gli elementi di importanza ed interesse che si collocavano a livello mondiale erano per noi le carte da giocare. Il resto era importante ma subordinato a questi aspetti che contavano ancora di più. Da tutto ciò è nata la conflittualità con chi prevedeva insediamenti con localizzazioni che implicavano il coinvolgimento dell’Epipoli ancora intatta nella sua parte mediana e superiore. Conflittualità che ovviamente s’intrecciava fortemente con la storia politica di quegli anni, i rapporti politico-finanziari tra amministratori ed acquirenti della grande proprietà fondiaria periurbana lottizzata o lottizzabile e politici consorziati nelle due correnti della Dc e relativi clienti e satelliti.
Un piano era visto come un’immagine, una bussola sistemica, anche esteticamente valutabile, di una nuova città ideale divenuta sistema territoriale, armoniosa a tutte le scale, un mondo quale si vede in uno zoom, come in una ripresa multispettrale di un satellite che si allontana dalla terra, che legge ed interpreta realtà ed interazione nel fisico e nel sociale, con la semiologia dell’ordine e del disordine significante nelle immagini, nei colori e nella composizione di tessuto delle zonizzazioni, con zone omogenee sempre più frattali per ricchezza di disomogeneità integrate.
Il piano doveva essere leggibile come lo spartito di una musica di raggiunta integrazione funzionale in una variazione fatta sempre di nuovi stati di equilibrio, armonici potenziali; nel piano doveva essere leggibile la qualità di coerenza con la geomorfologia della natura, la quantità e la qualità e la accessibilità alle attrezzature di tutti i livelli, ai servizi, la loro quantità ed integrazione nei tessuti, le dominanti di produzione e le dominanti di civiltà, la qualità politica e la qualità sociale delle proposte, le qualità estetiche in armonia con i contesti di scenario am-bientale.
Ricordo che allora, soprattutto alla fine degli anni ‘60, nell’ultima nostra edizione del piano, quello redatto in collaborazione con gli architetti siracusani Liistro e Santuccio, – cooptati a mia richiesta nell’équipe del piano per garantire un rapporto qualificato, diretto con la città nel brevissimo tempo concesso –, pensavamo pienamente in termini di modelli europei e di modelli nazionali. Questo avveniva nell’enfasi della conoscenza del “Progetto ‘80” – alla cui costruzione io partecipavo proprio come responsabile del Mezzogiorno e del settore dei Beni Culturali e Ambientali –, del modello per l’Italia del futuro, degli anni ‘80, per conto del Ministero del Tesoro e della Programmazione Economica, nel quale il sistema Siracusa-Augusta era un modello “P”, cioè Modello Programmatico di Area metropolitana (cfr. “Progetto ‘80”) di grande rilevanza.
Pensavamo a modelli territorializzati dei sistemi urbani di insediamento territoriale storici, attuali, di tendenza, da interpretare e valutare, patologici da contrastare, programmatici da promuovere, pensavamo a modelli con gerarchie urbane, metropolitane e ad armature culturali del territorio, a sistemi del verde a tutti i livelli, dai parchi nazionali agli standard del verde comunale, a sistemi infrastrutturali intermodali, integrati, portuali, ferroviari, autostradali, aeroportuali, ai grandi nodi infrastrutturali di scambio. Ricordo il sistema portuale nazionale nel quale la rada di Augusta aveva un grandissimo ruolo perché era l’unico grande porto con fondali così alti da poter ospitare le megapetroliere che doppiavano allora il Capo di Buona Speranza, perché il Canale di Suez era chiuso per il conflitto arabo-israeliano.
Ricordo che Siracusa, con il grande quieto bacino del suo “Porto Grande”, diveniva il più grande porto per la navigazione sportiva a vela del Mediterraneo centrale. Si poneva il problema di far rivivere uno dei più grandi porti velistici dell’antichità, senza però consentire che le attrezzature dei marinas divenissero germi e cavalli di Troia per grandi complessi alberghieri e poli di attrazione economica per grandi capitali internazionali di riciclo in cerca di investimenti, di grandi avventure speculative fondiarie, legate al settore edilizio. Era un tema delicatissimo, tra integralismo culturale e giustificato timore di travolgimenti speculativi.
Avevamo nel nostro modello nazionale ridotto strutturalmente nel rapporto residenza-lavoro gli sprechi di tempo – di oltre un’ora al giorno in media per ogni unità lavorativa – dovuti a contraddizioni e disordine territoriali, il che avrebbe aiutato a mettere il Paese in condizioni competitive, risanato il mercato del lavoro, portato equità e giustizia sociale nel meccanismo social-produttivo, liberando fondi per la ricerca, l’innovazione, la produttività.
La cultura e la formazione, la ricerca scientifica erano in primissimo piano con il sistema di “Armatura Culturale del Territorio”. Ogni cosa aveva obiettivi territorializzati e peso ben definito nel bilancio generale.
Il sistema autostradale era tutto pedemontano e con un modello a pettine serviva le coste in modo da renderle tutte pubbliche e accessibili, con una precisa esclusione di litoranee costiere. Il sole del Mezzogiorno diveniva così una risorsa concreta per un’enorme offerta per il turismo europeo. Eravamo esaltati da queste idee che stavamo tutte inserendo anche territorialmente nel “Progetto ‘80”.
Ma tutto questo non trovava riscontro nella potente maggioranza politica dalla quale, per via del Concorso Nazionale vinto a suo tempo, avevamo ricevuto l’incarico.
Ora debbo fare una confessione laica. Di fronte al sonno, all’inerzia, all’opposizione miope e meschina degli interessi della classe democristiana che occupava tutto il potere e che però, a sua volta, non contava nulla a livello regionale dominato dalla Dc palermitana, alla fine, dopo la consegna dell’edizione finale del 1970, all’ostilità avvilente e inconcludente dell’Amministrazione committente, non ebbi la forza civile di proseguire. Avevo appena ottenuto l’incarico universitario a Palermo, ero impegnato nel Direttivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, ero all’opera per il “Progetto dell’Italia degli anni ‘80”, ero impegnato nella progettazione di tutti i musei della Libia, lasciai tutto nelle mani dei miei due valorosi colleghi Liistro e Santuccio, che nel frattempo stavano divenendo due importanti docenti nelle facoltà di Architettura di Roma nell’ambito dei gloriosi Istituti di due grandi maestri come Piccinato e Carbonara e si sentivano ancora in grado di fronteggiare eroicamente la situazione del 1970.
Cosicché quando l’ultima edizione del piano del 1970, dopo un lungo tempo dalla consegna, andò in Consiglio Comunale per l’adozione, c’era ancora la mia firma per lealtà e per riguardo verso i miei colleghi, ma in realtà non controllavo più la situazione. Ci fu persino impedito di fotografare l’edizione finale del piano, unica a colori (a quei tempi si usava l’acquarello) esposta al pubblico, che nell’ansia ed urgenza della consegna, anche per difficoltà di dimensioni, supporti etc., non avevamo fatto in tempo a fotografare a studio, prima dell’imballaggio!
Il sindaco Dc Giuliano era un ex magistrato, pieno di un grandissimo senso dell’umorismo, che utilizzava anche nell’affrontare i problemi più gravi. Ogni volta, travolgeva il contenuto delle nostre formulazioni delle norme tecniche dicendo con accento severo che l’interpretazione degli autori era un’interpretazione rispettabile, ma le sue tortuose e finissime interpretazioni alla rovescia erano altrettanto valide. L’Assessore all’Urbanistica, il dottor Rizza, fu addirittura invitato a ripudiare il piano sotto la minaccia di espulsione dal suo partito, dalla Dc.
Aveva sempre correttamente difeso l’autonomia del Piano Regolatore dai suoi colleghi di partito, dalla stessa Amministrazione – la quale esprimeva interessi tutt’altro che generali –, ma era in minoranza, isolato dalla corrente interna rivale e dominante.
Tutta la mia energia mentale di urbanista, come dicevo, si stava trasferendo sul livello nazionale e regionale, concentrandosi sugli studi per il “Progetto ‘80”. L’interesse locale della Giunta era tutto concentrato non sul piano in generale ma su operazioni edilizie ben rappresentate e leggibili chiaramente sulle varianti integrative che furono introdotte dalla Amministrazione stessa in sede di adozione, dando luogo ad una contemporanea adozione del piano e di un antipiano, per cui alla fine, leggendo le osservazioni di “Italia Nostra”, sentivo e manifestavo tutta la condivisione ed immedesimazione in quelle formulazioni, cosicché tutti conclusero che le avevo redatte io stesso.
Mi stupisco, dicevo, della forza di utopia che aveva preceduto e accompagnato quelle vicende, rischiando però alla fine di coinvolgermi in problemi di gestione e mediazione del piano, nel vano tentativo di salvarlo da continui tentativi e richieste da parte dell’Amministrazione di modifiche sconvolgenti.
Ma gli interessi locali erano tutti concentrati sulle integrazioni da adottare contestualmente al piano, che noi avevamo rifiutato di introdurre nei disegni di progetto e nella normativa, che l’Amministrazione presentava a tutti i costi sotto forma di urbanistica scritta poi rifiutata dalla Regione Siciliana in sede di esame per l’approvazione.
Ammiro ancora una volta i due valorosi colleghi e professori Liistro e Santuccio, che mantennero i rapporti con l’Amministrazione forse anche in virtù dei legami di sangue con la città, dato che entrambi erano Siracusani anche per nascita oltre che per amore e per cultura.
* * *
Ora che tutto questo è svanito, che i protagonisti della politica di allora sono divenuti consumati attori pieni di rancori e disillusioni, attori che si arrabattano sul palcoscenico politico ben consapevoli di essere ormai destinati a non essere ascoltati mai più, leggere questa raccolta di scritti mi lascia pieno di stupore.
È tutto talmente lontano – quest’avventura era iniziata nel ‘52 e per me è finita nel ‘70 circa – e d’altra parte è talmente oggi ridotto in campo urbanistico il livello di utopia accettabile al di sotto delle soglie dell’ironia, nelle istituzioni e nei loro piani – ridotti ad enunciazioni elettorali o a fascicoli di archivio o testi di letteratura urbanistica – che veramente ho difficoltà a ricordare come reale, sopportata e combattuta quella situazione incredibile. Forse si tratta di un rifiuto dell’inconscio.
L’urbanistica oggi è ridotta in generale al pensiero di come violare quel che resta delle sue ceneri o come dare veste giuridica al disimpegno in nome di strategie non vincolanti, o come sviluppare il sopravvento dell’urbanistica scritta trasformata in ginnastica orale.
Ho difficoltà a ricordare quello che leggo in questi vecchi articoli, che un treno a vapore portava da Siracusa a Catania dove si stampava il giornale “La Sicilia” che li ospitava, in una pagina destinata alle Cronache di Siracusa. Difficoltà a comprendere quale utopia – quale forza di utopia fosse in me e come una briciola di uomo e di urbanista potesse combattere, termopili dopo termopili, prima da solo, poi con i due giovani bravissimi appassionati colleghi di Siracusa, Michele Liistro e Concetto Santuccio, entrambi ora docenti alla facoltà di Architettura dell’Università di Roma, contro una sfera enorme e lentamente rotolante di organizzazioni partitiche con idoli così diversi, e con l’alleanza di così poche figure locali disposte ad esporsi.
Voglio aggiungere una cosa poco nota, che mi fa pensare come piccoli eventi di piccoli uomini possano cambiare addirittura la storia.
Penso, come sia potuto accadere che un minuscolo avvocato, consulente ad hoc del Comune, abbia potuto far cadere (parlo della prima edizione del piano, quando combattevo da solo) per rinuncia giuridicamente motivata, tutto un grande patrimonio di cessioni di aree vincolate e destinate dal piano a parchi archeologici (lungo i 20 km. delle mura dionigiane!), a parchi naturali e attrezzati. Si trattava di aree che in sede di esame delle osservazioni avevo ottenuto a favore del Comune in donazione da parte di pochissimi grandi proprietari di aree dell’Epipoli, in particolare dai marchesi Gargallo, proprietari di quasi tutte le aree di espansione di Siracusa. Questi infatti, assistiti nella redazione delle “osservazioni” al Piano Regolatore da un generoso intellettuale e professore di architettura, il prof. Carbonara, avevano accettato di donare al Comune vaste aree rocciose inedificabili da destinare a Parco Pubblico Archeologico, a fronte dell’accoglimento contrattuale da parte del Comune di alcune piccole ininfluenti varianti di cubatura in sede di esame delle osservazioni al P.R.G. relativamente ad aree edificabili. Una contrattazione urbanistica per fini pubblici ante litteram che, gestita da uomini onesti con indicazioni degli stessi progettisti, sarebbe stata certamente una via importantissima per l’attuazione del piano.
Penso che cosa sarebbe ora Siracusa, con tutte quelle aree archeologiche donate (e poi non accettate proprio dal Comune beneficiario), trasformata in una città scenario del suo passato, in una trama spaziale di un immenso parco di resti archeologici immersi nella continuità di un contestuale tessuto verde che ne avrebbe focalizzato il carattere e la continuità nel nuovo scenario urbano.
Di questo sogno solo una piccola parte è stata attuata ed è il parco della Neapolis. Ricordo che quando lo progettai dovetti combattere, veramente combattere con la Cassa per il Mezzogiorno che lo finanziava e che voleva spendere denaro in opere aggiuntive ed in occupazione, ma era contrarissima agli espropri, mentre per me era assolutamente prioritario assicurare la demanialità di tutte le grandi aree della Neapolis, del Teatro Greco, dell’Ara di Jerone, dell’Anfiteatro Ro-mano, delle latomie, della balza, oltre a quelle ristrette dei singoli monumenti già in possesso della Soprintendenza, per garantire le aree archeologiche dagli insediamenti edilizi che si sarebbero sviluppati ai suoi bordi.
Ricordo che l’Ingegnere Capo del Comune, quando lo incontrai per la prima volta nel ‘52, mi disse a proposito dell’area della Neapolis e delle necropoli: “Tutti cimiteri hannu a restari? Iu ci facissi un cinema supra u teatru grecu”.
Mi ricordo che l’ambizione come progettista di realizzare, musealizzare, etc., era grandissima, ma la coscienza di giovane urbanista mi accendeva un forte senso di responsabilità civile del ruolo pubblico nella progettazione di un Piano Regolatore di così grande importanza per cui la demanializzazione era il primo fondamentale obiettivo da perseguire, per il controllo del processo e dell’assetto strutturale del governo pubblico del territorio.
In quegli anni la speculazione edilizia infuriava a Viale Zecchino e l’avv. Panico era l’elemento trainante dell’opposizione in Consiglio Comunale. Ricordo che preparò un manifesto nel quale si descriveva l’Ingegnere Capo del Comune come una figura della zoologia fantastica di Borges, la katablefa, con il titolo “Chi è?”, in cui tutti ravvisarono il personaggio, dati i riferimenti alle operazioni immobiliari di Viale Zecchino.
Ricordo che arrivai persino ad una situazione di tensione con il Soprintendente, grande archeologo e mio idolo e maestro, il prof. Bernabò Brea, che temeva di non riuscire, con la burocrazia statale di mezzo, a gestire e coltivare le vaste aree di cui progettavo nel piano la demanializzazione ed in particolare tutte quelle della Neapolis nelle quali era importantissimo tenere in vita le colture a frutteti che, nello scenario generale, erano una componente essenziale perché formavano un tappeto di ridente natura magnogreca all’interno della quale sorgevano i monumenti. Io proponevo di demanializzare e poi concedere in “concessione d’uso” ad agrumeti le aree espropriate, ma chi doveva amministrare bene sapeva a quali rischi interpretativi, controlli, formalità burocratiche, si andava incontro con la Finanza ed il Catasto.
Ricordo le parole del Sindaco che ci ricordava di essere i progettisti dell’Amministrazione e non dell’opposizione e che comunque dovevamo ricordare che avrebbe sempre vinto, ovviamente, perché aveva la maggioranza, perché a mezzanotte la gente che assisteva al Consiglio Comunale se ne andava, perché senza il pubblico le opposizioni non erano più interessate, perché potevano recitare soltanto, protestare, opporsi, recitare senza platea. Erano minoranza e a mezzanotte la maggioranza al completo restava sola e compatta a deliberare e verbalizzare tutto quello che il partito aveva deciso e a volte anche di più, nell’ebbrezza solitaria di una autogestione di verbali e decisioni miliardarie.
Dolore e lontananza ieri come oggi si accompagnano ormai a questi pensieri.
Gli interlocutori, gli amici e i nemici della prima fase della battaglia in solitudine sono scomparsi. L’avvocato Caracciolo, prima Assessore all’Urbanistica e poi Sindaco e sostenitore del piano, non c’è più. L’onorevole Sgarlata, Presidente della Provincia, poi Sindaco di Siracusa, poi Sottosegretario al Turismo e leader della locale corrente morotea, caro e stimato amico, non c’è più. Il presidente Rizza, Assessore all’Urbanistica, che aveva sostenuto il piano addirittura sino a subire il ricatto del suo partito, la Dc, era stato posto di fronte all’alternativa o di disconoscere il piano o di essere escluso dal partito, non c’è più. Bernabò Brea, il grande famoso archeologo, allora Soprintendente di tutta la Sicilia Orientale, dopo aver lasciato Siracusa per le Eolie, divenute il suo regno scientifico, ed avere realizzato a Lipari quello che forse oggi deve essere considerato il più esemplare museo della protostoria del Mediterraneo, non c’è più. Il prof. Monaco, Direttore dell’Istituto del Dramma Antico, prof. emerito dell’Università di Palermo, grande amico, non c’è più.
Quelli che furono i grandi oppositori del piano sono di tempra più resistente, ma il tempo, l’abusivismo e una dinamica edilizia oramai spontanea hanno sostanzialmente travolto tutti, sconvolto valori, partiti, il territorio.
Tutto è ora diverso, anche se i limiti di consapevolezza di ciò che si sta distruggendo non sono mutati. La finanza ha travolto l’economia a livello globale, tutto quello che il piano voleva evitare è stato realizzato prioritariamente per timore che il piano fosse approvato ed eventualmente attuato, l’industrializzazione a Nord, tra Siracusa e Augusta, è divenuta una necropoli di scheletri di una concentrazione colossale di inquinamento ambientale, ha monopolizzato l’accessibilità alla costa per poche industrie ormai desuete, le aree costiere a Sud della città son divenute lottizzazioni con privatizzazione degli accessi al mare. I giacimenti di petrolio del Ragusano si sono esauriti, le opposte fazioni sono in lite su tutto, l’Ortigia ha perso tutto il tessuto artigiano e microcommerciale confluito nei supermercati, e la popolazione ha abbandonato lo “scogghiu”.
Il piano particolareggiato dell’Ortigia, un capolavoro di competenza, amore ed impegno del prof. Pagnano che la difendeva, è decaduto per eccesso di amore progettuale-urbanistico a scala architettonica, in quanto redatto e formalizzato giuridicamente in forma di Piano Particolareg-giato Esecutivo che comporta la attuazione in termini decennali o l’indennizzo e non consente il ripristino dei vincoli.
L’incarico dato di recente al prof. Liistro per il piano dell’Ortigia è stato conferito con carattere soltanto consultivo, sono venute meno le collaborazioni d’ufficio, l’insistenza a procedere sulla via di un piano particolareggiato ma generale, a priori, ha mantenuto in vita le stesse condizioni di insostenibilità operativa dal punto di vista giuridico ed ora è arenato e non ha tensione che ne sostenga una riformulazione.
La pianificazione territoriale e la pianificazione in generale sono uscite dal dizionario stesso della politica, ieri erano più un problema che una risorsa, oggi sono addirittura una parola vana, anzi ostile nello scenario dell’urbanistica contrattata.
L’immagine da satellite del territorio visibile oggi al computer con Google Earth non è solo sconvolgente: è come vedere l’equivalente di una grande biblioteca incendiata, di una Firenze al-lagata dall’Arno. Mi procura la disperazione di un medico che guarda la risonanza magnetica aggiornata di un figlio e si trova di fronte ad una metastasi raccapricciante diffusa a livello impensabile.
Il prof. Santi Agnello ha scritto e raccolto i primi importanti documenti sull’Archivio Storico, appena formato e inizialmente diretto da M. T. Gargallo, “Appunti di storia urbanistica siracusana”, vol. I (1955), ma, anche lui, non c’è più. Restano gli scritti.
Io stesso, per sbaglio, sono ancora vivo.
Assieme, il prof. Santi Luigi Agnello e l’avv. Corrado V. Giuliano hanno pubblicato un prezioso libro dal titolo: “I guasti di Siracusa: conversazioni sulle vicende dell’urbanistica siracusana” (Siracusa, 2001) di cui in questo libro si pubblicano diversi documenti citati assieme ad altri faticosamente recuperati in edizione integrale.
Il prof. Michele Liistro ha scritto uno stupendo libro su Ortigia, Ortigia: memoria e futuro (Roma, 2008), un testo che affianca la grande competenza urbanistica con la finezza psicologica e letteraria di un Thomas Mann e la saggezza cinese di un Confucio. Un libro veramente commovente per l’amore che esprime per l’antica patria, per l’amata Ortigia piena di storia, di sole e di miele della sua giovinezza. Ma la quieta saggezza espressa da questo libro non ha riflessi concreti nell’azione dell’Amministrazione.
Ma ora basta con il gelo di queste considerazioni e consolazioni letterarie.
Altra cosa è la gratitudine con cui comunque voglio ringraziare il valoroso curatore di questo libro-documento, il dott. Giuseppe Palermo, che ha raccolto tutti i documenti che raccontano una storia così complessa da invocare un nuovo Tolstoi per scrivere questo capitolo, di una nuova “Guerra e pace” del XX secolo. Grazie ancora, quindi, al dott. Palermo, che ha voluto recuperare e ordinare la documentazione di tutto l’advocacy planning, la partecipazione dei Siracusani attraverso i giornali e le risposte degli urbanisti, durante la lunga battaglia urbanistica dall’inizio degli anni ‘50 all’inizio degli anni ‘70. Battaglia di una guerra che ancora continua all’interno di un palcoscenico di una città, che in un palcoscenico ulteriore, quello del Teatro Greco, ospita ogni anno la recita di prototipi classici di tragedie che si ripetono in permanenza, tra storia e psicologia, nella storia dell’uomo.
Ritornando a Siracusa per assistere ancora una volta alle rappresentazioni classiche alla fine degli anni ‘90, sono tornato in quel Teatro Greco di cui avevo curato la sistemazione con la guida di due grandi archeologi, Stucchi e Bernabò Brea, nel 1954. Mi sono ricordato di quando ritrovavamo gli antichi tracciati sotterranei e recuperavamo gli antichi acquedotti, riportando l’acqua nel ninfeo sopra la cavea del Teatro Greco, demanializzavamo l’intera area monumentale della Neapolis, curando il vastissimo impianto arboreo di querce, lecci, carrubi, agrumi, allori, cipressi.
In quell’atmosfera, ho scritto una poesia che riporto, tenendo fede al titolo che parla di utopia neoilluminista e neoromanticismo.
COME UNA PANATENAICA
Aiutami fanciulla
discendo
col passo incerto
della nostalgia
le gradinate
che mille volte
un tempo
il mio giovane corpo
avea disceso
con orgogliosa sicurezza
aiutami fanciulla
a entrare tra la folla
che lenta defluisce
verso il mio bosco
e più non mi conosce
Il poeta descrive il fiume umano che defluisce lentamente dal Teatro Greco di Siracusa, si riversa nell'orchestra e scompare in un bosco sacro di ulivi e cipressi che lui stesso ha piantato negli anni della sua giovinezza tra la scena e il paesaggio del porto e del Plemmyrion deturpato dallo scalo ferroviario e da una fumosa vecchia zona industriale.
Successivamente, come dicevo all’inizio di questo scritto, Siracusa ha ottenuto il riconoscimento di Sito appartenente al Patrimonio straordinario, unico ed intangibile dell’Umanità. Ma la Siracusa di cui si parla, per me non è quella attuale di un’edilizia disordinata che ha deturpato il paesaggio, delle strade che hanno tagliato l’Epipoli e le balze e delle lottizzazioni che hanno privatizzato le coste e metastasizzato tutto il territorio. La Siracusa alla quale mi riferisco è quel capolavoro straordinario che il lontano progetto di concorso aveva sognato e proposto affidando alle maestose rovine ed al contestuale scenario paesistico il ruolo primario di elemento configurante nel piano, risuscitando, per il mondo intero, un polo di riferimento storico-semiologico a livello di Epidauro, di Delfi, di Efeso, di Cartagine, di Atene – sua eterna grande rivale nel mondo antico –, una reminiscenza primaria della grande storia della civiltà classica, matrice della nostra identità.
Roma, 11 maggio 2012
Per chi volesse acquistare il libro, qui il link alla casa editrice
«L’intenzione di Fersuoch è dimostrare che non esiste un’opera buona, il Mose, inquinata dalla corruzione. È il Mose in sé un’opera che non si sa se funzionerà, persino dannosa, bocciata fin dal 1998». La Repubblica, 8 luglio 2014
Nel 2013 sono state 156 le volte in cui le maree, a Venezia, hanno superato di 80 centimetri il livello medio. Dato che le paratoie del Mose si innalzano a quota 110 centimetri, bloccando l’accesso in laguna, per 156 giorni, nel 2013, una parte di Venezia sarebbe stata invasa dall’acqua anche con il Mose. Una parte piccola, ma pur sempre piazza San Marco. È uno dei paradossi denunciati da scienziati, ingegneri, strutturisti e dalle associazioni ambientaliste impegnati da anni, inascoltati, nell’opposizione al Mose, che ora si vorrebbe portare comunque a compimento, nonostante si sia scoperto quanto fosse spinto nel suo cammino dalle tangenti.
Obiezioni, studi, cifre, raffronti internazionali sono raccolti da Lidia Fersuoch, presidente di Italia Nostra veneziana, in un agile, ma documentato libretto
A bocca chiusa. Sipario sul Mose (Corte del Fontego editore). L’intenzione di Fersuoch è dimostrare che non esiste un’opera buona, il Mose, inquinata dalla corruzione. È il Mose in sé un’opera che non si sa se funzionerà, persino dannosa, bocciata fin dal 1998 dalla commissione per la Valutazione d’impatto ambientale, mai smentita da un altro organismo scientifico, affidata in regime di monopolio al Consorzio Venezia Nuova, che badava a tutto, ai progetti, all’esecuzione, e poi, come sta accertando la Procura, all’acquiescenza di tecnici e accademici di varie discipline e alla corruzione di politici, amministratori e funzionari pubblici.
Le criticità addebitate al Mose iniziano dallo sconvolgimento dell’equilibrio lagunare, della dinamica dei flussi e dei riflussi di maree, vitale per l’esistenzadel bacino e per il benessere di Venezia. D’altronde del Mose non è mai stato elaborato un progetto esecutivo, ma solo il preliminare e il definitivo. Le barriere alle bocche di porto, stando alla legge, sarebbero dovute essere realizzate solo dopo altri interventi, che invece non sono mai stati compiuti. Fin dal 1994 si è denunciato il rischio che le paratoie (78 nelle tre bocche di porto, Lido, Malamocco e Chioggia), una volta sollevate e sollecitate dalla marea, oscillassero e lasciassero dei varchi dai quali l’acqua sarebbe passata. Il Mose, quindi, non garantiva una chiusura ermetica.
E ancora: le cerniere che tengono agganciate le paratoie ai cassoni di calcestruzzo (manufatti alti quanto un palazzo di dieci piani), per decisione del Magistrato alle acque, sono saldate e non fuse, come prevedeva il progetto originario. Ma chi in quella struttura sollevò dubbi sui costi e sulla manutenzione fu rimosso da Patrizio Cuccioletta, presidente del Magistrato alle acque, ora agli arresti.
E poi le cerniere sono così costose perché le paratoie si alzano andando contro la corrente. Nel 2005 Vincenzo Di Tella, ingegnere idraulico, dimostrò che si sarebbe potuto invertire il senso delle paratoie, alzandole assecondando la corrente, con un risparmio enorme. Ma la sua soluzione fu bocciata. Da chi? Dal Consorzio e dal Magistrato alle acque. Il libro inanella i passaggi che hanno accompagnato il Mose. E segnala tanti giudizi negativi rimasti senza conseguenze. Come quello di Antonio Mezzera, giudice della Corte dei Conti: la cui relazione, ha accertato la Procura, venne modificata su pressioni del
|
"A bocca chiusa. Sipario sul Mose", di Lidia Fersuoch ( Corte del Fontego editore, pagg. 36, euro 3)
|
«Intervistatori e intervistato sono consapevoli che le cosiddette scienze sociali sono spesso strumento nelle mani del "potere costituito" per il consenso a un ordine sociale. Pure ritengono che la sociologia possa svolgere un ruolo nella comprensione delle relazioni sociali». Il manifesto, 1 luglio 2014
A Zygmunt Bauman non difetta la scanzonata tendenza a mettere in relazione campi disciplinari, attorno ai quali sono state costruite mura strettamente sorvegliate dai padroni della produzione sociale della conoscenza. I suoi libri sono costellati da riferimenti letterari, filosofici, economici, televisivi e cinematografici. E tuttavia lo studioso di origine polacche non si stanca mai di ripetere che in fondo lui è solo un sociologo, una disciplina che può aiutare a comprendere il funzionamento della società. Ed è proprio dallo statuto disciplinare che prende le mosse il libro-intervista di Bauman con Michael Hviid Jacobsen e Keith Tester che ha come titolo La scienza della libertà (Erikson edizioni, pp. 160, euro 15).
Non è però la sociologia la scienza della libertà, anche se in passato è stata così rappresentata. Tanto gli intervistatori che l’intervistato sono consapevoli che le cosiddette scienze sociali sono stati spesso uno strumento nelle mani del «potere costituito» per costruire il consenso a un ordine sociale. Eppure ritengono che la sociologia possa continuare a svolgere un ruolo rilevante nella comprensione delle relazioni sociali. A patto, però, che la sociologia sia consapevole che la necessaria dimensione quantitativa e le astrazioni su cui poggia sono un modo diverso di rappresentare la vita, gli affetti, le passioni di uomini e donne al pari della letteratura, della cinematografia. Con alcune affermazioni di Bauman che suscitano meraviglia negli intervistatori. Come quando il cartografo della modernità liquida sostiene che ci sono, storicamente, alcuni romanzi che hanno avuto la capacità di cogliere la realtà sociale più di un trattato sullo stato nazione o sulle classi sociali.
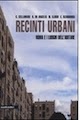 «Recinti urbani. Roma e i luoghi dell’abitare», è il titolo del libro di Carlo Cellamare, Roberto De Angelis, Massimo Ilardi ed Enzo Scandurra per manifestolibri. «Un territorio è dove si sta insieme tra esseri viventi e tra questi e la natura». Il manifesto, 20 maggio 2014
«Recinti urbani. Roma e i luoghi dell’abitare», è il titolo del libro di Carlo Cellamare, Roberto De Angelis, Massimo Ilardi ed Enzo Scandurra per manifestolibri. «Un territorio è dove si sta insieme tra esseri viventi e tra questi e la natura». Il manifesto, 20 maggio 2014
Esistono parole di cui tutti siamo convinti di conoscere alla perfezione il significato ma che poi scopriamo quanto, in realtà, siano estremamente difficili da definire. Accade così ad esempio con il termine «tempo», a proposito del quale Sant’Agostino diceva di sapere perfettamente cosa fosse, ma a spiegarlo, avrebbe trovato non poche difficoltà. È proprio a questo rimando agostiniano che si rifanno Carlo Cellamare, Roberto De Angelis, Massimo Ilardi ed Enzo Scandurra per affrontare il discorso su cosa sia un territorio, all’inizio della prefazione del loro Recinti urbani. Roma e i luoghi dell’abitare, uscito di recente per manifestolibri (Roma, pp. 126, euro 14). La risposta a tale quesito acquista un carattere dirimente e va oltre i confini del testo in questione. Gli autori, infatti, sono anche i curatori di una nuova collana, intitolata non a caso «Territori», di cui questo libro rappresenta la prima uscita. Il loro approccio alla questione, le riflessioni e le valutazioni espresse, le situazioni descritte ed analizzate, dunque, acquistano anche un valore programmatico, tendono a indicare, a iniziare a tracciare i percorsi possibili lungo i quali si inoltreranno anche i testi a venire. Il tutto non all’interno di una struttura chiusa e definita, ma al contrario in qualche maniera aperta, rizomatica quasi, in grado cioè di dare conto di punti di vista differenti, di analisi a più livelli, di approfondimenti multisettoriali.
Del resto, come affermano gli stessi autori, il problema della definizione della parola «territorio» più che risolto «può essere aggirato se partiamo dal presupposto che esso è il luogo in cui si co-abita, intesa questa come forma dello stare insieme tra esseri viventi e tra questi e la natura». E tale coabitazione, quasi mai pacifica, fa sì che «il territorio finisce per essere un luogo di conflitti permanenti», in cui vengono ad essere messi in gioco non soltanto valori e storie differenti, ma anche fattori quali l’emotività e l’affettività.
Tale concezione, che coinvolge dunque anche l’elemento culturale, quello simbolico, quello politico, emerge in questi saggi su di una città ricca di contraddizioni come Roma. E non è solo la diversa provenienza disciplinare degli autori – due urbanisti, un antropologo e un sociologo – né la diversità dei quartieri scelti come oggetto dell’indagine a garantire la molteplicità degli approcci e dei punti di vista, ma il metodo utilizzato, in grado di coniugare riflessione teorica, storia, narrazione ed esperienza vissuta.
Così, Enzo Scandurra nel suo Territorio come narrazione di forme di vita, partendo dalla concezione di territorio come suolo da sfruttare, problematicizza ulteriormente la sua definizione insistendo sul suo carattere di costruzione culturale e sul rapporto territorio-uomo-memoria.
Roberto De Angelis, invece, si concente su di una «periferia imperfetta», San Basilio, dove emerge in tutta la sua drammaticità «una caratteristica di fondo del caso italiano: la riproduzione della povertà attraverso le generazioni». Una narrazione ricca di dati, raffronti con altre situazioni come le banlieues parigine, ma soprattutto in cui si ritrovano le storie e le voci dei suoi abitanti, come quella di Nino il Sinto, da cui vengono fuori tutte le trasformazioni che hanno investito il quartiere.
Prefazione al libro Contenereil consumo di suolo in Italia. Saperi ed esperienze a confronto. Raccolta multidisciplinare di saggi a cura di Gian Franco Cartei e Luca De Lucia, Editoriale scientifica, Napoli 214
Una recensione molto critica del libro di Roberto Della Seta ed Edoardo Zanchini (Donzelli). La discussione, ovviamente, è aperta. www.bookdetector.it, gennaio 2014
Perché, come, quando si è consumato il divorzio tra la sinistra italiana e l’urbanistica? Questa è la domanda angosciosa che gli autori, entrambi attivi nella sfera politica (Pd e Legambiente) pongono nel libro, convinti della necessità di un’urgente riconciliazione. La questione è in effetti della massima urgenza, ed è senz’altro un bene che qualcuno l’abbia posta: perché è vero che la sinistra ha espulso la città dai programmi e dal vocabolario, mentre la destra se ne è appropriata, spingendo da un lato per la deregulation urbanistica a favore della speculazione immobiliare e dall’altro per una regolazione ossessiva dei dispositivi di sicurezza. Gli effetti di questo spostamento di campo e di segno sono diseguaglianza e segregazione, città sempre più estese sul territorio ma sempre più nettamente divise tra riserve per ricchi e spazi residuali per i poveri.
Fin qui siamo d’accordo, ma come è potuto succedere? Gli autori, chiusi in una prospettiva locale e assurdamente atemporale, sembrano totalmente concentrati sull’insipienza e la disonestà degli attori politici. Non sarà che fino agli anni Settanta c’era il welfare, esteso anche all’organizzazione della città? Che in buona parte del mondo occidentale, grazie allo spauracchio comunista e alle lotte dei lavoratori, venivano elaborate politiche redistributive, e quindi limitanti le prerogative della proprietà privata, anche da parte di governi e partiti conservatori, politiche che negli anni successivi sono state stigmatizzate e cancellate dall’ideologia neoliberista? E che le “sinistre” mondiali hanno aderito poi con entusiasmo ai suoi principi, da Clinton a Blair ai nostri esponenti locali?
Recensione del film di Paolo Virzì, Capitale umano: come la finanza distrugge vita e territorio. www. Dinamo, 13 gennaio 2014
Paolo Virzì ha scelto di ambientare il “Capitale umano” nella Brianza. Un territorio geograficamente omogeneo, seppur amministrativamente spacchettato in quattro capoluoghi di Provincia, considerato da sempre, nell’immaginario del nostro paese, come “ricco”. Una fabbrica totale dove attività legate alla costruzione di mobili convivono con il comparto del cuoio; le fabbriche di motori automobilistici con quelle di aerei; le lavorazioni del legno con i distretti manifatturieri; moda e design con il terziario avanzato e, naturalmente, l’edilizia. Case e fabbriche, a volte un unico edificio per tutte e due, che, in alcuni casi, hanno rappresentato fino alla seconda metà del ‘900, veri e propri saggi in cemento sull’abitare di alcuni tra i più bravi architetti italiani. Una ininterrotta città fabbrica.
Non è più così e questo, ormai, da molto tempo. La Brianza è un posto come un altro; non diverso dai moltissimi che, giorno dopo giorno, vedono scomparire i propri caratteri identitari. Succede ovunque. Anche l’intorno di Varese è oggi un luogo simile a qualsiasi provincia italiana.
Qui, tuttavia, la finanza e i suoi strumenti si esibiscono con maggiore visibilità, forti della condizione geografica del luogo rappresentata dalla prossimità di questo territorio al confine svizzero. Lì, a pochi chilometri dai cancelli delle proprie case, per decenni e decenni, i cosiddetti “imprenditori” locali hanno portato i soldi della propria rendita. Oggi, forse, è il luogo dove poter “raccattare” più facilmente, con promesse di altissimi interessi di reddito, capitali nascosti, sopravvissuti alla crisi, scudati o da riciclare. La riserva di caccia per illudere che è ancora possibile farcela, continuare a vivere di privilegi. Basta sostituire il lavoro con la nuova opportunità offerta dalla speculazione finanziaria: fare i soldi con i soldi.
Giovanni Bernaschi (Fabrizio Gifuni) vende questo sogno. Ha capito però che i capitali che servono per alimentare il suo fondo d’investimenti non si raccolgono allo sportello bancario, ma facendo di se stesso il manifesto tangibile del proprio “acume” finanziario. Giovanni e il suo fondo sono già leggenda assicurando, si dice, un più 40% su base annua. Per lavorare con soldi non suoi ha capito che oltre la propria fama di raider deve metterci dell’altro: l’immagine di una famiglia che tutto ha e tutto potrebbe avere e soprattutto la casa, il vero valore aggiunto al suo progetto.
Casa che non è a Milano. E’ volutamente lì, proprio in quella brughiera. Alta, bianca e squadrata, austera ma non solenne, con doppia scala d’accesso, ma sospesa appoggiata come è lievemente su di una collinetta dove è localizzata una piscina interna dalle ampie vetrate vista parco. Annessa c’è una zona sportiva: un campo per il tennis. In terra rossa naturalmente. Come si addice a chi, quello sport, pratica da sempre.
Una casa che segna un territorio, oggi devastato proprio dalle case: quelle degli altri
.Paolo Virzì, come fatto da Matteo Garrone in Reality, ci sbatte subito in faccia il disastro territoriale di questa eccedenza edilizia, facendoci atterrare, dopo una ripresa dall’alto, all’interno di una porzione dell’enorme villettopoli spalmata senza misericordia alcuna nell’hinterland a nord di Milano.
Le case, per Virzì, sono importanti. Le ha sempre scelte praticando una sorta di geografia duale, quale esemplificazione microspaziale, per raccontarci i diversi personaggi che incontriamo nelle sue storie. Succede in Ovo sodo; con i lividi palazzi della “Corea” livornese contrapposti alla raffinata edilizia del lungomare dell’Ardenza o, ancora ultimamente, in Tutti santi giorni dove la casetta a schiera di Acilia, con i rassicuranti riti di buon vicinato nella periferia romana, misura la distanza siderale con l’abitare metropolitano di San Lorenzo.
Giovanni Bernaschi usa anche il tennis per fare promozione. Lui vuole vincere non giocare. Componendo le coppie, dosando gli inviti, tesse le proprie relazioni. Anche Carla (Valeria Bruna Tedeschi), la moglie ex attrice strappata al palcoscenico, ha questo ruolo. E’ tutto uno con quella casa. Si muove silenziosa tra le molte stanze e quando esce stressa l’autista perché non è mai sicura dei suoi giri in città. Guida la macchina solo quando sa dove deve andare. Non è però la provincia a starle stretta né quella vita dorata, quanto piuttosto che marito e figlio la considerino un accessorio. Il marito non le spiega nulla di quello che fa e Massimiliano, il figlio fragilissimo, risponde alle sue domande dicendole di non “cagarle il cazzo”.
Carla non si stupisce più di tanto, né fa una piega quando, sembrandole impossibile che nel territorio dove vive stia per scomparire anche l’ultimo teatro - quello dove aveva debuttato Tino Buazelli - lo dice al marito e questo, che ha come rifermento il mondo, esclusivamente via conference-call, le domandi se sia proprio così importante.
Lei si è ritirata da molto tempo dal teatro, lui lo costruisce quotidianamente. Gli aderenti al suo fondo, i suoi soci, i propri dipendenti, non sono forse, al tempo stesso, suo pubblico e suoi attori?
Tutti a muoversi secondo il copione scritto dalla finanza vorace. Quella che non guarda in faccia nessuno, capace di far credere possibile ad un piccolo imprenditore edilizio che è meglio barattare mattoni e progetti con investimenti finanziari. Il gancio tra i due sono proprio i rispettivi figli, entrambi alunni di una scuola per fighetti, che tra loro stanno concludendo, senza dirlo ai genitori, una storia.
Così Dino Ossola l’immobiliarista brianzolo (interpretato da un supremo Fabrizio Bentivoglio capace di trasmettere perfettamente l’ambiguità del personaggio) fa il grande balzo. Sostituisce cementi e rogiti con soldi. Costruire e vendere case è un mestiere che non può finire perché, dice: “di case e bare ce ne è sempre bisogno”. Solo che, almeno delle prime, si è un po’ esagerato; ce ne sono tante, troppe e da qualche tempo sono destinate a restare vuote. Lui lo sa perché la crisi morde anche lui, tanto che ha già venduto ai cinesi una parte del suo ufficio. Ora vuole recuperare: riprendersi quello che dice spettargli: il poter continuare a lucrare rendita, il facile arricchimento, il non essere schiacciato dal governo della finanza del mondo, dalle sue nuove regole del gioco.
Vuole recuperare nell’unico modo che conosce: come ha sempre fatto. Prende i soldi che non ha grazie all’aiuto di un compiacente direttore di filiale millantando businnes plan di lavori inesistenti. Li tiene fuori da lavoro. Li investe nel fondo di Bernaschi.
Lo fanno tutti, anche, soprattutto, le banche perché non dovrebbe riuscire a lui? Solo che i conti non tornano perché questo fiume di denaro è destinato a vivere sollevato da terra a muoversi nello spazio altissimo e vastissimo rppresentato dalle oscillazioni valutarie, dalle scommesse sui titoli. Non è facile tirarlo giù quando si sta con l’acqua alla gola; trovarselo in quella strada dove vivi, dove scorre la vita; farlo atterrare secondo programma nella sua casetta con giardinetto, su due livelli simile alle centinaia con cui è costruita la lottizzazione.
La casa di Ossola e quella di Bernaschi, anche se dimensionalmente diverse e architettonicamente distanti, hanno una cosa in comune. La cucina ovviamente c’è ma, nei sei mesi dell’arco temporale in cui è raccolta la vicenda, non si vede mai un pranzo domestico. Nessuna delle due famiglie consuma pasti insieme. Né nella grande casa. Né nella villetta. La prima solo feste nel parco. La seconda solo passaggi veloci su tavoli multiuso, dove tracce di cibo si accostano a libri, computer, risultati di ecografie della compagna dell’immobiliarista (Valeria Golino), psicologa della Asl, attualmente inattesa di un parto gemellare.
Spazi non casa. Dove ognuno è solo con se stesso certo che così facendo, cullandosi nel proprio egoismo, farà il bene di chi gli sta intorno. Si sentono i genitori migliori del mondo. Perché loro il mondo lo sanno governare. Sanno quando c’è d’alzare la posta. Lo fanno perché vogliono i loro i figli vincenti e felici. Ognuno fa questo dal proprio singolo punto di osservazione. Virzì compone il film sezionando un medesimo avvenimento a loro ancora ignoto, ma che noi conosciamo fin dall’inizio della storia, attraverso tre capitoli che rappresentano come Carla, Dino e sua figlia Serena vivono quello che è successo, che sembrav non aver nessun rapporto con la loro vita, ma che, invece, gli precipiterà addosso .
Serena e Massimiliano, i figli, sono differenti dai loro genitori e tra loro. Mentre il ragazzo non riesce a vedersi fuori dai propri agi e il ruolo di privilegiato che la figura paterna gli assegna d’ufficio, Serena, la ragazza, saprà uscire fuori da questo mondo fatto di feste, sballi, automobili, repliche in piccolo delle mille sopraffazioni sociali di cui sono campioni i propri genitori , i loro amici, i loro avvocati. Saprà guardarsi intorno e non aver paura di quello che, a prima vista, le pare così distante da lei. Gli altri, i grandi, faranno quello che hanno sempre fatto, vivere di ricatti, tristi scopate, le isteriche scenate di un intellettuale meridionale che era convinto di tirar fuori, dopo un rapido amplesso con Carla, il proprio talento da uno squallido condominio, arredato come un foyer teatrale, passerelle dei politici di turno con l’assessore leghista con la suoneria del telefonino tarata sul Nabucco, preti beoti impacciati e deferenti presentatori di ragazzi-bene, amiche galleriste con le ultime cose appena arrivate dall’India, e tanti, tanti, comprimari per le feste nel parco. Sempre disponibili ad arraffare le briciole.
Non è la Roma di Sorrentino né la provincia brianzola. E’ l’Italia. Già affondata quando, ma è successo ormai da tempo, ha iniziato a ”tabellare” il valore di una vita secondo parametri finanziari. Quella del cameriere ucciso sul bordo della strada da una manovra avventata - è questo l’avvenimento che tiene insieme tutta la storia - vale poco più di duecentomila euro. Una cifra che il finanziere Bernaschi non accetterebbe di prendere neppure in considerazione accogliendo gli ospiti nella sua casa in cui si decide come saranno calpestati magari dal giorno dopo.
Virzì riesce a comporre tutto questo come un giallo rendendo tutti gli attori (protagonisti e comprimari) assolutamente credibili. Il sorprendente montaggio di Cecilia Zanuso ci fa sentire come spettatori di un set di diapositive, che non sono però ricordi di un viaggio già fatto, ma di quello verso cui vorrebbero trascinarci tutti.
Nel saggio di Francesco Erbani (Una vita per la città, il paesaggio, la bellezza, Corte del fòntego editore) ), le battaglie del fondatore di Italia Nostra per il territorio. La Nuova Venezia, gennaio 2014
«Non è a dire che io sia un vero giornalista, mi mancano tante qualità dei giornalisti. Ma grazie al cielo anche tanti difetti. Io mi vanto di aver scritto cose che in una repubblica ben ordinata sono ovvie... E a dir il vero scrivo sempre lo stesso articolo». Così Antonio Cederna, padre nobile dell'ambientalismo italiano, descriveva se stesso. «Sempre lo stesso articolo». L'amarezza di dover insistere sull'incuria del territorio, il saccheggio e il dissesto idrogeologico. Per ritrovarseli sempre davanti a ogni tragedia. Due giorni sulle prime pagine, poi tutto come prima.
La figura di Cederna, archeologo, giornalista e scrittore, autore di battaglie e denunce storiche sul "saccheggio del territorio" rivive grazie alla ristampa a cura della casa editrice veneziana Corte del Fontego del saggio del giornalista di Repubblica Francesco Erbani. «Una vita per la città, il paesaggio, la bellezza», è il titolo eloquente del volumetto. Che raccoglie testimonianze e documenti su colui che è stato uno dei capostipiti del movimento per la tutela della natura e della storia in Italia. Fondatore di Italia Nostra, giornalista al Mondo di Pannunzio insieme a Eugenio Scalfaci, poi al Corriere della Sera e a Repubblica, Cederna era conosciuto per i suoi attacchi senza paura a speculatori e cementificatori. la Società immobiliare nella Roma degli anni Sessanta, ma anche consorzi e imprese che hanno nel Dopoguerra "cementificato il territorio" attentando alla bellezza del Paese ma anche alla sicurezza di chi ci vive. «Scrivo da sempre lo stesso identico articolo, finché le cose non cambieranno continuerò a farlo», ripeteva Cederna, secondo la testimonianza della sorella Camilla. Così sui luoghi dell'alluvione della sua Valtellina ricorda le migliaia di vittime causate da alluvioni e inondazioni. «Le catastrofi sono sempre prevedibili», diceva citando il geologo francese Marcel Roubault, «non venitemi a parlare di fatalità». Si batteva come un leone contro le grandi opere ritenute inutili, a cominciare dal Mose a Venezia, dalle nuove strade in programma sui terreni antichi della via Appia a Roma.
Fu il primo a teorizzare la necessità di tutelare i centri storici, assediati dal cemento. «Non i singoli monumenti, ma gli interi centri storici». Si battè per la restituzione di palazzo Bar-berini, diventato circolo ufficiale dell'Esercito, a sede espositiva, per i nuovi Fori, che adesso la giunta capitolina prova a recuperare. Da parlamentare della Sinistra indipendente firma la rivoluzionaria - e mai applicata - legge sulla Difesa del suolo, nel 1989, dopo aver avuto come consulenti il veneziano Luigi Scano, Stefano Rodotà, Franco Bassanini. «Difficile stringere Cederna in una definizione», scrive nella postfazione Erbani, «ha dedicato all'urbanistica, all'uso dissennato del suolo, alla salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio le energie migliori e le riflessioni più innovative».
Un libro di Roberto Cuda, Strade Senza Uscita. Banchieri costruttori politici (editore Castelvecchi) per chi vuole capire, a un tempo, quanti sporchi interessi si nascondano dietro le devastanti politiche autostradali italiane e quanto sia grave, nonostante il gigantesco dispendio di risorse pubbliche, il deficit della mobilità.
Risorse che nessuno ha, semplicemente indebitando e pregiudicando il futuro, come dimostra in modo inesorabile questo testo di Roberto Cuda, che svela gli intrecci tra concessioni autostradali, consigli di amministrazione, imprese di costruzioni, banche e politica: una lunga storia di affari, inchieste e politiche assenti o sbagliate nel campo dei trasporti.
Una storia partita nel dopoguerra con l’avventura autostradale degli anni '60, poi fermata a causa della crisi petrolifera e dei conti che non tornavano, come certificò la Commissione Adorisio nel 1975, e come scrisse lucidamente l'ing. Guglielmo Zambrini su questioni di mobilità, trasporti e territorio intorno alla Politica autostradale e Programmazione.
Poi il tentativo di rilancio negli anni ‘80 con il Piano Decennale di grande viabilità, di nuovo fermato nel 1992 dalla magistratura con le inchieste “mani pulite” su “tangentanas”, che provocò un brusco arresto, non solo a parole ma molto concreto, di un intero sistema affaristico e politico legato alla costruzione di strade ed autostrade.
Dalla fine degli anni ’90, riparte il rilancio dei progetti autostradali grazie alla proroga generalizzata della durata delle concessioni invocata per realizzare nuovi investimenti grazie alle tariffe da incassare - in genere ventennale ed autorizzata proprio dai fautori del libero mercato. Poi la privatizzazione delle concessionarie pubbliche, a partire da Autostrade per l’Italia, autentica gallina dalle uova d’oro dell’I.R.I., ceduta ai privati proprio quando - realizzati a carico delle casse pubbliche i maggiori investimenti - era giunta l’ora di incassare dai pedaggi e ripagare il pesante debito pubblico generato. Basta scorrere il libro del prof. Giorgio Ragazzi, I Signori delle Autostrade, per questa storia poco edificante per l'interesse pubblico.
Infine, come documenta benissimo questo libro, si ripropone la solita vecchia lista di autostrade da realizzare con la nuova Legge Obiettivo voluta dal Governo Berlusconi nel 2001 per semplificare la realizzazione di grandi opere “strategiche” ma aggiornata con nuove parole d’ordine: il Project Financing, l’autofinanziamento, il mercato che paga le grandi opere. Proprio su questa ultima fase si concentra la rigorosa ricerca di Roberto Cuda, smascherando con dati incontestabili che non si tratta di capitale di rischio messo da soggetti privati, che non è vero che le nuove autostrade si ripaghino da sole con i pedaggi, e certificando la prudenza delle banche e dei fondi d’investimento a sostenere le nuove opere.
Grandi proclami e pompose inaugurazioni ma che dietro hanno il vuoto dei piani economici e finanziari, in realtà sempre protetti da garanzie pubbliche che assumono via via nuove forme ma senza in realtà cambiare la sostanza: l’allungamento della durata della concessione, il contributo a fondo perduto, il valore di subentro alla scadenza della concessione, il commissario straordinario, la vendita (o svendita) di azioni delle concessionarie pubbliche per far quadrare i conti, il “Prestito Ponte” delle banche in cambio di garanzie pubbliche, l’intervento della Cassa Depositi e Prestiti, il Proiect Bond, ed infine il credito d’imposta con la defiscalizzazione per aiutare i soggetti privati a realizzare le nuove autostrade, di recente approvazione.
Ed è proprio su questo crescendo di finanza “privata” in realtà garantita dal sistema pubblico che si concentrano diversi capitoli fondamentali di questo testo, arrivando a dimostrare che molte delle principali opere inaugurate di recente - come la Tangenziale Est Esterna di Milano o la Pedemontana Veneta - hanno finanziamenti e garanzie solo per piccoli lotti, creando dunque le premesse per opere incompiute, nuovi debiti per i futuri bilanci dello stato, e soprattutto per alimentare una pressione indebita verso la politica e le istituzioni, per trovare le risorse per il completamento delle opere già in corso.
E’ una vecchia tattica sempre utilizzata in modo consapevole dai fautori delle autostrade che gli ambientalisti ben conoscono: quando si propone un nuovo progetto l’opera si ripaga da sola in autofinanziamento e quindi come possono lo Stato, i Comuni ed i cittadini non accettare un simile regalo? Poi quando si passa alle approvazioni ed i costi crescono allora si cercano garanzie e soldi pubblici per far partire almeno un pezzo di nuova autostrada. Ben sapendo che poi una volta avviato il cantiere si metterà in moto un intero sistema territoriale per evitare l’incompiuta e lo scempio, che chiederà a gran voce - a partire da Comuni e Sindacati - il completamento dell’opera.
“Strade senza uscita” descrive in modo preciso e documentato chi sono i protagonisti ed i personaggi di questo “sistema” viziato, a partire dal mondo delle imprese di costruzioni, delle banche e della finanza, in realtà “porte girevoli tra politica e concessionarie” autostradali, spesso con forte contiguità se non con l'impegno diretto, nei Partiti ed in Parlamento, che decide (o dovrebbe decidere) le regole del settore. Cosi come parla di “sottobosco dell'illegalità”, raccontando di numerose inchieste della magistratura, che hanno coinvolto molti protagonisti del sistema, sia sul fronte delle imprese, delle banche che della politica.
Ma il libro che state per leggere non è solo di denuncia sul “sistema autostrade” ma contiene anche una significativa analisi sulla politica dei trasporti e sul deficit infrastrutturale che pesa sul nostro paese, dove tra studi e confronti con altri paesi europei, si capisce che il vero deficit in Italia è nelle città e nelle aree urbane, dove mancano davvero chilometri e chilometri di reti metropolitane, tranviarie, ferrovie locali e servizi per i pendolari, per essere allineati alle più competitive ed efficaci esperienze delle città europee. Qui dovrebbero concentrarsi le scarse risorse pubbliche e tutte le garanzie e protezioni pensate per il sistema autostradale italiano, per migliorare la mobilità urbana dove si spostano due terzi della popolazione, per aprire cantieri utili, per dare occupazione e sostegno ad un green new deal utile al Belpaese.
Racconta anche dell'impegno di ambientalisti, associazioni e comitati sparsi sul territorio per contrastare le autostrade sbagliate, capaci di leggere gli impatti ambientali, i piani finanziari gonfiati o inesistenti, smascherare proposte superate e dati di traffico, ed anche proporre alternative, magari con l'aiuto di esperti, credibili e praticabili al modello “tutto strada”.
Che fanno propria la famosa frase di Goudevert, ex presidente della Ford Germania: “Chi semina strade e parcheggi, raccoglie traffico e code”, riportata anche nel testo, che insieme a dati aggiornati su ambiente, salute, consumo di suolo, tutela del paesaggio e del territorio agricolo, futuro dell'auto e fine del petrolio, spiegano l'impatto ambientale e l'assenza di una strategia “capace di futuro” che sta sempre dietro queste scelte che vengono dal passato e vengono riproposte senza troppe domande per il futuro “all'infinito”.
Alla fine tra le tante sensazioni che si ricavano dalla lettura di “strade senza uscita” ne resta una amara verso la maggioranza trasversale della politica pubblica: che anche quando non è apertamente complice del sistema insieme a banche e costruttori, risulta insensibile e debole, senza una politica dei trasporti che orienti in modo coerente le scelte verso la sostenibilità economica ed ambientale. Senza la capacità di contrastare in mondo lungimirante la lista delle grandi opere, più preoccupata di una “valutazione di impatto elettorale” di breve periodo con l'annuncio dell'opera, piuttosto che ad offrire soluzioni durature ai problemi in tempi di crisi economica ed occupazionale. Incapace di definire regole e vigilanza per fare “l'interesse pubblico” nel sistema dei trasporti e delle infrastrutture, diventando quindi ostaggio di un sistema potente come quello delle concessionarie autostradali, capace di orientare la comunicazione, le opinioni, se non direttamente il sistema di finanziamento ed elezione del sistema politico.
Un libro quindi da leggere e conservare, questo “Strade senza uscita” scritto da Roberto Cuda, da aggiungere come un nuovo ed attuale capitolo ai testi di impegno civile scritti per far prevalere l'interesse pubblico e collettivo e contrastare “l'abbraccio mortale tra banche, costruttori e politici” sulle nuove e vecchie autostrade italiane.
Stralcio dalla relazione introduttiva alla presentazione del libro: Lezione di piano. L'esperienza pioniera del PPR della Sardegna raccontata per voci (Corte del fontego editore), Sassari, 9 dicembre 2013. La Nuova Sardegna, 8 dicembre 2013
1. Dalla tragedia del 18 novembre c’è stato un susseguirsi di inchieste, accompagnate da accuse reciproche di responsabilità. Ma se a questa fase di allarme non segue quella della riflessione e degli impegni concreti in termini di cambio di linea nel governo del territorio, tutti dovremmo essere consapevoli che ci saranno altre tragedie e altri morti, come immediatamente dopo è accaduto nelle regioni del centro-sud.
Partiamo dalle responsabilità. Gli attori pubblici e privati che hanno concorso agli scempi territoriali sono molti e riguardano le politiche urbanistiche e di governo del territorio italiano degli ultimi 50 anni. Intendendo per politiche tanto i piani adottati seguendo la logica che riempire il territorio di cemento equivalga a sviluppo economico, quanto tutte quelle forme di “disattenzione” delle istituzioni verso i numerosi cittadini che hanno aggirato le regole perché considerate inutili. Sono queste politiche (e connivenze di vario tipo) ad aver prodotto le numerose e continue emergenze ambientali.
Qualche esempio: 2008 Capoterra, alluvione luttuosa ma del tutto prevedibile per l’edificazione diffusa sul letto di un fiume; 2010 San Fratello, un paese nella provincia di Messina che è franato coinvolgendo circa 1500 persone costrette a rifugiarsi altrove. Lo stesso si può dire per paesi della Calabria come Maierato, Pizzo Calabro; 2011 le inondazioni in Veneto e Campania; 2012, lo stesso è avvenuto a Massa in Toscana e poi in Liguria. E ora il disastro colposo di queste ultime settimane. Naturalmente l’elenco è ben più lungo e riguarda l’Italia intera. In questo dissesto la Sardegna è ai primi posti perché, pur essendo tra le regioni meno popolate del Paese in relazione all’estensione del territorio, è anche tra le regioni più compromesse, nonostante qualche illustre opinionista abbia recitato il contrario.
Oggi la popolazione italiana si è mossa generosamente per aiutare i sardi; ieri lo ha fatto per aiutare altre regioni, domani lo farà sicuramente per altre calamità non naturali. Passata l’ondata emotiva, chi si ricorderà di ciò che è accaduto, se già sta diminuendo l’attenzione verso quel che è successo appena tre settimane fa? Tanta retorica della politica, grandi enfasi mediatica, scarsa memoria e, soprattutto, sguardo cieco sul futuro.
2. Non ci sono numeri certi in merito alle edificazioni e al consumo del suolo, vi sono per lo più stime che si sovrappongono. Eppure, basterebbe che ogni Comune fosse obbligato a tenere un registro del consumo del suolo e lo rendesse pubblico, magari mettendo un tabellone luminoso sulle pareti del Municipio con la scritta: Oggi abbiamo sottratto alla terra tot metri. Servirebbe a tenere alta l’attenzione sociale e a renderci più consapevoli del danno che provochiamo con i nostri modelli di vita.
Nonostante l’inadeguatezza dei numeri parto da alcuni dati dell’Istat, Agenzia delle Entrate, Regione Sardegna.
a) Dall’analisi dei dati Istat nell'arco temporale 2001/2011 in Italia vi è stato un incremento delle località urbanizzate pari a 20mila Km2, il 6.7% della superficie totale nazionale. Il paragone utilizzato dall’allora presidente Giovannini (attuale ministro del lavoro) è che, in appena dieci anni, si è consumata una superficie superiore all’intera Puglia e ciò è dovuto specificamente ai modelli urbanistici che si sono consolidati in anni recenti. E ancora, dal 1995 al 2009, i comuni hanno rilasciato permessi di costruire per 3,8 miliardi di metri cubi (oltre 255 all’anno) di cui l’80% di nuovi fabbricati. Che equivale a dire che (astrattamente) ogni italiano è stato autorizzato a realizzare circa 20 metri cubi. Queste autorizzazioni sono state incrementate dai cosiddetti Piani Casa di cui ogni amministrazione regionale si è rapidamente e convulsamente attrezzata: basti pensare che, proprio in relazione al Piano Casa, negli ultimi anni c’è stato un aumento fino al 29% del totale della quota di permessi rilasciati per incremento volumetrie.
Naturalmente la spinta al consumo del suolo non è stata omogenea. Nelle regioni del Nord vi è stato un rallentamento dovuto soprattutto alla crisi economica perché il calo delle cubature ha riguardato le strutture destinate alle attività produttive. Mentre nel Mezzogiorno sono state individuate 1.024 nuove località abitate (sempre fonte Istat), valore di molto superiore alle altre aree del Paese. Ma il dato veramente rilevante è che le percentuali più alte di questi nuovi agglomerati riguardano tre regioni. Nell’ordine decrescente, rispetto al totale delle località, troviamo la Sardegna (20,5%), seguita da Puglia (18,7%) e Sicilia (11,1%).
La Sardegna si trova al primo posto, seppure sia la regione che si caratterizza per gli ampi spazi, un tempo agricoli e pastorali, ora per lo più abbandonati; per il tessuto urbanizzato abbastanza debole, tranne che in alcune e delimitate aree (Cagliari e Sassari); per il calo demografico non compensato neppure dal movimento migratorio in entrata, anche perché va crescendo quello in uscita. Nella nuova pressione dell’urbanizzazione ha avuto, invece, un ruolo centrale un modello di turismo basato sul consumo di territorio.
b) Dai dati dell’Agenzia delle Entrate, riferiti alle cosiddette case fantasma in Sardegna vi sarebbero 19.229 immobili sconosciuti al Catasto e con rendite presunte complessivamente per oltre 16.559 milioni di euro.
Il cosiddetto Piano Paesaggistico dei Sardi, esplicitamente contrapposto al PPR della Giunta Soru, si inserisce in questo quadro, incorporando le disposizioni del Piano Casa e della legge sui campi da golf che possono incidere anche sulla fascia costiera e sui 300 metri; riportando in vita tutte le lottizzazioni che il PPR aveva bloccato (secondo Legambiente sarebbe un volume complessivo di 15 milioni di metri cubi) inserendo un insieme di deroghe e ammettendo l'attuazione di zone turistiche con un semplice atto di concerto RAS - Provincia - Comune; consentendo costruzioni in agro anche non in funzione dell'agricoltura.
Usando le parole di Cappellacci al meeting sul turismo tenutosi a Olbia il 30 novembre “la Sardegna è la stessa del 17 novembre: The show must go on". E che i familiari delle vittime si rassegnino.
Recensione di due libri su una parola «abusata e tradita»: partecipazione. uno recente, Competenza e rappresentanza, a cura di Cristina Bianchetti e Alessandro Balducci (Donzelli), e uno antico, Architettura come partecipazione, di Giancarlo De Carlo del 1971, ( Quodlibet). Il manifesto, 27 novembre 2013
Non c'è parola più abusata e tradita riferita all'urbanistica e all'architettura che «partecipazione». Accade, infatti, che quanto più urgenti siano le risposte che i cittadini chiedono alle istituzioni perché vengano soddisfatti i loro bisogni, altrettanto deludente si dimostri il loro coinvolgimento nei programmi delle amministrazioni pubbliche. Gli esempi sarebbero infiniti e ormai è una costante il ripetersi del conflitto tra abitanti di una città o di un territorio e i loro rappresentanti istituzionali.
Dal nord al sud dell'Italia sono innumerevoli i casi nei quali l'assenza di politiche ambientali, industriali e sociali esasperano la soluzione dei problemi anche i più semplici: i processi inclusivi sembrano estranei alla cultura di qualsiasi soggetto decisionale, inoltre l'eccesso di burocrazia non ne agevola le soluzioni. In modo confuso si fa riferimento alle politiche di coesione europee, alle «buone pratiche» messe in atto in molte nazioni per agevolare la partecipazione dei cittadini al governo della città, ma è frustante vedere come da noi accade il contrario.
Temi quali quelli di sostenibilità o di recupero urbano che ovunque contemplano processi partecipativi, nella maggioranza dei nostri comuni si disperdono in lunghissimi iter procedurali tra il cattivo uso delle risorse finanziarie e l'obsolescenza dei progetti. Così non si fa che riprodurre altra «ingiustizia spaziale» oltre a quella già esistente. Riflettere sull'importanza della partecipazione implica però, come ben sappiamo, esaminare il rapporto della gente con la classe politica e verificarne la loro capacità di attuare programmi efficaci rispetto la questione urbana.
Soggetti autoreferenziali
Il saggio Competenza e rappresentanza (Donzelli, pp.VI-108, euro 24) a cura di Cristina Bianchetti e Alessandro Balducci, affronta l'argomento della partecipazione all'interno delle più vaste problematiche che hanno riguardato negli ultimi vent'anni le trasformazioni delle competenze tecniche, quindi il ruolo degli intellettuali o degli «esperti», nel loro difficile confronto con le istituzioni della politica e i cittadini. Il saggio prende spunto dalla lectio magistralis che Alessandro Pizzorno fece a Torino nel 2011 in occasione della XIV Conferenza della Società italiana degli urbanisti. Scrive Pizzorno che tre sono le vie che conducono i cittadini al potere politico: «una è fondata sul principio di proprietà, una sul principio di competenza, una sul principio di maggioranza».
La democrazia rappresentativa che si fonda sul principio di maggioranza numerica deve fare innanzitutto i conti con l'insoluta questione dell'uguaglianza economica tra gli individui. Questo è il primo «fraintendimento» di qualsiasi sistema politico perché non può mai rappresentare gli interessi «diversissimi da elettore a elettore». Poiché sono i membri del parlamento - gli «eletti del popolo» - a rappresentarli succede, come scrive Pizzorno, che le differenti domande dei cittadini «non possono presentarsi altro che come indeterminate e non sintetizzabili».
La nascita dei partiti politici se è vero che ha permesso di «socializzare alla vita politica una popolazione» d'altra parte ha fatto sì che la fedeltà ideologica invece della competenza li trasformasse in soggetti autoreferenziali diffidenti verso i tecnici. Oggi i politici di professione compongono per Pizzorno un «sistema rappresentativo per campioni» e l'istituzione elettorale è diventata una gara sportiva. «Il richiamo alla sovranità popolare - scrive il sociologo triestino - si presenta semplicemente come sotterfugio concettuale per giustificare la classe politica stessa».
È difficile stabilire quali spazi possano ancora esserci per «raddrizzare» il sistema della nostra democrazia rappresentativa che, in ogni caso si disegni, «esce storta» alla prova dell'incapacità dei governi di decidere sul futuro dei cittadini. Un'astratta concezione riformista della politica pensò che il principio di maggioranza potesse garantire sulla qualità delle competenze, quindi dei programmi e delle scelte, ma così purtroppo non è successo. A partire dalle vicende di Tangentopoli, con la crisi dei partiti e la «disarticolazione» della politica, si sono prodotte le più devastanti modificazioni della città che hanno visto gli urbanisti assecondare le richieste dei politici che dal dopoguerra sono spesso stati scelti in base al criterio di «premiare coloro che avevano portato maggiore aiuto al partito» (Pizzorno). Purtroppo come scrive Alessandro Balducci nella sua incisiva postfazione: «una parte non irrilevante della produzione mediocre dell'urbanistica italiana dagli anni sessanta fino a tutti gli anni ottanta si spiega anche così».
In quella stagione della storia recente del nostro paese poche sono state le esperienze di coinvolgimento dei cittadini nella progettazione urbanistica. In assoluto, tra le più rilevanti, dobbiamo ricordare quelle di Giancarlo de Carlo a Rimini e a Terni. Gli scritti dell'architetto genovese su quelle esperienze sono ora riproposti nel saggio L'architettura della partecipazione (Quodlibet, pp.144, euro 14). Il titolo riprende quello della conferenza che De Carlo tenne nel 1971 al Royal Australian Institute of Architects di Melbourne, chiamato per ultimo dopo Jim M. Richards e Peter Blake a rispondere alla domanda su come si sarebbe contrassegnata l'architettura degli anni '70. Per scoprirne la straordinaria attualità, sebbene siano trascorsi molti anni, sarebbe utile partire proprio da questo intervento per riprendere un discorso interrotto e spesso travisato sul tema della partecipazione. Scrive Sara Marini nell'introduzione che De Carlo «disegna una visione sfaccettata della partecipazione, caratterizzata da un marcato astio verso ambigue utilizzazioni e facili strumentalizzazioni della stessa».
È assodato, infatti, che i «conformismi» e le «retoriche salvifiche» (Bianchetti) furono anche una sua preoccupazione. Il dato certo è che De Carlo è stato il solo a verificare sul campo la complessità dell'architettura della partecipazione che in molti casi lo ha visto perdente com'è successo a Rimini quando, incaricato di intervenire nel centro storico della città romagnola i suoi contributi - «concreti, realistici, strutturalmente eversivi» (Zevi) - finirono in un nulla di fatto. Sarà così ad Ameglia, come ricorda Pizzorno nel saggio precedente, dove De Carlo sarà «messo in minoranza da una maggioranza». Negli anni settanta, però, le competenze di un urbanista si collegavano alle politiche riformiste di partiti interessati a trasmetterle nelle istituzioni oltre che a impossessarsene essi stessi.
Tutto il contrario di quanto accade oggi: il «gioco della deliberazione» esclude qualsiasi dialettica tra tecnici e politici. «La differenza tra deliberazione e rappresentanza - ci ricorda Pizzorno - è che nella prima la discussione mira a far tacere gli interessi dei partecipanti; nella seconda è il contrario». In merito a queste differenze, De Carlo è stato ancor più esplicito. Egli comprese che nell'epoca postindustriale è il processo della cooptazione dei saperi da parte dell'architetto-urbanista a causare il «disastro sociale e politico» perché «divide gli esperti, quelli che 'sanno' e 'sanno fare' da quelli che non sanno neppure 'perché' si fa».
A Terni, con il Villaggio Matteotti progettato per gli operai delle Acciaierie, l'architetto genovese trasforma un agglomerato di case malsane in un esemplare progetto di riqualificazione urbana. Sottopone al giudizio della direzione aziendale e del consiglio di fabbrica cinque ipotesi di intervento. Tra queste esclude sia quella di incremento speculativo delle cubature sia quella di un inutile maquillage dell'esistente, per scegliere quella che consisteva nell'edificare tre piastre sovrapposte entro le quali inserire le abitazioni, i servizi con i loro collegamenti pedonali. La cronaca narrata da De Carlo conserva ancora la sua carica di suggestione nella spiegazione di come la tipologia delle abitazioni, così come la nuova configurazione del quartiere, si definiscono solo chiarendo prima i bisogni reali «complessivi» e poi quelli «specifici» dei 1800 operai che avevano bisogno di una casa.
Se è stata la «tensione rinnovatrice» a produrre quell'esperienza, è la «chiarezza» della lezione decarliana l'elemento più importante che l'ha sottesa. Senza la chiarezza non c'è comunicazione tra gli individui, quindi è impossibile finalizzare il risultato di una buona «organizzazione urbana».
Imporla non è compito delle istituzioni che non sono di loro «sagge, giuste, sane». Inoltre, anche le tecniche, le regole e le poetiche messe a punto nel secolo scorso dalla modernità architettonica hanno mostrato tutti i loro limiti pretendendo di modificare in modo assoluto comportamenti e abitudini. In questa fase esasperata dell'«idolatria della tecnologia alta» (smart grid city), l'urbanistica che nella città delle reti svilupperà forme e spazialità sempre più innovative e complesse, dovrà essere valutata nelle sue capacità di socializzazione, altrimenti per il prossimo futuro non si vedranno che crescere disagio e disuguaglianze.
«Il documentario vincitore del Leone d'Oro è un'esplorazione raffinata del paesaggio extraurbano contemporaneo, una testimonianza sottile e non giudicante degli esiti prodotti dall'occupazione crescente di territorio da parte del sistema della circolazione automobilistica»
Ammetto di essere fraquelli che vanno al cinema conoscendo volutamente solo il titolo delfilm. Così è stato anche per Sacro GRA, sebbene il conferimento del“Leone d'Oro 2013” abbia fatto in modo che si parlasse di questodocumentario e, volente o nolente, se ne svelassero alcuni contenuti,ovvero storie di vita legate al grande anello stradale che abbracciala città di Roma. Alla fine del film, in realtà, le storie e levicende hanno raccontato anche molto altro.
Sotto questo profilo, lascelta di Gianfranco Rosi di fissare lo sguardo sulla quotidianitàdi esistenze assai eterogenee restituisce una varietà di narrazioniche si sono sedimentate nel tempo attorno al grande raccordo anularee che, al contempo, appaiono piuttosto simili nel trasmettere unsenso di solitudine ed emarginazione. Così, ad esempio, un occhiosilenzioso spia il trascorrere di un'intera giornata fra le paretidei mini alloggi di edilizia popolare, costruiti evidentemente nelleimmediate vicinanze del principale aeroporto italiano, visto ilcontinuo passaggio di aerei a bassa quota che con il loro frastuonospezzano sequenze di lunghi silenzi, interni ed esterni.
Sintetica recensione di un episodio tipico de"patrimonio all'Italiana", puntualmente raccontato da Stefano Boato nel recente libretto della collana "Occhi aperti su Venezia" Corte del Fòntego editore. Il Fatto Quotidiano, 13 novembre 2013
Ora Stefano Boato, professore di Urbanistica allo Iuav, ripercorre puntualmente la vicenda in un utile libretto (“Giù dalla torre”) appena uscito nella collana “Occhi aperti su Venezia”, pubblicata da Corte del Fontego, che è un vero presidio civico. Nella primavera del 2012 la Torre catalizza le Larghe Intese anche in Laguna, riuscendo a essere dichiarata di interesse pubblico sia dalla Regione Veneto (Lega) sia dal Comune (Pd): senza un piano finanziario, senza che le aree siano proprietà di Cardin. A luglio arriva il parere negativo dell’Enac: il birillo è così alto da mettere in serio pericolo i voli del Marco Polo. Ma solo a novembre una enorme pressione politica indurrà l’ente a rimangiarsi il no, e a dare luce verde. Si oppone strenuamente Italia Nostra, Vittorio Gregotti definisce la torre “un’enorme porcata", Franco Miracco la martella dai giornali veneti, Settis la affonda su Repubblica e anche il Fatto fa la sua parte.Un anno fa il Mibac fa notare che un vincolo impedisce di costruire la Torre: ma il sindaco Orsoni minaccia di impugnarlo (e ci sarebbe mancato solo questo!).
Ma i colpi di scena non sono finiti: quello decisivo arriva dallo stesso Cardin, che dopo aver fatto capire che avrebbe sborsato due miliardi e mezzo di euro senza rivolgersi alle banche, a dicembre non riesce a trovare nemmeno 20 milioni per comprare i terreni. Sipario: fine ingloriosa della sceneggiata. E la liberazione dalla Torre-che-non-c’è ha una morale positiva, nelle parole di Boato: “Possiamo riprendere il filo, promuovere nuovi valori e disegni urbani realmente compatibili con il contesto e vivibili”. È l’unica possibilità: o sarà Venezia a non esserci più.
La presentazione dell'ultimo libro di Vezio De Lucia, occasione per riflettere sul passato il presente e il destino del capoluogo emiliano. Il Fatto quotidiano, 18 ottobre 2013
Ci sono alcuni argomenti che quando sono sollevati, suscitano nella classe dirigente politica e amministrativa di Bologna, una reazione allergica come l’orticaria. Si tratta essenzialmente delle opere pubbliche e dei progetti infrastrutturali, oltre che, negli ultimi anni anche i progetti misti, pubblico-privato che sono entrati, attraverso l’urbanistica contrattata e il project -financing, nel cielo empireo dei dogmi inviolabili, a prescindere dalla loro validità, utilità, dalle ricadute che generano, di solito immediati guadagni per i privati, costi riflessi e molte volte aggiuntivi o vere e proprie “rimesse” per il pubblico.
Bologna da questo punto di vista è stata, come per tante altre cose, nel bene e nel male un vero e proprio laboratorio, si potrebbe perfidamente definire un gabinetto del dottor Caligari, per parafrasare la favola cinematografica del regista Wiene che gioca molto tra realtà, sogno e incubo.
Il suo sviluppo urbanistico-edilizio è stato la contraddizione palmare tra enunciazioni e prassi: la sprawl, ovvero la dispersione edilizia cresciuta a ritmo incessante ha creato una congerie abitativa, laddove i piani soprattutto a livello provinciale, segnatamente il PTCP, avevano disegnato uno sviluppo lineare lungo gli assi dei collegamenti del Servizio ferroviario Metropolitano, non a caso l’infrastruttura meno amata dai vertici istituzionali.
Metrò, Civis, Peoplemover e Passante nord, sono i progetti contraddittori, quasi metafisici che le menti degli amministratori succedutisi in quest’ultimo quarto di secolo, hanno prodotto senza realizzarli, per dare soluzione alla fame di mobilità che una città esigente e complessa richiede, per la sua caratteristica di polo d’attrazione metropolitano, regionale, nazionale ed anche europeo.
Oggi che “ci si mangia le dita” per la perdita del Motor show, in fuga verso Milano, si dovrebbe fare mente locale su quanto ha inciso nella curva discendente della gloriosa Fiera, tra le altre cause, la perenne congestione stradale e autostradale e la mancanza di collegamenti su ferro con il centro fieristico, oltre che l’inadeguatezza dei servizi connessi, alberghi e ristoranti in primo luogo, ai nuovi standard qualità-prezzo che si ritrovano in altre realtà, soprattutto europee ma anche in Italia e perfino in regione.
Forse questa è veramente l’occasione buona per riflettere su un modello economico, urbanistico e infrastrutturale di città che segna fortemente il passo, per non usare il termine ancor più duro ma forse appropriato di declino.
Purtroppo non piace l’autocritica a nessuna classe dirigente al potere, non piace scavare nella memoria per risalire alle origini dei problemi dell’oggi, non ho mai, dico mai, sentito da uno dei leader più in vista in questo periodo, una frase come: “Ho sbagliato valutazione…dovevamo forse pensarci meglio….” Manco a dirlo! Tutto va sempre bene.
Invece inducono a farle altre autocritiche, questo si molto autorevoli, di alcuni tra i maggiori protagonisti dell’élite professionali: gli architetti Felicia Bottino ePierluigi Cervellati, con contenuti diversi Mario Cucinella e l’importante PaoloPortoghesi che hanno iniziato un serio dibattito sui limiti e gli errori delle scelte strategiche e specifiche di pianificazione e governo del territorio, in particolare le innumerevoli varianti per l’edilizia e per le infrastrutture che in questi venticinque anni, si sono realizzate a Bologna e in Emilia Romagna.
Si potrebbe considerare un’autocritica tardiva, lacrime da coccodrillo, ma c’è anche il detto “meglio tardi che mai”. E’ sorprendente che però questo dibattito pubblico, iniziato con clamore sulla stampa cittadina, sia rapidamente sopito, senza nessun intervento di personalità politiche a interloquire con gli architetti; è la conferma dell’imbarazzo ma forse soprattutto di disorientamento e mancanza d’idee.
La crisi può essere sempre anche un’occasione per cambiare in primo luogo l’atteggiamento culturale e la predisposizione ad allungare lo sguardo oltre il quotidiano, per trovare soluzioni coraggiose e innovative, al contrario far correre il tempo, aspettando che passi il peggio può essere l’anticamera della fine.
Ora c’è un’occasione importante per un confronto di opinioni qualificato: venerdì 25 ottobre, alle ore 17.30, presso l’aula A del Dipartimento di Filosofia e Musica, DAMS, in via Azzo Gardino 23, si discuterà del libro dell’architetto Vezio De Lucia, “Nella città dolente” (ed. Castelvecchi), che affronta con lucida passione la storia urbanistica del nostro sfortunato Paese, dai tentativi riformatori del ministro Sullo agli albori del primo centrosinistra, sconfitti dalla potente lobby della rendita, ai disastri edilizi, architettonici, ambientali e umani degli scempi che hanno stravolto il nostro bel paesaggio fino all’era berlusconiana.
Nel libro De Lucia fa un raffronto crudo nei capitoli, da “l’esempio di Bologna” a “Bologna dov’era e non com’era”, sulle mutazioni che hanno contaminato una delle realtà all’avanguardia e meglio amministrate in Italia che subisce i condizionamenti legislativi e dei rapporti di potere fra politica e sistema degli interessi economico-finanziari.
All’incontro interverrà anche l’architetto Pierluigi Cervellati, oltre al fisico Claudia Castaldini di Legambiente e al professor Gino Malacarne, vice presidente della scuola di Ingegneria e architettura di Cesena.
L'ultimo lavoro del geografo marxista Città ribelli, recentemente pubblicato in Italia, presentato e discusso al Teatro Valle di Roma, in un articolo di Benedetto Vecchi e un'intervista a Harvey di Roberto Ciccarelli. Il manifesto, 1 ottobre 2013
FORME DI VITA OLTRE L'AMBIVALENZA
di Benedetto Vecchi
Il capitale e la metropoli, un binomio che mostra le sue caratteristiche nei momenti di crisi e dunque di svolta nel regime di accumulazione. È questo il punto di avvio di David Harvey nel suo Città ribelli (il Saggiatore) che ha un obiettivo ambizioso: tratteggiare un punto di vista forte non solo sulle trasformazioni urbane, ma anche di comprendere fino in fondo il ruolo svolto dal capitale finanziario nel far ripartire lo sviluppo economico ridisegnando i rapporti sociali e di classe nelle metropoli. In una successione storica e geografica che parte dalla «Parigi capitale del XIX secolo» per passare alla Los Angeles del XXI secolo, approdando infine alla prometeica trasformazione urbana cinese degli ultimi dieci anni, il geografo americano applica creativamente la versione dei cicli economici di Giovanni Arrighi alle metropoli.
Ciò che merita di essere discusso è la progressiva trasformazione della metropoli in un conclamato habitat produttivo dove forme di vita, riproduzione della stessa forza lavoro sono diventate attività lavorativa o processi di valorizzazione del lavoro vivo. Il richiamo alla formula del «comune» non ha nessuna eco esotica, bensì è la realtà del moderno regime di accumulazione. Da questo punto di vista, la centralità è da assegnare al lavoro vivo, perché la metropoli è un caleidoscopio di produzione immateriale (high-tech, ma anche le imprese che gestiscono la riproduzione della forza-lavoro dopo la privatizzazione del welfare state) e produzione materiale. La finanza, in questo caso più che ruolo suppletivo svolge un ruolo di governance dello sviluppo capitalistico.
IL BUON DIRITTO ALLA COMUNE
intervista a David Harvey di Roberto Ciccarelli
«È come un grande terremoto preceduto da piccoli traumi quello che apre spazi come il teatro Valle, ma anche altrove, nelle fabbriche recuperate o nell'attivismo nei quartieri» afferma il geografo David Harvey, tra i più ascoltati intellettuali marxisti nel mondo. Parole che stridono con la campagna de Il Messaggero e Il Corriere della Sera contro il Valle. Gli attacchi, anche personali, sono ricominciati il 18 settembre scorso quando il Valle occupato ha presentato la sua fondazione, finanziata con 250 mila euro da cittadini e artisti, risultato della scrittura collettiva di uno statuto che rende il teatro un «bene comune», in altre parole un'istituzione dell'auto-governo. Per i quotidiani, invece, il teatro sarebbe stato «privatizzato» da una «minoranza», un'accusa che viene formulata contro tutte le occupazioni, e non poteva mancare anche nel caso di un teatro che è diventato un simbolo. Il punto di vista di Harvey, frutto dell'assidua frequentazione delle città globali, è utile per smontare questa campagna politica. Per usare un'espressione cara al geografo americano, quello del Valle è uno dei sintomi della «lotta di classe» che si svolge nelle «città ribelli», titolo del suo ultimo libro pubblicato in Italia da Il Saggiatore (manifesto, 12 settembre).
Riferimenti
In cima alla homepage c'è un'ampia finestra sensibile. Se ci scrivete David Harvey e cliccate sulla piccola lente d'ingrandimento a destra si apre un elenco di articoli di o su quell'autore.
 Sul documentario Sacro GRA vincitore a Venezia, si sono accumulate varie recensioni, tutte legittime, ma che non colgono il punto secondo il metodo e la prospettiva "psicogeografica". Intervento nel dibattito sul film di Rosi
Sul documentario Sacro GRA vincitore a Venezia, si sono accumulate varie recensioni, tutte legittime, ma che non colgono il punto secondo il metodo e la prospettiva "psicogeografica". Intervento nel dibattito sul film di Rosi
C'è una cosa che si chiama urbanistica, in senso lato, ed è uno sguardo più o meno analitico, più o meno sistematico, sul territorio modificato dall'uomo. Uno sguardo che ha come obiettivo la conoscenza, a volte la trasformazione, sempre la consapevolezza di quanto la nostra interazione con l'ambiente l'ha modificato, plasmato, a volte stravolto e irrimediabilmente devastato.
C'è un'altra cosa, magari parallela ma del tutto diversa, che si riassume nel concetto di psicogeografia, e che possiamo più o meno descrivere come il tentativo (analogo ad altri delle avanguardie artistiche) di leggere la modernizzazione nei suoi effetti sullo spazio urbano e territoriale, prescindendo dalla sua fisicità. La psicogeografia “studia le correlazioni tra psiche e ambiente, assumendo caratteri sovversivi nei confronti della geografia classica e ponendo al centro dei suoi scopi la ri-definizione creativa degli spazi”.
Non mi dilungo sul tema, rinviando il lettore al solito giro sui motori di ricerca, ed eventualmente su scaffali di biblioteca. Solo vorrei sottolineare come questa prospettiva psicogeografica, che si esprime almeno dagli anni '70 correntemente nel nostro linguaggio con la pratica della “deriva metropolitana”, sia stata utilizzata per confrontarsi direttamente con un paradigma della pianificazione territoriale moderna, ovvero il Greater London Plan di Patrick Abercrombie, e più in generale il concetto di equilibrio città/campagna espresso dalla teoria delle greenbelt e delle città satellite., così come tradotto in realtà nel '900.
Questo lavoro psicogeografico, mutuato anche dallo sguardo fantascientifico di James Ballard, si è sostanziato nel notissimo London Orbital, di Iain Sinclair, di cui in Italia esiste non solo una ricca edizione dotata pure di Dvd (Il Saggiatore, 2008), ma anche un dichiarato, semiserio plagio-omaggio di ambientazione milanese, con Tangenziali, di Gianni Biondillo e Michele Monina (Guanda 2010). Per uscire un po' dalla pedanteria dei riferimenti e precedenti, una breve e quasi conclusiva puntualizzazione: L'approccio psicogeografico agli anelli autostradali metropolitani contemporanei si confronta prevalentemente con il fallimento della pianificazione, intesa come pretesa di governare l'equilibrio fra cittadini e territorio, nella città moderna. Non ha alcuno scopo di denuncia, diretto o indiretto, e anzi individua le varie mutazioni indotte dai nuovi equilibri come stimolo ad altri sguardi e derive.
Ecco: nessuno dei (numerosissimi) recensori italiani di Sacro GRA, prima o dopo la vittoria a Venezia del Leone d'Oro, pare cogliere i due aspetti complementari, da un lato dei riferimenti alla cultura artistica internazionale del regista Rosi, dall'altro dell'applicazione di un metodo e prospettiva consolidati abbastanza casualmente all'anello autostradale romano. A parte il balzo cosmico del presidente della giuria di Venezia Bernardo Bertolucci, che ha paragonato il GRA inquadrato da Rosi direttamente agli Anelli di Saturno, il resto della critica si è soffermato sul contesto locale romano, citando al massimo il libro dell'urbanista Nicolò Bassetti (Sacro GRA, Lungo il Grande Raccordo Anulare, con Sapo Metteucci, Quodlibet 2013), uno dei suoi ispiratori Renato Nicolini, o peggio la canzone di Antonello Venditti e il suo imitatore Corrado Guzzanti.
Buoni ultimi, coloro che - ripeto legittimamente ma ancora una volta senza citare o cogliere o quantomeno intuire il mainstream alla base dell'opera – ne cavano l'ennesima denuncia di degrado del territorio, cementificazione, alienazione e compagnia bella. Tutte cose sacrosante e che confermano il classico percorso di un'ottima opera d'arte complessa, leggibile in tante prospettive, ma ne ignorano, sistematicamente, le radici. Eppure basterebbe sollevare lo sguardo: lo sanno tutti che gli anelli autostradali ci sono più o meno da quando hanno inventato le automobili. Non si fa un gran favore neppure a Roma e ai suoi problemi, leggendo in una prospettiva così angusta ed esclusiva quel documentario.
(nota: ho provato alcune settimane fa ad esprimere con qualche particolare in più il medesimo punto di vista su Mall, suggerendo lo stesso percorso da Abercrombie a Venditti)
La lucidità e la lungimiranza del pensiero dei Padri costituenti è inimmaginabile in una società come la nostra nella quale i beni culturali e il paesaggio «violando la legge, sono diventati soltanto merce; dove trionfa la religione del privato. Costituzione incompiuta, un libro di Alice Leone, Paolo Maddalena, Tomaso Montanari, Salvatore Settis. Corriere della Sera, 28 settembre 2013
Quando, nel 1947, l'Assemblea costituente stava discutendo sull'articolo 9 della somma Carta che riguarda la tutela del paesaggio, i giornali umoristici dell'epoca, non propriamente progressisti, andarono a nozze nell'ironizzare pesantemente, in malafede o incoscienti, su quel che significava quell'argomento focale per la vita di un Paese come il nostro. Il Travaso e poi Candido e L'uomo qualunque non lesinarono gli scherni, scrissero di ovvietà e di stupidità, come se la norma fosse una bizzarria degli uomini politici di allora. Basterebbero due film d'autore, Le mani sulla città di Francesco Rosi e Il ladro di bambini di Gianni Amelio, se non esistessero le ragioni della Storia, della Cultura e della Politica pulita a mostrare quel che è successo dopo e far capire com'era essenziale nell'Italia distrutta dalla guerra l'articolo 9 della Costituzione. Anche oggi non ha perso nulla della sua attualità.
Quattro autori — Alice Leone, storica; Paolo Maddalena, giurista; Tomaso Montanari, storico dell'arte; Salvatore Settis, archeologo, già direttore della Normale di Pisa, presidente del consiglio scientifico del Louvre — hanno firmato insieme un libro polemico e documentato, Costituzione incompiuta. Arte, paesaggio, ambiente, pubblicato da Einaudi (pagine 185, 16,50) che mette intelligentemente il dito sulle piaghe tormentose che seguitano a dilaniare un Paese disastrato, moralmente e materialmente, com'è l'Italia di oggi. Un libro che riesce a fondere la memoria di quel che accadde nel passato, con il presente e il futuro da ricostruire dopo il ventennio berlusconiano segnato dallo slogan «ognuno è padrone in casa propria».
Non era un'elegante astrazione intellettuale discutere quasi settant'anni fa del paesaggio e dell'arte come un fatto pubblico. Non fu, come scrive Alice Leone, né semplice né lineare, arrivare alla dizione dell'articolo 9. Rivolgimenti, mediazioni, scontri accesi, polemiche fuori e dentro gli schieramenti videro infatti contrapporsi interessi e scuole di pensiero. Non fu facile arrivare alla dizione definitiva: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».
Racconta Salvatore Settis, con amara nostalgia, che ci fu in Italia un tempo in cui la direzione generale delle Antichità e belle arti del ministero della pubblica istruzione poteva essere affidata a un uomo come Ranuccio Bianchi Bandinelli, «massimo archeologo italiano del Novecento e vigile coscienza della cultura europea»: la tutela delle bellezze naturali non può essere disgiunta da quella delle antichità e belle arti e deve essere sottoposta alla medesima regolamentazione legislativa, era il suo pensiero.
Sembra inimmaginabile un'idea così netta nella società dei consumi di oggi dove anche i beni culturali devono essere strumenti di «valorizzazione economica», dove — come documenta Paolo Maddalena — quei beni, violando la legge, sono diventati soltanto merce; dove trionfa la religione del privato; dove si costruisce senza vergogna, contro la volontà popolare, con l'avallo della Soprintendenza, un immenso parcheggio sotto e tutt'intorno alla più importante basilica milanese, Sant'Ambrogio; dove i prestiti selvaggi di delicatissime opere d'arte sono la regola, esportate all'estero come gingilli, utili più che altro a funzionari per i loro traffici di potere. (Pazienti viaggiatori hanno tentato più volte, per esempio, di vedere a Mazara del Vallo il meraviglioso Satiro danzante, sempre in trasferta come tanti altri capolavori, e hanno potuto esaudire il loro desiderio soltanto a un'esposizione alla Royal Academy di Londra dove il bronzo era ospite d'onore).
L'articolo 9 della Costituzione non nacque dal nulla. Il dopoguerra fu un momento fervido di riscatto e di comune visione del mondo di uomini e donne di diverse fedi e culture, dai liberali di gran nome come Benedetto Croce e Luigi Einaudi, al socialista Pietro Nenni, ai comunisti Togliatti e Concetto Marchesi al democristiano Aldo Moro all'azionista Piero Calamandrei che ebbero un ruolo essenziale nella stesura della Carta. La legge Croce del 1922 e la legge Bottai del 1939 furono il punto di partenza dei costituenti.
Tomaso Montanari spiega con chiarezza la sostanza dell'articolo 9: se la sovranità appartiene al popolo, com'è scritto nell'articolo 1, «anche il patrimonio storico e artistico appartiene al popolo. E la Repubblica tutela il patrimonio innanzitutto per rappresentare e celebrare il nuovo sovrano cui il patrimonio ora appartiene: il popolo».
Fu Concetto Marchesi, il grande latinista, a sostenere con energia la necessità di quell'articolo, voluto e difeso da costituenti di spicco. E fu Tristano Codignola a proporre con forza la parola «tutela», più completa della parola «protezione».
Che cos'è il patrimonio storico e artistico secondo gli autori del libro? «Non è la somma amministrativa dei musei, delle singole opere, dei monumenti, ma è una guaina continua che aderisce al paesaggio — cioè al territorio "della Nazione" — come la pelle alla carne di un corpo vivo».
Il libro (manca un indispensabile indice dei nomi) imposta un'infinità di problemi: la funzione delle Soprintendenze: Montanari propone una sorta di magistratura del patrimonio indipendente dalla politica; il perenne conflitto tra lo Stato e le Regioni competenti in materia urbanistica (un errore fatale dei costituenti); il consumo del suolo: l'8,1 per cento della superficie nazionale è coperta da costruzioni, la media europea è del 4,3 per cento. Dopo ogni terremoto, alluvione, disastro si piange (non per molto).
Chi deve provvedere, chi deve controllare i controllori? Lo Stato siamo noi, amava dire Calamandrei. E Bianchi Bandinelli: «Noi siamo, davanti al mondo, i custodi del più grande patrimonio artistico, che appartiene, come fatto spirituale, alla civiltà del mondo». Ce ne siamo dimenticati. Spaesati tra Imu e Iva.
 In attesa del processo di appello alla Commissione Grandi Rischi a L’Aquila, la recensione del volume di Antonello Ciccozzi che ha redatto la perizia su cui si è basata la condanna: l’analisi dell’operazione di falsificazione e rimozione della Protezione Civile di Bertolaso a copertura di interessi economici e corporativi (m.p.g.)
In attesa del processo di appello alla Commissione Grandi Rischi a L’Aquila, la recensione del volume di Antonello Ciccozzi che ha redatto la perizia su cui si è basata la condanna: l’analisi dell’operazione di falsificazione e rimozione della Protezione Civile di Bertolaso a copertura di interessi economici e corporativi (m.p.g.)
Ricordare la solitudine degli aquilani sotto il falso manto mediatico protettivo di Guido Bertolaso e del governo Berlusconi nei giorni antecedenti e successivi al sisma del 6 aprile 2009, è un imperativo morale categorico. Per questo il libro di Antonello Ciccozzi, Parola di scienza Un’analisi antropologica (Prefazione di Pietro Clemente, DeriveApprodi, 2013), che ci ricorda le contraddizioni e gli imbrogli perpetrati in quella oscura stagione non può che ricevere un forte encomio da chi ritiene che le vittime del terremoto dell’Aquila meritino giustizia e “verità”.
I fatti sono noti ma, poiché se ne va perdendo memoria, quasi fosse trascorsa un’era geologica, merita riassumerli brevemente. Dopo quattro mesi di scosse sismiche di magnitudo modesta ma molto frequenti avvertite a L’Aquila e nella regione circostante, a seguito di una più forte scossa di magnitudo 4.1 la popolazione allarmata (alcuni edifici si erano lesionati) cominciò a prendere alcune precauzioni, dormendo in macchina o spostandosi nelle seconde case o in case di parenti e amici ritenute più sicure. Un tecnico che lavorava nei laboratori del Gran Sasso notando che le sue apparecchiature segnalavano crescenti emissioni di radon, poiché la fuoriuscita di radon è notoriamente un precursore di terremoti, cominciò a fare circolare la voce che bisognava prepararsi a un forte evento. La Protezione Civile, ritenendosi l'unica depositaria del sapere sui terremoti in Italia, lo denunciò per "procurato allarme" e convocò la Commissione Grandi Rischi (CGR) allo scopo di “rassicurare la popolazione” (come risulta anche dalle intercettazioni telefoniche). Il 31 marzo 2009 la CGR (composta da tre membri ufficiali) e quattro funzionari “esperti” della Protezione Civile si riunirono a l’Aquila. Al termine della breve riunione (il cui verbale è stato diffuso dopo il terremoto) venne comunicato alla popolazione che poteva stare tranquilla e che addirittura poteva bere un bicchiere di vino. A seguito di questa comunicazione, molte persone rientrarono a dormire nelle loro case. Nella notte del 6 aprile il terremoto uccise 308 persone e distrusse il centro storico e altre aree intorno alla città. Colpiti nei loro affetti alcuni cittadini hanno denunciato gli esperti della CGR per la rassicurazione data che li aveva indotti a restare nelle abitazioni. Al termine del processo di primo grado, il 22 ottobre 2012 i sette esperti vengono condannati a sei anni di carcere, tutti indistintamente visto che come risulta dal verbale della riunione nessuno si dissociò. La ragione della condanna è nella leggerezza con cui hanno di fatto previsto che il terremoto non sarebbe accaduto.
Il cuore del libro “Parola di scienza” è la perizia antropologica, riportata integralmente, richiesta all’autore dal Tribunale de L’Aquila, per capire gli effetti della “rassicurazione” sui comportamenti individuali e collettivi della popolazione aquilana data dalla Protezione civile attraverso comunicazione mediatica dopo la riunione della CGR. La perizia, unica nel suo genere in ambito giuridico (mai prima in Italia sono state richieste perizie antropologiche su tematiche di rischio), è preceduta da una prefazione del prof. Pietro Clemente, ordinario di Antropologia culturale, che, oltre a mettere in luce le valenze scientifiche della ricerca, offre un ricco e convincente contributo interpretativo personale sul contesto antropologico in cui le vicende si sono svolte. Nella note introduttive dell’autore che precedono la perizia, viene descritta la sua personale esperienza e quella di altri cittadini, concentrando la lente su emozioni e decisioni suggerite ed ispirate da quel lo che - per usare le categorie del premio nobel per l’economia Daniel Kanheman - è il pensiero “veloce”, ma elaborate però con la severa razionalità del “pensiero lento”. Il concetto di fondo della perizia, supportato da una dovizia di argomentazioni antropologiche a sostegno, è molto chiaro: benché molti aquilani, sulla base della paura, avessero preso la decisione di lasciare le loro case, vi sono rimasti perché i loro comportamenti sono stati “viziati” dalla rincuorante comunicazione, in quanto dalla stessa comunicazione, e in generale dal clima creatosi intorno alla sequenza sismica si evinceva che solo gli “esperti” della CGR potevano meritare fiducia e che la loro parola era praticamente infallibile. In una densa e struggente postfazione, l’autore, collocandosi nello spazio temporale del dopo processo, punta il mirino sulla scomposta risposta della classe corporativa degli scienziati all’esito della sentenza. Scienziati che, senza aver letto le motivazioni della sentenza, sono caduti nella trappola predisposta da chi ha fatto passare lo slogan che gli esperti sono stati condannati “per non aver previsto il terremoto”.
Ma perché il libro di Ciccozzi è di così grande interesse culturale anche per chi antropologo non è? Per almeno tre motivi. Per la conservazione della memoria, innanzitutto. Nella cultura sismica, si sa, la memoria non è una scelta ma un obbligo, non soltanto perché il terremoto è un tragico evento di perdita, ma anche perché è un insostituibile laboratorio di apprendimento per la sicurezza del domani. In epoche antiche, in Italia, erano i riti collettivi, le processioni riparatrici, gli ex-voto, le preghiere e i racconti dei vecchi a mantenere viva nelle famiglie la memoria della tragedie e la cognizione delle tecniche di sopravvivenza che si tramandavano da una generazione all’altra. Anche in epoche più secolarizzate la ricostruzione storica è stata la via maestra per difendersi dai terremoti, nella crescente consapevolezza che il ricordo degli accadimenti non produce solo conoscenza scientifica ma anche conoscenza altra, cioè una conoscenza generata dall’esperienza del dolore, irriducibile ad altre forme di conoscenza, ma universalizzabile e capace di farsi misura di prevenzione. Persino oggi, nell’era della tecnica per eccellenza, se si vogliono affinare forme di pacifica coabitazione col terremoto, la memoria storica è la componente di base prioritaria, sia che si guardi al terremoto come “evento naturale” sia come “ evento sociale”. È infatti il principio cardine su cui si basa la classificazione sismica del territorio nazionale, la normativa sismica per le costruzioni e tutte le altre misure di prevenzione dei paesi avanzati.
Ma “la smemoratezza del moderno” – come la definisce l’antropologo Pietro Clemente nella avvincente prefazione al libro di Ciccozzi – sembra essere l’altro principio che, in Italia, governa la società del rischio che si autodefinisce moderna. Nel caso dei terremoti la ragione è ovvia. Il terremoto non schiude solo affascinanti universi scientifici o buoni sentimenti di pietà e solidarietà. I terremoti fanno venire a galla anche le realtà meno nobili di un paese: interessi economici, profitti, illegalità, omertà, complicità, che riguardano le classi dirigenti, le imprese, gli operatori, e persino il mondo della cultura e della ricerca. Per questo c’è un preciso interesse nel fare calare il velo dell’oblio sugli accadimenti che hanno preceduto e seguito il terremoto de L’Aquila, perché l’Aquila è l’archetipo di quel “grumo di misfatti” – per usare un’espressione di Barbara Spinelli – che formano un tutto unico con il sottobosco e la sottocultura del nostro paese.
Un interesse a dimenticare che si estende ad una finestra temporale anche molto più ampia di quella considerata nel libro di Ciccozzi, perché quanto accaduto a L’Aquila non è un fiore del male spuntato all’improvviso. È il punto di arrivo di un lungo percorso di cancellazione della memoria. Cancellare tutto dalla lavagna è stato, fin dal 2002, data di inizio della “resistibile ascesa” della nuova Protezione civile, il principio guida delle politiche di Bertolaso, spalleggiate oltre che dal capo del governo, da un piccolo manipolo di esperti, alcuni dei quali membri della Commissione Grandi Rischi (CGR), che hanno “rassicurato” gli aquilani e che hanno fornito le basi ingegneristiche per un rovesciamento a 180 gradi del modello di difesa dai terremoti. Depennare le buone pratiche accumulate nei precedenti trent’anni di cultura sismica in Italia era, allora, la conditio sine qua non per annunciare la nuova alba della cultura sismica in Italia e sostituire a un modello di difesa dai terremoti, basato su una dialettica «multipolare» centrata sul territorio, un modello centralizzato, esterno, unipolare, in cui solo la Protezione civile e il suo «polo esperto» erano i depositari della protezione sismica. Cancellare tutto dalla lavagna è, oggi, la conditio sine qua non per difendere l’operato degli esperti condannati dalla sentenza del 22 ottobre 2012, e per deviare l’attenzione verso porti delle nebbie dove tutto si mescola e si confonde, in modo da poter martellare in modo mirato su alcuni luoghi comuni circa l’imprevedibilità dei terremoti e così ridicolizzare la magistratura e tutti coloro che vogliono riprendere il filo delle buone pratiche.
È utile, oggi, per chi ha subito la condanna, far dimenticare che, oltre che accademici, alcuni degli esperti della CGR, in quanto liberi professionisti, ricevevano (in pieno conflitto di interessi con il ruolo di “esperti” della CGR) commesse professionali dalla Protezione civile, come è ancora oggi facile verificare sul loro stesso sito web. O far dimenticare che ad alcuni membri della CGR subito dopo il terremoto è stata affidata dalla Protezione Civile la progettazione e la realizzazione dei nuovi 19 quartieri a L'Aquila del Progetto C.A.S.E. , e che il collaudo delle apparecchiature antisismiche è stata affidata al Laboratorio (nato dal nulla nel 2003) finanziato dalla Protezione Civile e diretto da uno dei membri della CGR. E, infine, che questo centro di eccellenza venga oggi utilizzato per chiamare a raccolta 4000 operatori del mondo scientifico, tra cui dottorandi o anche studenti pomposamente chiamati “scienziati”, a difendere i nuovi “Galileo” (il quale Galileo starebbe, invece, oggi dalla parte dell’accusa, come bene dimostra Ciccozzi!). Solo seppellendo le tante imbarazzanti verità del passato è possibile completare la grande opera di falsificazione dell’era Bertolaso azzerando colpe e responsabilità. Se tutto è dimenticato è possibile reci- tare la parte degli scienziati feriti e umiliati da una condanna “assurda”, da loro falsamente presentata alla comunità scientifica e al mondo giornalistico come sanzione “per non avere previsto il terremoto”. Ed è facile trovare “esperti” pronti a gridare sulle persecuzioni alla scienza.
Ma è non solo per la conservazione della memoria che il libro merita apprezzamento. Perché – e questo è il secondo motivo di interesse – la doppia lente con cui l’autore esamina i fatti crea una circolarità virtuosa tra forme di conoscenza che permette di fare “verità” su molti aspetti della tragedia aquilana. Sia le vicende della notte del 6 aprile 2009 sia quelle più recenti sono infatti esaminate attraverso un doppio filtro critico: quello dell’analisi teorica condotta con categorie strettamente antropologiche e quello dell’analisi esperienziale di testimone della tragedia. Come è stato osservato a proposito del personaggio di Pessoa, Bernardo Soares, la finestra da cui l’autore guarda e interpreta gli accadimenti “ha le imposte che si possono aprire sul fuori e sul dentro”. Il “fuori” è l’operato della CGR. Il “dentro” , sono le gallerie segrete scavate nell’animo umano da un evento così sconvolgente dall’essere al di là delle possibilità di comprensione ma che producono e generano un modo del tutto nuovo di conoscenza. Ma anche quando la ricerca porta oltre i confini strettamente antropologici o sfonda addirittura nel territorio dell’esperienza personale, non c’è mai, nel libro, tema od evento che non sia descritto o interpretato senza uno sforzo di rigorosa razionalità. L’autore privilegia sempre il fattore cognitivo su quello valutativo, continuamente ricercando gli appropriati supporti scientifici, perché il suo obiettivo è conseguire la “verità”, attraverso “il pensiero lento”, i passaggi logici e i continui faticosi esercizi di spogliazione della soggettività, degli impulsi e delle tensioni emotive.
Il terzo motivo di interesse culturale è che il libro ci fa capire con argomentazioni avvolgenti quanto sia importante la vigilanza perché ciò che è accaduto non accada mai più. È inconfutabile che l’era Bertolaso rappresenti un unicum nella storia della Protezione civile italiana ma è anche indubbio che seppure più in segreto e in misura più contenuta il malessere di quella stagione non è finito. Se, come è stato detto , “solo la malattia permette di conoscere lo stato di normalità”, soltanto una comprensione piena delle patologie di quel momento storico può condurre a un’adeguata comprensione di alcune deformazioni fisiologiche del nostro paese. L’Aquila non è solo una lente che ha messo a nudo le patologie dell’era Bertolaso. L’Aquila ci permette di capire meglio i guasti della nostra normalità. Puntigliosamente attento a dare una rigorosa e oggettiva descrizione degli accadimenti e ad una loro interpretazione strettamente ancorata alle teorie antropologiche, l’autore tocca alcuni nervi sensibili della nostra attualità, gettando luce su quel mix di distorsioni nei rapporti scienza-potere-società che hanno avuto certamente il loro massimo storico nell’era di Bertolaso ma non certo estinte nella società italiana e persino mondiale: l’arroganza del potere, la pretesa infallibilità e cortigianeria degli esperti, il dispotismo della tecnica, la manipolazione mediatica, gli abusi di autorità autodefinitesi, che hanno tra i loro effetti l’appropriazione dei beni pubblici, la devastazione della geografia e della storia dei luoghi, la sottovalutazione dei rischi, le omissioni, le inconcludenze e le inadempienze del potere politico e accademico. Dopo avere centrato il compasso sulla ricerca antropologica svolta, l’autore allunga il raggio della sua riflessione, risale controcorrente per spiegare le connessioni tra cause ed effetti di quella vicenda dai tragici esiti. Ma è soprattutto la reazione degli scienziati (quasi coro unanime con pochissime voci in controcanto) che lo porta ad allargare il cerchio, a riflettere sulle nuove forme magico-sacrali della società tecnologica, sulla mancanza di autonomia dal potere degli scienziati e degli esperti. La ferita, inferta agli aquilani ma anche alla stessa scienza, dalla corporazione degli scienziati che a livello mondiale si sono piegati, senza verificare prima le ragioni della sentenza, a dare supporto alla tesi preconcetta degli esperti della Protezione civile in una questione così drammatica, rivela, alla luce dell’esperienza del dolore, tutta la anaffettività e la miseria umana che albergano nei cuori di “luminari” spesso autodefinitisi, supponenti e persino spietati. Un’analisi che chi conosce per esperienza i soggetti che mediamente popolano le commissioni tecniche non può che condividere, visto che l’indipendenza di pensiero e il senso della complessità non sono certo la nota saliente della maggior parte degli esperti italiani che le frequentano.
L’analisi è lucida e “distante”, l’autore si afferra con un tenace sforzo di volontà alle metodologie antropologiche in un continuo esercizio di oggettivazione. Ma più il “pensiero lento” lavora, più aumentano le ragioni per considerare quella “reazione” primitiva e scientificamente contro natura. Il pensiero veloce dell’autore interagisce con il pensiero lento e raccorcia le distanze tra oggetto e soggetto fino a diventare “ira santa”, passione furente, malessere esistenziale per manifestazioni come quella che ha portato gli scienziati a credere alle fandonie giornalistiche spacciate da chi ha interesse a dire di essere stato condannato per “non avere previsto il terremoto”.
Perciò tutti noi che abbiamo fatto o facciamo parte di commissioni tecniche non possiamo che essere infinitamente grati a chi dalla doppia angolazione dell’antropologia culturale e dell’esperienza del dolore ci ricorda i limiti del nostro sapere e ci richiama a coniugare competenza scientifica e sensibilità umana.
L'autrice ha insegnato, dal 1982 al 2010, Ingegneria Geotecnica Sismica presso l’Università degli Studi di Firenze.
Riferimenti:
Al terremoto e agli scandali del dopoterremoto eddyburg ha raccolto molti documenti, nella cartella Terremoto all'Aquila