

Internazionale, 22-29 giugno 2018. Altre vittime dello sviluppo: le dighe, la pesca intensiva e i cambiamenti climatici stanno distruggendo il lago Tonle Sap mettendo a rischio la sopravvivenza dei suoi abitanti. (i.b.)
Andrea Frazzetta ha fotografato i villaggi galleggianti sulle rive del lago Tonle Sap. Dove la pesca intensiva e i cambiamenti climatici spingono gli abitanti a trasferirsi sulla terraferma.
È un tardo pomeriggio e Reth Roth scuote il figlio. “È ora di alzarsi!”, gli grida all’orecchio. Suo marito Cheng Chak è già vestito e sta radunando telefoni, sigarette, un fornelletto da campeggio. Il figlio dorme come un sasso, immobile, poi improvvisamente si alza in piedi. Il sole invade i lati aperti della casa, tagliando il pavimento nudo e spazioso. Il ragazzo batte le palpebre, confuso, poi comincia a preparare le provviste.
 |
| Chong Khneas: uno dei villaggi galleggianti quando il fiume è in piena Chong Khneas: uno dei villaggi galleggianti
quando il fiume è in secca
|
Il lago Tonle Sap, che si estende sul territorio cambogiano come un 8 allungato, è il piùgrande bacino d’acqua dolce di tutto il sudest asiatico. Nella stagione secca è costeggiato da strade rosse e foreste. Quando arriva la pioggia, l’acqua inonda le pianure, le foreste e le risaie che lo circondano. Al culmine della stagione delle piogge, il Tonle Sap raggiunge un’estensione di 16mila chilometri quadrati, moltiplicando di sei volte le sue dimensioni. I pesci migrano e si riproducono, il riso germoglia.
Gli scienziati le chiamano pulsazioni di piena, i poeti le paragonano al battito cardiaco. Uno dei primi romanzi moderni la Cambogia s’intitola Le acque del Tonle Sap e molti proverbi alludono al movimento dell’acqua. Quando le piogge finiscono e il livello dell’acqua del Mekong cala, il lago si getta nel fiume Tonle Sap e poi nel Mekong. Nella stagione delle piogge le nevi sciolte che arrivano dal Tibet e i monsoni che si abbattono sulla Cambogia e più a monte gonfiano il Mekong. Allora il corso del fiume Tonle Sap s’inverte. L’unico fiume al mondo a fare una cosa simile, ogni anno, regolarmente. “Il doppio movimento del lago, la pulsazione annuale di questo cuore gigantesco legato alle migliaia di arterie del Mekong, è la vita dei pescatori”, rifletteva nel 1871 il tenente Jules Marcel
Brossard de Corbigny.
In tutto il pianeta, solo una manciata di paesi – tutti molto più grandi della Cambogia – possono vantare maggiori risorse ittiche nelle acque interne. E nessuno conta sui laghi nella stessa misura della Cambogia. Il pesce sfama la nazione e rappresenta la principale fonte di proteine per l’80 per cento della popolazione. Sfama anche i vicini della Cambogia, che ne importano migliaia di tonnellate ogni anno. E sta scomparendo.
Solo il Rio delle Amazzoni ha più specie di pesce d’acqua dolce del Mekong, mentre il lago Tonle Sap è il terzo più ricco di specie del mondo. Ma in meno di vent’anni la pesca qui è radicalmente cambiata.
Uno dei problemi del cambiamento climatico sono gli eventi atmosferici estremi: piene più piene e secche più secche. Nei prossimi anni si prevede che siccità e alluvioni peggioreranno. Con l’aumentare del riscaldamento climatico, aumenterà anche la temperatura dell’acqua. E questi cambiamenti hanno un effetto devastante sul modo in cui i pesci migrano e si riproducono.
Il salto, 6 Aprile 2018. La Shell sapeva da parecchi anni dei pericoli dell'uso dei fossili sul surriscaldamento globale. Ma il gigante del petrolio continua a investire in combustibili fossili e minare qualsiasi azione alternativa. (i.b.)
Clima di preoccupazione. È evidente fin dal titolo del film che ha realizzato nel 1991 che il gigante petrolifero Shell fosse perfettamente al corrente del nesso tra l’uso delle fonti energetiche fossili, il surriscaldamento globale e le conseguenze che ne sarebbero derivate. A quasi trent’anni di distanza, a inizio 2017 quella pellicola salta fuori insieme a un documento – con tanto di conchiglia sulla copertina – classificato come “confidential” e intitolato “The greenhouse effect”. Li ha scovati il giornalista Jelmer Mommers dopo un anno di indagini per il giornale olandese The Correspondent e ci ha poi lavorato con il collega del Guardian Damian Carrington.
Ne emerge un quadro nel quale Shell aveva piena consapevolezza della velocità elevatissima con la quale l’aumento di temperatura del globo avanzava, una velocità troppo elevata “perché la vita vi si possa adeguare” senza gravi ripercussioni sugli ecosistemi.
L’inquinamento delle pianure costiere, le isole tropicali sommerse, disastri “naturali” e carestie. Perfino la domanda “chi si farà carico di questi rifugiati climatici?”. “I problemi e i dilemmi del cambiamento climatico riguardano tutti noi” recita il film, che nasceva per essere divulgato ma pare non sia stato proiettato per molti anni. Le affermazioni e le stime riportate nel film si sono realizzate con un buon margine di precisione, eppure Shell e le altre “Big oil” non hanno mai fatto retromarcia né nei loro business né nel loro pressing sui governi e sull’opinione pubblica per minimizzare o addirittura negare le responsabilità umane nel fenomeno del climate change. Come fa notare un ex revisore esterno di Shell a The Correspondent, ciò che colpisce è che intanto non sia accaduto nulla per far dubitare di quei dati e della loro veridicità. Anzi, la scienza ha continuato a trovare conferme, unitamente all’evidenza dell’aumento costante delle temperature medie e all’intensificarsi di fenomeni naturali “estremi”.
“Una forma moderna di crimine contro l’umanità” lo definisce un altro degli intervistati, aggiungendo che ora Shell si nasconde dietro gli investimenti sul gas (la fonte fossile con meno emissioni “climalteranti”), mentre in realtà l’estrazione delle fossili dovrebbe cessare del tutto. Peraltro, chiarisce Paul Spedding di Carbon Tracker, se il gas naturale costituisce la metà delle riserve di Shell, un 30% è composto da sabbie bituminose, che rappresentano la modalità estrattiva con il peggiore impatto sul riscaldamento del pianeta e hanno un peso enorme sull’impatto della produzione complessiva del colosso.
A suffragare la tesi della piena consapevolezza del gigante petrolifero circa i rischi del global warming e la sua correlazione con le fonti energetiche fossili, c’è anche un report aziendale riservato del 1986, nel quale si faceva riferimento al rischio di “mutamenti repentini e drammatici” dalle gravi conseguenze sociali. Eppure tre anni dopo nasceva la cosiddetta Global Climate Coalition, con la quale le maggiori compagnie petrolifere hanno fatto pressione per mettere in dubbio la scienza del clima e opporsi all’azione del governo Usa.
Che le lobby petrolifere continuino ancora a incidere sulle decisioni che riguardano gli incentivi alle fonti fossili e che mirano a frenare le rinnovabili non è una novità, ma l’inchiesta di The Correspondent conferma anche che l’investimento minimo di Shell nelle ecoenegie (1% del fatturato) rappresenta praticamente un’operazione di marketing se non di greenwashing, dal momento che la gran parte del business è totalmente incompatibile con gli obiettivi, stabiliti al vertice sul clima di Parigi nel dicembre 2015, di far rientrare entro i 2 gradi centigradi l’aumento medio della temperatura terreste rispetto ai livelli preindustriali.
Il report interno del 1986 chiariva bene che la soluzione al problema devono trovarla i governi con il contributo essenziale dell’industria energetica, che su temi come questi si gioca anche la reputazione. Così, la soluzione più facile è stata mettere quel film sotto chiave, negare l’evidenza e raccontare il contrario di ciò che si faceva e ancora si fa, spesso proprio con il sostegno e la complicità dei governi.
A un anno di distanza, e nonostante la manifestazione della disponibilità a rispettare i limiti imposti dagli accordi di Parigi, gli obiettivi prioritari di Shell sono pressoché invariati: nei paesi Bassi, denuncia ad esempio Friend of the Earth, il 95% degli investimenti è ancora incentrato su petrolio e gas.
Intanto si fa sempre più pressante la richiesta di allineare il proprio business ai livelli di emissione prescritti dagli accordi sul clima di Parigi. E parallelamente aumentano le minacce di azioni legali. Friends of the Eart ha già portato una volta Shell davanti a una corte, ma queata volta l’azione giuriduca annunciata dagli ambientalisti olandesi sarebbe il primo caso di una causa che non chiede di pagare i danni ma di modificare le scelte strategiche di un’azienda.
Non è un caso che la minaccia di un’azione legale contro un colosso delle fossili arrivi proprio dall’Olanda. Proprio una corte dell’Aja, infatti, nel 2015 aveva ordinato al governo olandese di aumentare gli obiettivi di contenimento delle emissioni climalteranti almeno del 25% entro cinque anni, contro il 14-17% fissato dall’esecutivo. La battaglia non è stata facile neanche su questo fronte, tanto che il governo ha proposto appello contro la decisione, ma davanti a questa “sfida sociale complessa che dovrebbe essere affrontata attraverso una sana politica governativa e cambiamenti culturali”, come spiegano da Shell per ridimensionare gli impegni assunti e scongiurare il ricorso alle vie legali, anche la strada di consolidare una giurisprudenza che riaffermi la giustizia climatica assume un ruolo centrale.
Il video "Climate of Concern" è visibile sul sito de Correspondent.
la Stampa, 22 marzo 2018.Non sembra che l'attuale presodente del Brasile sia un ambientalista a 18 carati, ma l'iniziativa che sponsorizza, ospita e illustra in questo scritto è indubbiamente interessante
L’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici di base - tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e condizione per la vita umana - è un diritto. Oppure 2 miliardi di persone nel mondo sono prive di una fonte d’acqua sicura in casa; circa 260 milioni, più dell’intera popolazione brasiliana, devono camminare più di mezz’ora per raggiungerla e 2,3 miliardi hanno carenza di servizi igienici. Garantire l’accesso a questo bene è una delle principali sfide del nostro tempo.
La scelta del Brasile come Paese ospitante del più importante evento globale sulle risorse idriche non stupisce. Abbiamo già ospitato Rio 92 e Rio +20, in cui si è sottolineato lo stretto rapporto tra sostenibilità idrica e sviluppo. Più di recente, siamo stati tra i primi a ratificare l’Accordo di Parigi su una delle principali minacce al diritto all’acqua: il cambiamento climatico.
Abbiamo fatto grandi progressi anche nella protezione delle foreste, ampliando le aree di conservazione e invertendo la curva della deforestazione in Amazzonia, in precedenza in ascesa. E stiamo per creare due vaste aree di tutela della biodiversità marina. È così, proteggendo gli ecosistemi, che proteggeremo le nostre fonti d’acqua. Avere acqua è essenziale, ma non sufficiente. È necessario che essa raggiunga chi ne ha bisogno.
L'autore è Presidente della Repubblica Federativa del Brasile
Avvenire, 21 marzo 2018. Scoppiano ancora guerre per il possesso di uno dei più preziosi beni comuni dell'umanità. Sempre più frequenti e sanguinose saranno se parsimonia di risorse scarse e austerità negli stili di vita non prevarranno anche nei popoli spreconi
Dopo le città ortogonali inventate dai greci e quelle fortificate nel Medioevo, stiamo entrando nel secolo delle «città-spugna»? C’è da augurarselo, suggerisce l’ultimo rapporto Onu sulla valorizzazione delle risorse idriche mondiali, appena pubblicato con il titolo: «Le soluzioni fondate sulla natura per la gestione dell’acqua». In Cina, «entro il 2020, 16 “città-spugna” pilota saranno costruite su una superficie di oltre 450 chilometri quadrati, con più di tremila progetti di costruzione previsti e investimenti per un ammontare totale di 8,65 miliardi di yuan», evidenzia il rapporto, a proposito degli abitati avveniristici dotati di tetti vegetalizzati, rivestimenti permeabili al suolo ed altre soluzioni per captare, canalizzare, purificare, riutilizzare l’acqua piovana, di fronte al rischio di una grande sete planetaria nei prossimi decenni, fra crescenti consumi e annosi sprechi.
Ma gli scenari pessimistici non sono ineluttabili, sostiene il rapporto, presentando le strade già percorse o percorribili apparentate alle città-spugna. Ad accomunarle è il fatto di abbinare spesso l’ingegneria idraulica “grigia” convenzionale (acquedotti, canalizzazioni, sbarramenti ecc.) con soluzioni sapienti di gestione idrica che imitano la natura, oppure sfruttano processi chimico-fisici naturali. Certe pratiche anche antiche, spesso finanziariamente vantaggiose e talora inclusive delle popolazioni locali, potranno correggere la cecità mostrata nei contesti urbani e non in cui si è abusato del cemento.
La preservazione di ecosistemi umidi nelle campagne limita le inondazioni che hanno minacciato di recente pure Parigi ed altre grandi capitali, permettendo al contempo di alimentare gradualmente le preziosissime falde acquifere sotterranee. L’emergenza sete c’è già e lo si è visto anche a Roma e in altre città italiane. «Un terzo dei più grandi sistemi d’acqua sotterranei del mondo sono già in situazione di sofferenza», evidenzia lo studio, prefigurando gli scenari futuri: «Un forte aumento dei prelievi delle acque sotterranee dell’ordine di 1.100 chilometri cubi è previsto entro il 2050, il che corrisponderebbe a un aumento del 39% rispetto ai livelli attuali». Ampiamente trascurate in passato, le tecniche “verdi” appaiono vieppiù come un possibile salvagente planetario. Questo cambio di rotta «è essenziale per affrontare il problema della penuria d’acqua attraverso il capitolo dell’approvvigionamento idrico», soprattutto perché l’approccio “verde”’ «è riconosciuto come il principale modo per garantire la sostenibilità delle risorse idriche per l’agricoltura ».È infatti proprio per irrigare i campi che si consuma e si consumerà ancora gran parte dell’acqua necessaria all’umanità: oggi circa il 70%, contro il 10% per usi domestici e il 20% per l’industria. Favorire con soluzioni naturali la penetrazione graduale dell’acqua piovana nei suoli, attraverso tecniche conservative di aratura, semina, policoltura o silvicoltura, appare dunque ormai una posta in gioco decisiva. Se resta vero che «i flussi ascendenti e discendenti d’acqua e d’energia attraverso il suolo sono vasti e strettamente legati», come ricorda il rapporto, non si dovrà più sottovalutare un’oculata preservazione del ciclo idrogeologico, più che mai vitale per le popolazioni di tanti territori. Soprattutto nelle città e campagne d’Africa ed Asia, dove si prevede la maggiore crescita di popolazione del secolo.
Studio sintetico a cura dell’Unesco in cui convergono dati e lavori anche di altre agenzie Onu, sostenuto finanziariamente dal Governo italiano e dalla Regione Umbria, il rapporto coincide con l’8a edizione del Forum mondiale dell’acqua a Brasilia (18-23 marzo) e la Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo).A Brasilia il Forum mondiale sul più prezioso dei beni Le Nazioni Unite rinnovano l’allarme sull’emergenza-sete. Valorizzare le risorse.
Articolo tratto da Avvenire, dalla pagina qui raggiungibile
The Submarine, 1 marzo 2018. Le politiche isolazionistiche dell'Europa sono inutili difronte alla desertificazione del Sahel. Occorre accettare e gestire i flussi migratori e mettere in campo misure per garantire nuovi accessi a risorse naturali. Qui l'esempio della muraglia verde. (i.b.)
La desertificazione inarrestabile del Sahel sta rendendo invivibile un’intera regione del continente africano: è un problema da cui la politica europea non può (piú) scappare.
La definizione di “migrante climatico” è molto complessa. Gli eventi causati dalla crescente variabilità climatica sono così vari e imprevedibili che definire chi sia un migrante climatico è difficile, o forse impossibile.
Esistono i casi di migranti climatici in senso stretto, come gli agricoltori che devono spostarsi di fronte all’avanzata del deserto, ma ricadono in questa definizione anche persone che fuggono da conflitti o instabilità provocati dalla mancanza di risorse direttamente causata dal cambiamento climatico, o chi deve spostarsi in seguito a catastrofi imprevedibili.
Lo IOM (Organizzazione mondiale per le migrazioni) prova a definire il fenomeno come “persone o gruppi di persone che, principalmente perché colpiti negativamente dal cambiamento, improvviso o progressivo, nell’ambiente, sono costrette a abbandonare le proprie case, o scelgono di farlo, temporaneamente o permanentemente, e che si spostano all’interno del proprio paese o all’estero.” (Glossary on Migration, International Migration Law, no. 25, 2nd Edition, IOM, Ginevra, 2011, p. 33). Si tratta insomma, di una migrazione forzata che riguarda molte piú persone di quante in genere si pensi.
Il legame tra instabilità geopolitica e cambiamento climatico è forte quanto invisibile, e ignorato da una fetta di politici ancora piú ampia di chi già nega il cambiamento climatico.
È il caso dei migranti provenienti da vari paesi del Sahel, a sud del deserto del Sahara, che vengono puntualmente considerati dall’Unione Europea come “migranti economici,” e che la nostra politica usa volentieri come punching ball di retorica razzista e retrograda. Sono paesi come il Senegal, l’Algeria, la Nigeria e l’Eritrea — tra gli altri. Tutti i paesi della fascia del Sahel sono considerati dallaBanca mondiale come fragili — a causa di alti livelli di povertà, conflitti costanti, e governi tradizionalmente debolissimi. Secondo i dati raccolti lo scorso anno dall’OCHA, il 60% della popolazione della regione — 150 milioni di persone — è impiegata nell’agricoltura pluviale.
Catalogare come migranti economici persone che si vedono costrette a migrare di fronte a una desertificazione che avanza di vari chilometri l’anno è una lettura iperpoliticizzata di un problema da cui non si può scappare.
La migrazione, ovviamente, non è diretta, e sono tantissimi i fattori che offuscano il rapporto di concausa. Sara Vigil scrive, per “Out of Africa: Why People Migrate” (LediPublishing, ISPI, Milano, 2017) che “molteplici studi hanno sottolineato come nei periodi di siccità i fenomeni migratori diminuiscono. Questo è perché le persone usano le proprie ultime risorse per i bisogni primari (come il cibo), e non hanno quindi le risorse per imbarcarsi in viaggi piú lunghi.”
Le politiche che mirano a tenere il problema dei rifugiati fuori dal blocco europeo sono scandalosamente miopi. Spostare le cause della migrazione, anche quelle considerate strettamente politiche o economiche, nel contesto del cambiamento climatico rivela un’evidenza innegabile: che le grandi migrazioni dall’Africa subsahariana sono appena iniziate. La proiezione piú citata è quella firmata da Norman Myers, che calcola 200 milioni di persone costrette ad abbandonare la propria casa entro il 2050. Secondo dati raccolti da diverse organizzazioni umanitarie che operano nella zona, il 30% degli abitanti della zona del Sahel del Burkina Faso hanno dovuto migrare negli ultimi vent’anni.
La situazione è sistemica e riguarda l’intera fascia del continente — un abitante su quattro dell’Africa subsahariana vive in condizioni di malnutrizione. Sono 220 milioni di persone, che nel 2050 secondo le proiezioni di Meyers diventerebbero 330.
Malgrado queste condizioni di totale costrizione, i migranti saheliani non sono considerati tecnicamente rifugiati. Questo principalmente perché lo status di rifugiato riservato esclusivamente a chi si muove costretto da persecuzioni, è descritto da un documento molto datato, definito nel 1951 — anche se nel contesto politico mondiale contemporaneo i suoi contenuti sono di un’ambizione umanitaria sempre piú lontana alle sensibilità attuali, quasi un relitto di un momento di maggiore civiltà.
Ci sono voci che sostengono che le vittime del cambiamento climatico dovrebbero rientrare in questa definizione. È l’opinione, tra gli altri, anche di Alice Thomas, manager del programma di migrazioni climatica di Refugees International. “Per i poveri saheliani che devono ‘andarsene o morire qui’ — come una donna ha descritto il suo dilemma — leggi e politiche offrono protezione limitatissima, e pochissime soluzioni sul lungo termine,” dice Thomas.
“Negli ultimi 40 anni le temperature nella regione sono cresciute costantemente e la siccità è diventata un problema sempre piú costante e severo,” si legge in uno studio congiunto UNEP – IOP del 2011 coordinato da Alhousseïni Bretaudeau. La soluzione è ovviamente applicare politiche di adattamento al cambiamento climatico e cosviluppo — ne parleremo subito — ma non è possibile ignorare la necessità di gestire lo spostamento di persone causato da un evento di cui è fondamentalmente nostra la responsabilità.
Di fronte alla crescente povertà sono tantissime le persone saheliane che si trovano costrette a vendere i propri ultimi averi — spesso semplicemente, il proprio ultimo bestiame — per finanziare il proprio viaggio, arrivando a destinazione, sia all’interno del proprio paese che all’estero, in condizioni di estrema povertà — condizioni dalle quali nel labirinto di leggi e regolamentazioni internazionali diventa sostanzialmente impossibile risollevarsi.
La soluzione “aiutarli a casa loro” è inadeguata almeno quanto è odiosa. Quello che è necessario è un piano di cosviluppo che permetta all‘intera zona di uscire dalla povertà — e questo è possibile farlo solo attraverso investimenti, privati e pubblici, da donatori internazionali, sostanziali. È la tesi sposata anche da Grammenos Mastrojeni, responsabile ambiente del ministero degli Esteri italiano, e illustrata durante la presentazione del primo numero dell’edizione cartacea di Changes, magazine del gruppo Unipol.
È qui che crolla lo specchio isolazionista di così tante forze politiche europee, l’attivazione di piani globali non dipende dalla mancanza di risorse, ma da una visione politica necessaria per implementarli. Sollevare la zona al di sopra della povertà è anche negli interessi dell’Unione Europea — che dovrebbe vedere nell’Africa il proprio potenziale partner commerciale principale, al di là delle proprie responsabilità etiche e morali.
La fascia del Sahel ha necessità di politiche di adattamento al cambiamento climatico che vanno redatte accettando la realtà dei conflitti locali, e la presenza di fortissimi flussi migratori; programmi che risolvano problemi fondamentali di accesso e disponibilità di risorse naturali, in modo da garantire nuove possibilità di sviluppo. Si tratta di programmi difficili da stilare ma di cui esistono già bozze, che devono partire dal presupposto di combattere le ineguaglianze, di gruppi sociali quanto di etnia e di genere.
Si tratta, sostanzialmente, della necessità di ridefinire le proprie priorità: la presenza di flussi migratori intensi, di conflitti e governi instabili nella regione dovrebbe essere per l’Unione Europea motivo di investimento, concentrandosi sulle zone e le comunità piú fortemente colpite dal cambiamento climatico, o comunque dove le condizioni di vita sono piú fragili e a rischio.
Fondi per l’attivazione di programmi come questo esistono già, non vanno organizzati e non rappresenterebbero nuovi costi per i singoli stati — basti pensare al Fondo per il clima dell’UNFCCC. Si tratta, in ogni caso, di interventi il cui costo è irrisorio in proporzione al risultato: il paper di UNEP – IOP sopracitato pone il costo dell’attivazione di meccanismi di adeguamento su tutta la fascia attorno ai 12 milioni di dollari, compresa la costruzione di una nuova rete di stazioni meteorologiche e l’organizzazione di autorità nazionali e regionali per la pianificazione dell’adeguamento. Per fare le dovute proporzioni: all’ultima spending review questa cifra è l’equivalente di circa 4 ore di attività della Difesa dello Stato italiano.
Parlare di green economy per zone in profonda difficoltà come quelle dell’Africa subsahariana suona nell’attuale contesto socio-politico come un’idea rivoluzionaria, ma si tratta di una soluzione necessaria a un problema che finora abbiamo affrontato a stento alla giornata.
Senza una radicale ristrutturazione dei sistemi agricoli della regione il cambiamento climatico eroderà quello sviluppo che il continente è riuscito a strappare — con la forza — in queste decadi. Lo sviluppo di soluzioni ecologiche per l’Africa subsahariana vuol dire creare nuove possibilità di impiego specializzato. Una crescente industria agricola, capace di produrre posti di lavoro ben retribuiti e adeguata al cambiamento climatico, sarebbe una risorsa insostituibile nella lotta alle tensioni intestine di ogni paese presente nella zona — un altro mondo rispetto alle dannose politiche che vogliono risolvere il problema semplicemente addestrando e armando meglio uno dei fronti in battaglia.
Soluzioni al problema sono discusse dai primi anni cinquanta, quando Richard Barbe Baker per la prima volta presentò l’idea di costruire una Grande Muraglia Verde larga 50 km per contenere il deserto. L’idea è stata periodicamente riproposta, prima nel 2002 e poi nel 2005. Teoricamente la costruzione sarebbe in corso, con lavori in Burkina Faso e Senegal. Lo scorso settembre Amelia Martyn–Hemphill si è recata in Senegal per BBC per osservare come la costruzione del Muro stesse procedendo. Il paese ha già piantato 11 milioni di alberi, ma si tratta solo dell’inizio. La creazione di una barriera verde permette di bloccare l’avanzata del vento desertico che brucia le piantagioni circostanti immediatamente a sud. La situazione è così drastica che piantare e mantenere 11 milioni di alberi consuma meno acqua che contrastare i venti del deserto. Le foglie delle piante permettono di creare compost, e l’umidità prodotta dai tronchi, insieme all’ombra, riduce drasticamente il costo di mantenimento delle coltivazioni e degli orti. Le radici delle piante trattengono l’acqua nel terreno, ridando vita a pozzi che erano rimasti completamente a secco per anni. Gli effetti locali della Grande Muraglia Verde non sono solo ambientali — solo nella zona i nuovi campi coltivati hanno reso possibile l’assunzione di duemila donne.
La Grande Muraglia Verde è, questo sì, un progetto grandioso, in termini di risorse e tempistica. Ma solo attraverso il coraggio di avviare progetti come questo possiamo ridefinire le condizioni di vita nella fascia del Sahel e discutere seriamente di nuove politiche per l’Africa.
Nigrizia, 31 gennaio 2018. Una pesante accusa di landgrabbing e d'inquinamento ambientale (imputato "lo squalo" Vincent Bolloré, amico di Sarkosy), che definisce calunniose le accuse. Il tribunale deciderà
Soprannominato “lo squalo” per la sua ferocia negli affari, il miliardario Vincent Bolloré, al decimo posto tra gli uomini più ricchi di Francia e amico dell’ex presidente Nicolas Sarkozy, è al centro di un processo per diffamazione intentato dalla Società finanziaria del caucciù (Socfin, con sede in Lussemburgo) contro l’organizzazione non governativa Sherpa e diversi giornali francesi. La prima udienza si è svolta il 25 gennaio davanti al tribunale di alta istanza di Parigi.
La questione verte sulle accuse di accaparramento di terre in Camerun. Accuse mosse dagli abitanti delle aree confinanti con le piantagioni della Società camerunese di palme (Socapalm), filiale di Socfin di cui il gruppo Bolloré è azionista. Ora i problemi fondiari sono stati riconosciuti nel 2015 dal gruppo Bolloré davanti al punto di contatto nazionale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in seguito alla denuncia depositata nel 2010 da Sherpa e da altre ong, che hanno anche denunciato i problemi sociali dei dipendenti della piantagione e problemi ambientali (inquinamento delle acque) dell’area. Il gruppo Bolloré e Sherpa avevano anche trovato una convergenza su un piano d’azione che avrebbe dovuto porre rimedio ai problemi. Ma il piano non è stato attuato dal gruppo Bolloré che, nel dicembre 2014, ha dischiarato che a bloccare ogni iniziativa era la Socfin.
Va rilevato che, secondo quanto riportato da Le Monde il 19 agosto del 2017, la Socpalm è anche accusata di deforestazione e di dure condizioni di lavoro imposte ai suoi dipendenti. E nel settembre 2017, un gruppo di donne camerunesi che fanno capo alla Rete degli attori di sviluppo durevole (Radd) ha denunciato aggressioni sessuali e maltrattamenti di cui sarebbero vittime. Il problema è noto alle autorità camerunesi che già nel 2005 avevano chiesto a Socfin di restituire 20 mila ettari di terra alle popolazioni confinanti con le piantagioni.
Sbilanciamoci.info, newsletter 12 dicembre 2017. «Come il capitalismo, con le sue polarizzazioni tra oppressi e oppressori, colonizzati e colonizzatori, ha cambiato il rapporto uomo-natura: Antropocene, Capitalocene, Ecocapitalismo e Cthulhucene»
A 550 km dal circolo polare artico, sulle coste orientali della Groenlandia, si trova la Warming Island (‘l’isola del riscaldamento globale’), riconosciuta come tale nel 2005, quando il ghiacciaio che la univa alla terraferma, ritirandosi a causa dell’aumento della temperatura globale, ne provocò il definitivo distacco.
Quello del riscaldamento globale è uno dei fenomeni che appare oggi in cima alla lista delle principali emergenze ambientali del nostro pianeta. Il progressivo aumento della temperatura terrestre è dovuto all’emissione nell’atmosfera di crescenti quantità di gas serra, strettamente correlate ad attività umane industriali e a politiche economiche imperialiste. Tra gli altri fenomeni antropogenici di mutamento ambientale, la comunità scientifica annovera l’inquinamento (con l’immissione nell’atmosfera, nell’acqua e nel suolo di sostanze contaminanti), il buco dell’ozono, l’effetto serra, l’elettrosmog e l’estinzione di numerose specie naturali (con i suoi annessi fenomeni di deforestazione e desertificazione).
La portata di tali fenomeni ha convinto la maggioranza quasi assoluta della comunità scientifica (parliamo del 97%) a parlare di una nuova vera e propria era geologica, successiva all’Olocene, di cui attualmente le attività industriali dell’essere umano rappresenterebbero appunto i motori costitutivi delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche del pianeta: questa nuova era è definita «Antropocene», termine coniato negli anni anni ’80 dal biologo Eugene F. Stoermer e diffuso nei 2000 dal Premio Nobel per la chimica Paul Crutzen, con la pubblicazione del suo saggio Benvenuti nell’Antropocene.
Tuttavia la riflessione sugli effetti geologici delle attività industriali sull’ambiente ha portato alcuni sociologi, filosofi e analisti politici a indagare le possibili cause storiche del fenomeno. La postulazione di una colpa universale dell’uomo (in quanto specie) non tiene conto infatti delle ragioni storiche e sociali sottese, incentivando di fatto un processo di deresponsabilizzazione collettiva e ignorando del tutto il discorso sui modelli culturali e sociali tramite cui l’essere umano si è sviluppato nelle diverse epoche.
Se infatti per alcune culture non occidentali il rapporto con la natura è paritario e di profonda comunione e alleanza, per quelle tecnicamente più avanzate la netta separazione tra natura e cultura è condizione necessaria a garantire la propria sopravvivenza e il proprio modello di sviluppo. A tal proposito il sociologo Jason W Moore suggerisce di sostituire il termine «Antropocene» con quello di «Capitalocene». Secondo Moore e i suoi sostenitori, la teoria antropocenica, infatti, assumendo l’umanità come totalità omogenea e indistinta, indurrebbe in una vera e propria mistificazione della storia, poiché tralascerebbe di fatto l’analisi della relazioni di potere e dei rapporti di capitale scaturiti da un preciso modello economico (appunto quello capitalistico, sorto nel XVI secolo in Occidente, che avrebbe radicalmente mutato il rapporto tra uomo e natura). Nell’ottica di Moore, capitale e natura si troverebbero pertanto in una relazione dialettica, mutando e influenzandosi a vicenda.
L’oggetto di critica della teoria capitalocenica non sarebbe dunque la storia dell’umanità (in quanto specie), ma quella del capitalismo, con le sue polarizzazioni tra oppressi e oppressori, colonizzati e colonizzatori, con l’obiettivo ultimo di individuare le ragioni storiche e politiche che hanno portato allo sviluppo dell’attuale crisi ambientale.
Tra i sostenitori della teoria capitalocenica figura uno dei più importanti filosofi marxisti tedeschi, c professore di Scienze Politiche presso l’Otto-Suhr-Institut dell’Università Libera di Berlino e co-direttore del Journal for critical sciences. Abbiamo deciso di fargli qualche domanda.
Domande e risposte
Dario Giovanni Alì: Attraverso la teoria dell’Antropocene, gli scienziati hanno segnato il momento di inizio di una nuova era geologica, ponendo particolare attenzione a tutti quei fenomeni geologici distintivi della nostra attuale crisi ambientale: gli inediti livelli di CO2 presenti nella nostra atmosfera e il conseguente fenomeno del riscaldamento globale, le estinzioni di massa di svariate specie, l’aumento del livello dei mari ecc. Nonostante ciò, il termine “Antropocene”, prendendo in considerazione solo le cause e gli effetti geologici di questa crisi, rischia di indurre in una vera e propria mistificazione storica: considera infatti l’umanità (intesa in quanto specie) responsabile dei mutamenti ambientali e globali. A tal proposito, invece, perché il termine “Capitalocene”, coniato da Jason W Moore, sembra più appropriato a descrivere proprio quei rapporti socioeconomici e quelle relazioni di potere che restano fuori dalla teoria antropocenica?
Elmar Altvater: Non c’è alcun dubbio sul fatto che nel corso degli ultimi secoli il genere umano abbia trasformato la Terra in qualcosa di profondamente diverso rispetto al passato. I mutamenti sono evidenti e incisi nelle sfere terrestri, nella biosfera per via dell’influenza degli esseri umani sull’evoluzione, nella litosfera a causa degli effetti delle attività umane sulla struttura sedimentaria della crosta terrestre ecc. Per questo motivo il 29 agosto 2016 l’International Geological Association ha proclamato la fine dell’Olocene e l’inizio di una nuova età della storia terrestre. A seguito di una proposta fatta all’inizio del nuovo millennio dal premio Nobel Paul Crutzen e da altri scienziati naturali, questa nuova età è stata definita come Antropocene. Non vi è alcuna teoria dietro a questa asserzione, e il nome riflette semplicemente l’empirico factum brutum di una profonda influenza del genere umano sulle sfere del pianeta Terra, nello specifico e in modo più sensibile sull’atmosfera, attraverso l’effetto serra. Non andrebbero dimenticati nemmeno gli effetti dell’azione umana sulla biosfera, l’idrosfera, la criosfera ecc., che si sommano al crescente impatto dell’uomo sulla Terra: l’estinzione delle specie, l’acidificazione degli oceani, lo scioglimento delle calotte artica e antartica ecc. Nel complesso significa che per la prima volta nella storia terrestre, cioè in più di 4 miliardi di anni di vita, l’essere umano ha dimostrato di essere in grado di mutare l’evoluzione naturale del pianeta Terra.
Tuttavia, l’umanità rappresenta davvero quell’attore collettivo responsabile del drammatico cambiamento globale? Ovviamente l’umanità non è un’unica entità che agisce collettivamente, ma è invece suddivisa in uomini e donne, in nazioni, tra cui molte sono povere e deboli e alcune ricche e molto potenti. Esistono classi sociali e differenze o divisioni etniche ecc. L’impatto di differenti classi sociali, nazioni e sessi sulla natura del pianeta Terra è diverso. È questa la ragione per cui vi sono delle perplessità sull’appropriatezza o meno del concetto di Antropocene. Alcune autrici femministe preferiscono l’etichetta “Fallocene”, per via della predominanza dell’influenza maschile sulla Terra. Altri parlano di “Necrocene” a causa della tragica accelerazione dell’estinzione delle specie sulla Terra. In modo ironico Donna Haraway ha proposto il termine “Chthulucene” poiché non solo gli esseri umani determinano la direzione dell’evoluzione planetaria ma anche altri importanti attori non umani. Inoltre secondo alcuni autori l’Antropocene tra i suoi effetti collaterali negativi avrebbe il Misantropocene.
La società internazionale geologica rinuncia a tali questioni. I suoi membri sono in cerca di “segni” geologici significativi all’interno dei depositi della crosta terrestre e nelle altre sfere del pianeta, per valutare lo stato in cui si trova la Terra e il nome da dare a questa nuova età. Il caso del concetto di “Capitalocene” è diverso. Non sono l’uomo e la donna, Adamo ed Eva, a rappresentare le dramatis personae, e nemmeno gli altri esseri viventi. Tuttavia, uomo e donna agiscono come esseri sociali all’interno di un dato sistema sociale, e la costruzione sociale dominante del XX secolo è il capitalismo. Quando si schiera a favore del termine “Capitalocene” al posto di quello di “Antropocene”, Jason W Moore ha in mente proprio questo. Forse è stato il primo a utilizzare questo termine all’interno di una pubblicazione scientifica. Tuttavia si sentiva “nell’aria” ed era già stato usato da altri. L’aspetto fondamentale è che il concetto di Capitalocene include la costruzione sociale del capitalismo, così come l’accumulazione capitalistica, all’interno della trasformazione geologica della Terra. In linea teorica ciò conduce in maniera diretta al concetto marxiano del “duplice carattere” di ogni azione economica, del lavoro e della produzione, dello scambio, della distribuzione o del consumo. Trasforma materia ed energia, come per esempio la natura, e in modo coincidente trasforma il valore producendo plusvalore.
G. A: La Rivoluzione Industriale del XVIII secolo è considerata da molti scienziati come il momento d’inizio dell’Antropocene. Tuttavia un primo momento chiave di svolta nel rapporto tra uomo e natura risale probabilmente alle origini del capitalismo, nel XVI secolo, quando si verificò una netta separazione tra l’uomo, da un lato, e una natura oggettivata, dall’altro. In che modo – se è possibile – le pratiche artistiche sono in grado di ricucire questo strappo tra uomo e natura e generare nuovi modelli di conoscenza e consapevolezza?
A.: Si tratta di una questione determinante. Il discorso sull’Antropocene deve essere inteso come una sfida per la comprensione di sé come individui, come esseri sociali e come parti umane del pianeta, estremamente distinte e per lo più natura non umana. Pertanto la relazione sociale tra uomo e natura è importante. Occorre interpretare tale relazione come il complesso metabolismo dell’uomo con la natura. È impossibile un’esistenza umana al di là del circuito metabolico di input e output, di nutrimento e scarto, di sostanze nutritive ed emissioni ecc. Tuttavia dobbiamo ricordarci il significato cruciale della categoria marxiana di “duplice carattere” del lavoro, e in ultima istanza di tutti i processi economici all’interno di una costruzione sociale capitalista. Tutte le azioni umane al medesimo tempo trasformano materia ed energia, per esempio nella produzione agricola o nell’estrazione di carbone o di petrolio, o nella produzione industriale, e si tratta di trasformazioni di valore, come per esempio la produzione di valore e plusvalore. Pertanto il metabolismo dell’uomo con la natura è guidato dal meccanismo capitalista di plusvalore e dalla sua accumulazione. È questo il motivo principale per cui lo sviluppo economico emerge come una potente norma della società in grado di penetrare tutti i sottosistemi della vita sociale.
Dovremmo tenere presente che questa, all’interno della storia umana, è pur sempre una novità. Uno sguardo alle statistiche a lungo termine del millennio, realizzato dall’OECD nel suo Millennium Report del 2001, compilato dallo studioso di statistica Angus Maddison, mostra che nel corso dei secoli il tasso di crescita economico nella storia dell’uomo è sempre stato vicino allo zero. La stagnazione era un fenomeno normale, e i tassi di crescita inferiori non rappresentavano il segno di una crisi, di un cattivo risultato economico o di un fallimento delle politiche economiche. Soltanto a partire dalla rivoluzione industriale della seconda metà del XVIII secolo i tassi di crescita aumentarono di una media globale del 2% annuo. Le conseguenze di ciò furono rivoluzionarie. Tra una generazione e l’altra, il reddito pro capite medio raddoppiò. L’impatto sulle condizioni di vita, sull’esperienza quotidiana del tempo e dello spazio, e quello sulle ideologie furono enormi, molto più incisivi di quelli della rivoluzione francese o di quella russa.
A causa dell’influenza crescente di coloro che guidavano il capitalismo anche il metabolismo dell’uomo con la natura si espanse. Di conseguenza ricollegare l’inizio dell’Antropocene a un evento in particolare, a un “segno” storico, non ha alcun senso. Esso emerge infatti da un lungo processo storico che si svolge nel corso di millenni e che diventa maturo nell’Olocene. Nicholas Georgescu-Roegen, uno dei pochi economisti moderni che assume le fondamenta bio-fisiche dei processi economici, parla di due «Rivoluzioni prometeiche» nella storia dell’uomo. La prima avviene all’inizio dell’Olocene. Si tratta della rivoluzione neolitica dell’agricoltura stanziale che sostituisce la lunga era di caccia e raccolta. La seconda si verifica invece nel XVIII secolo, quando il genere umano comincia a dipendere energeticamente quasi al 90% dai combustibili fossili. Le fonti esterne di energia, come ad esempio le radiazioni solari, sono state sostituite da una fonte interna, le riserve fossili situate nella crosta terrestre, dapprima il carbone, in seguito petrolio e gas. Sfortunatamente le emissioni di combustibili fossili e della loro combustione rimangono nelle sfere terrestri, soprattutto nell’atmosfera. Le conseguenze sono funeste: la possibilità di un collasso climatico.
È ragionevole distinguere alcune fasi nel passaggio dall’Olocene all’Antropocene. La storia moderna antropocenica dell’umanità ha inizio con la rivoluzione neolitica e con i suoi effetti sulla cultura e le grandi civiltà moderne, soprattutto in Asia e Medio Oriente. La fase successiva è costituita dalla nascita delle grandi religioni monoteiste, il giudaismo, il cristianesimo e l’islam. Esse danno forma alla particolare logica dell’accelerazione nel tempo e dell’espansione nello spazio. Il risultato è lo sviluppo della scienza, di una specifica razionalità di conquista della Terra (anche fisica) e di cattura degli esseri umani e delle risorse a partire dal «lungo XVI secolo», com’è stato definito da Fernand Braudel. Vi sono buone ragioni per affermare che l’Antropocene abbia inizio con l’emergere della modernità e del capitalismo, all’epoca del Rinascimento.
Infatti, la fase successiva è quella della rivoluzione industriale, cioè il momento in cui la produzione capitalista di plusvalore assoluto e la sussunzione formale del lavoro (e della natura) sotto il dominio capitalista sono state trasformate in produzione di plusvalore relativo e sussunzione reale del lavoro (e della natura) sotto il Capitale, per usare le parole di Karl Marx.
Quella successiva è la fase della cosiddetta Grande Accelerazione, che si verifica dopo la seconda guerra mondiale. Le emissioni presenti in tutte le sfere del pianeta aumentano fino a un carico eccessivo ben oltre “i confini dello sviluppo”. Non c’è da stupirsi che lo studio del 1972 del Club di Roma sia stato così affascinante. Ancora più importante, comunque, è la capacità umana di distruggere il pianeta utilizzando l’arsenale di bombe atomiche e a idrogeno prodotte dalle superpotenze del pianeta. Il vero dominio del pianeta oggi permette anche la sua distruzione fisica e l’autodistruzione del genere umano. Di certo ciò segna una nuova era della storia umana e planetaria.
G. A.: Uno dei modi tramite cui il capitalismo sembra interessarsi alle questioni ecologiche è il cosiddetto «ecocapitalismo» (o “capitalismo verde”), una visione politica ed economica che estende il concetto di “capitale” all’intero ambiente naturale, con l’obiettivo di indicare le risorse naturali come uno strumento da usare in modo sostenibile e all’interno di un’economia di libero mercato. Possono capitalismo ed ecologia coesistere ed essere compatibili? O piuttosto l’ecocapitalismo rappresenta solo un ulteriore tentativo di sussumere la grande questione ecologica nel capitale?
A.: Visto dalla logica del capitalismo, il pianeta appare come un deposito di risorse e una miniera di inutili emissioni solide, liquide o gassose. Ma non tutto il mondo fa parte di questo deposito, sulla Terra ci sono molte erbacce inutili. Le risorse utili costituiscono l’obiettivo per le strategie del capitalismo di trasformare la natura per quanto redditizia in valore, di creare capitale naturale al di fuori della natura. Vi sono ancora economisti e politici ‘verdi’ che interpretano la trasformazione della natura in capitale come un positivo atto ecologico di difesa ambientale. Il concetto di green economy, di un capitalismo ‘verde’, non è altro che un tentativo ecologico di riconciliare economia ed ecologia, per giustificare la «liberazione del carbonio» come la definisce McKenzie Wark in Molecular Red. Dobbiamo considerare che di un milione d’anni di presenza umana sulla Terra solamente cinquecento anni hanno visto una coesistenza tra uomo e carbonio. Oggi si presenta come necessaria la cattura dell’anidride carbonica per arrestare l’impatto negativo che ha sul clima. La questione decisiva è se la cattura dell’anidride carbonica debba avvenire prima della combustione o, dopo, in forma di CO2. Si tratta solo in parte di una questione di natura tecnica. In fondo, pone i modelli di produzione e consumo in cima all’agenda politica: «Ende Gelände».
G. A.: In Anthropocene or Capitalocene? Donna Haraway presenta una teoria chiamata Cthulhucene. Secondo Haraway «gli esseri umani non sono gli unici attori importanti» coinvolti nei processi di trasformazione, «accanto a tutti gli altri esseri in grado solo di reagire», ma «sono le altre forze biotiche e abiotiche di questa Terra a essere la main story». Tale teoria sembra prendere in prestito alcuni elementi di certa letteratura visionaria e fantascientifica, e presenta una realtà ipercomplessa in cui vi sono interazioni (o intra-actions per usare le parole di Karen Barad) co-costitutive tra ogni cosa e ciascuna creatura. Come analista politico ed economista che cosa ne pensa di questa teoria?
A.: Prima le cose importanti, e ciò significa tradurre il linguaggio di Haraway, Barad e altri in un discorso che possa essere riconnesso ad altri discorsi comuni alle scienze e alle arti. Fatto questo, il concetto di «intra-action» è molto simile a quello hegeliano (ed engeliano) di Gesamtzusammenhang, o al concetto di totalità negli scritti di Marx. Tali concetti sono totalmente anti-individualistici e persino anti-neoliberali. Tuttavia le conseguenze politiche dipendono dalla visione del sistema sociale, del mondo contemporaneo e futuro. Pertanto include necessariamente elementi utopici (o distopici).
G. A.: A giugno 2017, il 45° presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la decisione di ritirarsi dagli Accordi di Parigi siglati da 195 paesi a dicembre 2015 con l’obiettivo di ridurre le emissioni annuali di CO2 e arrestare il fenomeno del riscaldamento globale. Questa notizia, che potrebbe causare disastrose conseguenze sul clima, è rimbalzata sulle prime pagine di tutti i giornali dando inizio a una serie di proteste in Europa e in USA. Tuttavia, generalmente i mass media, soprattutto in Italia – un paese poco attento alle questioni ambientali –, affrontano gli argomenti che riguardano l’ambiente con superficialità o con eccessivo sensazionalismo. Pensare alla crisi ecologica e a quella finanziaria come strettamente connesse l’una all’altra può costituire un modo per stimolare l’interesse pubblico nei confronti delle tematiche ambientali (ma a questo punto diremmo anche politiche e sociali)? Il sistema capitalistico può davvero essere rimesso in discussione e sconfitto? Una volta individuate le cause di questa crisi, che cosa possiamo fare per contrastare i suoi effetti?
A.: Hai ragione nel menzionare la comune origine delle crisi finanziaria e climatica. Si tratta di una delle ripercussioni del “duplice carattere”, che Marx delinea come punto cruciale («der Springpunkt») nell’analisi del lavoro del sistema capitalista. A causa del duplice carattere è impossibile concepire la merce o il denaro e il credito come fenomeni virtuali. Si tratta invece di fenomeni realmente esistenti (e in modo coincidente nella loro struttura sociale con tutte le conseguenze, incluso il feticismo della merce e del denaro). Ciò significa che una merce esiste come cosa materiale e fisica e come relazione sociale immateriale. Tuttavia entrambe le facce della merce sono reali. La crisi finanziaria irrompe per via dello sviluppo contrastante di benessere e debito, di capitale reale e capitale monetario, del mondo del lavoro e di quello della speculazione. I crediti monetari oltrepassano il reale benessere monetario prodotto, di modo che i crediti monetari o finanziari vengono cancellati. Quando le perdite diventano un fenomeno di massa, scoppia la crisi. Aumenta la disoccupazione, così come il numero di bancarotte, il capitale perso diventa visibile e quantificabile, come ad esempio la gradita riduzione delle emissioni di CO2.
Il benessere monetario può essere prodotto solo trasformando materia ed energia e perciò producendo CO2 e altre emissioni. Dato che la vera accumulazione non può essere fermata a causa dei fautori del capitalismo che applicano il sistema per produrre surplus, persino le emissioni di CO2 tecnicamente possono essere ridotte. Tuttavia, come già sappiamo, i margini tecnici della manovra sono limitati. Il duplice carattere è importante anche nei riguardi della soluzione alla crisi. Vi è l’alternativa tecnica di intervenire sul metabolismo grazie alla geoingegneria, mettendo in pratica modelli di gestione delle radiazioni o di cattura e deposito di anidride carbonica. Paul Crutzen, che ha coniato il termine Antropocene, è un fervido sostenitore della geoingegneria. Non a caso. Tecnicamente il genere umano ha trasformato il mondo nel pianeta antropocenico. Il genere umano è inoltre responsabile dei cambiamenti, e l’uomo è in grado di riparare il danno commesso. Tuttavia vi sono seri dubbi che gli interventi o le «intra-azioni» umane riescano ad avere successo su scala planetaria. Qui, come in molte altre aree dell’azione sociale, la portata conta. Con l’incremento di scala, gli investimenti negli impianti di geoingegneria aumentano, così come, secondo la logica dei profitti, la forza del capitale. La geoingegneria non è pertanto sostenibile né socialmente né ecologicamente.
Tuttavia, a causa del duplice carattere vi è un’altra via d’uscita dallo stallo della crisi antropocenica e geopolitica. La vediamo all’orizzonte quando interpretiamo l’Antropocene come Capitalocene. Questo perché la crisi climatica, l’estinzione delle specie, le minacciose catastrofi atomiche e le guerre non possono essere intese come un risultato dell’azione umana in quanto tale. La crisi del nostro mondo contemporaneo e antropocenico va intesa come la crisi della forma sociale, dell’insieme di forme sociali (come ad esempio della costruzione sociale) e dei suoi modelli di produzione. Pertanto la costruzione sociale e ogni sua emanazione possono e devono essere cambiate per superare le molteplici crisi capitaloceniche del sistema sociale e della natura del pianeta Terra, come ad esempio la crisi economica, finanziaria e sociale dell’accumulo di capitale e la propensione alla crisi del clima, dell’evoluzione, delle acque globali e della cultura umana. I primi passi per mettere in salvo il pianeta dal disastro dell’Antropocene vengono fatti all’alba di una rivoluzione.
Questo articolo, ripubblicato da Sbilanciamoci.info, è raggiungibile nella pagina di Kabulmagazine.com, dalla quale lo abbiamo ripreso
Uno degli argomenti più caldi in discussione alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP23), tenutasi a Bonn tra il 6 e il 17 novembre, sono stati gli aiuti finanziari per coprire i danni e le perdite (loss & damage) legati alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Questione urgente e troppo a lungo rimandata, divide i Paesi sviluppati e in via di sviluppo in una lotta che resta irrisolta. C’erano molte aspettative per quest’anno in cui le Fiji avevano la presidenza della conferenza, dato che le isole del Pacifico sono una tra le aree del mondo più colpite dal riscaldamento globale e a rischio di scomparsa per l’innalzamento del livello dei mari. Nonostante ciò, la questione è rimasta irrisolta, rimandata al 2018.
Azioni di persuasione non sempre lecite per convincere, con successo, i nostri governanti e la Commissione Europea a continuare una politica energetica basata sul gas, che è tutt'altro che un' energia pulita.
L’articolo ripreso su eddyburg dall’open democracy riporta alcune delle tante azioni di “lobby”, ampiamente descritte nel rapporto, messe in campo dall’industria del gas. Queste comprendono tangenti per ingraziarsi i politici europei, elargite con soldi riciclati attraverso il paradiso fiscale azerbaigiano nonchè azioni apparentemente più morbide, come le pressioni fatte a istituzioni accademiche in cambio di collaborazioni varie, la sponsorizzazione di eventi culturali e sportive. L’Azerbaijan è noto per le violazioni dei diritti umani, la repressione dell’opposizione, e la sua “diplomazia del caviale" che con abbondanti doni, da tappeti di seta a oro, argento e chili di caviale, si compra sia il silenzio sull’infrangimento dei diritti umani che l’appoggio alla costruzione del Trans Adriatic Pipeline (TAP), uno dei mega progetti in previsione (vedi la mappa qui sotto) per allargare l’approvvigionamento e consumo di gas.
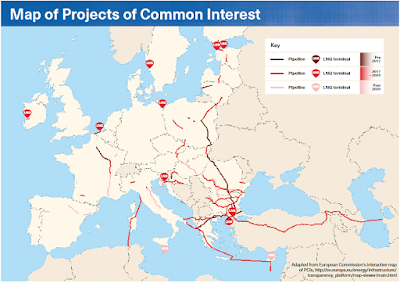 |
| Fonte: Balanyá, B. e Pascoe Sabido, P. (2017) The Great Lock-in, Corporate Europe Observatory |
Una lobby che ha dato i suoi frutti! Infatti la Commisssione Europea e i governi nazionali, anziché trasformare il sistema energetico in direzione del vento, del sole e soprattutto della riduzione del consumo di energia, hanno sostenuto, approvato e finanziato l’espansione della fornitura di gas.
Il TAP è un progetto iniziato a metà 2016 per la costruzione di un gasdotto che trasporterà il gas dall'Azerbaijan all’Europa, attraversando la Turchia - dove si collegherà al Trans Anatolian Pipeline - la Grecia settentrionale, l’Albania e l’Adriatico per poi approdare in Puglia, collegandosi alla rete nazionale. I lavori sono gestiti da un consorzio di aziende, tutti colossi dell’energia: Bp, Socar, Snam, Fluxys, Enags e Axpo.
«Una volta realizzato, costituirà il collegamento più diretto ed economicamente vantaggioso alle nuove risorse di gas dell’area del Mar Caspio, aprendo il Corridoio Meridionale del Gas, una catena del valore del gas lunga 4.000 chilometri, che si snoderà dal Mar Caspio all’Europa.» (dal sito della TAP: www.tap-ag.it/).
Ma vantaggioso per chi? Non certo per i cittadini.
Ad aprile un’ inchiesta dell’ Espresso, che aveva potuto esaminare i documenti riservati della Commissione Europea, aveva già rivelato come il progetto celava il riciclaggio di denaro mafioso con la compiacenza dei governanti e ovviamente di tutte le ditte coinvolte. Qui il link all’articolo, già ripreso da eddyburg.
La questione più spaventosa di questo intrigo tra affari, mafia e potere politico è che questa scelta costringerà l’intera Europa a protrarre per oltre 40-50 anni la sua dipendenza dai combustibili fossili, con conseguenze disastrose per il clima, le comunità locali e per i territori lungo tutta la tratta del gas, infrangendo gli impegni presi in materia di cambiamenti climatici ed energia pulita.
Il gas – nella sua forma convenzionale o quella ora più gettomata derivante da giacimenti non convenzionali in argille (fracked gas) - sebbene sia una fonte energetica più pulita del petrolio appartiene alla lista dei combustibili fossili e responsabile dell’incremento del cosiddetto effetto serra.
Il processo di estrazione dei fracked gas richiede alti volumi di acqua e prodotti chimici inquinanti, ha impatti particolarmente negativi sui territori e comunità locali. Ma anche l’estrazione del gas convenzionale provoca seri problemi in quanto favorisce la formazione di dissesti geologici. Per esempio nei Paesi Bassi il governo è stato messo sotto pressione per ridurre l’estrazione di gas dal campo di Groningen dopo ripetuti terremoti che hanno danneggiato migliaia di case.
Anche l'impatto sul clima è enorme. Nonostante il gas viene spacciato dalla lobby, dalla Commissione Europea e dai governi nazionali come “energia pulita” e “un ponte verso l’energia rinnovabile” esso rimane un dannosissimo combustibile fossile. È vero che quando brucia emette meno anidride carbonica rispetto al carbone, ma essendo il gas naturale composto in gran parte da metano, si verifica che il suo impatto, in arco di tempo di 10 anni sia 100 volte di più dannoso della CO2. Inoltre c’è una grande perdita nel trasporto e tariffe più alte di quanto stimate in precedenza. Lo scienziato Americano Robert Howarth ha affermato che "il gas naturale è un ponte verso il nulla".
Infine i danni causate dalle infrastrutture stesse. Le campagne “Platform” e “Re:Common” hanno documentato numerose violazioni lungo la rotta dal Mar Caspio all’Europa. Ma in Azerbaijan, dove inizia il gasdotto, quelli che tentano di denunciare il progetto sono finiti in carcere o assoggettati a dura repressione.
Non mancano le proteste in Italia, il Comitato No Tap cerca da tempo di fermare il progetto. Anche se la Commissione europea, il governo italiano e la società Tap dicono che i cittadini e le autorità locali, si sono mosse troppo tardi, le opposizioni si sono fatte sentire sin dal 2011. Su eddyburg abbiamo pubblicato un articolo a questo proposito: “No Tap, la lunga storia dell'opposizione al gasdotto pugliese”.
Proprio di recente, anche il ricorso della Regione Puglia non è stato ascoltato. La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il conflitto sollevato dalla Regione Puglia contro lo Stato, quindi la costruzione proseguirà. Il governatore della Puglia accusa il governo di avere agito senza l’intesa della regione e dei suoi abitanti in un progetto in cui "La prepotenza di questa scelta è sotto gli occhi di tutti", ed è calpestata "la volontà delle popolazioni che non accettano, giustamente, l'approdo del gasdotto" vicino a una delle spiagge più belle del Salento (Repubblica.it, 10 ottobre 2017). La Puglia accusa il governo – nella fattispecie il ministero dello Sviluppo economico (Mise) che ha autorizzato la costruzione dell'opera - di non avere intrapreso nessuna trattativa per trovare una soluzione condivisa, in particolare sul punto di approdo del gasdotto, ma la Consulta ha ritenuto non ammissibili i motivi del ricorso.
il Fatto Quotidiano, 31 ottobre 2017. Ferruccio Sansa intervista il meteorologo Luca Mercalli sui cieli colorati e gli inquinamenti dell'aria che respiriamo. (p.d.)
il manifesto, 29 ottobre 2017. Due incontri paralleli a Milano che esprimono un grande conflitto della globalizzazione capitalista: quello tra gli sfruttatori dell'acqua, che vogliono diventare più potenti, e quello degli assetati o sfrattati, che vogliono sopravvivere.
Il 5 e il 6 novembre si svolgerà a Milano l’incontro dei ministri della salute del G7.
Gli argomenti in agenda sono: le conseguenze sulla salute dei cambiamenti climatici, al quale verranno dedicate 3,5 ore di discussione; la salute della donna e degli adolescenti 1,5 ore, e la resistenza antimicrobica 1 ora. Tempi sufficienti, secondo i ministri, per arrivare ad una solenne dichiarazione finale su questioni la cui rilevanza è fondamentale per il futuro dell’umanità. Considerato che a quei tavoli siederanno i massimi responsabili dell’attuale modello di sviluppo è fin troppo facile immaginare che, al di là delle parole, vi sarà il vuoto.
Decine di associazioni impegnate in difesa della salute a livello locale, nazionale e internazionale hanno costituito il comitato «Salute senza padroni e senza confini» e, insieme al Gue, gruppo parlamentare «Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica» e al gruppo consiliare «Milano in Comune», hanno organizzato a Milano due iniziative.
Sabato 4 novembre un «Forum internazionale per il diritto alla salute e l’accesso alle cure»
Domenica 5 novembre si svolgerà un incontro tra i movimenti italiani attivi nella difesa della salute per organizzare insieme delle campagne nazionali. I temi del Forum sono: «la disuguaglianza sociale come determinante di malattie», nel 2012 l’effetto Glasgow aveva dimostrato come il tasso di mortalità fosse strettamente correlato alle condizioni sociali della popolazione, l’Istituto Mario Negri ha documentato lo stesso fenomeno a Milano.
«L’accesso alle cure», il 50 % delle persone colpite dal virus Hiv nel mondo ne sono prive e l’accesso ai farmaci salvavita non è più garantito nemmeno nel mondo occidentale come testimonia la vicenda del Sofosbuvir per l’epatite C.
«La privatizzazione dei servizi sanitari» vera preda del mercato globale ma anche locale come dimostra, ad esempio, il tentativo della Regione Lombardia di sostituire, nell’assistenza a 3.350.000 cittadini con patologie croniche, il medico di famiglia con un gestore, società per lo più private finalizzate al profitto.
E infine «Le conseguenze sulla salute dei cambiamenti climatici». Amitav Gosh, noto romanziere bengalese, ha recentemente pubblicato un saggio: «La Grande Cecità», quella dei cambiamenti climatici. L’accusa è, alla letteratura mondiale, di essere centrata su l’umano e i suoi diritti, e di aver ignorato il «non umano», indifferente ai destini della terra, dell’acqua e dell’aria, relegati tutti nella letteratura di serie B: la fantascienza. Eppure di cambiamenti climatici ci si ammala e si muore; per l’Oms potrebbero provocare 12,6 milioni di decessi tra il 2030 e il 2050. 250.000 morti in più ogni anno: per malnutrizione, malaria, diarrea. 20.000 morti per colpi di calore nella sola Europa. A questi numeri andrebbero aggiunti i morti per la maggior concentrazione di inquinanti nell’atmosfera dovuti all’assenza di piogge: 500.000 deceduti in Europa, 90.000 in Italia e 9 milioni nel mondo.
Ma la vera tragedia del cambio climatico è l’acqua. Siccità e alluvioni agiscono pesantemente nel ridurne la sua disponibilità. Nel 2050 verrà a mancare il 50% del necessario e a farne le spese saranno i poveri della Terra, i 900 milioni di persone prive di acqua potabile. La corsa all’accaparramento delle terre fertili e degli invasi da parte delle multinazionali e dalla Cina e dall’Arabia saudita è da tempo iniziata e i mutamenti climatici l’accentueranno sempre più. Le grandi dighe prolificano in Asia e in Africa con il loro seguito di profughi e di guerre e le multinazionali degli acquedotti Suez – Veolia – Thams Water – Rwe ecc.. premono con maggior forza per la privatizzazione dei rubinetti di tutto il mondo.
Le stime dell’alto commissario delle Nazioni Unite parlano di 79 guerre in corso per cause ambientali e appropriazione di risorse. Nella guerra del Kashmir (100.000 morti) ci sono le dighe sul fiume Indo e la concorrenza tra India, Pakista, Cina. L’Egitto è una polveriera di 90 milioni di persone che vivono attorno al Nilo aggredito dalle dighe dell’Etiopia. La guerra in Siria avviene dopo 5 anni di siccità e di dighe turche sul Tigri. Le guerre ai kurdi hanno acqua e petrolio sullo sfondo.Nella contabilità mondiale 3 miliardi di persone sono considerati da «qualcuno»: insostenibili esuberi.
Beni comuni salute del pianeta e salute pubblica vanno insieme e vanno collocate in cima alle nostre priorità.
Vittorio Agnoletto comitato «Salute senza padroni e senza confini». Emilio Molinari contratto mondiale dell’acqua
 Altreconomia, 13 ottobre 2017«Non possiamo fare finta di non vedere le contraddizioni di chi parla di produzioni sostenibili e allo stesso tempo costruisce gasdotti, Tav, e altre opere che cementificano la terra»(c.m.c)
Altreconomia, 13 ottobre 2017«Non possiamo fare finta di non vedere le contraddizioni di chi parla di produzioni sostenibili e allo stesso tempo costruisce gasdotti, Tav, e altre opere che cementificano la terra»(c.m.c)
Il G7 Agricoltura, sotto gli auspici della presidenza italiana, apre le porte sabato 14 ottobre a Bergamo. Una due giorni per avviare «un confronto internazionale di grande rilievo sulle azioni e sulle responsabilità da esercitare in campo agricolo e alimentare, per produrre meglio sprecando meno e garantire livelli di sostenibilità sempre maggiori al futuro dell’agricoltura globale», come scrive il ministro Maurizio Martina sul sito http://agriculturabg.it/. Un vertice che ha avuto un lungo prologo la settimana passata, con convegni, incontri e laboratori, mercati e degustazioni in città che -sulla spinta dell’Expo di Milano- parlano di “diritto al cibo”, “sostenibilità e giustizia”, “cibo più giusto e sicuro”.
Un vocabolario che sembra incompatibile con altre scelte portate avanti dal Governo, come spiega Roberta Maltempi, coordinatrice della “Rete bergamasca per l’alternativa al G7”. «Non possiamo fare finta di non vedere le contraddizioni di chi parla di produzioni sostenibili e allo stesso tempo costruisce gasdotti, Tav, autostrade come la Brebemi e altre opere che cementificano la terra, mettono a rischio la sicurezza idrogeologica del Paese e la salute dei cittadini. O ancora, un Governo che non mette in discussione le multinazionali dell’agrobusiness, responsabili dell’insicurezza alimentare, della desertificazione e della deforestazione e perdita di biodiversità».
Per la Rete alternativa -nata la scorsa primavera quando si è saputo che il ministro Martina, originario di Calcinate (Bg), avrebbe portato il G7 nella sua città -, «l’agrobusiness e l’agroecologia non sono compatibili. Fin dall’inizio abbiamo capito che il G7 di Bergamo avrebbe fatto leva sui percorsi ecosostenibili già attivi in città, come il distretto di economia solidale, ma proponendo questi come complementari a un sistema industriale distruttivo, anziché come reale alternativa -spiega Roberta-. Noi crediamo che si debba invece guardare alla sovranità alimentare e all’autodeterminazione dei popoli come modello alternativo all’intero sistema economico».
La caratteristica della Rete alternativa è quella di essere una comunità trasversale, che in questi mesi è stata capace di tenere insieme «il mondo -molto vivace nella nostra Provincia- dell’agricoltura biologica, dei piccoli produttori, dei gruppi d’acquisto solidale, che difendono un’agricoltura sana e naturale, con altre realtà che stanno praticando il mutualismo per affrontare la crisi e si pongono il problema di poter garantire a tutti l’accesso al cibo -spiega Roberta-. C’è il mondo cattolico, i sindacati di base, le associazioni locali e le reti di economia solidale», per 93 adesioni alla Rete da tutta Italia.
Insieme, hanno costruito un programma di tavole rotonde e momenti trasversali di confronto che si svolgeranno nel fine settimana per “svelare i lati oscuri del sistema agro industriale e proporre un’alternativa”. Le giornate del G7, infatti, vogliono essere solo “un pretesto per rafforzare una rete che costruisca sui territori pratiche di agricoltura sostenibile e mutualismo”.
Il forum alternativo si svolgerà all’Edoné Bergamo di Redona; si aprirà con una plenaria sabato 14 ottobre alle 9.00 sul tema “agrobusiness vs agroecologia” e si chiuderà con una manifestazione a Bergamo, domenica con concentramento alle 14.00 nel piazzale della stazione.
Agricoltura, mutualismo, lavoro e montagna saranno le quattro parole chiave del meeting all’Edoné, uno spazio che in questi giorni sarà animato anche da musica e convivialità attorno al cibo, con il mercato delle aziende bio e i banchetti delle associazioni locali.
In contemporanea, i “grandi 7” discuteranno “due grandi temi in agenda: la tutela degli agricoltori dalle crisi, dovute anche alle calamità naturali e ai cambiamenti climatici e le migrazioni e la sicurezza del cibo per una popolazione mondiale in crescita”. Una realtà fotografata anche dal report Fao 2017 “The state of food security and nutrition in the world” -in uscita in occasione del “World food day” del 16 ottobre-, nel quale si sottolinea il grave aumento della fame nel mondo: oggi colpisce l’11% della popolazione.
«Oltre ad aumentare la percentuale della popolazione mondiale che soffre di fame cronica a causa della malnutrizione - si legge nel report -, il numero di persone che soffre la fame è aumentato da 777 nel 2015 a 815 milioni». Tra le cause, le carestie in Sud Sudan, i conflitti in Nigeria, Somalia e Yemen, siccità e inondazioni legate al cambiamento climatico. «Negli ultimi 10 anni il numero di conflitti violenti è aumentato significativamente in tutto il mondo - scrive la Fao -, in particolare in paesi già toccati da una insicurezza alimentare, colpendo duramente le comunità rurali con un impatto negativo sulla produzione e la disponibilità di cibo».
Reset.it, 6 ottobre 2017. Il rapporto fra cambiamenti climatici, accesso alle risorse, giustizia globale, accentramento del potere e corsa agli armamenti analizzato da Amitav Ghosh. (p.d.)
Conosciamo Amitav Ghosh come un romanziere, probabilmente uno dei più grandi scrittori indiani contemporanei. Ghosh però è anche uno studioso, e la sua formazione di antropologo è visibile nel rigore della documentazione in ogni suo romanzo. Ghosh è anche un giornalista, autore di alcuni bellissimi reportage e di numerosi saggi.
È un lungo saggio anche il suo ultimo libro, La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile, che tratta di come la cultura, e in particolare la letteratura, reagisce alla drastica trasformazione dell’ambiente in cui viviamo. Un cambiamento globale e profondo, che ormai è sotto i nostri occhi. Basti pensare agli eventi degli ultimi mesi: la siccità in Italia, l’ondata di caldo battezzata Lucifero, le disastrose alluvioni in Asia Meridionale, una serie di uragani nel golfo del Messico (eventi che hanno ricevuto attenzione diseguale: alla fine di agosto, proprio mentre i media mondiali seguivano la marcia del ciclone Harvey verso il Texas, in Bangladesh e India le alluvioni hanno ucciso 1.500 persone: senza quasi lasciare traccia sui media italiani). Insomma: per dirla con Amitav Ghosh, le forze naturali che plasmano il nostro ambiente ci lanciano segnali che però stentiamo a riconoscere. Ho incontrato Amitav Ghosh durante il recente festival Internazionale a Ferrara.
Lei sostiene che il cambiamento del clima sta sconvolgendo il nostro ambiente fisico ma noi, gli umani, non vogliamo vederlo. È questa “la Grande Cecità”?
È vero, assistiamo a fenomeni meteorologici estremi un po’ ovunque. Quello che più mi ha impressionato è la recentissima inondazione a Livorno: una famiglia va a dormire tranquilla, senza segni di avvertimento, e si sveglia mentre sta annegando. Non solo non vogliamo riconoscere le forze naturali intorno a noi, non vogliamo neppure prendere atto dei pericoli che corriamo a causa del cambiamento climatico.
Ma perché lei chiama in causa gli scrittori? Un argomento centrale del suo libro è che la letteratura non riesce a riflettere sulla trasformazione del clima, benché sia di gran lunga la crisi più drastica del nostro tempo: dice che gli intellettuali, e più precisamente i letterati, rischiano di essere complici della “Grande cecità”.
Parlo degli scrittori in primo luogo perché è ciò io faccio proprio questo, scrivere. Ma è un atto di auto-critica, non sto additando gli altri. Mi interessa analizzare questo fallimento collettivo: noi, intellettuali, scrittori, artisti, ci stiamo dimostrando incapaci di riflettere sul cambiamento del clima. L’ironia è che questa è un’epoca di intellettuali e scrittori impegnati, engagés su ogni tipo di questione e in particolare questioni di identità, genere, razza, nazionalità, o delle diseguaglianze. Eppure la crisi ambientale, benché sia di gran lunga il pericolo più grande per l’umanità, resta al margine. È bizzarro che il grande cambiamento intorno a noi non entri a far parte della nostra consapevolezza.
Il ruolo del narrare, lei ha scritto, è “affrontare il mondo al congiuntivo“, cioè “immaginare altre possibilità”. La crisi del clima ci impone di immaginare altre forme di esistenza umana sul pianeta, e lei dice che la fiction è l’espressione culturale più adatta a farlo. Dunque oggi cosa si aspetterebbe da uno scrittore?
Se guardiamo il romanzo del Diciannovesimo secolo credo che Moby Dick sia uno dei romanzi più intensi mai scritti. Riesce a esprimere un profondo legame con il mondo non-umano: in Moby Dick la balena è un essere pensante, dotato di un’energia quasi diabolica. Herman Melville è consapevole del danno ambientale provocato dalla caccia alla balena, spinta quasi all’estinzione, e attraverso il linguaggio riesce a mostrarci le contraddizioni della storia umana in relazione al mondo naturale. Mi viene da pensare anche a Zola, e a come ha esplorato le prime fasi dell’economia basata sui combustibili fossili: il carbone è un tema ricorrente nel suo lavoro. Nel romanzo del Ventesimo secolo, prendiamo Furore di John Steinbeck: per me è un romanzo sul cambiamento climatico ante litteram. Steinbeck descrive la risposta umana a un catastrofico evento climatico, la grande siccità, e le prime quattro pagine del romanzo sono forse la più potente narrazione del clima mai scritta. Insomma: voglio dire che gli umani hanno avuto gli strumenti per parlare di tutto ciò. Ma questo si è perso negli ultimi cinquant’anni. Per ironia proprio i processi che hanno portato in campo i gas di serra, responsabili del riscaldamento globale, sono gli stessi processi che stimolano il consumismo e ci portano a dimenticare il mondo fisico intorno a noi.
In effetti l’ambiente naturale è molto presente nei suoi romanzi – penso a Il paese delle Maree, dove la foresta del Sundarban, in Bengala, è protagonista della narrazione. In La grande cecità troviamo numerose digressioni narrative, che ne fanno una lettura affascinante. Ad esempio racconta come la Birmania aveva sviluppato una primitiva industria petrolifera, poi assorbita dalle compagnie britanniche. In effetti un grande merito di questo libro è che sposta lo sguardo: dal nostro punto di vista Euro-centrico, ci porta a spostare l’attenzione sull’Asia. Dice che l’Asia è cruciale nella crisi del clima. In che senso?
L’Asia è al centro di tutta la faccenda del clima perché è stato il rapido sviluppo economico di alcuni paesi asiatici negli ultimi vent’anni a far precipitare la crisi climatica. La crescita in Cina, India, Indonesia, per citare i tre paesi più popolosi, ha accelerato le emissioni globali dei gas di serra, quindi il riscaldamento dell’atmosfera. Ma così l’Asia ha dimostrato che un modello di economia ad alta intensità di risorse e di capitali può funzionare solo se praticato da una piccola minoranza della popolazione mondiale. In effetti, nell’Ottocento e fino agli anni ’70 del Novecento era così, solo il mondo Occidentale poteva praticare un’economia basata sui combustibili fossili. Ma poi quando Cina, India e Indonesia sono entrati in gioco – sia pure in piccolo, perché l’impronta ecologica di questi paesi resta molto piccola se paragonata all’Europa – questa sia pur modesta espansione ha accelerato il collasso del clima. L’Asia ha dimostrato che l’economia basata sui combustibili fossili non può essere estesa a tutto il mondo. E questa è un’altra straordinaria ironia: negli anni seguiti al 1789 la Rivoluzione francese ha affermato le idee di libertà, eguaglianza e fraternità, ma allo stesso tempo abbiamo enormi diseguaglianze, il lavoro forzato, la corsa delle potenze coloniali ad arraffare le risorse nel Sud del mondo. Per tutto il Ventesimo secolo abbiamo inseguito idee di progresso per combattere le diseguaglianze. Ma ora dobbiamo scoprire che era solo un’illusione: non possiamo perseguire in modo paritario il consumo di combustibili fossili.
Quindi il cambiamento del clima mette sul tavolo la questione dell’accesso alle risorse e della giustizia globale.
Certo. Il mondo in cui viviamo oggi è più diseguale di quello del Diciottesimo secolo. Le disparità di ricchezza e di potere non sono mai state così forti, sia tra nazioni – ad esempio l’Asia rispetto all’Occidente – sia all’interno delle singole nazioni, ad esempio in Cina o in India. E questo è un effetto del neoliberalismo. Nel dibattito sul clima parliamo spesso di “scettici”,“negazionisti”, ma lei argomenta che i veri detentori del potere sono ben consapevoli della sfida del clima: semplicemente non hanno alcuna intenzione di modificare il modello di economia su cui è fondato lo stile di vita Occidentale. Questo è un punto importante. È un errore pensare che quanti avversano le politiche sul clima siano inconsapevoli. L’amministrazione Trump, lo stesso presidente Donald Trump, il segretario di stato Rex Tillerson, perfino Steve Bannon, sono ben informati. Sanno. E sarebbe un errore anche pensare che non abbiano un piano: il loro piano è questo. Il piano è lo status quo. Contano su un’apocalisse climatica che ucciderà un gran numero di esseri umani. E questo perché sanno benissimo che l’economia estrattiva su cui si fonda lo stile di vita occidentale può funzionare solo per numeri piccoli. In un certo senso sono catastrofisti malthusiani. Pensano che una catastrofe malthusiana si avvicina, e si stanno preparando.
È quella che lei chiama “politica della scialuppa armata”?
Esatto. La “politica della scialuppa armata” significa tenere fuori gli immigranti a tutti i costi, militarizzare le frontiere, armarsi fino ai denti, difendere il proprio accesso alle risorse, e fare di tutto ciò una questione di sicurezza.
In effetti negli ultimi dieci o quindici anno diverse istituti di studi strategici hanno cominciato a ragionare sull’impatto del cambiamento climatico come una questione di sicurezza. Non ultimo il Pentagono, cioè il ministero della difesa della prima potenza mondiale…
Sì, ed è interessante. Oggi il più grande singolo consumatore di combustibili fossili al mondo è proprio il Pentagono. Un anno di operazioni militari brucia una quantità di energia fantasmagorica. E tutti gli eserciti sono in espansione: Russia, Cina, India, tutti paesi che hanno firmato gli Accordi di Parigi sul clima, eppure stanno rapidamente rafforzando la propria difesa: e questo perché dall’inizio della Rivoluzione industriale i combustibili fossili e il potere sono inestricabilmente legati. Il carbone ha permesso alla Gran Bretagna di innescare la rivoluzione industriale e allo stesso tempo creare un’industria delle armi: è così che ha sconfitto l’intera flotta cinese con una sola nave da guerra a vapore, la Nemesis. Da allora ogni paese sa che i combustibili fossili hanno una relazione diretta con il potere, e ogni paese sta surrettiziamente allargando l’uso di combustibili fossili per la difesa. Solo che nessuno dirà al Pentagono “ora dovete tagliare”. E questo anche perché via via che il cambiamento del clima accelera, e cresce il suo impatto, vedremo più insicurezza. Conflitti per l’acqua e per le risorse sono già una realtà in diverse parti del mondo. Un circolo vizioso: aumentano i conflitti per le risorse e aumenta il consumo di combustibili fossili, cosa che a sua volta accelera il cambiamento del clima.
Vuol dire che andiamo verso una situazione in cui una piccola élite mondiale vorrà monopolizzare le risorse naturali, l’acqua l’energia?
Appunto. Il cambiamento del clima è in sostanza una questione di potere: non ci sarà un approccio realistico se non metteremo in discussione la distribuzione globale del potere.
Tra gli effetti del cambiamento del clima si parla spesso di masse di persone costrette a sfollare da eventi estremi come alluvioni o siccità, quindi nuove ondate di migranti. Nei suoi romanzi l’esperienza del migrare è molto presente – contadini egiziani che si spostano in Medio oriente, migranti bengalesi nella penisola Arabica, commercianti indiani nella Cina del secolo scorso… Lei sembra suggerire che attraversare frontiere, sia geografiche che culturali, è parte dell’esperienza umana, e di sicuro parte della modernità. In Europa però l’arrivo di alcune centinaia di migliaia di persone suscita paure e reazioni ostili…
La crisi dei migranti mi interessa molto. Sarà per la mia storia familiare: io sono bengalese; i miei avi venivano da quello che ora è Bangladesh ma dovettero emigrare, intorno al 1850, perché un fiume aveva cambiato il suo corso e sommerso il nostro villaggio. Forse è per questo che mi sono sempre interessate le storie di sfollati e migranti. Negli ultimi mesi ho visitato diversi centri per migranti in Italia – in Sicilia, vicino a Milano, a Venezia. Io parlo bengalese, hindi, urdu, arabo, e queste oggi sono le lingue dei poveri globali: posso avere una comunicazione diretta con le persone che ho incontrato. Cosa ho ricavato da queste visite? Primo, che in effetti è vero, la gran parte di questi migranti sono spinti da effetti del cambiamento climatico: è vero per il Sahel e l’Africa sub sahariana, ma anche per il Bangladesh, che oggi è il secondo paese di provenienza di immigrati in Italia. Ma è complicato. Prendiamo una famiglia rurale in Bangladesh. Un anno la terra viene allagata: è cosa che succede, e loro riescono a farvi fronte. Ma l’anno dopo l’alluvione si ripete, e anche quello dopo ancora, e le risorse per fare fronte non ci sono più. Di solito, la prima risposta sarà mandare il figlio, un ragazzo di 16 o 17 anni, a cercare lavoro in città, magari a Dhaka. Se non lo trova, il ragazzo finirà su una delle barche che attraversano il Mediterraneo. Ma se gli chiedete ‘sei un migrante climatico’ lui negherà. Un elemento che spesso sfugge agli europei è che nessuno dei migranti che sbarca in Europa si percepisce come vittima. Loro sono protagonisti. Hanno iniziativa. E in effetti per intraprendere un viaggio così pericoloso devi avere iniziativa, e coraggio.
Un altro aspetto spesso tralasciato è l’impatto delle nuove tecnologie delle comunicazioni. I telefoni cellulari e l’internet sono fondamentali per i migranti. Il telefonino ti permette di vedere foto, sapere cosa succede in Europa, essere aggiornato sui percorsi, trasferire soldi. Forse il servizio più importante che le Ong possono offrire ai migranti sono i punti di ricarica. In questo vedo un’altra delle ironie del cambiamento del clima: proprio il tipo di consumismo che porta alla crisi del clima porta anche a una sempre maggior dipendenza da questi strumenti che stanno tagliando la nostra connessione storica alla terra. In un villaggio del Bangladesh vedi telefilm magari girati a Calcutta, che mostrano una vita piena di automobili e frigoriferi e cose simili: e sono gli oggetti che tutti vorranno. Voglio dire che siamo di fronte a una crisi su parecchi livelli. È una questione di cambiamento del clima e anche una questione di desideri, solo che questo aspetto non è spesso considerato. Forse il solo che abbia compreso la natura ambigua della questione è Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Sì. Il capo della chiesa cattolica, con la sua rete di istituzioni a diretto contatto con i poveri, deve avere percepito che il desiderio di migrare non riguarda solo la povertà.
Amitav Ghosh è nato a Calcutta nel 1956. Ha studiato a Oxford, dove ha conseguito un dottorato in antropologia sociale. Vive tra New York e l’India. È autore dei romanzi Il cerchio della ragione; Le linee d’ombra; Il cromosoma Calcutta; Il palazzo degli specchi; Il paese delle maree; e la “trilogia dell’Ibis” (Mare di papaveri, Il fiume dell’oppio e Diluvio di fuoco). La grande cecità è il suo secondo lavoro di non-fiction dopo Lo schiavo del manoscritto. Tra i reportage vanno segnalati Conto alla rovescia (sui test nucleari dell’India nel 1998), e Danzando in Cambogia. Articoli e saggi di Ghosh sono stati pubblicati da The New Yorker, The New Republic e The New York Times; una raccolta di saggi brevi è pubblicata nel volume Circostanze incendiarie.
il Fatto Quotidiano, 23 settembre 2017. «Quanto vale un bosco, un ruscello, l’aria pulita? “Il nostro benessere: lo insegna la contabilità ambientale”». (p.d.)
Il clima sta cambiando, i suoi effetti sono evidenti e le responsabilità delle attività umane sono innegabili. Internazionale online, 11 settembre 2017 (p.d.)
Anche se ha riguardato l’intero paese, costringendo sindaci e governatori a dichiarare lo stato d’emergenza, alcune zone ne hanno risentito di più. La pianura padana, dove si concentra il 35 per cento della produzione agricola nazionale e dove si produce circa il 40 per cento del pil italiano, è una di queste: la sua principale riserva d’acqua, il bacino idrico del Po, si è ridotta drasticamente proprio nei mesi in cui c’era più bisogno di irrigare i campi. “L’acqua da queste parti non è mai stata un problema, ora invece dobbiamo scegliere quali coltivazioni innaffiare e quali lasciare al loro destino,” dice Varani. Come molte altre aziende della zona tra Piacenza e Parma, anche la sua ha dovuto fare i conti con disponibilità di acqua inferiori rispetto al passato. “Su circa 60 ettari coltivati a pomodoro, siamo riusciti a irrigarne 13. Poi l’acqua è finita”, dice.
La struttura che fornisce a Varani l’acqua per i suoi campi, ovvero la diga di Mignano – una piccola chiusa costruita su un affluente del Po – a giugno è stata chiusa, mettendo in difficoltà molti agricoltori. È la prima volta che accade in ottant’anni. “Non avevo mai visto niente di simile in tutta la mia vita e nemmeno credevo fosse possibile”, aggiunge Varani. “Abbiamo vissuto momenti di crisi anche in passato, ma siamo sempre riusciti a cavarcela. Questa volta però è diverso, non so proprio come faremo ad andare avanti”, conclude.
Campane a morto
Per ragioni geografiche e climatiche, i periodi di secca sono ricorrenti nell’area. Negli ultimi vent’anni, episodi di siccità ci sono stati nel 2003, nel 2007 e nel 2012. Ma l’estate del 2017 sarà ricordata come una delle più calde e meno piovose della storia recente in Italia. Me lo conferma il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), secondo cui durante i mesi estivi sono state registrate temperature al di sopra della media rispetto al trentennio di riferimento 1970-2000.
I periodi di siccità sono diventati sempre più numerosi, così come le piogge torrenziali che colpiscono il nostro paese. “Il clima sta già cambiando e aumentano i fenomeni meteorologici estremi”, denuncia Legambiente. “Dal 2013 al 2016 ben 18 regioni sono state colpite da 102 eventi estremi che hanno provocato alluvioni o fenomeni franosi”, si legge nel rapporto Le città alla sfida del clima. Per quanto possano sembrare distanti, per quanto possa sembrare che si neghino a vicenda, questi eventi sono collegati all’irruzione sulla scena di un unico fattore, e cioè il cambiamento climatico. Tuttavia, ogni volta che si pronunciano queste due parole, si alzano i sopraccigli degli scettici. A molte persone sembra di muoversi in un terreno sconosciuto, lontano, quasi fantascientifico. Ma per vederne gli effetti, basta spostarsi da Fiorenzuola d’Arda a Volpedo, in provincia di Alessandria.
Nel cuore della val Curone, a circa 200 chilometri dalla sorgente del Po, alberi da frutto si inerpicano sulle colline che circondano il paese. Gianpiero Chiapparoli, responsabile della cooperativa Volpedo, mi spiega che qui questo tipo di coltivazioni si è diffuso tra le due guerre mondiali proprio grazie al fatto che fosse un territorio ricco d’acqua. Molte famiglie vivono ancora di questo, ma tante cose sono cambiate rispetto al passato e la situazione per alcuni è drammatica. Gran parte delle mele, delle ciliegie, delle albicocche e delle susine hanno subìto danni ingenti, così come il 70 per cento delle pesche di Volpedo, uno dei frutti più pregiati della zona. L’emergenza ha spinto l’amministrazione comunale ad annullare la festa tradizionale di fine luglio e a far suonare le campane a morto in segno di protesta. “Per quel che riguarda le pesche, parliamo di 800mila euro di fatturato in meno rispetto all’anno scorso”, dice Chiapparoli. “Nel complesso, il fatturato della cooperativa Volpedo passa da tre milioni di euro nel 2016 a 1,3 nel 2017”.
E la situazione non è migliore nella zona del delta del Po. Nell’area del Polesine i raccolti di mais e soia si sono dimezzati, impedendo anche la produzione di foraggio per il bestiame. Mentre nella provincia di Venezia il basso livello delle falde ha favorito l’infiltrazione dell’Adriatico lungo le foci dei fiumi in secca. Il fenomeno prende il nome di cuneo salino ed è uno dei problemi che fa più paura agli studiosi. “Nel delta del Po si verificava già negli anni cinquanta, ma la risalita non andava oltre tre chilometri dalla foce”, spiega Alessio Picarelli, dirigente dell’autorità di bacino del fiume Po. “Mentre oggi è stata rilevata a più di 20 chilometri dal mare. I motivi sono tanti, dall’abbassamento del canale di scorrimento del fiume per il continuo prelievo di sabbia e pietrisco agli stati di magra del Po, un fenomeno in netto aumento a causa del cambiamento climatico”, aggiunge Picarelli. Nelle campagne del litorale veneto il cuneo salino ha reso inutilizzabile l’acqua per irrigare e ha così causato danni ingenti agli agricoltori, facendo registrare quasi il 30 per cento di raccolto in meno rispetto al 2016.
L’influenza umana
Nel caso della pianura padana, l’analisi dell’agenzia regionale per la protezione ambientale dell’Emilia-Romagna (Arpae) conferma i dati delle Nazioni Unite e dell’Ispra: “Dal 1960 a oggi sul bacino del Po si osserva un aumento delle temperature medie annue di circa due gradi, che potrebbero arrivare a tre o quattro alla fine del secolo”. Al tempo stesso, rispetto a trent’anni fa le precipitazioni medie annue sono diminuite del 20 per cento. Secondo uno studio del Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici(Cmcc), il cambiamento climatico ha giocato un ruolo determinante nel ridurre le riserve idriche del bacino. La situazione è evidente grazie ai dati raccolti dalla stazione di Pontelagoscuro, in provincia di Ferrara.
“I numeri ci dicono che più ci si avvicina al presente, più le temperature aumentano e più le precipitazioni diminuiscono”, dice Paola Mercogliano, una delle autrici dello studio del Cmcc. “La combinazione tra questi due fattori influisce sulla disponibilità idrica in diversi modi. Il ciclo idrologico alterato provoca uno scioglimento anticipato dei nevai e le stagioni di coltivazione diventano più lunghe, facendo così crescere la domanda d’acqua e i prelievi: è un circolo vizioso”, spiega Mercogliano.
A Pontelagoscuro i rilevamenti sono effettuati in corrispondenza di un ponte ferroviario dei primi del novecento, una struttura che collega le due sponde del fiume lungo la linea Bologna-Ferrara. Nella banchina sono ormeggiate alcune chiatte per la ghiaia e un rimorchiatore. Lungo il bacino del Po c’è una rete navigabile di oltre 900 chilometri, che serve una manciata di porti commerciali e alcuni attracchi industriali privati. Ogni giorno gli operatori ricevono un’email dall’agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo) con gli aggiornamenti sui livelli del fiume. “Lo scorso marzo, qui il livello segnava -4,9 metri, lo stesso che di norma si registra ad agosto e due metri in meno rispetto allo stesso periodo del 2016”, mi dice Dario Barborini, che da più di vent’anni lavora come manovratore sulle chiatte. “Io qui ci sono nato e non ricordo nulla del genere”. Secondo lo studio del Cmcc, la situazione è destinata ad aggravarsi. “Abbiamo simulato lo scenario nel periodo tra il 2021 e il 2050. Nella valle del Po le temperature continueranno ad aumentare e le piogge saranno sempre meno, la portata del fiume si ridurrà in estate e gli eventi di magra saranno più frequenti e severi”, dice Mercogliano.
Verso nord
Il cambiamento riguarderà anche i cicli stagionali, che saranno meno definiti di un tempo. “Le coltivazioni potranno essere esposte a rischi che prima non correvano, come quello di gelate tardive”, conclude Cacciamani. Gli esperti temono inoltre che non sarà possibile garantire le stesse quantità d’acqua usate oggi per irrigare i campi. Ogni anno vengono estratti dal bacino del Po circa 20,5 miliardi di metri cubi d’acqua. Gran parte – 16,5 miliardi di metri cubi – è destinata al settore agricolo. “Il cambiamento climatico ridurrà la disponibilità di acque superficiali, la ricarica delle falde sarà inferiore rispetto a oggi e i livelli si abbasseranno, causando una riduzione delle risorse idriche”, dice Alessio Picarelli dell’autorità di bacino del fiume Po.
Adattamento e pianificazione
Le strade per affrontare la situazione sono due: quella della mitigazione e quella dell’adattamento. La prima riguarda l’adozione di politiche per ridurre le emissioni di gas serra ed è fondamentale nel caso della pianura padana, visto che nella valle del Po si respira l’aria peggiore di tutta l’Europa occidentale, dice l’Organizzazione mondiale della sanità. “Intanto, si potrebbe applicare una rotazione delle colture, così da aumentare o almeno mantenere la fertilità dei terreni”, dice Silvano Pecora, responsabile del servizio idrologia dell’Arpa dell´Emilia-Romagna e vicepresidente dell’Organizzazione mondiale per la meteorologia. Per quanto riguarda l’adattamento alle mutazioni del clima, Pecora è convinto che “bisognerà produrre alimenti in modo più efficiente, adottare nuovi combustibili biologici, usare tecniche di irrigazione che consentano un maggiore risparmio idrico, scegliere materiale genetico più adatto alle nuove condizioni climatiche e colture che abbiano bisogno di meno acqua”.
I costi per tradurre tutto questo in realtà sono trascurabili rispetto a quelli da sostenere se non si fa niente, ma gli ostacoli per farlo sono molti. Il primo è di ordine burocratico. Il Po è stretto tra un’intricata rete di norme e un numero indefinito di consorzi, agenzie, autorità e commissioni. Un sistema così complesso che “diventa quasi impossibile applicare certe misure di adattamento”, dice Pecora.
Un problema di comunicazione
Il romanziere Guido Conti ha scritto che il fiume che “passa per Torino e accarezza il parco del Valentino è diverso da quello dell’Oltrepò pavese e da quello che comincia a Piacenza, e non è lo stesso che solca la pianura fino a Mantova; da Ferrara al delta, il fiume cambia di nuovo aprendosi come un fiore di canali verso il mare”. Ha ragione a dire che il Po ha mille facce, mille colori, mille forme. Purtroppo, ad accomunarle oggi è l’ombra del cambiamento climatico sulle sue acque, la minaccia che venga recisa una delle arterie principali di questo paese.
Da sapere
Ma, naturalmente, nel momento in cui veniva ritenuto opportuno sollevare tali questioni, i riflettori dei media erano da tempo passati ad altro. Oggi, mentre Alberta spinge per almeno tre nuovi oleodotti per aumentare notevolmente la produzione di sabbie bituminose, non si è imparato nulla da quella storia. C’è una lezione invece per Houston. La finestra per avere una discussione importante è piccola. Non possiamo permetterci di gettarla al vento. Parlare onestamente di ciò che sta alimentando questa epoca di disastri non è una mancanza di rispetto per le vittime. Anzi, è l’unico modo per onorare veramente le loro perdite, e la nostra ultima speranza per impedire un futuro pieno di innumerevoli altri morti.
Riprendiamo da Internazionale (8 settembre 2017) articoli di J. Watts, J. Adhikari, G. Ansaldi e G Milani sugli ultimi disastri ambientali. Siano conseguenze del cambiamento climatico o dell'espansione scellerata di attività umane che rendono fragili i territori, è chiaro che questo sviluppo ci mette sempre più in pericolo. (i.b.)
I 64 miliardi di metri cubi di pioggia (più o meno l’equivalente di 26 milioni di piscine olimpioniche) rovesciati sul Texas dall’uragano Harvey alla fine di agosto hanno stabilito un nuovo record per un ciclone tropicale negli Stati Uniti. Ma è un record che difficilmente durerà a lungo, visto che le emissioni di anidride carbonica provocate dagli esseri umani stanno spingendo il clima in un territorio sconosciuto.
Le immagini delle strade allagate in Texas fanno pensare a quelle delle comunità colpite dalle inondazioni in India e in Bangladesh, alle recenti valanghe di fango in Sierra Leone e all’esondazione di un affluente del fiume Yangtze, in Cina, che ha provocato decine di morti ad agosto. In parte si tratta di calamità stagionali, e le loro conseguenze dipendono anche da fattori locali. Ma gli scienziati sostengono che gli eventi estremi di questo tipo diventeranno sempre più frequenti e devastanti a causa dell’aumento delle temperature globali e dell’intensità delle precipitazioni.
Il nostro pianeta sta vivendo un’era di record spiacevoli. Ogni anno, dal 2015 a oggi, le temperature hanno toccato picchi mai visti dalla nascita della meteorologia, e probabilmente da 110mila anni. La quantità di anidride carbonica nell’aria è ai livelli più alti degli ultimi quattro milioni di anni. Non è questo a provocare eventi come l’uragano Harvey: in questo periodo dell’anno nel golfo del Messico ci sono sempre tempeste e uragani. Ma l’aumento delle temperature rende questi eventi più piovosi e potenti.
Più l’acqua degli oceani si riscalda, più evapora facilmente e fornisce energia alle tempeste. E, scaldandosi, l’aria sui mari trattiene una quantità maggiore di vapore acqueo. Ogni mezzo grado in più fa aumentare di circa il 3 per cento l’umidità dell’atmosfera. Questo vuol dire che i cieli si riempiono prima di acqua e ne hanno una quantità maggiore da scaricare. Oggi nel golfo del Messico si registrano temperature di superficie superiori di un grado rispetto a trent’anni fa.
A contribuire all’aumento delle tempeste c’è anche il fatto che, negli ultimi cento anni, il livello dei mari si è alzato di venti centimetri a causa del riscaldamento globale provocato dall’uomo. I ghiacciai si sono sciolti e le acque marine hanno subìto un’espansione termica. Quando le piogge in Texas si sono avvicinate al record statunitense di 120 centimetri di precipitazioni registrato nel 1978, i meteorologi hanno dovuto introdurre un nuovo colore nei graici. Potrebbe non essere l’ultima revisione.
“Probabilmente i paesi grandi come gli Stati Uniti raggiungeranno altri record di precipitazioni, e non solo a causa degli uragani”, ha affermato Friederike Otto, vicedirettrice dell’Environment change institute dell’università di Oxford. Si tratta di una tendenza globale. “Nell’immediato futuro in tutto il pianeta toccheremo nuovi picchi di caldo e precipitazioni estreme”. La situazione potrebbe cambiare da un paese all’altro, avverte Otto. I fattori in gioco sono molti, ma le conseguenze dell’attività umana sul clima hanno contribuito a scatenare tempeste più violente e siccità più gravi.
Nelle ultime settimane in India e in Bangladesh l’aumento del livello dei mari si è aggiunto a un monsone particolarmente forte, che ha inondato alcune regioni uccidendo circa 1.200 persone e costringendone milioni a lasciare le loro case.
Ora è importante capire se il cambiamento climatico ha a che fare con la “sedentarietà” delle tempeste. Negli Stati Uniti gli uragani di solito si spostano verso l’interno e la loro potenza diminuisce man mano che si allontanano dal mare. Ma Harvey è rimasto nella stessa area per giorni, e questo spiega il record di precipitazioni in Texas. Secondo gli scienziati potrebbe essere la questione più grande sollevata da Harvey. “Non credo che qualcuno si sia mai posto il problema. E non credo che qualcuno avesse previsto un evento di questo tipo”, ha detto Tim Palmer, ricercatore della royal society all’università di Oxford.
Di recente i ricercatori hanno individuato un rallentamento nella circolazione atmosferica estiva alle medie latitudini, conseguenza del forte riscaldamento dell’Artico. Secondo Palmer, tuttavia, per studiare gli schemi della pressione servono strumenti analitici più potenti, tra cui i supercomputer. Ma negli Stati Uniti la ricerca è condizionata dalla politica: il presidente Donald Trump sostiene che il cambiamento climatico è una truffa inventata dalla Cina, e ha annunciato che Washington si ritirerà dal trattato di Parigi sul clima e taglierà i fondi per la ricerca sul clima. “Cercare di capire quanto saranno frequenti eventi come Harvey in futuro non dovrebbe essere oggetto di discussioni politiche”, conclude Palmer.
Internazionale
SVILUPPO INSOSTENIBILE
Giovanni Ansaldi
Mentre a Houston le acque portate dall’uragano Harvey si ritirano, una cosa è chiara: una parte dei danni – umani ed economici – poteva essere evitata”, scrive il New York Times. Uno dei problemi principali è lo sviluppo urbanistico. Negli ultimi trent’anni il boom dell’industria petrolifera ha causato una forte crescita immobiliare: a Houston sono nati nuovi quartieri residenziali e di uffici in zone a forte rischio di inondazioni. In tutta la città sono stati costruiti parcheggi, strade ed edifici che hanno cancellato la vegetazione fondamentale per facilitare il drenaggio. A questo si aggiunge il fatto che le mappe della federal emergency management agency (Fema, l’agenzia statunitense che si occupa di gestire e prevenire le emergenze), create per evidenziare le zone a rischio in caso di catastrofe, non sono mai state aggiornate. Confrontando le mappe con le foto scattate dopo il passaggio dell’uragano, si vede che alla fine di agosto sono state inondate zone che secondo la Fema avevano lo 0,2 per cento di possibilità di essere invase dall’acqua. Le mappe non sono aggiornate perché il congresso non assegna abbastanza fondi all’agenzia. Inoltre non tengono conto degli effetti futuri dei cambiamenti climatici. “Ancora più preoccupante è il fatto che il Texas non sembra preparato ad affrontare la ricostruzione”, osserva il New York Times. “La maggioranza dei residenti della regione colpita non era assicurata”.
Secondo The Atlantic, quello che è successo a Houston è un segnale d’allarme per tutto il paese e mette in discussione una certa idea di sviluppo: “Quando si parla di gestione degli uragani, l’aspetto più difficile da affrontare è la convinzione degli statunitensi di poter vivere e lavorare dove preferiscono. Nel paese ci sono zone – come alcuni quartieri di Houston e di New Orleans o intere regioni della florida – che non dovrebbero essere abitate”. E che in futuro saranno sempre più a rischio a causa dell’innalzamento del livello dei mari e dei disastri naturali causati dai cambiamenti climatici.
Nelle ultime settimane il Nepal è stato colpito da forti inondazioni che hanno alimentato le tensioni regionali. I politici e i mezzi d’informazione locali sostengono che le infrastrutture indiane lungo il confine hanno reso il Nepal più vulnerabile.
Durante un incontro in India alla fine di agosto, il primo ministro nepalese Sher Bahadur Deuba e l’indiano Narendra Modi hanno rilasciato un comunicato in cui promettono che lavoreranno insieme per evitare nuove alluvioni. Ma i rapporti tra i due paesi restano tesi.
La tensione è dovuta in parte alla geografia dell’Himalaya: una diga o una strada costruita nel paese può provocare un’inondazione in un paese confinante. Così India, Cina e Nepal si accusano a vicenda di politiche egoiste e poco lungimiranti. La mancanza di un’organizzazione regionale che raccolga le informazioni e coordini le operazioni di soccorso ha sicuramente aumentato le sofferenze della popolazione.
Miniere illegali
Nella regione dell’Himalaya le inondazioni sono eventi quasi annuali. Grandi fiumi che nascono nella catena montuosa attraversano le popolose pianure del Terai, che si estendono sia in India sia in Nepal, e durante la stagione dei monsoni il livello dell’acqua cresce notevolmente.
Ma le inondazioni di quest’anno sono state particolarmente devastanti. Negli ultimi due mesi in Nepal, India e Bangladesh hanno colpito venti milioni di persone e ne hanno uccise almeno 1.200.
Questi eventi sono un problema politico ma anche logistico. Nel caso delle ultime inondazioni, il ministro dell’interno nepalese ha puntato il dito contro due grandi dighe costruite dall’India lungo i fiumi Koshi e Gandaki, e anche contro le strade, gli argini e i canali costruiti lungo i 1.751 chilometri del confine tra India e Nepal, sottolineando che queste infrastrutture hanno ostacolato il corso naturale dell’acqua.
L’India accusa a sua volta il Nepal, e molti sono convinti (anche se negli ambienti scientifici la tesi è discussa) che la deforestazione in corso in Nepal contribuisca alle piene in India. Il problema è che la costruzione di infrastrutture di un paese può avere conseguenze importanti per i paesi vicini, soprattutto nella stagione dei monsoni. Almeno una decina di persone sono rimaste ferite l’anno scorso negli scontri durante le proteste contro la costruzione di una diga in India che, secondo il Kathmandu Post, causerà l’inondazione di alcune aree del Nepal una volta completata.
I problemi non sono causati solo dalle dighe. Gli esperti di disastri e gli idrologi nepalesi sostengono che le recenti inondazioni sono state aggravate dall’intensa attività mineraria illegale sulle colline Churia per estrarre sassi e sabbia da usare nell’edilizia indiana, in rapida espansione.
E le dispute non riguardano solo India e Nepal. Nel 2006 India e Cina hanno firmato un accordo per la condivisione di informazioni idrologiche sui grandi fiumi che scorrono in entrambi i paesi, per rispondere meglio alle piene annuali. Ma all’inizio dell’anno il ministro degli esteri indiano ha accusato la Cina di non aver condiviso dati essenziali, e di aver così peggiorato gli effetti delle inondazioni nell’India nordorientale.
Non è un incidente isolato. Nel 2013 una grande inondazione in quella zona dell’India ha ucciso circa seimila persone. All’epoca le autorità indiane hanno sostenuto di non aver ricevuto informazioni dal Nepal sulle forti piogge in collina o sulle condizioni dei ghiacciai. Le autorità nepalesi hanno risposto che la Cina era in una posizione migliore per condividere le informazioni sulle condizioni climatiche in quell’area dell’Himalaya. Alcuni studi condotti in seguito hanno stabilito che un’efficiente condivisione delle informazioni e un’allerta tempestiva avrebbero potuto ridurre sensibilmente i danni.
Il problema è particolarmente urgente in un momento in cui la regione dell’Himalaya è colpita dagli effetti del cambiamento climatico. I climatologi hanno sottolineato che qui le “inondazioni estreme” sono aumentate, a causa di piogge meno frequenti ma più intense.
Bisogna cambiare il modo in cui le istituzioni gestiscono questi disastri. Alla fine di agosto India e Napal hanno annunciato che creeranno una commissione congiunta per la gestione delle inondazioni e delle alluvioni, e una squadra di esperti per “migliorare la cooperazione bilaterale” nella gestione dell’acqua. È un segnale positivo.
Ma nella regione dell’Himalaya c’è urgente bisogno di istituzioni con competenze regionali invece che nazionali. Queste organizzazioni potrebbero condividere le informazioni sul clima, agire per ridurre i danni causati dalle inondazioni e consultarsi durante la costruzione di infrastrutture che potrebbero avere conseguenze per gli stati vicini.
Le attività umane e la miopia della politica hanno aumentato gli effetti negativi delle inondazioni. È ora che tutti i paesi della regione accettino di condividere le responsabilità e s’impegnino per aiutare le persone colpite, a prescindere dalla nazionalità.
Internazionale
CLIMA, STORIA E CULTURA
di Giuliano Milani
Wolfgang Behringer, "Storia culturale del clima", Bollati Boringhieri, 349 pagine, 14 euro
Mentre negli ultimi anni si sono aperte feroci polemiche sul riscaldamento globale, la storia del clima ha assunto una nuova importanza. Capire se in passato ci sono stati periodi in cui la temperatura è cambiata, quantiFicare il cambiamento e comprenderne le ragioni è diventato importante per affrontare le side che ci pone il presente. Non sempre è facile accedere alle ricerche che permettono di capire come si è evoluto il clima del nostro pianeta. Ecco perché è utile questo libro che, dopo aver spiegato come il clima cambia, ricostruisce questa vicenda dall’inizio della Terra a oggi, con sempre maggiore dettaglio avvicinandosi al nostro tempo. Si segue il riscaldamento dell’olocene, cominciato
12mila anni fa e i vari, occasionali raffreddamenti che in quel periodo si alternarono ai momenti più caldi (nell’età romana e nel basso medioevo).
Per la “piccola età glaciale”, cominciata nel trecento e terminata nel corso del novecento, il maggior numero di fonti e dati consente a Behringer alcune ipotesi sulla relazione tra clima e fenomeni sociali
e politici come la stregoneria, la democratizzazione, l’illuminismo. La cautela con cui questi collegamenti sono fatti e la quantità d’informazioni fornite al lettore rendono questo libro un’efficace chiave di lettura per orientarsi in un campo di studi nuovo, complesso e già al centro di molte
discussioni.
Oggi le previsioni meteo funzionano e l’allerta è stata data con successo con alcuni giorni di anticipo. Ma le piogge hanno superato le attese, con valori fino a circa 1300 millimetri caduti in pochi giorni su vasti bacini pianeggianti, e gli allagamenti sono stati molto più estesi del previsto. Gli abitanti si sono così trovati isolati, senza luce, acqua potabile e cibo, e con il pian terreno invaso da fango inquinato. Le vittime sono state poche decine grazie alla relativa calma della piena, a differenza di quanto avvenuto nel 2005 a New Orleans, dove l’uragano Katrina aveva divelto le dighe costiere e l’invasione delle acque in città era stata repentina e irruenta, con oltre 1800 vittime.
In Italia abbiamo sia la piena fluviale lenta e prevedibile, come quella del Po, sia le piene-lampo (flash-flood) dei territori montuosi, dove in pochi minuti insieme all’acqua precipitano anche detriti rocciosi e alberi, come frequentemente avviene a Genova. Anche le zone percorse dagli incendi di quest’estate, specie se vicine a centri abitati, dovranno essere tenute sotto controllo in quanto potrebbero essere soggette a rapida erosione durante forti precipitazioni.
Ma veniamo alle istruzioni per ridurre il rischio: all’emissione di un bollettino meteo di allerta (intensità crescente da gialla-arancione-rossa), prima di tutto bisogna chiedersi: dove sarò io in quel momento? Se in casa, conviene già alcuni giorni prima farsi uno scenario mentale: ho cose preziose al pian terreno facilmente allagabili? Le porto a un piano superiore. Dove è parcheggiata l’auto? La sposto in luogo sicuro (molte vittime sono annegate in garage sotterranei nel tentativo di salvare la loro tonnellata di ferraglia invece della vita, come in Costa Azzurra a inizio ottobre 2015). Ho riserve di cibo in caso rimanga isolato per alcuni giorni? Faccio una piccola riserva di scatolame non deperibile, pensando pure a un’avaria del frigo per mancanza di elettricità. Ho messo da parte qualche tanica di acqua potabile? E se la mia casa è esposta a frane, ho considerato l’opzione di andarmene da parenti o amici in zona più sicura? Se ho in programma di essere in auto, posso annullare il viaggio e starmene a casa per sorvegliare che non ci siano grane?
Se devo per forza muovermi, so che non devo mai entrare in un sottopassaggio che si sta allagando? L’auto galleggia in mezzo metro d’acqua e resterei imprigionato sul fondo senza poter risalire, con elevato rischio di annegamento, come dimostrano decine di banali incidenti simili. Se passo su un ponte su un fiume in piena, non mi fermo a guardare: potrebbe crollare o essere sormontato dalle acque. Se è già stato transennato dalle autorità, non forzo il blocco, perché è meglio attendere mezza giornata che morire tra i flutti: accadde durante l’alluvione del Tanaro nel novembre 1994.
Anche nel cuore dell’Asia c’è il rischio di una guerra per il controllo dell’acqua. Alla base del conflitto: usi contrastanti (acqua per energia e irrigazione), un bene non disponibile omogeneamente e uno sfruttamento legato a interessi particolari. Internazionale, 25 Agosto 2017. (i.b)
Il 17 maggio del 2017 il ministro degli esteri del Tagikistan, Sirodjidin Aslov, è volato a Bruxelles per promuovere, di fronte a un gruppo di funzionari dell’Unione Europea, il progetto per la costruzione della centrale idroelettrica di Rogun, sul fiume Vachš. Ma per quale motivo l’Unione europea dovrebbe essere interessata a una centrale elettrica sulle remote montagne dell’Asia centrale? E perché mai un rappresentante del governo di Dušanbe si è recato fino in Belgio per ottenere il via libera alla realizzazione di un’infrastruttura nel suo paese?
Il punto è che questa banale iniziativa è in realtà la testimonianza del fatto che nel cuore dell’Asia i rischi di una guerra sono concreti. Non si può escludere, infatti, che le ex repubbliche sovietiche della regione possano entrare in conflitto per il controllo di una risorsa molto preziosa: l’acqua.
Irrigazione ed energia
Ormai da qualche tempo sia i mezzi d’informazione occidentali sia quelli dei paesi ex sovietici si occupano regolarmente del rischio, tutt’altro che remoto, di una guerra per l’acqua in Asia centrale. Non sono previsioni infondate, considerato che questa risorsa è distribuita tra i paesi della regione in modo estremamente disomogeneo.
L’alto corso dei fiumi che nascono nel territorio del Kirghizistan e del Tagikistan garantisce enormi riserve d’acqua. Ma più a valle, in Uzbekistan, Turkmenistan e Kazakistan, l’acqua non basta: il 77 per cento delle risorse idriche consumate dagli uzbechi arriva dall’estero, in Turkmenistan la percentuale supera il 90 per cento e in Kazakistan è il 40 per cento.
Le tensioni legate al controllo dell’acqua, che non hanno ancora raggiunto la fase più critica, sono cominciate subito dopo l’indipendenza delle cinque repubbliche sovietiche, nel 1991. Alla radice dei contrasti c’è il fatto che i fiumi possono essere sfruttati sia per l’irrigazione sia per produrre energia elettrica, e se l’acqua destinata a irrigare i campi è necessaria d’estate, i consumi di elettricità aumentano invece d’inverno, cosa che costringe le aziende energetiche a impiegare nella stagione fredda le risorse di cui avrebbero invece bisogno gli agricoltori con l’arrivo del caldo. In epoca sovietica la gestione centralizzata del settore idrico-energetico consentiva di agire nell’interesse di tutte le parti coinvolte, ma oggi i nuovi stati indipendenti nati dalla disgregazione dell’Unione Sovietica non riescono ad amministrare insieme le risorse.
Negli anni novanta il Kirghizistan e il Tagikistan approvarono progetti per la costruzione di grandi centrali idroelettriche sui fiumi che proseguono il loro corso in Uzbekistan. In Kirghizistan fu pianificata la realizzazione della centrale di Kambara tin 2, sul fiume Naryn; in Tagikistan fu invece varato il progetto della già citata centrale di Rogun, sul fiume Vachš. L’Uzbekistan considerò quei progetti come una minaccia alla sicurezza nazionale: le nuove dighe avrebbero infatti interrotto i lussi, lasciando i contadini uzbechi senz’acqua per l’irrigazione. Inoltre, cosa di cui rara mente si parla in modo esplicito, le dighe avrebbero costituto una gravissima minaccia per i centri abitati lungo il corso inferiore dei due fiumi: nel caso di un cedimento tecnico o di un attentato terroristico la violenza dell’acqua avrebbe distrutto tutto. Negli anni novanta il Tagikistan visse una guerra civile che oppose il governo agli estremisti islamici (ancora non del tutto sconfitti), mentre il Kirghizistan era un paese molto instabile, anche per gli standard postsovietici.
In questo contesto, per l’Uzbekistan i grandi progetti di Dušanbe e Biškek rappresentavano un rischio enorme. Da allora le cose non sono molto cambiate: Tagikistan e Kirghizistan sono paesi tuttora imprevedibili e potrebbero entrare in possesso di uno strumento per ricattare gli stati a valle. Per questo nel 2015 il presidente uzbeco di allora, Islam Karimov, dichiarò senza mezzi termini che i problemi idrici nella regione sarebbero potuti “peggiorare fino al punto di generare non solo gravi tensioni, ma perfino una guerra”. E aggiunse che la realizzazione della centrale di Kambaratin avrebbe dato un duro colpo alla produzione agricola dell’Uzbekistan, una delle principali voci d’esportazione del paese.
Nel marzo del 2016 il governo kirghiso ha constatato con preoccupazione che il tentativo di riprendere il controllo degli impianti lungo il confine aveva avuto come conseguenza un’intensificazione delle attività militari dell’Uzbekistan alla frontiera. Poco dopo i rapporti si sono ulteriormente inaspriti a causa della disputa sul controllo del bacino idrico di Kosonsoy, al confine tra i due paesi. Ad agosto sia il governo di Biškek sia quello di Taškent hanno inviato militari e poliziotti in questa striscia di terra la cui sovranità è ancora indefinita.
Nell’ottobre del 2016 il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, si è messo alla guida di un bulldozer per gettare il primo carico di terra nelle acque del iume Vachš e inaugurare così la costruzione della centrale idroelettrica di Rogun. Secondo i suoi avversari, Rahmon si è potuto permettere un simile gesto simbolico solo dopo la morte, nel 2016, di Karimov, il presidente uzbeco considerato di fatto il patriarca dell’intero spazio postsovietico, che era sempre stato inflessibile nella difesa degli interessi di Taškent. Già nel 2009, infatti, Rahmon aveva costretto i cittadini tagichi ad acquistare azioni della centrale. Per Dušanbe il progetto è da tempo un chiodo fisso.
Nel frattempo il nuovo presidente uzbeco, Shavkat Mirziyoyev, ha dimostrato di non avere nessuna intenzione di cambiare la linea seguita di Karimov. Durante una visita ad Astana, a marzo, ha ribadito, insieme al presidente kazaco Nursultan Nazarbaev, che le risorse idriche sono un patrimonio comune di tutti i paesi della regione. La questione è di grande importanza anche per il Kazakistan, considerato che l’acqua consumata nel paese arriva non solo dall’Uzbekistan e dal Kirghizistan, ma anche dalla Cina. Le sorgenti dei fiumi Ili, Irtyš e Tekes, che riforniscono d’acqua alcune regioni del Kazakistan, si trovano infatti nel nordest della Cina, proprio l’area in cui Pechino negli ultimi tempi sta concentrando i suoi progetti di sviluppo. L’economia della regione autonoma dello Xinjiang, abitata dalla minoranza musulmana degli uiguri, ha grande bisogno d’acqua, che però nella zona scarseggia. L’Irtyš e l’Ili risentono già delle conseguenze dello sviluppo frenetico della regione, e la loro portata sta diminuendo. Il problema di questi fiumi è aggravato anche dal rapido scioglimento dei ghiacciai, legato al riscaldamento globale.
Secondo il sinologo russo Konstantin Syroežkin, il Kazakistan è in una posizione di debolezza nei negoziati con Pechino sulle risorse idriche. “Ha giocato tutti gli assi nella manica che aveva”, spiega. “Non gli rimane che fare aidamento sulla disponibilità dei cinesi”. Considerato che la Cina ha investito nell’economia kazaca tra i 24 e i 27 miliardi dollari, stando ai dati del 2016, per Astana non è facile aprire una disputa con Pechino. La Cina, tuttavia, ha importanti investimenti anche negli altri paesi della regione. Dopo la visita di Mirziyoyev, Cina e Uzbekistan hanno concluso un accordo del valore di 22 miliardi di dollari.
Durante il viaggio a Pechino, il presidente uzbeco ha partecipato anche al forum della nuova via della seta, cioè la strategia di Pechino per sviluppare nuovi collegamenti con i paesi dell’Eurasia e trovare un’alternativa alle rotte marittime tradizionali, che sarebbero vulnerabili in caso di un conflitto.
Ma la presenza della Cina nella regione può davvero contenere il rischio di una guerra per l’acqua? A giudicare dal tono degli esperti interrogati dai giornali occidentali, la risposta è no.
Riserve di stabilità
Come ha scritto alla fine del 2016 l’agenzia d’intelligence privata Stratfor, “l’Asia centrale sta consentendo alla Cina di sviluppare una rotta verso l’Europa più distante dai mari in cui sono presenti gli Stati Uniti. Se quindi la stabilità dell’Asia centrale dovesse crollare, per Pechino sarebbe un incubo. E le regioni confinanti diventerebbero un bacino di fuga per le organizzazioni separatiste armate”.
Alcuni anni fa gli esperti della Stratfor avevano anche previsto che nella regione centrosiatica le tensioni legate alla gestione dell’acqua non sarebbero finite presto. A gennaio del 2017, inoltre, un esperto della Harvard International Review, la rivista dell’università di Harvard, ha ammesso di essere “scettico sulla possibilità di risolvere i problemi dell’acqua nella regione, problemi che stanno assumendo dimensioni preoccupanti”. Secondo le sue previsioni, in futuro le dinamiche politiche della regione saranno dominate dal principio del “tanto peggio, tanto meglio”.
A marzo The Diplomat, una rivista online che ha la redazione a Tokyo, è arrivata a chiedersi in un articolo se le guerre per l’acqua possano mandare a monte i piani della Cina in Asia centrale. La risposta dell’autore è stata chiarissima: “Pechino deve prendere atto che sono ormai mature le condizioni per lo scoppio di conflitti e per una destabilizzazione della regione”. Oggi né i paesi dell’Asia centrale né le vicine Cina e Russia vogliono un conflitto nella regione. Tuttavia, come ha ricordato qualcuno parlando della vigilia della prima guerra mondiale, anche allora “nessuno voleva la guerra. Ma la guerra era inevitabile”.
Non si può escludere che alla fine le previsioni più catastrofistiche si riveleranno sbagliate. Una cosa è certa, però: nella regione le riserve di stabilità si stanno esaurendo.
«Equazione Secondo gli scienziati le temperature saliranno costantemente provocando sempre più profughi ambientali». il Fatto Quotidiano, 9 agosto 2017 (p.d.)
IL FALLIMENTO
DELL'ACQUA PRIVATIZZATA
di Marco Bersani
Dentro l’Italia che brucia, dentro l’agricoltura sfiancata dalla siccità, nel disastro ambientale del lago di Bracciano e del possibile razionamento dell’acqua a Roma Capitale, spiace dover dire ancora una volta «i movimenti l’avevano detto». Ma, per quanto frustrante, è la pura verità. Le dichiarazioni dei politici ai telegiornali, le dissertazioni degli opinionisti nei talk show, le roboanti tabelle degli amministratori delegati delle società privatizzate di gestione dell’acqua si inseguono tra loro, compiendo una consapevole rimozione su un nodo di fondo: l’acqua, bene comune naturale, essenziale alla sopravvivenza delle persone, non può essere gestito, se non tenendo conto dell’interesse generale e della conservazione del bene per le generazioni future.
Siamo da tempo immersi nella drammaticità di cambiamenti climatici in corso, le cui conseguenze peseranno per decenni a venire, eppure periodicamente ci si stupisce del fatto che le stagioni non siano più quelle di una volta e il binomio siccità/alluvioni non sia più un evento straordinario, bensì una nuova normalità con cui dover fare i conti e che solo con adeguata prevenzione può essere affrontata. Con buona pace degli sviluppisti, l’acqua è una risorsa limitata e la natura ha tempi di rigenerazione che non possono essere accelerati: per questo, quando i nodi vengono al pettine, non è possibile affidarne la soluzione al libero conflitto degli interessi particolari e meno che mai agli interessi privatistici di chi dell’acqua ha fatto il nuovo business su cui riprendere l’accumulazione finanziaria. Il fatto è che il modello liberista ha modificato i concetti di spazio e tempo: allargando esponenzialmente il primo, fino a voler fare del pianeta un unico grande mercato, e riducendo esponenzialmente il secondo, fino a farlo coincidere con gli indici di Borsa del giorno successivo.
Occorre aver chiaro come su queste basi nessuna soluzione sia possibile. L’acqua non può essere gestita dal mercato e il mercato dev’essere escluso dall’acqua: questo hanno detto oltre 27 milioni di cittadini nel referendum del giugno 2011 e la mancata attuazione di quella decisione sovrana pesa come un macigno tanto sui drammatici accadimenti di questi giorni, quanto sulla crisi della democrazia, oggi segnata da una crescente disaffezione popolare. In venti anni di privatizzazioni della gestione dell’acqua, gli investimenti sono crollati a un terzo di quelli fatti dalle precedenti società municipalizzate, la qualità del lavoro e dei servizi offerti é nettamente peggiorata e le tariffe sono aumentate senza soluzione di continuità. In compenso, sono saliti esponenzialmente i dividendi degli azionisti, cui tutti gli utili vengono destinati, anziché essere reinvestiti nel miglioramento di infrastrutture a dir poco obsolete.
E’ possibile invertire la rotta? Certo che sì, a patto che tornino al centro l’interesse generale e il diritto al futuro per tutte e tutti. Un intervento pubblico sul dissesto idrogeologico dei nostri territori e un piano per il riammodernamento delle reti idriche costerebbero complessivamente 15 miliardi e produrrebbero 200.000 posti di lavoro pulito e socialmente utile. «Non ci sono i soldi», ripete il mantra liberista, ma intanto sono 17 i miliardi messi a disposizione per regalare Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca al colosso IntesaSampaolo, che produrrà 4000 esuberi. Da qualsiasi punto la si voglia affrontare, è un problema di volontà politica: possiamo continuare a tollerare che siano i vincoli finanziari dell’Unione Europea e la trappola del debito a determinare le scelte politiche collettive o vogliamo mettere finalmente il diritto alla vita, alla dignità e al futuro al primo posto?
il Fatto Quotidiano
OGGI C’È LA SICCITÀ,
DOMANI LE ALLUVIONI
di Luca Mercalli
Siamo un Paese ostile alla prevenzione. Solo quando l’emergenza ci mette con le spalle al muro affrontiamo la realtà, spesso pure con solidarietà e fantasia, ma appena passato il dolore acuto torniamo in uno stato di indifferente apatia di indolente fatalismo fino alla crisi successiva. E che con l’acqua di crisi ci sia da attendersene continuamente lo si sa almeno dall’epoca degli antichi egizi: siccità e alluvioni costellano le cronache di ogni civiltà. Solo che per millenni si è preso ciò che il cielo dispensava, subendolo e attribuendolo a castigo divino, mentre da un paio di secoli la scienza ha compreso le dinamiche idrologiche e con l’aiuto di meteorologia, climatologia, geomorfologia e idraulica oggi dispone di una capacità previsionale utile a prepararsi al futuro. Ammesso che questo sapere venga utilizzato e non messo in un cassetto, limitandosi a predare i beni comuni con improvvisazione, pigrizia, sovrasfruttamento. Ed è così che in Italia vuoi quando si contano i morti nel fango delle inondazioni, vuoi quando si cercano affannose soluzioni alla penuria d’acqua, il copione è sempre lo stesso: un po’ di cronaca vera “ha avuto paura?”, “rinuncerà all’idromassaggio?”, “mai successo a memoria d’uomo!”, seguita da banali polemiche, ricerca del responsabile diretto da additare alla magistratura (nel tentativo di trovare cause semplici a problemi complessi), e qualche analisi più vasta del problema. Tre giorni, poi tutto finisce e si torna al solito chiacchiericcio politico di fondo che spesso poco ha a che fare con le questioni davvero strategiche per il nostro futuro.
E invece è proprio sulle analisi più ampie dei problemi che tocca soffermarsi, approfondire, pianificare, legiferare, agire. Quando parliamo di acqua, risolta l’emergenza dei soccorsi, tutto si basa su un’accurata preparazione in tempo di pace: formazione della cittadinanza, che ignora completamente tanto i manuali di protezione civile quanto le basi del ciclo dell’acqua, più importante delle oscillazioni del Pil, e lavoro capillare sulle infrastrutture idriche. Sappiamo bene che gli acquedotti d’Italia fanno acqua da tutti i tubi: 38 per cento sono le perdite medie nazionali secondo Istat, ma a Milano sono il 16 per cento, a Roma il 43, a Bari il 50, a Potenza il 64 per cento. E copiare da chi fa meglio, no eh? Ci sono società di servizi idrici come quella di Torino che da anni si preoccupano dei cambiamenti climatici e investono in infrastrutture idrauliche di accumulo,ben sapendo che dovranno servirsene nei prossimi anni, via via che la temperatura e le siccità aumenteranno. Sono tutte cose scritte anche nella Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del Ministero dell’Ambiente, abbiamo i dati, abbiamo le competenze, abbiamo anche esempi di eccellenza già funzionanti, dobbiamo solo applicarli in un quadro coerente e univoco su tutto il territorio nazionale. Invece ciò non avviene, anche perché molti servizi tecnici nazionali di antica data, che avevano doveri e capacità per armonizzare la gestione dell’acqua sono stati sistematicamente smantellati, riaperti sotto altro nome, richiusi, frammentati, a colpi di leggi e decreti sempre più ravvicinati che hanno generato una giungla burocratica, una polverizzazione di responsabilità e spesso una valanga di deresponsabilizzazione, nonché un’oggettiva difficoltà a mettere insieme monitoraggio e previsione meteoidrologica, pianificazione degli usi a scala di bacino, protezione civile, urbanistica e uso del suolo. Un terreno però fertilissimo per l’appalto e il subappalto esterno, che non viene più seguito direttamente dal tecnico governativo con una visione a lungo termine, ma delegato a un esecutore che non ha certo a cuore il futuro dell’umanità, bensì la massimizzazione del suo profitto immediato.
Abbiamo bisogo di tornare alla concretezza delle azioni e al buon senso della pianificazione di lungo periodo, visto che gli scenari climatici impongono una rivisitazione dell’esistente: manutenzione delle reti idriche, adeguamento degli invasi, che sono in gran parte vecchi di un secolo, costruzione di nuove dighe laddove sia possibile, uscendo dalla logica della grande opera colonizzatrice imposta dall’esterno ma entrando nel campo della negoziazione condivisa con il territorio, semplificazione burocratica, diffusione dei contratti di fiume, alfabetizzazione dei cittadini sull’uso prudente e parsimonioso dell’acqua, almeno nei periodi di scarsità. Non sono originale, lo so. Tutte cose già dette e scritte in mille occasioni. Ma forse un po’ di sete in capitale potrà essere utile per occuparsi con lungimiranza di quel bene liquido che tutti diamo per scontato ma che quando manca fa precipitare la qualità della vita a livelli intollerabili. Ci risentiamo in autunno, sicuramente pioverà, la siccità sarà un ricordo e commenteremo l’alluvione!
Un'altra prevaricazione dell'economia (capitalistica) sul diritto. L'erogazione dell'acqua è un servizio pubblico di "rilevanza economica" che deve assoggettarsi alle regole di mercato, non c'è diritto che tenga. economiaepolitica, 10 luglio 2017 (i.b)
Qualche settimana fa il Consiglio di Stato ha respinto, in via definitiva, i ricorsi presentati dal Codacons, da Federconsumatori e dall’Associazione Acqua Bene Comune Onlus contro il metodo tariffario approvato nel 2012 dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) per calcolare la tariffa che gli utenti devono pagare ai loro gestori per la fornitura e il trattamento delle acque.
Le associazioni dei consumatori e i proponenti dei referendum per l'acqua pubblica del 2011 lamentavano il fatto che l’Aeegsi non avesse rispettato, nell’elaborazione dei metodi di calcolo, gli esiti del secondo referendum che aveva abolito dal calcolo delle tariffe idriche l’«adeguatezza della remunerazione del capitale investito» con il voto di oltre 26 milioni di italiani.
Volendo riassumere brevemente le motivazioni del Consiglio di Stato, si potrebbe dire che, secondo il supremo giudice amministrativo, ai sensi della normativa italiana ed europea attualmente in vigore il servizio idrico è un servizio ‘a rilevanza economica’ e, dunque, anche per tale servizio vale la regola per cui tutti i costi devono essere coperti dalla tariffa secondo il principio del “full cost recovery”. In presenza di tale principio, il diritto deve fare un passo indietro e lasciare il campo alla scienza economica che è la sola legittimata a stabilire quali voci di spesa rientrino effettivamente tra le nozioni di costo e, di conseguenza, debbano essere coperte dalla tariffa e pagati dagli utenti finali.
Il collegio peritale – composto da tre professori uno della Sapienza Università di Roma, uno dell’Università di Roma Tor Vergata e uno dell’Università LUISS “Guido Carli”, designati dai rispettivi Rettori – ha stabilito che «le formule e i parametri diretti a calcolare il tasso di interesse di riferimento e la componente di copertura della rischiosità rientrano nei limiti di attendibilità e di ragionevolezza del settore tecnico-scientifico dell’economia industriale, sotto il profilo della loro idoneità a riflettere la componente tariffaria strettamente limitata alla copertura dei costi del capitale investito. Inoltre, sono in linea con le pratiche della regolamentazione in ambito nazionale ed internazionale» [2]
Insomma gli interessi sul capitale proprio investito si devono pagare in ogni caso perché rientrano nel principio di totale copertura dei costi come ci insegna la scienza ‘esatta’ dell’economia industriale.
Non vi può essere, dunque, alcuna attività a rilevanza economica che escluda dai propri conti il costo del capitale proprio investito e nessun referendum popolare potrebbe stabilire il contrario.
Del resto il quesito referendario del 2011, secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato, è stato pienamente rispettato, dal momento che la remunerazione del capitale investito non deve essere più «adeguata» e, dunque, non assicura una posizione di ‘rendita’ prefissata una volta per tutte dal legislatore, ma è stabilita direttamente dai mercati finanziari e trasferita poi nella tariffa idrica attraverso la complicata formula matematica elaborata dall’Aeegsi che garantisce agli utenti finali l’assenza di aggravi o duplicazioni e cioè la piena economicità del servizio.
Insomma il secondo quesito referendario del 2011 è stato del tutto inutile: il servizio idrico è un servizio pubblico locale a rilevanza economica da gestire secondo le leggi del mercato. Non basta eliminare l’adeguatezza della remunerazione del capitale per rendere il governo e la gestione dell’acqua estranei alle logiche del profitto.
Ciò è il segnale di un processo molto preoccupante e ancora in corso: il progressivo appiattirsi del diritto sulla scienza economica. Tale processo avviene in due modi: da un lato attraverso un’interpretazione della normativa in vigore che privilegia le ragioni dell’efficienza economica su quelle della natura del servizio pubblico, dall’altro con l’ingresso diretto della scienza economica, attraverso lo strumento della consulenza tecnica, all’interno della decisione giudiziaria.
Il primo punto è stato messo in luce già qualche anno fa dal giurista francese Alain Supiot che ne aveva individuato le ragioni nel fatto che «La struttura linguistica e il mercato appaiono dunque oggi come i due punti di riferimento attorno ai quali le scienze sociali strutturano la loro ricerca delle leggi sotterranee che governano le questioni umane» [3]. La prova di ciò sta nel fatto che proprio la locuzione “rilevanza economica” applicata al servizio idrico integrato funge da paradigma linguistico attraverso cui il mercato entra prepotentemente nel settore dell’acqua. Tale locuzione dal punto di vista del diritto ha una duplice funzione, da un lato, serve a far rientrare anche i servizi idrici all’interno dei servizi pubblici locali in regime di libera concorrenza sia pure di concorrenza per il mercato e non di concorrenza nel mercato; dall’altro, serve a far rientrare la materia dell’affidamento dei servizi idrici all’interno della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Sono questi i motivi per i quali il legislatore italiano nel 2003 ha sostituito il concetto di «rilevanza industriale» con quello più ampio e indefinito di «rilevanza economica» per definire le caratteristiche di quei settori nell’ambito del servizio pubblico locale nei quali si doveva procedere con affidamenti mediante procedure ad evidenza pubblica [4].
Il secondo punto, cioè quello che si riferisce all’ingresso diretto della scienza economica nelle decisioni che riguardano la gestione del servizio idrico, trova la sua prova inconfutabile proprio nel fatto che i giudici del Consiglio di Stato si affidano alla consulenza tecnica di tre economisti per definire se le tariffe idriche vengono calcolate correttamente attraverso il metodo elaborato dall’Aeegsi. Solo la scienza economica può dire, infatti, al diritto come comportarsi per il calcolo delle tariffe determinando così una vera e propria identificazione della razionalità giuridica con quella economica.
La scelta politica viene così affidata esclusivamente al mercato senza lasciare alcuno spazio per una allocazione alternativa delle risorse affidata ad una diversa gerarchia di valori come quella che sta alla base della scienza giuridica.
Anche questo rischio era stato identificato qualche anno fa da un sociologo da poco scomparso, Ulrich Beck, il quale aveva sottolineato come le decisioni su come guidare i processi di investimento non sono tanto il risultato di una decisione diretta dei vertici imprenditoriali, quanto un effetto collaterale: «È importante sottolineare che il metapotere di indirizzare gli investimenti non dipende da vertici manageriali che perseguono attivamente un disegno politico. Piuttosto, accade loro di fare “politica” come effetto collaterale. Il loro coinvolgimento non è né politico né non-politico è una sorta di sub-politica globale» [5].
Resta il problema di capire fino in fondo quali siano i modi per evitare la concentrazione delle risorse finanziarie in un settore quale quello dell’acqua in cui la progressiva “depubblicizzazione” ha permesso l’ingresso di un numero rilevante di operatori privati. La strategia finora messa in campo dal Forum dei movimenti per l’acqua è stata quella di contrastare i processi di privatizzazione attraverso tutti gli strumenti giuridici a disposizione: prima con il ricorso a una legge di iniziativa popolare, che non è stata mai discussa dal Parlamento, poi promuovendo i referendum popolari del 2011, i cui esiti sono stati neutralizzati dal legislatore. Anche l’ultima forma di resistenza, quella di rivolgersi alla magistratura amministrativa contro le decisioni dell’Aeegsi ha portato a una sonora sconfitta.
Insomma si potrebbe dire che se gli italiani con il referendum del 2011 avevano provato a tirar fuori l’acqua dal sistema di mercato, ma l’intento non è stato raggiunto anche perché il collegio degli esperti di economia aziendale ha contribuito a far rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta: la teoria microeconomica dominante riconosce anche la remunerazione del capitale come esito spontaneo del mercato.
Si potrebbe dire, con Karl Polanyi, che una volta istituito il sistema di mercato «deve essere lasciato funzionare senza interferenze esterne. I profitti non sono più garantiti ed il commerciante deve realizzarli sul mercato. Si deve anche permettere che i prezzi si regolino da soli, ed un tale sistema autoregolato di mercati è ciò che intendiamo per economia di mercato» [6].
Tenendo conto del fatto che i referendum sull’acqua sono stati in grado di portare alle urne ventisei milioni di italiani in un periodo di elevata astensione politica, l’idea di una gestione pubblica dell’acqua potrebbe essere ancora in grado di smuovere una vasta partecipazione politica diretta a realizzare la redistribuzione dei benefici derivanti dall’utilizzo di una risorsa che va facendosi sempre più scarsa e, per questo, sempre più preziosa per l’intera comunità degli utenti, compresi quelli delle generazioni future.
Note
[1] Consiglio di Stato, sent. n. 2481 del 26 maggio 2017.
[2] Consiglio di Stato, sent. n. 2481 del 26 maggio 2017.
[3] A. Supiot, Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto, Milano, 2006, p. 92.
[4] Mi si consenta di rinviare sul punto a S. Marotta, Le tariffe del servizio idrico integrato dopo il referendum, in «Munus», n. 3/2012, pp. 657-666.
[5] U. Beck, La società cosmopolita. Prospettive dell’epoca postnazionale, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 233.
[6] K. Polanyi, La grande trasformazione, Einaudi, Torino, 1974, p. 56.
Un altra diga in Tanzania modificherà il sistema idrico privando le regioni delle inondazioni stagionali, vitali per le popolazioni. Ambientalisti, gestori di Safari e abitanti contro il progetto, greenMe.it, 28 giugno 2017, (i.b.) con postilla
Non si arresta la protesta delle popolazioni indigene contro la costruzione di un’enorme diga idroelettrica in uno dei più grandi polmoni verdi dell’Africa. Accanto a loro gli ambientalisti che temono che la costruzione causerà danni irreversibili alla riserva Selous in Tanzania. Sono sempre più minacciati gli indigeni, costretti a lottare contro multinazionali e governi compiacenti, pur di difendere le loro terre ancestrali, diventate ormai solo fazzoletti invivibili.
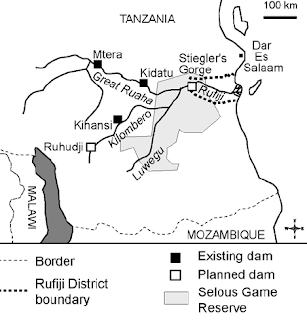 |
| Il fiume Rufiji con dighe esistenti e future. Estratto da un articolo di Duvail et at (2013) |
Non si arresta la protesta delle popolazioni indigene contro la costruzione di un’enorme diga idroelettrica in uno dei più grandi polmoni verdi dell’Africa. Accanto a loro gli ambientalisti che temono che la costruzione causerà danni irreversibili alla riserva Selous in Tanzania. Sono sempre più minacciati gli indigeni, costretti a lottare contro multinazionali e governi compiacenti, pur di difendere le loro terre ancestrali, diventate ormai solo fazzoletti invivibili. Dopo anni di ritardo e false partenza, in questi giorni il presidente della Tanzania John Magufuli ha annunciato che la diga Gola Stiegler sul fiume Rufiji, si farà.
E non c’è da stare tranquilli perché dalla sua elezione nel 2015, Magufuli soprannominato ‘il bulldozer’, è conosciuto soprattutto, per il suo record di infrastrutture costruite.Dopo anni di ritardo e false partenza, in questi giorni il presidente della Tanzania John Magufuli ha annunciato che la diga Gola Stiegler sul fiume Rufiji, si farà. E non c’è da stare tranquilli perché dalla sua elezione nel 2015, Magufuli soprannominato ‘il bulldozer’, è conosciuto soprattutto, per il suo record di infrastrutture costruite. Poca attenzione per l’ambiente, a fronte del profitto. La diga sorgerà, infatti, nel cuore del Selous, una riserva naturale che ha una superficie pari a quella della Svizzera. Un’oasi per elefanti, ghepardi, coccodrilli e giraffe che vivono a due passi dalle popolazione indigene.
Un luogo diventato Patrimonio Unesco, ma dichiarato anche in pericolo, a causa del bracconaggio. Adesso, arriva questa ennesima scure: la diga che fornirà 2100 MW di energia elettrica in un paese che sta soffocando. “Siamo molto preoccupati per la costruzione della diga che avrà un impatto negativo sul sito. Bisogna già lottare contro tutte le attività illegali che mettono in pericolo la vita degli animali, tra cui il rinoceronte nero e degli indigeni”, dice Remco van Merm dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.
“Questo tipo di progetti vengono giustificati dal fatto che forniranno energia elettrica e vengono inquadrati come misure poco impattanti. In realtà, che senso ha una costruzione che distrugge la riserva e limita la sopravvivenza dei popoli locali?”, dice Thabit Jacob, specialista in Energia e Ambiente.“Questo tipo di progetti vengono giustificati dal fatto che forniranno energia elettrica e vengono inquadrati come misure poco impattanti. In realtà, che senso ha una costruzione che distrugge la riserva e limita la sopravvivenza dei popoli locali?”, dice Thabit Jacob, specialista in Energia e Ambiente.
A luglio, il Comitato del Patrimonio mondiale si riunirà insieme al governo della Tanzania per trovare una soluzione e per chiedere ancora una volta che il progetto venga abbandonato perché non è compatibile con lo status di riserva protetta.
postilla
Con il nuovo boom delle dighe idroelettriche, anche i buoni propositi per una gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche, che tanto consenso hanno avuto, vengono messi da parte. Questa gestione che dovrebbe promuovere lo sviluppo e la gestione coordinata dell'acqua, del suolo e delle risorse correlate, al fine di massimizzare un benessere sia economico che sociale senza compromettere la sostenibilità degli ecosistemi vitali e dell'ambiente, da grande importanza ai flussi e alle portate dei fiumi. Non solo riguardo al mantenimento dei flussi minimi, ma anche al mantenimento dei flussi di punta e a tutti quei ecosistemi legati alle inondazioni.
Sono proprio la diminuzione delle inondazioni che modificheranno profondamente il funzionamento dei laghi della regione, mettendo a rischio la sopravvivenza delle popolazioni circostanti.
Meno male che oltre agli interessi delle popolazioni povere circostanti sono a rischio anche il turismo legato ai Safari e un Patrimonio Unesco, altrimenti di questi “dannati dello sviluppo” non ne sapremmo mai l’esistenza. (i.b.)
Espropriazione dei beni comuni in Polonia, la destra populista autorizza il disboscamento dell’ultima foresta vergine Europea, il Manifesto, 4 Luglio, (i.b.)
Una parte della Polonia piange i suoi alberi e lancia un appello alla comunità internazionale. La speranza è quella che la Conferenza del Patrimonio mondiale, in programma a Cracovia fino al prossimo 12 luglio, possa sensibilizzare l’Unesco sul disboscamento di Bialowieza, l’unica foresta vergine rimasta sul continente europeo, vittima di un piccolo coleottero, il bostrico e del governo.
Negli ultimi mesi la mobilitazione ha portato diversi attivisti, alcuni dei quali giunti da Romania e Repubblica Ceca, a incatenarsi agli alberi, mentre altri hanno provato a ostacolare le cesoie forestali al lavoro. Adesso sono arrivati anche i primi fermi e multe. C’è ancora una parte del paese capace di indignarsi e che spera in un «Rospuda-bis», quando nel 2009 dopo otto anni di battaglie, il governo fu costretto a deviare il percorso di un’autostrada che sarebbe dovuta passare attraverso l’omonima valle. Le proteste cracoviane culmineranno in un happening previsto nella giornata di oggi. Una mobilitazione che porterà in strada numerose sigle e Ong: Greenpeace, Wwf, ma anche Fundacja Dzika Polska, Greenmind e Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
Il ministro dell’ambiente polacco Jan Szyszko ha dichiarato che l’argomento non è finito in agenda a Cracovia. Ma l’Unesco starebbe valutando proprio in questi giorni l’invio di un’altra missione di monitoraggio a Varsavia.
Quasi la metà della foresta, che si estende per oltre 3.000 km² tra Polonia e Bielorussia, è protetta come parco nazionale. La presenza di zone cuscinetto e di oasi protette all’interno di Bialowieza, contribuisce a disegnare una mappa amministrativa complessa del parco, dove lo sfruttamento per uso commerciale dei boschi, ai margini dell’aree strettamente protette, è comunque consentito. E lì che il governo della destra populista Diritto e giustizia (PiS) ha deciso l’anno scorso di triplicare il limite al volume di legno recuperabile da Bialowieza. Un’iniziativa, che con buona pace anche degli entomologi, mette a repentaglio tutta la biosfera della foresta. La decisione è stata giustificata dalla diffusione incontrollata del bostrico o tipografo dell’abete rosso, che continua a lasciare il segno in tutti i boschi europei. Abbattere gli alberi di Bialowieza «è il male minore», secondo il ministro Szyszko.
A fare il gioco del partito fondato dai fratelli Kaczynski, c’è anche l’allarmismo di una certa stampa locale che tende a presentare la diffusione del bostrico alla stregua di un’epidemia incontrollabile. Eppure, uno studio del 2008 sull’impatto del bostrico nel parco nazionale di Sumava in Repubblica ceca, ha mostrato un maggior impoverimento del sottobosco nelle aree sottoposte a un abbattimento preventivo. Più in generale, buona parte della comunità scientifica concorda sul fatto che gli alberi vittime del bostrico e il legno morto dovrebbero restare al proprio posto: i tronchi vecchi o caduti attaccati dal tipografo infatti trasformano il legno in humus. Ed è proprio questo a preoccupare maggiormente il governo che non intende rinunciare allo sfruttamento della legna. Che finisca nei camini o venga venduta ai mobilifici poco importa.
La strategia perseguita dal PiS a Bialowieza è solo uno dei tasselli nella disastrosa politica ambientale del governo. Un esempio, la cosiddetta lex Szyszko approvata in sordina dalla maggioranza a dicembre scorso. Il provvedimento in vigore nel 2017 ha autorizzato l’abbattimento degli alberi su un suolo privato senza il via libera della autorità locali. Mettendo insieme i dati raccolti sul territorio polacco si stima che le motoseghe abbiamo fatto fuori almeno 300.000 alberi dall’inizio di quest’anno. Una sorta di condono ecologico «a tempo» durato cinque mesi prima che il governo ponesse nuovamente alcune restrizioni in materia. Il maggior beneficiario delle politiche di Szysko è l’Azienda delle foreste statali polacche, Lasy Panstwowe, che gestisce per conto del governo una superficie pari quasi al 30% del paese. L’amministrazione forestale da lavoro a oltre 26.000 persone e garantisce salari di oltre 6.000 zlotych al mese (circa 1.500 euro) ai suoi dipendenti, oltre il doppio dello stipendio medio in Polonia. Compensi lauti paragonabili soltanto a quelli del settore minerario: legno e carbone, appunto. Da un punto di vista giuridico si tratta di un’azienda statale ibrida che autofinanzia le proprie attività, versa alcune tasse agli enti locali ma senza beneficiare del gettito fiscale dei contribuenti. Un giocattolo difficile da smontare, insomma, anche a medio termine. Il direttore dell’azienda, Konrad Tomaszewski, cugino del numero uno del PiS Lech Kaczynski, continua a paragonare in pubblico l’ecologia a una forma di «nazismo verde». Trasportare, piantare nuovi alberi e tagliare tronchi per conto degli enti locali: un circolo vizioso che permette all’autorità forestale di fare e disfare la tela a piacimento per generare profitti.
«Bialowieza è prima di tutto il risultato dell’intervento dell’uomo nel corso della storia», ha ripetuto come un mantra negli ultimi mesi Szyszko. La natura ridotta a merce è fatta per l’uomo e non il contrario: è questo il messaggio che vuole lanciare la Polonia «orbanizzata» ai tempi del PiS. Ma la foresta primaria di Bialowieza non è un hortus conclusus da potare con le cesoie. E con questi argomenti Szyszko non è riuscito a scongiurare l’intervento di Bruxelles visto che la foresta fa parte anche del programma Ue Rete Natura 2000. Intanto la battaglia per un’altra Rospuda è appena cominciata.