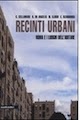«Quel «livello politico» evocato in questi mesi ora pare realtà. Trasmesso un fascicolo stralciato da quelli su Mose e Consorzio al tribunale dei ministri, l'organo «filtro» per le indagini su ministri o ex per reati commessi nell'esercizio di funzioni governative».
«Quel «livello politico» evocato in questi mesi ora pare realtà. Trasmesso un fascicolo stralciato da quelli su Mose e Consorzio al tribunale dei ministri, l'organo «filtro» per le indagini su ministri o ex per reati commessi nell'esercizio di funzioni governative». Corriere del Veneto
, 28 maggio 2014 (m.p.r.)
Una cosa è certa: nel mirino della procura di Venezia è finito un ministro, o più probabilmente un ex ministro. A ormai 15 mesi dagli arresti di Piergiorgio Baita, Claudia Minutillo, Nicolò Buson e William Colombelli per le false fatture Mantovani e a una decina di mesi dalla retata di arresti per turbativa d'asta che hanno coinvolto l'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova Giovanni Mazzacurati, la complessa indagine della Guardia di Finanza, coordinata dai pm Stefano Ancilotto, Paola Tonini e Stefano Buccini, è a una prima svolta. E quel «livello politico» tanto evocato in questi mesi, ora pare una realtà. Nei giorni scorsi la procura ha infatti trasmesso un fascicolo stralciato da quelli su Mose e Consorzio al tribunale dei ministri, l'organo che secondo una legge costituzionale del 1989 fa da «filtro» per le indagini relative a ministri o ex ministri qualora i reati siano stati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni governative.
Questo significa che — come prescrive la legge — nel corso delle verifiche successive ai numerosi interrogatori effettuati dalla procura, sarebbero emerse notizie di reato relative a una persona che ha avuto incarichi ministeriali. I pm hanno dunque subito inoltrato il fascicolo, compresi anche tutti gli altri indagati, al tribunale dei ministri, che avrà tre mesi di tempo per eseguire delle proprie indagini preliminari. Nei giorni scorsi, oltre al ministro, il cui nome per ora è top secret (ma non sarebbe veneto), sono arrivati degli avvisi anche ad altri indagati, in particolare a Baita e Buson, rispettivamente l'ex presidente e l'ex direttore amministrativo della Mantovani. Avvisi scarnissimi, in cui si dice solo che è stata avviata la procedura, ma in cui non c'è né un'ipotesi di reato (toccherà al tribunale stabilirla), né i nomi degli altri indagati.
Quello che si può capire è che Baita e Buson avrebbero partecipato in concorso con il ministro nella consumazione del reato. Per esempio — ma è solo un esempio visto che il reato è ancora coperto dal segreto — se all'ex ministro fosse stata contestata una corruzione, Baita e Buson potrebbero essere stati identificati come i corruttori. In realtà da quel poco che trapela, visto che gli interrogatori sono stati praticamente tutti secretati, sia Baita che Mazzacurati avrebbero parlato del coinvolgimento di un ex ministro, a cui sarebbero stati versati dei fondi non direttamente ma attraverso un giro di società da lui indicate.
Dichiarazioni che nel corso di questi mesi sono state verificate dalle fiamme gialle del Nucleo di polizia tributaria. E probabilmente proprio da una recente informativa sarebbe scattata la trasmissione al tribunale dei ministri, che deve avvenire entro 15 giorni. Saranno ora i tre giudici designati a stabilire se disporre l'archiviazione (qualora ritengano che il reato non ci sia o che sia stato commesso al di fuori delle funzioni di ministro) oppure ritrasmettere gli atti al procuratore per poter chiedere l'autorizzazione a procedere al Parlamento. Il collegio sarà composto dalla presidente Monica Sarti (gip a Verona), da Priscilla Valgimigli (tribunale del riesame di Venezia) e da Alessandro Girardi (sezione fallimentare di Venezia), estratti a sorte tra tutti i magistrati del distretto. Da tempo inoltre si attendono gli sviluppi anche dell'inchiesta «madre», dopo che appunto molti degli arrestati del primo «giro» avrebbero fatto numerose rivelazioni ai pm, anche su finanziamenti ai politici.

"Rigenerare". Una delle tante parole alla moda che può assumere significati diversi, anche antitetici. E' utile cominciare a guardare che cosa può esserci dietro. La Repubblica, 27 maggio 2014
La parola chiave è rigenerazione. E il luogo dal quale si srotola il racconto di una nuova frontiera per architettura e urbanistica - non occupare altro suolo libero, intervenire sul già costruito restituendo vita a pezzi di città non solo dal punto di vista fisico, ma sociale - è Corviale. Simbolo per molti di sconcerto e quasi di orrore metropolitano, per altrettanti, invece, manufatto fra i pochi significativi del secondo Novecento, il grande edificio lungo un chilometro della periferia ovest di Roma, concepito a metà anni Settanta e che ora ospita 4.500 persone (ne erano previste 8 mila), sta per conoscere una nuova esistenza.
E se si rigenera Corviale vuol dire che la sfida è alta e rischiosa e rimbalza nelle periferie di altre città, dove, secondo le stime, almeno i nove decimi del costruito sono successivi al dopoguerra. Un costruito affetto da malattie profonde.
Renzo Piano ha invitato al “rammendo”, una metafora che rimanda alla riparazione e non all’aggiunta di nuovo tessuto. E in questo programma ha coinvolto giovani professionisti. Alla imminente Biennale architettura (dove viene esposto il progetto Corviale), il titolo del padiglione italiano curato da Cino Zucchi è “Innesti”, cent’anni di edifici realizzati in ambienti già storici (ma qui si sconfina in un campo assai controverso, quello del moderno nell’antico). A Scampìa, periferia napoletana, Vittorio Gregotti costruisce da anni, stop and go permettendo, una sede della facoltà di medicina dove un tempo svettava una delle Vele poi demolita, altra architettura con lo sbrigativo bollino di infamia. A Roma l’assessore Giovanni Caudo – assessore alla Rigenerazione urbana – ha impostato un piano per realizzare, in un’area di caserme dismesse di fronte al Maxxi, un museo della scienza, abitazioni a canone concordato e spazi pubblici, lasciando una parte all’edilizia privata.
Rigenerare è connesso con l’abbandono dell’idea di un’espansione illimitata. La legge urbanistica toscana, promossa dall’assessore Anna Marson, prevede che le aree urbanizzate vengano perimetrate e che si costruisca solo al loro interno, lasciando integro il territorio libero. Un’invalicabile linea rossa intorno ai centri urbani è stata immaginata dall’urbanista Vezio De Lucia nel Piano della provincia di Caserta, la Gomorra massacrata da un’edilizia selvaggia.
Gli esempi italiani potrebbero continuare. Molte università sono impegnate nella ricerca. Si guarda all’Olanda, alla Germania, alla Svezia. Ma intanto Gregotti, che di questi temi ha scritto in Architettura e postmetropoli (Einaudi), mette sull’avviso: «Rigenerare significa ricreare un tessuto urbano, non pensare a un oggetto isolato.
Occorre legare l’intervento all’ambiente che lo contiene, creare una mescolanza fra abitazioni, servizi e altre funzioni che soddisfino i bisogni di quel contesto». Architettura e urbanistica insieme. Un cambio di paradigma: non più oggetti che splendano in solitudine, ma ricuciture nelle slabbrature di una città cresciuta senza regole, che ha invaso terreni agricoli, diradandosi e sprecando suoli pregiati. Esiste però buona rigenerazione e cattiva rigenerazione, non basta dire “stop al consumo di suolo”: è l’avvertenza di Edoardo Salzano, urbanista, animatore del sito eddyburg. it. «Una cosa è proporsi di migliorare le condizioni fisiche di parti della città e la vita delle persone», spiega Salzano, «altro è preoccuparsi di moltiplicare il volume d’affari e i valori immobiliari. La prima strada è rigenerazione, la seconda no». Rigenerazione non solo dell’involucro fisico, ma della qualità del vivere.
I progetti di Corviale li illustra Daniel Modigliani, architetto, commissario dell’Ater, l’azienda regionale per l’edilizia pubblica proprietaria dell’edificio: «Il primo problema è densificare Corviale. Molto spazio è sprecato. E anche le abitazioni sono troppo grandi per famiglie ridotte a una coppia o anche solo a una persona. Al quarto piano, che l’architetto Mario Fiorentino aveva destinato ai servizi e alle aree collettive, poi occupato da abusivi e ora degradato, Guendalina Salimei ha previsto un centinaio di alloggi». Per Massimiliano Fuksas, Corviale andrebbe abbattuto. Per altri, spezzettato in una trentina di convenzionali palazzine. «Lo decideremo con il concorso», replica Modigliani. «Io insisto per conservarne l’unitarietà. Abbiamo un progetto per aprire il pian terreno e installarvi servizi e altre attività e per consentire il passaggio dalla strada agli orti che sono alle spalle dell’edificio, così da alimentare le relazioni con il quartiere. Sul tetto sono previsti verde e impianti per la raccolta dell’acqua e il risparmio energetico ». A Corviale il verde è tanto e anche i servizi, compresa una delle migliori biblioteche comunali. Al progetto si è arrivati dopo consultazioni fra le istituzioni, il ministero per i Beni culturali, l’università e, soprattutto, i comitati di cittadini. La nuova frontiera della rigenerazione in realtà viene rincorsa da una trentina d’anni. Da quando, in Europa e in Italia, si rendono disponibili aree in zone periferiche o semicentrali occupate da industrie e altri impianti.
Resta esemplare la storia delle caserme francesi di Tubinga, in Germania: 64 ettari, liberati dai militari dopo la riunificazione, hanno accolto case ad affitto convenzionato per 6 mila abitanti, costruite da cooperative degli stessi futuri residenti, aziende per 2 mila occupati, verde, scuole, servizi comunitari come il car sharing, biciclette a disposizione di tutti. E se si allarga lo sguardo ecco le esperienze, ormai storiche, dell’America Latina, da Curitiba (Brasile) del sindaco-urbanista Jaime Lerner a Medellín in Colombia. Qui, nella capitale del narcotraffico, si è avviata una rigenerazione che – racconta Mario Tancredi, architetto italiano che insegna in Colombia – «ha fronteggiato la segregazione sociale con una rete di trasporto pubblico e una linea di cabinovie che a ogni stazione realizzava uno spazio di convivenza e che si arrampicava su un’altura raggiungendo alcune biblioteche, cinque progettate nel giro di poco tempo, e poi un parco urbano. Tutto questo accompagnato da piazze, strade, scuole, fognature e dalla ristrutturazione di tante abitazioni sorte in maniera incontrollata e in luoghi pericolosi. Gli effetti? Omicidi crollati di decine di punti percentuali e crescita del commercio del 300 per cento».
Se invece di progetti a questa scala si punta a incrementare la rendita – insiste Salzano – la rigenerazione non c’è più: centri commerciali, residenze a prezzi di mercato, speculazione. Occasioni sprecate. Come a Vicenza, dove a poche centinaia di metri dalla Rotonda di Andrea Palladio, nella zona di Borgo Berga, al posto dello storico stabilimento Cotorossi sta sorgendo un quartiere di forme spropositate, realizzato da una società che fa capo a Enrico Maltauro, in carcere per le tangenti Expo 2015, che grava sui due fiumi, il Retrone e il Bacchiglione, esondati due anni fa. «Per queste iniziative è indispensabile la regìa pubblica, senza sottomissioni al volere dei privati», spiega Salzano. «La città non è fatta solo di abitazioni, ma di spazi per stare insieme. La prima cosa che si insegnava a chi studiava urbanistica era di calcolare i fabbisogni. Adesso si calcola la valorizzazione delle aree».
proprietarie delle più belle dimore storiche tra i vigneti dell'Amarone». L'Espresso, 23 maggio 2014
Anche le le ville venete insorgono contro il cemento. Succede in Valpolicella, tra Verona e il Lago di Garda, in una zona doc che è famosa nel mondo per la qualità dei suoi vini, come l'Amarone e il Recioto. E per la bellezza del paesaggio, con distese di vigneti e ciliegi contornate da antichi muri in pietra, chiese romaniche, paesini storici e splendide ville nobiliari.
A partire dagli anni Sessanta, purtroppo, anche questa provincia veneta, come troppe parti d'Italia, è stata stravolta da un'ondata di nuove costruzioni speculative, con schiere di lottizzazioni-conigliere, orridi capannoni e mostruosi ipermercati, che hanno arricchito pochi affaristi danneggiando un territorio che è la vera ricchezza di tutti. Uno dei maggiori comuni della Valpolicella, Negrar, è diventato addirittura un luogo-simbolo di questi decenni di cementificazione insensata. Eppure proprio qui una giunta di centrodestra, ora in scadenza, ha varato un nuovo “piano di assetto del territorio” che minaccia di consegnare agli speculatori anche le ultime aree verdi, perfino nella frazione-gioiello di Arbizzano, tanto che le opposizioni lo hanno ribattezzato “piano d'assalto del territorio”.
Per cercare di salvare ciò che resta dell'ambiente e del paesaggio, da mesi si stanno mobilitando dozzine di associazioni civiche e comitati locali. Tra i cittadini più informati e sensibili c'è un ricercatore, Gabriele Fedrigo, autore di un libro-inchiesta che documenta decenni di orrori urbanistici, con un titolo eloquente: «Negrarizzazione: speculazione edilizia, agonia delle colline e fuga dalla bellezza». Nell'agosto scorso, di fronte ai nuovi progetti speculativi della giunta di destra, aggravati dalla scoperta di gravi casi di inquinamento industriale delle falde, Fedrigo ha affisso alle finestre della propria abitazione, a Negrar, due striscioni con queste scritte di protesta: «Basta cemento» e «Acqua e aria sane».
A fine aprile, l'amministrazione comunale ha reagito: il ricercatore si è visto notificare un avviso di apertura di un procedimento sanzionatorio, che gli contesta una pretesa violazione del regolamento comunale sul «decoro urbano delle aree scoperte». Come se a rovinare il paesaggio di Negrar fossero gli striscioni di protesta, anziché le colate di cemento o gli avvelenatori delle acque. Il singolare provvedimento, emesso a ridosso delle elezioni comunali del 25 maggio, si chiude con una diffida a rimuovere le scritte di protesta, sotto minaccia di multe salate. Alla rituale richiesta di presentare una difesa scritta, Fedrigo ha risposto comunicando che «la mia memoria difensiva è la Costituzione italiana, che tutela il paesaggio e la libertà di pensiero»: «Gli striscioni sono stati esposti come forma di manifestazione del mio pensiero, per esprimere la mia protesta e indignazione contro una politica di gestione del territorio palazzinara e devastante».
Il tentativo politico di zittire il ricercatore scomodo, proprio in coincidenza con la fase finale di una campagna elettorale che è diventata una specie di referendum pro o contro il cemento, ha scandalizzato molti cittadini. E tra i tanti indignati sono comparse, a sorpresa, alcune delle più nobili famiglie veronesi, proprietarie delle più famose ville storiche della Valpolicella. In breve, sulle splendide facciate di queste dimore secolari, sono comparse le stesse scritte di protesta, in aperta solidarietà con Fedrigo: «Basta cemento». Ora il tam-tam dell'iniziativa sta facendo il giro di Internet, dove cittadini e associazioni si scambiano una cartolina con la casa di Fedrigo contornata dagli striscioni di protesta comparsi sulle prime otto ville (come gli otto comuni della Valpolicella) che hanno raccolto la sfida contro la definitiva cementificazione del territorio.
Una essenza vegetale non autoctona che si insinua ovunque nelle nostre città: come reagire o adeguarsi? Di norma evitando eccessi. Corriere della Sera, 24 maggio 2014, postilla (f.b.)
Gli alieni sono tra noi. Vedete quegli spilungoni che spuntano qua e là, senza dare troppo nell’occhio? Mai notati? Eppure, ormai, sono dappertutto. Una ventina d’anni fa erano ancora una curiosità venuta dalla Cina. Anche il mondo vegetale, però, adesso va più veloce, si globalizza. Una volta l’Abc lo imparavi da bambino (Abete, Bosso, Castagno…) e con quello arrivavi alla vecchiaia; oggi, nel giardino planetario, l’abbecedario va aggiornato in continuazione. A partire dalla A di Ailanto (nella foto) . Una pianta che tende a puntare in alto. Lo sottolinea il nome scientifico: Ailanthus altissima. Ribadito da altri appellativi popolari, come il Toccacielo. O l’albero del paradiso. Poi si scopre che il paradiso può essere un inferno.
L’ultima scomunica porta il sigillo Royal Botanic Gardens: «È una delle piante più infestanti che si conoscano. Non deve essere coltivata in nessun luogo». Torna il fantasma dei baccelloni e delle liane carnivore. E la fantascienza, stavolta, è sotto casa: l’ailanto, l’alieno, ormai s’è infiltrato ovunque, da Nord a Sud. Guardatevi attorno. Il portamento è leggiadro, le foglie ben ordinate, il tronco svettante, venato di esotismo orientale. L’indole rusticissima tollera l’inquinamento, si accontenta di poca terra. Cresce in fretta. Così l’hanno piantato di qua e di là: davvero una bella pianta, senza problemi. Il problema, invece, era proprio quello. L’ailanto è uno che si adatta fin troppo. Riproducendosi sia attraverso le radici, che avanzano partorendo una raggera di nuovi alberelli, sia dai semi che in soli sei mesi dalla germinazione ti sfornano un intero boschetto già pronto, a sua volta, a fiorire e fruttificare. Se lo tagli ricaccia peggio di prima. Ultima nota dell’identikit: l’ailanto è una specie allopatica. Avvelena tutte le piante che la circondano.
Viste le premesse: difficile che non lo abbiate ancora incontrato. Identificate la prima volta quegli spilungoni imparruccati di foglioline verdi (in questi giorni sono appena spuntate). E comincerete a rivederli ovunque: ai margini del parco, tra i ruderi, negli spartitraffico. Un’invadenza che supera robinie e canneti. Imponendo anche al giardiniere dilettante gli ultimi aggiornamenti dettati dalla flora globalizzata: A come Ailanto. Un vegetale senza troppi scrupoli, s’è detto. Da trattare con circospezione. Ma anche, in fondo, con il rispetto per chi, colonizzando tanti spazi abbandonati, inquinati, schifati dalle piante nostrane, si ritrova a fare uno sporco lavoro: un effetto, non la causa del degrado. Sembra un allarme rosso sui pericoli di un’infiltrazione extraterrestre. E invece è un monito: per ricordarci che, agli alieni, le piste di atterraggio le costruiamo noi.
postilla
Il tono leggero dell'articolo non nasconde certo la natura del problema, del resto analogo a quello delle nutrie e di tante altre specie vegetali e animali che in tempi recenti e meno recenti si sono sia “globalizzate” che “urbanizzate” andando spesso a costruire associazioni e ambienti che anche gli ecologi considerano di notevole interesse. Ci sono poi altri aspetti, sociali e identitari, curiosa la campagna contro l'abbattimento di un filare di ailanti, cresciuti lungo le sponde di un canale per pura incuria, e che una tardiva manutenzione voleva eliminare allo stadio di piante adulte: gli abitanti di un quartiere, diventati adulti vedendo crescere quelle piante “aliene e infestanti”, le consideravano un valore, altro che fastidio! Ovvero, pur con tutte le ovvie cautele del caso, come con la vicenda della nutria di Milano Due già riportata su questo sito, non sarà certo un integralismo ambientale di stampo “eco-leghista” l'approccio adeguato ai nuovi equilibri urbani e naturali, ma la ricerca di forme di convivenza diverse e avanzate tutte da scoprire (f.b.)

Il Fatto quotidiano, 22 maggio 2014, con postilla
Difficile dimenticare un’alba tra le torri di San Gimignano, a buon diritto definita dall’Unesco (che nel 1990 ne ha incluso il centro storico nel patrimonio dell’umanità) un “capolavoro del genio creativo umano”. Ma se uno fa l’errore di rimanerci fino alle 11 di mattina, sarà indimenticabile anche l’invasione turistica che fa della cittadina medioevale della Val d’Elsa una piccola Venezia. Nei giorni di punta anche ventimila consumisti della vista marciano a passo di corsa lungo le due strade e nelle due piazze in cui consiste la meravigliosa ruota da criceti in cui si autoconfina questo rito di conformismo di massa. Quasi ventimila pullman e due milioni di auto fanno sbarcare – spesso dopo chilometri di coda – tre milioni di persone all’anno (anzi in otto mesi: perché dai Morti a Pasqua non c'è quasi nessuno) in un centro che conta poco più di mille residenti.
Qualche anno fa il costante aumento di queste cifre da capogiro aveva indotto l’Unesco a chiedere (inutilmente) un numero chiuso, per difendere i monumenti dall’usura: ma il vero problema non riguarda le pietre, riguarda la qualità della vita dei cittadini. Il sito web del Comune è una gigantesca excusatio non petita: “Se un viaggiatore, entrando in San Gimignano, avesse l’impressione che la dimensione prevalente è quella a misura di turista farebbe bene a ricredersi alla svelta”, perché “San Gimignano non è solo le sue splendide torri, né solo il tessuto urbano, o l’ingente patrimonio artistico che chiese, palazzi e musei conservano, ma è anche un corpo vivo e attivo”. Quel corpo è ancora vivo, sì: ma non lo sarà ancora per molto. Negli ultimi trent’anni, il centro storico ha perso due terzi dei suoi residenti: man mano che il turismo è diventato la monocultura economica e l’unica dimensione esistenziale, San Gimignano ha progressivamente perso i connotati della città per assomigliare sempre più a una quinta cinematografica, a una Disneyland del Medioevo, con tanto di ben tre ‘musei’ della tortura.
I paurosi prezzi delle case, la riduzione e l’omologazione delle professioni possibili, il bassissimo livello di un turismo da mezza giornata (quando va bene) mettono in fuga i giovani.
Tutto è per i turisti, e prima e dopo il loro grottesco turno (11-18) la città non c’è più: e fa davvero impressione sentirsi dire che la sera d'inverno, dopo le nove, l’unico posto pubblico in cui ci si può trovare per fare quattro chiacchiere è la lavanderia a gettone.
Di fronte a questa situazione, l’unica strada sarebbe coltivare un turismo di qualità, diversificare l’economia, e soprattutto ridare un senso civico e comunitario al patrimonio artistico. E invece che fa la giunta guidata dal Pd Giacomo Bassi? Affida per cinque anni tutti i musei comunali (seconda voce delle entrate del Comune, dopo i parcheggi) a Opera Laboratori Fiorentini, del gruppo Civita (presidente Gianni Letta): il più grande oligopolista del patrimonio italiano, che gestisce già – tra il molto altro – gli Uffizi e i musei di Siena. E questo vuol dire uscire dal circuito della ricerca ed entrare definitivamente in quello dell’intrattenimento di cassetta: vuol dire che vedremo a San Gimignano mostre trash profumate di Van Gogh e Caravaggio, come in qualunque altro non-luogo sfigurato dalla triste omologazione commerciale che opprime le nostre città d’arte. E così i ragazzi di San Gimignano avranno un motivo in più per andarsene. Chi ha capito benissimo la situazione sono i cinesi. La multinazionale ForGood ha deciso di costruire un’altra San Gimignano nei sobborghi di Chongqing, uno degli agglomerati urbani maggiori del mondo (circa 33 milioni di abitanti).
Avete capito bene: 253 ettari saranno impiegati per ‘ricreare’ un angolo di paesaggio toscano – con tanto di colline e di piante tipiche, viti incluse – che ospiterà una San Gimignano 2: non una copia esatta, ma una sorta di generica cittadina toscana “medioevale” con torri. L’allucinante iniziativa è stata presentata ai cittadini di San Gimignano dagli architetti dello studio pisano che sta seguendo il progetto, i quali l’hanno descritto come “un nuovo incredibile centro turistico, con la nostra atmosfera artistico culturale: un'esperienza commerciale unica”. Già, perché i cinesi hanno intuito che copiare San Gimignano non vuol dire copiare una città, ma un centro commerciale medioevale, un outlet della storia, un mall della “cultura” senza veri abitanti, ma solo con clienti. La domanda è: hanno preso un abbaglio o hanno, tragicamente, capito quello che sta succedendo?
Domenica si vota anche nella cittadina toscana: una buona occasione per invertire la rotta. Forse l’ultima: prima che San Gimignano diventi la copia della sua copia cinese.
Luigi Scano definiva "razionamento programmato dell'offerta turistica" all'inizio degli anni Ottanta, una politica del turismo volta a definire (e a tradurrre in regole e azioni) un equilibrato rapporto tra la capacità di carico delle risorse e le presenze di visita e soggiorno, di estendere la fruizione a tutte le numerosissime aree ricche di qualità ambientali e paesaggistiche e di evitare che l’unica discriminante alla fruizione sia quella del reddito.
«Ogni opinione, naturalmente, è lecita; però dire che Expò sarà una colata di cemento, mentre l’eredità di Expo sarà un parco di quasi 50 ettari, uno dei più grandi d’Europa, non ha niente a che vedere con il legittimo dissenso». Il manifesto, 22 maggio 2014 (m.p.r.)
Ho letto l’articolo di Guido Viale su Expo e siccome il suo giudizio è costruito anche su informazioni inesatte, credo sia mio dovere correggerle e spiegare le scelte della mia amministrazione. Ogni opinione, naturalmente, è lecita; però dire che Expo sarà una colata di cemento, mentre l’eredità di Expo sarà un parco di quasi 50 ettari, uno dei più grandi d’Europa, non ha niente a che vedere con il legittimo dissenso. Parto anch’io dalla campagna elettorale per ricordare che nel programma della coalizione, voluto da tutti i partiti che mi sostenevano — da Prc a Sel al Pd — non c’era scritto da nessuna parte che Milano avrebbe abbandonato l’Expo.
Anzi, c’era scritto che si trattava di un appuntamento irrinunciabile. Certo, tutti, a cominciare da me, promettevano un Expo ben diversa da quella descritta nell’articolo di Guido Viale e questa promessa è stata mantenuta.
Expo non sarà semplicemente un’esposizione universale; sarà una vetrina di contenuti. Come a Kyoto si sono gettate le basi per combattere i cambiamenti climatici, a Milano in occasione di Expo, quando avremo qui 140 Paesi, getteremo le basi di una nuova e più sana politica alimentare che lotti contro la fame nel mondo, gli sprechi alimentari, l’accaparramento dei terreni agricoli dei paesi poveri, che sia per l’acqua bene comune, per la sostenibilità della catena alimentare.
Leggo equivoci anche sul dopo Expo. Su quelle aree – che non abbiamo scelto noi — non ci sarà nessuna speculazione edilizia o finanziaria. Il 54 per cento del sito sarà destinato a verde e la restante parte ad un grande progetto, scelto attraverso un bando trasparente e aperto a tutti, che abbia anche una utilità pubblica. Lascito di Expo sarà anche una storica e bellissima cascina milanese, la Cascina Triulza, ristrutturata dopo anni proprio per questa occasione. Sarà la sede del volontariato, della cooperazione internazionale, delle Ong, dell’associazionismo sociale. Un sede permanente, definitiva, che rimarrà anche dopo il 2015. E la Darsena, il vecchio porto di Milano, sarà riaperto dopo decenni di abbandono.
In momenti difficili come questi, confesso che non trovo per niente da snobbare nemmeno la possibilità di avere oltre 200 mila posti di lavoro. O gli effetti positivi sul Pil e sull’occupazione che continueranno fino al 2020, generati da un indotto che sarà di dieci miliardi di euro.
Comunque, anche per me, sono i contenuti l’aspetto più importante. E in questo abbiamo avuto fortuna: l’Expo, per una questione di reputazione internazionale, avremmo dovuto farla comunque, a meno di non fare davanti al mondo la figura di una repubblica delle banane, però farla sul tema della nutrizione ci consente di avere un peso su un tema fondamentale. E su questo, forse a Viale è sfuggito, stiamo lavorando con le migliori intelligenze, a partire proprio da Carlin Petrini che con Slow Food avrà un ruolo decisivo sui temi cardine dell’Esposizione.
Credo che Viale giudichi la città in base a degli stereotipi: vero che il Salone del Mobile è un momento magnifico. Ma, caro Guido, c’è anche altro: Book City riempie la città di eventi legati alla lettura e avresti dovuto essere con noi la settimana scorsa, quando il progetto Piano City ha acceso la città di oltre trecento concerti in ogni angolo di Milano. Tutte iniziative legate ad ‘Expo in città’. Avresti visto – e non è un’esagerazione – persone felici, come saranno felici le persone che lunedì saranno in Piazza Duomo per ascoltare gratuitamente la Filarmonica della Scala.
Diciamo che il modello–salone, nell’accezione di coinvolgere il maggior numero di persone possibili, di toccare con iniziative ogni zona della città, di fare cultura diffusa, è il nostro modello. E così sarà, naturalmente, per Expo, quando Milano sarà una città ancora più accogliente, allegra, aperta. Pronta a ricevere tante persone che arrivano da tutto il mondo, non certo per scambiare affari, ma per scambiare conoscenza e immaginare un futuro migliore per tutti.
Capisco che nessuno sia profeta in patria, però per uscire da un certo pessimismo cosmico, suggerisco di dare una scorsa ai giornali stranieri: ieri eravamo su Le Monde, apprezzati per avere vinto un premio importante dell’Ocse, primi tra tutte le città europee. Una sorta di ‘Oscar’ per quanto abbiamo fatto e stiamo facendo per la mobilità sostenibile. Siamo stati chiamati a far parte dei C-40, le città leader nelle politiche ambientali. Ci chiedono il know how per la raccolta differenziata visto che siamo insieme a Vienna al livello più alto tra le grandi città d’Europa. Insomma, non mi sembra affatto che abbiamo perso un’occasione. Piuttosto, l’occasione, abbiamo saputo coglierla, ora dobbiamo coltivarla insieme a tutte le forze sane del Paese. Altro che cemento…

«Expo e corruzione. Sfilarsi dal progetto, scegliere il modello "fuori salone", decidere di seguire l’idea di Petrini sulla trasformazione del parco agricolo di Milano. Invece ha vinto la colata di cemento.Il manifesto, 20 maggio 2014
Come per De Magistris, Zedda e Doria anche il sindaco Pisapia era stato eletto sull’onda di una mobilitazione straordinaria per partecipazione, entusiasmo, creatività. Pisapia doveva porre fine alle malefatte di Letizia Moratti. E tra quelle tante malefatte la peggiore è senz’altro l’Expò: un “Grade evento” fatto di “Grandi Opere” che non hanno alcuna giustificazione se non distribuire commesse, incassare tangenti e tenere in piedi un comitato di affari impregnato di corruzione e di mafia che aveva già devastato la città per anni. Si badi bene: le tangenti sono una conseguenza e non la causa.
Se ci fossero solo le tangenti, il territorio non ne riceverebbe danni irreparabili. Il vero danno sono le Grandi opere, la devastazione del territorio e delle relazioni sociali; e il modello di business di cui sono frutto, fondato sull’indifferenza per le esigenze delle comunità locali, sullo strapotere di banche e finanza, sul subappalto del subappalto, che apre le porte alle mafie, sul precariato (e ora anche sul lavoro gratuito) che hanno fatto dell’Expò il laboratorio dell’Italia di Renzi; e, ovviamente, anche sulla corruzione.
Avendo ereditato l’Expò dalla Moratti, Pisapia si era impegnato a renderla comunque meno pesante possibile. Ma ha tradito quel mandato. Non è in discussione la sua onestà, né la sua buona fede; lo sono le sue scelte. Appena insediato è stato trascinato a Parigi da Formigoni per sottoscrivere gli impegni con l’Ufficio Internazionale dell’Expò. Da allora l’Expò ha preso il posto dei progetti presentati in campagna elettorale, alcuni dei quali sanciti dalla vittoria di sei referendum cittadini (senza seguito). E con l’Expò ha cominciato a dissolversi quell’ondata di entusiasmo e di speranze che aveva portato Pisapia in Comune.
Oggi in città la partecipazione, che era stata la grande promessa di quella campagna elettorale, è a zero. E le forze che si erano impegnate per sostenerlo – e soprattutto i giovani, e tra i giovani i centri sociali — sembrano ormai orientate a non votare nemmeno più: per nessuno. E’ questo l’effetto peggiore di quel tradimento.Poteva andare diversamente? Certamente sì. Ma solo con un taglio netto nei confronti della cultura dominante: il pensiero unico; il refrain del “non c’è alternativa”.
L’osservanza dei vincoli di bilancio e del Patto di stabilità che strangola i Comuni per costringerli a svendere suolo, beni comuni e servizi pubblici locali; e a reprimere la partecipazione della cittadinanza. E tuttavia la Giunta non si è sentita le mani legate quando si è trattato di stanziare 480 milioni (ma forse molto di più, perché molte opere gravano su altre voci del bilancio) per fare l’Expò.
«Sarà un rilancio per l’economia per tutto il paese», ci hanno detto uno dopo l’altro Prodi, Berlusconi, Monti, Letta e Renzi. Ma c’è qualcuno che veramente ci crede? Gli ultimi Expò, con l’eccezione di Siviglia, sono stati un bagno di sangue per le città e i paesi che li hanno ospitati. «Sarà il rilancio dell’immagine dell’Italia nel mondo» ripetono. Sì, ma dell’Italia come il paese più corrotto dell’Ocse, e forse del mondo.
Lo si poteva capire dall’inizio. Due anni per negoziare l’organigramma senza nemmeno sapere che cosa fare veramente dell’Expò fanno capire a tutti qual era la posta in gioco. Adesso ci vogliono far credere che i manager al vertice dell’Expò erano ignari di tutto. Se davvero lo fossero, sono stupidi e incompetenti, e certo non meritano le centinaia di migliaia di euro del loro stipendio. Se non lo erano, com’è ovvio, non lo era neanche chi li ha messi lì.
Eppure Pisapia le alternative le aveva: quando si è insediato, bastavano 20 milioni di euro di penale (una “bazzecola” rispetto a quelli che ci costerà l’Expò) per sfilarsi dal progetto. Le ragioni per farlo non mancavano: nell’epoca di internet una esposizione universale è un’idea stupida; e da tempo le Expò sono bagni di sangue: si aspettano milioni di turisti straricchi dall’estero e poi bisogna fare appello alle visite scontate dei connazionali per risollevare un po’ i bilanci; d’altronde, “nutrire il pianeta” con una colata di cemento non è un’idea geniale o innovativa.
La seconda opzione era l’Expò diffuso (sul modello del “fuori salone” abbinato da anni alla fiera del mobile, che ha sempre molto successo). A Pisapia quel progetto glielo aveva messo in mano un gruppo di architetti, designer e urbanisti che ci lavorava da tempo (c’è anche una pubblicazione in proposito); sarebbe costato molto meno, non avrebbe comportato penali, e i soldi spesi sarebbero serviti per rendere più bella la città; ma più difficili e meno remunerative speculazione e corruzione.
La terza opzione era seguire i suggerimenti di Petrini: nutrire Milano per insegnare a nutrire il pianeta. Cioè promuovere la trasformazione del parco agricolo Sud Milano, il più grande d’Europa, in un giardino coltivato a frutta e ortaggi, per alimentare le mense gestite dal Comune (80.000 pasti al giorno); per promuovere una rete di Gas (gruppi di acquisto solidale, trasferendo a costo zero il know-how di chi un Gas lo sa fare, perché lo ha già fatto, a chi vorrebbe farlo e non sa da dove cominciare; magari con un pizzico di promozione); per insegnare a tutti a magiare meglio e a chi lavora la terra a trasformarla in vera ricchezza; e poi, portare i visitatori a vedere quel miracolo.
Invece si è scelto il cemento: per realizzare la cosiddetta “piastra” (un nome, un programma), cioè la sede espositiva dell’Expo, che all’inizio doveva essere un grande orto; localizzandola per di più, unico caso per tutte le Expò, su terreni privati da comprare a caro prezzo, per poi costruirci sopra tanti stand di cemento che dovranno poi essere demoliti. E si è scelto l’asfalto; perché per far arrivare i visitatori stranieri si è dato il via alla costruzione di tre autostrade periurbane, come se i milioni di visitatori cinesi, statunitensi e australiani attesi arrivassero in automobile da Brescia, Lodi o Varese. Naturalmente tutto in project-financing; ma in attesa dei soldi di privati e banche che non arriveranno mai, si è comunque provveduto a scassare il territorio in vari punti lungo le traiettorie di queste autostrade per mettere tutti di fronte al fatto compiuto: in qualche modo quei soldi dovranno saltare fuori, perché intanto il danno è fatto.
Dulcis in fundo, il progetto iniziale prevedeva un canale navigabile per farvi arrivare in barca i visitatori - le “vie d’acqua” - parallelo a un naviglio leonardesco, come segno di sfida tra “moderni” e “antichi”. Nel corso del tempo quel progetto si è trasformato in una fogna in cemento di due metri di larghezza, per far defluire le acque della fontana che ornerà la “piastra”. Poi si è deciso di interrarne una buona parte per far fronte alle proteste degli abitanti di alcuni quartieri. Ma il costo è rimasto immutato (80 milioni) e l’appaltatore pure (Maltauro, quello delle mazzette); anche se il progetto non sarà comunque pronto per l’Expo.
Poi c’è il “dopo”. Che fare di tutto quel cemento? Problema risolto: Formigoni e Maroni volevano farci le Olimpiadi. Ma Roma ha detto no. Pisapia ha ripiegato su uno stadio. Non che a Milano uno stadio, manchi. C’è; si chiama San Siro. Ma grazie a una legge approvata dal governo Monti oggi fare uno stadio vuol dire poter costruire alberghi, case, centri commerciali, parcheggi, discoteche e cinema multisala: cioè altro cemento. Finanziato dalle stesse banche che, per concedere i nuovi prestiti, prenderanno in garanzia, come fanno da tempo, i grattacieli vuoti già edificati con i prestiti precedenti, che quei costruttori, quasi tutti in bancarotta, non sono in grado di rimborsare.
Il problema vero che tutti i cittadini di Milano e d’Italia si pongono è invece questo: quante altre cose meravigliose si sarebbero potute fare con i miliardi dell’Expò? Ma è una domanda che a Pisapia non ha fatto nessuno.
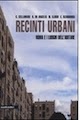 «Recinti urbani. Roma e i luoghi dell’abitare», è il titolo del libro di Carlo Cellamare, Roberto De Angelis, Massimo Ilardi ed Enzo Scandurra per manifestolibri. «Un territorio è dove si sta insieme tra esseri viventi e tra questi e la natura». Il manifesto, 20 maggio 2014
«Recinti urbani. Roma e i luoghi dell’abitare», è il titolo del libro di Carlo Cellamare, Roberto De Angelis, Massimo Ilardi ed Enzo Scandurra per manifestolibri. «Un territorio è dove si sta insieme tra esseri viventi e tra questi e la natura». Il manifesto, 20 maggio 2014
Esistono parole di cui tutti siamo convinti di conoscere alla perfezione il significato ma che poi scopriamo quanto, in realtà, siano estremamente difficili da definire. Accade così ad esempio con il termine «tempo», a proposito del quale Sant’Agostino diceva di sapere perfettamente cosa fosse, ma a spiegarlo, avrebbe trovato non poche difficoltà. È proprio a questo rimando agostiniano che si rifanno Carlo Cellamare, Roberto De Angelis, Massimo Ilardi ed Enzo Scandurra per affrontare il discorso su cosa sia un territorio, all’inizio della prefazione del loro Recinti urbani. Roma e i luoghi dell’abitare, uscito di recente per manifestolibri (Roma, pp. 126, euro 14). La risposta a tale quesito acquista un carattere dirimente e va oltre i confini del testo in questione. Gli autori, infatti, sono anche i curatori di una nuova collana, intitolata non a caso «Territori», di cui questo libro rappresenta la prima uscita. Il loro approccio alla questione, le riflessioni e le valutazioni espresse, le situazioni descritte ed analizzate, dunque, acquistano anche un valore programmatico, tendono a indicare, a iniziare a tracciare i percorsi possibili lungo i quali si inoltreranno anche i testi a venire. Il tutto non all’interno di una struttura chiusa e definita, ma al contrario in qualche maniera aperta, rizomatica quasi, in grado cioè di dare conto di punti di vista differenti, di analisi a più livelli, di approfondimenti multisettoriali.
Del resto, come affermano gli stessi autori, il problema della definizione della parola «territorio» più che risolto «può essere aggirato se partiamo dal presupposto che esso è il luogo in cui si co-abita, intesa questa come forma dello stare insieme tra esseri viventi e tra questi e la natura». E tale coabitazione, quasi mai pacifica, fa sì che «il territorio finisce per essere un luogo di conflitti permanenti», in cui vengono ad essere messi in gioco non soltanto valori e storie differenti, ma anche fattori quali l’emotività e l’affettività.
Tale concezione, che coinvolge dunque anche l’elemento culturale, quello simbolico, quello politico, emerge in questi saggi su di una città ricca di contraddizioni come Roma. E non è solo la diversa provenienza disciplinare degli autori – due urbanisti, un antropologo e un sociologo – né la diversità dei quartieri scelti come oggetto dell’indagine a garantire la molteplicità degli approcci e dei punti di vista, ma il metodo utilizzato, in grado di coniugare riflessione teorica, storia, narrazione ed esperienza vissuta.
Così, Enzo Scandurra nel suo Territorio come narrazione di forme di vita, partendo dalla concezione di territorio come suolo da sfruttare, problematicizza ulteriormente la sua definizione insistendo sul suo carattere di costruzione culturale e sul rapporto territorio-uomo-memoria.
Roberto De Angelis, invece, si concente su di una «periferia imperfetta», San Basilio, dove emerge in tutta la sua drammaticità «una caratteristica di fondo del caso italiano: la riproduzione della povertà attraverso le generazioni». Una narrazione ricca di dati, raffronti con altre situazioni come le banlieues parigine, ma soprattutto in cui si ritrovano le storie e le voci dei suoi abitanti, come quella di Nino il Sinto, da cui vengono fuori tutte le trasformazioni che hanno investito il quartiere.
Anche lo sguardo di Carlo Cellamare si appunta sulla periferia, concentrandosi però sulle diverse forme di autorganizzazione e autogestione con cui gli abitanti hanno cercato di affrontare i disagi legati al territorio, tentando di riappropriarsene. Il tutto alla luce di una questione fondamentale connessa al «fare città»: «Chi produce la città? Chi la costruisce?» in un’epoca in cui le forze economiche «hanno una preponderante capacità di orientare, condizionare e addirittura mettere al lavoro la città». Infine Massimo Ilardi, sulla scorta dei propri ricordi, racconta le trasformazioni profonde che hanno investito, a partire dagli anni Cinquanta, quella che lui stesso definisce «una periferia al centro della città», ovvero Trastevere, quartiere simbolo che da sempre incarnava l’anima più profonda di Roma.
Il Fatto Quotidiano, 20 maggio 2014
La riforma della P.A. annunciata dal premier Matteo Renzi e dalla ministra Marianna Madia prevede di superare i “blocchi” dei pareri paesistici e delle Soprintendenze (“dobbiamo ridurre i casi in cui il parere serve”, ha detto Renzi). La filosofia sottostante è quella espressa da Giovanni Valentini su Repubblica: le soprintendenze “troppo spesso” sarebbero “di freno e ostacolo allo sviluppo”. Galoppando su questa linea, che si potrebbe chiamare delle mani (libere) sul territorio, alcuni senatori del Partito Democratico hanno usato la legge di conversione del cosiddetto Decreto Casa (sarà approvata definitivamente oggi, dopo che ieri la Camera ha detto sì alla questione di fiducia del governo) per imbucare un articolo che allarga la possibilità - già concessa dal lettiano decreto del Fare - di installare ovunque “case mobili” senza chiedere alcun permesso di costruire.
Così le piazzole per tende dei campeggi di tutta Italia potrebbero trasformarsi per incanto in altrettante schiere di casette e bungalow: e, chissà, un domani potrebbero mettere radici e trasformarsi in vere case di vero cemento. Molte recenti sentenze dei Tar, del Consiglio di Stato e della Cassazione hanno invece ribadito che se questi insediamenti sono permanenti (per esempio attraverso l’allaccio alle reti idriche, energetiche e fognarie ), essi incidono sul territorio e dunque devono passare attraverso tutti i vagli di legge. Al contrario, l’emendamento del Pd permette di fare esattamente quel che sognano Renzi e Madia, e cioè aggirare piani regolatori, piani paesaggistici e vincoli e costruire ovunque: perfino nei parchi nazionali o in aree archeologiche. Un parere dell’Ufficio legislativo del Mibac ha cercato di circoscrivere le nefaste conseguenze di questo punto del decreto del Fare, chiarendo che le autorizzazioni paesaggistiche non possono essere omesse: ma si tratta pur sempre solo di un parere, e questa nuova riscrittura della legge rischia di aprire un grosso varco. Un varco alla costruzione di strutture ufficialmente mobili, è vero: ma la storia italiana insegna che non c’è niente di più stabile dell’effimero. E le nostre pinete e le nostre coste non hanno certo bisogno di un’ondata di urbanizzazione selvaggia.
Il simpatico grimaldello distruggi-paesaggio, introdotto in Senato, da oggi sarà legge grazie alla scelta del governo di includerlo nel pacchetto sottoposto a duplice voto di fiducia, che rende nere tutte le vacche nella notte della democrazia. I promotori sono stati quattro senatori pd: Stefano Collina, primo firmatario, eletto in Emilia Romagna, Mario Morgoni, eletto nelle Marche, Andrea Marcucci e Manuela Granaiola, entrambi eletti in Toscana ed entrambi firmatari nel novembre scorso di un emendamento che aveva l’obiettivo di vendere ai proprietari degli stabilimenti balneari le spiagge demaniali che hanno in concessione per “contribuire al risanamento dei conti pubblici”. Un provvedimento che hanno poi dovuto ritirare, sommersi dall’onda di sdegno suscitata da un’idea di svendita dei beni comuni tanto intimamente berlusconiana.
È da notare che Marcucci (già Pli, già Lista Dini, già Margherita, ora renziano di ferro) è stato sottosegretario ai Beni culturali (e dunque anche al paesaggio) ed è ora nientemeno che presidente della commissione Cultura del Senato. Difficile liquidare questa uscita come l’iniziativa estemporanea del primo che passa: è invece un segno del fatto che la “Svolta buona” di Renzi rischia di avere un inconfondibile color cemento. E c’è da chiedersi se non sia proprio a causa di questo orientamento “maniliberista” del senatore Marcucci se la commissione del ministero per i Beni culturali (presieduta da Salvatore Settis, che certo ha un altro orientamento) che dovrebbe revisionare il Codice dei Beni culturali e del paesaggio non sia ancora riuscita, dopo nove mesi dalla nomina, ad avere la delega dal Parlamento.
Il caso è stato sollevato pubblicamente dal consigliere nazionale di Italia Nostra Emanuele Montini, e inutilmente nelle ultime ore il blog Carteinregola (che riunisce centotrenta associazioni e comitati romani) ha scritto ad ogni deputato “sperando che qualche politico di buon senso, come è già successo per la privatizzazione delle spiagge,faccia sentire la voce dei cittadini più forte di quella delle lobbies”.
Antonio Cederna non si stancava di ripetere che bisogna stare attenti “perché sennò ci strappano il territorio da sotto i piedi, perché l’Italia è il Paese più provvisorio che ci sia”. È ancora così. Il Paese è terribilmente provvisorio, ma le case provvisorie di cui Marcucci & c. vorrebbero coprirlo rischiano, invece, di essere eterne.
Riferimenti
Sull'argomento vedi su eddyburg gli articoli di Annamaria Bianchi e, dal manifesto, di Paolo Berdini.

L'accaparramento dei beni comuni essenziali, dall'acqua alla terra, è una terribile realtà in tutto il mondo. Un'analisi e la proposta dei principi essenziali da assumere al più presto. Pressenza, International Press agency, 17 maggio 2014 (i.b.)
Intervento di Maude Barlow, presidente di Council of Canadians e Food & Water Watch nella sessione “A caccia di risorse. Gli effetti dell’accaparramento e il ruolo dell’Europa”, nell’ambito del Convegno Internazionale “Un futuro giusto o giusto un futuro? Ambiente, consumo e sviluppo: istruzioni per l’uso” avvenuto a Milano il 9 e 10 maggio 2014. Evento organizzato da Mani Tese in occasione del loro 50 esimo anniversario. Pubblicato su: http://www.pressenza.com/
In un mondo che sta esaurendo l’accesso all’acqua, la questione del controllo incombe. L’acqua è un diritto umano, un bene pubblico e un patrimonio comune o un prodotto da mettere sul mercato come il petrolio e il gas?
L’accaparramento dell’acqua
La paura della scarsità di cibo per il futuro ha portato paesi ricchi, investitori internazionali e operatori di commodities ad accaparrarsi grandi quantità di terra nel sud del mondo per sfamare le loro popolazioni o come investimenti speculativi. Un’area pari a quasi tre volte la dimensione del Regno Unito è stata “accaparrata” a prezzi stracciati. Gli investitori stanno facendo affari incredibili: alcuni affittano enormi pezzi di terreno per 99 anni pagando non più di 40 centesimi all’acro all’anno.
Oltre un quinto dell’area della Cambogia è stato concesso a interessi privati, spostando quasi mezzo milione di persone. L’Etiopia è uno dei paesi con il più alto livello di fame al mondo, eppure il suo governo sta offrendo enormi distese dei suoi terreni più fertili a speculatori per coltivare cibo da esportare.
Chi si accaparra terreni si appropria anche dell’acqua, poiché gli investitori hanno bisogno di garantirsi l’accesso all’acqua per quelle che sono essenzialmente colture da esportazione, devastando i bacini idrici locali. Non solo questi grandi agro-investitori scelgono il terreno migliore per le loro colture, ma bloccano anche il diritto di accesso a ruscelli, fiumi e falde idriche locali. Un numero allarmante di paesi sta cedendo i propri diritti all’acqua per i decenni a venire, la maggior parte a prezzi stracciati.
La quantità d’acqua necessaria in Africa per coltivare un terreno acquisito nel 2009 è da sola due volte il volume d’acqua usato per l’agricoltura in tutta l’Africa appena quattro anni prima. Se l’accaparramento delle terre continua al ritmo attuale, in cinque anni la richiesta di acqua fresca supererà le scorte di acqua rinnovabile in Africa. Alcuni lo definiscono “suicidio idrologico”.
L’acqua è anche la causa di altri spostamenti forzati. Alta tecnologia ad alta intensità di capitale e “zone economiche libere” su larga scala costringono ogni anno 15 milioni di persone a spostarsi. Inoltre terreni agricoli, zone di pesca, foreste e villaggi vengono convertiti in serbatoi, sistemi di irrigazione, miniere, piantagioni, autostrade, insediamenti urbani, complessi industriali e resort turistici. In questo modo e con l’autorizzazione dei governi, gli interessi privati assumono il controllo dell’acqua che un tempo sosteneva intere popolazioni.
L’acqua viene “accaparrata” e mercificata anche in altri modi. L’interesse delle aziende per le fonti mondiali di acqua pulita, ormai in via di esaurimento, è andato crescendo per tre decenni, ma è aumentato in modo vertiginoso negli ultimi anni. Le multinazionali considerano l’acqua un prodotto vendibile e negoziabile, non un patrimonio comune o un bene pubblico e sono decise a creare un cartello somigliante a quello che oggi controlla ogni aspetto dell’energia, dalla ricerca, alla produzione fino alla distribuzione.
Molti paesi poveri sono stati costretti a stipulare contratti sui servizi idrici con utenze private a scopo di lucro, una pratica che ha generato un’accanita resistenza da parte dei milioni di persone escluse a causa della povertà. Ora sotto la maschera dell’austerity anche l’Unione Europea sta promuovendo servizi per l’acqua privata e di scarico.
Altre lotte sono dirette contro le compagnie dell’acqua in bottiglia, che prosciugano grandi quantità di acqua dai bacini idrici locali per venderla. Alcuni paesi, come il Cile, vendono all’asta l’acqua non purificata di laghi e fiumi a interessi globali come le società minerarie, che oggi posseggono letteralmente l’acqua che prima apparteneva a tutti. Le aziende private controllano enormi quantità di acqua usata nell’agricoltura industriale, nell’industria mineraria e nella produzione di energia e possiedono la maggior parte delle dighe, dei canali, degli impianti di dissalazione e delle infrastrutture urbane del mondo.
Molti paesi, tra cui l’Australia, il Cile, gli Stati Uniti e la Spagna, hanno introdotto i mercati idrici e il commercio d’acqua; una licenza diventa così una proprietà privata e investitori privati e imprese del settore agro- industriale accumulano, comprano, vendono e commerciano acqua non purificata nel mercato, destinandolo a chi può permettersi di comprarla. In ognuno di questi casi, l’acqua diventa proprietà privata di chi ha i mezzi per comprarla e viene negata a chi non li ha.
Neanche i governi possono competere con il mercato. Quando il commercio dell’acqua è stato introdotto in Australia, gli investitori privati e i broker hanno portato il suo prezzo alle stelle. Quando il governo australiano ha provato a ricomprare l’acqua che aveva dato via gratis per salvare dal prosciugamento il fiume Murray-Darling non ha più potuto permetterselo.
Impatti sulle comunità locali e sull’ambiente
L’impatto di questo saccheggio d’acqua sulle comunità locali e sul loro ambiente è stato devastante. Piccoli agricoltori e popolazioni indigene sono stati scacciati a milioni per far spazio all’accaparramento delle terre, ora usate per coltivazioni destinate all’esportazione; le comunità locali si ritrovano così sempre più affamate e prive d’acqua.
Inoltre l’agricoltura locale, sostenibile e basata sulla biodiversità, viene ormai sostituita dai peggiori esempi di imprese agro-industriali, complete di inquinamento idrico per l’uso di prodotti chimici, sovra-estrazione di acqua sotterranea e irrigazione superficiale. Coloro che vengono scacciati dalle terre sono proprio quelli che sanno praticare l’aridocoltura e la rotazione delle colture per proteggere le fonti d’acqua e convivere con le oscillazioni di siccità e inondazioni che caratterizzano la maggior parte del mondo.
Questi contadini si uniscono ad altri sfollati climatici e comunità costrette ad abbandonare la loro terra per fare spazio a zone di libero scambio, mega-dighe, mega-progetti e siti industriali ed emigrano nelle baraccopoli che circondano le città dei paesi in via di sviluppo. Là molti di loro non hanno accesso all’acqua pulita o ai servizi igienici, perché questi slum non sono formalmente riconosciuti, o perché il prezzo dell’acqua, spesso privatizzata, è fuori dalla loro portata.
Conoscete le tremende statistiche: le malattie dovute all’acqua uccidono più bambini di tutte le forme di violenza messe insieme, inclusa la guerra. L’ONU ci assicura che sta chiudendo il divario dell’accesso all’acqua, ma io ho i miei dubbi. Per valutare gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio riguardo all’acqua, calcola il numero di nuove condutture installate in un paese, ma non è detto che da una tubatura esca acqua pulita. Una conduttura potrebbe anche essere molto lontana o misurata, mettendola fuori dalla portata dei poveri.
Personalmente credo che la diminuzione dei rifornimenti mondiali d’acqua a causa dell’inquinamento, della cattiva amministrazione e dello spostamento dell’acqua dai bacini idrici stia portando a una crisi di enormi proporzioni. Secondo UN Habitat entro il 2030 più della metà della popolazione dei grandi centri urbani abiterà in baraccopoli senza accesso all’acqua o ai servizi igienici.
Non bisogna credere che questi abusi siano relegati al sud del mondo; è importante sapere che si profilano anche per il nord. Oltre 90.000 poveri di Detroit (Michigan) si sono visti tagliare l’acqua perché non potevano pagarla e molte altre migliaia subiranno presto la stessa sorte. In Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo altre migliaia di persone hanno perso l’accesso all’acqua e sono state sfrattate.
Chi sta guidando l’accaparramento dell’acqua?
Nessuna di queste violazioni dei diritti umani e ambientali doveva accadere. Una buona politica pubblica e una vera cooperazione internazionale poteva evitare tutto questo. Ma negli ultimi decenni la maggior parte dei governi e delle istituzioni internazionali ha adottato un modello economico che favorisce la crescita illimitata del mercato, riducendo in modo drammatico i poteri del governo, la de-regulation delle finanze e delle risorse, il cosiddetto “libero” scambio al di là dei confini e il crescente potere delle imprese.
Sostenuta dall’Unione Europea e dalle banche europee, la Banca Mondiale continua a promuovere la privatizzazione dei servizi idrici nel sud del mondo, nonostante molti di questi accordi siano stati un completo fallimento. Inoltre il finanziamento di questi servizi va ormai direttamente a imprese come Suez e Veolia, aggirando i governi e adesso la Banca Mondiale sta investendo nelle compagnie stesse.
La Società finanziaria internazionale, un’agenzia della Banca Mondiale, inoltre finanzia in modo cospicuo il settore agro-alimentare nel sud del mondo e asserisce che l’alto costo del cibo offre ai paesi poveri opportunità uniche per giovarsi dello stesso accaparramento delle terre che li sta distruggendo. La Banca Mondiale lavora addirittura con i governi dei paesi poveri per cambiare la legislazione in modo da aumentare la quantità di terra che uno straniero può possedere e ha persino una “classifica del business” che favorisce i governi che rendono la vita più facile agli investitori decisi ad accaparrarsi le terre.
Un’altra tendenza inquietante è la privatizzazione degli aiuti esteri. Un ammontare crescente di aiuti pubblici viene trasferito non ai governi, ma al settore privato, dando alle aziende maggiore potere per determinare le politiche locali. Un rapporto dell’European Network of Debt and Development ha scoperto che nell’ultimo decennio la maggior parte degli aiuti della Banca Mondiale e della Banca europea degli investimenti sono finiti in paradisi fiscali e aziende con sede nel nord del mondo, soprattutto banche commerciali, fondi speculativi e fondi di private equity.
Alcuni governi – come quello del mio paese, il Canada – finanziano solo agenzie umanitarie disposte a collaborare con gli obiettivi delle imprese che fanno affari con il paese designato. In America Latina gli attivisti dell’acqua che si oppongono alla distruzione delle risorse idriche locali per mano delle compagnie minerarie canadesi non possono più chiedere aiuto alle agenzie umanitarie del paese.
Come gli aiuti sono privatizzati, così i gruppi umanitari locali sono politicizzati. Gli attivisti africani per la giustizia dell’acqua segnalano che solo i gruppi a favore della privatizzazione e delle appropriazioni dei terreni sono finanziati per il loro lavoro.
La nuova generazione di accordi commerciali e sugli investimenti è un altro enorme ostacolo al diritto umano all’acqua. Questi accordi non hanno niente a che fare con la riduzione delle tariffe e l’apertura dei commerci e riguardano invece la totale limitazione del potere dei governi di proteggere i diritti della popolazione, le loro risorse e il loro ambiente.
Questa nuova generazione di accordi commerciali, come il Comprehensive Economic and Trade Agreement (Accordo economico e commerciale globale – CETA) tra Canada e Unione Europea e il Transatlantic and Investment Partnership (Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti – TTIP) tra Unione Europea e USA, stabiliscono clausole investitore-stato che danno alle aziende straniere il diritto di citare in giudizio i governi se ritengono che il loro “diritto al profitto” sia colpito da leggi e regolamentazioni interne.
In Canada abbiamo convissuto con questo orribile potere corporativo per vent’anni e questo ha avuto un impatto assolutamente negativo sulla capacità di proteggere in modo reale la nostra acqua dalle società americane. Con il CETA, sarà più difficile mantenere l’acqua pubblica. Suez e Veolia non vedono l’ora.
Esistono oggi quasi 3.000 accordi bilaterali nel mondo, molti dei quali prevedono il diritto delle aziende a far causa direttamente ai governi per un risarcimento se i loro profitti sono influenzati da leggi e pratiche nazionali. Immaginate l’impatto di questi accordi sui paesi poveri che cercano di proteggere i loro rifornimenti d’acqua dal saccheggio straniero.
È importante sottolineare che i trattati investitori-stato danno diritto agli accaparratori stranieri di terre e acqua non solo al raccolto che stanno coltivando, ma anche alla terra e all’acqua usate per produrlo.
Qui non si tratta solo di speculazione. Nel 2010 il governo canadese ha pagato 130 milioni di dollari a una compagnia americana di cellulosa e carta che aveva abbandonato il suo stabilimento di Terranova, lasciando i dipendenti senza lavoro e pensione. La compagnia ha fatto causa al governo grazie alla disposizione investitore-stato del North American Free Trade Agreement, sostenendo che l’acqua che aveva usato per decenni le apparteneva. E’stato così stabilito un pericoloso precedente, che si potrebbe ripetere altrove.
Con queste regole, se un paese che oggi permette l’accaparramento di terre e acqua decidesse di riprendere il controllo di queste risorse, dovrà prepararsi all’eventualità di pagare enormi risarcimenti per il basilare diritto di auto-governarsi.
Il rapporto investitore-stato ha suscitato di recente una grande preoccupazione in Europa, ma purtroppo, nonostante sia in corso una consultazione pubblica al riguardo, il Parlamento Europeo ha concordato un inquadramento per la gestione delle conseguenze finanziarie di questo regalo alle imprese, invece di respingerlo in modo definitivo.
Cosa possiamo fare per impedire l’accaparramento dell’acqua e realizzare il diritto all’acqua?
La globalizzazione economica, con la sua enfasi sulla crescita ad ogni costo, il suo servilismo verso l’1%, la sua sistematica riduzione dei beni comuni, il suo rafforzamento dei diritti aziendali nella legislazione internazionale e la cacciata dei custodi locali di terra e acqua costituisce una ricetta infallibile per arrivare a una crisi idrica.
Se si vuole avere qualche speranza di successo, la soluzione alla crisi idrica globale deve includere una rinuncia a questo modello di crescita. I paradisi fiscali vanno chiusi e lo stato di diritto deve prevalere sul capitale transnazionale.
Il commercio deve essere riformato radicalmente per servire un diverso insieme di obiettivi e giungere a un controllo democratico. Le aziende devono perdere il diritto di fare causa ai governi. Gli accordi investitore-stato vanno vietati dovunque, come è successo in Australia, Brasile e Bolivia. Inoltre ogni riferimento all’acqua come bene negoziabile, servizio o investimento va rimosso dagli accordi commerciali. Gli interessi delle aziende e del mercato non devono essere in alcun modo usati per ostacolare la protezione locale e internazionale dell’acqua.
L’accaparramento delle terre e dell’acqua deve finire. Abbiamo bisogno di una moratoria internazionale sulle acquisizioni su larga scala e le terre razziate devono essere restituite. La vera sicurezza alimentare in Africa e in ogni altro luogo verrà da una genuina riforma agraria e idrica e dall’orientamento degli investimenti pubblici verso l’agricoltura di comunità o familiare.
Una nuova etica dell’acqua
Entro il 2030 la nostra domanda globale di acqua supererà le risorse del 40%, una ricetta infallibile per produrre una grande sofferenza. Cinquecento scienziati hanno di recente informato il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon che l’abuso collettivo di acqua ha fatto sì che il pianeta entrasse in “una nuova era geologica” . La maggior parte della popolazione del pianeta vive in un raggio di 50 chilometri da una fonte di acqua di scarsa qualità.
Se il pianeta e noi stessi vogliamo sopravvivere, abbiamo bisogno di una nuova etica, che ponga l’acqua e la sua tutela al centro di tutte le politiche e pratiche.
Questa nuova etica dell’acqua dovrebbe basarsi su quattro principi.
Il primo è che l’acqua è un diritto umano e deve essere divisa equamente. Nel 2010 l’Assemblea Generale dell’ONU ha formalmente riconosciuto il diritto umano all’acqua e ai servizi igienici. Poco dopo il Consiglio per i Diritti Umani ne ha precisato il significato. Mentre la risoluzione taceva sulla questione della proprietà dell’acqua, il Consiglio ha chiarito che questo nuovo diritto è vincolante per i governi e stabilisce i loro obblighi e responsabilità nel metterlo in pratica.
Non solo adesso tutti i governi hanno la responsabilità di impostare un piano per distribuire acqua sicura, conveniente e pulita ai propri cittadini, ma devono anche impedire a terzi di interferire con questo nuovo diritto. Aziende come le imprese agro-alimentari che si appropriano di terreni e acqua e inquinano o prosciugano fonti idriche locali possono essere accusate di violare il diritto umano all’acqua. Questo fornisce un importante strumento alle comunità locali di tutto il mondo nelle lotte contro le miniere, le dighe e l’estrazione dell’energia.
Il secondo principio sostiene che l’acqua è un patrimonio comune dell’umanità e delle generazioni future e va protetta come un bene pubblico dalla legge e nella pratica. L’acqua non deve mai essere comprata, venduta, tesaurizzata o scambiata come merce sul libero mercato e i governi devono mantenerla come bene comune, non per il profitto privato. Le imprese possono aiutare a trovare soluzioni alla crisi idrica, ma non dovrebbero avere la possibilità di decidere l’accesso a questo essenziale servizio di base, poiché la loro ricerca di profitto prevarrà sempre sul bene pubblico.
Secondo il terzo principio, l’acqua ha dei diritti anche al di fuori della sua utilità per gli esseri umani. Appartiene alla Terra e alle altre specie. La nostra credenza nella “crescita illimitata” e il nostro modo di trattarla come uno strumento per lo sviluppo industriale ha messo in pericolo i bacini idrografici della Terra. L’acqua non è una risorsa per la nostra convenienza e il nostro profitto, ma costituisce l’elemento essenziale di un ecosistema vivente. Dobbiamo adattare le nostre leggi e pratiche per assicurare la protezione dell’acqua e il ripristino dei bacini idrici – un antidoto cruciale al riscaldamento globale.
Infine credo fortemente che l’acqua ci possa insegnare come vivere insieme, se solo glielo permettiamo. Possono scoppiare guerre per l’acqua in un mondo con una domanda crescente e forniture sempre più scarse, ma così come può essere fonte di dispute, conflitti e violenze, l’acqua può anche unire persone, comunità e nazioni in una ricerca comune di soluzioni.
La tutela dell’acqua richiederà vie più collaborative e sostenibili per l’agricoltura, per la produzione d’energia e per i commerci internazionali e avrà anche bisogno di un potente controllo democratico. La mia più profonda speranza è che l’acqua possa diventare un dono della natura all’umanità e insegnarci come vivere più leggermente sulla terra, in pace e nel reciproco rispetto.
Come ha detto Eleanor Roosevelt: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei loro sogni”. Bene, io credo nella bellezza di questo sogno: credo che la crisi idrica globale diventerà la spinta per la pace nel mondo, che tutta l’umanità capirà che l’acqua è la fonte della vita e si inchinerà alla necessità di proteggere e di ripristinare i bacini idrici e che grazie al nostro lavoro comune i popoli del mondo dichiareranno che le sacre acque della vita sono un diritto umano e una proprietà comune della Terra e di tutte le specie, da preservare per le generazioni a venire.
In un quartiere simbolo una vicenda emblematica di nuovi possibili atteggiamenti ed equilibri fra città e natura. Corriere della Sera Milano, 17 maggio 2014, postilla (f.b.)
C’è una nutria che vive nel laghetto di Milano 2. Nuota insieme alle anatre selvatiche, pascola nel prato dove si riscalda al sole e assaggia le margherite. «È socievole, non dà fastidio e non fa danni», dicono alcuni residenti, che hanno chiesto alla Polizia provinciale di poterla sterilizzare e mantenere nello specchio d’acqua. Invece, è scattata l’operazione di cattura, «nell’ambito del piano di contenimento delle nutrie». Nel laghetto sono state posizionate due grosse gabbie. Ed ecco lo scontro. Nei giorni scorsi una abitante, scrive la Polizia provinciale, «è stata colta in flagrante mentre liberava la nutria dalla gabbia, indagata e denunciata per sabotaggio e interruzione di pubblico servizio». E l’assessore alla Sicurezza Bolognini aggiunge: «Per quanto si cerchino di comprendere le posizioni degli ambientalisti, è irragionevole che venga ostacolato il lavoro dei nostri agenti, costretti a svolgere servizio di appostamento di notte per evitare che venga vanificata un’operazione finalizzata a salvaguardare la comunità da una specie dannosa per l’ambiente». La donna nega: «Le gabbie non avevano contrassegni istituzionali, avrebbero potuto danneggiare la fauna del laghetto. Sterilizzino la nutria e la riportino qui».
Forse salta abbastanza all'occhio, o forse no, sino a qual punto stia cambiando non solo il rapporto fra città e natura, ma l'atteggiamento dei cittadini rispetto a questo cambiamento. C'è da un lato la nutria, animale considerato infestante per i danni agli argini e l'enorme potenzialità riproduttiva tipica dei roditori, e dall'altro gli abitanti di un quartiere che ne hanno non solo adottata una, ma paiono ben consapevoli della necessità di cercare una specie di “terza via” fra il classico equilibrio città-campagna e le forme tradizionali di gestione del territorio. Che, provano a spiegare loro le autorità locali, prevedono l'eliminazione fisica dei soggetti devianti. Era successo qualcosa del genere anche con l'oasi naturale cresciuta nel vecchio cantiere abbandonato alla Darsena di Milano, ma forse lì il tema appariva troppo complesso. Qui ci sono un grosso simpatico topone, dei cittadini che cercano di capire, e dei funzionari che applicano regole. La domanda suona: non sarebbe forse il caso di porre l'enfasi sull'obiettivo (l'equilibrio città campagna) anziché sulla lettera burocratica delle regole, senza per questo cedere ai particolarismi e a una specie di rischiosa deregulation ideologica?
«In un viaggio da Nord a Sud Italia le nuove stazioni ferroviarie. Spesso progettate da archistar, ma funzionalità e utilità suscitano più di un dubbio. Mentre mancano del tutto controlli e sanzioni per eventuali costi impropri. Cosa farà l’Autorità dei trasporti?». Lavoce.info, 16 maggio 2014 (m.p.r.)
Il fenomeno del gold plating. Il fenomeno noto in linguaggio regolatorio come gold plating ha origini nella prima esperienza americana di regolazione economica dei monopoli naturali negli anni Trenta: quel regolatore aveva posto limiti al saggio di interesse sul capitale investito tramite il controllo delle tariffe (Rate of Return Regulation), si era generato così un ovvio incentivo a investimenti inutili, o inutilmente costosi, visto che il dispositivo ne garantiva la remunerazione. Da qui il nome.
Ma ovviamente l’incentivo a un uso inefficiente delle risorse si genera anche nel caso di finanziamenti pubblici per investimenti fatti sostanzialmente “in solido”, situazione che si verifica in Italia per le Ferrovie dello Stato. Non sembra infatti che sia in atto alcun controllo “terzo” ex-ante, né alcuna sanzione ex-post per costi impropri delle opere, se non forse per un’unica audizione parlamentare sui costi straordinariamente elevati delle infrastrutture per l’alta velocità, conclusa con la molto generica costatazione della “eccezionalità del caso italiano” rispetto agli altri paesi europei.
Ora, che il problema abbia dimensioni potenzialmente estese risulta anche da una semplice osservazione sulle stazioni Fs più recenti, fatta in termini intuitivi, mancando ogni contabilità accessibile sui costi e i ricavi aggiuntivi che quelle opere generano (una contabilità che qualsiasi privato terrebbe con estrema cura). Che poi motivazioni artistiche o “mecenatistiche” possano giustificare spesa pubblica a fondo perduto non sembra un argomento molto convincente, data l’autoreferenzialità della situazione e la totale assenza di verifiche contabili: per esempio, quanta spesa in più di quella necessaria viene giustificata con motivazioni artistiche? E d’altra parte anche l’esperienza diretta in valutazioni di questo tipo fatte all’estero da chi scrive conferma la fattibilità e l’opportunità dell’analisi per gli investimenti pubblici. (1) Anche perché le società “Grandistazioni” e “Centostazioni” hanno obiettivi unicamente legati alla massimizzazione dei ricavi, non alla remunerazione delle risorse pubbliche impiegate.
Un viaggio in Italia. Il primo caso che prendiamo in considerazione è la stazione centrale di Milano, rifatta integralmente con materiali pregiati e un sistema di rampe molto impegnativo e complesso. Ora accedere ai binari dalla metropolitana è molto meno diretto di prima, e questo grave disagio (si pensi a persone in ritardo e con bagagli) è chiaramente pensato in modo da “costringere” i viaggiatori a percorrere vaste aree commerciali. Potremmo classificare questo caso come “discutibile induzione alla spesa”. È un modo sensato e accettabile di spendere i denari pubblici, anche nell’ipotetico ma improbabile caso che i ricavi aggiuntivi ripagassero l’investimento pubblico con un ritorno accettabile?
Proseguendo verso Sud, incontriamo la stazione di Reggio Emilia, progettata dall’archistar Santiago Calatrava e da alcuni maligni denominata lo “scheletro di dinosauro”. Al di là di soggettive valutazioni estetiche, era necessario convocare una celebrità (con i del tutto probabili costi relativi) per una stazione che in realtà è una semplice fermata in un’area in aperta campagna, dove sostano pochi treni al giorno? Qualche dubbio è legittimo. Potremmo classificare questa categoria come “discutibile pregio architettonico”.
La vicenda delle stazioni alta velocità che incontriamo più a Sud, quelle di Bologna e di Firenze, ha una storia peculiare. Tutto parte dalle preoccupazioni per il possibile inquinamento acustico che i treni veloci diretti avrebbero potuto generare transitando a piena velocità attraverso Bologna. L’amministrazione, invece di valutare la possibilità di schermature antiacustiche integrali alla linea, pretese una stazione sotterranea, decuplicando i costi. L’amministrazione di Firenze ritenne di non poter essere da meno di quella bolognese e richiese anch’essa una stazione sotterranea, per motivi analoghi.
Ora, la nuova stazione di Bologna ha senza dubbio un ruolo importante, ma si dispiega su una profondità di circa cinque piani interrati, con un volume interno straordinario (ricorda una cattedrale). I tempi e le complessità logistiche da superare per risalire dal livello dell’alta velocità alla superficie e ai treni locali sono altrettanto straordinari, e suscitano forti perplessità sulla razionalità dei costi di una soluzione così scarsamente funzionale per le coincidenze, una delle massime esigenze delle stazioni di interscambio.
Ma il caso più eclatante è quello della costruenda nuova stazione sotterranea di Firenze, progettata da un’altra archistar, l’inglese Norman Foster. Sul piano funzionale, si suppone che una stazione sotterranea si costruisca per accelerare i treni in transito e per ottimizzare l’interscambio con i treni locali. Ma non è così: la linea sotterranea percorre un tracciato tutt’altro che rettilineo e la risalita verso i treni locali è complessa, con una lunga rampa obliqua e una tratta ulteriore in orizzontale. Per quanto concerne i costi, poi, si possono stimare quadrupli di quelli di una soluzione a raso, ma in questo caso sarebbero stati ancora più alti: per raccordarsi con la soluzione sotterranea è stato modificato, sembra, lo sbocco in pianura della tratta alta velocità Bologna-Firenze, con una decina di chilometri supplementari in galleria e con costi aggiuntivi (parametrizzando sui costi dell’intera tratta) dell’ordine di molte centinaia di milioni. Potremmo classificare il caso di queste due stazioni come “gigantismo progettuale”.
Proseguendo verso Sud, nulla si può dire invece della funzionalità della nuova stazione “a ponte” di Roma Tiburtina, anche questa firmata da un’archistar (Zaha Hadid). La sensazione qui è di semplice gold plating, per i materiali e le dimensioni complessive, mentre gli sconfinati spazi commerciali la fanno rientrare nella tipologia della “discutibile induzione alla spesa”.
Rimanendo a Roma, possiamo ricordare un altro episodio celebre di gold plating, seppure accaduto più lontano nel tempo: la stazione Ostiense. Doveva essere il terminale urbano per i treni diretti all’aeroporto di Fiumicino. Già l’idea appariva insensata: perché non far proseguire semplicemente la metropolitana urbana per Fiumicino, visto che non esistevano problemi di scartamento né di alimentazione, che oltretutto avrebbe evitato ai viaggiatori uno scomodissimo interscambio? Sembra per semplici ragioni di gestione di risorse pubbliche afferenti a due amministrazioni diverse (nella più benevola della ipotesi). Comunque la scomodità della soluzione era tale che il (monumentale e, si suppone, costosissimo) terminal fu presto abbandonato e divenne per dieci anni rifugio per senzatetto. Nessuno ovviamente ha mai risposto dello straordinario spreco di risorse pubbliche che l’operazione ha comportato. Il livello di disfunzionalità di questo caso lo rende difficilmente classificabile.
Certo, questo è un “processo indiziario”, in cui prevalgono considerazioni qualitative, che per definizione risultano fragili e opinabili. Ma proprio questo è il problema: dati gli incentivi a massimizzare la spesa, incentivi condizionati politicamente sia dai costruttori che dalle amministrazioni locali (il residual claimant pubblico si è sempre dimostrato molto disponibile), è urgente una rendicontazione regolatoria e dettagliata, che sgombri il campo da ogni sospetto di gold plating. E questo vale ovviamente per tutte le infrastrutture regolate: la casistica infatti potrebbe ampliarsi molto. Finora, a questo tipo di fenomeni nel panorama italiano non è stata data alcuna attenzione, ma la recente costituzione dell’autorità regolatoria indipendente per il settore trasporti fa sperare (obbliga a sperare) in un radicale cambio di scenario.
(1) È il caso della verifica costi-benefici di una stazione di autobus a Montevideo, opera candidata al finanziamento da parte della Banca Mondiale.
Stasera la banca d’affari newyorchese Morgan Stanley accoglierà i suoi danarosissimi ospiti per una cena ultraesclusiva (organizzata dall’albergo di lusso Four Seasons) nel Cappellone degli Spagnoli, che è la sala capitolare trecentesca di Santa Maria Novella a Firenze. Si chiama così perché, a metà del Cinquecento, divenne la cappella dove si riunivano gli spagnoli del seguito di Eleonora di Toledo, moglie del granduca Cosimo I. È, insomma, una chiesa – con tanto di grande crocifisso marmoreo sull’altare – completamente coperta di affreschi che raccontano la spiritualità e le opere dell’ordine mendicante fondato da San Domenico.
La brillante idea di usarla come location al servizio della grande finanza responsabile della crisi è del vicesindaco e candidato a sindaco Dario Nardella: la cappella è, infatti, compresa nel circuito museale comunale. Rispettando più il desiderio di discrezione del gruppetto di super-ricchi che non il diritto dei cittadini a essere informati dell’uso del loro patrimonio monumentale, il Comune ha tenuto finora segreto l’evento. Ma si apprende che il beneficio economico sarà minimo: meno di 20 mila euro, che dovrebbero essere destinati al restauro di un’opera d’arte. La precipitosa e silenziosa organizzazione della serata – gestita direttamente da Lucia De Siervo, responsabile della Direzione cultura di Palazzo Vecchio e membro del cerchio magico renziano – potrebbe comportare la temporanea chiusura della chiesa di Santa Maria Novella (eventualità che ha fatto infuriare il Fondo Edifici di Culto del ministero dell’Interno, proprietario del tempio), e obbligherà a collocare le cucine in un chiostro del convento ancora di proprietà dei frati, all’oscuro di tutto.
Nardella, evidentemente, non cambia verso rispetto a Renzi: l’unico uso del patrimonio pubblico è ancora quello commerciale. Ma vista la grottesca esiguità del canone, è evidente che il vero movente è piuttosto quello di disporre di queste location per costruire e consolidare la rete dei rapporti politici ed economici del gruppo dirigente renziano, assai proclive a frequentare la più spregiudicata finanza internazionale. Colpisce che il connubio chiesa-lusso-affari non turbi i sonni di politici che non perdono occasione per esibire il proprio cattolicesimo. Negli affreschi del Cappellone i milionari vedranno San Domenico, ardente di amore per la povertà, che converte e confessa coloro che vivono nel lusso: ci si riconosceranno? Poco più in là vedranno rappresentato il trionfo di San Tommaso d’Aquino, il grande filosofo medioevale che scrisse che “il lucro non può essere un fine, ma solo una ricompensa proporzionata alla fatica”, e che “nessuno deve ritenere i beni della terra come propri, ma come comuni, e dunque deve impiegarli per sovvenire alle necessità degli altri”. Chissà cosa avrebbe pensato se avesse saputo che la sua immagine dipinta avrebbe un giorno decorato la location di un banchetto per i super squali che hanno costruito la più grande disuguaglianza della storia umana.
Il prossimo passo quale sarà? Far sfilare modelle in biancheria intima su un altare? Ma si è già fatto, e proprio a Firenze: in Santo Stefano al Ponte, con la benedizione della Curia. Si arriverà a prestare pezzi di chiese gotiche a centri commerciali? Già fatto anche questo: Oscar Farinetti ha appena annunziato che porterà un pezzo del Duomo di Milano nel suo supermercato sulla Fifth Avenue, a New York, per la precisione “due guglie”. E sì, la Veneranda Fabbrica del Duomo (quella che voleva mettere un ascensore per fare una terrazza da aperitivi sul tetto della Cattedrale) gli presta due guglie da tempo musealizzate, con relative statue di santi. Non per un progetto scientifico, ma come attrazione: insieme a quattro di quelle che Farinetti ha chiamato “grondaie” (le gronde gotiche), e a quella che ha definito “una statua di Santa Lucia incinta”. Ora, Santa Lucia era vergine e finì martire: ma incinta non risulta, e probabilmente l’esuberante Farinetti ha frainteso la veste goticamente cinta sotto il seno della bellissima Santa Lucia del Maestro del San Paolo Eremita, che verrebbe strappata al circuito del Museo del Duomo. Ma il punto non è la gravidanza della statua, né la cultura del patron di Eataly: il punto è chiedersi se abbia senso portare pezzi di una grande chiesa medioevale in un supermercato di cibo a New York, o far banchettare i banchieri in una chiesa del Trecento.
Il Vangelo dice che non si può servire a due padroni, e che si deve scegliere tra Dio e il denaro: bisogna riconoscere che sia la Veneranda Fabbrica sia Nardella hanno scelto. Ma anche chi non ha scrupoli religiosi dovrebbe preoccuparsi per la distruzione della funzione civile del patrimonio culturale. Chi crede nel marketing dovrebbe interrogarsi sulla ridicola entità degli utili, e chi immagina che questa privatizzazione sia la via del futuro dovrebbe farsi qualche domanda sulla mancanza di trasparenza. Gli unici che in nessun caso avranno dubbi sono i pochissimi che ci guadagnano: questo è certo.

omune-info.net, 16 maggio 2014
Tre anni fa, nel giugno 2011, la maggioranza assoluta del popolo italiano votò un referendum per dire che l’acqua e i beni comuni, in quanto essenziali alla vita delle persone e garanzia di diritti universali, dovevano essere sottratti alle regole del mercato e riconsegnati alla gestione partecipativa delle comunità locali. Si è trattato di una cesura storica contro la favola, da decenni imperante, del pensiero unico dal mercato e della promessa di ricchezza collettiva prodotta dal suo libero dispiegarsi, senza vincoli di sorta.
Venne allora decretata la fine del consenso all’ideologia del “privato è bello”, mentre la miriade di conflittualità sociali aperte sulla difesa dei beni comuni e dei territori suggerì la possibilità e l’urgenza di un altro modello sociale. Fu allora che, complice la crisi, artificialmente costruita attorno alla trappola del debito pubblico -in realtà una crisi del sistema bancario, scaricata sugli Stati e fatta pagare ai cittadini- venne proposto, con rinnovata forza e ferocia, il paradigma del “privato” che, anche se non più bello, va comunque accettato come “obbligatorio e ineluttabile”.
L’obiettivo, tuttora in campo, è la consegna della società, della vita delle persone e della natura ai grandi capitali accumulatisi in trent’anni di speculazioni finanziarie, che, per uscire dal circolo vizioso di bolle che preparano altre bolle, necessitano di investimenti su asset nuovi e altamente profittevoli, beni comuni in primis.
Ed è esattamente nella facilitazione del raggiungimento di questo obiettivo che si colloca la strategia delle elite politico-finanziarie al comando dell’Unione Europea e l’azione compulsiva del governo Renzi: privatizzazione di tutti i beni pubblici, siano essi patrimonio o servizi, deregolamentazione totale delle condizioni di lavoro, messa a valorizzazione finanziaria del territorio e della natura, piena libertà di movimento per i capitali finanziari e messa a disposizione degli stessi della ricchezza sociale e delle risorse a disposizione.
In attesa che, con il Partenariato Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti (Ttip), in piena e segreta negoziazione fra Ue e Usa, si crei la più grande area di libero scambio del pianeta realizzando l’utopia delle multinazionali.
Che tutto questo necessiti di una drastica riduzione della democrazia, appare evidente da diversi fattori di stretta attualità: le proposte di riforme istituzionali e di una nuova legge elettorale, tese all’azzeramento di ogni ruolo dell’attività parlamentare e al rafforzamento autoritario dei poteri degli esecutivi;l’attacco definitivo alla funzione pubblica e sociale degli enti locali, con l’obbligo, sotto la scure del patto di stabilità, della messa sul mercato di patrimonio, servizi e territorio; la repressione messa in campo contro i movimenti sociali, dalle assurde accuse di terrorismo per gli attivisti No Tav alla sconsiderata gestione dell’ordine pubblico nelle piazze di Roma e Torino.
Siamo di fronte alla crisi sistemica di un modello che, per poter proseguire, è necessitato ad aggredire i diritti sociali e del lavoro e ad impossessarsi dei beni comuni. Le conseguenze di questa perseveranza nelle politiche di austerità sono più che evidenti: un drammatico impoverimento di ampie fasce della popolazione, sottoposte a perdita del lavoro, del reddito, della possibilità di accesso ai servizi, ai danni ambientali e ai conseguenti impatti sulla salute, con preoccupanti segnali di diffusione di disperazione individuale e sociale.
Ma a tutto questo è giunto il momento di dire basta. In questi anni, dentro le conflittualità aperte in questo paese, sono maturate esperienze di lotta molteplici e variegate, tutte accomunate da un comune sentire: non vi sarà alcuna uscita dalla crisi che non passi attraverso una mobilitazione sociale diffusa per la riappropriazione sociale dei beni comuni, della gestione dei territori, della ricchezza sociale prodotta, di una nuova democrazia partecipativa.
Sono esperienze che, mentre producono importantissime resistenze sui temi dell’acqua, dei beni comuni e della difesa del territorio, dell’autodeterminazione alimentare, del diritto all’istruzione, alla salute e all’abitare, del contrasto alla precarietà della vita e alla mercificazione della società, prefigurano la possibilità di una radicale inversione di rotta e la costruzione di un altro modello sociale e di democrazia.
Grazie ad una proposta avanzata dal Forum italiano dei movimenti per l’acqua, tutte queste esperienze si sono incontrate, si sono riconosciute e hanno giudicato maturo il tempo di prendere parola, per riaprire lo spazio pubblico della speranza e dell’alternativa, promuovendo tutte assieme una manifestazione nazionale a Roma per sabato 17 maggio.
Un appuntamento collettivo - radicale nei contenuti, pacifico, colorato e partecipativo nelle pratiche - che chiama le donne e gli uomini di questo paese a dire, tutte e tutti assieme, come non vi sia alcuna uscita possibile dalla crisi, perseguendo le politiche di austerità dell’Unione Europea e del Governo Renzi, fatte di Fiscal Compact, patto di stabilità, pareggio di bilancio, svendita del patrimonio pubblico e dei territori, precarizzazione e privatizzazioni.
Una grande alleanza sociale dal basso, aperta e inclusiva, per riappropriarsi della possibilità di un futuro diverso, e per affermare come, tra la Borsa e la vita, abbiamo scelto la vita. Con l’allegria di chi vede l’orizzonte, con la determinazione di chi conosce l’insopportabilità del presente.
Qualunque cosa diventa potenziale elemento di degrado quando è di massa, e quindi quella demografica è per forza una tematica centrale per il futuro. Le prospettive della prossima enciclica ecologica di Papa Francesco. Corriere della Sera, 16 maggio 2014, postilla (f.b.)
Leggo che papa Francesco sta preparando una enciclica «verde», vale a dire una enciclica che condanna la crescente scomparsa delle zone vergini della Terra, sempre più erose dalla cementificazione dell’uomo. Una cementificazione prodotta dal crescente e insensato aumento della popolazione. Siamo già più di sette miliardi e, se le proiezioni di poco fa indicavano un tetto massimo di nove miliardi, oggi se ne prospettano persino dieci. Dove li mettiamo? Per ora affollano città sempre più smisurate e squallide periferie rese pericolose da immigrati affamati senza lavoro e senza mestiere. Tokyo potrebbe arrivare (nella ultima proiezione dell’Economist ) a 39 milioni di abitanti, Delhi a 30 milioni, San Paolo e Città del Messico a più di 20 milioni, e così via.
Ma la popolazione che cresce di più e più rapidamente è in Africa con punte di nascite fino a 40 figli, una follia che potrebbe e dovrebbe essere contrastata. Senonché nel 1968 papa Paolo VI con l’enciclica Humanae Vitae ha condannato l’uso dei contraccettivi. Nessun’altra religione e nemmeno i cristiani protestanti hanno recepito questo messaggio. Ma la Chiesa di Roma, con l’appoggio dei Paesi sudamericani e dei potentissimi cattolici americani, ha bloccato perfino la politica della contraccezione sia alle Nazioni Unite sia e soprattutto in Africa (dove gran parte delle missioni sono cattoliche).
La storia della enciclica Humanae Vitae è nota ed è stata minutamente raccontata. Il Papa costituì una commissione di teologi che concluse i suoi lavori dichiarando che la dottrina cattolica non forniva nessun sostegno alla tesi di Humanae Vitae . Ma Paolo VI non si lasciò convincere.
Per la fede l’uomo è tale e diverso da tutti gli altri esseri viventi perché dotato di anima. E San Tommaso, il massimo pensatore della Chiesa, nella sua Summa Teologica distingue tre forme e fasi dell’anima. La prima è «l’anima vegetativa», la seconda è «l’anima animale», e solo la terza è «l’anima razionale» che caratterizza gli esseri umani, e che arriva tardi, soltanto quando il nascituro è formato o anche già nato. Dunque il Tomismo vieterebbe l’aborto di una anima razionale, ma certo non vieta i contraccettivi.
Dunque spero ardentemente che l’enciclica «verde» di papa Francesco lasci cadere la Humanae Vitae . Il Papa argentino ha scelto di essere francescano ma è anche stato educato dai gesuiti, un ordine che assieme ai domenicani costituisce l’ordine colto della Chiesa. L’enciclica che sta elaborando papa Francesco non può ignorare che un formicaio umano ucciderebbe anche il verde della Terra, la natura «vera». Gli esperti ci dicono che ci restano 10 anni prima della catastrofe climatica che sarebbe anche la catastrofe umana delle donne e degli uomini che la stanno vivendo.
Papa Francesco, si obbietterà, non può ignorare e tanto meno contraddire la tesi dei suoi recenti predecessori. Invece nulla lo vieta. La dottrina della infallibilità papale è del 1876, e riflette la caduta del potere temporale della Chiesa. In ogni caso questa infallibilità vale soltanto per i pronunciamenti solenni ex cathedra , su materie di fede e di morale. E quindi papa Francesco è liberissimo di asserire — come ha già fatto, visto che cito proprio lui, da una omelia del 19 marzo 2013 — che «la vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani ma una dimensione che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire l’intero Creato, la bellezza del Creato». Sante parole.
postilla
Anche al netto della pessima abitudine del professor Sartori di provare a dare la linea pure al Papa. Anche al netto dal fatto che (lo avranno già pensato in molti) quello del problema demografico è un antico pallino del professore. Ecco, anche al netto da queste considerazioni, e dei probabili sorrisetti di compatimento di chi sta già pensando ai fallimenti di politiche come quella cinese sul figlio unico eccetera eccetera, va detto che il problema sovrappopolazione è ovviamente centrale. Tutto quanto chiamiamo temi ambientali, ovvero gli impatti delle attività umane sugli equilibri naturali, dalle emissioni al land grabbing ai consumi energetici e alla produzione di rifiuti, tutto insomma, dipende in buona sostanza da quello. E non a caso quando si discute di una cosa o dell'altra, spessissimo emerge la solita considerazione: beh, finché si tratta di una cosa di élite possiamo non farci caso, ma quando riguarda centinaia e centinaia di milioni di persone diventa inquietante. Appunto: al netto delle simpatie per il professor Sartori, quei quaranta figli africani citati dovrebbero dare i brividi, e ovviamente non perché sono africani, ma esattamente perché gli augureremmo, a tutti quanti, una casa, doppi servizi, un'auto, tre pasti abbondanti al giorno, il weekend al centro commerciale. Chiaro, no? (f.b.)

Rivelazioni sulle menzogne a nascondere la decisione di distruggere la Laguna di Venezia. Ma c'è chi resiste. Informazioni e commenti di R. De Rossi, la Nuova Venezia, S. Testa, il Gazzettino, e Corriere del Veneto, 15 maggio 2014. Intervenga l'Europa, almeno il nuovo Parlamento. Con postilla
La Nuova Venezia
Comitati tra blocchi e diffide a Renzi
di Roberta De Rossi
Affollata assemblea a San Leonardo: sabato a Roma e poi "sorprese eclatanti" per la Biennale Lettera al premier per annunciare ricorsi all'Europa in caso di scavo di canali e attacco diretto al Comune: «Serve una valutazione sulla compatibilità tra porto e laguna»
II Comitato No Grandi navi serra le fila in vista «di quest'ultimo mese che porterà al Comitatone e nel quale ci giochiamo tutto per fermare lo scempio», per dirla con chi è intervenuto ieri alla grande assemblea pubblica che ha affollato Sala San Leonardo. Il programma è fitto. Intanto c'è la lettera-appello-diffida inviata al presidente del Consiglio Renzi per avvisarlo - come spiega Luciano Mazzolin - «che qualora il governo da lei presieduto, nell'ambito del decreto Clini-Passera, autorizzi lo scavo di un qualsiasi canale di accesso alla Marittima (sia Contorta Sant'Angelo voluto dal Porto, quello lungo la Giudecca sostenuto da Scelta civica e Vtp o il Vittorio Emanuele caldeggiato dal Comune), partirà immediata una richiesta alla Commissione europea per mettere l'Italia sotto procedura di infrazione per violazione delle direttive Acque 2000/60». Poi sabato prossimo, a Roma, lo striscione "No grandi navi" aprirà il corteo dei comitati territoriali alla manifestazione nazionale per l'acqua pubblica e contro le grandi opere. E in mattinata ci sarà annunciata visita al ministro Lupi: in partenza 3 pullman. Quindi sabato 7 giugno - per dirla con Tommaso Cacciari - «corteo da piazzale Roma ai cancelli della Stazione Marittima: pacifico, ma molto ben determinato a produrre un disturbo e il blocco all'imbarco dei passeggeri». Domenica 8 giugno, «sorprese eclatanti allo studio» in vista dell'inaugurazione della Biennale d'Architettura e dellaVogalonga.
Il Comitato Nograndi navi rilancia poi i progetti che portano fuori dalla laguna lo scalo passeggeri: «Sono 4, perfezionabili, ma puntiamo su quelli», sottolinea l'urbanista Stefano Boato. E attacca chiunque voglia scavare, Comune compreso. Così, il vice presidente di Italia Nostra, Lanapoppi, legge l'ultimo parere della commissione tecnica di verifica del ministero dell'Ambiente che - dopo aver dato parere negativo (1346/2014) sullo scavo Contorta Sant'Angelo - stoppa ora anche il progetto di Nuovo porto passeggeri a Porto Marghera, sostenendo che serve una valutazione tra compatibilità tra laguna e porto: «L'ipotesi progettuale predisposta dal sindaco di Venezia e relativa a nuovo porto passeggeri a Porto Marghera», si legge, «non contiene i necessari requisiti tecnici e di documentazione ambientale, indispensabili anche per esprimere un parere preliminare tecnico circa una possibile compatibilità ambientale del progetto», con «l'esigenza che, prima di poter formulare specifiche valutazioni sui vari progetti in discussione, sia avviato un processo di valutazione di impatto ambientale e o valutazione ambientale strategica, per una visione complessiva delle funzionalità e compatibilità portuali con l'ecosistema lagunare».
Per la commissione «occorre chiarire e definire quali siano le funzioni portuali che risultino non superare i limiti di compatibilità ambientale rispetto alla protezione e conservazione dell' ecosistema lagunare nel suo complesso. Ogni progetto per individuare vie di navigazione alternative dovrà essere compiutamente esaminato nell'ambito di una valutazione ambientale approfondita che tenga conto dell'intero complesso lagunare e degli aspetti sin qui non considerati tra i quali si evidenziano la circolazione idrodinamica, incidenza sugli habitat e sulle specie tutelate della Rete Natura 2000 e sull'ecosistema lagunare, l'estensione e il trasporto dei sedimenti, nonché le interazioni dell'opera con il funzionamento del Mose» [nostri corsivi- n.d.r.].
La Nuova Venezia
Incurante del parere negativo della Via,
la Capitaneria ritiene compatibili solo il Contorta e il canale retro Giudecca
di Roberta De Rossi
II risultato del gruppo di lavoro del ministero delle Infrastrutture, del quale fa parte anche l'Autorità portuale che propone Io scavo del canale: bocciati gli ormeggi a mare Dipendesse dalla Capitaneria di porto, il prossimo Comitatone di fine maggio avrebbe due sole opzioni tra le quali scegliere: scavo del canale Contorta dell' Angelo o scavo di un nuovo canale retro Giudecca. Con ponti d'oro alla prima ipotesi.
Lo scarno dossier - 9 pagine - che riassume al Comitatone i progetti esistenti, ritiene solo questi due progetti compatibili con il decreto Clini-Passera: a firmarlo è l'ammiraglio Tiberio Piattelli, che ha coordinato il gruppo di lavoro composto da Capitaneria, Autorità portuale (per altro parte in causa, come promotrice dello scavo del Contorta) e Magistrato alle Acque (che ha fatto mettere a verbale come il livello di progettazione delle proposte sia difficilmente comparabile), al quale il ministro delle Infrastrutture aveva dato l'incarico di valutare i progetti presentati. Un giudizio finale che scatenerà reazioni accese, di segno opposto al parere della commissione Via del ministero dell'Ambiente, che ha bocciato lo scavo del Contorta.
Nell'analizzare costi, impatto sull'occupazione, tempi dei vari progetti, l'ammiraglio Piattelli conclude che «le proposte che in relazione al decreto Clini Passera individuano vie alternative sono quelle della Realizzazione tangenziale lagunare canale retro Giudecca e della Ricalibratura Canale Contorta Sant'Angelo e solo tra le stesse, qualora voglia mantenersi l'operatività dell'attuale stazioni passeggeri in Marittima, debba effettuarsi la comparazione», potendole inserire in Legge obiettivo.
Tutte le altre proposte si riferiscono a nuove stazioni marittime in siti diversi da quelli attuali e pertanto subordinate al procedimento di revisione del piano regolatore portuale». Dopo aver qualificato i fascicoli "No Grandi Navi" e "Gersich" come «piani programmatici e non ipotesi di progetto», il dossier boccia le ipotesi che puntano a spostare gli ormeggi in bocca di porto, per «riserve sulla compatibilità con la presenza del sistema Mose», l'esposizione a «venti dominanti», tempi non ipotizzabili perla necessità di varianti, ricadute sulla crocieristica e il Comune di Cavallino Treporti che ha già deliberato contro.
Così per la proposta Claut; il progetto Boato Iuav, ma anche per il progetto Duferco Italia Holding (costo 127 milioni) anche relativamente all'«aumento del traffico in laguna per la movimentazione dei passeggeri da bocca di porto a Marittima, comunque necessaria per tutti i servizi ai passeggeri», con aumento di costi per i servizi alle navi. Bocciato anche il progetto E3d Srl, nuovo Porto passeggeri a Porto Marghera, 6 anni di lavori e 299 milioni di spesa, caldeggiato dal Comune che vorrebbe integrarlo con lo scavo del canale Vittorio Emanuele, con ormeggi provvisori a fianco dell'isola serbatoi petroliferi e di fronte alla banchina petroli: «Ciò è incompatibile con la sicurezza. Per le fasi successive si evidenzia l'interferenza negativa tra il traffico passeggeri e il traffico merci, petrolifero, chimico». Il sito rientra nel Piano di Sicurezza integrato trattandosi di area a rischio industriale» e «comporterebbe conseguenze negative sul traffico commerciale e industriale», con perdita di ricavi pubblici e privati e occupazione..
E, ancora: «La sostenibilità economica non è garantita, la proposta non appare compatibile con la legge 84/94, il codice della navigazione». Promosso, si diceva, il progetto dell'Autorità portuale Apv (in commissione) per la "ricalibratura contorta Sant'Angelo": 2 anni e 11 mesi dalle autorizzazioni ai collaudi, con lo scavo di 7,168 milioni di metri cubi di fanghi, interramento oleodotto Eni, Terna, materiale riutilizzato per la formazione di velme ai lati canale. Progetto ritenuto «reversibile» e «via alternativa di emergenza al traffico commerciale»: «Realizzare questo percorso comporta trascurabili conseguenze nella fase transitoria sull'offerta crocieristica. Spesa: 157 milioni di euro, 80 per lo scavo, 77 milioni per il recupero morfologico attività prevista esclusivamente in questo intervento. I modelli idraulici evidenziano che l'intervento abbia efficacia nella riduzione degli effetti erosivi tipici della laguna centrale: l'effetto della realizzazione si può considerare positivo per l'ecosistema lagunare. Compatibile con Legge speciale, decreto Clini Passera».
Nessun accenno alla Via negativa dell'Ambiente. Quanto al progetto Zanetti (neo sottosegretario all'Economia), Vtp per un nuovo canale retro Giudecca: in fase di esercizio, i modelli evidenziano che l'abitato della Giudecca è interessato alla ricaduta dei contaminanti e superamento limiti acustici sulle facciate, a spot, per duemila abitanti. «Relativamente alle modifiche dell'idrodinamica lagunare e del trasporto in solido, su larga scala non si notano modifiche della morfologia lagunare rispetto allo stato di fatto, ma «circoscritte e blande». Tre anni e 6 mesi per i lavori, 6,5 milioni di metri cubi scavati, 60 milioni di spesa, opere a protezione delle rive della Giudecca: «Protocolli volontari per il transito con carburanti di basso contenuto di zolfo, potranno rivelarsi strumenti utili per la riduzione degli impianti e l'impatto diretto sulla Giudecca sarebbe limitato».
Corriere del Veneto
Lettera-diffida inviata a Renzi dai No Nav
di E.Lor.- E.Bel
Parte domani indirizzata al premier Renzi e ai componenti del Comitatone la lettera-diffida firmata da Ambiente Venezia, No Navi e Laguna Bene Comune. Annunciano di essere pronti, nel caso in cui il governo decida di scavare nuovi canali in laguna per le crociere, di chiedere l'avvio della procedura di infrazione alla Commissione Europea per violazione della Direttiva Acque. Accusano mancanza di trasparenza nell'individuazione degli scenari, chiamano in causa i pareri «segreti» della Via-Vas, sottolineano che il sindaco ha presentato un progetto senza mandato di Ca' Farsetti. A leggere la lettera, ieri sera, è stato Luciano Mazzolin durante l'assemblea pubblica a San Leonardo, dove il clima si è scaldato. Armando Danella ha accusato il Pd di totale assenza nella discussione e ha puntato il dito contro gli stessi consiglieri comunali: «Se non si oppongono li consideriamo conniventi». E poi ha aggiunto: «Siamo di fronte a un altro Expo? In Italia per ogni grande opera c'è una tangente».
Meloni al Porto Riguardo agli atti ancora La presidente di sconosciuti Fratelli d'Italia: «Non Cristiano possiamo regalare di p alare g Italia Nostra turisti ai turchi» chiede che sia l'assessore all'Ambiente Gianfranco Bettin a farsi dare tutti i materiali per metterli a disposizione della città e Stefano Boato annuncia incontri pubblici per illustrare i progetti in bocca di porto e degli altri pur in assenza di atti. Intanto venerdì il Comitato presenta un libro bianco sul tema delle navi, in attesa delle altre iniziative, con il clou il 7 giugno con il corteo da piazzale Roma al Porto per bloccare i crocieristi.
Ha parlato di navi ieri anche Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale nel suo tour elettorale a Venezia. Meloni, in un incontro con gli operatori del Porto ha promesso di mettere i bastoni tra le ruote del decreto Clini-Passera. Agli operatori delle crociere che le hanno parlato di 2 mila posti di lavoro a rischio Meloni ha promesso «appoggio per qualsiasi iniziativa parlamentare, perché in questo momento non possiamo certo permetterci di regalare un milione di turisti ai turchi».
Il Gazzettino
Grandi navi, il "sarto" Costa e la laguna sciancata
di Silvio Testa
Quando si crede al lupo che si traveste da agnello, allora si è perduti. Per questo bisogna diffidare delle suadenti parole del presidente dell'Autorità Portuale, Paolo Costa, che favoleggia una laguna da Mulino Bianco spiegando al colto e all'inclita che grazie al Mose alle bocche di porto e - udite udite - grazie allo scavo del canale Contorta Sant'Angelo, sarà possibile ricostruire la morfologia del bacino centrale che egli stesso riconosce ridotto a un braccio di mare.
Costa non dice per quale ragione la laguna sia ridotta così, forse sarà colpa di un destino cinico e baro, ma allora glielo ricordiamo: a distruggere la laguna è stato il Canale dei Petroli con le circa 4 mila navi che vi passano ogni anno, e il Contorta ne sarà la replica. Salvo, naturalmente, arginarli entrambi, per confinare all'interno di un alveo chiuso gli effetti erosivi provocati dallo spostamento di migliaia e migliaia di tonnellate d'acqua innescato dal dislocamento delle navi.
Il presidente dell'Autorità Portuale non parla di argini, ma parla di velme e di barene, come se una volta tagliato un albero si potesse dire al falegname sotto casa di ricostruirne un altro. Le veline e le barene sono frutto della Natura e se sono scomparse è per colpa dell'intervento dell'uomo che si, è vero, ha sempre operato in laguna, ma per preservarla e per difenderla mirando al suo equilibrio, non per distruggerla. Ciò fino alla Modernità, poi sono arrivati i Costa e quelli come lui, che danno ragione a chi dice che per certi ingegneri il fiume più bello è un tubo. Chiamiamo, allora, le cose con il loro nome: le veline e le barene di Costa sono argini, isole artificiali, palizzate, burghe riempite di fanghi (inquinati, inquinanti) e di sassi, se non addirittura dighe di pietrame come quella lunga 8 chilometri e larga 26 metri che l'Autorità Portuale ha per l'appunto proposto chissà perché per confinare il Canale dei Petroli tra San Leonardo e Fusina. Con le finte barene del Contorta si tratterebbe, sia chiaro, della divisione della laguna in due bacini idraulici separati. A sentire Costa, viene in mente una mitica barzelletta di Walter Chiari che raccontava di un cliente e di un sarto che non voleva ammettere i propri errori. Per far star bene un vestito sbagliato sul malcapitato, il sarto lo convinceva a modificare in continuazione la sua postura (le spalle, la schiena, le gambe eccetera), finendo per trasformare il cliente in uno sciancato al quale, però, il vestito cadeva a pennello! Meglio, allora, una laguna "sciancata", come vorrebbe il sarto Costa, o una laguna sana e con un bel vestito tagliato bene? Nella seconda ipotesi, le navi incompatibili devono restare fuori dalla laguna, conservando la Marittima come terminal per le navi compatibili e come snodo logistico per la nuova portualità.
Silvio Testa, già valoroso giornalista del Gazzettino, è autore del libro "E le chiamano navi" e componente del Comitato NO Grandi Navi
A mo' di postilla pubblico le due dichiarazioni che ho rilasciato, per il sito web della lista L'altra Europa con Tsipras" e per il facebook eddyburg, il 24 aprile e oggi 15 maggio.
24 aprile 2014. Un’affollata assemblea del Comitato “No Grandi Navi – Laguna bene comune” ha deciso come proseguire l’azione per contrastare lo scempio provocato dalle Grandi navi su Venezia e la sua Laguna. Ancora una volta è dal basso che viene un segnale di chiarezza, verità, onestà intellettuale e saggezza. Il comitato No grandi navi ha avuto il grande merito di aprire gli occhi al mondo sulle scempio dell’arrivo dei Grattacieli del mare in Laguna. Oggi ha ancora, e di nuovo, il merito di mettere l’accento su due verità che l’opinione pubblica italiana e internazionale non conosce, e che i decisori (da Orsoni a Costa, da Renzi e dai suoi ministri e sottosegretari ai rappresentanti dei poteri economici) se conoscono nascondono nelle parole e nei conseguenti atti.
La prima verità nascosta dai potenti è questa: il problema non è estetico, non è l’impatto visivo dei Grattacieli, non è il disturbo e il rischio nel “salotto buono”della citta: il Bacino San Marco. Il problema e il danno è costituito dalla salute dei cittadini e dal degrado ulteriore di quel monumento unico al mondo che è la Laguna: la Laguna di Venezia, l’unica laguna rimasta tale da un millennio grazie al sapiente incontro tra la natura e la cultura e il lavoro quotidiano dell’uomo. E’ questo il bene universale che il pensiero corrente ignora o nasconde (24 aprile 2014)
15 maggio 2014. La vergogna delle Grandi navi .La protervia con la quale Venezia si nascondono i documenti ufficiali per poter proseguire nella distruzione del millenario monumento costituito dalla Laguna spinge ad andare al di là dell’indignazione. Intervenga l’Europa, come fece per evitare a Venezia la minaccia dall’Expo 2000.
Come oggi la stampa informa ben tre differenti pareri della Commissione per la Valutazione d’impatto ambientale hanno bocciato le le soluzioni che sembrano essere le sole all’esame del governo Renzi: quella del nuovo canale Contorta, tenacemente sostenuto dal, presidente del Porto, sia quella del rafforzamento del nefasto Canale dei petroli e del Vittorio Emanuele, proposto dal Sindaco Orsoni, sia infine quello a sud della Giudecca.
Le grandi navi, i nefasti “grattacieli del mare sono incompatibili con la sopravvivenza della Laguna. Non lo dicono solo i comitati, le associazioni, i cittadini di Venezia, gli esperti indipendenti dalle pressioni dei poteri forti, e le persone di buon senso di tutto il mondo. Lo sostengono anche documenti ufficiali, che i fautori dell’ulteriore mercificazione della città e del suo ambiente hanno colpevolmente nascosto.
Già una volta il Parlamento europeo intervenne per impedire lo scempio per la città, minacciata dalla proposta di far scorrazzare nel prezioso ambiente della città e del suo ambiente l’elefante dell’Esposizione universale: evitare che i dinosauri delle Grandi navi distruggano ciò che un millennio di collaborazione tra storia e natura hanno realizzato. Venezia e la sua Laguna sono un bene dell’intera umanità. Chi ha aderito alla lista “L’altra Europa con Tsipras” non può non impegnarsi affinché il nuovo Parlamento europeo, rafforzato oggi nei suoi poteri, faccia ciò che i poteri istituzionali del nostro paese non hanno dimostrato di voler fare. (15 maggio 2014)
Tutti piangono la città, la società e l'ambiente feriti a morte, insieme a lavoro e operai. Quarant'anni fa si prevedevano le conseguenze, nessuno ascoltava, Cederna considerato una Cassandra: ma le visioni della sacerdotessa di Apollo erano sempre giuste. Il manifesto, 15 maggio 2014
«Soffocata a occidente dall’enorme zona industriale (centro siderurgico Italsider) e a oriente da una sgangherata espansione edilizia, Taranto offre oggi al visitatore uno spettacolo raccapricciante, esempio da manuale di che cosa può produrre il sonno della ragione, cioè il sistematico disprezzo per le norme elementari del vivere associato nel nostro tempo». Non è un’inchiesta dei giorni nostri, è un articolo profetico di Antonio Cederna sul Corriere della Sera del 18 aprile del 1972, quarantadue anni fa. In un pezzo di qualche giorno prima aveva scritto: «Era logico pensare che un’impresa così gigantesca che coinvolge tutto il territorio dovesse essere inquadrata in un provvedimento urbanistico ed economico strettamente coordinato e integrato con ogni altra attività (agricoltura, media e piccola industria, difesa delle risorse ambientali, edilizia economica e popolare, eccetera) provvedendo nello stesso tempo ad affrontare i problemi creati dal proprio peso schiacciante (dalla progressiva analisi del traffico all’inquinamento dell’aria e dell’acqua).
Niente di tutto questo: è triste dover riconoscere che l’industria a partecipazione statale, che beneficia di enormi contributi e agevolazioni da parte dello Stato pretende di far a meno di piani che appena esorbitino dal suo limitato settore e, giovandosi della debolezza dei responsabili a tutti i livelli, impone le proprie scelte particolari alla comunità». Cederna si riferisce al raddoppio (da mille a duemila ettari) del centro siderurgico allora avviato, con lavori ciclopici che alteravano la geografia dei luoghi, in contrasto con gli strumenti urbanistici.
Eppure, in quegli stessi anni, il Comune di Taranto era attraversato da sorprendenti spinte innovative, quasi contemporaneamente a Bologna, e cominciava a progettare il recupero del centro storico, cioè di Città Vecchia, l’isola, anima e simbolo di Taranto, che separa il Mar Piccolo dal Mar Grande, dove si erano insediati i primi coloni greci. Fu una vicenda straordinaria legata al nome dell’architetto Franco Blandino, che ha dedicato la vita allo studio, alla conservazione e alla rinascita della sua città (esperienza che Enrico Grifoni e altri giovani urbanisti stanno cercando di rilanciare). Nel 1974 il Consiglio d’Europa riconobbe a Bologna e a Taranto il primato in materia di recupero del patrimonio abitativo storico. E grazie alle leggi di riforma degli anni Settanta e a cessioni volontarie il comune acquisì circa trecento alloggi degradati destinandoli a edilizia popolare. La maggior parte delle poche famiglie che oggi abitano nella Città Vecchia sono inquilini di quegli alloggi. Il recupero andò avanti abbastanza coerentemente fino all’inizio degli anni Ottanta, sostenuto in particolare dal sindaco comunista Giuseppe Cannata, in carica dal 1976 al 1983.
Poi, a mano a mano, è cambiato tutto e il recupero è finito su un binario morto. Nel 1993 fu eletto sindaco Giancarlo Cito, una specie di Berlusconi in formato ridotto. Anche lui, all’inizio degli anni Novanta, usando spregiudicatamente una sua televisione locale, raccolse crescenti consensi e nel 1993 fu eletto sindaco con un suo partito, AT6 — Lega d’Azione Meridionale. Assunse iniziative spettacolari, ma durò poco. Nel 1995 fu rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa. Deputato nel 1996, è stato poi definitivamente condannato e incarcerato. Da ricordare anche Rossana Di Bello, la prima donna sindaco di Taranto dal 2000 a 2006, esponente di Forza Italia, che provocò un pauroso dissesto nelle finanze comunali.
Intanto Taranto diventa sempre più «la piccola appendice di un gigantesco monnezzaio» (Adriano Sofri). Accanto al più grande centro siderurgico d’Europa convivono un porto industriale, una raffineria, un cementificio, due termovalorizzatori, centinaia di altre attività cresciute vertiginosamente: un immane complesso industriale è scagliato addosso a una città dalle strutture fragilissime. Dall’inizio dell’industrializzazione, la superficie urbanizzata si è almeno decuplicata, da circa 500 a oltre 5.000 ettari, più della metà per attività produttive.
Una città e un paesaggio fino a cinquant’anni fa di emozionante bellezza, sono oggi irriconoscibili. L’isola versa in condizioni orribili, è in rovina, in gran parte disabitata e murata per impedire l’accesso nelle aree a rischio di crolli. I muri esposti ai venti che vengono dalla fabbrica sono marcati dai segni rossastri delle polveri dei parchi minerari criminosamente collocati a ridosso del cimitero, del centro storico e del quartiere Tamburi. Ai bambini del quartiere è proibito giocare negli spazi verdi (si fa per dire) contaminati da berillio, antimonio, piombo, zinco, cobalto nichel e altri veleni. La rovina colpisce anche la campagna in gran parte trasformata in una sconfinata e desolata distesa di sterpaglie bruciate dal sole e dagli incendi. Viene proibito l’allevamento del bestiame e sono soppressi gli animali contaminati. Sono state smaltite in discarica montagne di cozze coltivate nel Mar Piccolo.
Ma la politica locale e nazionale e i sindacati stanno dalla parte dell’industria, in difesa purchessia del lavoro, poco attenti alle conseguenze micidiali di una dissennata industrializzazione. I primi controlli ambientali a norma di legge cominciano nel 2006 con la presidenza di Nichi Vendola alla Regione Puglia. All’assenza di politiche pubbliche la città risponde con la ricerca privata di migliori condizioni ambientali. I tarantini voltano le spalle alla fabbrica e fuggono verso est, da capo San Vito a Marina di Pulsano e oltre, in quella «sgangherata periferia» che dalla denuncia di Cederna del 1972 ha continuato a essere comandata dal cemento e dall’asfalto. In trent’anni, i residenti in città sono diminuiti di circa 30 mila, una specie di si salvi chi può.
La scena cambia repentinamente nel luglio del 2012, quando la giudice per le indagini preliminari Patrizia Todisco impone all’Ilva della famiglia Riva di sospendere la produzione fino a quando non fossero eliminate le emissioni nocive. L’Italia del Palazzo rimane spiazzata e cerca impossibili compromessi. Il ministro dell’Ambiente Corrado Clini arriva a negare la storia sostenendo che è stata la città a circondare la fabbrica. Il contrasto fra la magistratura da una parte e il governo e l’Ilva dall’altra diventa imbarazzante e settori sempre più vasti dell’opinione pubblica si schierano a sostegno della magistratura.
Si susseguono le inchieste, i servizi giornalistici, le interviste, i sondaggi, che affrontano soprattutto il rapporto fabbrica-salute dando conto dei gravissimi danni inflitti ai lavoratori e a tutti i tarantini dall’apocalittico inquinamento. Ma non mancano le disperate dichiarazioni di chi preferisce la morte alla disoccupazione.
La vasta discussione sull’inquinamento trascura però quasi del tutto le vistose responsabilità del Comune e degli altri pubblici poteri in materia di politiche territoriali. Mentre avanza il degrado, le scelte più importanti fra Comune e Regione hanno riguardato il discutibile impianto — in località Cimino, in prossimità del centro commerciale Auchan e della lottizzazione Sircom, sempre nella sgangherata periferia orientale — del nuovo polo ospedaliero S. Cataldo, che sostituisce l’antico ospedale della SS. Annunziata e quello più recente di Statte.
Invece, a Taranto, proprio per compensare la prepotenza di una spietata industrializzazione sarebbe stato importante — è importante — un impegno eccezionale di Comune e Regione per non arrendersi alla spirale perversa della degradazione e dell’abbandono. Ma forse non tutto è perduto se in un recente documento di Anna Migliaccio destinato alla Regione si legge quanto segue. «Per riconciliare ambiente e società bisogna approntare la cura per i danni accertati e, contemporaneamente, costruire una nuova via allo sviluppo locale, ripartendo dai valori patrimoniali resistenti. Taranto è una città ancora ricca di risorse e, malgrado le offese, capace ancora di convincente bellezza. (…). Dallo splendore resistente di questa antichissima città del Mediterraneo si può e si deve ripartire per ritrovare il bandolo del futuro»
 |
| Verso il Castello. Foto F.B. |
Botta e risposta sul monumento “effimero” (non si sa quanto) che dovrebbe accogliere il visitatore nel suo percorso dalla città storica verso il sito espositivo e i suoi contenuti culturali. Fulvio Irace e Giancarlo Consonni si schierano rispettivamente pro e contro le scelte progettuali. La Repubblica, 8 e 10 maggio 2014, postilla (f.b.)
L’EXPO GATE ASCOLTA ILCUORE DELLA CITTÀ
di Fulvio Irace
Sabato 10 maggio sarà il giorno della riconciliazione tra Milano e il cantiere dell’Expo: alle 17.30 una parata musicale da piazza San Babila raggiungerà via Beltrami, nella zona di Piazza Castello, dove sarà consegnato alla città Expo Gate, il complesso dei due padiglioni gemelli che funzioneranno da infopoint della manifestazione e, si spera, da centro di rianimazione di un’operazione che sino a questo momento è apparsa a molti tanto problematica quanto nebulosa. Nonostante la sua trasparenza, il Gate di vetro e metallo non sarà tuttavia il Cristal Palace di Milano: progettato dall’architetto Alessandro Scandurra, può essere infatti considerato come un sincero contributo alla storia di Milano capitale del Moderno: laboratorio di un progetto che ancora non è si arreso agli stereotipi del pensiero unico e anzi sfrutta i pochi spazi ancora a disposizione per rivitalizzare una tradizione che la nuova Milano di porta Garibaldi e dell’ex Fiera ha cercato di sterilizzare e rendere del tutto obsoleta.
Per quanto marginali e temporanei, i due padiglioni di Scandurra ci danno una misura di come sarebbe potuta essere Milano se la sua pianificazione fosse stata più meditata e meno succube alle esigenze del Real Estate e dei capitali globali. Cos’ha di particolare l’Expo Gate che i milanesi dovrebbero imparare ad apprezzare, se non amare? Innanzitutto la devozione di un pensiero progettuale che non parte da una forma stravagante da vendere come scatola delle meraviglie per indigeni ingenui. Il progetto è semplice e al tempo stesso sottile e complesso. Parte dal luogo e cerca di dare una risposta alle esigenze di rivitalizzazione di un’area che funzionava più o meno da parcheggio o da crocevia caotico di traffico. La pedonalizzazione dell’area del Castello ha trovato così una giustificazione e una gratificazione per i cittadini che rinunciando all’auto troveranno il piacere di una piazza che mette in evidenza la visuale del rettilineo di via Dante con i suoi corollari monumentali. Un commentario, insomma, sulla città ottocentesca del Beruto, ma anche alla visionarietà del grande piano del Foro Bonaparte dell’Antolini, che rende omaggio a uno dei punti più consolidati dell’urbanistica milanese. I due padiglioni gemelli sono infatti inclinati in modo da lasciare sempre aperta questa visuale e anzi rafforzare l’asse tra la Torre del Filarete, la fontana e la statua di Garibaldi. Questo gesto suggerisce un metodo di intervento basato sulla suggestione del famoso libro dedicato a Milano da Alberto Savinio: “ascolto il tuo cuore città”.
 |
| Folla il giorno di inaugurazione. Foto F.B. |
Fa parte di quest’ascolto anche la forma dei padiglioni: due triangoli di sottili aste metalliche che fanno pensare a prima vista a un castello di carte o al gioco di bastoncini shangai. Subito dopo affiorano alla mente, però, i disegni del Cesariano che nel 1521 mostrava le geometrie triangolari del Duomo di Milano come un miracolo di equilibrio tra verticalismo gotico e armonie rinascimentali. Ma si pensa anche agli allestimenti razionalisti della vicina Triennale dove Albini e Persico negli anni Trenta sfidavano le leggi della gravità disegnando impalcature di tubi sottili per sostenere immagini ed oggetti. Di questo va reso grazie a Scandurra: di aver tenuto alta la posta e restituito un’immagine di Milano né conservatrice né pacchiana. Sembra poco? Basta spostarsi in piazza San Babila con il suo funesto baldacchino per la vendita di maglie e gadget per decidere la risposta.
CHE SCEMPIO QUEI CASELLIDAVANTI AL CASTELLO
di Giancarlo Consonni
Verrebbe da scegliere il silenzio. Perché, dopo questo mio intervento, chi ha responsabilità di governo della città potrà ribadire la formula auto-assolutoria: «È un progetto di rottura, e come tutti i progetti di questo tipo possono piacere e non piacere». Solo che scempio e rottura non sono sinonimi. Dopo le rotture — gli accanimenti littori e la spregiudicatezza postbellica a celebrazione del mito della capitale economica — questa nostra Milano, un tempo cultrice di una bellezza riservata (Alberto Savinio), ha visto moltiplicarsi gli scempi, piccoli e grandi, in misura esponenziale.
La bruttezza dilagante sta diventando il marchio di una fase storica iniziata con la dismissione industriale (e la Milano da bere), di cui non si intravede la fine. Eppure Fulvio Irace (nel suo intervento pubblicato su Repubblica Milano di giovedì 8 maggio) dice che i due organismi gemelli dell’Expo gate firmati da Alessandro Scandurra sono il segno di una svolta. Parto da Carlo Emilio Gadda che, con Savinio, è l’altro grande interprete novecentesco dell’anima di Milano. Si legge nell’Adalgisa: «Valerio ed Elsa, nella luce di un pomeriggio bramantesco, poterono involarsi alla folla, e alla guardatura della sfavillante lanterna filaretiana, che li aveva seguitati fin là, cioè fino allo sbocco di via degli Orefici nella piazza del re a cavallo, e del duomo».
Qui Gadda rende omaggio a Luca Beltrami: a quel falso storico che è il Castello Sforzesco, il capolavoro architettonico- urbanistico che ha consentito a Milano di trovare una degna conclusione all’asse di via Dante e di muoversi in direzione di un rinnovato policentrismo. Una linea su cui il Novecento non ha saputo/voluto proseguire (con conseguente indebolimento dell’armatura urbana). Bene: fin da via Orefici, man mano che si procede verso il fulcro della torre “del Filarete”, i “caselli” di Scandurra manifestano il loro carattere di corpi estranei: sono due ospiti invadenti e ottusi, sbagliati sul piano urbanistico come su quello architettonico.
Piazza Castello necessitava di essere sottratta alla funzione di parcheggio che l’aveva degradata? Certamente; ma l’operazione avrebbe dovuto limitarsi a un’adeguata sistemazione della pavimentazione e delle sedute che ne esaltasse il doppio carattere di interno urbano e di soglia. Per il resto l’architettura di questo spazio era già ottimamente definita sui quattro lati.
Viene rispettata la simmetria rispetto all’asse via Dante-Castello? Questo non garantisce alcunché dal momento che i due bianchi gemelli di ferro e vetro si oppongono al luogo. Lo occupano spaccandolo: forzano la prospettiva in senso assiale, quando qui l’interazione di quanto c’è già è ben più ricca e complessa. Per questo il vuoto non andava riempito: occorreva solo favorire l’interazione dialogica e sinfonica delle presenze che lo strutturano come un palcoscenico: i fulcri del Castello e del monumento equestre a Garibaldi e le testate dei due grandi circus del Foro Bonaparte (architettura raffinata nell’impaginato quanto negli accostamenti materico-cromatici, perfettamente integrata dai possenti bagolari). I due intrusi sono sbagliati anche sul piano architettonico. Velleitaria combinazione di ludico e gotico, non riescono a mascherare la loro natura di parvenu. Quanto è lontana la leggerezza armoniosa dell’architettura di ferro e vetro con cui l’Ottocento ha costruito esposizioni, biblioteche e giardini d’inverno.
postilla
 |
| Expo Gate verso via Dante. Foto F.B. |
Senza nulla aggiungere o togliere alle considerazioni sulla forma urbana dei due illustri studiosi, va sottolineato quanto non solo il loro approccio sia deliberatamente teorico-critico, ma anche che essi sviluppano i propri ragionamenti a partire dai rapporti fra progetto, contesto, storia. In pratica, anche indipendentemente dalle specifiche scelte degli Autori, le cose di cui parlano non possono basarsi anche, eventualmente, sul modus operandi “a regime” dell'Expo Gate, inaugurato insieme all'operativa pedonalizzazione di Piazza Castello dalla giornata di sabato 10 maggio. Ebbene, quello che accade operativamente, in questa giornata in cui la solita folla di milanesi e city users si sposta sull'asse Duomo-Sempione, è che quel portale rappresenta un vero e proprio tappo, visivo come sottolinea Consonni, ma anche e soprattutto rispetto ai flussi. Il sistema della pedonalizzazione sull'ultimo tratto di via Dante, di fatto si interrompe in una serie di strettoie, per iniziare di nuovo a respirare, visivamente e letteralmente, nella nuova piazza ancora in attesa di sistemazione e arredi. Se questa scelta è deliberata, si tratta di una patente sciocchezza. Se, come si spera vivamente, dopo l'evento quella discutibile ingombrante architettura verrà smontata, e la torre del Filarete restituita a chi si avvicina dalla direzione del Duomo, magari si potrà discutere quale soluzione di continuità pensare, per uno spazio in effetti forse un po' troppo vasto per la sola libera circolazione dei pedoni. Qualcuno dal Comune aveva insinuato tempo fa “stiamo lavorando per rendere definitivo l'Expo Gate”, beh: si riposi un po', ha già lavorato a sufficienza, e fatto abbastanza danni così (f.b.)
p.s. vista l'esplosione dello scandalo tangenti più o meno in contemporanea all'inaugurazione della struttura, la scelta del nome "ExpoGate" si rivela nefasta
 No della a commissione VIA al previsto nuovo canale per le Grandi navi rischierebbe di innescare processi erosivi in Laguna grazie al dragaggio di oltre 8 milioni di metri cubi di fanghi. Molti dubbi anche sul canale Vittorio Emanuele II proposto dal sindaco. La Nuova Venezia, 10 maggio, 2014 (m.p.r.)
No della a commissione VIA al previsto nuovo canale per le Grandi navi rischierebbe di innescare processi erosivi in Laguna grazie al dragaggio di oltre 8 milioni di metri cubi di fanghi. Molti dubbi anche sul canale Vittorio Emanuele II proposto dal sindaco. La Nuova Venezia, 10 maggio, 2014 (m.p.r.)
Il progetto del nuovo canale Contorta "bocciato" dalla commissione Via del ministero per l'Ambiente. Un parere che non lascia spazio a interpretazioni, di segno nettamente negativo sulla proposta presentata dall'Autorità portuale. Per i «significativi impatti ambientali sull'intero ecosistema lagunare», ma anche per i «tempi troppo lunghi di realizzazione, almeno quattro anni». Una bocciatura che riapre gli scenari e alimenta le polemiche. E si tinge di giallo. Perché il documento, approvato all'unanimità dalla commissione tecnica per l'impatto ambientale Via e Vas, porta la data del 27 settembre scorso e non è mai stato reso pubblico. «Un silenzio inspiegabile», accusa il senatore veneziano del Pd Fenice Casson. Che ieri ha inviato una interrogazione urgente al presidente del Consiglio Matteo Renzi e ai ministri dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dei beni culturali. Casson chiede «se il governo non ritenga di garantire la massima trasparenza e la massima pubblicità, anche al fine di evitare che sulle questioni connesse ai suindicati lavori pubblici possano verificarsi interventi iIleciti o peggio ancora criminali, come peraltro per recenti vicende concernenti lavori pubblici nella laguna di Venezia è già successo».
Parole che fanno sobbalzare Paolo Costa, ex sindaco e presidente dell'Autorità portuale. «Ma di che parla? Mi domando quale trasparenza sia stata garantita dal ministero dell'Ambiente, che ha esaminato un progetto a insaputa del proponente. Noi non abbiamo presentato niente». Eppure nella prima pagina del parere allegato all'interrogazione (il numero 1346 del 27 settembre 2013) si parla del progetto proposto dall'Autorità portuale per individuare «vie di navigazioni alternative a quelle vietate dal decreto Clini Passera». Il progetto preliminare depositato all'Ambiente riguarda «l'adeguamento della via acquea di accesso alla Stazione marittima e la riqualificazione delle aree limitrofe al canale Contorta-San'Angelo».
La commissione, presieduta dall'ingegnere Guido Monteforte Specchi e composta da 22 architetti, ingegneri ed esperti di varie materie, ha espresso dunque parere contrario sullo scavo del nuovo canale, 5 chilometri di via d'acqua che dovrebbero essere portati da un metro e mezzo a dieci metri e mezzo di profondità. La commissione richiama il rischio di innescare processi erosivi per il dragaggio di oltre 8 milioni di metri cubi di fanghi. Ma la commissione esprime molti dubbi anche sul canale Vittorio Emanuele II proposto dal sindaco per far arrivare le navi in Marittima. Per la commistione di traffico con le navi merci - anche se il sabato e la domenica gli arrivi sarebbero quasi nulli - e per la difficoltà di far compiere la "curva" alle grandi navi. Accoglie le osservazioni della Capitaneria, che ha scartato il Vittorio Emanuele e propone di lasciare tutto come sta e nel frattempo di studiare la possibilità di far passare le navi dietro la Giudecca. Scenario sempre più confuso, in attesa del vertice tecnico convocato per lunedì a Palazzo Chigi dal premier Renzi. Riunione in cui si dovrà scegliere la soluzione migliore tra quelle depositate. Intanto spunta il parere contrario della commissione Via alle proposte di utilizzare nuovi canali in laguna.

La nuova urbanistica (che ha un cuore antico): «Ciò che conta non sono più i contenuti delle scelte insediative e pianificatorie, ma la loro funzionalità a muovere il business immobiliare da spartirsi». Inviato a eddyburg il 10 maggio 2014
“Per piacere: evitateci lo stupore scandalizzato, «chi se lo immaginava?», «non l’avrei mai detto…». Tutto sono, gli arresti di ieri per l’Expo 2015, tranne che una clamorosa sorpresa. Perché, ferma restando l’innocenza di tutti fino alle sentenze, le cose stavano procedendo esattamente come era andata troppe altre volte. Il solito copione. Recitato per i Mondiali di nuoto, le Universiadi, la World Cup di calcio, l’Anno Santo... Anni perduti nei preliminari, discussioni infinite sui progetti, liti e ripicche sulla gestione e poi, di colpo, l’allarme: oddio, non ce la faremo mai! Ed ecco l’affannosa accelerazione, le deroghe, il commissariamento, le scorciatoie per aggirare lacci e lacciuoli, le commesse strapagate, i costosissimi cantieri notturni non stop.”
Così scrive G.A. Stella
nell’editoriale del Corriere della Sera del 9 maggio scorso. Parole sante, cui ci sarebbe poco o nulla da aggiungere, se non fosse che mettendo sullo stesso piano inefficienze, litigi e ripicche, ritardi e deroghe nella procedura attuativa dei progetti con il terreno germinativo di quelle distorsioni, e cioè ciò che Francesco Indovina nel bel titolo di un suo libro del 1993 ha icasticamente definito “la città occasionale”, si rischia di oscurare la radice originaria su cui quelle distorsioni trovano modo di attecchire e prosperare e cioè la sostanziale sfiducia in un progetto di lungo periodo della città, fondato su scelte collettivamente discusse e condivise, ciò che costituisce il nucleo fondativo del pensiero urbanistico moderno. Non è un caso che le pratiche corruttive all’ origine dell’ondata di arresti non riguardino solo il progetto di Expo 2015, maturato originariamente dalla collusione della lobby politico-affaristica di Cl-Compagnia delle Opere annidatasi contestualmente nella conduzione politica e dirigenziale dell’assessorato all’urbanistica del Comune di Milano - tenuto dai ciellini Lupi prima, durante la sindacatura Albertini,e Masseroli poi, durante la sindacatura Moratti -; della lunga presidenza del ciellino Formigoni alla Regione Lombardia e infine della presidenza di Fondazione Fiera, consegnata da Formigoni al ciellino Luigi Roth.
Roth, con la straordinaria valorizzazione immobiliare consentitagli dal Comune di Milano nella vendita dell’area dismessa del vecchio recinto fieristico in città, ha trovato le risorse non solo per completare il nuovo polo fieristico di Rho-Pero, ma anche quelle per acquisire a basso costo le aree a destinazione agricola su cui oggi si sta attuando in modo raffazzonato l’evento Expo 2015, dopo averle cedute a prezzo quasi decuplicato alla società regionale Arexpo. La medesima distorsione corruttiva, con il coinvolgimento più o meno delle stesse figure dirigenziali nelle istituzioni e stessi referenti del mondo della sussidiarietà, cooperazione e imprenditoria di vario orientamento politico si ritrova, infatti, anche nella vicenda della Città della Salute a Sesto San Giovanni (comune da sempre amministrato dalle sinistre) quasi a forza ficcata nello strumento-veicolo delle aree pubbliche del piano di valorizzazione immobiliare dell’ex acciaieria Falck, che, in deroga al PRG, ha ottenuto gli stessi assurdi indici edificatori dell’ex Fiera di Milano, come ormai giudizialmente accertato grazie alle facilitazioni mediate dall’ex sindaco Penati, a seguito dei contributi erogati dalla proprietà immobiliare alla sua Fondazione “Fare Metropoli”.
La scelta di realizzazione a Sesto di una nuova cosiddetta Città della Salute per riallocarvi integralmente gli istituti scientifico-ospedalieri di Milano (Neurologico Besta, Istituto Nazionale Tumori, ecc.) ora insediati nel quartiere Città Studi e che avrebbero potuto più utilmente trovare spazio alle proprie esigenze di riassetto funzionale in aree pubbliche, oggi sottoutilizzate e attigue alle sedi esistenti, appare, quindi, più che altro un’opzione orientata ad alimentare una catena di prospettive immobiliari (il passo successivo sarebbe inevitabilmente quello del riutilizzo immobiliare delle vecchie sedi liberate in città). Ciò favorisce la possibilità di condizionamento corruttivo da parte di ambiti imprenditoriali clientelari delle varie tendenze politiche, e non, viceversa, una scelta insediativa razionalmente individuata dalle pubbliche amministrazioni nel pubblico interesse.
Le vicende giudiziarie di questi giorni ne sono la coerente conseguenza e non un incomprensibile episodio dovuto ad avidità o debolezze umane di singoli individui. Certo la fretta necessitata forse ad arte dai ritardi procedurali e il conseguente allentamento dei controlli di legittimità sono un’ulteriore facilitazione al prevalere della spartizione clientelare dei frutti del condizionamento corruttivo, ma la ragione di fondo è la sudditanza della pianificazione pubblica ad esigenze particolaristiche, cosa che ormai caratterizza quasi indifferentemente amministrazioni locali di qualsiasi colore politico a fronte di bilanci pubblici sempre più asfittici e condizionabili da economie esterne.
Ciò che conta non sono più i contenuti delle scelte insediative e pianificatorie, ma la loro funzionalità a muovere il business immobiliare da spartirsi. É ciò che si profila all’orizzonte per il destino finale dell’area dell’Expo 2015, dopo l’evento intitolato al tema “Nutrire il pianeta” (un grande tema sfruttato come mero pretesto per giustificare i cambi di destinazione d’uso, dato che trascura completamente il rapporto tra settore agro-alimentare e modi di produzione sul territorio) nel semestre maggio-ottobre 2015, che quasi certamente si concluderà con un clamoroso “flop” di affluenza dei visitatori ed un enorme deficit di bilancio.
Ciò servirà a giustificare la necessità di rivendere l’area ad uno scalpitante mondo della sussidiarietà cooperativistica ansioso di nuove occasioni in campo edilizio e dei servizi sociali, in particolare su un’area resa accessibile dall’infrastrutturazione per l’evento Expo, ma quanto mai isolata dal resto del contesto sociale ed urbano. Un vero e proprio feudo per il rilancio di collateralismi negli ultimi decenni ormai svaniti nella crisi di credibilità della politica propriamente detta. Solo con questo orizzonte allargato di considerazioni potremo evitare che episodi come quelli di questi giorni tornino nuovamente ad apparirci come imprevedibili e sorprendenti.

«L'azione più singolare, e quanto mai vitale nella sua partecipazione popolare, la stanno compiendo, in questi giorni i duemila veneziani, e non solo, che stanno animando l'asta per evitare che l'isola di Poveglia finisca in mano ad un riccone». L'Avvenire, 10 maggio 2014 (m.p.r).
La Serenissima non si salva solo col Mose, il sistema delle dighe mobili. Proprio in queste ore si è conclusa la posa dei cassoni alla barriera di Lido. Per salvarla non basta neppure delocalizzare le grandi navi dal bacino di San Marco a Marghera, col rischio magari che si trasferiscano ad Atene, come hanno anticipato minacciato compagnie croceristiche. L'azione più singolare, e quanto mai vitale nella sua partecipazione popolare, la stanno compiendo, in questi giorni — e da pochi giorni, non quindi con i lunghi cronoprogrammi degli interventi pubblici in laguna — i duemila veneziani, e non solo, a cominciare dal sindaco Giorgio Orsoni, che stanno animando l'asta per evitare che l'isola di Poveglia finisca in mano ad un riccone.
Loro hanno raccolto 160 mila euro, ma sono in trepidazione perché lo Stato che vuole alienare il bene per fare cassa ha ricevuto un'altra offerta, di 4 volte superiore, pari a 513 mila euro. "User 10801" è la sigla che cela probabilmente un'immobiliare. Popilia, com'era anticamente denominata Poveglia per i suoi pioppi, è diventata, dai tempi dell'invasione longobarda del VI secolo, una specie di Lampedusa dei nostri giorni, un centro di approdo e di reinsediamento delle popolazioni in fuga dall'entroterra. L'isola è tra le più isolate - e non è un gioco di parole - della laguna. Priva di abitanti, non raggiunta dai mezzi pubblici, è abbandonata a se stessa, ovvero affidata al demanio statale.
Già nel 1997 il Centro Turistico Studentesco e Giovanile avanzò un piano per la realizzazione di un ostello della gioventù. Due anni dopo il Ministero del Tesoro escludeva Poveglia dai beni da alienare. Ma l'anno scorso è stata di nuovo messa in vendita per essere recuperata a fini turistici. Poche settimane è nata, all'improvviso, per iniziativa di alcuni volontari, l'associazione "Poveglia - Poveglia per tutti" con l'intento di evitare che questo patrimonio venga privatizzato. Dell'antica pieve di San Vitale resta soltanto il campanile, risparmiato dalle soppressioni napoleoniche. C'è un ex convento, c'è pure un'ex polveriera, trasformata poi in "convalescenziario". Tutto ex, purtroppo: anche questa struttura è abbandonata, da almeno trent'anni. Riusciranno i veneziani a respingere gli attacchi del moderno Napoleone? Il 13 maggio, alle ore 13, il confronto, a colpi di mille euro, tra l'associazione e l'investitore sconosciuto, su una piattaforma virtuale gestita dal Demanio.
Lorenzo Pesola e Giancarlo Chigi, i promotori della raccolta, sono fiduciosi, nonostante la distanza. Raccolta a parte, contano già su una disponibilità di 200 mila euro da parte dei generosi donatori, numerosi dei quali rilanciano. E ce ne sono in arrivo anche da fuori laguna, dall'intera Europa. L'ultima spiaggia— anche sedi lidi a Poveglia non ce ne sono — è che non essendo congrue le offerte al valore dell'isola, la gara venga annullata e l'azionista Orsoni riesca a convincere il demanio a garantire per il futuro ciò che la storia ha fino ad oggi assicurato: l'interesse pubblico del sito. A questo punto potrebbe scattare da parte del Comune la prelazione. Un acquisto a prezzo ridotto o forse un canone annuale. E per l'associazione sarebbe già una vittoria. Anzi, "la" vittoria.
Gli arresti per tangenti Expo illuminano di luce sinistra anche il grande progetto “itinerante” per anni nell'area metropolitana. Corriere della Sera Milano, 9 maggio 2014, postilla (f.b.)
Di nuovo sanità e affari sporchi. Stavolta il tentativo è stato quello di spartirsi illecitamente appalti per quasi 350 milioni di euro. Sono quelli del più importante progetto di edilizia sanitaria d’Italia, la Città della Salute, da ieri al centro dell’ennesima bufera giudiziaria. Con un’infilata di sette arresti, per un totale di 19 indagati. È una nuova Tangentopoli all’ombra di Expo? Di sicuro, per quanto riguarda la sanità, adesso più che mai viene messo a nudo il sistema di assegnazione degli appalti in Lombardia. Un sistema dove gli interessi bipartisan si saldano per dividersi le torte milionarie dell’edilizia sanitaria e della fornitura dei servizi ospedalieri no core (appalti per le pulizie, la ristorazione, la lavanderia).
Emblematica a tal proposito è l’iscrizione, ieri, nel registro degli indagati del super manager delle cooperative Claudio Levorato, 54 anni, alla testa di Manutencoop, colosso del facility management. Proprio Manutencoop, insieme con l’impresa di costruzione Maltauro, avrebbe dovuto vedersi assicurata la vittoria dell’appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva della Città della Salute, con la relativa gestione dei servizi ospedalieri non sanitari. È a questo che dovevano portare gli accordi sottobanco tra l’ex politico dc Gianstefano Frigerio & C. e Antonio Rognoni, alla guida di Infrastrutture lombarde (la holding che gestisce gli appalti pubblici per conto del Pirellone), già arrestato a marzo in un altro filone d’indagine. Negli atti della Procura, ora, viene fatto chiaramente riferimento alla ripartizione politica che sta dietro la costituzione della cordata (ati) creata per partecipare alla gara d’appalto.
In questo caso ci sono aspetti penali: ma il meccanismo di accordi bipartisan per l’aggiudicazione degli appalti sanitari svelato dall’indagine giudiziaria in corso, in Lombardia è una costante, anche se non ci sono prove di illeciti. Due gli esempi su tutti. Già nel 2009 il ministero dell’Economia aveva messo sotto accusa gli affari che ruotavano intorno al Niguarda, un’operazione da oltre un miliardo di euro che ha visto per protagoniste la Nec Spa (vicino a Cl) e la Progeni Spa (legata alle cooperative rosse). E, in una ricostruzione realizzata dal Corriere nell’estate 2012 sulla lobby degli appalti in sanità, veniva documentato come le società degli uomini vicini all’allora governatore Roberto Formigoni (Mario Saporiti e Fabrizio Rota) saldassero i loro interessi con quelli delle coop.
Con l’arresto di Antonio Rognoni lo scorso marzo anche la gara per la Città della Salute si è bloccata. E adesso la nuova indagine allunga pesanti ombre sull’intero progetto, che prevede il trasloco nell’ex area Falck di Sesto dell’Istituto dei tumori e del neurologico Besta. Si andrà avanti lo stesso, anche a costo di rifare da zero la gara d’appalto? Il progetto già da tempo è al centro di un altro interrogativo: l’opera edilizia è necessaria a migliorare le cure dei malati o l’unione dei due ospedali è un business immobiliare? Gli interessi in gioco sono notevoli: la Città della Salute è prevista su un’area di 210 mila metri quadrati all’interno de gli 1,5 milioni di metri quadrati delle acciaierie ex Falck, acquistate dalla SestoImmobiliare dell’imprenditore Davide Bizzi. La presenza dell’Istituto dei tumori e del Besta servono come volano per lo sviluppo dell’intera area. Nel frattempo l’altro affare, quello delle bonifiche (vale 50 milioni), è in mano all’azienda Ambienthesis riconducibile alla famiglia Grossi. Lui, il patron Giuseppe Grossi, scomparso nel 2011, era finito in carcere per le bonifiche di Santa Giulia.
postilla
In questo sito, molto probabilmente, basta scrivere la parola “salute” nella finestrella del motore di ricerca interno, per ripercorrere alla luce degli ultimi eventi almeno parecchi indizi di una vicenda che non aveva, non poteva avere, sviluppi lineari davvero comprensibili, se non appunto nella logica distorta che pare emergere dalle indagini. Ogni occhiello, ogni postilla, e tanti, troppi contraddittori passaggi di quegli articoli, raccontano criteri surreali, di pura facciata, a volte oltre la spudoratezza, per le scelte localizzative di questa fantomatica Città della Salute, quando non addirittura per la logica della sua esistenza. Milioni di metri cubi che schizzavano inopinatamente qui e là per l'area metropolitana, su e giù per le Tangenziali, ma oggi si scopre che seguivano forse invece i percorsi delle Tangenti. Un progetto di riorganizzazione sanitaria e della ricerca che, secondo il parere anche di molti operatori di prestigio, non avrebbe neppure avuto necessità di interventi edilizi e urbanistici, almeno su quella scala e rilevanza, ma che al contrario vedeva in primissimo piano, quasi esclusivo, proprio le trasformazioni urbane e la loro localizzazione. Una storia decisamente surreale, dove la Salute svolgeva un ruolo di puro paravento, per interessi e appetiti di ben altra natura. Non a caso più o meno identica a quella parallela di Expo, dove al posto della Salute c'è l'Alimentazione, ma oggetto del contendere sono metri quadri, appalti, tracciati … Già (f.b.)
p.s. Rinnovando l'invito a scrivere "Città della Salute" nel motore interno di ricerca Eddyburg, propongo ad esempio questo articolo dedicato agli interessi sottesi, ripreso dal Fatto Quotidiano di un anno e mezzo fa circa

«Il nocciolo strategico della politica comunale appare centrato sulla modernizzazione dell’immagine cittadina come confezione accattivante dello sfruttamento intensivo delle rendite di posizione. Tutto ruota intorno a vicende asfitticamente edilizie che delineano una prospettiva decisamente implosiva per la città. Due casi su tutti: il Crescent e la variante 2012 al Puc». Il manifesto, 8 maggio 2014
Salerno ha un territorio di quasi 59 kmq, per la maggior parte collinare, a tratti anche impervio; la zona pianeggiante costiera non ne copre più di un terzo. La popolazione residente, pari a circa 91mila abitanti nel 1951, salì a oltre 157mila nel 1981 riducendosi poi progressivamente fino a quasi 133mila nel 2011. La città crebbe fisicamente soprattutto negli anni del boom (circa 11mila abitazioni e oltre 42mila stanze in più soltanto negli otto anni fra 1961 e 1968) sfruttando fino all’ultimo metro quadrato le zone edificabili del piano regolatore generale (Prg) redatto da Plinio Marconi (1958). Quel Prg non fu mai adeguato alla normativa sugli standard (1968) e, giocando sull’equivoco, molte lottizzazioni successive realizzarono ingenti volumetrie private senza trasferire al comune le prescritte urbanizzazioni primarie e le aree per le urbanizzazioni secondarie. Le periferie recenti salernitane sono fra quelle più carenti in Italia di spazi e attrezzature collettive e il traffico automobilistico a Salerno è da allora un problema sempre più grave.
In quegli anni le ambizioni della borghesia imprenditoriale e mercantile, con interessi fortemente intrecciati ai meccanismi della rendita urbana, si concentrarono — grazie anche alle relazioni privilegiate con il governo e la Cassa per il Mezzogiorno — sulla costruzione del nuovo porto, da un lato, e sull’infrastrutturazione dell’area industriale, dall’altro, ubicati agli estremi opposti della città: il porto a ridosso della costa alta del primo tratto della Costiera d’Amalfi, l’area industriale all’imbocco della piana del Sele. Due operazioni che conferivano un supporto non solo simbolico al ruolo polarizzante di Salerno nella regione, documentato dalla immigrazione dall’hinterland, ruolo che la dirigenza salernitana ha tentato a più riprese di valorizzare secondo l’aspirazione, invero un po’ velleitaria, a un qualche «sorpasso» sulla Napoli ex capitale in declino.
La gestione territoriale della città negli anni ’80 dimostrò la gravità delle contraddizioni antiche e recenti. Si tentarono varie soluzioni spesso confuse e contorte (negli anni di «tangentopoli» ci fu anche chi propose di attribuire nuova edificabilità alle aree per standard rimaste illegalmente in proprietà ai privati), finché si decise di dare alla città un nuovo strumento urbanistico generale (1989) con la consulenza di grido del catalano Oriol Bohigas.
Nel regno di De Luca
Negli anni seguenti l’Amministrazione comunale guidata da Vincenzo De Luca, divenuto sindaco nel 1993, forte della gestione efficace della città consolidata che vi ha conseguito condizioni di vivibilità e decoro inconsuete nel panorama meridionale, ha parallelamente sviluppato, attraverso meccanismi negoziali su progetti specifici, una strategia urbana orientata alla realizzazione di nuove sedi dei servizi di rango non locale, affidata a famosi architetti stranieri, e, insieme, di ingenti densificazioni edilizie.
Il Prg ha avuto una tormentata elaborazione all’insegna della prevalenza, sulle regole dell’urbanistica, dell’immagine architettonica collegata con le grandi edificazioni. Nel 2003 viene resa nota la versione finale del Prg che tuttavia non viene ancora adottato: nel dicembre 2004 l’approvazione della nuova legge urbanistica regionale giustifica una ulteriore rielaborazione che trasforma il Prg in Puc: «piano urbanistico comunale», secondo la modifica tutt’altro che nominalistica della legge regionale 16/2004, la quale articola il piano in disposizioni strutturali valide a tempo indeterminato e disposizioni operative da rielaborare con frequenza. In realtà il Puc conserva l’impianto e la fisonomia tecnico-normativa tradizionali del Prg, ma contiene nuove scelte ulteriormente favorevoli alla cementificazione. «Il confronto tra il piano del 2003 e quello del 2005 mette in evidenza una serie di variazioni, tutte peggiorative, che la dicono lunga sui veri motivi della mancata adozione nel 2003: pur lasciando inalterato il dimensionamento del piano, cresce l’edificabilità totale di mezzo milione di metri cubi; aumentano gli indici di conversione degli immobili industriali; l’edilizia residenziale pubblica, che Bohigas avrebbe voluto diffusa in tutta la città, viene concentrata in enormi e periferici quartieri-ghetto, capaci di ospitare fino a 5000 abitanti» (Fausto Martino). Grazie a una valutazione «politica», l’Amministrazione provinciale approva tuttavia il Puc senza troppi approfondimenti.
Il nocciolo strategico della politica comunale appare centrato sulla modernizzazione dell’immagine cittadina come confezione accattivante dello sfruttamento intensivo delle rendite di posizione. La visione del rapporto con il contesto territoriale delle giunte De Luca è priva di ogni connotato «metropolitano» dimostrandosi centralistica e autoreferenziale: tutta l’edificazione possibile nel territorio comunale, le cose di pregio nel quadrante urbano occidentale, le cose ingombranti nel quadrante sud-orientale (dall’ospedale allo stadio, dagli impianti per il tempo libero all’industria residua), la cosa occasionalmente suscettibile di grandi opportunità finanziarie — cioè l’inceneritore — in quell’estremo lembo orientale del comune che è incuneato nel territorio di comuni confinanti (saranno così questi a subirne la maggior quota dell’impatto).
Il miraggio del porto
Una vicenda di segno diverso è sembrata temporaneamente profilarsi nei primi anni 2000 in relazione al porto. L’impianto, gestito in modo accorto ed efficiente, ha visto crescere il suo movimento fino a esaurire ogni possibilità espansiva e, in presenza di prospettive internazionali confortanti, ha ritenuto di poter puntare a un salto di scala che obbliga però a una radicale delocalizzazione con la costruzione di un «porto-isola» davanti alla parte nord della piana del Sele. È sembrato così possibile immaginare un grande nodo infrastrutturale e logistico che metta a sistema il proposto porto-isola, l’aeroporto di Pontecagnano, la futura stazione Av di Battipaglia e i servizi che un simile nodo può attirare. È la prima volta che da Salerno si lancia un’idea che coinvolga altri territori in prospettive di sviluppo rilevanti (gran parte dell’Università, nei tardi anni ’80, fu localizzata a Fisciano-Baronissi solo per l’imposizione di De Mita che volle il «campus» come struttura in condominio fra il Salernitano e l’Avellinese). Purtroppo l’aeroporto è gestito invece molto male e stenta a conquistarsi un ruolo. E le politiche restrittive di governo e regione non solo obbligano oggi a rinviare a tempi indefiniti il salto di qualità sia per il porto che per la linea Av, ma impongono anche la cessazione del «metrò» ferroviario che a Salerno ha servito per qualche anno gli insediamenti comunali costieri, con un bacino di utenza evidentemente insufficiente.
Occorre a questo proposito sottolineare ancora la miopia municipalistica che non ne aveva considerato strategico l’inserimento organico e vivificante nella cosiddetta «circumsalernitana». Questa linea ferroviaria collega — con livelli di servizio oggi peraltro poco più che simbolici — la parte nord della piana del Sele con il capoluogo, con Cava de’ Tirreni e il Nocerino e con le valli della Solofrana e dell’Irno: una linea che serve la principale struttura urbana della provincia, con l’Università e servizi connessi e i poli industriali ancora attivi. Ma Salerno l’ha giudicata meno importante del «metrò» comunale, soltanto per il quale ha voluto binari e convogli appositi. Sicché quelle odierne di Salerno sono vicende asfitticamente edilizie che sembrano delineare una prospettiva decisamente implosiva per la città. Due casi su tutti: il Crescent e la variante 2012 al Puc.
Il Crescent
Il cosiddetto Crescent (su progetto di Ricardo Bofill) investe aree in parte demaniali al bordo del porto storico di Salerno e al margine occidentale del centro medievale. Il progetto prevede un edificio privato per residenze e uffici, alto 28 m e lungo quasi 300, ubicato sull’arco aperto verso il mare della circonferenza di una grande piazza circolare; si stima che l’edificio possa ospitare 500 residenti e qualche centinaio di addetti al terziario in un sub comparto del Puc che resta privo di urbanizzazioni secondarie. L’intervento è iniziato (il rustico imponente già incide pesantemente sul paesaggio della prima Costiera), ma non ne è ancora certa la legittimità: si discute della ammissibilità di interventi privati su aree demaniali, si afferma che un vincolo idrogeologico relativo a un piccolo corso d’acqua sia stato ignorato, è in ogni caso necessaria ora una esplicita autorizzazione paesaggistica visto che anni addietro la Soprintendenza fece scadere i termini senza esprimersi. Il cantiere è stato sequestrato dalla magistratura nel novembre scorso e le polemiche infuriano tuttora.
La variante al Puc del 2012
Dopo 5 anni dall’approvazione del piano, invece di rielaborare la sola componente operativa del Puc (interventi prioritari negli ambiti classificati come trasformabili a fini insediativi dalla componente strutturale del Puc), l’amministrazione comunale dichiara delle «criticità» riportabili a una stasi dell’attività edilizia con il conseguente mancato introito degli oneri concessori che penalizza il bilancio comunale. Essa adotta perciò una variante al Puc che incide sulla trasformabilità delle aree ai fini della «valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale»: in effetti ciò si traduce nell’attribuzione di rilevanti diritti edificatori a aree libere, di proprietà pubblica, collocate in zone centralissime della città e, peraltro, già classificate come standard. Il cerchio si chiude: quello che non era riuscito ai tempi di «tangentopoli» potrebbe realizzarsi oggi, impoverendo radicalmente la città delle sue dotazioni di spazi collettivi e incrementando la densificazione edilizia e la congestione dei quartieri centrali ancora a vantaggio soltanto delle rendite parassitarie
Riferimenti
Le precedenti puntate della serie di inchieste sulle città italiane dopo 30 anni di neoliberalismo sono state dedicate a Milano (7 febbraio), Sassari(13 febbraio), Venezia (20 febbraio), Napoli (27 Febbraio), Avellino (6 marzo), Bologna (13 marzo), Parma (20 marzo 2014), Roma (27 marzo), Firenze (3 aprile), Reggio Calabria e Messina (10 aprile), Cagliari (17 aprile 2014).
Mentre volge al termine questa bella giornata di sole e di democrazia, – questa giornata civile in cui centinaia di persone scendono in piazza, come ha detto Giovanni Losavio, per chiedere restauri! – vorrei per prima cosa ringraziarvi tutti. Vorrei ringraziare coloro che ne hanno avuto l'idea: e cioè Maria Pia Guermandi e Giuseppina Tonet, di Italia Nostra. E tutta Italia Nostra; Nicoletta Arbìzzi, presidente dell'Associazione Nostra Mirandola e nostra guida stamani: specialissimo
genius loci di questa terra e dei suoi vivi monumenti. Vorrei ringraziare Santa Nastro, che ci ha aiutato generosamente a comunicare questa giornata, e tutti coloro che ci hanno accolto e ristorato con generosità, e vorrei dire con affetto.
Tutte le altre associazioni che hanno aderito: ANISA, Bianchi Bandinelli, Comitato della Bellezza, Eddyburg, il FAI. Gli organi di tutela dell'Emilia: nostri principali interlocutori.E Massimo Bray, che ha voluto essere qua con noi. E il cui mandato da ministro è stato uno dei pochi motivi di speranza per il nostro patrimonio.
Vorrei infine ringraziare tutti gli oratori che hanno appena parlato, e voi tutti che oggi siete qua.All'Aquila – l'Aquila, a cui va il nostro saluto e il nostro continuo pensiero – abbiamo riascoltato le parole di Roberto Longhi con le quali proprio ha poco fa concluso il suo intervento Salvatore Settis.
Qua a Mirandola vorrei iniziare con altre parole, scritte più o meno negli stessi anni da un altro protagonista dei nostri studi umanistici.Dopo l'8 settembre del 1943 Augusto Campana non riuscì a rientrare a Roma, dove lavorava come scriptor della Biblioteca Apostolica Vaticana. Così, egli rimase nella sua Romagna fino alla Liberazione. Ma non si chiuse a studiare tra altri libri. Quasi ogni pomeriggio egli percorse in bicicletta i 18 chilometri che separano Sant'Arcangelo da Rimini: per sapere cosa fosse successo alle amatissime pietre di Rimini, minacciate, scomposte, distrutte dalle bombe. Egli tenne un diario, oggi edito appunto con il titolo Pietre di Rimini, che andrebbe fatto leggere ad ogni studente di Lettere del primo anno.Ve ne leggo solo una pagina:
«30 gennaio 1944, domenica. Le voci giunte a Sant'Arcangelo sul Tempio Malatestiano sono catastrofiche. Andiamo a Rimini. Il Tempio è aperto, e gente e operai vanno e vengono. Si tratta, salvo errore, di una sola bomba, caduta fortunatamente sulla parte posteriore della chiesa, che è crollata in gran parte, fino alle arcate gotiche aggiunte: nessun danno sostanziale alla parte originale, ma sbertucciature, anche ai bassorilievi. Lo spostamento d'aria ha scoperchiato totalmente il tetto, di cui rimane la sola travatura, ha distrutto il bussolone di legno alla porta d'ingresso e ha aperto la porta della cella delle reliquie (qui è intatto l'affresco di Piero della Francesca). Danni non gravi alla tomba di Sigismondo, scoperchiata dal contraccolpo il 28 dicembre. Vedo le ossa scoperte, tra calcinacci e frammenti ... Una nuova perdita grave è la casetta del Rinascimento in Via Gambalunga, un vero gioiello e un monumento a me carissimo, al quale penso da tanti anni, e con Gino Ravaioli siamo d'accordo di illustrarlo, se le mie ricerche storiche giungeranno in porto. Colpita in pieno la casetta, più che metà della facciata è crollata. Anche qui il problema è di raccogliere accuratamente i frammenti architettonici; la ricostruzione è indispensabile».
È una pagina dove ritroviamo tutti i fili che oggi ci hanno condotto qua. Campana non era un architetto, un urbanista, uno storico dell'arte. Non era un funzionario di soprintendenza. Era un umanista, un epigrafista, un filologo: ma non si curava solo di incunaboli, lapidi, manoscritti. Si curava del contesto, del palinsesto unico che circonda, accoglie, plasma le nostre vite.Era un cittadino: ed è per questo che aveva a cuore le pietre della sua citta.Ancora. Campana ccorre al Tempio Malatestiano, certo. Ma si china in egual modo sulla casetta di Via Gambalunga. Sa che ciò conta è il tessuto continuo, la relazione tra le cose, il contesto.Raccoglie i frammenti, e li connette ai suoi studi.E, soprattutto, non ha alcun dubbio: «la ricostruzione è indispensabile». In quei mesi terribili, questa è l'unica certezza. L'Italia, Rimini, sarebbero risorte com'erano e dov'erano. Era la certezza da cui scaturì la Costituzione, con il suo articolo 9. La Repubblica tutela: una «rivoluzione promessa», avrebbe detto Piero Calamandrei. Una promessa che sta a noi mantenere.
Oggi siamo qua nello spirito di Augusto Campana. Coscienti che gli storici dell'arte hanno smesso di occuparsi di architettura, felici di baloccarsi con le loro opere mobili. Che gli architetti non sanno e non vogliono saper nulla di urbanistica, presi dai loro disegni irrelati e irresponsabili. Che gli urbanisti rigettano la dimensione politica del loro lavoro. I nostri studi ci hanno costretto in una crescente segregazione. Le nostre soprintendenze hanno diviso le loro competenze in modo tale che ormai tra gli affreschi e i muri che li sostengono passano confini guardati col filo spinato.
Sappiamo che tutto questo è vero: ma sappiamo anche che ciò che è successo all'Aquila, ciò che è successo in Emilia, qua a Mirandola, ci costringe a ricordare che il nostro testo comune è la città. Questo il nostro oggetto di studio, questo il campo della nostra tutela. Se vogliamo riconquistare la capacità di incidere sulla politica, dobbiamo ricominciare ad occuparci della polis. Ed è per questo che oggi siamo qui.Uno degli episodi più luminosi del post-sisma è stata la creazione, all'interno del Palazzo Ducale di Sassuolo, di un Centro di raccolta e cantiere di primo intervento sulle opere mobili danneggiate: un centro organizzato in modo esemplare, coordinato da Stefano Casciu, soprintendente di Modena e diretto da Marco Mozzo, funzionario della stessa soprintendenza: che sono lieto di salutare. Ma se oggi siamo qua è perché la stessa attenzione non è toccata agli edifici che contenevano quelle opere. La grandissima pala d'altare della Chiesa del Gesù di Mirandola è oggi al sicuro a Sassuolo. Ma è la chiesa del Gesù a non essere al sicuro. Dopo due anni è ancora scoperchiata, e ingombra di macerie, arredi, decorazioni. Non è in sicurezza, e dunque è impossibile svuotarla: ma dopo due anni è impossibile accettare che non sia in sicurezza. Mancano soldi? Personale?
Qualunque sia il punto, siamo qua per dire ai nostri amici degli organi di tutela emiliani: ditecelo, ditelo in pubblico, sollevate il problema. Permetteteci di aiutarvi a salvare il nostro patrimonio. Non trasformatevi in una controparte dei cittadini che chiedono di riavere i loro monumenti. Siamo dalla stessa parte.Anzi. Vorremo che questa giornata fosse anche una giornata di solidarietà – vorrei dire di amore – verso le soprintendenze italiane. I 44 punti della cosiddetta rivoluzione della Pubblica Amministrazione appena annunciata dal governo di Matteo Renzi prevede l'«accorpamento delle sovrintendenze e gestione manageriale dei poli museali» e la presenza di «un solo rappresentante dello Stato nelle conferenze di servizi, con tempi certi»: e siamo certi che quel rappresentante non sarà un soprintendente. Perché, cito il presidente del Consiglio, occorre «superare i "blocchi" dei pareri paesistici e delle Soprintendenze: dobbiamo ridurre i casi in cui il parere serve». Ecco che il linciaggio delle soprintendenze iniziato su quello che fu un grande giornale di sinistra acquista ora una chiara chiave di lettura: siamo evidentemente alla resa dei conti con l'unica magistratura che, tra mille difficoltà, cerca di salvare quel che rimane del paesaggio e dell'ambiente italiani.
Siamo molto dispiaciuti che oggi non sia tra noi il ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini: che abbiamo ripetutamente invitato.Ci avrebbe fatto piacere chiedergli da che parte sta: con il suo presidente del consiglio, o con le sue soprintendenze? Non so voi, ma io non l'ho ancora capito.In ogni caso noi lo sappiamo, da che parte stiamo. E oggi vogliamo dirlo chiaro e forte: siamo con le donne e con gli uomini che ogni giorno lavorano esemplarmente nelle trincee dei nostri organi di tutela.È per questo che abbiamo voluto invitare il Direttore regionale per i beni culturali dell'Emilia Romagna, Carla Di Francesco. Per ribadire il nostro profondo rispetto per il sistema della tutela. E insieme per chiedere ascolto.Siamo vicini – o almeno lo speriamo – al momento in cui le soprintendenze architettoniche e la direzione regionale dovranno varare i progetti per la ricostruzione del patrimonio monumentale. Ebbene, in questi due anni si sono moltiplicati i segnali che ci hanno allarmato. L'astratta dottrina di alcuni teorici del restauro si è saldata ai concreti interessi di alcuni costruttori: nel cercare di far passare un messaggio che giudichiamo eversivo, quello per cui bisognerebbe, sì ricostruire il patrimonio dov'era, ma non com'era.
Al Salone del Restauro di Ferrara del 2013 lo stand del Ministero per i Beni Culturali si intitolava «Dov'era ma non com'era»: questa era la linea della ricostruzione. Il testo ufficiale, firmato proprio da Carla Di Francesco e stampato su grandi pannelli, si concludeva affermando: «di considerare questo evento drammatico come un'opportunità. L'opportunità di affermare una cultura architettonica della ricostruzione capace di prendere le mosse dalla reale situazione e consentire la coesistenza tra le preesistenze e gli edifici contemporanei, l'attualizzazione del bene culturale laddove era, dando ad esso nuovi significati vitali».Ecco, cara dottoressa Di Francesco, glielo diciamo con estrema, ma garbata, franchezza: vorremmo che nessun responsabile della tutela definisse il terremoto un'opportunità.Gli interventi che mi hanno preceduto hanno dimostrato perché rinunciare al com'era e dov'era sia un errore: un errore tecnico, architettonico, urbanistico, giuridico, storico-artistico.Se nel 1945 si fossero considerate le distruzioni della guerra un'opportunità, oggi vivremmo in città storiche largamente rifatte negli anni cinquanta: e non saremmo più felici. Equesto ci insegna a guardare, oggi, al di là del feticismo dell'edificio 'originale': a guardare invece al contesto, al tessuto, alla funzione civile e sociale dei nostri centri storici.
Ma accanto alle fondamentali ragioni culturali, ce ne sono altre: ancora più profonde. E sono quelle dei cittadini, di coloro che fanno parte della comunità ancorata a quei monumenti e a quel territorio.In un momento in cui l'unico sguardo che sappiamo posare sui nostri monumenti è uno sguardo economico è legittimo credere che i monumenti emiliani non siano stati restituiti a noi perché non sono monumenti di rilevanza turistica. Non sono Venezia, non sono Firenze: e dunque, cosa abbiamo da guadagnare nel restaurarli?Ecco: oggi siamo qua a dire che quei monumenti vanno restaurati e riaperti perché sono la riserva di futuro delle comunità che vivono intorno ad essi. E che quella comunità non è solo quella emiliana, ma è quella italiana: come dicemmo all'Aquila un anno fa, l'Emilia è un grande problema italiano.
Ed è importante aggiungere una cosa. Una parte rilevante, forse preponderante, di questo patrimonio è costituita da chiese: da luoghi di culto della religione cattolica. Noi non crediamo che il restauro di queste chiese sia un problema del clero cattolico. È un problema nostro. Perché non crediamo che quei luoghi siano proprietà solo della comunità cristiana che vi prega.La Repubblica tutela non solo il patrimonio in sé, ma la sua appartenenza alla Nazione: ogni cittadino, membro della nazione e sovrano è così proprietario dell’intero patrimonio nazionale, senza altre limitazioni. È per questo che un cittadino italiano di religione musulmana o semplicemente ateo possiede San Francesco di Mirandola non meno del prete che la officia.La chiesa del Gesù, sempre qua a Mirandola, era tenuta aperta da oltre dieci anni non dal clero, ma dall'associazione Nostra Mirandola. C'è una funzione nuova del patrimonio ecclesiastico: che non nega la sua sacralità, ma la integra con valori laici, costituzionali, repubblicani.
Chi impara a parlare la lingua di queste chiese storiche non abbraccia la storia delle istituzioni occidentali o la religione cattolica, e nemmeno la storia dell’arte italiana, ma i valori inclusivi, tolleranti e aperti della Costituzione. Non si vincola alle «radici» della identità collettiva italiana, ma accetta di fluire nelle acque – felicemente impure, mescolate, contaminate – della tradizione italianaIl patrimonio artistico è dunque divenuto un luogo dei diritti della persona, una leva di costruzione dell’eguaglianza, un mezzo per includere coloro che erano sempre stati sottomessi ed espropriati. È difficile capirlo perché nessuno, nemmeno a sinistra, ha inteso il Ministero per i Beni culturali come un ministero per i diritti. Alla sua nascita lo si è inteso come ministero per il Patrimonio, cioè per le «cose» da difendere; all’epoca di Veltroni lo si è voluto «per le Attività culturali» (cioè per lo svago e per il tempo libero); il governo Letta l’ha reso anche per il Turismo (anzi, del Turismo), e c’è chi lo vorrebbe astrattamente «della Cultura».Ma, almeno nei fatti, il Ministero per i Beni culturali dovrebbe essere, invece, un ministero per i diritti della persona: come quello della Salute, come quello dell’Istruzione. Un ministero che lavori per garantire l’accesso di ogni cittadino al patrimonio: innanzitutto l’accesso materiale, ma soprattutto quello conoscitivo, intellettuale, culturale. Un ministero che sia capace di tutelare l'integrità del patrimonio che appartiene anche a chi non ha nient'altro: e cioè il paesaggio e il patrimonio della nazione.
Cicerone racconta che Verre, corrotto governatore della Sicilia, ingiunse al Senato di Segesta di donargli una grande statua di Diana che era stata razziata dai Cartaginesi, e che Scipione l'Africano aveva riportata in Sicilia e collocata di fronte ad un tempio su un piedistallo che raccontava questa storia eroica. La perdita di quell'insieme di arte, memoria collettiva e storia era era potuta avvenire solo «magno cum luctu et gemitu totius civitatis, multis cum lacrimis et lamentationibus virorum mulierumque omnium».Ecco, questo è il messaggio che oggi parte da Mirandola: è il momento di ricostruire il patrimonio monumentale dell'Emilia dov'era e com'era. Perché lo dice la Costituzione, perché lo dice la legge, perché lo dice la nostra storia, perché lo chiedono i cittadini. Perché la forma dei nostri luoghi possa ancora dare forma alla nostra comunità, aiutarci a ricostruire la nostra democrazia. Perché ogni ferita al patrimonio dobbiamo piangerla «con un gran lutto e con il pianto di tutta la comunità, con molte lacrime di tutti gli uomini e di tutte le donne». Perché non sono degli oggetti ad esser feriti: sono i nostri diritti, la nostra democrazia, il nostro futuro.
Ed è per questo che l'Emilia monumentale distrutta dal terremoto va ricostruita dov'era e com'era.
Ora. Senza se e senza ma.