

Le recenti imprese di un protagonista del gruppo di potere dominante nell'economia e nella politica veneziane: il «king maker dello "sviluppo" che vola insieme alle colate di cemento». Il manifesto, 26 agosto 2015, con ampia postilla
Marchi è presidente Save (35,9 milioni di euro di capitale) quotata in Borsa da dieci anni, che detiene il 27,65% dell’aeroporto belga di Charleroi ed è entrata nella spa che gestisce gli scali di Verona e Brescia. Fino ad ottobre 2016, Marchi può contare sul patto parasociale con Agorà Investimenti e Marco Polo Holding (entrambe società con sede a Conegliano). Ed è riuscito perfino a piegare il finanziere franco-americano Joseph Oughourlian (presidente di Amber Capital Italia Sgr) che con il 20% delle azioni Save aveva attaccato senza pietà la gestione del «Marco Polo» da parte dello staff di Marchi.
Ma il quadrante di Tessera continua a rappresentare, da lustri, il core business dell’urbanistica a senso unico. Fin dalla «svolta» in Save con gli enti pubblici locali beffati dal governatore Galan che incorona Marchi: è la privatizzazione, perfino a dispetto di Paolo Sinigaglia (presidente di Veneto Sviluppo). Così oggi il presidente di Save sfodera un’altra operazione in grande stile: il masterplan che ridisegna tutto, con orizzonte finale 2021.
Contiene un mega-hotel di fronte al progettato terminal acqueo che da solo vale 630 milioni di investimento. Il commissario Zappalorto aveva dato il via libera, ma sono insorti i comitati dei cittadini di Tessera e Campalto. L’albergo è previsto in un’area di 10 mila metri quadrati: il 30 settembre scade il termine della manifestazione d’interesse. Un analogo progetto era già contenuto in «Porta di Venezia» firmato dall’architetto canadese Frank O. Gehry e rimasto lettera morta per assenza di finanziamenti. L’idea dell’hotel viene rispolverata accanto alla specie di Croisette con vista laguna.
Il 22 luglio il comitato cittadini di Tessera e Campalto contro l’inquinamento acustico, atmosferico e ambientale da traffico aeroportuale ha depositato in commissione Via ulteriori 17 pagine di critiche al masterplan Save. «Non può essere l’Enac il proponente di una istanza di Via di un Masterplan redatto dal gestore aeroportuale, poiché all’Enac è attribuito per conto dello Stato il compito primario di controllare e vigilare sull’operato e le scelte del gestore», spiegano evidenziando il conflitto d’interesse. Il comitato si preoccupa anche del rumore notturno all’interno della municipalità: «La frequenza dei sorvoli in allontanamento è destinata ad aggravarsi con l’aumento del 30% dei sorvoli a bassa quota». Save promette una dozzina di opere di mitigazione a Tessera? «Abbiamo conferma dalla controdeduzione del dubbio espresso nelle nostre precedenti osservazioni: il complesso delle opere di mitigazione e compensazione è stato elaborato e inserito pro forma. Appare chiaro che è un collage pubblicitario, per imbonire i cittadini».
postilla
L’area di Tessera è un punto nodale della strategia diprivatizzazione e della città e della sua Laguna. Da un punto di vistaterritoriale è uno dei tre poli sui quali si concentrano grandi operazioniimmobiliari. A Tessera sono state avviate con una serie di modifiche dellastrumentazione urbanistica e di acquisizioni immobiliare finalizzata avalorizzare economicamente un enorme complesso di aree. Nel gigantescocomplesso immobiliare dell’Arsenale di Venezia, di eccezionale valorestorico-artistico, sono in atto da tempo iniziative di privatizzazione e“valorizzazioni” degli immobili oggi di proprietà pubblica. Al Lido di Veneziasono in corso iniziative di “valorizzazione” turistica basata essenzialmentesulla privatizzazione di complessi immobiliari pubblici. I tre poli dovrebberoavere il loro collegamento funzionale con la metropolitana sub lagunare,intervento devastante per l’impatto sullastruttura geologica di base dellacittà (il “caranto”) e per l’ulteriore apporto di flussi turistici verso unacittà già alle soglie del collasso.
«È quella del terremoto senza rinascita, delle trivellazioni selvagge e della «catena di comando» fuori controllo. E dell’Abruzzo arrabbiato con il governo bipartisan. Il premier non regge le contestazioni e salta la prima tappa. In prima fila il coordinamento contro le trivelle di "Ombrina", gli studenti e i comitati per la ricostruzione». Il manifesto, 26 agosto2015
In una quasi rissa, con feriti e malori e autoambulanze arrivate per i soccorsi. E il primo ministro costretto, alla fine, a defilarsi da una porta di servizio, perché all’esterno urlano contro di lui, la sua politica e il suo governo.
La città è blindata: non si passa. Transenne ovunque, anche per i giornalisti. Vengono tenuti a debita distanza da palazzo Fibbioni, di proprietà del Comune, nel cuore del centro storico, dove impazza la consueta sfilata di politici, soprattutto Pd, e dove è prevista la tappa iniziale del presidente del Consiglio: è la sua prima volta a L’Aquila. La presenza di Matteo Renzi era stata annunciata più volte, e poi sempre smentita, da circa un anno e mezzo.
Temi centrali del summit con le istituzioni del territorio saranno, in particolare, i fondi governativi per la ricostruzione post-sisma e il problema della restituzione di tasse e contributi sospesi dopo il disastro. Ma il tour e il programma previsti vengono presto accantonati. Perché scoppia la protesta.
Grida, le forze dell’ordine cominciano a correre, i cronisti che rompono gli sbarramenti dietro i quali sono stati relegati. Ad aspettare al varco Renzi comitati di residenti e l’Unione degli studenti.
«Veniamo chiamati a fare da spettatori all’ennesima passerella istituzionale sul nostro suolo» dice William Giordano, coordinatore dell’Unione degli studenti L’Aquila, «Alle promesse mai mantenute sui tempi della ricostruzione e alla futile ricerca di consensi e mediaticità da tempo opponiamo percorsi di partecipazione attiva e reale. Non è un caso se qui sono stati raggiunti picchi di mobilitazione contro un modello autoritario di scuola e il definitivo smantellamento della scuola pubblica. Renzi ha dimostrato di procedere per forzature democratiche e di rifiutare il confronto. Per questo a L’Aquila non è il benvenuto».
In prima linea il Coordinamento No Ombrina con bandiere e striscioni bianco e azzurri, il Wwf, Legambiente e i «No triv»: tutti contro la perforazione di pozzi di petrolio in Adriatico, e in particolare a ridosso delle Costa dei trabocchi, in provincia di Chieti, in luoghi protetti e di bellezza unica. Ci sono il comitato «3 e 32» e una delegazione contro il gasdotto Snam di Sulmona.
Il parapiglia inizia sotto i portici di via San Bernardino. «Renzi, Renzi fuori dall’Abruzzo», viene ripetuto. Con il cordone delle forze dell’ordine sempre più massiccio. Arrivano le squadre antisommossa. «L’Aquila libera, mai la mafia, non la vogliamo».
I manifestanti vengono accerchiati e respinti, ci sono tafferugli e nella foga c’è chi sviene e finisce sull’asfalto: un uomo sarà soccorso e caricato in ambulanza e portato in ospedale. «È inaudito quello che sta accadendo» tuona Maurizio Acerbo, di Rifondazione comunista «Si prendono a botte cittadini che volevano soltanto avere un confronto civile».
Poco in più in là, nei pressi della villa comunale, vanno in scena gli scontri. «Via Renzi il petroliere». Forse c’è qualche lancio di pietre, forse no. «Hanno tirato sampietrini addosso alle forze dell’ordine», dirà il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso.
L’Aquila si… surriscalda. Ci sono manganellate e uova che volano di qua e di là. Da un lato la folla, dall’altra la polizia. Che picchia. Ci sono ragazzi colpiti alla testa, che debbono far ricorso alle cure, un’agente ricoverata per la frattura del setto nasale.
È il marasma e così Renzi, per motivi di sicurezza, salta il primo appuntamento e viene dirottato, in fretta e furia, verso la sede del Gran Sasso Science Institute, sempre in centro città.
In questo luogo, il premier avrebbe dovuto avere un secondo ed ultimo appuntamento con i sindacati e con le associazioni di categoria, in particolare quelle imprenditoriali e commerciali.
Impazzano i cori di critica, pesanti i toni: «Non vogliamo le lobby»; «Non ci piace lo Sblocca Italia che devasta i territori»; «Vogliamo la ricostruzione dell’Aquila».
«Renzi distrugge l’ambiente che è il nostro pane e quello delle nuove generazioni» affermano Franco Mastrangelo e Alessandro Lanci, in prima linea contro la piattaforma petrolifera Ombrina mare.
«È venuto un emissario del Pd a chiederci se tre di noi volevano incontrare Matteo Renzi. Ma gli abbiamo detto: no, grazie. Non facciamo selfie con un premier che ha dato il via libera alle trivelle ammazza-Adriatico con il sì alle perforazioni petrolifere offshore» riferisce Augusto De Sanctis, del Forum Acqua Abruzzo, «Invece di discutere con noi» conclude, «rispetti la volontà popolare di tutte le regioni adriatiche che si oppongono alla deriva petrolifera».
Vista dall’alto, dal terrapieno dove sorge la Casina Dell’Aquila, Pompei trasmette un senso di calma. Il silenzio sembra mescolarsi a una specie di muta saggezza e riveste le pareti scoperchiate, le pietre e i colonnati della città antica. In una mattina d’estate, con il sole che emette solo opachi bagliori, quel che anima le strade, il frastuono di chi visita gli scavi non intacca la quiete che pare attinga la propria misura direttamente dal mondo classico di cui Pompei è testimone. È una trama di muri e di vegetazione, di opere dell’uomo e della natura, un paesaggio culturale che, se si volta lo sguardo verso nord, scivola senza che apparentemente nulla lo contamini fino al Vesuvio, lo “sterminator Vesevo” al quale Giacomo Leopardi nella “Ginestra” conferisce il ruolo di arbitro di un destino contro cui gli esseri umani hanno pochi o nessuno strumento per opporsi. La città morta, insomma, vista da qui sovrasta ogni cosa viva, pulsante, nervosa e rumorosa, e quasi fortifica l’illusione che solo il passato sia sede dell’armonia e che qualunque contatto con il contemporaneo sia un’intrusione, indebita e rovinosa.
È, appunto, un’illusione. Meglio: una pericolosa illusione consolatoria. Senza rapporti con il contemporaneo, con il contesto, Pompei non è più nulla, non essendo un oggetto chiuso dentro la bacheca di un museo. È una città alla quale manca la condizione dell’abitare, ma della dimensione urbana possiede molte altre caratteristiche. Vive in un ambiente dal quale dipendono sia il suo stato di salute sia molte cause del suo degrado.
L’area archeologica è grande 66 ettari, la parte scavata 44. Conta 1.500 domus, vanta 242 mila metri quadrati di superfici murarie, 18 mila di superfici dipinte, 20 mila di intonaci, 12 mila di pavimenti. Pompei non è in un museo e neanche in un lembo desertico né è avvolta da una specie di green belt, una cintura protettiva, una camera di compensazione con tanti filtri che depurano tutto ciò che entra, materiale o immateriale che sia. Pompei vive, sebbene morta, in un contesto dove la densità di popolazione è fra le più alte d’Europa. La sua storia inizia nel VI secolo avanti Cristo, ma ora è parte – grosso modo il 5 per cento – di un comune che si chiama sempre Pompei, nato appena nel 1928 e dove risiedono oltre 25 mila persone. Alle quali si aggiungono, almeno, le 44 mila di Torre Annunziata, le 64 mila di Castellammare di Stabia e le 50 mila di Scafati, tre paesi che stringono la città antica in una morsa edilizia spaventosamente dilatatasi dagli anni Cinquanta del Novecento nella piana del fiume Sarno, fra il Vesuvio e il monte Faito, spazzando via campi fertilissimi e lasciando pochi lacerti di un tessuto residenziale che va ancora tristemente fiero della propria gentilezza, talvolta di una sontuosa solennità – la Reggia di Portici, le ville vesuviane. Mescolando legalità e illegalità, in quest’area della provincia di Napoli si è prodotta una qualità abitativa che anche solo un fugace sguardo coglie nell’inusuale e casuale brutalità.
Pompei è qui dentro, in un ammasso senza vuoti. È una città recintata, gli accessi sono limitati alle ore diurne (salvo rari casi). È una città laboratorio, la si studia, vi si scava. Ma la sua antica e silenziosa saggezza fa i conti con il disagio di questa terra, con gli indici della disoccupazione, in specie giovanile, indici già alti ma aggravati dalla crisi industriale degli ultimi decenni; con la criminalità camorrista; con un ceto politico e amministrativo – non tutto, per carità – che articola il proprio consenso in termini clientelari e che guarda proprio agli scavi di Pompei come serbatoio cui attingere a mani basse; con ambienti imprenditoriali che immaginano grandi affari dentro e soprattutto fuori delle sue mura; con un mondo di piccoli e spesso miserabili commerci ambulanti, attività che si affollano agli ingressi, in parte abusive o con licenze frutto di contrattazioni politiche. E poi i visitatori. Due milioni e mezzo, circa, ogni anno. (…) Pompei è un enigma italiano, metafora della condizione generale del nostro patrimonio storico e culturale, del suo stato di conservazione, dei valori che esprime e della qualità della sua fruizione. Ed è metafora di un paese, di tanti aspetti della sua vicenda politica e sociale, un paese che, prendendosi scadente cura di quel patrimonio, mostra un volto di sé rivelatore di un malessere che si fatica anche solo a definire e di una condizione non all’altezza dell’eredità ricevuta e poco adeguata al futuro che quest’eredità lascia intravedere. Pompei assume su di sé altre metafore. È la metafora di un atteggiamento politico, culturale e finanche antropologico per cui ci si muove in maniera ondivaga, inseguendo emergenze, l’ultima emergenza, forzando gli apparati amministrativi e varando provvedimenti di legge sempre in affanno, in contraddizione l’uno con l’altro, e orientandosi al massimo sulla breve durata. (…) Pompei è poi metafora delle relazioni con l’Europa, relazioni segnate da adesioni e ripulse che s’inseguono a singhiozzo, da richieste d’aiuto e timori di commissariamenti, da solidarietà e messe in mora. Dalle casse di Bruxelles provengono i 105 milioni del Grande Progetto Pompei destinati a restaurare oltre una cinquantina di domus e ad altri interventi. Deliberati nel 2012, a marzo del 2015 erano stati spesi in una percentuale minima: appena 5,9 i milioni versati per una manciata di cantieri chiusi, ma non ancora collaudati. Il programma dei lavori prevede come scadenza inderogabile il dicembre 2015, pena il rien- tro di quel pacco di milioni nei forzieri europei, a meno che non si trovi un accordo con Bruxelles per una proroga.
E ancora: come non leggere in tante recenti storie pompeiane la metafora di una dialettica fra il Grande Intervento e la cura minuta e costante, fra la Grande Opera e la manutenzione puntuale? È una dialettica giocata al tavolo di una retorica che contrappone il fare al riflettere e al discutere. Una retorica che molte cose dice dell’ethos contemporaneo e che in Italia è diventata spesso conflitto su regole e deroghe, sulle funzioni di controllo proprie di una democrazia complessa e sulle accelerazioni forzate, dettate da insofferenza verso quei controlli e scandite da invettive contro un’imprecisata burocrazia: una guerra fra procedure ordinarie e straordinarie – invocando, per gestire queste ultime, commissari, prefetti, manager e generali.
E, sempre restando all’ambito dei beni culturali, Pompei è metafora di altre discussioni, spesso ridotte a ritornello: quella su pubblico e privato, su quanto spetti allo Stato (obbligato dall’articolo 9 della Costituzione) e quanto possano fare imprese, persone singole, associazioni di cittadini, cooperative di giovani; e quella su conservazione e fruizione, perennemente sbilanciata e incapace di verificare nel concreto quanto il buon assetto della prima possa servire alla seconda e quanto un corretto esercizio della seconda sia essenziale per la prima.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
*
IL LIBRO
Il brano che qui pubblichiamo è in libreria da dopodomani L’autore lo presenta al Festivaletteratura di Mantova venerdì 11 settembre alle 16,30
«Avevo nove anni quando l’uragano Katrina si è abbattuto su di noi. È quel giorno che sono diventata nera». Madeleine Le Cesne, giovane poetessa afroamericana, ricorda così la tragedia di dieci anni fa: una «catastrofe razziale», per il modo in cui un’intera popolazione venne abbandonata per giorni alla mercè delle acque, nel collasso della protezione civile, senza i soccorsi degni della nazione più ricca del mondo. Fu quel giorno che Madeleine capì cosa voleva dire essere nera. Fu quel giorno, anche, che perse la sua innocenza. «Che cosa ricordo della New Orleans della mia infanzia? Rovine. Case abbandonate. Cimiteri. Campi di gioco distrutti. La nostra evacuazione verso il Texas. La fine di ogni fiducia. I miei genitori avevano sempre pagato le tasse, avevano sempre votato, ma nessuno si è occupato di loro. Casa nostra fu distrutta. Quest’anno, diventata maggiorenne, io non mi sono neppure iscritta al registro degli elettori».
Amarezza, disincanto, cinismo: la voce severa di questa ragazza poeta interpreta una generazione. Com’è diversa dall’aspetto ufficiale che New Orleans vuole offrire al resto del mondo, in questa settimana di celebrazioni ufficiali. Sono arrivato qui per una conferenza organizzata dalla rivista The Atlantic , quattro giorni prima della visita dei “tre presidenti”: Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton saranno tutti in città giovedì, per le commemorazioni solenni. New Orleans ha messo l’abito da festa. Per il turista distratto è più bella che mai: i palazzi storici del French Quarter, dell’epoca coloniale spagnolesca o di Luigi XIV, hanno le verande e le balaustre di ferro battuto ridipinte e lustrate, meglio che nel Mardi Gras carnevalesco. La vegetazione tropicale è lussureggiante, il quartiere residenziale del Garden District è elegante come ai tempi delle piantagioni schiaviste. Per gli intenditori il jazz è sempre sublime, per esempio allo Snug Harbor Cafe sulla Frenchmen Street o al Royal Sonesta sulla Bourbon. Ma la giornalista nera Gwen Ifill della Pbs mi mette in guardia contro le apparenze: «Questa città non è più la stessa. Non è guarita dopo quella tragedia. Fu la peggiore esperienza nella storia americana recente». È lei a sottolineare come nella “rinascita” di New Orleans «l’edificio nuovo più visibile, arrivando all’aeroporto, è un supercarcere ».
A parlare ossessivamente di rinascita, di riscatto, di “resilienza”, è il sindaco Mitch Landrieu che incontro alla conferenza di The Atlantic allo Sheraton. 55 anni, democratico, bianco. Figlio e fratello di politici di professione, anche lui il prodotto di una politica “dinastica”. Landrieu interpreta a meraviglia la volontà di riscatto di questa città, il pensare positivo.
Ha preparato nei minimi dettagli le celebrazioni di questa settimana, anche il contestatissimo invito a Bush. Landrieu non vuole cancellare le responsabilità politiche gravi di «colui che era il comandante supremo nell’ora della catastrofe». Ricorda che «la tragedia di Katrina non fu affatto una calamità naturale, fu un collasso delle istituzioni, un fallimento umano, politico, organizzativo. I danni li provocarono gli uomini, non l’uragano. La furia dell’uragano era quasi passata, quando ci fu il vero disastro e cioè il cedimento degli argini, e l’inondazione di interi quartieri cittadini». Ammette che «ancora oggi, a dieci anni di distanza, siamo solo un po’ più preparati, potremmo resistere a un uragano forza 3, ma non ad uno che raggiunga la forza 5».
Landrieu sa anche che la sua fortuna politica è indissolubilmente legata a Katrina. Che travolse il suo predecessore nero, Ray Nagin, poi condannato a dieci anni di carcere per corruzione. Soprattutto, Katrina ha modificato gli equilibri demografici ed anche elettorali di questa città. «Centomila neri evacuati non sono più tornati, la maggior parte di loro adesso vivono a Houston e Atlanta». Senza quel calo vistoso nella popolazione nera, oggi New Orleans forse non avrebbe un sindaco bianco. Né avrebbe una maggioranza bianca in consiglio comunale. È questa nuova classe dirigente guidata da Landrieu, a recitare il mantra della resilienza e della rinascita. Anche se democratico, Landrieu non prende veramente le distanze da quel grande esperimento economico, poli- tico e sociale che la destra repubblicana volle lanciare qui dopo Katrina. Che cos’è stato questo esperimento, lo ricorda un giovane artista afroamericano, Lolis Eric Elie, scrittore e regista cinematografico. «La ricostruzione della mia città — dice — ha esposto il volto peggiore del capitalismo americano. Chi dice che oggi New Orleans è rinata, usa un solo metro di misura: l’arricchimento dei ricchi».
Per capire a cosa allude Elie sono andato a seguire una contro-celebrazione del decimo anniversario di Katrina, organizzata dal centro culturale Ashe sull’Oretha Castle Haley Boulevard. Una denuncia accorata delle due principali novità introdotte nel dopo-Katrina: la privatizzazione degli alloggi popolari e delle scuole pubbliche. Noncurante della figuraccia fatta dalla sua Amministrazione nei giorni dell’uragano, Bush nel dopo-Katrina affidò New Orleans ai guru del neoliberismo. Ebbero carta bianca per sperimentare le loro ricette più estreme. Voucher ai poveri invece delle case popolari: col risultato che i poveri restano senza alloggi, perché i padroni di appartamenti privati non li vogliono. Voucher anche al posto delle scuole statali: ma le “charter school” (istituti privati che ricevono aiuti pubblici) sono libere di selezionare la popolazione studentesca, rifiutando i meno bravi per non sfigurare nelle statistiche sulle promozioni.
Tracie Washington è una leader riconosciuta della comunità nera: militante dei diritti civili, avvocatessa, presidente del Louisiana Justice Center. «La New Orleans in cui sono nata e cresciuta — dice — era una città speciale per l’intensità dei legami fra di noi. Mi era impossibile passeggiare in un quartiere senza riconoscere quasi tutti. Eravamo davvero una grande famiglia, abituati a frequentarci da generazioni. Oggi l’aver perso centomila abitanti neri, è un’amputazione, la perdita di un pezzo di quel che significava New Orleans. Questa è una città dove il 52% dei maschi adulti afroamericani sono disoccupati. Dove la gentrification espelle i neri anche dal centro storico, e gli artisti che suonano nei locali jazz non possono abitare lì vicino, neppure possono permettersi di pagare il parcheggio nel French Quarter».
Il sindaco obietta che i problemi sociali e il declino della sua città sono ben più antichi di Katrina. «Nel 1960 New Orleans aveva 680 mila abitanti — dice Landrieu — cioè più del doppio di oggi, lo spopolamento è stato graduale, inarrestabile. E sì che siamo un’area economicamente strategica per tutta la nazione. Non siamo solo la culla storica del jazz o un gioiello di architettura: qui si raffina e si trasporta più di un terzo di tutto il petrolio americano. Eppure dopo i 150 miliardi di danni provocati da Katrina, gli aiuti pubblici per la ricostruzione non sono arrivati neanche alla metà».
L’emergenza nuova che New Orleans deve fronteggiare, è un’escalation di violenza, con gli omicidi che sono risaliti quasi ai massimi storici nonostante la popolazione sia ridotta. Landrieu ammette la sua impotenza, e perfino l’incapacità di capirne le cause: «Non è un problema solo locale visto che sta accadendo anche a Chicago, Baltimora, Oakland, perfino a Boston. La stragrande maggioranza delle vittime assomigliano ai loro omicidi: sono giovani maschi neri. Noi in Louisiana mettiamo più gente in carcere che in qualsiasi altra parte d’America e del mondo, evidentemente non è questa la risposta. E continuiamo ad avere alti tassi di recidiva, chi esce dal carcere commette nuovi delitti».
Landrieu sta preparando New Orleans per un evento ben più festoso del decimo anniversario di Katrina: si avvicina il terzo centenario della fondazione della città, che coinciderà con la conclusione del suo mandato. Resilienza, rilancio, rinascita, sono gli slogan che la New Orleans bianca, ricca e turistica vuole diffondere nel resto del mondo. Di qui anche la scelta del sindaco democratico di commemorare Katrina in modo «inclusivo», senza polemiche di parte, senza regolamenti di conti: «Bush da presidente fu lento e inadeguato — dice Landrieu — ma non fu solo lui a sbagliare. Nessuno di noi fu immune da colpe». Vedere Bush qui insieme a Obama servirà almeno a ricordare una cosa: chi oggi teorizza che c’è una recrudescenza della “questione razziale” perché l’America ha un presidente nero dimostra di avere la memoria corta.
Come i grandi media nostrani, hanno rapidamente gettato nel dimenticatoio l'ultima enciclica di papa Francesco, così hanno totalmente ignorato questo importante documento del mondo islamico. Lo riprendiamo dal sito Lifegate, 19 agosto 2015. In calce il link al testo integrale della dichiarazione.
Redatta dai rappresentanti del mondo islamico, la Dichiarazione invita i fedeli a seguire il testo sacro per proteggere "il fragile equilibrio del pianeta".
Il simposio, tenutosi il 17 e 18 agosto 2015 a Istanbul, ha visto impegnati più di 60 rappresentanti del mondo islamico, provenienti da 20 Paesi. L’incontro si è concluso con la redazione della “Dichiarazione islamica sul cambiamento climatico“. Un’importante presa di posizione da parte del mondo islamico, che sprona il 1,6 miliardo di musulmani a prendersi cura del “fragile euqilibrio (mīzān) della Terra” e i leader politici a sottoscrivere degli accordi vincolanti durante la prossima Conferenza sul clima a Parigi, perché: “Le attività umane stanno facendo una tale pressione sulle naturali funzioni della Terra, che la capacità degli ecosistemi di sostenere le generazioni future non può più essere dato per scontato“.
Ecco alcuni dei passaggi più rappresentativi:
- Gli ecosistemi e le culture umane sono già a rischio a causa del cambiamento climatico;
- Il rischio di eventi estremi causati dal cambiamento climatico come ondate di calore, precipitazioni estreme e le inondazioni delle coste sono già in aumento;
- Questi rischi sono distribuiti ineguale, e sono maggiori per le comunità povere e svantaggiate di ogni Paese, a tutti i livelli di sviluppo;
-Gli effetti prevedibili avranno ripercussioni sulla biodiversità terrestre, sui beni e sui servizi prodotti dai nostri ecosistemi e sulla nostra economia globale;
- Gli stessi sistemi fisici della Terra sono a rischio di bruschi e irreversibili cambiamenti.
La dichiarazione afferma che:
- Dio ha creato la Terra in perfetto equilibrio (mīzān);
- La sua immensa misericordia ci ha dato terreni fertili, aria fresca, acqua pulita e tutte le buone cose sulla Terra che rendono la nostra vita qui praticabile e piacevole;
- Le funzioni naturali della Terra nei suoi cicli stagionali e naturali: un clima in cui gli esseri viventi – compreso l’uomo – possono prosperare. L’attuale catastrofe del cambiamento climatico è il risultato della perturbazione umana di questo equilibrio.
Qui la versione integrale della dichiarazione.
1. Stranieri ed estranei
La Repubblica, 21. agosto 2015
In questi giorni Jean Clair è a Venezia, in giro con la moglie per calli e mostre. Vent’anni fa curò una Biennale dedicata al volto e al corpo umano, ma oggi è deluso. Non gli piacciono le esposizioni affollate di turisti e quando gli si chiede di commentare la nuova riforma dei musei, all’inizio sembra possibilista, ma poi di fronte all’idea di una nuova figura di direttore-manager si accalora: «Un direttore di un museo non deve fare grandi mostre, ma far conoscere il patrimonio spirituale di una nazione. È la fine. L’arte ha perso ogni significato».
Che cosa non la convince nella riforma italiana dei musei?
«Prima di tutto ho paura che non si rispetti l’identità di un museo, la specificità della cultura locale che vi è custodita e che va tutelata».
Un direttore straniero potrebbe essere inadatto a questo compito?
«Un direttore di un museo deve per prima cosa essere un critico e uno storico dell’arte. Da questo punto di vista, scorrendo la lista dei nomi selezionati, mi pare che ci siano professionalità di rilievo. Conosco Sylvain Bellenger, che a Capodimonte farà un ottimo lavoro. Ma il problema è un altro. È un problema spirituale e culturale più ampio. Si stanno trasformando i musei in fondi bancari, in macchine finanziarie, hedge fund specializzati in speculazioni. Non abbiamo più idea di che cosa sia l’arte, di quale sia il suo compito».
Non pensa sia anacronistico tentare di arginare l’internazionalizzazione della cultura?
«Sono curioso di vedere cosa accadrà in Italia. Il fatto che molti dei prescelti siano stranieri è in sé un fatto positivo, se non fosse che dovranno operare dentro musei ridotti a macchine per incassare soldi. Io stesso prima di essere nominato al Beaubourg e al museo Picasso ho studiato in America. Ricordo il sorriso del direttore del Louvre quando decisi di partire. Mi disse: “Che vai a fare in America?” Non lo ascoltai. Sono rimasto ad Harvard tre anni. Era il 1966. Da lì sono poi andato in Canada, al museo nazionale».
Nei suoi scritti ha però attaccato più volte il sistema museale contemporaneo. Mercato e cultura sono forze antagoniste?
«Molti musei sono in mano a mercanti senza cultura. Il compito di un museo dovrebbe invece essere educare e dilettare. Il direttore dovrebbe preoccuparsi di tutelare il patrimonio d’arte che gli è affidato senza venderlo. Prenda l’idea di portare il Louvre ad Abu Dhabi. Una follia».
Crede si arriverà a questo anche in Italia?
«Ho l’impressione che tra un po’ di tempo ci sarà l’esigenza di mettere sul mercato qualche opera per rimpinguare le casse della macchina-museo. Nel 2006, Françoise Cachin, che è stata la prima donna a essere eletta direttrice dei musei di Francia, scrisse un articolo contro l’idea di vendere i musei e venne allontanata dal suo incarico. Invece aveva ragione. Le opere d’arte sono ormai ridotte a merce senza qualità, senza identità».
Immagino che l’idea di affittare un museo per eventi privati non le piaccia affatto…
«L’idea del neo direttore tedesco degli Uffizi, Eike Schmidt, di dare in affitto delle stanze della galleria segna l’inizio della fine. O piuttosto la continuazione di una decadenza della quale lui stesso sarà il responsabile finale».
Lei ha guidato grandi musei. Ora ai direttori si richiede di essere anche dei manager. Quali possono essere dal suo punto di vista le conseguenze di un tale cambiamento?
«Guardi cosa succede al Centre Pompidou, dove si è chiusa da poco una retrospettiva dedicata a Jeff Koons. La mostra è stata appaltata a privati. Duemila metri quadrati di esposizione per mettere in scena una buffoneria. Una buffoneria che prende però autorevolezza dalle collezioni del Beaubourg, che sono il vero patrimonio del museo, come l’oro conservato nei caveau delle banche. Sono Cézanne e Picasso a dare valore a Koons. I musei sono utilizzati come riserve auree per dar credito a operazioni di manipolazione finanziaria, forniscono quel deposito che dà pregio alle proposte del mercato privato. Quella di Koons è chiaramente un’operazione fraudolenta, un falso, una bolla speculativa. È quanto accade quando si preferiscono direttori manager. Come nel caso di Alain Seban, alla guida del Pompidou».
Ma per far funzionare il sistema museale servono soldi, dove trovarli?
«Il costo per mantenere un museo è ridicolo rispetto a quello della sanità o dei trasporti».
Al centro della riforma c’è l’idea di “valorizzazione”? Le piace?
«È un termine delle banche. Si valorizzano i soldi non le opere d’arte. Leggo che nei musei si apriranno ristoranti e bookshop. C’è bisogno di un manager per aprire un ristorante?»
Ha visitato la Biennale Arte?
«Tantissimi padiglioni da tutto il mondo, tutti uguali. Sono a Venezia da qualche settimana e quello che vedo mi spaventa. I musei sono molto frequentati, come le spiagge, ma non sono più frequentabili».
Come ridare significato all’arte?
«L’opera d’arte non significa più nulla, è autoreferenziale, un selfie perpetuo. I jihadisti dell’Is hanno decapitato l’archeologo Khaled Asaad. Da una parte abbiamo paesi che credono nell’arte al punto da uccidere e dall’altra pure operazioni di mercato».
Meglio tornare al passato?
«Non è possibile. Viviamo nel tempo dell’arte cloaca. Il museo è il punto finale di un’evoluzione sociale e culturale. È una catastrofe senza precedenti. Il crollo della nostra civiltà».
La riflessione sulle cause umane del cambiamento climatico, forse ancor di più quando tocca eventi remoti, apre scenari attualissimi di contrasto al grave fenomeno. La Repubblica, 20 agosto 2015, postilla (f.b.)
Il riscaldamento globale compie tremila anni. A inaugurare l’era del cambiamento climatico sono stati i nostri antenati europei, che hanno dato letteralmente fuoco alle foreste del continente per aumentare le superfici coltivabili e incrementare l’allevamento del bestiame. A dirlo è uno studio condotto dall’Istituto per la dinamica dei processi ambientali del Cnr, insieme all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il titolo del progetto parla chiaro. «Europe on fire 3000 years ago: arson or climate?» (Europa in fiamme 3000 anni fa: incendio doloso o clima?). L’equipe internazionale, guidata da Carlo Barbante, professore di Chimica analitica nell’ateneo lagunare, ha appena pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters i risultati di questa ricerca che getta una nuova luce su chi ha scagliato la prima pietra dell’inquinamento atmosferico.
In realtà l’indagine ridimensiona le colpe della rivoluzione industriale, fino ad ora ritenuta la grande responsabile del disastro ecologico. A fornire la prova regina è stata una carota di ghiaccio, lunga 2.537 metri, estratta nel Nord-Ovest della Groenlandia. Una specie di sonda lanciata nelle profondità del tempo che ha consentito ai ricercatori di fare un salto indietro di ben 128.000 anni. Grazie a una metodologia innovativa, sviluppata dal team di scienziati, è stato possibile rilevare le tracce di una forte attività incendiaria risalente a circa tremila anni fa. E non riconducibile a eventi naturali. In altre parole, una catena di incendi dolosi con conseguenti deforestazioni. Di questa task force di “forestali della storia” fa parte anche il celebre paleoclimatologo William Ruddiman, professore emerito all’Università della Virginia e padre della teoria dell’Early Anthropocene. Da sempre convinto che l’era dell’impatto ambientale dell’uomo sul pianeta, il cosiddetto Antropocene, non sia cominciata con la rivoluzione industriale ma qualche millennio prima, cioè con quella agricola. L’uomo, insomma, si è messo ad allungare le mani sull’ecosistema quando la civiltà delle macchine, la plastica, le emissioni di gas serra, le scorie nucleari, non erano neanche in
mente dei . E soprattutto quando la popolazione del pianeta superava di poco i cento milioni di anime. Più o meno gli abitanti attuali di Italia e Francia messi insieme, ma con l’universo mondo tutto per sé.
E che in quel tempo lontano sia accaduto qualcosa di veramente forte lo testimoniano le parole di Platone che, 2500 anni fa, nel Crizia , uno dei suoi dialoghi più famosi, denuncia la deforestazione sistematica del suolo dell’Attica. Quella terra verde e florida, dice il grande filosofo, è stata letteralmente spolpata, fino a ridurla uno scheletro. E di fatto la potenza ateniese pagò come prezzo la distruzione dei boschi e della vegetazione spontanea, per far fronte ad una complessa serie di bisogni economici, militari e sociali. Legna da ardere e per costruire navi. Ma anche disboscamenti per produrre più cibo. Platone arriva addirittura a prevedere fenomeni tristemente attuali come il land grabbing, l’accaparramento delle terre, e come l’effetto serra, con conseguente desertificazione del mondo. Insomma l’idea dell’apocalisse ecologica non è un’invenzione dell’integralismo ambientalista contemporaneo. L’ambientalismo di ieri e di oggi hanno però in comune l’attribuzione di ogni responsabilità agli uomini, cattivi e imprevidenti, che saccheggiano la terra senza curarsi del domani. Lo dice anche Plinio il Vecchio, che rimprovera ai suoi contemporanei di «assistere con orgoglio da dominatori alla rovina della natura». Siamo solo nel primo secolo dopo Cristo e di cattiva strada da allora ne abbiamo fatta molta.
Quel che colpisce è che questi ragionamenti venissero fatti quando la popolazione mondiale era più o meno la cinquantesima parte di quella attuale. E al confronto di oggi il mondo era un Eden. Si potrebbe obiettare che ogni epoca misura l’apocalisse a partire dai suoi parametri e dai suoi problemi. Il che è plausibile. Ma questa storia sembra pure insegnarci che, ora come allora, è insito nell’uomo un doppio atteggiamento. Di onnipotenza da un lato e senso di colpa dall’altro. Entrambi proiettati sullo sfondo di una “natura” che non è altro che il riflesso delle nostre attese e paure.
In fondo è come se la civiltà fosse da sempre bipolare. Divisa tra la fede nello sviluppo e il timore di avere osato troppo. Di avere superato il limite. Limite che cambia con i tempi, ma resta sempre come monito e come fantasma. Soglia etica e frontiera conoscitiva. È quel che emerge chiaramente dall’ultima Enciclica di Papa Bergoglio, Laudato si’, francescanamente green ma al tempo stesso lontana da ogni spiegazione semplicistica.
Viene da pensare che in molti casi perfino la nostra auto-colpevolizzazione sia l’altra faccia di un’arroganza superomistica. Tipica di chi pensa che la natura sia alla nostra mercé. Nel bene come nel male. Perché, senza nulla togliere alla fondatezza di molta riflessione ecologista, il rapporto uomo-ambiente è più complesso e multifattoriale di quanto di solito non immaginiamo. E questa ricerca sull’Europa in fiamme ce lo ricorda opportunamente.
postilla
Non è la prima né sarà l'ultima, questa ricerca, a indicare la radice degli sconvolgimenti planetari in alcuni comportamenti umani precedenti all'era dell'ancora detestata (a quanto pare) industrializzazione nel segno dell'imbrigliamento dell'energia: vapore, elettricità, carbone, petrolio, e poi la civiltà dei consumi di tutto quanto. Forse è il caso di ricordare, per chi coltiva studi territoriali, che anche le primordiali civiltà urbane crollarono per micro o macro tragedie ambientali e climatiche prodotte da attività umane di trasformazione del territorio, ne sono esempi assai noti e studiati quelli della Valle dell'Indo, della Mesopotamia, di diverse civiltà urbane precolombiane in America. Detto in altre parole, non esistono attività dell'uomo buone (l'agricoltura magari biologica o comunque «sostenibile») e altre cattive (la trasformazione di tipo industriale con uso di energie). Esiste solo il nostro rapporto con l'ecosistema, da conoscere in modo approfondito e da non alterare in modo stupido e suicida. Per esempio, cosa non nota a tutti, è proprio dagli studi sul crollo delle civiltà urbane citate sopra, e non dalle fantasie di qualche architetto chiacchierone, che nasce la teoria originaria della vertical farm, concetto agricolo produttivo ed ecologico, non edilizio come ama pensare qualcuno pronto alla condanna a prescindere (f.b.)
Il manifesto, 19 agosto 2015 (m.p.r.)
Valentina Porcheddu I l 17 agosto Dario Franceschini ha annunciato, tramite il suo account Twitter, il completamento delle procedure per la nomina dei venti direttori dei più grandi musei italiani: «Si volta pagina», ha affermato il ministro. Benché l’aspettativa di colmare «decenni di ritardi» con un concorso di portata internazionale fosse ardua da soddisfare, ieri abbiamo quasi creduto di poterci risvegliare in un paese dove il merito non è una parola vuota buona per tutte le occasioni e deciso a restituire dignità al patrimonio archeologico e artistico, attraverso «l’investitura» delle professionalità più idonee a conservarlo e promuoverlo. Invece, dopo le accese polemiche estive che hanno riguardato i fondi per la ricostruzione dell’arena del Colosseo, l’anastilosi delle colonne del Tempio della Pace ai Fori Imperiali e la mancanza di personale a Pompei, per il Mibact non è ancora tempo di successi incondizionati.
Prosegue e si estende la protesta contro uno dei mille delitti contro il territorio contenuti nel nefasto "Sblocca Italia, epitome del renzismo. ReTe, rete dei comitati, newsletter, 15 agosto 2015
L’Italia in piazza contro l’art.35 e la nuova ondata inceneritorista del Governo Renzi.
Il 9 settembre si riunirà la Conferenza Stato-Regioni per approvare il decreto attuativo dell’articolo 35, parte integrante dello Sblocca Italia.
Se approvato, l’incenerimento diverrebbe “attività di recupero” (anziché di smaltimento) e si aprirebbe la strada a nuovi impianti di incenerimento, addirittura non previsti dai Piani regionali, insieme a una miriade di “ristrutturazioni” di impianti obsoleti allo scopo di bruciare rifiuti da tutta Italia.
Il Governo, invece di impegnarsi a promuovere un Piano Nazionale del Riciclo e della Riparazione-Riuso (ed anche la reintroduzione del vuoto a rendere), misura che darebbe lavoro a centinaia di migliaia di persone (pensiamo ad esempio a tutte le operazioni di estrazione di metalli preziosi dai Rifiuti elettrici ed elettronici!) ancora una volta con l’accoppiata Renzi-Galletti si sdraia ai piedi della lobby degli inceneritori e delle fameliche multiutilities.
Se questo tentativo passasse si brucerebbe l’opportunità di estendere sempre più le buone pratiche verso Rifiuti Zero,decisive non solo per la tutela sanitaria ed ambientale delle comunità e dei territori, ma addirittura per la nostra intera economia, bisognosa delle materie prime-seconde contenute nei rifiuti. Insomma, se il tentativo dovesse andare a buon fine significherebbe bruciare in un sistema già di per sé costosissimo ed inquinante (pagato dalle bollette dei cittadini) risorse che rappresentano una ricchezza economica in grado di connettere rispetto ambientale e promozione di impresa locale e posti di lavoro.
L’altro effetto collaterale di tale “incursione piratesca” sarebbe quello di trasformare in carta straccia i Piani regionali, con una deregulation incontrollabile dei conferimenti da fuori Regione. Il paradosso sarebbe quello di Regioni che puntano sulle buone pratiche (e per fortuna ce ne sono) e che già fanno registrare obiettivi superiori al 60%-70% di RD (e che magari prevedono obiettivi superiori al 70-75% oltre a piani di prevenzione dei rifiuti) costrette ad accogliere rifiuti da tutta Italia, magari da Regioni arretrate e impermeabili alle buone pratiche.
Non parliamo poi dei cittadini: da un lato impegnatissimi a ridurre e riciclare i loro scarti e dall’altro costretti a subire l’inquinamento di chi ancora questo sforzo non lo sta facendo. Altro che Sblocca Italia! Oggi occorre uno Sblocca Cervelli, che chiuda con questo ennesimo regalo alle multiutilities e con l’incenerimento, per marciare verso un ciclo economico basato sul contrasto a tutti gli sprechi e sull’efficienza (basta con l’industria sporca ed assistita!).
Per questo un ampio cartello di forze locali e regionali con il pieno sostegno di Zero Waste Italy ha promosso per il 7-8-9 settembre mobilitazioni territoriali da svolgersi preferibilmente di fronte ai palazzi regionali, in modo da chiedere agli Enti Regioni di non firmare questo atto di prepotenza avvelenato ed autoritario (si brucerebbe non solo la democrazia dei territori ma anche quella delle autonomie locali).
Nei prossimi giorni forniremo maggiori dettagli ma già da ora è disponibile un documento di “Osservazioni” curato da Enzo Favoino, coordinatore scientifico di Zero Waste Europe e di Zero Waste Italy, da divulgare al massimo ed altri strumenti (bozze di comunicati stampa e brochure) da utilizzare da parte dei gruppi che aderiranno a questa mobilitazione.
Inceneritori Zero, Rifiuti Zero, Riciclo Totale dei Materiali: indietro non si torna!
Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe e di Zero Waste Italy
La solita prospettiva pur affascinante ma tutta centrata su architetture e stili di vita, forse manca di cogliere il nocciolo ambientale ed economico della sostenibilità urbana e di un diverso equilibrio fra natura e artificio. La Repubblica, 17 agosto 2015, postilla (f.b.)
Un'esplosione di verde. Un paradiso terrestre moderno e tecnologico. Una metropoli punteggiata dalla natura, con torri vegetali che svettano verso l’alto, fasci di edere e rampicanti che scendono a cascata dai tetti. Un corridoio ecologico di 23 torrette foto-catalitiche. Un parco naturale realizzato in spirali ascendenti e ricoperto da alghe. Torri termodinamiche con balconi che ospitano gli orti urbani.
La “Ville des lumières” riprogetta se stessa. Angosciata da un inquinamento sempre sottovalutato, Parigi si proietta nel futuro e si candida ad essere la “Smart city mondiale” del 2050. Si è candidata all’Unesco come patrimonio dell’umanità. Avviato nel giugno del 2014, il progetto è stato affidato all’architetto belga Vincent Callebaut e allo studio d’ingegneria Setec. L’idea parte dall’obiettivo di ridurre del 75% le emissioni dei gas entro 35 anni.
Il verde è quindi il cuore della pianificazione che vedrà punteggiare di natura tutti i 20 arrondissement di Parigi. Su 40 mila interpellati, ben 20 mila si sono detti pronti a collaborare con idee e suggerimenti. Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha creato un’applicazione con la quale chiunque può spedire via web una segnalazione di arredo, la proposta di restauro di una facciata, la creazione di uno spazio verde che renda più accogliente il quartiere, il condominio, uno scorcio annacquato dal grigio e dal cemento.
Se si naviga sul sito del progetto, messo in rete dal Comune, sembra di attraversare la città di Pandora, quella del film “Avatar” di James Cameron. I plastici disegnano palazzi ornati da cascate di verde che scendono dai tetti; edere che avvolgono cornicioni e balconi; aiuole e prati che separano strade; ciuffi di bambù e boschetti di alberi e piante che in modo armonico dividono le vie dalle piazze. La Torre Montparnasse, l’unica che svetta in una città risparmiata da grattacieli, è stata lo spunto di una rivoluzione urbanistica. Costruita nel giugno del 1940, ha sempre rappresentato il cuore del fermento culturale. Le trasformazioni degli anni 70 l’hanno confinata nel degrado. «Il quartiere», sostenne un anno fa Jean-Louis Missika, vicesindaco e incaricato all’urbanistica, «è spento. Va ripensato e rilanciato».
La torre diventa così l’“Atelier di Montparnasse”: un laboratorio di progettazione architettonica al quale aderiscono i sindaci delle circoscrizioni. Il dibattito ruota attorno a tre programmi di riabilitazione: spazi verdi sui tetti dei parcheggi, grandi aiuole e prati negli incroci, punti ecologici che dividono i boulevard. Il piano non si limita a un accurato make-up. Con il verde si punta a energie alternative: da quella positiva (Bepos) da ricavare negli immobili di grande altezza, fino all’idroelettrica prodotta dai circuiti delle acque.
Non si tratta di filosofia urbanistica. Il piano è già operativo. Assieme al grande progetto è scattato quello destinato a tutta la popolazione: «Il verde fai da te». Su 1200 proposte 250 sono state selezionate e finanziate. Entro un mese, gli ideatori riceveranno a casa un kit di giardinaggio con terra vegetale e semi da piantare. La parola d’ordine è “vegetalizzare”. La Parigi del futuro conserverà l’assetto lineare voluto dal barone Haussmann. Assieme ai simboli religiosi e laici della Francia moderna: tra le torri ecologiche spiccheranno sempre le Sacre Coeur e la Tour Eiffel. La storia non si cancella ma le città cambiano: invece del grigio dominerà il verde.
Alessandra Baduel, «Buona idea ma i costi la renderanno irrealizzabile» (intervista all'architetto del verde Paolo Pejrone)
Beati loro che possono pensare a questo, diventare primi al mondo nella costruzione del verde pubblico. Però sarà di certo costoso e non credo tanto rapido come i francesi si propongono». L’architetto di giardini e progettista paesaggistico Paolo Pejrone commenta così la novità di Parigi.
Architetto, Parigi dedita al verde con emissioni ridotte del 75% entro il 2050. Le sembra possibile?
«Parigi è sempre stata un luogo di sperimentazione sul verde, fin da Napoleone III e a cominciare dal suo dono alla città del Bois de Boulogne, primo parco pubblico francese. Non mi stupisco affatto. Ma credo che si tratti anche di un progetto che avrà i suoi costi» .
Si va dai tetti verdi ai balconi coltivati.
«Parigi ama stupire, gli inglesi hanno giardini e parchi bellissimi fatti in maniera più pacata. In ogni caso, ben venga che la città diventi un territorio di sperimentazione verde sotto gli occhi del mondo. La cosa che mi piace di più è l’idea dei boschetti fra le vie. Non credo affatto nel verde verticale, invece: non è né facile, né sostenibile. La verticalità è innaturale e rende le piante totalmente dipendenti dall’uomo, bisognose quindi non di una normale cura, ma di giardinieri molto esperti».
I costi prevedibili?«Sono enormi. Per l’acqua e per le cure. Ma soprattutto trovo sbagliato immaginare uno sviluppo così poco spontaneo per le piante: ci si avvicina al mondo dei bonsai, con radici e teste degli alberi tagliate, ovvero a un certo culto della sofferenza » .
E gli orti sui balconi?«Una buona idea, ma solo se davvero ben tenuti. E’ tutto molto bello, innovativo, ma come sempre poi la realizzazione dipende solo da una cosa: la passione delle persone».
postilla
Come spesso accade in certe descrizioni della metropoli futura, si colgono elementi superficiali di indubbia attrattività, senza però chiedersi «cosa ci sta sotto» davvero. E qui le risposte sono almeno due, non necessariamente in contraddizione: ci sta sotto solo un po' di interesse professionale e immobiliare, se diamo retta a questa visione tutta di progetti singoli, cascate di verzura, terrazze e tetti verdi al posto delle coperture tradizionali; oppure ci sta sotto il tema della sostenibilità interpretato in senso proprio, da una amministrazione che ha scelto di declinare seriamente, e strategicamente, un paio di concetti, ovvero le «infrastrutture verdi» e i dibattuti «servizi dell'ecosistema». Tutte queste bellissime emergenze di verzura soprattutto privata, altro non solo che i terminali capillari di un ben più vasto sistema che da un lato collega la città alla campagna senza soluzioni di continuità (una sorta di rete ecologica continua in senso proprio), dall'altro viene usata in alternativa ad altre «infrastrutture grigie» tradizionali per scopi di depurazione dell'aria, dell'acqua, e per altre funzioni come la mobilità dolce o l'agricoltura urbana. E, inquadrato in questo modo il problema, saltano anche tutte le obiezioni del paesaggista che ci trova una incongruenza economica, nella «Parigi Verde»: se sappiamo leggere l'economia alla scala adeguata, tutto si tiene molto bene, se invece caschiamo nel solito equivoco dei boschi verticali molto carini ma nulla più che giocattoli per chi se li può permettere, non cogliamo il punto. Infrastrutture verdi vuol dire proprio infrastrutture, cose indispensabili, solo che stavolta costano meno e impattano molto meno. A Parigi l'hanno capito (f.b.)
Nella serenissima Mose Capitale (un miliardo di euro il valore del «sistema parallelo» alla più grande delle opere pubbliche) detta legge la rotta unica. Il nuovo sindaco di centrodestra, di fatto, censura il fotoreporter di fama internazionale. E il Tribunale amministrativo regionale querela per diffamazione il molleggiato per antonomasia. Sono le Grandi Navi ad incarnare simbolicamente il mix di politica & business, interessi privati e sussidiarietà nazionale, istituzioni e poteri. Molto più del «cubo» dell’hotel Santa Chiara, fra piazzale Roma e il ponte di Calatrava, che per altro dovrebbe scandalizzare le anime belle almeno quanto altri «buchi neri» al Lido o le operazioni immobiliari accademiche. Così Adriano Celentano è chiamato a rispondere di diffamazione, dopo la querela del giudice Roberto Vitanza che così spiega le ragioni dell’offesa canora al Tar: «Non corrisponde al vero che esiste un decreto che vietava il transito alle navi, ma il decreto al quale si faceva riferimento era solo un'ipotesi subordinata alla preventiva individuazione delle vie alternative per l'approdo delle navi a Venezia. Invece nell'articolo si attribuisce al Tar del Veneto la diretta responsabilità per non aver impedito passaggi marittimi alle grandi navi».
I governatori non lo sanno. Se lo sanno, fanno finta di non saperlo. In ogni caso: gli inceneritori del governo non li vogliono. Un rapido riassunto delle puntate precedenti: come scritto ieri dal Fatto, lo scorso 29 luglio le Regioni hanno ricevuto la bozza di decreto legislativo che attua una delle previsioni dello “Sblocca Italia” di Renzi (approvato a novembre 2014). Il testo stabilisce la realizzazione di 12 nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti in 10 Regioni: uno in Piemonte, Veneto, Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania e Puglia, due in Toscana e Sicilia. Gli inceneritori sono sostanzialmente anti-economici, alternativi alla raccolta differenziata e hanno un impatto ambientale che puntualmente scatena le proteste furiose delle comunità a cui toccherebbe farsene carico. Infatti –governo Renzi a parte – non li vuole davvero nessuno.
Alcune delle responsabilità e dei responsabili della lunga vicenda che ha condotto al "cubo bianco", che ha straordinariamente colpito l'opinione pubblica.
Ha cominciato la giunta Tognazzi cedendo nel 1957 al proprietario dell’hotel S. Chiara un terreno pubblico a fianco dell’albergo con diritto privato a costruire.
Nel 1990 però la giunta rosso-verde, nel concludere il nuovo PRG (iniziato nel 1980), ha elaborato precise norme per i diversi Piani Particolareggiati prescrivendo in particolare (come risulta dalle norme specifiche per questo ambito) che il termine ultimo dei mezzi rotabili fosse il Piazzale Roma, separato dalla città d’acqua storica da un lato dal Canal Grande e dall’altro dal “prolungamento del Rio di S.Andrea a suo tempo interrato”. Le norme escludono “gli accessi carrabili agli edifici e agli spazi aperti”; la parte residua del piazzale viene “trasformata in giardino pubblico” . Alcuni tipi di accessi di automezzi dalla terraferma vengono vietati: una ordinanza del sindaco Casellati vieta dal giugno 1990, “con validità immediata”, l’accesso ai mezzi turistici che sono arretrati provvisoriamente al Tronchetto e in Terraferma. Altri automezzi vengono ridotti, attivando al massimo i trasporti pubblici in particolare con i mezzi F.S. alla stazione per i grandi eventi (in preparazione a un servizio navetta Mestre-Venezia poi divenuto Servizio Metropolitano Regionale di Superficie, SFMR) e con mezzi ACTV dai Terminal di interscambio terra-acqua, subito da Fusina e con programma operativo da Tessera. I Piani dei due terminal vengono ri-progettati a parte e approvati ambedue all’unanimità del Consiglio Comunale sempre nel 1990.
Ma negli ultimi vent’anni questa linea è stata prima evasa, poi rovesciata.
Già nel 1993 una prima sentenza del TAR riconosce il diritto del privato a costruire (in base agli accordi del 1957): la Giunta Comunale non ricorre e non tenta neppure una trattativa o un indennizzo.
Nel 1997 viene presentato un progetto di raddoppio dell’albergo S.Chiara ma nel 1999 gli viene opposta dagli uffici comunali e dalla Commissione di Salvaguardia la norma con l’obbligo di un Piano Particolareggiato che progetti unitariamente le funzioni e le volumetrie di tutto l’ambito di P.le Roma.
Ma per primo l’assessore all’urbanistica D’Agostino aggira la norma per poter realizzare direttamente il progetto del ponte di Calatrava che contraddice la possibilità di “chiudere la volta del Canal”. Non interessa rapportarsi paesaggisticamente al Canal Grande e ricomporre la quinta edilizia di separazione tra l’acqua e i mezzi rotabili, ma collegare direttamente (camminando in quota dal primo piano su una passerella parallela al Garage) il colmo del nuovo ponte, verso l’altra sponda del Canale tagliato trasversalmente, per raggiungere in pochi minuti l’area dove si doveva insediare il Casinò.
E così una nuova sentenza del TAR nel 2003 decide che non è necessario fare il Piano Particolareggiato, il Comune non obbietta e non ricorre.
Tre dinieghi tecnici degli uffici comunali e le obiezioni della Commissione di Salvaguardia portano almeno a rispettare le norme edilizie e ad abbassare di un piano l'altezza dell’edificio solamente verso il C. Grande, dalla parte dell’acqua.
Ma il proprietario dell’albergo chiede anche di poter fare due piani sotterranei per 14 parcheggi privati (in contrasto con tutte le norme che vietano gli scavi e i parcheggi). Nel 2009 in Consiglio Comunale un emendamento, specifico ed esplicito, del consigliere Centenaro di Forza Italia che modifica le Norme di Attuazione di una Variante al PRG della Città Antica viene approvato con il voto determinante del sindaco M. Cacciari e di alcuni consiglieri del PD (il che provoca la rottura del centro sinistra e con la municipalità).
Il permesso di costruire non viene dato dal nuovo assessore all’urbanistica Vecchiato, ma dall’assessore Bortolussi attraverso lo Sportello Unico alle Attività Produttive (SUAP) che consente deroghe alle norme.
Per lungo tempo è continuato il rapporto tra i progettisti e la Soprintendenza sulla qualità architettonica in una posizione molto visibile: la porta della città.
L’albergo esistente è derivato dalla trasformazione di un antico convento del ‘500. Nessuno ovviamente ha mai chiesto, né in città né in Commissione di Salvaguardia di fare un “falso storico” o un “finto antico”.
La posizione è particolarmente impegnativa essendo a conclusione della via d’acqua forse più famosa del mondo. Ma vi sono alcuni ottimi esempi precedenti che da anni, volendolo, hanno offerto modi eccellenti di coniugare il nuovo linguaggio architettonico con gli edifici di qualità veneziani: con leggerezza, articolando verticalmente i volumi, le strutture portanti, le superfici e i materiali: vedi in particolare il progetto di Frank Lloyd Wright per la casa dello studente Iuav proprio ‘in volta de Canal’ (a fianco di pal. Balbi) e gli edifici di Carlo Scarpa.
Ma l’esistenza di vincoli architettonici e paesaggistici ha dato un potere giuridico monopolistico alla Sovrintendente Renata Codello (anche rispetto alla Commissione di Salvaguardia) che autorizza il grossolano scatolone; il proprietario Dazzo dichiara “ringrazio la Soprintendenza per l’assistenza che ci ha dato nella revisione del progetto”.
La discussione su questo terreno è difficile perché ogni giudizio viene ritenuto soggettivo e perché la difesa del progetto si fa forte delle peggiori recenti esperienze realizzate proprio nel piazzale retrostante: la nuova Cittadella della Giustizia e il rigido, incredibilmente invasivo, parallelepipedo scuro della lunga pensilina del tram.
Se si vuole, questa discussione sugli aspetti estetici, architettonici e paesaggistici si può fare ma con criteri oggettivi e argomentati, non soggettivi e beceri.
Intanto, con un minimo di coerenza urbanistica, si può e si deve impedire l'abbattimento della Torre di S.Andrea (già autorizzato dalla Soprintendenza per un ipotetico rischio) e il conseguente grande raddoppio del Garage S. Marco.
Stefano Boato, assessore all’urbanistica della giunta rosso-verde nel 1990
Dal campo al piatto non è solo un fortunato slogan per forme agricole più urbane e sostenibili, ma anche un metodo diretto e sicuro per tutelare gli spazi aperti rendendo più consapevole la società locale. La Repubblica Milano, 12 agosto 2015, postilla (f.b.)
Tutto esaurito. È il riso a chilometro zero di Milano, prodotto nelle 65 cascine della città. E dallo scorso aprile in arrivo direttamente dai produttori agli scaffali della grande distribuzione, grazie a all’intesa siglata tra il consorzio Dam Distretto agricolo milanese) e il gruppo Esselunga. L’accordo, promosso da Palazzo Marino, è stato realizzato nell’ambito della valorizzazione del territorio rurale urbano (sono oltre 2.900 gli ettari di terra coltivata in città, dei quali circa 630 quelli coltivati a riso) e prevede che le tre varietà di riso milanese (Arborio, Carnaroli e Sant’Andrea: a questi prodotti si sono poi aggiunte anche le forniture di zucchine e fiori di zucca) arrivino direttamente dai campi delle aziende agricole milanesi ai supermercati di Milano, Monza Brianza e Pavia.
La prima fornitura di riso era di 500 quintali: inizialmente prevista per un intero anno, in quattro mesi è finita. «Il Comune - assicura l’assessore all’Urbanistica e agricoltura, Alessandro Balducci - continuerà a impegnarsi per la promozione dell’agricoltura milanese, che sempre più si dimostra un’occasione fondamentale di sviluppo e di tutela del territorio urbano ». «Si tratta di un progetto - aggiunge il presidente del Consorzio Dam, Andrea Falappi - nato per la promozione dell’agricoltura cittadina, all’insegna della filiera corta e dei consumi a chilometro zero, si sta rivelando anche un successo di mercato. E Milano si conferma una metropoli rurale a tutti gli effetti».
postilla
Ci sono due modi per leggere questo interessante processo di risensibilizzazione degli abitanti rispetto ai propri spazi agricoli: quello della «metropoli rurale» come la chiama pro domo sua il rappresentante dei coltivatori, e quello di un senso rinnovato dell'agricoltura urbana e del verde che diventa a tutti gli effetti infrastruttura portante della città. Preferiamo di gran lunga questa seconda prospettiva, che è tra l'altro il medesimo genere di sensibilizzazione che in Gran Bretagna viene operato almeno dai tempi delle prime leggi nazionali sulla greenbelt, col risultato di tutelarla efficacemente anche contro le più subdole politiche di urbanizzazione, come quelle che fanno leva sull'emergenza abitativa. Quando il rapporto di una società locale con il suo verde è così diretto che si porta in tavola ogni giorno, non c'è speculazione che tenga: la greenbelt è un accessorio di casa propria, intoccabile (f.b.)
Il sindaco Brugnaro, che possiede anche una laurea in architettura, non ha dubbi sulle qualità estetiche dell’albergo- “il bianco sposa il materiale del ponte di Calatrava”, ma è sdegnato, perché la burocrazia ha rallentato la realizzazione di “un pezzo di storia di Venezia fatto tutto con soldi di privati” . Non ha chiarito se, a suo giudizio, anche la costruzione dell’edificio (l’unico costo rimasto a carico dei proprietari, ai quali ormai regaliamo terreni, permessi, agevolazioni fiscali, concessioni, condoni) dovrebbe esser pagata dai contribuenti, ma ha invitato ad aver pazienza “l’opera va capita… e per il gusto, bisogna dargli tempo”.
L’albergo non piace, invece, a Vittorio Sgarbi che vorrebbe ricoprirlo d’edera. Non piace neppure al rettore dell’Università IUAV, Amerigo Restucci, che suggerisce alla Biennale di indire un concorso fra giovani progettisti per trovare il modo di “mimetizzarlo”. Non è escluso che, con un rivestimento vegetale, l’edificio potrebbe essere spacciato come capolavoro green ed ecosostenibile, ma a prescindere dall’opportunità di camuffare un manufatto che si addice perfettamente al modello di città a cui si ispira il sistema di potere che domina Venezia, il rettore dimentica che già nei primi anni 90’, quando il direttore era Francesco Dal Co, la Biennale di Architettura indisse un concorso internazionale per la sistemazione di piazzale Roma. E l’unico concreto risultato fu l’idea, fortemente sostenuta da Dal Co e da lui caldeggiata presso l’amministrazione comunale allora retta dal sindaco Cacciari, e quindi inserita nel piano regolatore del 1995, di costruire un ponte nella esatta posizione in cui è stato messo il Calatrava.
Da allora ha preso avvio la trasformazione di piazzale Roma, in cui si inserisce l’albergo Santa Chiara. Ha ragione, in questo senso, Elio Dazzo, il proprietario, nonché presidente dell’associazione pubblici esercizi di Venezia, quando dice “piazzale Roma, con la nuova Cittadella della Giustizia, la nuova pensilina, il people-mover, l’arrivo del tram e il ponte di Calatrava sta già cambiando volto. Non capisco perché il mio albergo, in questo contesto, non possa starci”. Ci sta, infatti, e ci sta anche F 30, il locale che Dazzo possiede sull’altra sponda del Calatrava, all'interno della stazione ferroviaria, e che viene così pubblicizzato: “con ampia metratura, si affaccia su piazzale Roma e sul ponte di Calatrava. Dispone di un ampio dehors sulla parte terminale del Canal Grande… offre servizio di bar, ristorante, pizzeria e pasticceria ed è aperto tutto il giorno. Cucina italiana con piatti di carne e pesce con cucina a vista. Musica live in serate dedicate”. Forse, queste non sono le priorità per chi va in stazione, sperando di salire su un treno regionale che non c’è più, ma sono sicuramente funzioni e attività coerenti con il contesto a cui fa riferimento il proprietario dell’albergo. Contesto, il cui progetto avrebbe dovuto essere discusso pubblicamente nella sua interezza, e che viene invece esibito un pezzo alla volta, ed ogni volta avendo cura di attirare l’attenzione su aspetti marginali, e comunque inerenti solo l’immagine dei singoli episodi architettonici.
La cittadella della Giustizia


Nello stesso periodo in cui si tesseva l’operazione Calatrava, il demanio trasferì il vicino compendio della Manifattura Tabacchi (attività sospesa nel 1997) al comune di Venezia che decise di collocarvi tutti gli uffici giudiziari della città. È stata cosi realizzata la cosiddetta cittadella della Giustizia, in parte all’interno degli edifici della Manifattura- “un’occasione per restituire alla città un’area inaccessibile”- in parte con una nuova costruzione incastrata di fianco al garage san Marco, subito insignita del premio medaglia d’oro dell’architettura italiana per la committenza pubblica, riconoscimento con il quale il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, assieme alla Triennale di Milano e a MadeExpo intende promuovere l’architettura contemporanea come “costruttrice di qualità ambientale e civile”. Tra le sue “qualità ambientali” c’è quella che i fanghi ed i materiali ricavati dagli scavi sono stati usati per imbonire un pezzo di laguna (intervento esplicitamente vietato dalla legge speciale) ed ampliare il cimitero affidato alle cure progettuali di una archistar. Tra le peculiarità formali, invece, il palazzo di Giustizia si fregia del fatto di avere un’apertura in linea con il ponte di Calatrava, che è stato scelto come “fuoco del cannocchiale prospettico!”. L’edificio “in bilico tra storia e contemporaneità” è stato pubblicato su prestigiose riviste di architettura e Fulvio Irace l’ha definito “un’agopuntura di architettura contemporanea in quel terrain vague che segna il confine tra città storica e terraferma” .
Nel 2013, la giunta del sindaco Orsoni inserì nell’elenco dei suoi progetti strategici nuovi edifici per la cittadella della Giustizia, il cui ampliamento consentirebbe di raggiungere due obiettivi importanti, ancorché non esplicitamente dichiarati: quello di fornire la “giustificazione” per la costruzione di ulteriori parcheggi e quello di liberare i palazzi storici vicino al ponte di Rialto e al Fontego dei Tedeschi, nei quali gli uffici giudiziari erano situati, in modo da poterli adeguatamente “valorizzare” (ad esempio trasformandoli in alberghi per i clienti del centro commerciale del Fontego del Tedeschi). Ovviamente, l’intervento dovrebbe essere realizzato “grazie” ad investimenti privati, secondo le regole del project financing. Per “invogliare” i privati ad aiutare la città, il comune si dichiarò disposto ad offrire una concessione di lunga durata per tutti i servizi all’interno del complesso giudiziario (bar, pulizie, riscaldamento, condizionamento, sicurezza e sistemi di sorveglianza), nonché sui parcheggi a tempo che si affacciano su piazzale Roma.
Contemporaneamente l’amministrazione comunale si attivò per accelerare la costruzione di parcheggi. La cittadella della giustizia “esige” un nuovo parcheggio, spiegò nel 2014 l’assessore alla mobilità Ugo Bergamo, con riferimento alla decisione di raddoppiare il garage san Marco con nuovi 1000 posti auto. Come è noto, nello stesso 2014, la Giustizia che lavora nella cittadella ha mandato a casa la giunta del sindaco Orsoni, ma non per questo i piani per la moltiplicazione dei parcheggi si sono fermati; anzi molti ostacoli sono stati superati.
Innanzitutto, la sopraintendenza ha tolto il vincolo sulla torre piezometrica di Sant’Andrea, eretta alla fine dell’Ottocento quando fu costruito l’acquedotto a Venezia, una delle poche testimonianze di un’epoca di modernizzazione della città non ancora distrutte o convertite in albergo. Così la torre, che si trova a pochi metri dal garage san Marco potrà essere demolita e si libererà l’area destinata alla nuova costruzione. Il commissario Zappalorto, poi, pochi giorni prima della conclusione della sua gestione, ha approvato il progetto preliminare e una apposita variante urbanistica per consentire il raddoppio del garage.
Potrebbe sembrare un’incongruenza che, con questa conclamata fame di parcheggi, si sia contestualmente deciso di demolire il garage Venezia, dal 1957 in funzione a pochi metri della cittadella. Forse era troppo piccolo, o forse i suoi gestori non hanno amici potenti.
Il garage ed il terreno su cui sorgeva fanno parte del dono fatto dal demanio al comune con il conferimento della Manifattura Tabacchi. Il comune l’ha poi ceduto, insieme ad altri terreni ed immobili al fondo immobiliare Est Capital, di proprietà di una società presieduta da Giancarlo Mossetto, ex assessore della giunta Cacciari. Dalle poche informazioni apparse sulla stampa locale, si evince che il comune non ha informato i gestori del garage del cambio di proprietà, cosicché questi hanno continuato per anni a pagare l’affitto al comune. Dopo di che Est Capital li ha sfrattati; e solo allora il comune ha trasferito i soldi regolarmente incassati. Troppo tardi, però, per salvare il garage. Non tutto è andato male, però, perché nel passaggio dal comune a Est Capital è provvidenzialmente “sparito” il vincolo sull’area che ne prevedeva un uso pubblico, per l’appunto parcheggio. Beneficata dall’inaspettato regalo, Est Capital ha quindi rivenduto l’area, senza alcun vincolo di destinazione, ad un gruppo di investitori francesi che intendono costruirvi un albergo di 50, camere, con parcheggio.
La sopraintendenza.
Se questo è il contesto, il motel al casello di Benettown è la cosa giusta al posto giusto e appaiono poco eleganti i tentativi di incolpare la Sopraintendenza per averne approvato il progetto.
L’opera è stata autorizzata dalla sopraintendenza, dice il proprietario dell’albergo, anzi ” noi lo volevamo diverso, ma abbiamo soddisfatto le richieste della sopraintendenza”. Anche Alessandro Maggioni, assessore ai lavori pubblici della giunta Orsoni, non ha dubbi “il cubo fa schifo”, ma “il comune non ha colpe, è la sopraintendenza che l’ha autorizzato”.
Finora la stampa non ha riportato eventuali reazioni di Renata Codello, la sopraintendente in questione, nel frattempo promossa a Roma, sulla quale tutti cercano di scaricare le responsabilità per la “bruttezza” del Santa Chiara. Tutte persone che nulla ebbero da ridire quando, nel 2013, durante un convegno organizzato dall’Università IUAV sul rapporto tra Venezia e l’architettura contemporanea, Renata Codello, quasi anticipando la visione renziana del ruolo delle sopraintendenze, si dichiarò favorevole a una “deregulation urbanistica a Venezia per favorire l’arrivo dell’architettura contemporanea - in una città che la vede ancora con ostilità - abolendo il sistema di norme fissate dai piani regolatori, ma stabilendo caso per caso, con le autorità competenti, Soprintendenza e Comune in prima fila - cosa è ammissibile e cosa no”. Tutti zitti, allineati e coperti, allora, ognuno pensando che forse ci avrebbe cavato qualcosa, e tutti a caccia dell’unica colpevole, adesso. Ingrati.
In mezzo a tante schifezze, spicca la visione lungimirante, la capacità di vedere come nelle grandi opere di architettura “la forma segue la funzione”, dimostrata dai quattro giovani di Jesolo che, nel 2011, hanno percorso in automobile il ponte di Calatrava e hanno poi tranquillamente parcheggiato in campo san Geremia. L’allora sindaco Orsoni decise di collocare dei “dissuasori” all’imbocco del ponte, involontariamente confermando che esso non solo sembra, ma è la bretella di collegamento tra il ponte della Libertà e i centri commerciali che la società Grandi Stazioni si è fatta, dopo essersi impadronita della stazione ferroviaria e degli edifici adiacenti, acquistati nel 1999. Centri commerciali che, nel 2009, l’ex sindaco Cacciari presentò con queste parole: “con questi interventi attesi e necessari si ribadisce la centralità di un’area che di fatto è anche collegata al terminal automobilistico di piazzale Roma grazie al ponte ideato da Calatrava “. I quattro giovinastri vennero “puniti” con il divieto di ingresso a Venezia per tre anni. Ormai i tre anni sono passati e sarebbe gentile invitarli a tornare sul luogo del delitto ed offrir loro un pernottamento omaggio al motel Santa Chiara, come premio per aver saputo captare prima di tutti la “vocazione” del luogo e lo spirito dei tempi.
Il giornalista non ha capito niente. Il fatto è che promettono interventi sopratttutto per far piacere ai loro amici, dagli attori degli appalti, giù fino al signore che vuole l'autostrada vicino al suo terrenuccio; ma poi si fanno convincere dai gufi e dai comitatini, e allora ci ripensano. Il Fatto Quotidiano, 11 agosto. 2015
Danno i numeri, letteralmente. Una festosa tradizione alla quale si è unito il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio: “In 20 mesi sbloccheremo opere per almeno 15-16 miliardi”, ha detto in un’intervista a Repubblica.
L'arma segreta è il verbo “sbloccare”, che dà l’idea di un Paese governato con lo Svitol. Non a caso lo slogan pubblicitario del popolare lubrificante è “Serve sempre!”. Ma che cosa vuol dire sbloccare? Niente, come ha spiegato ieri autorevolmente uno dei maggiori sbloccatori di sempre, Corrado Passera: “Il governo non fa che riannunciare opere già annunciate e comunque già sbloccate da governi precedenti”, ha detto ieri il ministro delle Infrastrutture del governo Monti. All’inizio del 2012 spiegò alla Camera: “L’idea è di poter vedere nel corso dei prossimi 12 mesi un ammontare di complessivi 40-50 miliardi di lavori il più possibile avviati”. Venne poi, con il governo Letta, Maurizio Lupi. Appena insediato, maggio 2013, ruppe gli indugi: “La prima priorità è vedere tutto ciò che è cantierabile, sbloccare e revocare se serve”. Un anno dopo lo svitol non aveva ancora fatto effetto, e dunque, con il nuovo premier Renzi, si passò alle maniere forti: il decreto Sblocca Italia. “Lo Sblocca Italia mira prevalentemente a sbloccare la burocrazia”, tuonò Lupi. Era l’agosto dell’anno scorso. L’afa accentuava il bisogno di sbloccare. Renzi annunciò trionfale che con le misure di sburocratizzazione contenute nel decreto avrebbe sbloccato cantieri già finanziati per 30 miliardi e 402 milioni (il dettaglio rende sempre più credibile la sparata) mentre nuove risorse avrebbero sbloccato altri cantieri già finanziati per 13 miliardi e 236 milioni. In tutto 43 miliardi e 638 milioni, per la precisione, il tutto da sbloccare entro 6-12 mesi. Dieci mesi dopo, il 6 luglio scorso, Renzi ha detto: “Per favorire la ripartenza dell'economia italiana si possono sbloccare infrastrutture per circa 20 miliardi: soldi già stanziati per opere al momento ferme”. Viene da chiedersi se i 20 miliardi di Renzi, già scesi a 15-16 nel giro di un mese, con miliardi che vanno e vengono, sono parenti di quei 43 dell’anno scorso. Cioè: sbloccati quei 43 grazie alle mirabolanti sburocratizzazioni dello Sblocca Italia, adesso ne sblocchiamo altri 15 o 16 o 20? O i 15, i 16, i 20, i 43 e i 50 di Passera sono sempre gli stessi, cioè il nulla delle parole al vento buone per catturare titoli agostani?
Passera, che parla con l’autorevolezza dell’inventore del metodo “sblocca continua”, insinua che sia tutta una presa in giro. Quando era ministro aveva istituito il sito “Cantieri Italia”, con l’impegno di informare in modo trasparente sull’avanzamento delle grandi e piccole opere infrastrutturali. L’ultimo aggiornamento del sito è datato 1 agosto 2014. La pagina cantieriecrescita.gov.it che lasciò sul sito del ministero il resoconto dell’attività di Passera è stata cancellata dai successori, come se si fosse spezzata la continuità dello Stato. Così è impossibile sapere come stanno esattamente le cose, proprio a causa dell’opacità di un governo che pure si fonda sulla comunicazione.
Qualcosa però si può intuire osservando le tracce più evidenti dello scollamento tra gli annunci e i fatti. Un anno fa, Renzi annunciò che l’Alta velocità tra Napoli e Bari avrebbe aperto i cantieri a novembre 2015 anziché nel 2018. La nuova ferrovia Palermo-Catania-Messina avrebbe aperto i cantieri a dicembre 2015. Tra poche settimane vedremo dunque i cantieri aperti? Può darsi, ma i 12 miliardi complessivi di costo delle due opere vanno nel conto dei 43 sbloccati da Renzi nel 2014 o dei 15 che Delrio deve ancora sbloccare? E i dieci miliardi di investimenti nelle autostrade –che Renzi sbloccò un anno fa promettendo ai gestori della rete la proroga delle concessioni – come li consideriamo, visto che l’Unione europea ha ribloccato il tutto bocciando l’astuta operazione come aiuti di Stato illegali? Sbloccati o da sbloccare? Il mistero è fitto. Passera ieri ha chiesto trasparenza al governo, sostenendo che è il solo modo per “capire se i 15 miliardi di cui parla Delrio sono investimenti ulteriori rispetto a opere già finanziate o sono come i carri armati di Mussolini”. Ma è evidente che per l’ex ministro, e non solo per lui, la risposta è già chiara.
Twitter@giorgiomeletti
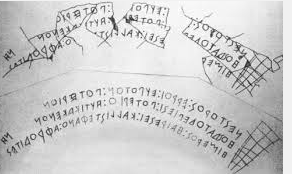 «Io sono la bella coppa di Nestore, chi berrà da questa coppa subito lo prenderà il desiderio di Afrodite dalla bella corona»: non è un verso dell’Iliade, ma avrebbe potuto esserlo. Risale alla fine dell’VIII secolo prima di Cristo, ed è dunque contemporaneo alle più antiche parti del poema omerico: la cosa straordinaria è che non lo conosciamo attraverso una lunga catena di manoscritti, ma direttamente dall’iscrizione (una delle scritte più antiche d’Italia, la più antica in greco), incisa sulla coppa stessa.
«Io sono la bella coppa di Nestore, chi berrà da questa coppa subito lo prenderà il desiderio di Afrodite dalla bella corona»: non è un verso dell’Iliade, ma avrebbe potuto esserlo. Risale alla fine dell’VIII secolo prima di Cristo, ed è dunque contemporaneo alle più antiche parti del poema omerico: la cosa straordinaria è che non lo conosciamo attraverso una lunga catena di manoscritti, ma direttamente dall’iscrizione (una delle scritte più antiche d’Italia, la più antica in greco), incisa sulla coppa stessa.Ebbene, quella coppa che in qualunque altro paese sarebbe tra le glorie nazionali, rischia ora di finire – insieme a molti altri reperti – chiusa in una cassa, sigillata in una cantina fino a nuovo ordine. Già, perché il comune di Lacco Ameno, sull’isola di Ischia, è ridotto alla canna del gas, e sta valutando di vendere a qualche ricco privato Villa Arbusto, che ospita il piccolo, ma magnifico, Museo Archeologico di Pithecusae, che prende il nome da quello della prima colonia greca d’Italia, che si installò appunto sull’isola.
Negli anni Quaranta del Novecento Giorgio Buchner – archeologo ischitano di origine tedesche – ha scavato e studiato gli oggetti provenienti da più di settecento tombe di greci e fenici, di campani e di laziali che si collocano tra il settimo secolo a. C. e l’età imperiale: la messa all’asta dell’immobile significherebbe di fatto la fine del museo che oggi li accoglie. Ed è contro questa assurdità che l’Associazione Bianchi Bandinelli ha lanciato un appello, richiamando alla vigilanza «il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo al quale la Costituzione addossa l’onore, ma anche la responsabilità, della promozione della cultura e della tutela del patrimonio storico della Nazione ». Il ministro Dario Franceschini non ha finora trovato il tempo per rispondere, mentre il sindaco di Lacco Ameno è ricorso ad una finissima metafora: «Io devo curare un tumore, e per molti cittadini il museo è solo un’unghia incarnita». Parlando poi con Costanza Gialanella, una degli archeologi della Soprintendenza cui si deve la fondazione e l’allestimento del museo, il sindaco ha detto di non poter dare garanzie sul futuro del museo. Ma i cittadini ischitani sanno benissimo che il futuro del Museo Archeologico di Pithecusae coincide con il futuro – economico e civile – della loro comunità, e l’allarme che si è diffuso ha fatto sì che nelle ultime settimane la raccolta sia visitatissima: nonostante (assurdamente, visto che si tratta di un luogo di mare) essa sia aperta solo nelle ore della mattina. La speranza è che la pressione dell’opinione pubblica induca l’amministrazione a evitare questo suicidio: la cui misura è data dalla sproporzione tra il beneficio effimero della chiusura di un singolo bilancio e il danno permanente della chiusura di un simile laboratorio di futuro.
È una vicenda esemplare: che ci ricorda che il patrimonio artistico italiano non coincide che in minima misura con i venti mitici supermusei in attesa di direttore. E che dimostra che il Sud non ha bisogno di colossali infrastrutture mangia-suolo, ma del risanamento delle economie dei comuni, e della capillare cura di un territorio straordinario, che aspetta solo di essere aperto ai cittadini e ai turisti.
Quando gli dissero che per superare la crisi bisognava tagliare i fondi alla cultura, Barack Obama rispose che sarebbe stato come provare a far ridecollare un aereo buttandone il motore fuori bordo. Una verità elementare che la classe dirigente italiana non ha ancora capito.
Il veicolo privato a combustione interna con un solo passeggero, attorno a cui si organizza tutto il resto del mondo, pare avviato a un faticoso e drammatico tramonto: quanta fatica però! La Repubblica, 10 agosto 2015, postilla (f.b.)
Il brivido al volante resterà un’emozione virtuale. Da provare quando stai incollato al mouse di un videogioco e ti misuri con i tuoi riflessi. Nella vita reale le auto del futuro sono destinate a velocità ridotte, probabilmente elettriche e sempre più spesso autonome. Guidate da un computer che ti porterà dritto alla meta senza stress, distrazioni e soprattutto consumi. Slowdrive, ecodrive, il driverless da tendenze diventano imperativi per molti governi. Finiscono per condizionare la politica commerciale delle grandi industrie automobilistiche. Perché una riduzione del limite di velocità significa più vita: meno inquinamento, meno incidenti, meno traffico, meno spese per carburanti e assicurazioni.
Anche la Francia, dopo l’Olanda e la Gran Bretagna, ha deciso che la battaglia del sindaco di Valenza, nel Drôme, il repubblicano Nicolas Daragon, non è poi così folle. Anzi, piace a molta più gente di quello che si pensava. Si corre in pista, nelle gare di rally. Su strade e grandi arterie, nella vita di tutti i giorni, meglio portare il limite di velocità dai 120 ai 90. Da sempre scettica, il ministro dell’Ecologia Ségolène Royal alla fine si è convinta e ha deciso di presentare un decreto sulla materia. «E’ necessario - ha spiegato qualche giorno fa adottare delle misure per tutelare la salute delle popolazioni attraversate da tratti di autostrada». Il sindaco della città del sudest francese si batte da anni per allentare la morsa del traffico sulla A7 che sconvolge la sua popolazione. È l’arteria più frequentata d’Europa: un fiume di 70 mila veicoli la solca ogni giorno. Tremila ogni ora, 50 al minuto. L’emissione dei gas di scarico e delle polveri sottili ha un impatto decisivo sulla vita della comunità. Tanto da spingere Daragon ad imputare al traffico la morte per tumore di 55 residenti del circondario.
Forte di tre studi che ha commissionato, il sindaco ha chiesto che il tratto della A7 che taglia la periferia di Valenza abbia un limite di 90 chilometri orari. Si è infatti accertato che anche una riduzione di soli 30 km abbassa del 5 per cento il livello di contaminazione dell’aria. Rilevazioni analoghe svolte a Parigi hanno dimostrato che imporre una velocità di 70 all’ora dagli attuali 80 riduce anche del 23 per cento il numero degli incidenti e del 65 per cento quello dei morti e dei feriti sulle strade. Pochi ci riflettono ma i numeri e i confronti aiutano a capire il male che ci facciamo. In Francia il costo annuale dei danni da inquinamento è di 101,3 miliardi: il doppio del tabacco (47) e tre volte l’alcol (31). Le mini particelle di ozono sono all’origine dei 45 mila decessi legati all’aria che respiriamo. Il decreto dovrebbe essere applicato in 12 grandi città del paese. In via sperimentale. A Parigi ha resistito 18 mesi: guidare sempre e ovunque sotto i 70 all’ora, anche nei Périphériques, ha finito per creare enormi intralci alla circolazione. Sulle autostrade è diverso. Tours, Lione, Reims, Tolone e altri grandi centri sono favorevoli. Renault e Citrôen hanno già messo a punto modelli con limiti di velocità predefiniti. Le altre case costruttrici si stanno adeguando. Fiat Chrysler in testa.
La tendenza è già futuro. Google, con Apple, sta progettando macchine totalmente robotizzate. Un computer non commette gli errori umani che sono la principale causa degli incidenti. A meno di essere hackerato. Ma questo è un altro problema. Sebastian Thurn, coordinatore ricerche mobilità della casa di Cupertino, è certo che le auto automatizzate ridurranno del 90 per cento gli incidenti, del tempo impiegato, dell’energia usata, del numero di veicoli in circolazione. Morgan Stanley ha valutato i vantaggi per una città come New York: un guadagno di 1,3 trilioni di dollari (8 per cento del Pil). Nella Grande mela si è proceduto a una simulazione sui 13 mila taxi che forniscono 500 mila corse al giorno. Per coprire il fabbisogno basterebbero 9 mila auto robotizzate. I tempi di percorrenza si limiterebbero da 5 a 1 minuto; i costi sarebbero ridotti di 7 volte. A Rotterdam ce ne sono una decina, su piccoli e previsti percorsi. Funzionano. Come un orologio. Cala lo stress, cala l’inquinamento. Guidare torna a essere un piacere. Gli unici a remare contro, in un silenzio imbarazzato, sono le assicurazioni: rischiano di perdere il 70 per cento degli introiti. Si stanno rassegnando. Hanno già pensato dove recuperare.
postilla
Come si prova a spiegare secondo varie prospettive da parecchio tempo, il processo della cosiddetta «demotorizzazione» pare ineluttabile, anche se onestamente gli organi di informazione (a differenza delle case automobilistiche e di altri comparti del mercato) e i decisori politici sembrano molto riluttanti ad accettarne il portato culturale. Probabilmente il mito della velocità fisica novecentesco, il famoso zang-tumb-tumb dei futuristi, della «automobile rombante più bella della Vittoria di Samotracia», sta non solo immerso nella nostra percezione del mondo, ma soprattutto impregna di sé una miriade di rivoli economici che non intendono esaurirsi davanti alla misera questione della propria certificata inutilità. Per esempio qualche giorno fa l'amico ed esperto di trasporti Alfredo Drufuca, leggendo criticamente un documento di programmazione settoriale del centrodestra, scopriva addirittura la categoria della «velocità percepita» come fattore di decisione tecnica, dentro uno di quei progettoni di infinite reti autostradali e corrispondente «sviluppo del territorio» circostante. Ecco quali sono gli ostacoli dell'innovazione tecnologica, sociale, della sostenibilità ambientale. Pare strano, ma davvero «il problema è politico» (f.b.)
Un episodio significativo, che non stupisce ci ricorda le iniziative che l'attuale sindaco di Venezia assunse per contrastare chi si opponeva ai Grattacieli del mare. La Nuova Venezia, 9 agosto 2015, con postilla
A fermare la mostra sulle grandi navi di Berengo - con il catalogo già in stampa, come riferisce anche il grande fotografo nell’intervista che pubblichiamo a fianco - è stato infatti il nuovo sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Il sindaco infatti ha convocato i vertici della Fondazione Musei - con il presidente Walter Hartsarich e il direttore Gabriella Belli - per comunicare loro l’opportunità di far slittare l’esposizione a data da destinarsi.
Il motivo? Perché la mostra non suscitasse polemiche e non desse un’immagine solo in negativo del passaggio delle grandi navi a Venezia, in un momento tra l’altro cruciale, con un vertice ministeriale sul problema atteso tra pochi giorni, dopo che il Tar del Veneto ha definitivamente “silurato” il progetto alternativo dello scavo del Canale Contorta-Sant’Angelo, prima sostenuto dall’Autorità portuale di Venezia.
L’idea esposta da Brugnaro - secondo quanto riferisce anche lo stesso Berengo Gardin - è quella che le sue immagini-denuncia sul passaggio delle grandi navi siano esposte in contemporanea con le tavole del nuovo progetto alternativo al transito in Bacino San Marco, a cui il presidente dell’Autorità portuale di Venezia Paolo Costa e il sindaco stanno lavorando in sintonia. Quello del cosiddetto progetto “Tresse Est”, che prevede lo scavo del Canale Vittorio Emanuele e che è già stato “annunciato” come Variante del Contorta-Sant’Angelo alla commissione “Via” del ministero dell’Ambiente, entro novanta giorni. In questo modo - secondo l’impostazione del sindaco - ci sarebbe nella mostra il momento di denuncia del problema, con le immagini di Berengo Gardin. Ma anche quello della sua soluzione, con il progetto alternativo “targato” Costa-Brugnaro, che il Governo dovrebbe fare proprio. Togliendo in pratica - con questo “fritto misto” espositivo - ogni valenza originale alle immagini di Gianni Berengo Gardin e creando così, di fatto, le condizioni per una sua rinuncia.
Di nuova data della mostra al Ducale, infatti, per ora non si parla, anche se si ventila la possibilità che possa essere prevista a fine ottobre. Ed è singolare che la nuova proposta di Brugnaro ricordi molto quella che il suo “alleato” Costa aveva già fatto a Berengo Gardin lo scorso anno, dopo le polemiche seguite alla sua denuncia di non aver potuto esporre le sue immagini a Venezia. «Quello che Le propongo», aveva scritto allora Costa al fotografo, ricevendone un cortese rifiuto, «è che, proprio partendo dalle sue opere, negli spazi della mostra si organizzino convegni e incontri sul tema di Venezia e della sua portualità. Una serie di incontri e seminari che affrontino ogni aspetto della saga sulle grandi navi in una sorta di confronto tra “verità” - più o meno scientifica - e “verità” fotografica». Un modo astuto, insomma, per “annacquare” l’effetto delle immagini di Berengo Gardin in una sorta di “festival” della crocieristica.
Ora si andrebbe oltre, perché la mostra del Ducale diventerebbe di fatto uno “spot” del progetto Tresse-Vittorio Emanuele. Usando, anche in questo caso, le immagini di Berengo come sfondo. Difficile - come pare di capire anche dalle sue dichiarazioni che riportiamo qui a fianco - che un grande fotografo con la reputazione di Gianni Berengo Gardin accetti questa mostra “a mezzo servizio”. E allora se - come è possibile - rifiuterà, la responsabilità sarà ufficialmente solo sua e il Comune potrà archiviare senza danni questa esposizione “scomoda”, che è evidentemente meglio che a Venezia non si veda.Almeno fino a quando i “giochi” sulle grandi navi e i progetti alternativi non siano finalmente conclusi.
postilla
Interessante il confronto tra i due personaggi, Gianni Berengo Gardin e Luigi Brugnaro. Berengo Gardin è certamente uno dei maggiori poeti della fotocamera, è un maestro che è il prodotto (e il dono) di un'antica cultura della bellezza e della sua rappresentazione. Luigi Brugnaro è felicemente rappresentato ed espresso da questo episodio, che Tantucci ben racconta. Due mondi incomunicabili, tra loro in opposizione. Peccato che i nostri tempi vedano la vittoria dei Brugnaro. Potrebbe forse far comprendere ai non veneziani che cosa significa il disastro delle Grandi navi in Laguna, così amate da Brugnaro, un'ideuzza, che lanciamo qui: perché non organizzare un tour europeo della mostra di Berengo Gardin? Alcune battagli per la salvaguardia di Venezia furono vinte ottenendo l'adesione del parlamento italiano e dall'opinione pubblica europea. alle proteste dei veneziani. Sul parlamento italiano c'è poco da sperare. Ma il resto dell'Europa?
Il manifesto, 9 agosto 2015
Adriatico. La rabbia dell’Abruzzo dopo il via libera del governo alle trivellazioni petrolifere. Al via ricorso al Tar ma la lotta non si ferma: «Così si distrugge turismo e agricoltura»
È «Ombrina» la parola che, più d’ogni altra, attualmente fa imbestialire l’Abruzzo e il suo milione e 332mila abitanti. E nelle scorse ore il governo Renzi, col Pd, con i suoi fedelissimi, ha regalato ad una società delle Falkland l’ok alla distruzione di uno dei tratti più belli dell’Adriatico.
Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, l’altro ieri, hanno infatti firmato il decreto di compatibilità ambientale per la costruzione della piattaforma «Ombrina mare» della multinazionale Rockhopper al largo della Costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti. È l’ultimo atto amministrativo — a parte il decreto di concessione del ministero dello Sviluppo economico che, però, a questo punto diventa mera formalità — prima dell’avvio dei lavori per la nascita dell’impianto petrolifero. Un progetto contestatissimo e combattuto da anni, da movimenti e comitati, e dai cittadini che il 23 maggio scorso a Lanciano (Ch) – erano in 60 mila — e il 13 aprile 2013 a Pescara – in 40 mila — sono scesi in massa in piazza per ribadire che questa regione non vuole diventare il regno delle trivelle. Un fiume di no ad Ombrina e alla politica energetica del premier che, tra un tweet e un selfie, sta trasformando il Belpaese in Texas. In barba alla volontà delle popolazioni. «Se ci penso… è folle… a pochi chilometri da riva, nel mezzo di un mare chiuso, vicino alle spiagge, di fronte al costituendo Parco nazionale della Costa Teatina. Ma che razza di ministero dell’Ambiente approva queste cose? - chiede la ricercatrice Maria Rita D’Orsogna - . E quale salvaguardia ci si può attendere da un ministero dei Beni culturali che, in 53 pagine più allegati, autorizza uno scempio del genere?».
Il progetto di «sviluppo del giacimento Ombrina», come spiega proprio lo sciagurato decreto numero 0000172 del 7 agosto, prevede la realizzazione «a circa 6,5 chilometri dalla costa, su un fondale di circa 20 metri, prevalentemente sabbioso», di «una piattaforma per la produzione di gas pliocenico» e petrolio «da cui si dipartiranno da un minimo di 4 ad un massimo di 6 pozzi di produzione»; di «un serbatoio galleggiante» (nave Fpso che sarà sempre in funzione con fumi, torce e termodistruttori) «per il trattamento e lo stoccaggio» del petrolio; di circa 25 chilometri di condotte sottomarine o «sealines per il trasferimento del greggio dai pozzi alla nave desolforante e del metano».
La concessione era stata originariamente rilasciata alla Medoilgas, che l’ha ceduta a Rockhopper. «La struttura – spiega Antonio Massimo Cristaldi, ingegnere di Monza, esperto in materia – porterà al rilascio di sostanze tossiche in mare, come è prassi in tutte le installazioni offshore del mondo. “Ombrina” abbraccerà ben due riserve di pesca, finanziate con fondi pubblici e comunitari, che saranno interessate da fenomeni di bioaccumulo di inquinanti gravi, fra cui mercurio e cadmio. Nel luglio 2008 – evidenzia -, le prove di produzione provocarono l’intorbidimento del mare attorno ad essa. L’Agenzia regionale di tutela ambientale (Arta) dimostrò che mentre lontano da “Ombrina” le acque erano “buone”, quelle attigue erano passate ad “inquinamento medio”. E ciò in soli tre mesi. Secondo i documenti forniti dalla ditta proponente ai suoi investitoti – spiega ancora Cristaldi – il petrolio in quest’area non è facile da estrarre e per ciò si prevede l’uso di tecniche aggressive, fra cui quelle della acidizzazione del pozzo, di violente tecniche di stimolazione, tra cui la fratturazione; dell’utilizzo di fanghi diesel di perforazione, i più impattanti che esistano. Questi fanghi sono vietati nei mari del Nord dal 2000, a causa dell’inquinamento che comportano, a seguito della convenzione Ospar. Vogliamo parlare anche dell’inceneritore installato sulla Fpso? Emetterà di continuo sostanze tossiche, come l’idrogeno solforato, un veleno ad ampio spettro. E c’è anche il pericolo di subsidenza». L’impianto sorgerà nel cuore di una riviera che sta puntando «ad una rinascita turistica», con il proliferare di attività ricettive – soprattutto hotel e bed and breakfast – , con gite in barca, con vela e surf , con la cucina tipica e la ristorazione sugli antichi trabocchi, che attraggono turisti da ogni parte del pianeta. Minacciata anche la fiorente produzione vitivinicola.
«A Matteo Renzi e ai suoi – riprende D’Orsogna — piacciono le trivelle, e non c’è democrazia, o intelligenza o buon senso che tenga. Nessuno mette navi desolforanti così vicino a riva nel mondo civile, ma in Italia sì. Le prescrizioni all’impresa? Fanno ridere. Ci sono tanto perché ci devono essere…». «Il parere positivo di Valutazione d’impatto ambientale (Via) – tuona il coordinamento “No Ombrina” -, da una prima analisi, mostra falle clamorose e un’illogica inversione procedurale riguardante l’Analisi del rischio che, per un progetto in cui basta un incidente per massacrare l’intero Adriatico, non è oggetto di valutazione preventiva ma si fa… dopo il decreto! Cioè prima si rilascia il parere favorevole e poi si studiano, da parte dell’azienda interessata, gli effetti devastanti di un incidente. Inaudito…». Anche su altri aspetti fondamentali, «come le modalità di scavo di chilometri di reti sottomarine per gli idrocarburi, quelle per l’ancoraggio della meganave Fpso lunga 330 metri e addirittura per il piano di smantellamento delle opere, il decreto rimanda a fasi progettuali successive». «Tra l’altro – sottolinea Augusto De Sanctis, del Forum Acqua — questo progetto non è stato sottoposto a Via transfrontaliera secondo quanto prevedono precise norme internazionali quando è evidente che uno scoppio o un incendio potrebbe coinvolgere le acque e le coste degli altri Paesi. Un provvedimento – aggiunge – che è solo il sigillo a scelte antidemocratiche di un governo mai eletto e che sta portando avanti politiche mai oggetto di consultazione popolare». Perché decisioni così importanti sono state prese a ridosso di ferragosto? «Sembra quasi che gli stessi estensori di tali atti si vergognino delle loro scelte. O probabilmente sperano di passare inosservati. Ma questo non è certamente possibile per “Ombrina” che è l’opera meno amata dagli abruzzesi negli ultimi anni»’: scrivono Wwf, Legambiente, Fai, Italia Nostra, Marevivo, Pro Natura e Arci.
Sotto attacco, oltre al governo, la Commissione Via nazionale, che precedentemente, a primavera, ha dato il nulla osta ad “Ombrina”. «E’ inquietante quanto emerge da interrogazioni di eurodeputati di L’Altra Europa con Tsipras e di parlamentari del Movimento 5 Stelle – afferma Maurizio Acerbo, di Rifondazione — sui componenti del comitato nazionale per la Via. Ci si aspetterebbe che a esaminare i progetti fossero fior di esperti e scienziati e invece si scoprono personaggi che poco hanno a che fare con l’ambiente e con biografie poco rassicuranti. Un vero caravanserraglio: indagati per corruzione, sospettati di legami con la ’ndrangheta, pidduisti… Quando ci raccontano che le grandi opere sono state sottoposte a tutte le verifiche ricordiamoci che razza di gente è questa». Il decreto – sostiene ancora il coordinamento “No Ombrina” — è uno schiaffo per il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso: la linea dialogante con il governo è bocciata inesorabilmente. A lui domandiamo: quando si romperà definitivamente con Renzi, che non ha timore di costruire un enorme gasdotto sulle faglie sismiche più pericolose d’Europa passando anche per L’Aquila?».
Il decreto emesso obbliga da un lato la società Rockhopper a realizzare il progetto entro 5 anni, nello stesso tempo ammette il ricorso al Tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, e al Capo dello Stato, entro 120 giorni. E su questo si sta già lavorando. «Stiamo studiando, con un gruppo scientifico e con le associazioni, il doveroso ricorso al Tar avverso detto atto governativo. Parimenti procederemo anche contro l’eventuale futuro decreto concessorio — dichiara l’assessore regionale all’Ambiente, Mario Mazzocca -. Il modello di sviluppo che vogliamo si basa su criteri improntati ad una reale sostenibilità. Per l’affermazione di questo modello di crescita la Regione, questa Regione, si batterà fino in fondo. E venderà cara la propria pelle».
«Grandi opere. Tav, super-tunnel, tram, aeroporti: tanti i progetti avulsi dalla realtà, capolavori dell'anti-programmazione. Il conflitto sull’urbanistica tra politica e università: prevale la logica dall’alto». È ovvio, caro: siamo del feudo dell'Imperatore, lì Lui comanda direttamente, non gli servono vassalli, valvassori e valvassini; al massimo adopererà qualche sgherro per i più riottosi.Il manifesto, 7 agosto 2015
A Firenze è ormai imploso il sistema delle grandi opere; a cui pure il nuovo sistema di potere renziano voleva «dare un ‘accelerazione». Invece è tutto fermo o quasi : bloccato il progetto Tav anche dalle inchieste giudiziarie; stoppato quello dell’aeroporto dalla commissione VIA (Valutazione d'Imatto Ambientale) del Ministero dell’Ambiente; a rilentissimo, con forti ritardi e disagi, i cantieri per i tram.
Il progetto dell’Enac è addirittura più grande e in contrasto con quanto previsto dal PIT Paesaggistico, che pure prevedeva un ampliamento con una nuova pista di «soli» 2 mila metri e la ricerca di una difficile compatibilizzazione con l’esigenze dell’adiacente Parco della Piana, già minacciato da altre attrezzature assai impattanti. In questi giorni il Ministero dell’Ambiente– accogliendo sostanzialmente le Osservazioni alla VIA avanzate da apposito gruppo di lavoro di docenti di Ingegneria– ha bloccato il progetto, chiedendo delucidazioni sulla sua compatibilità programmatica, sulla coerenza e sulla possibile coesistenza con altri strumenti di piano e con attrezzature già esistenti. Soprattutto ha mosso rilievi sugli impatti ambientali: rumori e vibrazioni che colpiscono abitanti e lavoratori dell’intorno, assetto idrogeologico, effetti sugli ecosistemi del Parco, insufficienti analisi sull’inquinamento atmosferico. Sottolineati anche dall’urbanista e storica Ilaria Agostini.
Il gruppo di ricerca «Mobilità sostenibile nell’Area Fiorentina» sottolinea come si sia andati avanti con progetti singolari di pezzi di linea– pure spesso variati– che guardano solo a sé stessi, con logica esasperata dalle esigenze del project-financing; anche in contrasto, oltre che con le esigenze generali della mobilità, con quelle delle altre linee. Bisogna fermarsi un attimo e redigere un Piano complessivo di rete nell’ambito di un piano di mobilità integrato per la città e l’Area metropolitana. Intanto, invece che proseguire con la realizzazione –invero assai difficoltosa come dimostrano i forti ritardi e i continui stop ai cantieri– di infrastrutture assai impattanti, si potrebbero attivare subito alcune LAM (Linee ad Alta Mobilità)con ecobus (Autobus a bassissimo consumo e impatto) su corsia riservata , che potrebbero soddisfare una domanda più ampia di quella dei tram, senza cantieri per nuove opere e disagi per la cittadinanza e l’ecosistema urbano; e in attesa di un piano per la mobilità credibile. Infine c’è quello che è ormai diventata un’icona del fallimento delle Grandi Opere. Il Grande Buco di Firenze, il supertunnel e stazione sotterranea TAV. I lavori sono sostanzialmente fermi da tempo, per due inchieste della magistratura. Ma ai problemi ambientali– irrisolti tuttora– messi in luce dall’inchiesta (compatibilità della fresa con il sottosuolo interessato, caratteristiche dei materiali, natura delle terre di scavo, oltre agli aspetti più evidentemente penali, legati a corruzione e irregolarità amministrative) se ne sono nel tempo aggiunti diversi altri, puntualmente segnalati dal Gruppo di lavoro dell’Università sul tema.
Tra questi la mancanza di VIA della megastazione sotterranea; che perdura , nonostante le inchieste che hanno investito MinAmb proprio su questo tema. «Se si fa la VIA della Stazione Foster non si fa più il Sottoattraversamento!» urlò Matteoli,allora ministro berlusconiano dell’Ambiente e la VIA non si fece più : anche perché avrebbe esplicitato la presenza di problemi insormontabili. Ancora non ci sono le Autorizzazioni Paesaggistiche, il che rende abusive le (poche) attività in essere che andrebbero subito fermate. Soprattutto, grazie agli studi di Teresa Crespellani e Massimo Perini, oltre a Giovanni Vannucchi, c’è oggi molta più contezza sugli effetti dello scavo dei tunnel, finora mai avviato: emerge l’incompatibilità della natura e delle dimensioni delle operazioni previste con le particolari caratteristiche del sottosuolo fiorentino; specie in presenza di forte urbanizzazione , con patrimonio abitativo densissimo, presenza di monumenti direttamente impattati e pochissima distanza dal core dell’enorme patrimonio artistico del centro Storico. Appare purtroppo corretto prevedere piccoli e grandi disastri , la cui entità specifica è oggi impossibile da stimare, a fronte dei più che probabili problemi continui, lesioni, cedimenti, crolli. Firenze continua a soffrire il continuo tentativo di imposizione di “grandi progetti”, in realtà operazioni quasi sempre avulse dalla reale domanda sociale; ma finalizzate a spendere a breve, a beneficio degli interessi speculativi che ne condizionano e distorcono la governance. Tale logica va abbandonata per tornare a scenari di pianificazione corretta e sostenibile del territorio e dei trasporti.
Presentazione del resoconto sull'attività svolta nei primi due anni di mandato dell'assessore alla trasformazione urbana della giunta Marino. Le iniziative in corso e le sfide da cogliere per la città di domani. Conferenza stampa del6 agosto 2015. Con una premessa
Premessa
È con molto piacere che presentiamo il resoconto dell'assessore Caudo. Conoscevamo da tempo la mole e la qualità del lavoro svolto, la sterminata quantità di fatica che costa invertire in pochi mesi (e praticamente senza struttura idonee) trent'anni di scelte urbanistiche sbagliate.
Poichè il punto è questo. Come comprenderà chi avrà la pazienza di leggere i documenti allegati (ma senza pazienza non si comprende e si è costretti a esprimere giudizi superficiali) Caudo e la sua piccola équipe hanno dovuto, con il sostegno del sindaco Ignazio Marino, cancellare scelte urbanistiche negli anni di Alemanno ma decise in sostanziale continuità con la visione formata e consolidata negli anni di Rutelli e Veltroni: la visione e la prassi iniziata quando, nel 1993, si teorizzò e praticò il metodo del "pianificar facendo": cioè si scelse di passare all'attuazione delle previsioni di un piano formato sulla base della situazione sociale ed economica degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, ed enormemente sovradimensionato rispetto alla esigenze della fine del secolo scorso.
Certo, sarebbe stato meglio per tutti se Giovanni Caudo fosse stato assessore all'urbanistica in quegli anni: avrebbe potuto cavar via molti più volumi edilizi inutili. Ma il problema non sono le singole persone, la lori capacità tecnica e la loro personale visione delle cose. Il problema è il contesto nel quale si opera, qual'è in quel momento l'ideologia egemone. E dalla fine degli anni Ottanta l'ideologia era quella della crescita indefinita di tutti i valori economici: a partire da quelli determinati dalla crescita della rendita fondiaria.
Costruire di più era l'aspettativa dominante di chiunque avesse un pezzetto di terra urbanizzabile: un'aspettativa quasi sempre accettata come legittima da troppi politici, amministratori, e tecnici pronti a ogni compromesso pur di seguire il "principe".Questa ideologia è oggi ben lungi dall'essere contraddetta, nè è in vista il nascere di una promettente contro-egemonia - almeno sul terreno specifico delle politiche del territorio. Anche per questo occorre essere grati all'assessore Caudo e a chi lo sostiene, e aiutarli a proseguire il loro sforzo. (e.s.)
DUE ANNI DI SCELTE PER ROMA
Introduzione alla conferenza stampa del 6 agosto 2015
Sono passati due anni dal primo atto della giunta Marino quello di cancellare gli ambiti di riserva previsti da una delibera di Alemanno, 20 milioni di potenziali metri cubi di cemento per 160 proposte di nuove urbanizzazioni che si sarebbero riversati su 2300 ettari di Agro romano. In seguito abbiamo cancellato altri 5 milioni di metri cubi di cemento, all’Ex Snia, al Casilino, abbiamo revocato la delibera sulla valorizzazione delle caserme e ridotto i volumi in altre delibere come quella della ex fiera, da 93 mila mq a 67.500 mq.
Sono state scelte fondate sulla convinzione che il ciclo novecentesco della città dell’espansione è finito. Ma non sono scelte contro lo sviluppo o contro la legittima attività economica dei privati. Sono scelte che riaffermano il rispetto delle regole e orientano in modo inequivocabile il futuro della città verso il riuso dell’esistente, del già costruito del già urbanizzato.
I fatti ci dicono che, anche grazie ad una forte regia pubblica, soggetti importanti hanno scelto Roma per investire e non solo per fare case. A cominciare dagli oltre 100 milioni che Telecom investe per portare il quartier generale di TIM nelle Torri di Ligini, per le quali è previsto il restauro funzionale e il ritorno alla destinazione d’uso a uffici. Un intervento che riqualifica l’intero quartiere dell’EUR. Oppure, in centro storico, a largo Santa Susanna, da centro commerciale a uffici. Continuando con i diversi protocolli d’intesa con CDP, per il quartiere della Scienza e l’housing sociale. Ammontano a 190 milioni gli investimenti che il consiglio di amministrazione del fondo immobiliare Investire Abitare gestito da CDPi sgr ha già deciso su Roma, l’ultimo di 100 milioni il 24 Luglio scorso. A tutto questo si può aggiungere lo stadio di Tor di Valle, ora all’esame della Regione Lazio, il cui investimento, anche questo tutto privato, ammonterà a circa 1,2 miliardi di euro di cui 325 saranno di opere pubbliche.
L’attività dell’assessorato alla Trasformazione urbana, in questi primi due anni, ha guardato però anche a Roma prossima, alla Roma di domani, con i progetti di Roma 2025 e Roma resiliente, volti a ridefinire le priorità nuove del governo urbano, che guardano alla cura e alla ricucitura, al ciclo delle acque e a quello dei rifiuti, alle infrastrutture anche minute e all’ecosistema.
Ma ha scelto al tempo stesso di dare impulso per portare a termine i progetti e i piani già incardinati nel PRG del 2008. Modificando le regole, come nel caso della nuova convenzione per i Piani di zona e il nuovo schema di convenzione urbanistica con i privati, per dare maggiore certezza alla conclusione dei programmi e alla realizzazione delle infrastrutture. Case insieme ai servizi e anche case a un prezzo accessibile.
Abbiamo rifinanziato il progetto di piazza Augusto Imperatore, con 12 milioni di euro, e aperto cantieri nell’ex Mattatoio per altri 12 milioni. Abbiamo chiesto agli uffici che seguono i piani di edilizia economica e popolare una particolare dedizione nel verificare e nel promuovere la realizzazione delle opere primarie e secondarie che i lembi estremi della città aspettano da anni, fra i casi più emblematici Montestallonara o Castelverde.
Con le restrizioni del patto di stabilità e con le difficoltà di bilancio gli investimenti privati nella realizzazione di opere pubbliche diventano ancora più importanti e strategici per l’economia della città. Oggi ai cantieri aperti per opere pubbliche a scomputo, con fondi privati, corrisponde un valore economico di circa 150 milioni di euro. Nel solo 2014 abbiamo ultimato due scuole, una a Tor Pagnotta, una a Vigna Murata e un mercato (plateatico) a Lunghezza-Ponte di Nona. Fogne per 21 km, di cui 7 per acque nere, 2.500 Punti luce (Torrino Mezzocammino, Papareschi, Ponte di Nona). E ancora strade per 56 ha e Parchi per 99 ha. Inoltre nella manovra di assestamento votata il 1 Agosto ci sono circa 64 milioni di euro di opere a scomputo in quartieri come Torresina, La Storta e Borghesiana Pantano. Abbiamo anche inserito per l’Acquisizione di aree nei piani di zona altri 17 milioni di € mediante compensazioni di cubature, la cosiddetta cessione compensativa, ad esempio a Tor Vergata 2, via Lucrezia Romana, Casilino Bis, Infernetto ovest.
Ed è prossima l’apertura di nuovi cantieri, come quelli previsti dalla delibera approvata la scorsa settimana su Tor Bella Monaca e Torre Angela che prevede lavori, soprattutto per i nuovi collegamenti stradali, per 50 milioni di euro. Un utile termine di paragone: nel 2014 le opere pubbliche finanziate direttamente dal comune di Roma ammontano a 30 milioni di euro.
Abbiamo approvato ed è in corso di realizzazione la stazione ferroviaria a Ponte di Nona, finalmente il quartiere si avvicina alla città. Era una condizione per la sua edificazione, ora finalmente ci sarà la stazione.
Abbiamo convinto il privato ad appaltare il cavalcavia del Gra e rendere possibile il completamento del corridoio di trasporto di superficie tra Laurentina e Tor Pagnotta 2, il cantiere è stato avviato ad ottobre scorso, anche questo erano anni che lo si aspettava. Abbiamo ultimato l’isola pedonale del Pigneto e completato così gli obblighi del privato collegati alla riqualificazione della ex Serono, 1,8 milioni, anche questo si aspettavano da anni.
Abbiamo riavviato le opere pubbliche a Casal Bertone, sono in corso i lavori per il parco di via Pollio. Abbiamo concluso il contenzioso dei frontisti della TAV, 35 famiglie a cui era stata promessa una casa a seguito del passaggio dell’Alta velocità. Ora le 35 famiglie hanno firmato i contratti di acquisto degli immobili e RFI può avviare i lavori, dopo quasi venti anni di battaglie e di trascuratezza.
Due anni in cui, anche grazie al lavoro dell’Assemblea capitolina e della commissione urbanistica, con le 91 delibere approvate, 61 di giunta e 30 di assemblea, abbiamo potuto disegnare trasformazioni importanti e favorito opere minute e diffuse.
Abbiamo aperto gli uffici al dialogo e all’ascolto di tutti e dedicato sempre una attenzione particolare alle esigenze dei cittadini come nel caso dei prezzi massimi di cessione delle abitazioni nei piani di zona.
E mentre seguiamo il quotidiano, anche quello che può sembrare più minuto, pensiamo a Roma prossima, attraverso tre iniziative: Roma 20-25, con 24 università nazionali e internazionali, Conferenze urbanistiche, con la partecipazione di oltre 2.000 cittadini nei 15 municipi, Roma Resiliente assieme ad altre 100 città nel mondo.In queste ore siamo impegnati, con lo stesso spirito e finalità, a cogliere l’opportunità del giubileo della Misericordia perché a Roma, quella che vive Oltre-Gra, resti il lascito importante del giubileo di strada, migliorando le condizioni di vita di chi ancora aspetta strade, piazze, spazi verdi. Abbiamo individuato luoghi e interventi, sedici in tutto, per un ammontare di circa 6 milioni li abbiamo presentati alla presidenza del consiglio per avere finanziamenti e agevolazioni per i tempi di realizzazione.
Qui si può scaricare "Due anni di scelte urbanistiche. Come cambia Roma" : una relazione contenente l'elenco ragionato delle iniziative assunte e delle delibere approvate, introdotto da alcune riflessioni dell'assessore.