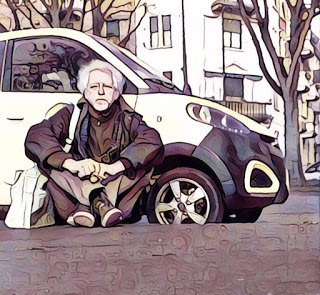«
Cosmopoli multietnica e multireligiosa, città-mondo ed economia-mondo sono i termini che usiamo per indicare ieri Venezia, oggi New York, Hong Kong o Mumbai». Doppiozero
online,
19 dicembre 2016 (c.m.c.)
Da Weber e Simmel a Saskia Sassen, la città è cosmopoli, riunisce e ‘ordina’ (kosmos) individui diversi per estrazione sociale e provenienza geografica, non tutti cittadini però – la città da sempre ospita molte figure intermedie e provvisorie, spurie. Molto più degli Stati che confinano ed espellono, le città sono luoghi di mescolanze e ibridi, con tutti i significati e i valori che ciò porta al processo di civilizzazione. Come quest’ antico lascito sia tuttora vitale è un aspetto non trascurabile della nostra visione del mondo.
1. Ieri
Venezia, come dimostra il materiale iconografico raccolto in “
Venezia, gli Ebrei e l’Europa 1516-2016” a cura di Donatella Calabi ed esposto in mostra al Palazzo Ducale di Venezia, è il luogo simbolico di una sorprendente pagina di storia del cosmopolitismo europeo. Ci si aspetterebbe che la formazione nel 1516 del primo ghetto d’Europa fosse processo di chiusura, persecuzione di minoranze religiose e prototipo di ogni futura segregazione. E invece la città ha lì sperimentato, in un’epoca di espulsioni e forzate conversioni, di crociate e di stermini a sfondo religioso guidati dall’Occidente, un mix di convivenza etnica e religiosa che prepara la moderna cosmopoli: forse unica Utopia del nostro tempo segnato da nuove linee di frattura.
La ragnatela delle persecuzioni antiebraiche nei due secoli che precedettero il ghetto veneziano, dalla Spagna e Portogallo alla Francia agli staterelli di ciò che restava del Sacro Romano Impero germanico, rende ancora più forte ed ‘eccentrica’ la scelta della Repubblica veneziana di ospitare, certo circoscrivendoli in uno spazio controllato, gli Ebrei in città.
Già essi erano internamente articolati (italiani tedeschi levantini portoghesi) e parlavano lingue e praticavano riti diversi, come testimoniano le diverse sinagoghe (italiana, spagnola, levantina). Ma l’intera città era un mosaico di comunità straniere, ospitate e circoscritte: albanesi, greci ortodossi, turchi, arabi, persiani, tedeschi. Ne rintracciamo ancora i segni nel tessuto urbano.
‘Zone naturali’, simili a quelle che a Chicago saranno create nell’immigrazione del Novecento colorandosi di italiani, polacchi, irlandesi, ebrei (cui il sociologo Louis Wirth dedica nel 1928 “
The Ghetto”, storia della comunità ebraica che nella metropoli si auto-seclude e quando la seconda generazione di immigrati cercherà di abbandonare quello spazio, fatalmente li riattrarrà ‘costringendoli’ a tornare volontariamente sui propri passi).
A Venezia la chiusura del ghetto, la sorveglianza notturna lungo il canale perimetrale imposta agli (e pagata dagli) stessi Ebrei a opera di custodi cristiani, gli insulti che accompagnavano le imbarcazioni che portavano i feretri al cimitero ebraico del Lido: sono tutti aspetti ben documentati, compresi gli effetti imprevisti eppure benefici come l’apertura ad opera degli Ebrei di un nuovo canale (il canale degli Ebrei a Castello) per far transitare quei feretri, che porterà vantaggi a tutta l’economia urbana.
Ma colpisce la porosità urbanistica e culturale del confine imposto, il dialogo tra veneziani ed Ebrei anche lungo e nonostante quel bordo, e soprattutto l’apertura diurna che permette agli Ebrei di alimentare tutte le attività e i traffici della città commerciale. Il dialogo è raffigurato dall’incantevole Carpaccio nella predica di santo Stefano, in cui si affollano turbanti e lunghe barbe ad ascoltare il santo in un paesaggio urbano che è Venezia e insieme Gerusalemme. Perfetta rifrazione urbanistica del dialogo tra due mondi culturali. Innovazioni urbane e dialogo filosofico che si svolgono al più alto livello intellettuale tra Ebrei e cristiani.
La mancanza di spazio poi produce quella rilevante innovazione della crescita verticale delle abitazioni del ghetto Nuovo e Nuovissimo, quella piccola Manhattan che ancora si visita con sorpresa alzando gli occhi verso l’alto nel sestiere di Cannaregio. E poi colpisce la forte integrazione dell’élite ebraica nell’élite veneziana, documentata intorno a figure che tra Sei e Settecento rallentano la lunga braudeliana decadenza della Repubblica. La ricchezza degli Ebrei, che non poteva tradursi in rendita urbana per mancanza di titolo alla proprietà immobiliare, si traduceva in flussi finanziari, in moneta circolante: inaugurando nei banchi degli Ebrei la filosofia del denaro di Simmel e forse la finanziarizzazione del capitalismo contemporaneo.
Quando nel 1797 Napoleone abbatte le porte del ghetto la città festeggia, è cosmopolitismo anche politico e non solo economico quello degli Ebrei veneziani che inneggiano ai princìpi della rivoluzione francese, iniziando un’epoca di assimilazione che continua nell’Otto e Novecento. Il ritorno al ghetto degli Ebrei veneziani sopravvissuti alla Shoah chiude con una foto sobria il percorso della mostra.
2. Oggi
Cosmopoli multietnica e multireligiosa, città-mondo ed economia-mondo sono i termini che usiamo per indicare ieri Venezia, oggi New York, Hong Kong o Mumbai. A New York il 35,8 % della popolazione è nata fuori ed è immigrata, a Hong Kong il 40 %, mentre a Mumbai l’altissima percentuale di immigrazione viene dal subcontinente indiano. Le logiche spaziali di ghetto (o di slum a Mumbai) hanno a lungo segnato queste città-mondo.
Oggi la segregazione, o auto-segregazione, si declina come mescolanza incessante e porosità dei confini. La diversità etnica è cresciuta negli ultimi tre decenni creando mescolanze e accentuando segregazioni: a New York vivono oggi due milioni di Asiatici (sono raddoppiati in 20 anni), molto segregati spazialmente e socialmente anche se non sempre in aree svantaggiate come gli Afro-americani. Oggi a New York più della metà delle famiglie è concentrato nelle aree più povere oppure in quelle più ricche, mentre le aree a medio reddito della middle class si sono ridotte scendendo dal 65 al 44 % nelle metropoli americane.
A Hong Kong invece, dove la middle class sta crescendo in modo fortissimo, la crescita urbana ad alta densità si concentra nei nuovi quartieri di edilizia pubblica (che raggiunge il 50% dell’intero stock edilizio, la percentuale più alta al mondo di public housing) e la mescolanza sociale ed etnica si esprime in forme nuove: la recente e tuttora in corso mobilitazione politica di Hong Kong è anche il frutto di questa crescita. A Hong Kong ci sono attivisti, associazioni di welfare e movimenti sociali molto simili a quelli occidentali.
A Mumbai metà della popolazione, cioè sei milioni di persone, vive in slums che crescono a fianco delle aree più ricche ed esclusive: nello slum semplicemente abitano i domestici, lavoranti, custodi e autisti delle case in cui vivono i ricchi Global Indians, mentre nello stesso tempo si sviluppano città satelliti e new towns come Navi Mumbai, dove si concentra la nuova classe media in aree a bassa densità (tre volte meno dense della incredibile densità media di Mumbai) e servizi urbani avanzati.
Rispetto alle relazioni ‘centrale-locale’ di chiara origine imperiale (vecchia e nuova), il mondo si sta ridefinendo come glocale. Il globale e il locale non sono due piani o pianeti posti uno sopra l’altro, uno alto l’altro basso, essi sono lo stesso piano: nastri e circuiti entro cui fluisce la società globale. Alta e bassa, insieme: anche se nuove segregazioni spaziali e abissali distanze di ricchezza si sono moltiplicate negli ultimi tre decenni. Ogni discorso sulla glocal city, sulla città smart etc. dovrebbe andare in questa direzione: identificarne i crocevia, le intersezioni, i nodi del mondo e gli incroci.
Occorrerebbe ridisegnarne la geografia sociale. Sul piano dell’informazione, a formare un recente strato virtuale che si sovrappone agli altri strati formatisi nel tempo lungo ci sono: le reti, le imprese, gli users, gli Internet exchange, i linguaggi funzionali, l’Internet fisico della logistica delle merci, ecc. Sul piano dell’urbano (la dimensione planetaria dell’umanità globale, con diverse piegature e ispessimenti localizzati) essi sono le città, i flussi, le agenzie funzionali, i think-tank, le comunità trans-nazionali e diasporiche, ecc.
Per questo l’urbanizzazione planetaria non ha più alcun ‘interno’ ed ‘esterno’ ma tutto succede allo stesso tempo e nello stesso spazio, come scriveva Lefebvre. Possiamo riconoscere i nodi di un intelletto metropolitano espanso, non più confinato in alcuna amministrazione locale né dipendente da alcun centro nazionale. Le nostre reti, agenzie, funzioni, politecnici, piattaforme sono le basi di nuovi raggruppamenti, cluster, assemblaggi di cui è fatta la società globale; in attesa che altre istituzioni a scala planetaria possano emergere dalla crisi attuale.
Filone di Alessandria coniò il termine megalopoli in un’altra grande crisi, quella ellenistica; per il filosofo ebraico alessandrino megalopoli era un ‘mondo di idee’ che predetermina e dirige il mondo materiale in cui viviamo. Quel cosmopolitismo ellenistico, sostiene Sloterdijk, fu il tentativo di rendere l’anima capace di sopportare l’esilio attraverso l’ascesi; quello moderno è invece l’impresa di fornire ai corpi dei turisti lo stesso comfort dovunque essi vadano. Nella prima Ecumene il mondo della mescolanza, il Mediterraneo, si disfece senza più ricomporsi. Sta succedendo ancora oggi nella seconda Ecumene, negli spazi globalizzati in cui l’ultima Utopia cosmopolitica potrebbe tramontare.
Come Venezia ieri, l’Europa oggi può costruire il suo cosmopolitismo non tanto sulla dimensione delle sovranità territoriali delle nazioni o sul numero delle persone che esse ricevono e ospitano, quanto sulla capacità di trascendere questa espansione visibile e nell’allargare il proprio orizzonte geopolitico in un’area di gran lunga più vasta.
Intanto altri ibridi geopolitici si stanno formando, in altre parti del mondo, che spingono nelle più diverse direzioni: a Hong Kong, a Taiwan, a New York, ad Abu Dhabi sullo sfondo di passate e recenti colonizzazioni si mescolano popolazioni, tecnologie ed ecologie producendo utopie e distopie, razionalità tecniche ed esternalità negative, conflitti e nuove schiavitù di cui il nostro secolo sarà a lungo testimone.
Un governo fantoccio, un parlamento che non esiste, un insieme di istituzioni che gli elettori hanno clamorosamente bocciato continuano nell'errore come delle ruspe impazzite. Il manifesto, 20 dicembre 2016 (p.d.)
Oggi la Camera è impegnata a ratificare gli accordi intercorsi nel 2015 e 2016 tra i governi italiano e francese per l’avvio dei lavori della sezione transfrontaliera della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione.
C’è da non crederci.
Il Paese è in balia di un Governo caricaturale, la crisi economica e le disuguaglianze aumentano (è di pochi giorni fa il rapporto di Eurostat che colloca l’Italia all’ultimo posto in Europa occidentale quanto a entità di salari e stipendi), le «grandi opere» bruciano le risorse necessarie al risanamento di un territorio devastato e incapace di assorbire piogge appena più intense del normale, la credibilità della politica è ai minimi storici e, a fronte di ciò, un Parlamento non rappresentativo (perché eletto con una legge incostituzionale) si accinge ad approvare ulteriori spese insostenibili, inutili e dannose.
Superfluo dirlo: quando gli interessi economici e finanziari premono, non c’è «navetta» né «bicameralismo paritario» che rallenti i lavori parlamentari. E altrettanto superfluo è sottolineare che il partito del cemento e i suoi sponsor (Repubblica su tutti) si scatenano in pressioni scomposte e annunciano trionfanti che a breve «non resterà che avviare i bandi di gara per far partire le ruspe e le frese che scaveranno il tunnel di base più lungo del mondo».
Ovviamente non è così: l’effettivo inizio dei lavori richiederà anni e gli accordi politici sono sempre suscettibili di modifiche e cancellazioni, soprattutto in caso di persistenza della crisi economica e di cambiamento del quadro politico (in Italia come in Francia, già oggi assai tiepida sull’opera). Ma non c’è dubbio che la ratifica degli accordi segnerebbe un nuovo passo verso quella che appare sempre più la versione ferroviaria della Salerno-Reggio Calabria. Non è dunque inutile, almeno a futura memoria, ricordare le ragioni che ostano alla ratifica e che consiglierebbero alla Camera, quantomeno, una qualche prudenza.
Ci sono ragioni generali, note da tempo, che riguardano la tutela dell’ambiente e della salute della popolazione, l’inutilità della nuova linea, lo spreco di risorse in periodo di gravissima crisi economica, l’incertezza sui costi complessivi, l’irrazionalità dell’assunzione da parte dell’Italia della maggior parte delle spese per la tratta transfrontaliera (pur incidente per 45 km in territorio francese e solo per 12 km in territorio italiano), l’aggiramento di fatto della normativa antimafia nella aggiudicazione degli appalti (nonostante un escamotage finale del tutto inidoneo a modificare il quadro dei trattati) e molto altro ancora.
Basterebbe, ovviamente. E alla grande. Ma ci sono anche ragioni specifiche riguardanti la legittimità stessa della ratifica.
Due su tutte.
Anzitutto c’è, nei trattati di cui si discute, una violazione dell’accordo intergovernativo Italia-Francia del 29 gennaio 2001, costituente l’atto normativo fondamentale relativo alla Nuova linea ferroviaria, il cui articolo 1 prevede esplicitamente che la realizzazione dell’opera è subordinata alla imminente saturazione della linea storica. Orbene, tale condizione è irrealizzata e ben lungi dal realizzarsi posto che la linea esistente è attualmente utilizzata al 16 per cento della sua capacità e l’entità delle merci trasportate è in costante calo (attestandosi oggi su un terzo di quella raggiunta nel 1997).
In secondo luogo, c’è una violazione, altrettanto clamorosa, della convenzione di Aarhus del 1998, sottoscritta dal nostro Paese, concernente, tra l’altro, la «partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale». L’articolo 6 della Convenzione vincola, infatti, gli Stati contraenti a inserire, nell’iter procedimentale in materia ambientale, «termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente», e a far sì che «la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un’influenza effettiva». Orbene, nulla di ciò è avvenuto nella fase che ha preceduto i trattati, come accertato, tra l’altro, nella sentenza 8 novembre 2015 del Tribunale permanente dei popoli.
Basta ricordare, tra l’altro, che l’Osservatorio tecnico sulla Torino-Lione, istituito dal governo italiano come «luogo di confronto» di tutte le realtà interessate sui necessari «approfondimenti di carattere ambientale, sanitario ed economico» è, a partire dal gennaio 2010, limitato ai soli «comuni che dichiarino esplicitamente la volontà di partecipare alla miglior realizzazione dell’opera» (sic!), con la conseguenza che non ne fa parte la stragrande maggioranza degli enti locali della Val Susa e che, da ultimo, ne è uscito anche il comune di Torino.
Dunque la ratifica dei trattati in discussione formalizzerebbe, ancora una volta, l’esclusione, finanche in termini normativi, della partecipazione prevista dalla convenzione di Aarhus. In una situazione siffatta un Parlamento rispettoso delle regole e del comune «buon senso» si concederebbe, almeno, una pausa di riflessione. Non accadrà. E ciò la dice lunga – se ancora ce ne fosse bisogno – sullo stato delle nostre istituzioni e sulla loro distanza dai bisogni e dalle richieste dei cittadini.
 Articoli di Eleonora Martini, Manuela Perrone, Marco Travaglio, Alessandro Trocino, Andrea Arzilli, Corrado Augias, Paolo Graziano e Massimo Almagisti da
Articoli di Eleonora Martini, Manuela Perrone, Marco Travaglio, Alessandro Trocino, Andrea Arzilli, Corrado Augias, Paolo Graziano e Massimo Almagisti da il manifesto
, il Sole 24 ore,
Il Fatto Quotidiano, Corriere della sera
, La Repubblica,
18 dicembre 2016 (c.m.c.)
il manifesto
VIRGINIA RAGGICOMMISSARIATA,
IL MINI DIRETTORIO RIPRENDE
IL CONTROLLO ROMA.
di Eleonora Martini
«Dopo la terza riunione fiume, la sindaca accetta il diktat di Grillo e dei big del Movimento: via il raggio magico per salvare la giunta. Si dimettono il vicesindaco Daniele Frongia e il capo della segreteria politica Salvatore Romeo. La pace è fatta. In serata il comico genovese riconosce Virginia sindaca del M5S»
Non c’è il notaio ma anche così la sensazione di déjà-vu è forte. Alla terza riunione fiume in due giorni con i consiglieri di quella che stava per diventare la sua ex maggioranza, per tentare di salvare capra e cavoli Virgina Raggi capitola ad una sorta di commissariamento.
La sindaca di Roma cede all’aut-aut dell’inviperito Beppe Grillo che ieri ha lasciato all’alba la Capitale senza incontrarla, e accetta il diktat del disciolto mini direttorio romano che si riprende così il controllo sulla giunta pentastellata: fare fuori il capo della segreteria politica Salvatore Romeo che insieme a Raffaele Marra, arrestato per corruzione, aveva in mano le chiavi della macchina capitolina, e declassare ad assessore il vicesindaco Daniele Frongia, sulla cui amicizia Marra aveva fatto perno per ottenere la completa fiducia della prima cittadina.
A sera, una nota del Campidoglio formalizza le dimissioni: «Daniele Frongia ha deciso di rinunciare al ruolo di vicesindaco mantenendo le deleghe alle Politiche giovanili e allo Sport. Contestualmente Salvatore Romeo ha deciso di dimettersi dall’incarico di capo della Segreteria politica. A breve avvieremo una nuova due diligence su tutti gli atti già varati». Trasferimenti in vista potrebbero esserci anche per Renato Marra, fratello di Raffaele, appena promosso a capo della direzione turismo.
La pace è fatta. Sugellata anche da Beppe Grillo in persona che subito dopo pubblica sul blog: «Roma va avanti con Virginia Raggi sindaco del MoVimento 5 Stelle».
Per tutto il pomeriggio di ieri però i 29 consiglieri e la sindaca si sono asserragliati a Palazzo Valentini, sede della città metropolitana, per trovare una exit strategy al pantano romano che rischia di inficiare le magnifiche sorti e progressive nazionali. Tutt’altro che una serena riunione di maggioranza, una vera e propria resa dei conti. Virginia Raggi ha preso più volte in considerazione l’ipotesi di «autosospendersi» dal M5S, almeno finché non fosse chiaro che su di lei non pende alcuna ipotesi di reato.
Un termine – autosospensione – giuridicamente vuoto ma che avrebbe sortito l’effetto di dare un segnale immediato di discontinuità, come preteso da Grillo, e contemporaneamente prendere tempo, come caldeggiato da Davide Casaleggio. Un modo per evitare il ritiro del simbolo d’imperio, invocato ormai a gran voce dall’ala ortodossa grillina ma osteggiato dal presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito e dal capogruppo Paolo Ferrara. Senza simbolo del M5S la giunta non avrebbe avuto infatti lunga vita, e il ritorno alle urne sarebbe stato inevitabile. Con l’autosospensione invece la consiliatura avrebbe potuto continuare, potendo contare sull’appoggio esterno dei grillini.
Una soluzione a dir poco artificiosa, degna dei migliori strateghi politici. Ma sembrava l’unica possibile. «Non mi sento più parte del M5S, non mi ci riconosco più», avrebbe detto più volte la sindaca (parole poi smentite dal Campidoglio ma senza grande convinzione) ai componenti di quel suo “raggio magico” che ora ha accettato di sacrificare.
Grillo non ha lasciato margini di dubbio: «Romeo si deve levare dal c…», avrebbe ordinato al telefono durante il tragitto in treno da Roma a Genova (evidentemente non era solo sul vagone). E Frongia va ridimensionato. I rumors parlano di un avvicendamento con l’assessore alle partecipate Massimo Colomban, l’imprenditore veneto che Casaleggio Jr aveva voluto in giunta poco più di due mesi fa. L’incubo del comico genovese è che si concretizzi quel rischio ipotizzato da ben «cinque avvocati», come avrebbe puntualizzato al telefono.
Ma a parte l’eco delle parole di Grillo, trapela ben poco dalla blindatissima riunione di Palazzo Valentini. Il silenzio è totale perfino sui social. Roberto Fico annulla «L’intervista» da Maria Latella, i consiglieri escono alla spicciolata e rispettano la consegna del silenzio. Solo poche parole pronunciate da De Vito dopo la riunione con le quali il presidente dell’assemblea capitolina non smentisce la tentazione di Raggi di lasciare il M5S.
Il dèjà-vu è, appunto, forte. Appena un paio di giorni fa Paolo Ferrara aveva assicurato che quel che era successo con il Pd non si sarebbe potuto ripetere con «una comunità di fratelli impegnati per il bene» di Roma. Ieri sera a Otto e mezzo l’ex marziano dem Ignazio Marino, lo ha contraddetto: «Un anno fa un sindaco veniva tolto tramite notai e oggi un comico di successo commissaria il sindaco di Roma. Ma allora perché i cittadini dovrebbero andare a votare?».
il Sole 24 ore
RAGGI CEDE AGRILLO:
FUORI FRONGIA E ROMEO
di Manuela Perrone
«Accantonate per ora le ipotesi di autosospensione o rimozione del marchio - Il leader: errori ma avanti»
Alla fine della seconda giornata più difficile per il M5S prevale la soluzione “minima”, quella prudente e attendista suggerita da Davide Casaleggio per salvare la giunta capitolina dopo l’arresto di Raffaele Marra: via quel che resta del “raggio magico”, Daniele Frongia e Salvatore Romeo, che ieri sera hanno rinunciato all’incarico rispettivamente di vicesindaco e di capo segreteria della sindaca di Roma Virginia Raggi. «Barra dritta e avanti tutta», scrive Beppe Grillo sul blog in serata. «Roma va avanti con Virginia Raggi sindaco del MoVimento Cinque Stelle. Sono stati fatti degli errori che Virginia ha riconosciuto: si è fidata delle persone più sbagliate del mondo».
Resta in canna, per ora, l’altro colpo ipotizzato ieri, silenziato da un bagno di realpolitik: la richiesta a Raggi di autosospendersi. Come invocano gli ortodossi del M5S che chiedono un taglio netto con la giunta capitolina prima che sia tardi. Qualcuno si lascia sfuggire quel che tanti pensano: «Un avviso di garanzia a Raggi sarebbe un toccasana».
L’allusione è all’inchiesta della procura di Roma sulle nomine, tra cui quella di Romeo, che potrebbe vedere la sindaca indagata per abuso d’ufficio. A quel punto – è la tesi – nessun compromesso sarebbe più possibile. «Invece così ci lasciano a bagno, con il rischio di farci morire». Ma dal blog il “capo politico” Grillo sembra prepararsi anche a questa evenienza, quando scrive: «A breve definiremo un codice etico che regola il comportamento degli eletti del MoVimento 5 Stelle in caso di procedimenti giudiziari. Ci stanno combattendo con tutte le armi, comprese le denunce facili che comunque comportano atti dovuti come l’iscrizione nel registro degli indagati o gli avvisi di garanzia. Nessuno pensi di poterci fermare così».
La tregua raggiunta ieri sera è arrivata al termine di due riunioni di maggioranza, l’ultima delle quali durata quasi cinque ore, che si è tenuta a Palazzo Valentini, sede della città metropolitana. Grillo era partito all’alba per Genova, concludendo infuriato e deluso la trasferta romana peggiore di sempre. All’Hotel Forum aveva incontrato alcuni tra i parlamentari e i consiglieri, tra cui le deputate Roberta Lombardi e Carla Ruocco, da sempre le più critiche con la giunta Raggi. Ruocco ribadisce secca: «Sono fiera di essere sempre dalla parte delle persone perbene. E dalla parte delle persone perbene resto».
La proposta di togliere il simbolo a Raggi (che aveva sondato senza successo l’ipotesi di proseguire senza marchio) non è passata. Secondo indiscrezioni, la sindaca avrebbe comunque tentato di resistere, chiedendo il supporto dei consiglieri e cercando sponde a destra, tra i banchi di Fratelli d’Italia. Quella destra che – attacca il Pd – rappresenta il vero terreno di coltura della sua giunta, l’area grigia (con il supporto dello studio legale Sammarco, da cui Raggi proviene) che detta le sue scelte.
Il clima tra i Cinque Stelle è vitreo. I cosiddetti “pragmatici” si sono eclissati: nessuna notizia del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, che pure è sfilato davanti a Grillo senza quasi proferire parola, raccontano. «È lui il responsabile di tutto questo», mormorano in tanti. Sparito anche Alessandro Di Battista, che fino all’ultimo aveva provato a sostenere Raggi, tra i principali sponsor della linea “oneri e onori” sposata dopo la bufera di settembre (la raffica di dimissioni e la notizia dell’ex assessora all’Ambiente Paola Muraro indagata).
Il presidente della commissione di Vigilanza sulla Rai, Roberto Fico, che incarna l’anima movimentista delle origini e ha definito «gravissimo» quel che è successo a Roma, disdice la partecipazione a “L’intervista” di Maria Latella in tv. L’impressione è quella di un Movimento vicino a sgretolarsi. Che naviga a vista, quasi paralizzato.
Scosso da divisioni su divisioni: una sorta di tutti contro tutti. Ortodossi versus pragmatici, appunto. Ma anche consiglieri comunali contro parlamentari. E consiglieri più severi contro quelli più morbidi, convinti che siano i deputati e le loro iniziali interferenze i principali responsabili della deriva della giunta. Con la sindaca che ha resistito fino all’ultimo, chiusa in una sorta di bunker emotivo e politico, difendendo ostinatamente i suoi fino all’ultimo, Frongia in particolare.
Che mantiene le deleghe alle Attività giovanili e allo Sport. Sarà sacrificato anche Renato Marra, il fratello di Raffaele, l’ex vicecomandante dei vigili urbani promosso a inizio novembre a capo della direzione Turismo del comune, con la firma del fratello e la difesa accorata della sindaca in una lettera all’Anac.
Raggi ha annunciato anche l’altra condizione imposta da Grillo: l’avvio di una due diligence su tutti gli atti firmati fin qui da Raffaele Marra. Sia quando era vice capo di gabinetto sia quando, dal 7 settembre scorso è stato trasferito alla guida del dipartimento Personale (casella cruciale, il Campidoglio conta 23mila dipendenti). Altra fatica che sottrae tempo alle vere emergenze della capitale.
il Fatto quotidiano online
SALA DI RIANIMAZIONE
di Marco Travaglio
Giorgio Bocca lo chiamava “il Paese di Sottosopra”, ma era un eufemismo. Questo è un manicomio, però gestito non dagli psichiatri, ma dai matti. A Milano c’è un sindaco indagato per falso materiale e falso ideologico sul principale appalto del principale grande evento degli ultimi anni: l’Expo 2015. Il sindaco si “autosospende” e si fa sostituire dal vicesindaco, inventandosi un istituto giuridico che non esiste in natura e nell’ordinamento, giustificato con un “impedimento temporaneo” anch’esso inventato visto che le indagini non gli impediscono di esercitare le sue funzioni.
Una penosa manfrina per fare pressioni sulla Procura generale che ha osato riesumare l’inchiesta sepolta dalla Procura ordinaria e riaperta dal gip. E tutti, compreso Salvini, implorano Sala di restare al suo posto perché “Milano dev’essere governata”. Intanto a Roma viene arrestato il capo del Personale del Comune per fatti estranei e precedenti all’attuale amministrazione (una casa comprata nel 2013 con soldi del costruttore Scarpellini) e tutti chiedono le dimissioni della sindaca Raggi che l’aveva nominato senza sapere – né poter sapere – nulla di quel fatto, scoperto dalla Procura di Roma con intercettazioni e indagini patrimoniali.
Evidentemente “Roma non dev’essere governata”, o almeno non da lei. Tra i più feroci censori della sindaca ci sono alcuni dei suoi compagni (si fa per dire) di movimento, riuniti in permanenza per processarla in contumacia (la presenza dell’“imputata” non è prevista), che pretendono, in alternativa o in accumulo: la testa della Raggi, quella del vicesindaco Frongia, quella del suo capo-segreteria Romeo.
I quali non sono accusati né indagati di nulla e non si sa bene di che debbano rispondere, a parte dell’essersi fidati di un dirigente mai inquisito né sospettato di corruzione fino all’altroieri. Infatti nessuno li convoca per ascoltare la loro versione dei fatti, né propone nomi formidabili al posto loro. Poi c’è chi approfitta del disastro romano per regolare i conti con Di Maio, invidiatissimo perché risulta il più autorevole parlamentare M5S, e non per investitura divina, ma per la più impietosa delle selezioni naturali: quella darwiniana.
L’espressione “caos Raggi”, rubrica fissa sui giornaloni e sui tg Rai, Mediaset e Sky, riassume all’ingrosso e a senso unico un groviglio di responsabilità: la drammatica difficoltà e la terribile impreparazione manifestata dalla Raggi e dall’intero M5S nel trovare una classe dirigente all’altezza per governare un Comune allo sfascio; e il totale inquinamento della burocrazia capitolina, dove il più pulito ha la rogna.
Non avendo una squadra all’altezza sia per l’inadeguatezza sua e del M5S, sia per la scarsa collaborazione della “società civile”, la sindaca ha formato una giunta di esterni al M5S, cercando di valorizzare alcuni pezzi di establishment per orientarsi in un palazzo infetto dalle fondamenta con 23mila tra dipendenti e dirigenti (tra cui moltissimi indagati).
L’operazione è miseramente fallita, nonostante precauzioni più stringenti di quelle adottate da qualunque altro sindaco: la richiesta, a chiunque si candidasse a una nomina, non solo della fedina penale immacolata, ma addirittura del certificato di nessuna indagine a carico; e il vaglio di Cantone sulle nomine dello staff. Fu per questo che si scoprì che la nomina della Raineri a capo di gabinetto era illegittima; che l’assessora Muraro era sotto inchiesta per reati ambientali; che il Pg della Corte dei Conti De Dominicis, neoassessore al Bilancio, era pure lui inquisito. Su Marra invece nulla risultava, né sotto il profilo penale né sotto quello amministrativo, salvo la questione tutta politica di aver collaborato con giunte precedenti, come il 99% dei funzionari e dei dirigenti comunali, non soggetti allo spoils system.
Quando un altro sindaco-marziano, Luigi De Magistris, si insediò nel 2011 in un altro Comune disastrato, quello di Napoli, nominò 12 assessori e poi ne cambiò 11 in cinque anni (totale 23), prima di trovare la quadra e la stabilità. Lo stesso Sala è stato costretto ad avvicendare vari collaboratori indagati o non idonei. Questi sono i fatti, nudi e crudi. Anziché invocare la testa di questo e quello, capi e capetti dei 5Stelle farebbero bene a ragionare con loro, di testa, e non con le viscere. Partendo dall’unica bussola che dovrebbe orientarli: le aspettative dei romani che sei mesi fa hanno chiesto loro di governare la Capitale. Se la Raggi fosse stata beccata a commettere reati o a tenere condotte indecenti, andrebbe sfiduciata. Ma non è questo il caso. Quindi governi, se ne è capace. Poi verrà giudicata per quello che avrà fatto.
Certo, è bizzarro che il caso Marra provochi discussioni infinite e appassionate in un movimento che passa per autoritario e verticistico, mentre il caso Sala non suscita il minimo stormir di fronda in un partito che si fa chiamare “democratico”, si vanta di discutere liberamente di tutto e un anno fa sfiduciò davanti al notaio il sindaco Marino per uno scandalo infinitamente meno grave.
Nessuno pensa che Sala debba dimettersi perché è iscritto nel registro degli indagati (anche se il suo partito, per lo stesso motivo, ha chiesto per mesi le dimissioni della Muraro): se ne riparlerà a fine indagine. Ma se, tra le 12 o 18 correnti del Pd, per non parlare della stampa, non si leva una voce su un sindaco probabilmente ineleggibile e sospettato di aver falsificato atti e truccato appalti, mentre sono tutti impegnati a chiedere le dimissioni della Raggi, qualche riflessione sulla diversità del M5S andrà fatta. I 5Stelle si impegnano allo spasimo per regalare agli altri il comodo slogan “siete uguali a noi”. Ma gli altri ce la mettono tutta per dimostrare che i 5Stelle sono diversi.
Corriere della sera
VIA IFEDELISSIMI.
E GRILLO SALVA RAGGI
di Alessandro Trocino
«Roma, si dimettono Frongia e Romeo. Ipotesi sospensione della sindaca in caso di avviso di garanzia»
Grillo dà la linea: «Roma va avanti con Virginia Raggi. Da oggi si cambia marcia». Via il vicesindaco Frongia e Romeo, capo della segreteria. A Milano appello a Sala per restare.
Ha provato a resistere fino all’ultimo, nel bunker di Palazzo Valentini, mentre al Campidoglio andava in scena Suburra . Nel senso che, per quelle bizzarre coincidenze della storia, proprio lì si era stabilito il set della serie tv sul malaffare capitolino. Alla sette di sera, dopo cinque ore di trattative esterne con i vertici M5S e interne con i consiglieri comunali, Virginia Raggi china la testa, accettando i diktat del Movimento. Per salvare se stessa e la sua giunta da un tramonto inevitabile. Da lontano sorridono (ma non troppo) Beppe Grillo e soprattutto Davide Casaleggio, vero ispiratore di una soluzione non traumatica, preoccupatissimo di una rottura.
Il post mai pubblicato
Molte ore prima, alla mezzanotte di venerdì, la sindaca si barrica in Campidoglio, con i consiglieri riuniti al capezzale della giunta, come nel famoso videoselfie. Quasi una veglia funebre, per una partita data quasi per persa. Perché dall’Hotel Forum giunge la notizia di una mannaia imminente: un post, già pronto, impaginato e firmato, con la revoca del simbolo. Ma il tasto «pubblica» non sarà mai premuto. Perché a quell’ora c’è il primo dei tanti colpi di scena: vanno online i giornali del mattino.
Grillo e Casaleggio cercano la giudiziaria e tirano un sospiro di sollievo: non ci sono intercettazioni compromettenti con la Raggi. Così, si va al piano B, suggerito tra gli altri da Paola Taverna, ma non condiviso dagli ortodossi come Roberta Lombardi, Roberto Fico e Nicola Morra: un diktat, prendere o lasciare, con la rimozione da vicesindaco di Daniele Frongia, la cacciata e il ridimensionamento di Salvatore Romeo e di Renato Marra. Ma anche l’affiancamento di un pool di avvocati per verificare gli atti degli ultimi mesi e un cambio radicale dell’assetto della Comunicazione, anche e soprattutto dopo il tetro videoselfie notturno.
Lo scontro su Frongia
La sindaca, alle due di notte, verifica la tenuta di un’eventuale maggioranza senza il simbolo. Verifica compiuta: «Ragazzi, non ce la facciamo». La notte si consuma nell’incertezza. Grillo riparte per Genova all’alba, dopo ore di telefonate con Casaleggio, stremato. La Raggi si sveglia presto. La notte pare abbia portato consiglio. Fa arrivare al quartier generale M5S il suo via libera. Con una condizione: «Ok, ma prima devo vedere i consiglieri». Si rifà un post e lo si mette in attesa.
Ma ecco un nuovo colpo di scena. La Raggi alza il telefono e richiama, con lo stesso tono che ha avuto in questi giorni, definito dalla controparte «algido»: «Ho cambiato idea, Frongia non si tocca». Dall’altra parte trasecolano. Speravano di aver vinto la sua resistenza, ma Virginia sembra non mollare mai. L’avviso di garanzia per la sindaca, però, è in arrivo e dato per certo, con la possibilità che le si chieda di autosospendersi. Il vicesindaco, a quel punto, ne assumerà le funzioni. Ma i vertici M5S vogliono un proprio uomo. E chi meglio di Massimo Colomban, uomo della Casaleggio associati, già imposto alle Partecipate? Lui, di fatto, diventerà il «sindaco ombra».
La seduta fiume
Raggi alle due del pomeriggio convoca i consiglieri di maggioranza a Palazzo Valentini, sede della Provincia. Fa melina, chiede ai consiglieri di votare, prende tempo. Continuano i contatti con l’esterno. I vertici M5S le fanno arrivare messaggi come: «Se non mandi via Frongia, vai a casa». Con tanto di penale da 180 mila euro, come prevede il contratto firmato all’atto dell’insediamento con la Casaleggio. Su piazza Venezia si addensano ombre cupe. Un’agenzia batte una frase della Raggi: «Non mi riconosco più nel Movimento». La smentita arriva subito. Ma intanto passa una Smart con una scritta che sembra premonitrice: «Ciao Roma».
L’epilogo
Raggi cede su Frongia: «Va bene, non sarà più vicesindaco, ma deve restare in giunta». E così il fedelissimo collaboratore, nonché amico di Marra, resterà in giunta: come assessore allo Sport, stessa materia destinata a Luca Lotti, braccio destro di Renzi, nel governo Gentiloni. Ma la battaglia non è finita. Perché Raggi prova a resistere anche su Colomban. Lei vuole Andrea Mazzillo, attuale assessore al Bilancio. Per sparigliare le carte, chiede che siano i consiglieri a votare per decidere. Grillo si infuria. Alle 18, il presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito esce da una porta laterale. È irritato: sperava di diventare vicesindaco. E come lui Paolo Ferrara, altro «lombardiano» (nel senso di Roberta Lombardi).
A De Vito non sono piaciute le parole della Raggi. Che si scusa con i consiglieri — «ho fatto degli errori» — ma attacca Carla Raineri. Colomban, salvo contrordine dell’ultima ora, è il predestinato. Il post Il «raggio magico» è decimato, le ultime resistenze vinte. Manca solo il timbro finale. Poco dopo le 20, Virginia Raggi abbandona Palazzo Valentini con un sorriso forzato. Alle 21.45, per la prima volta da giorni, Raggi e il Movimento parlano all’unisono. Il blog titola: «Barra a dritta e avanti tutta». Seguono 16 righe a firma Beppe Grillo e 10 a firma Virginia Raggi. Nelle prime le bacchettate: «Sono stati fatti degli errori che Virginia ha riconosciuto: si è fidata delle persone più sbagliate del mondo». Nelle seconde, l’annuncio della resa, mascherata da «cambiamento». Da domani, la Raggi non sarà più sola. Andrà avanti, scortata e controllata a vista
Corriere della sera
LA RESA DI RAGGI.«SI VA AVANTI CON LEI»
di Andrea Arzilli
Fuori il vicesindaco Daniele Frongia e il capo della segreteria politica Salvatore Romeo, rimosso dalla direzione Turismo Renato Marra, fratello di Raffaele arrestato venerdì mattina: «Via il Raggio magico o via il simbolo», insomma. È l’ultimatum del M5S che la sindaca Raggi ha deciso di raccogliere alla fine di un’altra giornata di trattative serrate. «Al termine delle ultime due riunioni di maggioranza, e dopo un confronto con il garante Beppe Grillo — il post esce in contemporanea sul blog del leader e sulla pagina Facebook di Raggi —, abbiamo stabilito di dare un segno di cambiamento.
Daniele Frongia ha deciso di rinunciare al ruolo di vicesindaco mantenendo le deleghe alle Politiche giovanili e allo Sport. Contestualmente Salvatore Romeo ha deciso di dimettersi dall’incarico di capo della Segreteria politica. Al contempo a breve avvieremo una nuova due diligence su tutti gli atti già varati».
Una resa dei conti, nel corso di un’altra lunghissima assemblea di maggioranza tenutasi stavolta a Palazzo Valentini, sede della Città metropolitana, perché in Campidoglio gli stanzoni erano occupati dalle troupe di una fiction.
Una riunione dalla quale la sindaca è uscita di fatto commissariata dopo aver comunque tentato di tenere duro sui suoi uomini di fiducia: ha insistito per avere come vice Andrea Mazzillo, l’assessore al Bilancio, ma il posto di Frongia alla fine dovrebbe prenderlo l’assessore alla Partecipate Massimo Colomban, uomo vicino a Casaleggio.
In più, sarà varato un codice etico per gli eletti e un pool di legali 5 Stelle vigilerà sugli atti dell’amministrazione per azzerare il rischio di un nuovo caso nomine. A cominciare dalla prima in programma: Grillo ha chiesto di assegnare già domani la delega all’Ambiente che era di Paola Muraro. Ieri Raggi, sulla quale pende anche la grana Paolo Berdini, assessore all’Urbanistica in bilico, ha perfino cercato l’appoggio esterno della destra di FdI per andare avanti da sola. O almeno per provarci, visto che sulla sindaca pende sempre il rischio di finire indagata per le nomine fatte nei sei mesi di governo, quella di Salvatore Romeo in primis.
Beppe Grillo, in ogni caso, ha chiarito che la spina non è stata staccata. «Roma va avanti con Virginia Raggi sindaco del MoVimento 5 Stelle — scrive il leader M5S sul blog —. Sono stati fatti degli errori che Virginia ha riconosciuto: si è fidata delle persone più sbagliate del mondo. Da oggi si cambia marcia. Bisogna riparare agli errori fatti per fugare ogni dubbio. Governare Roma è più difficile di governare il Paese. Lo sapevamo e non intendiamo sottrarci a questo compito assegnatoci dal popolo. Combatteremo con le unghie e con i denti perché Roma cambi, ma in un ambiente così corrotto e marcio dobbiamo aspettarci di tutto. Mettiamo la barra a dritta e avanti tutta».
La Repubblica
BASSO IMPERO
di Corrado Augias
«La crisi dell’ultimo decennio è l’emblema della grande debolezza di una città vittima della sua eterna vocazione plebea. Con problemi che si ripresentano sempre uguale»
Che Virginia Raggi avrebbe fallito era un po’ scritto nei suoi precedenti ambigui e inadeguati, nelle voci unanimi che descrivevano una donna alle prese con un incarico superiore alle sue forze, probabilmente alle forze di chiunque, così spaventoso da dare inaspettata verosimiglianza alla celebre frase della senatrice Taverna prima delle elezioni: c’è un complotto per farci vincere.
Sembrava una battuta paradossale, alla Crozza, come minimo una gaffe. Tutti risero. Invece, nel suo candore popolaresco, la senatrice aveva visto giusto; non era un paradosso ma una profezia. Non il complotto naturalmente, ma l’estrema difficoltà della prova certamente sì.
Gli aspetti politici, amministrativi e tecnici in questi giorni sono stati esaminati di sopra e di sotto. Io stesso ho fatto notare l’improvvida decisione della sindaca di mettere alla porta, appena nominata, Raffaele Clemente, capo della polizia municipale chiamato da Ignazio Marino, che stava cercando di mettere ordine in un settore lasciato agli appetiti famelici di consorterie, bande, “famiglie”.
Qualcuno, oggi possiamo perfino sospettare chi, consigliò l’inesperta Virginia, di liberarsi subito di quel rompiscatole che voleva ricondurre i tavolini all’aperto dei ristoranti nei limiti della concessione comunale, far ruotare gli incarichi e le funzioni dei vigili per limitare i ripetuti episodi di corruzione, dare una disciplina alle decine di venditori abusivi che assediano romani e turisti: caldarroste, aste per i selfie, fazzoletti di carta, orologi finti, mostruosi pupazzi di plastica, ombrelli.
In una giornata di pioggia ho comperato anch’io un ombrellino per 5 euro. Ho chiesto al ragazzo che me lo vendeva: arriverà fino a stasera? Con simpatico candore, mi ha risposto: non lo so. O forse ha detto non credo, ricordo solo un sorriso bellissimo e l’evidente divertimento di dirmi la verità dopo aver intascato quella modesta somma.
Credo di sapere perché Virginia s’è circondata di personaggi discutibili, perché ha fatto nomine disdicevoli, forse illegittime, smarrendosi nei meandri del Campidoglio sotto il peso dell’eredità lasciata dalla pessima giunta Alemanno che l’ha preceduta. Virginia Raggi ha cominciato a lavorare nello studio Sammarco che fa parte della galassia di Cesare Previti.
Si racconta che quando Previti entrava nel suo circolo canottieri, i soci più giovani lo salutavano festosi alzando il braccio nel saluto romano, gridando in coro: Ave Caesar! Oggi le possiamo quasi considerare ingenuità romantiche, goliardia, se paragonate alle ingiurie urlate in coro nelle piazze a piena gola che il Movimento ha poi introdotto come metodo politico, se possiamo chiamarlo così; cose di tale gravità nessuno le avrebbe mai immaginate ma — il che è ancora peggio — nessuno ormai ci bada più. Virginia è maturata tra quelle persone e nell’ambiente neofascista romano, quindi non bisogna troppo stupirsi se da uomini di quello stesso ambiente s’è fatta suggerire le nomine, se le persone più responsabili che ha chiamato sono velocemente fuggite appena capito che aria tirava.
Non è la prima volta che a Roma succedono cose molto gravi anche se l’attuale amministrazione dei Cinque Stelle vi ha aggiunto il connotato inedito di un sindaco (una sindaca) vincolata da un contratto con una società privata che stabilisce in pratica i limiti della sua azione; questo francamente non s’era mai visto.
Chi ha la mia età ricorda invece benissimo certe amministrazioni democristiane di mezzo secolo fa e più, prone al volere dei costruttori e delle maggiori società immobiliari, gli scempi impuniti, gli anni che ci vollero per trasferire una raffineria di petrolio che con l’estendersi dell’abitato era finita con i suoi fumi pestilenziali in mezzo alle case, gli abusi in luoghi come l’Appia Antica che dovunque nel mondo sarebbero stati ritenuti sacri — oltre che una cospicua fonte di reddito per la collettività.
Di fronte a quel passato le amministrazioni Rutelli e Veltroni sono state tra le rare parentesi dove pareva che il sindaco avesse voglia di occuparsi dei problemi cittadini e non di quelli della sua giunta. Anche prima c’erano stati sindaci di alta qualità: Petroselli o Argan, prima ancora (molto prima) Ernesto Nathan, insomma s’era visto più volte che non era impossibile dare a Roma un’amministrazione all’altezza di una capitale europea.
Ignazio Marino ha cercato di intonarsi a quei precedenti, è scivolato sulla sua inesperienza, sulla sottovalutazione di problemi gravi, sull’ostinata presunzione di fare da solo scegliendo i candidati alle cariche su Internet per liberarsi dal soffocante abbraccio dei partiti. Il risultato sono state alcune nomine stonate di cui la città ancora paga le conseguenze.
Se volessimo inquadrare l’entusiastica elezione e il desolante apprendistato di Virginia nella più ampia vicenda della città, potremmo richiamare la costante vocazione plebea di Roma, i suoi eterni problemi con le immondizie testimoniati dalle targhe marmoree murate qua e là. Non dipende certo da una caratteristica genetica degli abitanti, ma dal fatto che a quello per secoli la popolazione è stata ridotta. Per troppo tempo a Roma non è esistita una borghesia consapevole, il “popolo romano” era fatto di nobili legati al trono pontificio chiusi nelle loro fastose dimore e di una plebe largamente analfabeta, riottosa, la stessa alla quale l’immenso poeta Giuseppe Gioacchino Belli ha eretto un monumento con i suoi 2.279 sonetti. Bellissimi da leggere, durissimi da vivere.
il manifesto
ROMA, LA CRISI DI CRESCITA
DEL MOVIMENTO 5 STELLE
di Paolo Graziano e Massimo Almagisti
Prima le dimissioni dell’assessora all’ambiente in seguito a un avviso di garanzia, poi l’arresto del capo del personale: la giunta capitolina a 5 stelle fa parlare per i suoi problemi e non per l’iniziativa amministrativa. Considerata la situazione della capitale, molte delle difficoltà incontrate dalla nuova amministrazione erano prevedibili; tuttavia colpiscono l’intensità e la durata di una impasse politica e amministrativa con pochi precedenti nella storia recente delle città italiane. Ad esempio, ripercorrendo l’insediamento delle prime giunte leghiste a metà anni ’90, molte città di varie dimensioni (Varese, Milano, Pavia, Treviso) si sono trovate guidate da sindaci che non avevano alcuna significativa esperienza di governo. Eppure, quella «rivoluzione elettorale» non diede vita alle difficoltà di cui si legge in questi mesi.
Si potrebbe dire in modo semplicistico che Virginia Raggi si è rivelata fino ad ora una guida meno abile e fortunata del sindaco pentastellato di Torino, Chiara Appendino, e quindi che si tratti solo di una questione di leadership. La leadership indubbiamente ha un certo peso, ma non possiamo isolarla dal contesto. Questo significa fare riferimento alle dinamiche evolutive di una formazione di così recente origine e soprattutto ai processi di acquisizione della cultura di governo da parte del Movimento 5 Stelle, in particolare in una città così problematica (e ambita) come Roma, dove si gioca una partita dagli evidenti riflessi nazionali. La cultura di governo non si inventa, e a tal riguardo altre amministrazioni pentastellate hanno mostrato la difficoltà di passare dalla protesta alla proposta. A Parma, Federico Pizzarotti ha impiegato non poco a comprendere come prendersi cura della città, con risultati – a detta di molti – non disprezzabili. Ma dopo una fase prolungata di conflitto con il vertice nazionale oggi è fuori dal Movimento. A Livorno, Filippo Nogarin, dopo oltre due anni di governo, non è ancora riuscito a lasciare il segno. Si Roma abbiamo detto. I diversi profili professionali di Appenddino e Raggi (più manageriale il primo, più legal-burocratico il secondo) e la connessa capacità individuale di governo spiegano solo in parte la diversa capacità di gestire la sfida dell’amministrazione. Tuttavia, il problema non è solo la capitale: la difficoltà di trasformare slogan efficaci in scelte adatte al governo di una città è una sfida classica per nuovi soggetti politici che sono chiamati a gestire il proprio successo elettorale. Senza una preparazione al governo non si riesce a creare un governo.
Il Movimento 5 Stelle ha il merito di aver tematizzato questioni in grado di attrarre vaste porzioni di opinione pubblica, anche dal lato progressista: riguardanti, ad esempio, la partecipazione dei cittadini, il reddito di cittadinanza e le questioni dell’ecologia e delle fonti di energia rinnovabile. Tuttavia, a livello locale – a differenza di altri soggetti politici esteri che di recente hanno vinto elezioni municipali di città importanti, come Podemos in Spagna – i pentastellati non sembrano brillare per capacità di fare proposte politiche articolate. Tutta colpa dei cittadini, le cui proposte presenti sulla piattaforma Rousseau sono inadeguate? Tutt’altro: il maggiore coinvolgimento dei cittadini – seppur con modalità discutibili – è un elemento di novità del Movimento da guardare con molto favore. Si tratta di un percorso da valorizzare, poiché comporta una concezione della partecipazione che non si esaurisce nel momento elettorale. Il problema risiede piuttosto nella scelta fatta finora dal movimento di non trasformarsi in partito, ossia riguarda il delicato momento in cui una neoformazione politica deve adottare una cultura partitica di governo che si sostanzia nella costruzione di una classe dirigente nuova e competente e nell’aggregazione strutturata della domanda politica emergente. Concorrendo alle elezioni e quindi accettando i fondamenti della democrazia rappresentativa, il Movimento non può continuare a far finta che una competente dirigenza «partitica» non sia necessaria. Le primarie come strumento di selezione del personale politico costituiscono già una sfida per i partiti strutturati; nel caso di una neoformazione quale il M5S possono innescare dinamiche distruttive.
D’innanzi ai recenti accadimenti romani sarà molto interessante analizzare come il Movimento stesso deciderà di rispondere, in particolare per quanto riguarda la selezione del proprio personale politico, se manterrà gli strumenti finora utilizzati oppure se deciderà di introdurre alcune modifiche. Inoltre, sarà importante seguire come si combineranno le modalità di partecipazione on-line e off-line del Movimento, al fine di aggregare in modo efficace e realmente partecipativo la domanda politica. Servono luoghi di discussione e di confronto, dove è bene che il dissenso emerga e non venga bollato come boicottaggio e sanzionato con l’espulsione dei dissidenti come è già avvenuto in alcuni contesti locali. Gli eventi romani inducono ora il M5S a confrontarsi con queste sfide, ma è bene ricordare che non sono questioni che riguardano solo i pentastellati. Come selezionare la classe dirigente e garantire la sua onestà e la sua competenza è una questione cruciale – e irrisolta – della politica italiana dei nostri anni e, come tale, chiama in causa tutti i partiti.

Qualche decennio fa si svelò la strategia, definita "induzione del consumo", volta a convincere i consumatori a comprare determinati prodotti. Ora la si applica per accrescere il consumo di suolo. Lo racconta il gustoso articolo dello studioso americano. La città conquistatrice online, 17 dicembre 2016
Ci sono una miriade di comportamenti, consumi, orientamenti, atteggiamenti, fortemente cercati, agognati, perché paiono far bene. E invece, lo si scopre nell’immediato, appena messi in atto, fanno malissimo a sé e agli altri. Senza scivolare necessariamente dentro a questioni estreme, come il consumo di sostanze varie che danno dipendenza, basta pensare a cose assai più innocenti come le scelte alimentari istintive che «danno soddisfazione immediata», per capire a cosa ci si riferisce. L’atteggiamento, è chiaramente infantile: qualcosa piace, conforta, c’è addirittura un intero contesto che rafforza quell’orientamento, e puntualmente ci si casca. Il problema comincia però a manifestarsi nei suoi risvolti negativi quasi da subito, vuoi coi valori ematici, vuoi con vere e proprie patologie, vuoi in altri infiniti modi che vanno dal guaio estetico, al non entrare più in qualche taglia di abiti, alle spese dirette e indirette per procurarsi quella in genere rinunciabile roba. Vale per la bulimia da gelato al pistacchio acquistabile solo a trenta chilometri di distanza, ma vale anche per lo stile dell’abitare e le relazioni socio-economiche che lo inducono e che induce.
Da varie generazioni imperversa quell’ideologia, sostenuta da vere e proprie politiche pubbliche, secondo cui esiste un territorio infinito a disposizione del genere umano, dentro cui il nucleo familiare ha praticamente il dovere di ritagliarsi una fettina di residenza privata. Qualunque altra soluzione, dalla vita da single, alla socialità urbana eccetera, è da considerarsi eccezione o passaggio momentaneo. A quanto pare non se ne esce, anche di fronte alle peggiori patologie, sociali e ambientali.
Il mondo ritagliato per comodi segmenti di mercato
Quella strumentale «contraddizione città-campagna» tutta novecentesca focalizzata sull’insediamento suburbano e automobilistico, anche oltre certe indifendibili (indifendibili razionalmente) ideologie un po’ estreme, pare comunque aver lasciato in pianta stabile la liceità e quasi naturalità delle due forme: concentrata e complessa, segregata e dispersa, che in fondo fanno tanto bene al rapporto fra domanda e offerta, come il gelato al pistacchio. Se c’è la domanda ci sarà pur sempre una ragione profonda, e il cliente va accontentato, ci spiegano pur raffinatamente i bottegai del settore. Non vorremo per caso buttare a mare così alla leggera, decenni, generazioni addirittura, di prezioso know-how accumulato nell’offerta di prodotti sempre più avanzati di residenza, servizi, forme di convivenza? E come quando nelle emergenze per l’inquinamento atmosferico, comincia l’infinito battibecco su chi sia il colpevole principale (le industrie? i trasporti? il riscaldamento domestico?), allo stesso modo anche di fronte alla constatazione degli innegabili impatti ambientali e sociali del suburbio, si finisce per rifugiarsi nel comodo margine del dubbio residuo, magari in attesa della pur sempre possibile «soluzione tecnologica». Sottolineando, addirittura, che lavorare su entrambi i fronti dell’urbanizzazione, riqualificando di qua ed espandendo di là, si finisce solo per migliorare la qualità dell’abitare. Mentre invece si tratta solo dell’ennesimo trucchetto per «non allarmare l’investitore».
Pieni e vuoti
Distogliendo invece risorse, economiche così come di aspettativa, a tutte le forme di retrofitting, generale e particolare, attivabili anche a breve termine, dall’edilizia in senso proprio, all’impiantistica, e in termini allargati alla mobilità, all’organizzazione dei servizi, alla produzione energetica e al ciclo consumo-rifiuti. Favorendo quelle campagne di per sé piuttosto odiose a ben guardare, dove si coccolano i cosiddetti Millennials finché restano giovani, produttivi, adattabili, e in fondo adeguati ad esprimere le loro preferenze per una adolescenza prolungata dentro lo «studentato di area vasta» messo a loro disposizione dagli immobiliaristi. Perché questo, sono, i quartierini gentrificati dei mini appartamenti costosissimi, degli ambienti di coworking lussuosi e delle strade per lo shopping e il tempo libero fruibili comodamente a piedi o in bicicletta. Ma appena il corpo e lo spirito iniziano a trovarsi un po’ a disagio, dentro quel college improprio fatto città, come in un film di fantascienza sociologica in fronte al Millennial si accende la lucetta lampeggiante del mercato: è ora di traslocare, e di ripercorrere rispettosi le orme dei genitori. Altri giovincelli prenderanno il suo posto nel quartierino spartano trendy, mentre per lui/lei aspettano nuovi di zecca classici casa con giardino cul-de-sac, magari con la promessa dell’auto senza pilota a brevissimo termine, che scorazzerà tutta la famiglia in giro, manco continuasse il cartone animato cominciato all’asilo. Pare un po’ troppo acida questa presentazione, ma il tono «ragionevole» e un po’ paternalistico dell’ultimo rapporto Urban Land Institute sul mercato edilizio suburbano decisamente la provoca. Verificare per credere.
Riferimenti:
Urban Land Institute, Housing in the evolving American suburb, Washington D.C. dicembre 2016

Stiamo continuando a distruggere tutte le componenti del pianeta Terra: la terra, l'aria, gli oceani (per non parlar dei popoli) Non riusciamo neppure a impedire i pestiferi packaging, inutili a tutti salvo ai padroni del Mercato. La Repubblica, 17 dicembre 2016
Il Mediterraneo è diventato una zuppa di plastica. Un chilometro quadro, nei mari italiani, ne contiene in superficie fino a 10 chili. È questo il record del Tirreno settentrionale, fra Corsica e Toscana. Attorno a Sardegna, Sicilia e coste pugliesi, la media è invece di 2 chili. Sono valori superiori perfino alla famigerata “isola di plastica” nel vortice del Pacifico del nord: un’area di circa un milione di chilometri quadri in cui le correnti accumulano la spazzatura dell’oceano. Qui la densità delle microplastiche - i frammenti di pochi millimetri da cui è formata la “zuppa” - è di 335mila ogni chilometro quadro. Nel Mediterraneo arriva a 1,25 milioni. Per evitarlo, tutta la spazzatura dovrebbe andare nei cassonetti anziché nell’ambiente.
L’analisi che ha riguardato i mari della penisola arriva da un gruppo di biologi del Cnr ed è pubblicata su Scientific Reports. «A finire in mare sono soprattutto i rifiuti della nostra vita quotidiana » spiega uno dei coordinatori, Stefano Aliani, che con i colleghi nel 2013 ha raccolto i campioni di spazzatura a bordo della nave del Cnr Urania. «Sacchetti e bottiglie vengono degradati dalla luce. Nel giro di anni o perfino secoli, a seconda del tipo di plastica e dell’ambiente in cui finiscono, questi rifiuti si riducono in poltiglia». I frammenti microscopici sono stati raccolti con una rete speciale trainata dall’Urania in 74 punti di Adriatico e Tirreno. «Nel complesso - scrivono i biologi nello studio - la plastica è meno abbondante nell’Adriatico, con una media di 468 grammi per chilometro quadro, rispetto al Mediterraneo occidentale » con una media di 811 grammi.
«La gravità della situazione del Mediterraneo non ci stupisce » dice Aliani. «È un mare sostanzialmente chiuso, in cui una particella ha un tempo di permanenza di circa mille anni. Teoricamente, cioè, impiega tutto quel tempo per attraversare la stretta imboccatura di Gibilterra. Nelle sue acque sboccano anche fiumi importanti come Danubio, Don, Po e Rodano». Anche se i mari diventano sempre più torbidi (si calcola che dei 300 milioni di tonnellate all’anno di plastica prodotta nel mondo, una dozzina finiscano in mare), quale sia la sorte di buona parte della spazzatura resta un mistero. «Non sappiamo dove sia oggi tutta la plastica che abbiamo prodotto » spiega Aliani. «Quella che ritroviamo nelle nostre spedizioni non si avvicina neanche lontanamente all’ammontare che secondo i nostri calcoli dovrebbe essere finito in mare. Può darsi che molta si perda in fondo agli oceani, dove non abbiamo la possibilità di osservarla».
La responsabilità delle zuppe marine va in buona parte al packaging non riciclabile. In Europa scatole e involucri contribuiscono al 40% della produzione di questo materiale e a più del 10% dei rifiuti. Il 92% della plastica trovata in mare è composta da frammenti di meno di 5 millimetri. Tracce sono comparse in Artide e Antartide. Sono finite inglobate in alcune rocce (un campione dei cosiddetti “plastiglomerati” è stato osservato alle Hawaii nel 2014) e si sono infilate nei sedimenti dei fondali oceanici. Questo materiale è perfino stato proposto come uno dei segni distintivi dell’antropocene, l’era geologica caratterizzata dai segni della presenza umana sulla Terra.
«Per l’ecosistema marino, i danni sono molteplici» conferma Aliani. «Il pericolo più evidente per gli animali è il soffocamento ». Ma questi frammenti possono anche essere ingoiati dal plancton, le minuscole creature che si trovano alla base della catena alimentare del mare. In Spagna è nata un’azienda - la Ecoalf - che raccoglie sacchetti e bottiglie finiti nelle reti dei pescatori e li ricicla producendo vestiti. «Il problema non è solo la plastica in sé» prosegue il biologo del Cnr. «Mancano studi approfonditi, ma si pensa che questo materiale sia inerte per gli organismi ». Più pericolose sono le sostanze che alla plastica vengono combinate durante i processi industriali, per fornirle le caratteristiche volute. «Potrebbero agire come pseudo-ormoni, creando scompensi nel sistema endocrino. Abbiamo osservato il problema nelle balene».

«Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nel fuoco della Geenna». La Repubblica online, blog "articolo 9", 16 dicembre 2016 (c.m.c.)
Esattamente sei mesi fa, il 14 giugno scorso, ho spiegato su questo blog perché non potevo accettare la proposta di entrare nella giunta di Virginia Raggi come assessore alla Cultura, e perché l’avrei votata al ballottaggio se fossi stato un cittadino romano.
Allora, tra l’altro, scrivevo: «Se la sinistra radicale non riesce, con ogni evidenza, a rispondere a tutto questo, è impossibile non riconoscere che i Cinque Stelle (occupando di fatto lo spazio che in Spagna è stato conquistato da Podemos) stanno invece aprendo nuovi spazi di cittadinanza: suscitando partecipazione almeno quanto questo Pd sembra invece puntare, irresponsabilmente, sull’astensione. Se votassi a Roma, al secondo turno sceglierei dunque la Raggi, anche perché (nonostante l’evidente probità di Roberto Giachetti) è vitale – dopo l’impressionante disastro consociativo – che sul Campidoglio tiri un’aria radicalmente nuova. Se poi quest’aria riuscirà a costruire una alternativa nazionale ispirata ad un riformismo radicale, e se lo farà aprendosi a valori e personalità della sinistra, il Paese non avrà che da guadagnarci».
Ebbene, a distanza di sei mesi quelle promesse, quelle possibilità, quelle aperture si chiudono nel peggiore dei modi. Personalmente ero già rimasto interdetto dalla fiducia continuamente rinnovata alla Muraro contro ogni ragionevolezza, e poi dalla palese insopportazione per il rigore di Paolo Berdini, ben deciso a far rispettare il piano regolatore e dunque a non far affogare il futuro stadio nel cemento e nella corruzione.
L’arresto clamoroso di Raffaele Marra è il drammatico epilogo di un crescendo di inadeguatezza, superficialità, arroganza. E peggio ancora dell’arresto, è come ora si cerchi di minimizzarlo e addirittura di rimuoverlo.
È il momento di ricordare a Virginia Raggi che i valori fondamentali per cui una parte rilevante dei cittadini italiani continua a guardare al Movimento Cinque Stelle sono la totale trasparenza; la discontinuità radicale con il sistema di poteri che annulla la politica vera; l’onestà; la fedeltà al mandato dei cittadini e la dichiarata volontà di perseguire solo l’interesse generale. Ebbene, cosa rimane di tutto questo quando addirittura le manette certificano che siamo tornati al peggio della gestione Alemanno?
E non si dica che Marra era un qualunque dipendente del Comune: perché l’effetto di questa versione da impuniti è lo stesso che provocò chi farfugliò di email non lette, o (per cambiare partito) lo stesso che ora provoca chi prima promette di ritirarsi dalla politica in caso di sconfitta al referendum, e ora cerca di fare il puparo dietro le quinte. Tutto: ma non provate anche a prenderci in giro.
Ora siamo al momento della verità: o il Movimento 5 stelle dimostra agli italiani di saper tener fede alle proprie promesse, e cioè di essere in grado di rispondere ai propri principi e di mantenere il proprio patto con gli elettori, o la sua sorte è segnata. E sarebbe una notizia terribile per la democrazia italiana, che ha bisogno di un Movimento 5 Stelle davvero trasparente come avrebbe bisogno di un Partito Democratico davvero di sinistra.
Ci vuole coraggio: se fosse l’unica strada possibile, anche il coraggio di dichiarare chiusa l’esperienza di questa giunta, chiedere scusa solennemente e impegnarsi a selezionare in modo efficace la propria classe dirigente. «Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nel fuoco della Geenna». Un linguaggio radicale, certo: ma non era questo il linguaggio del Movimento?
 «La città devastata dal consumismo e dal costruire dissennato è un'immagine che si è sovrapposta all'insieme costruito. Assistiamo così alla perdita della polis, alla perdita dello spazio pubblico come segno dell'armonia».casa della cultura milano, 16 dicembre 2016 (c.m.c.)
«La città devastata dal consumismo e dal costruire dissennato è un'immagine che si è sovrapposta all'insieme costruito. Assistiamo così alla perdita della polis, alla perdita dello spazio pubblico come segno dell'armonia».casa della cultura milano, 16 dicembre 2016 (c.m.c.)
Con Urbanità e bellezza (Edizioni Solfanelli, 2016) Giancarlo Consonni ha scritto un libro sulla crisi della civiltà e una testimonianza sull'idea di bellezza civile, ovvero quel territorio magico dove l'etica e l'estetica si sovrappongono divenendo un'unica cosa. Questo territorio era, o poteva essere, la città urbanizzata, ma oggi non è così.
L'idea di bellezza civile come unione di etica ed estetica è presente sin da Leon Battista Alberti che, nel De re aedificatoria (1452), ricorda come la bellezza di una città la preservi dalla mano dei nemici. Si ritrova in Giambattista Vico, che ha coniato il termine stesso, passa per il dibattito estetico romantico, transita per la Scuola di Francoforte dove l'esteticità diventa azione e palestra di battaglia civile, e giunge a Norbert Elias - caro a Consonni - che la riscopre nell'urbanità come sede delle buone maniere.
L'approccio di Consonni riecheggia il celebre scritto heideggeriano Costruire, abitare, pensare in cui la terra è luogo dell'abitare dei viventi sotto il cielo e in cui il "prendersi cura" è l'azione cardinale. È quella terra in cui abitare e costruire si uniscono e dove l'agri-coltura è cultura così come l'urbis cultura è la città come territorio della felicità attraverso il miglioramento delle condizioni che si ottiene con la generosità reciproca.
È una tesi, questa, che si ritrova anche nel programma degli anni Sessanta del XIX secolo di William Morris raccolto in L'arte e la bellezza della terra (1881), dove si afferma che l'uomo potrà riscoprire la propria dignità solo riappropriandosi del proprio lavoro nel quadro di una riforma della civiltà che assegna all'architettura il ruolo di custode della bellezza del mondo, di cui tutti gli uomini sono responsabili. Ogni distruzione di questo patrimonio è dunque una perdita senza contropartita.
Nella sua storia, l'Italia è stata capace di costruire con teatralità spazi aperti che hanno rappresentato la capacità di saper realizzare e trasmettere queste forme di urbanità. Ma oggi - è il rilievo che emerge in Consonni - questo aspetto sembra perduto. È in atto un arretramento del significato della città, una sua perdita di legame con il territorio e di relazione con il suolo. La città è diventata luogo di esibizionismi globalisti, luogo dell'ansia e della paura anziché dell'azione collettiva, con annientamento della memoria e con forme di anestesia collettiva. La città, che era il sedimentarsi di azioni collettive fino alla metà Ottocento e prodotto d'arte collettivo, si va trasformando nel luogo della finanza indifferente alla stratificazione e della memoria.
C'è una perdita del disegno della città - sia del controllo urbano che dell'idealità utopica - ridotta a merchandising: nei villaggi vacanze, nei non-luoghi e nelle altre nelle sedi della consumer society. La contemporaneità ha bloccato questa idea di sviluppo dove etica ed estetica si incontravano lasciando spazio a una metropoli ibrida, al sovrapporsi e contrapporsi di dimensioni e strategie diverse, senza dimensione di riconoscimento. Non esiste più uno "stile" di città, una identità.
La città devastata dal consumismo e dal costruire dissennato è un'immagine che si è sovrapposta all'insieme costruito. Assistiamo così alla perdita della polis, alla perdita dello spazio pubblico come segno dell'armonia. Le città è colpita nel suo divenire espanso sino ad essere finta perché è finita una "teoria della città" e un perimetro. E ciò proprio nel momento in cui più della metà dei cittadini del mondo vive in città.
La città storica non è più concepita come tale ma solo nel consumismo dell'immagine, non nella consapevolezza dell'eredità. Smart city, App city, città telematica sono declinazioni della perdita di esperienza della città vissuta. La città non è una app che segnala ristoranti o che l'autobus è in ritardo! Si sovrappongono immagini sofisticate della città a desolanti immagini reali, la città digitale che non c'è alla città problematica che c'è.
La città postmoderna ha finito i suoi entusiasmi proprio perché urbanità e bellezza non si incontrano. Il modello di New York, nato distruggendo il volto di Nuova Amsterdam, è stato assunto - come già descritto in Delirious New York di Rem Koolhaas - come emblema di sviluppo della società metropolitana del XX secolo e oltre. New York è diventata modello di appropriazione e sfruttamento del territorio capace di rispondere ai bisogni elementari di una società che produce e consuma.
Un consumo nel quale è previsto lo svago, al quale l'estetica è asservita. Non è una estetica della bellezza quella di Manhattan, ma dello stupefacente e del popolare; disciplinata e massificata. Il cinema e il luna-park erano i luoghi simbolo che esemplificavano questa tendenza pop ed ora lo sono gli shopping mall e gli App-store. I marchi sono il biglietto da visita di società e città globalizzate dove etica ed estetica non si incontrano più. Tanto che oggi Milano sta regalando a una mela morsicata una sua piazza liberty.
 «E' quanto emerge dal 12° Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano di Ispra. Il report aggiorna per tutti i 116 capoluoghi di provincia italiani un insieme di indicatori fondamentali per valutare la qualità ambientale delle città e della vita nelle aree urbane italiane». Il Fatto Quotidiano online, 16 dicembre 2016 (c.m.c.)
«E' quanto emerge dal 12° Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano di Ispra. Il report aggiorna per tutti i 116 capoluoghi di provincia italiani un insieme di indicatori fondamentali per valutare la qualità ambientale delle città e della vita nelle aree urbane italiane». Il Fatto Quotidiano online, 16 dicembre 2016 (c.m.c.)
Dall’inquinamento da polveri sottili, migliorato nei primi mesi del 2016 rispetto al 2015 (un vero e proprio anno nero), allo stato del suolo e del territorio italiano con 2 milioni di persone a rischio alluvioni e oltre 22mila frane censite. Sono questi alcuni degli aspetti affrontati nel 12° Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano di Ispra, l’Istituto di ricerca del Ministero dell’Ambiente e del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente.
Dai fattori demografici, alla qualità dell’aria, dalla mobilità alle risorse idriche, fino al suolo e ai rifiuti: il report aggiorna per tutti i 116 capoluoghi di provincia italiani un insieme di indicatori fondamentali per valutare la qualità ambientale delle città e della vita nelle aree urbane italiane. Si tratta del primo rapporto a essere presentato dopo l’approvazione della legge 132 del 28 giugno 2016 (che entrerà in vigore il 14 gennaio 2017), che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), costituito da Ispra, Arpa e Appa.
Fattorisociali ed economici
In Italia, al 31 dicembre 2015, i residenti erano circa 60 milioni e 665mila, oltre 130mila in meno rispetto all’anno precedente. La diminuzione della popolazione residente ha interessato 87 dei 116 comuni presi in esame, più di tutti Roma (-7.290) e a Torino (-6.244). Al contrario i residenti sono aumentati maggiormente a Milano (8.696), Parma (2.552). L’incidenza dei cittadini stranieri è massima nei comuni capoluogo di provincia di Milano, Brescia, Prato e Piacenza dove più di 18 residenti su 100 sono stranieri. Anche nel 2015, la densità della popolazione è più alta a Napoli, seguita da Milano e Torino. Nel Comune di Roma, il più esteso dei comuni italiani, risiede circa il 5% della popolazione nazionale. Dal punto di vista economico di segno positivo, anche per il 2015, è il tasso di crescita delle imprese (0,2 punti percentuali in più rispetto al 2014) che, grazie al saldo positivo di 45mila nuove imprese, a livello nazionale ha raggiunto lo 0,7%. I nuovi imprenditori ‘under 35’ hanno contribuito con 66.202 nuove unità, 32mila sono quelle create dagli stranieri e 14.300 dalle donne.
Qualitàdell'aria
Un capitolo del dossier è dedicato al rapporto tra inquinamento atmosferico e salute, sulla base degli studi più recenti in materia e sottolinea che l’aria che respirano milioni di italiani nelle maggiori città della Penisola rappresenta ancora un grave problema di salute. Per quanto riguarda l’inquinamento da polveri sottili, al 13 dicembre 2016 almeno 18 capoluoghi di provincia hanno già superato il limite giornaliero per il pm10 (Frosinone, Venezia e le altre città della pianura padana le peggiori. Ma anche Napoli e Terni).
I dati sono migliori rispetto a quelli del 2015, quando 45 aree urbane su 95 non hanno rispettato il valore limite giornaliero del pm10. Sempre lo scorso anno, il 90% della popolazione nei comuni considerati è risultato esposto a livelli medi annuali superiori al valore guida dell’Organizzazione mondiale della Sanità per il pm10, l’82% a quello del pm 2,5, il 27% a quello del biossido di azoto. “Emerge chiaramente – rileva il rapporto – la notevole distanza dagli obiettivi dell’Oms” e, quindi “non sorprende il fatto che nelle stime recentemente elaborate dall’Agenzia Europea per l’Ambiente l’Italia figuri tra le nazioni con gli indici di rischio sanitario più elevati”.
Rischio alluvioni e frane
Uno dei principali elementi di pericolo per il territorio è costituito dai fenomeni di dissesto idraulico. Le conseguenze risultano in genere più pesanti in quelle aree dove l’intervento dell’uomo ha profondamente modificato il territorio e il paesaggio naturale, rendendoli più fragili e vulnerabili. La popolazione a rischio alluvioni è stimata in 1.950.954 abitanti, pari all’11,1% della popolazione residente totale nei 116 comuni.
Le città nelle quali è stato individuato un maggior rischio sono quelle lungo i grandi fiumi italiani (Po, Tevere, Arno) o in aree di pianura, oltre alla città di Genova. Dodici comuni capoluogo hanno più di 50mila abitanti a rischio. “Altro fenomeno di grande impatto – spiega il rapporto – sia per l’incolumità della vita umana che delle per i danni a infrastrutture ed edifici, è quello dei fenomeni franosi”. L’11,5% dell’area totale dei comuni censiti è compreso in aree a pericolosità da frana e in aree di attenzione dei Piani di Assetto Idrogeologico, il 3,3% se riduciamo l’analisi a quelle soggette a maggiori rischi e, quindi, a vincoli di utilizzo del territorio più restrittivi.
In questa pur ridotta percentuale di territorio vivono attualmente circa 170mila abitanti, pari all’1% della popolazione totale dei comuni capoluoghi di provincia. Nel 2015 sono 22.270 le frane censite nell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia che ricadono nel territorio dei 116 Comuni capoluoghi di provincia. I comuni con più abitanti a rischio frane sono: Napoli, Genova, Massa, Chieti, Palermo, Catanzaro, Salerno, Caserta, Siena, Lucca, Trento, Grosseto, Ancona, La Spezia e Campobasso. Ma il fenomeno rappresenta un rischio anche per i beni culturali: 1.117 sono a rischio, ovvero l’1,9% di quelli che si trovano nelle aree prese in esame.
Risorse idriche e balneabilità
Tra il 2012 e il 2015, nelle 116 città prese in esame si è registrata una riduzione dei consumi idrici dell’8,4%, ma nel 2015 è stata registrata una dispersione reale dell’acqua immessa nella rete di distribuzione del 35,4%. In 90 città si hanno valori di dispersione di rete reali superiori al 20%, di cui 18 superiori addirittura al 50%. Per la stagione balneare 2016, i monitoraggi confermano che la quasi totalità dei tratti costieri dei 9 capoluoghi costieri di Regione, monitorati da Snpa, è idonea alla balneazione. Diversi i dati sui pesticidi. Per il 2014 riguardano complessivamente 79 capoluoghi: su 160 punti di monitoraggio nelle acque superficiali, 26 (16,2%), relativi a 18 città, hanno livelli di concentrazione superiore ai limiti.
 , 16 dicembre 2016. eddyburg aderisce e invita ad ampliare la diffusione
, 16 dicembre 2016. eddyburg aderisce e invita ad ampliare la diffusione
APPELLO IN DIFESA DI CHI DIFENDE LA BELLEZZA
Quanto costa difendere la bellezza?
La Bellezza non ha prezzo ma proteggerla costa fatica e impegno. Per una volta non vi parliamo della tenacia e della dedizione con cui tanti si battono per rendere più belle le proprie comunità, vogliamo invece parlarvi del prezzo che si è talvolta costretti a pagare per difendere le ragioni della tutela dell’ambiente, della salvaguardia del paesaggio e della salute dei cittadini, cioè per fare tutto quello che, con il sostegno dei propri soci, di altre associazioni e di tanti altri cittadini, fa da sempre Legambiente Sicilia, da Lampedusa a Ragusa, dalle Isole Eolie a Siracusa.
Quanto costa oggi difendere la Bellezza a Siracusa? La risposta è: costa 18.000 euro. A tanto ammonta la condanna alle spese legali inflitta a Legambiente Sicilia per avere difeso le Mura Dionigiane e il Castello Eurialo dalla costruzione di un centro commerciale e le casse del Comune (e quindi di tutti i siracusani) da un risarcimento senza precedenti.
Dopo essere intervenuta nelle diverse sedi giudiziarie per contrastare la realizzazione del centro commerciale che sfigura le grandi vestigia della fortificazione greca, Legambiente Sicilia in una delle sue numerose iniziative per evitare questa aggressione alle risorse della città, ha impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione la sentenza con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (C.G.A.R.S.) aveva condannato il Comune a pagare il risarcimento del danno in favore della società Open Land per avere in un primo momento negato l’autorizzazione a realizzare un centro commerciale sulla Balza di Epipoli, a due passi da una delle aree più delicate del patrimonio monumentale archeologico siciliano.
Legambiente si è caricata la responsabilità civile di contrastare, a fianco del Comune, un enorme esborso di risorse pubbliche per il danno che il Comune avrebbe causato all’Open Land per avere inizialmente rigettato un’istanza di concessione edilizia che, come ha riconosciuto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (C.G.A.R.S.), “non avrebbe potuto in alcun modo essere accolta difettando in radice i presupposti urbanistici per il suo legittimo rilascio” (Sentenza n. 605/13 del 20.06.13) ma che in seguito è stata rilasciata per silenzio - assenso. Nelle diverse fasi del processo, il contributo degli esperti e degli avvocati di Legambiente è stato decisivo per fare ridimensionare le pretese risarcitorie della società (quasi 35 milioni euro) per oltre sedici milioni.
Respingendo il ricorso la Cassazione, con una decisione che lascia sconcertati e che non ha precedenti nei confronti di associazioni di volontariato, ha condannato Legambiente Sicilia al pagamento delle spese processuali per l’importo di 12.000 euro oltre accessori (di qui i 18.000 euro), dei quali il gruppo che pretende il risarcimento milionario ha subito intimato il pagamento.
Siamo al summum jus summa injuria: la concessione edilizia per la costruzione di un enorme centro commerciale pur in contrasto con il piano regolatore ed i vincoli archeologici rilasciata in virtù di un silenzio - assenso formatosi per circostanze ancora da chiarire.
Senza contare che è ancora pendente sempre dinanzi al giudice amministrativo un altro contenzioso in cui Legambiente è costituita a difesa dello stesso importantissimo sito archeologico dalla possibile costruzione di un complesso edilizio (70 ville!), nel quale è stata avanzata nei confronti della Regione Siciliana una richiesta di risarcimento di oltre 200 milioni di euro per avere negato la Soprintendenza il rilascio del nulla-osta.
In tutti questi anni Legambiente Sicilia, con il supporto del suo Centro di Azione Giuridica (avvocati ed esperti che prestano il loro lavoro in favore dell’associazione) è stata in prima linea nel denunciare le illegalità ambientali e nel difendere il territorio e la salute dei cittadini da opere inutili e dannose. Ricordiamo solo alcune delle battaglie vinte nel corso del tempo anche grazie alle iniziative in sede giudiziaria di Legambiente:
- Piano regionale dei Rifiuti del governo Cuffaro: annullato grazie a un ricorso alla Corte di Giustizia Europea. Prevedeva quattro mega inceneritori in Sicilia (uno ad Augusta per bruciare 280.000 ton/anno di spazzatura);
- difesa delle Riserve naturali storiche di Sicilia: Vendicari (Noto), Zingaro (Trapani), Stagnone di Trapani, Irminio (Ragusa), Timpa (Acireale);
- contrasto al Ponte sullo Stretto di Messina, con decine di ricorsi ed un impegno nelle sedi giudiziarie di Catania, Reggio Calabria e Roma;
- sospensione dei lavori di costruzione del M.U.O.S., l’impianto militare di comunicazione satellitare da realizzare dentro la sughereta di Niscemi;
- limitazione della Caccia in Sicilia: con una serie di ricorsi Legambiente è riuscita a fare riconoscere la previsione della procedura di valutazione di incidenza ambientale nelle aree di importanza naturalistica (SIC e ZPS);
- difesa con successo (sino alla Corte Costituzionale) del Piano Paesaggistico delle Isole Eolie;
-difesa dei Piani Paesaggistici di Siracusa e di Ragusa, a tutela dell’ambiente e del paesaggio degli Iblei;
- riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio da parte di associazioni o comitati locali, che proteggono l’ambiente, la salute e la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio.
Chiunque è in grado di capire che per un’associazione di volontariato l’esborso di 18.000 euro è un onere gravosissimo: rischia di metterla in ginocchio, di comprometterne le attività correnti e ipotecarne il futuro, scoraggiando le concrete efficaci azioni di tutela che preoccupano chi opera contro il Bel Paese. Questa condanna, che riteniamo ingiusta e sproporzionata, rischia di impedire a Legambiente Sicilia di sostenere le mille battaglie in cui sono impegnati su tutto il territorio regionale i propri circoli, per primi quelli di Siracusa, Priolo Gargallo, Augusta e Melilli Ragusa, Modica, Messina, Capo d’Orlando, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Trapani, Palermo che insieme a associazioni e comitati operano in territori da decenni minacciati dall’inquinamento industriale, dal malgoverno e dalla svendita del territorio e dei beni culturali.
Per questo, vi chiediamo di sostenere la raccolta fondi in favore di Legambiente Sicilia “Diciottomila Azioni per la Salvezza della Bellezza”. Con la sottoscrizione di azioni di 1 euro ciascuna sul conto corrente con il seguente Codice Iban: IT56B0200804610000102308987), si potrà aiutare Legambiente Sicilia a estinguere il debito di 18.000 euro per la condanna subita e con essa tutte quelle associazioni, comitati, gruppi di cittadini impegnati nella coraggiosa battaglia per i beni comuni.
Quanto più vasta sarà la partecipazione all’iniziativa tanto più forte diremo ai Distruttori di Bellezza e ai Ladri di Futuro che non possono agire indisturbati. Servirà a ricordargli che non intendiamo in alcun modo abbandonare il campo, rinunciare all’azione in tutte le sedi politiche e giudiziarie che per le Associazioni Ambientaliste e le ‘formazioni sociali” richiamate dall’Art. 2 della Costituzione, rappresenta un mezzo irrinunciabile per affermare gli interessi primari della collettività, della Salute (art.32 della Costituzione), della Cultura e del Paesaggio (art.9 della Costituzione) e per i cittadini una garanzia democratica fondamentale.
Dobbiamo far sentire la voce del Paese della speranza nel cambiamento, delle coscienze per i beni comuni aggrediti e minacciati, lottare per una giustizia di garanzia in un mondo che vogliamo continuare a cambiare.
«Dobbiamo ricucire ciò che è lacerato, rendere immaginabile la giustizia in un mondo evidentemente così ingiusto» (Albert Camus)
Patrizia Maiorca
Beatrice Basile ex Soprintendente ai BB AA CC di Siracusa
Sebastiano Tusa Soprintendente del Mare Palermo – archeologo
 «Sovranità alimentare. Una ventina di realtà disseminate dalla Lombardia alla Sicilia, un'organizzazione al tempo stesso di produzione e di lotta, sul modello dei Sem terra brasiliani». il manifesto, 15 dicembre 2016 (c.m.c.)
«Sovranità alimentare. Una ventina di realtà disseminate dalla Lombardia alla Sicilia, un'organizzazione al tempo stesso di produzione e di lotta, sul modello dei Sem terra brasiliani». il manifesto, 15 dicembre 2016 (c.m.c.)
C’è chi produce salsa di pomodoro e chi coltiva arance, chi fa il cioccolato e chi il caffè. Si tratta per il momento di una ventina di realtà disseminate dalla Lombardia alla Sicilia, dalla Puglia alla Toscana. Le ha unite la presa di coscienza del fatto che se vuoi tentare di produrre in maniera diversa, cioè rispettando la dignità delle persone e l’ambiente, e vuoi sottrarre migranti e non dal ricatto del caporalato e dello sfruttamento, devi unirti, ché da solo non ce la fai.
E ciò vale soprattutto in un settore come quello dell’agricoltura, in cui a dare le carte, cioè a stabilire prezzi e quindi, a cascata, condizioni di lavoro e retribuzioni, è la grande distribuzione, che punta a pagare il meno possibile i prodotti che finiranno negli scaffali dei supermercati. È nata così la rete Fuorimercato, che di recente ha tenuto a Milano la sua terza assemblea nazionale e che nel prossimo mese di febbraio vedrà il suo quarto incontro a Rosarno (Reggio Calabria), dove si trova una delle realtà aderenti alla rete, «Sos Rosarno».
Ma che cosa è fuorimercato? È da un lato un insieme di realtà che combattono, producendo, sfruttamento delle persone e dell’ambiente in campo agricolo. Dall’altro una serie di spacci, anche questi sparsi un po’ in tutta la penisola, che distribuiscono i beni prodotti che finiscono anche in mercati popolari e nelle liste dei Gruppi d’acquisto solidale di molte zone del nord Italia.
Detta così sembra facile, ma le difficoltà sono più d’una. Per questo Fuorimercato si sta tentando di strutturare come un’organizzazione al tempo stesso di produzione e di lotta. I modelli sono quelli del movimento dei Sem terra brasiliani e del Soc Sat andaluso, un sindacato che nella regione del sud della Spagna difende gli interessi dei braccianti. E qui si arriva a un altro pezzo del dna di Fuorimercato. Che oltre a essere una rete di produttori e di punti di distribuzione dei beni alimentari, è anche il tentativo di costruire un’alternativa.
«Siamo partiti dai bisogni», dice Gigi Malabarba di Rimaflow, una fabbrica lombarda che produceva per il settore automobilistico e che dopo essere stata rilevata dai lavoratori è stata riconvertita a «cittadella dell’altraeconomia» e oggi fa parte di Fuorimercato. I bisogni e i diritti cui tenta di fare fronte la rete sono tanti: quello dei migranti a un lavoro pagato dignitosamente e a un tetto decente sulla testa; quello dei braccianti e dei piccoli produttori italiani a non essere strangolati dai prezzi decisi da chi sta in alto. E quello dei consumatori di mangiare cibo decente e non avvelenato. Si tratta di cose diverse ma che si tengono insieme le une con le altre, e a Fuorimercato tentano di farlo. Come? «Con il mutuo soccorso», dice Gianni De Giglio di Sfrutta Zero, realtà pugliese attiva nel lavoro con i migranti.
Mutuo soccorso. Un salto all’indietro agli albori del movimento operaio per guardare al futuro: sorreggersi gli uni agli altri per evitare di farsi spazzare via dai giganti e garantire e garantirsi un’alternativa fatta di rispetto dei diritti, salubrità dell’ambiente e bontà del cibo. Ma se cerchi l’alternativa sei a tutti gli effetti una realtà anche politica.
Così, questo strano animale che è Fuorimercato, si sta attrezzando per fare del mutuo soccorso una leva per agire a 360 gradi: dal punto di vista della produzione per tentare di tenere sotto controllo tutta la filiera: «Per quanto riguarda coltivazione e trasformazione dei prodotti, ci siamo; la logistica e i trasporti invece sono le criticità, perché ad esempio per trasportare gli agrumi servono i tir, che noi non abbiamo; e sai, se riesci a dare continuità alle produzioni e alla filiera, crei anche lavoro e più in generale dai maggiore solidità a tutta l’organizzazione», dice Malabarba. «E affidarci ai corrieri non ci piace», aggiunge De Giglio. Perché? «Perché l’alternativa dev’essere completa, non ci possono essere coni d’ombra: non possiamo produrre e trasformare i nostri prodotti seguendo certi principi e poi affidarci per la loro spedizione a realtà che operano in modi che non condividiamo e che anzi combattiamo.
Così Rimaflow sta dando una mano fungendo da magazzino e consentendo così di fare meno spedizioni dal sud al nord e ottimizzando i periodi in cui si dispone di mezzi garantiti in mutuo soccorso da altri.
L’altro versante è quello delle vertenze: per l’accesso alle terre e per il diritto alla casa, innanzitutto, sia dei migranti che dei nativi. E anche qui si tenta di fare mutuo soccorso. Così, se una delle realtà della rete dispone di competenze al suo interno su un singolo settore, le mette a disposizione di tutti. Agronomi, avvocati, commercialisti, esperti di web e quant’altro, attivi in uno dei nodi, diventano patrimonio di tutti. Insomma, «tentiamo di costruire l’alternativa praticandola, facendone vedere i frutti – dice Malabarba – perché la teoria da sola non basta».
Ma non solo. Alla base di Fuorimercato c’è proprio la volontà di costruire un’altra economia. Che a partire dalle emergenze più stringenti, quella dei migranti sfruttati dal caporalato particolarmente virulenta al sud, si allarghi ad altri settori della produzione e della distribuzione di beni e servizi. Per questo, dopo tre incontri nazionali e in vista del quarto, si sta mettendo in piedi il coordinamento nazionale, nel quale un paio di rappresentanti di ognuno dei nodi dovranno tenere il filo dei rapporti tra la rete e le singole realtà. E, a proposito di mutuo soccorso, si sta apprestando una «cassa comune» che consenta di sopperire alle esigenze primarie di Fuorimercato.
Anche magari quelle derivanti dalle vertenze aperte. «Il tentativo è di coniugare l’aspetto mutualistico e quello del conflitto, perché per cambiare le cose sono necessari entrambi», dice De Giglio.
Ancora una volta: un passo indietro alle radici che resero saldo il movimento operaio, e sguardo avanti, «liberandosi dalle differenziazioni che spesso hanno minato le possibilità di alternativa per tuffarsi nel fare», chiosa Malabarba.
 «Roma. La questione dello stadio della Capitale e il M5S che non scioglie l’ambiguità per un’operazione urbanistica in continuità con il passato e con gli interessi dei costruttori». il manifesto, 14 dicembre 2016 (c.m.c.)
«Roma. La questione dello stadio della Capitale e il M5S che non scioglie l’ambiguità per un’operazione urbanistica in continuità con il passato e con gli interessi dei costruttori». il manifesto, 14 dicembre 2016 (c.m.c.)
Provate ad immaginare (se ci riuscite) che la città di Parigi scivoli all’88° posto della graduatoria delle città francesi per la qualità della vita. Impossibile. Parigi è la Francia e la Francia è Parigi, così che, per definizione, Parigi non può che essere la migliore tra tutte le città francesi. In Italia, invece, nessuno grida allo scandalo e tanto meno si prendono provvedimenti, se la Capitale diventa addirittura l’esempio nazionale del degrado in termini di trasporti, smaltimento dei rifiuti, qualità della vita.
Roma è stata anche in passato città di corruzione, di malaffare. Espressioni come «Roma ladrona», «Capitale infetta», sono state usate dai leghisti per rivendicare una loro presunta purezza e onestà padana, ma nessuno, al di là della loro strumentalizzazione politica, le ha mai considerate fuori posto o, come si dice a Roma, «campate per aria». Albergano indisturbate e mai smentite dai fatti, nell’immaginazione popolare degli italiani.
Molte persone di provata fede di sinistra, nelle ultime votazioni che hanno visto contrapposti i due candidati sindaci: Giachetti (Pd) e Raggi (M5S), hanno votato, con più o meno reticenza e convinzione, per quest’ultima. Sulle ragioni di questa disaffezione nei riguardi della sinistra ufficiale (confermata e, direi, sancita definitivamente dal recente referendum) si potrebbe discutere a lungo, ma non è questo l’argomento del giorno dell’agenda politica.
A spingere per questa sofferta decisione (di votare Raggi), fu anche la scelta, da parte del M5S, di candidare come assessore all’urbanistica Paolo Berdini. Molti furono indotti a ritenere che tale scelta rappresentasse un segnale di netta discontinuità col passato; che finalmente si sarebbe recisa quella complicità storica tra amministrazione e costruttori e immobiliaristi, quelli, insomma, che, a Roma, hanno sempre avuto la meglio rispetto alla tutela dell’interesse pubblico e collettivo.
A Paolo Berdini, in passato, non erano certo mancate occasioni per manifestare pubblicamente la sua opposizione a tentativi di speculazione; le sue denunce sul malaffare che ruota intorno al mattone erano regolarmente pubblicate sui quotidiani e, in particolare, sul manifesto. Egli stesso era diventato il simbolo di un’urbanistica romana decisa a rivendicare l’affermazione dell’interesse pubblico su quello privatistico, sugli affari. E siccome il nome di Berdini fu uno dei primi (se non il primo) ad essere fatto dalla neosindaca Raggi per la sua squadra di governo, tutto faceva supporre che si stava preparando una fase nuova nella tribolata storia dell’urbanistica romana.
In primis era la questione della candidatura di Roma alle Olimpiadi (e fin qui la Raggi, seppure con qualche tentennamento iniziale, ha tenuto), ma poi, ancora più importante, era la questione scandalosa del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle, voluta dal sig. James Pallotta, con al seguito tre grattacieli, uffici, una catena di centri commerciali, residenze e quant’altro sufficiente a ritenere che lì, a Tor di Valle, lo stadio fosse solo la foglia di fico con cui far nascere una nuova città in barba a qualsiasi criterio urbanistico e, dietro la quale, si nascondevano giganteschi interessi economici. «Obbrobrio», se ricordo bene, fu l’espressione usata da Berdini per definire quell’infausta ipotesi urbanistica.
Ora i vertici del M5S, in odore di elezioni anticipate non esitano a ritenere che quello stadio e quella sciagurata avventura s’ha da fare. Forse vogliono accattivarsi le simpatie (soltanto?) dei grandi costruttori che ruotano intorno all’operazione, tanto da far dire alla stessa deputata M5S, Roberta Lombardi che «il sospetto che Mafia Capitale, con i suoi interessi milionari nel dipartimento che fa capo a Berdini, alberghi ancora in Campidoglio, anche con la giunta Raggi».
Fatto è che sono circolate (somministrate ad arte proprio nel vecchio stile democristiano di affermazioni e altrettanto immediate smentite) voci sulla sostituzione di un assessore cui non è mai stata data neppure la possibilità di iniziare il proprio lavoro.
C’è da dire ancora, questa volta nella direzione del Pd che già gongola per il tradimento dei 5S nei confronti del popolo romano, che Giachetti (in sede di campagna elettorale) neppure ci aveva provato a contrastare quell’infausto progetto dello Stadio e che, con il Pd al Campidoglio, neppure staremmo a scrivere queste cose perché gli accordi erano già conclusi.
E così, per tornare alle ragioni esposte all’inizio, Roma continuerà a scivolare nella graduatoria delle città italiane. Crotone già teme di venire scalzata dal suo primato di ultima città italiana.
«Il “confronto pubblico” non è quindi importante di per sé, ma come lubrificante politico, utile a sbloccare l’Italia e garantire che i progetti si facciano, senza troppe rotture di scatole. Lo “strumento di democrazia” del sindaco è uno strumento privatizzato per una democrazia esternalizzata». Internazionale online, 10 dicembre 2016 (p.d.)
Pubblichiamo la seconda puntata del reportage in tre puntate condotto da Wolf Bukowski e Wu Ming sul Passante di Bologna (la prima puntata la trovate qui).
Per vedere di nascosto l’effetto che fa
Il ponte di mattoni rossi sulla via Emilia, a cavallo del fiume Reno, ha ottenuto fama letteraria con il nome di Pontelungo. Nelle pagine di Riccardo Bacchelli lo attraversano prima il diavolo, con addosso un cappello a cilindro gibus, di quelli tenuti in forma da molle nascoste, e poi l’anarchico Bakunin. Oggi è piuttosto malandato, ha un marciapiede transennato e attende da tre anni lavori urgenti che lo mettano in sicurezza. Superato il ponte si svolta a destra, verso l’aeroporto di Bologna, e lungo la strada s’incontra La Birra, un quadrilatero di case stretto tra la ferrovia, il fiume e la tangenziale; nella frazione c’è la scuola elementare, e accanto alla scuola, la palestra. Sul pavimento in gomma, con le linee dei campi da basket e pallavolo, ci sono per l’occasione dieci tavoli rotondi. A uno di questi è seduta la signora, accanto a lei il suo deambulatore. È venuta fin qui e ha atteso paziente l’inizio dei “tavoli di discussione” per poter dire quello che la inquieta. Però, quando viene il suo momento, anche noi, che le sediamo vicini, non capiamo quel che dice, perché ogni tavolo discute in contemporanea, contendendo agli altri lo spazio acustico della palestra, dove l’altissimo soffitto fa di ogni brusio un frastuono. Cogliamo giusto qualche parola, “la mia casa… esproprio… mila euro”, e questo basta a lasciarci intravedere il dramma. La signora perderà la casa, nel luogo dei suoi ricordi ci sarà uno svincolo nuovo di zecca, e teme che i soldi dell’indennizzo “a prezzo di mercato” non bastino per una sistemazione altrettanto dignitosa.
Per fortuna ogni tavolo ha un facilitatore o una facilitatrice, anche il nostro. La facilitatrice incita la signora a parlare a voce più alta, come ogni santo scolastico giorno fanno le insegnanti nell’edificio accanto con i bambini troppo timidi. Poi, con la stessa pazienza di una brava maestra, aiuta la signora a chiarire il proprio pensiero, compitando con lei parole e concetti – “il prezzo di mercato significa la valutazione del mercato nel momento in cui l’esproprio viene fatto” – e suggerendole di dare al suo tormento una forma propositiva – “tuttavia, possiamo fare una domanda che riguardi specificatamente il criterio con il quale viene determinato il valore dell’immobile”. L’importante, per la facilitatrice, è arrivare a “formulare una domanda” a cui le autorità e “gli esperti” risponderanno. La signora deve essere propositiva affinché il “giro di tavolo” possa proseguire. Dopo di lei intervengono due donne. Parlano con l’esperienza di chi abita vicino alla tangenziale da decenni, non con il lessico affinato da chilometriche riunioni di “antagonisti”. Esprimono, in altri termini, il proverbiale concetto “chi semina strade, raccoglie traffico”. Ma alla facilitatrice non va bene, bisogna…“provare a tradurre questa preoccupazione in una domanda”. Le signore ci cascano e accettano di chiedere informazioni dettagliate sulle… barriere acustiche.
Questa è la “facilitazione”, ovvero la messa in campo (da basket) del “confronto pubblico” sul Passante di Bologna, il processo partecipativo che il sindaco Merola considera uno “strumento di democrazia”. Uno strumento che le amministrazioni usano sempre più spesso, negli ultimi tempi, con risultati molto deludenti. Tra le critiche più diffuse, c’è quella di voler allestire un dibattito di facciata, per poi farsene scudo contro ogni contestazione successiva. “Siamo stati aperti e disponibili, vi abbiamo ascoltato, abbiamo risposto, che altro volete?”.
Libertà è partecipazione
Nel campo delle grandi opere, il precedente che tutti citano, l’esperimento apripista, è il débat public “alla francese”, istituito nel 1994 dopo le violente proteste delle popolazioni locali contro l’alta velocità Marsiglia-Lione. Da allora, tutte le grandi infrastrutture passano al vaglio di un’apposita commissione nazionale, che decide se avviare il confronto. “Ma nel momento in cui lo decide”, spiega Iolanda Romano, esperta di processi decisionali inclusivi, “il confronto diventa obbligatorio e, sottolineo, aperto a tutti. Nel débat public, e questo è importantissimo, non si discute solo del come, ma anche del se, dell’opportunità dell’opera. E deve svolgersi in una fase anticipata rispetto al progetto definitivo”.
Il primato italiano per una “legge sulla partecipazione” spetta invece alla regione Toscana, che ha approvato la propria nel 2007. Secondo i commentatori più entusiasti, si trattava della prima legge al mondo che mirasse a promuovere il coinvolgimento dei cittadini nelle politiche pubbliche in generale e non solo su tematiche specifiche. Eppure, tanta inedita promozione non ha funzionato granché. Il “dibattito pubblico” non si è svolto neppure per la grande opera più controversa, l’ipotesi di sotto-attraversamento Tav di Firenze. La legge stessa prevedeva una valutazione dei propri risultati a cinque anni dall’entrata in vigore. E il risultato della valutazione è che è stata riscritta. Il nuovo testo prevede che il dibattito pubblico non sia più solo un diritto, ma anche un dovere, per i progetti di maggiore impatto. Tuttavia, a fronte di questo “dovere di ascoltare”, non c’è nessun dovere di recepire, nessun rapporto vincolante tra le conclusioni del confronto e i progetti definitivi. Il promotore dell’opera deve rispondere alle critiche e motivare le sue scelte, ma fatto questo può tirar dritto. Così i cittadini, dopo mesi di confronto, si portano a casa la convinzione che partecipare sia una perdita di tempo.
Non va meglio con un’altra legge regionale, quella dell’Emilia-Romagna, introdotta nel 2010. Qui il dibattito pubblico non è obbligatorio, anzi, per ricevere sostegno e finanziamenti, un progetto di partecipazione deve rispondere a requisiti, modalità e criteri fissati dalla giunta regionale. Inoltre, l’ente locale coinvolto deve dare il proprio assenso. Altrimenti, nisba. Quindi, se i cittadini di Roccafritta vogliono avviare un dibattito pubblico sulla nuova fondovalle, devono progettarlo in modo che piaccia alla regione e al loro comune. Così, i dibattiti sgraditi alle autorità locali hanno ben poche possibilità di ricevere un sostegno. Ma se per caso lo ottengono, niente paura: anche in questo caso, le conclusioni del processo partecipativo non sono vincolanti per nessuno.
Questo è il quadro nelle due regioni considerate all’avanguardia per la promozione dei processi partecipativi e di dibattito pubblico. Ma il panorama è ancora più sconfortante se ci spostiamo in ambito nazionale. Nel marzo 2015 è stato presentato un disegno di legge sul débat public, il cui primo firmatario è il senatore Stefano Esposito. L’esigenza che muove i promotori è quella di “colmare il gap infrastrutturale che […] affligge il nostro Paese” e di “superare lo stallo decisionale che affligge la nostra economia”. Una delle cause di questo ritardo sarebbero i cittadini, che si oppongono ai progetti “in quanto percepiti come frutto di decisioni ‘calate dall’alto’ nonostante siano state assunte da rappresentanze democraticamente elette”. “Si tratta di chiudere un’epoca”, continua Esposito, “per aprirne un’altra, attraverso la presa d’atto che il modello […] delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente […], è divenuto, da solo, insufficiente a dare garanzie sulla fattibilità concreta di un progetto”. Il “confronto pubblico” non è quindi importante di per sé, ma come lubrificante politico, utile a sbloccare l’Italia e garantire che i progetti si facciano, senza troppe rotture di scatole.
Mentre il disegno di legge Esposito è all’esame del senato, il parlamento italiano deve occuparsi di tre direttive europee, che obbligano a rivedere le leggi sui lavori pubblici. Il nuovo codice degli appalti entra in vigore il 19 aprile 2016 e tra i cambiamenti che introduce c’è proprio la “consultazione pubblica”. L’articolo 22 la rende obbligatoria per “le grandi opere infrastrutturali e di architettura, di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio”. Un decreto dovrà poi stabilire come individuare tali opere, in base al tipo e alla dimensione, e con quali modalità svolgere il dibattito che le riguarda. Tutti i progetti avviati dopo l’entrata in vigore del codice dovranno sottostare alle nuove regole. Per non sbagliare, il Passante di Bologna viene approvato proprio quattro giorni prima, il 15 aprile, mentre il ministero delle infrastrutture avrà un anno di tempo per emanare il decreto con tutti i dettagli. Tra questi “dettagli” c’è la questione di chi debba condurre la consultazione. Esposito, nella sua proposta, immagina un “soggetto pubblico indipendente” che agisca “in modo assolutamente imparziale”, ma come garantire questa indipendenza e imparzialità è uno degli aspetti più delicati da definire. In Francia, la commissione nazionale per il dibattito pubblico è composta da 25 persone, tra le quali una indicata dalla corte dei conti, sei elette localmente, due scelte dai sindacati, due dalle associazioni di consumatori, due da quelle ambientaliste. La legge toscana sulla partecipazione ha istituito un’autorità, chiamata a svolgere una funzione simile. Sono tre componenti, designati dal consiglio regionale. Considerando che la regione è spesso tra i proponenti delle opere che si vanno a discutere, l’imparzialità di quest’organismo risulta quantomeno dubbia. Nel dibattito sul Passante di Bologna, un “soggetto pubblico indipendente” che gestisse il confronto non si è nemmeno visto, ma l’organizzazione degli incontri è stata affidata a una società privata, individuata con un meccanismo che non è affatto garanzia d’indipendenza. Vediamo perché.
(Non) sarà un’avventura
L’articolo 3 bis dell’accordo per la realizzazione del Passante di Bologna, assegna ad Autostrade per l’Italia il compito di individuare “specifiche professionalità con comprovata esperienza” al fine di attivare un confronto pubblico. Esso “consisterà nella presentazione al territorio […] delle soluzioni progettuali individuate nel Progetto preliminare, attraverso illustrazioni pubbliche e attività di coinvolgimento dei cittadini […] favorendo la proposizione di idee che consentano di raccogliere i vari contributi premiando le migliori soluzioni. Ciò al fine di individuare, […] i possibili miglioramenti da apportare al progetto per favorire un migliore inserimento nel tessuto urbano dell’opera e per ottimizzare l’utilizzo delle risorse”. Torna, ineludibile, l’aria di scuola elementare che si respira nella palestra della Birra. Il confronto pubblico diventa un’attività di coinvolgimento – “Bambini, oggi facciamo un collage!” – attraverso illustrazioni pubbliche – “fermi con quelle forbici: vi faccio vedere come si ritaglia” –, che favoriscano la proposizione di idee premiando le migliori soluzioni: “Siete tutti bravissimi, però faremo una mostra speciale dei lavori dei più bravi dei bravissimi”. Ma i migliori collage non devono andare fuori tema, e possono riguardare solo l’inserimento dell’opera nel tessuto urbano e un più generico “utilizzo delle risorse”. D’altra parte, il “Progetto preliminare”, cioè il punto di partenza del dibattito, è completo fino nei dettagli: dalle rotatorie e gli svincoli da costruire alle canalette di raccolta dell’acqua.
Nel sito del Confronto pubblico, la traduzione in lingua corrente dell’articolo 3 bis lo interpreta ancora più al ribasso. Si tratta, semplicemente, di “presentare con un linguaggio chiaro anche ai non addetti ai lavori il progetto del Passante” e di “ascoltare i cittadini per raccogliere proposte su come migliorare gli interventi di inserimento ambientale, paesaggistico e di protezione acustica”. Un po’ poco per definire il processo partecipativo “una grande occasione per entrare nel merito di un grande progetto”, secondo le parole del sindaco Merola. Pochissimo rispetto al modello proposto da Iolanda Romano, quello in cui “non si discute solo del come, ma anche del se, dell’opportunità dell’opera. E [che] deve svolgersi in una fase anticipata rispetto al progetto definitivo”. Eppure è proprio Avventura Urbana, di cui Romano è fondatrice e presidente fino al febbraio 2016, ad assumere l’incarico di gestire la consultazione bolognese.
Scrive Franco La Cecla, in Contro l’urbanistica (Einaudi, 2015): “Avventura Urbana è […] una agenzia che si occupa professionalmente di organizzare processi partecipativi. Tutto questo è molto bello, ma la mia impressione è che abbia poco scalfito l’urbanistica in quanto tale e sia diventata molto presto un’attività a parte. Come esistono quelli specializzati nel piastrellare un pavimento, così esistono i partecipatori. Questi vengono adoperati da amministrazioni, autorità locali ma anche grosse imprese di progettazione per mediare il rapporto tra progetto e utenti. Diventano facilitatori del consenso, o comunque negoziatori tra le richieste della popolazione e le decisioni dei pianificatori. È il grande campo dell’animazione sociale […] il vastissimo campo del filtro sociale tra utenti sempre meno abituati a far valere direttamente i propri diritti e pianificatori che non vogliono direttamente essere implicati. Serve ad attutire i conflitti, certamente, una specie di professione cuscinetto tra interessi diversi. Il problema è che in questa funzione filtro specializzata tutto si ricompone in maniera tale che poco cambia nella passività degli abitanti e nella vecchiezza dell’impostazione progettuale”.
Nel caso bolognese, come abbiamo visto, è Autostrade che ha incaricato Avventura Urbana. L’accordo dice che la scelta deve avvenire “di concerto con le parti”, cioè con i firmatari pubblici (governo, regione, comune…), ma non è affatto chiaro chi debba pagare le “specifiche professionalità con comprovata esperienza”. Le questioni di soldi, in tutta questa vicenda, sono appena sfiorate, noblesse oblige. Sulle pagine di Avventura Urbana srl, tra i clienti dell’azienda, ci sono Autostrade e la sua controllata Spea, che progetta il Passante, ma non gli altri soggetti. C’è, è vero, la regione Emilia-Romagna, ma probabilmente solo per i servizi formativi forniti da Avventura Urbana dal 2009 al 2011. Inoltre il sito del confronto pubblico, passantedibologna.it risulta registrato dall’azienda che cura la presenza in rete di Autostrade. È quindi evidente che la titolarità del Confronto pubblico va ricondotta ad Autostrade, ed è più che ragionevole supporre che sia Autostrade a pagare Avventura Urbana. Lo “strumento di democrazia” del sindaco è dunque uno strumento privatizzato per una democrazia esternalizzata. Così Autostrade, che ha interesse a realizzare l’opera per avere più veicoli ai caselli bolognesi, paga un altro soggetto privato per gestire la partecipazione e “farsi fare le domande” dai cittadini, domande che però devono essere solo su aspetti marginali.
Anagramma (quasi) perfetto di facilità
Come questo si realizzi sul playground del “Confronto pubblico” è presto detto, basta tornare al tavolo di discussione nella palestra della Birra. Tocca a Valeria, più giovane di età e di residenza nel quartiere rispetto a chi l’ha preceduta. Parla delle minacce alla salute, della partecipazione-farsa, degli impegni su rumore e inquinamento che non sono affatto impegnativi per Autostrade, e poi: “Non cambia nulla se ce lo becchiamo noi l’inquinamento o quelli del Passante nord o sud, il problema è di tutti!”. E ancora: “Invece di fare il compitino delle domande da preparare dobbiamo parlarne tra noi, poi si vedrà se ci interessa fare delle domande agli esperti!”. La facilitatrice cerca di interromperla più volte con la scusa di chiedere chiarimenti, ma Valeria la ferma: “Lei mi chiede mi chiede, ma mi lasci la mia libertà di esporre quello che voglio!”. Due minuti dopo, quando l’addetta ci prova di nuovo, Valeria l’accusa di “non facilitare un bel niente, ma anzi di essere un ostacolo alla comunicazione”. In quel momento, ci si compone in testa il neologismo che descrive quell’infelice ruolo professionale: difficilitatrice. Ostacolare la partecipazione, scongiurare l’emergere di conflitti, indurre gli oppositori a marginalizzarsi da soli: questo il compito dei difficilitatori, parola perfetta proprio perché difficile anche da pronunciare. Il momento si fa meravigliosamente caotico quando la difficilitatrice cerca di trasformare le considerazioni di Valeria in una domanda – “potremmo chiedere se esiste un organo terzo che verifica il rispetto degli impegni in merito a…” –, ma all’improvviso si materializza al tavolo una sua collega dai gradi più alti, reduce di altre impegnative avventure urbane, che si impone e ricomincia a parlare di barriere antirumore. Così viene definitivamente scongiurata l’irruzione della realtà in una discussione fondata su un presupposto immaginario, cioè che “fare le domande” abbia un qualche senso. Valeria si alza e se ne va, sconfitta e irritata per la farsa.
Intorno a noi gli altri nove tavoli: il divide, siedi, et impera. I potenziali oppositori sono messi nell’impossibilità tecnica di diventare massa critica: possono scegliere di costituire un Aventino in un tavolo tutto loro, per essere marginalizzati collettivamente, oppure diluirsi su più tavoli, per essere marginalizzati individualmente. Il report dell’incontro ci informa che tutto è andato secondo i programmi: “Le persone presenti all’incontro sono 147, la discussione si è svolta correttamente ed è stata rispettata la struttura prevista. Tutti i gruppi di discussione hanno condiviso almeno un quesito che è stato sottoposto da un portavoce di ogni gruppo ai tecnici di Autostrade per l’Italia e agli amministratori presenti. […] Nel corso della serata è stato possibile rispondere a tutti i quesiti presentati dai partecipanti”. In conclusione, l’assessora Priolo ringrazia chi ha prestato la propria opera per la riuscita dell’incontro. Sono, dice, venti facilitatori di Avventura Urbana e venti membri dello staff di Autostrade, più “i massimi dirigenti” della società di Benetton e, naturalmente, gli amministratori. Proviamo a fare due conti. Un totale di 45-50 professionisti si è occupato di 147 cittadini: il rapporto è di circa un addetto ogni tre partecipanti. Con grande dispiego di mezzi, la difficilitazione è riuscita. Gli ostacoli alla partecipazione hanno funzionato perfettamente – “è stata rispettata la struttura prevista” – e hanno posto le premesse per futuri Confronti pubblici ancor più intimi.
Successi di questo tipo devono essere premiati. Le revolving doors tra gli esperti “di processi decisionali inclusivi” e le stanze dove si prendono davvero le decisioni sono pronte a girare. Come già nel gennaio scorso, quando Iolanda Romano è stata nominata commissario governativo “per la realizzazione dell’intervento relativo al Terzo Valico dei Giovi”, la Tav Milano-Genova. Da quello scranno, rinnegando il proprio modello – “non si discute solo del come, ma anche del se, dell’opportunità dell’opera”–, Romano promuove confronti pubblici per le compensazioni di un’opera già iniziata. Processi partecipativi a numero chiuso, con meccanismi di iscrizione e verifica quasi polizieschi – “l’iscrizione sarà effettiva solo dopo una conferma telefonica da parte della segreteria”; messe in scena di cui i No Tav denunciano modalità e contenuto. Con una tempistica imbarazzante, poi, l’evento si terrà tre giorni dopo gli arresti di presidente e vice di Cociv, il consorzio incaricato di realizzare l’infrastruttura.
Viaggi e miraggi
Autostrade per l’Italia ha prodotto anche il dossier di partenza del dibattito pubblico, che dovrebbe contenere le informazioni sul progetto utili ai cittadini per discutere nel merito delle diverse scelte. Sono in tutto 44 pagine a colori, più sei appendici di approfondimento: Traffico, Atmosfera, Acustica, Espropri, Cantierizzazione e Opere di adduzione. Sul sito sono poi comparsi – ma solo a dibattito iniziato – ulteriori materiali tecnici, come tavole e planimetrie, rivolti più che altro agli esperti e ai consulenti dei comitati e delle associazioni coinvolte. Il tema più caldo e discusso è quello del traffico e degli inquinamenti che ne derivano, ma farsi un’idea chiara non è per niente facile, e il dossier non aiuta.
Anzitutto, c’è un problema che viene dal passato. L’allargamento in sede dell’A14/Tangenziale fu bocciato nello studio di fattibilità del 2004 (vedi 1ª puntata), con precise motivazioni trasportistiche e sanitarie. Dodici anni dopo è diventato la soluzione ideale per il nodo di Bologna. Va bene “cambiare verso”, va bene “imparare dagli errori”, ma come si spiega un tale ribaltone? Il dossier dovrebbe quantomeno tener conto di quel precedente e far capire ai cittadini perché ieri no e oggi invece sì, fortissimamente sì. Invece snocciola i suoi dati come se niente fosse e il lettore si domanda: perché dovrei fidarmi di questo nuovo studio e buttare alle ortiche il precedente? Delle due, l’una: o nel frattempo è cambiato qualcosa di fondamentale, oppure una delle analisi è clamorosamente toppata. Anzi, potrebbero anche essere sbagliate entrambe: non sarà che queste previsioni del traffico, pur con tutti i loro numeri e formule, sono meno attendibili di un oroscopo? Lo studio del 2004 presentava una proiezione fino al 2011. La crescita della domanda di trasporto era stimata intorno all’1,5 per cento annuo. Oggi sappiamo che nel 2011 il traffico del nodo bolognese è tornato ai livelli dei primi anni duemila. Quindi è questa contrazione il Grande Cambiamento che ha cambiato tutto? Nessuno aveva previsto la crisi economica globale, con la conseguente diminuzione di mezzi sulle strade, così che un progetto sbagliato nel 2004 è diventato giusto nel 2016? A studiarsi le carte, non pare questo il motivo, perché anche il dossier di Autostrade parte dall’incrollabile certezza che il traffico aumenterà, tornando ai livelli registrati prima del 2008, annus horribilis del motore a scoppio e dell’economia italiana. La sfera di cristallo dice +6,7 per cento nel 2025 e +10,1 per cento per il 2035. Il calcolo non si basa sulla Smorfia, bensì sull’andamento demografico Istat e sulle stime del prodotto interno lordo nazionale. Ma basta scrivere “Istat rivede stime pil” su un motore di ricerca, per scoprire che l’istituto di statistica ritocca ogni anno le sue previsioni. Il dato, insomma, non è di quelli scolpiti nel granito.
Non è dunque la fede nel traffico a differenziare i due studi. E allora perché uno ha bocciato il Passante e l’altro invece lo promuove? I tecnici del 2004 scrivevano che “il potenziamento in sede è l’unica ipotesi che produce un incremento [dei chilometri percorsi sulla rete] anche rispetto allo scenario tendenziale”. In sostanza, temevano che l’allargamento dell’A14/Tangenziale avrebbe portato i veicoli a percorrere più chilometri sulle strade di Bologna. Questo dato, espresso in “veicoli per chilometro”, ha uno stretto legame con l’inquinamento, perché più chilometri percorrono auto e camion e più aumentano le emissioni. Oggi, invece, il dossier di Autostrade sostiene che il Passante di Bologna porterà a una grande riduzione delle percorrenze sulla rete (meno 46 milioni di veicoli per chilometro in un anno), dal momento che la viabilità urbana si decongestionerà, non dovendo più sopportare le auto di chi evitava la tangenziale intasata. A prescindere da chi dei due abbia ragione, è interessante notare la differenza nel modo di esprimere i dati. Lo studio del 2004 sostiene che l’allargamento in sede comporterà un aumento del 7 per cento dei “veicoli per chilometro” – cioè delle percorrenze sulle strade – mentre il dossier giura che diminuiranno di 46 milioni in un anno. A parte il fatto che la rete stradale considerata non è la stessa, è significativo che il dossier di Autostrade si giochi il numerone (46 milioni! Urca!) e non fornisca una percentuale (che faccia capire quanto valgono quei milioni rispetto al totale). Per dare un’idea, basta pensare che nelle strade bolognesi studiate nel 2004, i veicoli per chilometro di un giorno medio erano 10.798.653. Quindi il numerone – 46 milioni di veicoli per chilometro in un anno – equivale a quattro giorni di traffico. Quattro giorni in un anno, equivale a una riduzione dell’1,1 per cento. Non va molto meglio per l’altro numerone proposto dal dossier, due milioni di ore di viaggio risparmiate ogni anno. “Ridiamo tempo di vita ai cittadini!”, hanno titolato i giornali citando il sindaco. Però, aspetta: quei due milioni di ore saranno risparmiati in un anno da tutti i veicoli che battono il nastro A14/Tangenziale, considerati insieme appassionatamente. E quanti saranno questi veicoli? Il dossier prevede che i mezzi, sul Passante di Bologna, arriveranno a 180mila al giorno nel 2025, cioè 65,7 milioni in un anno. Dividiamo il numerone, due milioni di ore, per tutte queste auto, camion e vetture ed ecco che la montagna partorisce un topolino: un minuto e quarantotto secondi di risparmio medio per ogni veicolo.
Da questi dati sul traffico – poco affidabili, discordi tra loro e presentati in maniera oscura – discende la maggior parte delle considerazioni sullo smog, il rumore e la salute dei cittadini, delle quali ci occuperemo nella prossima puntata. Qui vogliamo solo ricordare che lo studio di fattibilità del 2004 aveva bocciato il potenziamento in sede perché avrebbe prodotto “in particolare per alcuni inquinanti, quantità di emissioni superiori”. Ovvero: +11,4 per cento di ossidi di azoto e +4,6 per cento di anidride carbonica. Inoltre, avrebbe comportato “circa il 20 per cento in più di popolazione esposta a valori di rumore superiori ai 55dB(A)”. Per Autostrade, invece, il Passante di Bologna sarà tutta salute. Ma i suoi vantaggi non finiscono qui.
L’ultima occasione
“Con questo accordo”, ha dichiarato Irene Priolo, “abbiamo portato a casa mitigazioni ambientali e opere stradali che i cittadini aspettano da 30 anni”. Opere architettoniche, paesaggistiche e di ricucitura urbana che sono il fiore all’occhiello di tutto il progetto, ma che erano in gran parte previste dal piano strutturale comunale per la “città della tangenziale”. Opere dovute che si trasformano in “gentili omaggi”. Una metamorfosi molto diffusa, nel sistema delle grandi opere. Tra le “compensazioni” si inseriscono anche lavori che erano già in programma, necessari per il territorio. In questo modo l’opera diventa l’Occasione unica e imperdibile per esaudire quelle antiche promesse, e chi la ostacola è un mestatore che vuol privare tutti di un bel regalo. Infine, l’ultimo vantaggio del Passante di Bologna propinato alla cittadinanza è il minore consumo di suolo rispetto al Passante nord. Dato innegabile, ma relativo. Rispetto a una bastonata in testa, meglio un ceffone. E se dopo il ceffone ti offrono cinque cioccolatini? Il male passa più in fretta, no? Con una logica simile, il sito del Confronto pubblico proclama che le “aree a verde” previste dal progetto saranno “superiori a cinque volte l’occupazione di nuovo suolo”. Detto così, uno si immagina che a ogni ettaro di terreno asfaltato ne corrisponderanno cinque di nuovi parchi, giardini e fasce boscate. Invece, studiando meglio le carte, si scopre che tra queste “aree a verde” sono calcolati anche parchi già esistenti, dove si pianterà qualche nuovo albero, e pure le “aree intercluse”, cioè gli spazi completamente circondati da uno svincolo. Di nuovo, invece di favorire il dibattito, sembra che i suoi promotori siano più interessati a confezionare slogan accattivanti e numeri da ufficio stampa.
Dodici anni fa, quando il comitato per l’Alternativa propose il potenziamento in sede dell’A14/Tangenziale, sembrava si trattasse di un intervento a “impatto zero”, senza consumo di suolo. Lo studio di fattibilità degli enti locali dichiarò quel risultato impossibile da raggiungere, evidenziando la necessità di espropriare 54 ettari di terreno. Oggi Autostrade sostiene di potercela fare con 20 ettari, più altri 20 “temporanei” e la demolizione di quattro fabbricati residenziali, due rurali, due magazzini artigianali e un deposito. L’equivalente di 31 campi da calcio finirà sotto asfalto e guardrail, mentre altri 31 saranno occupati temporaneamente, e chissà come saranno ridotti dopo. In Italia, più del 5o per cento del territorio cementificato è coperto da infrastrutture di trasporto. Edifici e capannoni si “limitano” al 30 per cento. Forse in un futuro radioso si potranno allargare le strade senza mangiare terreno, e le auto emetteranno effluvi di ragù, ma per il momento non sembra possibile conciliare il motto “meno consumo di suolo” con il ritornello “servono più infrastrutture”.
Nell’ultima puntata della nostra inchiesta metteremo le scarpe nel fango, lungo i margini della tangenziale, per confrontare le promesse da confronto pubblico, con quel che davvero si vede, si tocca e si respira oltre i guardrail e le barriere antirumore.
New York Times, 9 dicembre 2016
SINTESI
Nell’attesa di vedere come Trump, una volta insediato alla Casa Bianca, darà il via al suo feroce, inaccettabile, ma anche miope, programma di deportazione di massa di 3 milioni di immigrati ‘illegali’, lo Stato della California si sta già attrezzando per rafforzare la sua legislazione a difesa della popolazione di origine ispanica. Nelle scorsa settimana il parlamento, in una sessione congiunta dei suoi due rami - State Assembly e State Senate -, ha approvato immediatamente alcuni disegni di legge molto coerenti con l'obiettivo e molto conflittuali nei confronti dei programmi annunciati in campagna elettorale dal nuovo Presidente degli USA.
Sono tre gli obiettivi e le aree di intervento: garantire sostegno legale agli immigrati che si oppongano alla deportazione; finanziare con risorse aggiuntive l'efficienza dei servizi legali offerti agli immigrati dallo Stato della California; finanziare un programma di aggiornamento degli avvocati d’ufficio.Appellandosi al Primo Emendamento della Costituzione (che garantisce al cittadino la possibilità di appellarsi per correggere i torti) e al Quarto Emendamento (che tutela tutti i cittadini da perquisizioni, confische irragionevoli e arresti), lo Stato della California, nel quale il 40% della popolazione è costituito da latinos, si prepara a una lunga battaglia a difesa dei diritti civili e della giustizia sociale. Ecco perché la Costituzione serve! Editoriale del New York Times, 9 dicembre 2016 (m.c.g.)
CALIFORNIA LOOKS TO LEAD
THE TRUMP RESISTANCE
Nobody knows yet what Donald Trump is going to do to immigration enforcement. Only a month has passed since the election, and the president-elect is no different from the candidate: erratic, self-contradictory, hazy on principles and policies.
But states and cities that value immigrants, including the undocumented, do not have the luxury of waiting and hoping for the best. They are girding for a confrontation, building defenses to protect families and workers from the next administration.
They fear that Mr. Trump, who ran on a pledge of mass deportation, dehumanizing immigrants and refugees, will remove humane discretion from immigration enforcement. They understand that not all unauthorized immigrants are criminals, that not all should be detained or deported and that the country cannot enforce its way out of its failure to reform unjust immigration laws.
But they know that the nativist ideologues and white nationalists around Mr. Trump are itching for him to be merciless. They know that if he does anything close to what he has repeatedly vowed to do — set dragnets for millions of unauthorized immigrants, triple the number of enforcement officers, immediately revoke President Obama’s administrative actions shielding young people from deportation and pull federal funds from cities that defend immigrants — their prudence will have been justified.
Mr. Trump has reportedly chosen a retired Marine general, John Kelly, to run the Department of Homeland Security. He seems to fit the Trump pattern of seeing immigrants not as a resource to be tapped, but as a threat to be neutralized, beginning at the border. General Kelly, who led the United States Southern Command, warned Congress last year of the danger of terrorists and “weapons of mass destruction” coming in from Mexico. He admitted he had no evidence, but was clanging the alarm all the same.
In immigrant-rich communities across America, there are more legitimate fears for the immigrants. Bills introduced this week in the California State Legislature confront them directly. One would create a program to finance legal services for immigrants fighting deportation. Another would provide training and advice on immigration law to public defenders’ offices. Come the purge — and Mr. Trump has said he is going after two million to three million people immediately — many will need lawyers.
The third bill, potentially the most consequential, seeks to ensure that California will never be an accomplice to mass deportation. Its sponsor, Kevin de León, the California Senate president pro tempore, calls it the California Values Act, befitting a state that is nearly 40 percent Latino, and where one in four residents is foreign-born. It would bar state or local resources from being used for immigration enforcement, a strictly federal duty. No state or local law enforcement agency would be allowed to detain or transfer anyone for deportation without a judicial warrant.
Nothing in the bill would obstruct the federal government. This is not a nullification of federal laws or a rebellion against the Constitution. It’s upholding the Fourth Amendment, preventing unreasonable search and seizure, so mothers and fathers can go to work and children go to school without fear of losing one another. It's upholding the First Amendment, so day laborers can solicit work on a sidewalk. It's allowing the local police to keep the trust and cooperation of crime victims and witnesses, who will not fear avery ecounter as a prelude of deportation.
“Nobody wants bad people in our communities or neighborhoods or in our streets,” Mr. de León said, particularly the local and state police. “They’ll always go after the rapist, the violent criminal drug dealer; we’ve made that abundantly clear.”
Expect Mr. Trump and his immigration brain trust, led by the Senate hard-liner Jeff Sessions and ideologues like Kris Kobach, the secretary of state of Kansas, to denounce all such efforts as providing sanctuary to dangerous criminals.
But the opposite is true: By drawing a bright line between federal immigration enforcement and local policing, the California Values Act would promote smarter, more effective law enforcement. Local officers would continue to keep the peace, and in the face of criminal threats — as validated by a warrant from a judge — would cooperate with federal agents. But if the Trump administration begins roundups of those who pose no danger, of minor offenders and noncriminals, staking out schools, churches, businesses and homes — they will not do its job for it.
“We’re not looking for a fight with the president-elect and his administration,” said Mr. de León. “We’re guided by the principles of justice and dignity for all people.”

Nella Roma dei palazzinari divenuti famelici pescicani, delle nuvole di sprechi pubblici per affari privati, dell'abbandono della manutenzione del verde e del trionfo dell'affare immobiliare sulla tutela chiunque, con un po' di potere minaccia di voler cambiare strada, e magari comincia a farlo, è da abbattere. I mass media ne saranno l'utile strumento.Un appello di un manipolo di associazioni. salviamoilpaesaggio.roma, 10 dicembre 2016
SSOLIDARIETÀ ALL'ASSESSORE
SOTTO ATTACCO MEDIATICO
Comitati, Associazioni, Reti, Movimenti, Forum e cittadini qui sottoscritti sono convinti che se lo stadio di James Pallotta si deve costruire, questo debba essere fatto nel rispetto della legalità, senza accessori in contrasto col Piano Regolatore di Roma, in un’area libera da vincoli, sicura dal punto di vista idrogeologico e, soprattutto, con modalità rispondenti al pubblico interesse.
Crediamo fermamente che la mano pubblica debba riappropriarsi della Città, marcando con forza la discontinuità con le giunte precedenti attraverso una moratoria sul consumo di suolo, come ormai sostenuto da un’amplissima componente della popolazione, da movimenti ambientalisti, dal mondo scientifico e della cultura.
Ricordiamo che l’assessore Berdini ha promosso, sostenuto e redatto rigorose leggi contro il consumo di suolo insieme ai movimenti e come, in questi decenni, abbia sempre lavorato per un’urbanistica al servizio degli abitanti delle città, non solo di Roma, “(…) conducendo battaglie contro la cementificazione e a favore della rigenerazione urbana, con un occhio particolarmente attento ai destini delle periferie cittadine e caldeggiando piccoli ma significativi interventi in serie piuttosto che opere inutilmente sfarzose.” *
Per quanto riguarda i Media, auspichiamo un deciso cambio di rotta circa il modo di servire al pubblico notizie che si basano più sull’emozione dei lettori che sulla veridicità dei fatti creando vere e proprie post-verità (termine coniato dalla Oxford University che ben si addice a quanto propinato da decine di testate).
All’assessore Berdini va quindi il nostro massimo sostegno, consapevoli di come stia lavorando senza sosta per la Giunta e per i cittadini, per dare a Roma quello che in trent’anni non si è riuscito a realizzare e per ripristinare quanto è stato compromesso.
Una città più a misura di persona, dalla periferia al centro.
Salviamo il Paesaggio Roma e Lazio
Coordinamento Agro Romano Bene Comune
Comitato No Corridoio Roma Latina
Salviamo Tor di Valle dal Cemento
Dolce Spiaggia
Comitato FuoriPista
Italia Nostra Litorale Romano
Respiro Verde Legalberi
Emergenza Cultura
Stop I-60
Comitato Pisana Estensi
Gruppo Territorio e Ambiente ( GTA) IX° Municipio
Salute Ambiente Eur
Ciampino Bene Comune
Comitato Piccolomini
Italia Nostra Castelli Romani
Difendiamo Tor di Valle
C.A.L.M.A. Coord. Ass.ni del Lazio per una Mobilità Alternativa
Brigate Verdi
Comitato Roma12 per i Beni Comuni
Comitato Aspettare Stanca
Cooperativa Agricola Coraggio
Paolo Maddalena
Vittorio Emiliani
Vezio De Lucia
Tomaso Montanari
Rosanna Oliva
Fulco Pratesi
 «La città catalana rilancia la scommessa su un modello di urbanistica partecipata, definendo macro-isolati a vocazione prevalentemente pedonale». ilgiornaledell'Architettura, 4 dicembre 2016 (m.c.g.)
«La città catalana rilancia la scommessa su un modello di urbanistica partecipata, definendo macro-isolati a vocazione prevalentemente pedonale». ilgiornaledell'Architettura, 4 dicembre 2016 (m.c.g.)
BARCELLONA. Se c’è una cosa che non manca alla città catalana, è la capacità di mettersi in gioco. La Giunta guidata dalla sindaca Ada Colau mantiene le promesse lanciate in campagna elettorale: “Urbanistica a vocazione sociale”, uno degli slogan del programma del partito Barcelona en Comú, si traduce nella ferma decisione d’investire in attenzione concreta ai residenti, soprattutto nei quartieri meno agiati, ed abbandonare le opere faraoniche od il primato dell’investitore privato e del turista come referente del business cittadino.
Tra le “ossessioni” dell’attuale sindaco, oltre alle pari opportunità per gli abitanti e le case popolari, c’è quella di limitare la presenza del traffico su gomma, che al momento occupa il 60% dello spazio pubblico, e ridurre così del 30% le emissioni di anidride carbonica. Così, il Comune ha deciso di prendere in mano un progetto promosso da amministrazioni precedenti e riguardante niente meno che il ripensamento dell’idea di città, con il pedone come protagonista.
L’idea dei macro-isolati non è nuova a Barcellona: il primo fu istituito nel 1993 vicino alla Chiesa di Santa Maria del Mar, nel quartiere del Born, a cui seguirono altri due a Gràcia nel 2005; ma il primo progetto risale al 1987 ed è ascrivibile a Salvador Rueda, attuale direttore dell’Agenzia di ecologia urbana della città. La sindaca Colau ne ha fatto una priorità, ha stanziato 10 milioni e la prima Superilla è già stata inauguarata nel quartiere Poblenou.
Secondo la definizione che ne dà il Comune, il Programma Superilles “Riempiamo di vita le strade” (2016) è un progetto di città rivolto al miglioramento della vita delle persone. Tutto ruota intorno alla messa a punto di un modulo in grado di configurare nuovi spazi di convivenza, secondo un modello organizzativo del tessuto urbano pensato in primis per i residenti. Un’opportunità per favorire la mobilità sostenibile, la produttività, il verde e la biodiversità, così come gli spazi di sosta per il pedone. L’idea consiste nel definire il perimetro d’un insieme d’isolati che deve assorbire la maggior parte del traffico privato e pubblico, mentre l’interno viene destinato ad uso esclusivo di residenti, pedoni e biciclette.
In pratica, l’attuale Superilla è un modo differente di distribuire la mobilità, studiato ad hoc per la trama urbana definita nell’Ottocento da Ildefonso Cerdà: in un ambito formato da nove isolati, il traffico veicolare viene deviato in modo da evitare il transito all’interno della zona vedendosi obbligato a tornare verso le strade perimetrali del macro-isolato. Al suo interno le auto circolano a 10 km all’ora su un’unica corsia, con l’obiettivo di ridurne al minimo i passaggi. Vengono eliminati i parcheggi negli incroci e così si liberano circa 2.000 mq che restano ad uso praticamente esclusivo dei pedoni. Anche le strade interne alle Superilles si trasformano in luoghi più accessibili al pedone, oltre che meno rumorosi, più verdi e gradevoli, in linea con la vocazione della città mediterranea.
Josep Maria Montaner, regidor del distretto di Sant Martì [a Barcellona ciascuno dei dieci quartieri in cui è suddivisa la città ha una sorta di “sottosindaco” che fa a sua volta riferimento alla sindaca Colau; nda], dove a settembre è stata inaugurata la prima Superilla, è tra i ferventi sostenitori del progetto: l’obiettivo è coinvolgere il 58% delle strade e aumentare di 380 ettari gli spazi verdi del quartiere. Secondo Montaner, il macro-isolato del Poblenou è da intendersi come un esperimento, come banco di prova per verificarne il funzionamento ed eventuali criticità, con un investimento tutto sommato modesto (55.000 euro).
La consigliera per l’urbanistica della Municipalità, Janet Sanz, ha affermato in diverse occasioni che questi cambiamenti saranno realizzati gradualmente mediante azioni di tipo reversibile, con l’imprescindibile partecipazione dei residenti, secondo un’idea di “democrazia aperta” imprescindibile per questa giunta: l’uso dei nuovi spazi deve essere deciso in collaborazione con i residenti, attraverso diverse modalità di confronto.
Coraggiosa e trasparente, da parte del Comune, è la scelta di rendere noti, in un documento pubblicato lo scorso ottobre, i risultati delle considerazioni espresse dai vari collettivi coinvolti nella consultazione popolare in seguito all’inaugurazione della Superilla del Poblenou. Decine di proposte e critiche raccolte in occasione della giornata aperta di valutazione del progetto, dei dibattiti cittadini tenutosi sul posto, delle riunioni dell’Amministrazione con enti, imprese, scuole con sede nel quartiere, oltre a quelle raccolte in un’apposita cassetta.
Anche circa 200 studenti delle Scuole di Architettura cittadine sono stati coinvolti per redigere proposte. I dati raccolti sono ora al vaglio dell’Amministrazione, che è disposta a modificare il modello iniziale laddove risultasse meno soddisfacente del previsto ma che assicura che questa Superilla è solo la prima di una lunga serie.
 «Lombardia e Sassonia a confronto dove a differenza della Lombardia sono state introdotte non solo misure quantitative per la limitazione del consumo di suolo, ma sono stati indicati degli indirizzi programmatici, volti alla pianificazione di territori resilienti adatti a fronteggiare, gli impatti di un clima sempre più in mutamento». ArcipelagoMilano n.40, 6 dicembre (m.c.g.)
«Lombardia e Sassonia a confronto dove a differenza della Lombardia sono state introdotte non solo misure quantitative per la limitazione del consumo di suolo, ma sono stati indicati degli indirizzi programmatici, volti alla pianificazione di territori resilienti adatti a fronteggiare, gli impatti di un clima sempre più in mutamento». ArcipelagoMilano n.40, 6 dicembre (m.c.g.)
Nel dibattito lombardo (e italiano) il tema del consumo di suolo è spesso ridotto a un asettico confronto di percentuali di superficie urbanizzata e di metri quadrati di nuove costruzioni. Numeri che fanno riferimento a banche dati e metodi di rilevamento diversi e che quindi generano problemi non solo di comparazione ma anche di comprensione del fenomeno. Cosa produce “consumo di suolo”? Solo le case e le strade oppure anche le aree verdi attrezzate, oppure le strade sovracomunali sono escluse perché sono da considerare servizi pubblici? E se in Italia il suolo urbanizzato è pari al 7% (circa) del territorio, è così reale il rischio di cementificazione? Queste le domande un po’ fuorvianti ma più comuni.
Se ridotto a numeri e percentuali astratte si rischia di non comprendere in pieno questo tema, per il quale è necessario una prospettiva differente, che lo riconduca all’interno dei confini di un dibattito sull’uso del suolo inteso come risposta spaziale a strategie di sviluppo economico e sociale.
Neppure Regione Lombardia, con la sua legge 31/2014, Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato (che proprio in questi giorni compie due anni) è riuscita ad andare oltre a un approccio quasi esclusivamente quantitativo. Infatti, se il processo di determinazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo – dalla scala regionale a quella (ex)provinciale, fino a quella comunale – è iniziato, seppure in ritardo, con la revisione del Piano Territoriale Regionale, nulla è stato fatto per quelle misure che dovevano promuovere azioni di rigenerazione e che, nel testo normativo, venivano demandate a successivi atti mai emanati.
Per vedere un approccio alternativo però basta fare poca strada. La Germania è stata tra i primi Paesi ad affrontare il tema del consumo di suolo già dagli anni Ottanta e poi, con un ministero all’ambiente guidato da Angela Merkel, nel 1998, ha elaborato per la prima volta un obiettivo quantitativo di riduzione dell’occupazione di suolo a fini urbani (la soglia fu fissata a 30 ettari al giorno, pari a un quarto della tendenza in atto nel 2000) integrato poi, nei diversi Länder, con misure di compensazione ambientale, politiche fiscali incentivanti per il recupero e strumenti tecnici ed economici mirati a facilitare le bonifiche delle aree dismesse e la loro riqualificazione.
In particolare, la Sassonia, dopo la pesante inondazione che ha colpito molti quartieri di Dresda nel 2002, ha adottato un modello mirato alla “compensazione biologica” secondo il quale ad ogni intervento di impermeabilizzazione deve corrisponderne uno di de-impermeabilizzazione di pari superficie. La città di Dresda, in particolare, ha poi adottato un “Piano di adattamento ai cambiamenti climatici” che prevede, da un lato, un piano di azioni per la regimazione capillare delle acque superficiali, introducendo zone tampone così da ridurre la velocità di scorrimento delle acque in ambito urbano, e, dall’altro, l’obbligo, per chi vuole costruire, di rendere nuovamente permeabile un’area dismessa.
Il sistema di Dresda è interessante non solo dal punto di vista strettamente ambientale ma perché, nel solco della tradizione urbanistica tedesca, ha come obiettivo anche l’equità e per farlo agisce sulla rendita fondiaria. Il Piano, infatti, contiene una lista delle aree da de-impermeabilizzare, e la scelta dipende non solo dalla loro superficie ma anche dal valore del terreno da edificare: se si costruisce in aree di pregio (e quindi si realizzeranno immobili di valore economico elevato) l’area da recuperare dovrà essere più ampia. Ultimo dettaglio interessante: questo obbligo non è derogabile né monetizzabile.
Torniamo in Lombardia, regione peraltro caratterizzata da un’elevata vulnerabilità idrogeologica anche a causa di processi di urbanizzazione e di conurbazione che hanno generato, nel corso del tempo, ingente consumo di suolo e impermeabilizzazione delle superfici drenanti. Qui, se alcune norme recenti introducono principi condivisibili e innovativi (non solo riduzione del consumo di suolo ma anche invarianza idraulica e drenaggio urbano sostenibile con la L.R. 4/2016 e azioni di adattamento e di mitigazione con la 2”Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici” del 2014), non si può non rilevare l’assenza di una visione complessiva e unitaria sui temi territoriali.
Sembra che la debolezza politica dell’attuale maggioranza di centrodestra si traduca in una vaga e indefinita promessa di revisione della L.R. 12/2005 e nell’adozione di diverse norme che, in modo frammentario e quindi incoerente, introducono nuovi adempimenti in capo agli oltre 1500 Comuni lombardi senza però indicare indirizzi programmatici, di scala vasta, sulle reti ambientali, sulle reti infrastrutturali e sui sistemi insediativi, volti alla pianificazione di territori resilienti adatti a fronteggiare, nell’ottica della sostenibilità, gli impatti di un clima sempre più in mutamento.
«La fede nel buon governo locale, erede della leggendaria pianificazione riformista degli anni sessanta, si è trasformata nel culto di Asfalto, Mattone, Tondino e Cemento». Internazionale online, 7 dicembre 2016 (p.d.)
wumingfoundation.com, 3 dicembre 2016
IL «PASSANTE DI #BOLOGNA»:
UNA DISAVVENTURA URBANA
di Wu Ming e Wolf Bukowski
Da alcuni mesi facciamo inchiesta su una grande opera inutile e imposta: il cosiddetto «Passante di Bologna». Il caso è molto interessante e ha rilevanza nazionale, per diversi motivi.
Le ipotesi per risolvere i problemi di traffico del nodo bolognese si rincorrono ormai da vent’anni. Nel 2005 ha iniziato a consolidarsi quella del cosiddetto «Passante Nord», una bretella autostradale che doveva tagliare la campagna a Nord della città, collegando Anzola Emilia (A1), Altedo (svincolo A13) e San Lazzaro (Uscita A14). Quel progetto, già finanziato, è stato respinto l’anno scorso, grazie all’azione di un comitato e dei sindaci dei comuni interessati. Ma il comitato ha scelto di «non dire soltanto no» e ha proposto una “brillante” alternativa: l’allargamento di una corsia per senso di marcia dell’infrastruttura congiunta autostrada/tangenziale, che già ammorba la periferia bolognese. E così, un comitato che all’inizio contestava la ratio stessa del progetto, ha finito per scaricare il barile sui cittadini di un altro territorio.
Il comune di Bologna ha approvato e sottoscritto il nuovo progetto a fine luglio. Dai primi di settembre è partita una fase di consultazione dei cittadini, che si è conclusa a metà ottobre dopo aver messo in mostra tutte le più bieche strategie per svuotare di senso un percorso partecipativo, a partire dall’esclusione a priori dell’«opzione zero». Ovvero: la cittadinanza è stata chiamata a esprimersi su una decisione già presa.
Abbiamo partecipato ad alcuni degli incontri, abbiamo preso appunti e nelle settimane seguenti abbiamo approfondito, fino a farci un’idea molto precisa delle tattiche di evaporazione del conflitto, del ruolo dei «facilitatori» e delle loro agenzie, dello svuotamento di ogni pratica partecipativa.
La finta partecipazione, ovviamente, è soltanto uno dei problemi. Il progetto è un luna park di interventi compensativi implausibili, parchi in luoghi improbabili, piste ciclabili fantasma, sottopassaggi spacciati per «le nuove porte della città». Ma l’irrazionalità di questo progetto, che peggiorerà la vita dei cittadini e gioverà solo ad Autostrade e alle lobby dell’edilizia e dell’asfalto, non si può comprendere appieno senza il racconto di come ci si è arrivati. Sullo sfondo – o meglio: a far da cornice al tutto – la fine della programmazione territoriale «all’emiliana», l’amore cieco del Pci/Pds/Ds/Pd per il cemento, i precedenti di altre opere inutili in salsa bolognese (abortite, in costruzione o già realizzate per poi essere sconfessate): Civis, People Mover, Centro Agro Alimentare, FiCO, Stazione AV…
Abbiamo proposto a Internazionale un’inchiesta in tre puntate. La prima è da poco on line, illustrata dalle foto di Michele Lapini. Buona lettura.
Eddyburg pubblicherà le successive puntate appena saranno rese disponibili.
Internazionale, 3 dicembre 2016
IL PASSANTE DI BOLOGNA:
UNA DISAVVENTURA URBANA
di Wu Ming e Wolf Bukowski
1a puntata
Al centro dell’inquadratura campeggia uno svincolo autostradale, di quelli che in gergo si chiamano a quadrifoglio completo. Tutt’intorno, a volo d’uccello, si stendono boschi, prati, un fiume e un’anonima cittadina, resa ancor più irriconoscibile dall’effetto di sfocatura ai margini dell’immagine. Il paesaggio è un’esplosione di verde, per lo più abeti, appena interrotti da larici e faggi in veste autunnale. Sopra uno spicchio di foresta, si staglia un simbolo bianco. Archi di circonferenza che ricordano onde radio, come nel logo del wi-fi, ma potrebbe anche essere un orecchio stilizzato, o la curva di una strada a quattro corsie. Subito accanto, una scritta in corsivo recita: “Confronto pubblico”. E una riga sotto, in grassetto, “Passante di Bologna”.
Già alla prima occhiata, avvertiamo che qualcosa non torna, come di fronte a un quadro di Magritte. Chi mai le ha viste, tante conifere, nella campagna intorno alle due torri? Stregati dall’enigma, perlustriamo la rete in cerca di autostrade, foreste, svincoli, alberi e verde. Traduciamo le parole chiave in inglese, francese, tedesco. Passiamo al setaccio i risultati e una fotografia s’impone sulle altre. Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald. La prospettiva non è la stessa, ma molti elementi corrispondono. Troviamo altre immagini, mappe digitali, e un laghetto artificiale perfettamente rotondo ci conferma che abbiamo fatto centro. Lo scatto ritrae la foresta dell’Alto Palatinato, in corrispondenza dell’incrocio tra due autostrade, la A6 e la A93. Il paese sullo sfondo non è Casalecchio di Reno e nemmeno San Lazzaro di Savena, bensì Wernberg, Baviera.
Inquieti, ci domandiamo per quale motivo il sito ufficiale per il confronto pubblico sul Passante di Bologna sia illustrato con l’immagine di uno svincolo tedesco. Considerando che per quattordici anni si è favoleggiato di aggirare Bologna con una nuova autostrada, e si è discusso di quanto a nord costruirla rispetto alla città, si potrebbe pensare che il “confronto pubblico” riguardi la proposta di farle attraversare l’Alto Palatinato, ma la regione tedesca sembra davvero troppo a nord. E poi quell’autostrada – il cosiddetto Passante nord – appartiene ormai al passato. Il 22 luglio scorso Virginio Merola, sindaco metropolitano da poco rieletto, ha presentato un progetto alternativo. Non più colate di cemento sulla campagna bolognese! Non più consumo di suolo! Ecco a voi il “potenziamento in sede del sistema autostradale e tangenziale”. Battezzato con il nome di Passante di Bologna, altrimenti detto Passante di mezzo. Ovvero l’aggiunta di quattro corsie alla mezzaluna d’asfalto che da cinquant’anni taglia la periferia della città. Il borgomastro, nel suo discorso, ha speso parole suggestive: “rigenerazione urbana”, “svincoli [che diventano] nuove porte della città”, “ridare ai nostri cittadini tempo di vita”, “cantieri [che] hanno bisogno di un’anima”, “dimostrare al resto del Paese che può contare su Bologna”. Ma soprattutto, ha magnificato “uno strumento di democrazia che affrontiamo per la prima volta”: il confronto pubblico.
Stregati da una simile occasione, ci siamo subito diretti alla piazza virtuale del dibattito, il sito passantedibologna.it, dove trovare tutti gli strumenti per “costruire insieme, nella massima trasparenza, la migliore soluzione per la città”. Ci siamo imbattuti così, per la prima volta, nell’immagine sfocata e traditora dell’Autobahnkreuz Operpfälzer Wald. Quattro mesi più tardi, osservandola con più attenzione, ci rendiamo conto che quell’istantanea della foresta palatina, con le due scritte bianche che l’attraversano, non racchiude una sola bugia, ma addirittura tre, nella nobile tradizione di Simon Pietro. Anzitutto, mente dal punto di vista descrittivo, perché quello non è il Passante di Bologna. Poi mente in senso evocativo, perché le parole “confronto pubblico” suggeriscono una realtà molto lontana dai dodici incontri che sono stati promossi in città. Infine mente anche sul piano metaforico, perché nessun passante, snodo o svincolo “di Bologna” potrà mai essere verde e boscoso come quell’incrocio di autostrade tedesche.
Smascherare queste tre bugie è l’obiettivo della nostra indagine: nella prima puntata, cercheremo di illustrare cos’è davvero il Passante di Bologna; nella seconda, racconteremo gli incontri del “confronto pubblico”, ai quali abbiamo partecipato, “per vedere di nascosto l’effetto che fa”; nella terza, osserveremo in che modo il progetto di allargamento di autostrada e tangenziale sia stato verniciato di un verde che non è verde, finto come un bosco d’abeti nel bel mezzo della pianura padana. Sono tre piccole storie locali, eppure siamo convinti che sia utile conoscerle anche fuori dei confini della città, e non solo perché il nodo autostradale di Bologna è uno dei più nevralgici della penisola.
L’Emilia-Romagna, negli ultimi vent’anni, ha ispirato molti cautionary tales, racconti ammonitori su cosa succede al territorio quando i cittadini non si preoccupano delle sue trasformazioni. L’alta velocità Bologna-Firenze, la variante di valico, il viadotto modenese della linea alta velocità Bologna-Milano, sono esempi ormai noti in tutt’Italia tra coloro che si battono per la tutela del paesaggio. Lo stesso può dirsi per alcuni disastri urbanistici, come il cantiere dell’ex mercato Ortofrutticolo di Bologna o la cementificazione selvaggia e ‘ndranghetista nelle province di Parma e Reggio Emilia. La fede nel buon governo locale, erede della leggendaria pianificazione riformista degli anni sessanta, si è trasformata nel culto di Asfalto, Mattone, Tondino e Cemento. Autostrade, megastazioni e ferrovie veloci sono sempre benedette dal clero laico degli amministratori e accettate senza tanti disturbi dalla maggioranza del popolo.
Proprio il Passante nord sembrerebbe la prima, grande infrazione della liturgia. L’opera è stata contestata dai cittadini e poi respinta dopo tredici anni di manifestazioni e migliaia di firme. Solo che non si è trattato di una bocciatura. L’infrastruttura è stata respinta più in là, dalla campagna bolognese alla periferia cittadina, e con essa si sono trasferiti anche il danno e la beffa, scaricati soprattutto sui residenti di cinque quartieri. Non una vittoria degli eretici, quindi, ma sostanza per un nuovo racconto ammonitore, che aiuti a non ripetere altrove gli errori fatti da queste parti. In fondo, come disse il poeta Miguel Torga, l’universale è il locale senza i muri.
Col trattore in tangenziale
Martedì 11 luglio 1967, a pagina 4 di l’Unità, un articolo firmato da Luciano Vandelli celebrava “l’ultima domenica d’estate in cui Bologna ha dovuto filtrare attraverso i suoi congestionati itinerari cittadini le diaspore motorizzate che convogliano fiumi di automobili verso la riviera adriatica”. Alle 22 del giorno successivo sarebbe entrata in funzione la tangenziale, “un raccordo ancora unico nel suo genere in Italia”, con la caratteristica di “affiancare ai percorsi autostradali del traffico di transito, due nastri complanari, che collegano la viabilità ordinaria”. L’autore del pezzo non mancava di lodare “la felicissima intuizione che più di dieci anni fa fece vincolare dal sindaco Dozza una fascia di centodieci metri di larghezza, lungo quello che oggi è il tracciato della tangenziale nord”.
La lungimiranza di Dozza in quell’occasione è ormai un attributo del suo santino ma, per comprenderla davvero, bisogna aggiungere almeno due dettagli. Primo, che la tangenziale complanare fu il risultato di un baratto. In cambio di quella, la società Autostrade (allora di proprietà statale) ottenne di costruire l’A14 a tre chilometri da piazza Maggiore, a ridosso della prima periferia, con il vantaggio di un tragitto più breve.
Secondo, che solo quattro anni prima, nel 1963, il vecchio sindaco partigiano aveva celebrato il funerale dell’ultimo tram. Sotto la sua guida, Bologna smantellò 16 linee su rotaia, una rete capillare, elettrica e sostenibile di 75 chilometri e 155 mezzi. La sua previdenza non si spingeva oltre i confini di una certa idea di progresso, secondo la quale il futuro doveva battere al ritmo del motore a scoppio. Da allora, il capoluogo emiliano non ha mai brillato per le idee innovative sulla mobilità, se si esclude una minuscola isola pedonale, in anticipo sui tempi italiani (1968), e la breve stagione degli autobus gratuiti nelle ore di punta (1973-76).
Oggi la città è famosa per il Civis, un filobus a guida ottica, acquistato, mai usato e infine ripudiato perché insicuro, dopo anni di lavori per adattare le strade al suo passaggio. Nel 2013, mentre i 49 esemplari del superfilobus marcivano in un parcheggio di periferia, veniva inaugurata la stazione bolognese dell’alta velocità, progetto vincitore di un concorso internazionale bandito da Rete Ferroviaria Italiana. Tre anni dopo, la stessa Rfi considera l’enorme astronave sotterranea “un esempio critico”, perché “a fronte di grandissimi spazi necessari, la frequentazione dei passeggeri è molto bassa”. Per non parlare del People mover, la navetta per l’aeroporto, tutta su monorotaia soprelevata nuova di zecca, quando un collegamento analogo si poteva ottenere aggiungendo pochi binari alle linee ferroviarie già esistenti. Prima ancora dell’inaugurazione dei cantieri, il People mover si è guadagnato le prime pagine dei giornali con un processo per turbativa d’asta e abuso d’ufficio nell’appalto al Consorzio Cooperative Costruzioni, mentre due mesi dopo l’inizio dei lavori la procura ha aperto un altro fascicolo per favoreggiamento e abuso d’ufficio. Ma Civis, Astro-stazione e People mover non erano ancora all’orizzonte quando cominciò a farsi strada l’idea di un ritocco alla tangenziale.
Nell’autunno del 1985, Italia Nostra promosse il convegno nazionale “La strada sbagliata. Nuova politica dei trasporti”. L’iniziativa coinvolgeva tre sindaci “dissidenti” e due eroi della pianificazione riformista, Giuseppe Campos Venuti e Pierluigi Cervellati. Nell’affollato cinema di Sasso Marconi, gli intervenuti contestavano la regione Emilia-Romagna per aver approvato il “progetto irragionevole” di un raddoppio appenninico dell’Autosole, quello che allora si chiamava “camionabile” e che oggi conosciamo come variante di valico. Le accuse rivolte ai sostenitori della nuova autostrada erano principalmente due. Quella di insistere su un modello di mobilità basato sulla gomma e quella di voler ottenere, in cambio del via libera alla camionabile, “il raddoppio della tangenziale bolognese”. Anche la loro preveggenza andrebbe ricordata: trent’anni dopo, mille capriole dopo, appena inaugurata la variante si è arrivati proprio al risultato previsto. Il potenziamento in sede del sistema autostradale tangenziale.
Variante di valico e “allargamento dell’A14 – Terza corsia tangenziale di Bologna” si tenevano a braccetto anche nella convenzione del 1997, quella con cui lo stato si preparava a far cassa vendendo la società Autostrade alla famiglia Benetton. Ed è proprio con la nuova concessionaria che gli enti locali si impegnano, all’inizio del 2002, per ampliare l’A14 con una terza corsia. Poi però cambiano idea e nell’agosto dello stesso anno, firmano l’accordo con il ministro Lunardi che dà il via alla progettazione del Passante nord, cioè la nuova bretella autostradale a nord del capoluogo, pensata per mandare in pensione proprio quel tratto di A14 che un attimo prima volevano allargare. L’apertura del Passante, infatti, andrebbe di pari passo con la banalizzazione della vecchia autostrada, cioè il suo declassamento a strada ordinaria, senza pedaggio, così che le otto corsie dell’autostrada/tangenziale sarebbero tutte dedicate al trasporto urbano, roba da far invidia a Los Angeles.
Il progetto è abbastanza megalomane da far proseliti e si guadagna un posto tra le “scelte fondamentali” della provincia, mentre i sindaci dei comuni attraversati espongono in un documento le loro condizioni. A quel punto, la fondazione Carisbo (gruppo Sanpaolo) promuove uno “studio di fattibilità per la riorganizzazione infrastrutturale del nodo autostradale tangenziale di Bologna”. Lo studio mette a confronto il Passante nord con “altri tre scenari alternativi”: il Passante sud, ovvero un tunnel sotto i colli della città; la banalizzazione secca, cioè l’apertura, senza pedaggio, dell’autostrada/tangenziale, e infine la sola realizzazione delle opere già previste (variante di valico, tre nuovi caselli autostradali, completamento di alcune arterie provinciali).
Scenari “alternativi” per modo di dire, visto che nascono tutti dalla stessa premessa, quella che il traffico si riduce se aumenta la capacità della rete stradale. Eppure, la tesi contraria è ormai talmente riconosciuta da essersi guadagnata tre nomi diversi. I matematici lo chiamano paradosso di Braess, i trasportologi congettura di Lewis-Mogridge e gli economisti paradosso di Downs-Thomson. Non solo l’aggiunta di strade può aggravare la congestione e aumentare i tempi di percorrenza, ma danneggia anche il trasporto pubblico, che si ritrova ad avere meno utenti, quindi meno risorse, quindi un servizio più scadente, fino a raggiungere un equilibrio negativo dove tutti rallentano e il trasporto privato non è più veloce di quello pubblico. Lo studio di fattibilità è completato nel maggio 2003 e già alla prima occhiata non brilla per imparzialità. Su diciotto capitoli, dieci sono dedicati al Passante nord e solo quattro al confronto tra le varie ipotesi. La valutazione, come spesso accade, sembra cucita su misura per rivestire decisioni già prese.
I lupi e gli agnelli
Contro quel documento, insorgono i cittadini dell’hinterland bolognese, che d’improvviso vedono precipitare su campi e cortili un “muraglione” di quasi quattro metri di altezza, lungo 42 chilometri, accompagnato dal solito corteo di capannoni, centri commerciali e condomini. Raccolgono cinquemila firme per scongiurare l’assalto, si riuniscono, studiano e in meno di un anno presentano l’Alternativa. Allargare l’autostrada, allargare la tangenziale, ma senza consumo di suolo e potenziando il trasporto su ferro. Tutto in un’unica, magica mossa. Le scarpate del sistema complanare sarebbero colmate per sostenere le quattro nuove corsie e dentro il terrapieno così ottenuto si scaverebbero due gallerie, una per lato, dove stendere i binari di una metropolitana.
Tanto sforzo produce un primo risultato. La provincia istituisce un comitato tecnico-scientifico per integrare lo studio di fattibilità e valutare l’Alternativa. Gli oppositori della nuova autostrada potranno indicare due tecnoscienziati su dieci. I Gruppi spontanei contro il passante nord rimandano l’invito al mittente, giudicandolo “un’apertura solo apparente”. E hanno ragione, ma non si rendono conto che il terreno per piazzare la trappola l’hanno predisposto loro, chiedendo di vagliare una controproposta. Come insegna Fedro, se il lupo e l’agnello si trovano a bere allo stesso rivo, l’agnello deve scappare o preparare una difesa, perché se accetta di discutere col lupo dei suoi diritti di predatore, quello prima o poi troverà una buona ragione per divorarlo.
Al posto del comitato tecnico-scientifico, i Gruppi spontanei invocano un “concorso internazionale di idee”, il classico rimedio contro tutti i mali, ispirato alla favola liberista che “il mercato premia i migliori”. Quindi, dato un problema, se faccio competere tutte le soluzioni possibili, alla fine sceglierò quella ideale. In realtà, sarà anzitutto la formulazione del problema a selezionare le risposte. Poi ci saranno decine di soluzioni equivalenti, con pro e contro, e ci si ritroverà da capo a non saper scegliere, perché prima di dire “vinca il migliore” bisognerebbe aver capito che cosa si intende con quel termine. Una decisione politica che non può ridursi a un confronto di numeri e perizie.
I tecnoscienziati, invece, fanno i loro calcoli a tempo di record. A novembre 2004, lo studio di fattibilità aggiornato e approfondito finisce sulla scrivania del ministro Lunardi. Nell’addendum, i tecnoscienziati promuovono il Passante nord – con il solo voto contrario di Maria Rosa Vittadini – e bocciano senz’appello il “potenziamento in sede”, esprimendo “seri dubbi sull’opportunità di indurre ulteriori profonde e durature sofferenze alle attuali gravi condizioni di vivibilità e di qualità dell’ambiente, riscontrabili nella fascia a ridosso del nastro tangenziale/autostradale. Particolarmente convincenti e decisive, a questo proposito, risultano le considerazioni svolte nel capitolo dedicato all’analisi della qualità dell’aria e del rumore, che avvertono di quali ulteriori danni la proposta del potenziamento in sede porterebbe allo stato attuale dell’atmosfera e del clima acustico nella prossimità del nastro”. Un giudizio negativo che suona sorprendente, se si pensa che il “potenziamento in sede” oggi si chiama “Passante di Bologna”, ed è il progetto decantato dal sindaco Merola come “un’idea di città che punta a rafforzare fortemente la nostra qualità urbana complessiva”.
Chilometri da odiare
Archiviato lo studio di fattibilità, si passa alla fase operativa. Bisogna sviluppare un progetto e trovare i soldi per realizzarlo. Il governo pensa a un finanziamento pubblico/privato ormai tipico del settore infrastrutture. È lo schema Bot (Built – Operate – Transfer). Il privato paga una parte dell’opera, la costruisce e poi recupera l’investimento riscuotendo il pedaggio fino all’anno X. A quel punto, sazio e satollo, si fa da parte e l’autostrada diventa gratuita. Peccato che lo schema funzioni solo in teoria, mentre nella pratica – chissà perché – l’abolizione della tariffa non arriva mai, e l’infrastruttura si trasforma, per il gestore, in una rendita garantita.
Le prime a farsi avanti per il Passante nord, sono l’italiana Pizzarotti e la francese Eiffage, accoppiate per l’occasione. Ma i tempi si allungano, qualcosa s’inceppa, e ci vogliono due anni prima che il ministro Di Pietro bolli il progetto come “irricevibile sul piano tecnico e giuridico”. “Ognuno tira la giacca dalla propria parte”, si lamenta il ministro. E allora sai che si fa? Altro che Pizzarotti-Eiffage! Questa nuova autostrada è una priorità nazionale, se la deve accollare l’Anas con un finanziamento pubblico, i soldi ci sono, si fa un apposito emendamento nella prossima finanziaria. Che problema c’è? C’è che l’apposito emendamento non passa in commissione bilancio, suscitando il “rammarico” del premier Romano Prodi. Negli stessi giorni – siamo a novembre 2007 – con le classiche “indiscrezioni” a mezzo stampa si comincia a nominare, sottovoce, il deus ex machina che può sbloccare la situazione. Autostrade per l’Italia (in sigla, Aspi).
“Autostrade? Bell’idea, ma mica gli possiamo dare il Passante così, senza gara d’appalto. L’Unione europea ci scortica vivi”. “Dipende. Se la chiamiamo ‘nuova autostrada’ ci vuole un bando pubblico. Se la chiamiamo ‘variante’, possiamo farne a meno. È come se Autostrade pigliasse l’A14 e la spostasse più a nord”. “Geniale! Così il Passante rientrerebbe tra gli investimenti già previsti sul nodo bolognese. Sarebbe tra gli obblighi della convenzione del 1997. Lo pagherebbero tutto loro!”. L’idea geniale deve però fare i conti con alcuni guastafeste, che oggi qualcuno chiamerebbe “gufi”, mentre Di Pietro li accusa di voler difendere bruchi, rospi e passerotti. Legambiente denuncia il governo italiano alla Commissione europea, sostenendo che l’affidamento diretto ad Autostrade viola le regole sugli appalti. Rifondazione comunista e Verdi minacciano di raccogliere le firme per un referendum contro il Passante, mentre i Comitati di cittadini rinforzano la protesta contro il “muraglione”.
Passano altri due anni, cade il governo Prodi. Di Pietro se ne va dal ministero delle infrastrutture e arriva Altero Matteoli. Intanto a Bologna la vita continua. A vent’anni dall’ultimo piano urbanistico generale, viene adottato, a luglio 2008, il nuovo Piano strutturale comunale. “Bologna si fa in sette” è il pay off del nuovo documento, e vi si descrive una città formata da sette città. Una di queste è la “città della tangenziale”, ovvero “la sequenza di insediamenti che, addossati alla grande barriera, ne soffrono tutti gli inconvenienti”. La lungimirante “fascia vincolata” del sindaco Dozza negli anni si è riempita di case, palazzi, interi quartieri, con la sola eccezione di qualche “cuneo agricolo”. Così, per “recuperare l’abitabilità” della zona, il piano confida molto nella “scelta di realizzare un Passante autostradale a nord, che comporterà il ‘declassamento’ a sola tangenziale del tratto autostradale bolognese, con una riduzione del traffico e del suo carico inquinante”.
Aggrappandosi al Passante più vicino
Che il “declassamento” immaginato dal comune possa portare davvero a un “recupero di abitabilità” non è affatto scontato. Se un’infrastruttura contamina per decenni la vita di un quartiere, non è addomesticando il mostro che si guarisce l’infezione. Tuttavia, i cittadini della tangenziale sono invitati a immaginarsi un futuro con meno auto e meno inquinamento sotto le finestre di casa, oltre alla promessa di mitigazioni ambientali, inserimenti paesaggistici, ricuciture, corridoi e spine verdi, attraversamenti ciclo-pedonali, tutela, riqualificazione, potenziamento degli spazi di uso pubblico.
Il Passante nord intanto è ancora ben lungi dall’essere approvato, ma in comune tirano dritto come se lo fosse, sperando che si materializzi a furia di nominarlo. Finalmente, a ottobre 2009, nuntio vobis magnum gaudium: l’Unione europea ha detto sì. O forse no. ‘Spetta ‘n attimo. Qua dice che il passante di 42 chilometri non gli va bene. Una roba così lunga, come fai a chiamarla variante? Bisogna scorciarlo, bisogna stare più a sud. Seee, più a sud! Se passiamo più a sud tocca convincere soquanti altri sindaci, diventa La storia infinita… Il risultato è che altri due anni – quasi fosse una scadenza rituale – se ne vanno per discutere se l’Unione europea ha dato il via libera al Passante nord o al Passantino-più-corto-più-a-sud, interrogandosi su quale sarebbe, nel caso, il tracciato di questo Passantino.
Nel novembre 2011, Anas e Autostrade rompono gli indugi e firmano l’accordo per la realizzazione del Passante. Costo previsto: un miliardo e quattrocento milioni. Il tracciato? Non è dato saperlo, ma pare ormai certo che si tratterà della versione ridotta. Il sindaco di Castelmaggiore, incupito, dichiara che il Passantino “rischia di diventare la nostra Val di Susa”. Ma la battaglia evocata dalle sue parole non è tanto sul territorio del suo comune, quanto all’interno del suo partito, il Partito democratico, tra sindaci e provincia, tra consiglieri e consiglieri, tra pezzi contrapposti dello stesso blocco di potere. Un indizio evidente della guerra intestina è la nuvola di polvere che si alza a confondere la vista: non ci sono più progetti chiari, intenzioni riconoscibili, studi di fattibilità sbilanciati ma quantomeno consultabili.
Autostrade per l’Italia, nell’estate 2012, consegna agli enti locali un’ipotesi di tracciato, ma il documento non viene divulgato. Trapela giusto a spizzichi e bocconi, una tabella qui, un parere là, qualche frase tra virgolette. Come quella che definisce il Passante nord “un progetto che sembra discendere da scelte di carattere urbanistico, piuttosto che rappresentare un’efficace alternativa all’uso dell’esistente sistema autostradale”. E ancora: i “modesti benefici trasportistici” e i “consistenti impatti territoriali e ambientali” portano alla “conseguente scarsa sostenibilità dell’analisi costi benefici, evidente” per il Passante nord nella sua versione originale, e “molto probabile” anche per il Passantino. Uno dice: a ‘sto punto non lo faranno di sicuro, ‘sto maccherone di Passante nord. E invece, nonostante una seconda denuncia di Legambiente all’Unione europea, il 29 luglio 2014 si va tutti quanti dal ministro Lupi a firmare l’accordo per la progettazione del Nuovo-passantino-non-troppo-a-nord. Maurizio Lupi, però, rassegna le dimissioni prima di vedere uno straccio di progetto e il suo successore, Graziano Delrio, chiede tempo, per valutare bene – dice – quali grandi opere siano davvero necessarie al paese. Alla fine, senza troppe fanfare, il Passante passa. Autostrade fa i compiti delle vacanze, consegna tutte le carte, ma il 4 dicembre 2015 arriva lo stop definitivo: “Dopo consultazione dei sindaci, le parti convengono di non dar seguito all’opera prevista”.
Evviva. La campagna bolognese è salva. Si evita di costruire un’autostrada dannosa, inutile e imposta. Ora magari si valuteranno altre soluzioni, per risolvere il problema delle code in tangenziale. Magari si aspetterà di vedere come se la cava il Servizio ferroviario metropolitano, che doveva andare a regime nel 2005 e invece lo sarà – forse – solo nel 2017. Magari… Magari un corno. Per la prima volta in tutta questa storia, si decide in fretta, si bruciano i tempi, non si rispettano i due anni della liturgia consolidata. Il 15 aprile 2016 c’è già un nuovo accordo da sottoscrivere. Le firme sono quelle del ministro Delrio, del sindaco Merola, del presidente della regione Stefano Bonaccini e di Irene Priolo, delegata ai trasporti per la Città metropolitana (ex provincia), nonché sindaca di Calderara di Reno, oppositrice del Passante nord sul suo territorio. Nella nuova giunta bolognese che si insedierà di lì a due mesi, sarà assessora alla mobilità, pur rimanendo sindaca di Calderara. Sull’ultima riga utile del documento, non previsto dall’intestazione e nemmeno dagli appositi spazi per le firme, c’è un sesto autografo – largo allo Sbloccatutto! – : il presidente del consiglio dei ministri, Matteo Renzi. Il titolo è: “Accordo per il potenziamento in sede del sistema autostradale/tangenziale nodo di Bologna”.
Sui motivi di un’intesa tanto rapida, si possono formulare solo ipotesi. Certo, la scadenza delle elezioni amministrative ha il suo peso. Il 5 giugno si vota in molti comuni della Città metropolitana. Ma c’è anche un’altra data – poco nota ai più – che i firmatari conoscono di certo. Il 19 aprile 2016, sotto la pressione di tre direttive europee, entrerà in vigore il decreto legislativo numero 50 del 2016, meglio noto come Nuovo codice degli appalti, destinato a riordinare la normativa in materia di contratti, bandi e concessioni nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. Sai mai che a firmare cinque giorni dopo non ci si vada a inguaiare con qualche nuova disposizione, come per esempio l’articolo 22, sulla trasparenza e il dibattito pubblico. Quindi via, di corsa, prima si firma, poi si vota, poi si nomina la giunta e infine a luglio, con le valigie in mano e l’afa che addormenta la città, si presenta in comune il nuovo progetto. Merola dichiara: “Abbiamo bisogno di amministratori che sappiano imparare dagli errori e abbiano l’umiltà di dirlo”. Un errore durato dodici anni?
Chissà cosa ne pensano quelli del Comitato per l’Alternativa al passante autostradale nord di Bologna. Sulle prime, com’è giusto, festeggiano. “Questa è una storia che nasce già/ben quattordici anni fa” – comincia la zirudella composta per l’occasione, ma “il quindici aprile di quest’anno/pare finito l’infinito inganno”. Sul loro sito, scrivono che “il potenziamento in sede è […] la proposta avanzata dal Comitato fin dal 2004”. In seguito correggono il tiro, sottolineando che “l’allargamento di cui si sta discutendo oggi non è la nostra proposta e rischia di disattendere le ragioni che l’avevano ispirata”. Autostrade per l’Italia, infatti, aggiungerà le quattro nuove carreggiate consumando 20 ettari di suolo (ma guarda un po’!), e le scarpate dell’infrastruttura non diventeranno gallerie ferroviarie. Né ha immaginato l’avveniristica “opzione 2”, una specie di strada-condominio, formata da due tunnel sovrapposti, suddivisi per tipi di traffico (auto, treni, bici), in parte adibiti a parcheggi e ricoperti all’esterno con pannelli fotovoltaici. Queste ultime osservazioni si possono leggere nel “documento finale” di 149 pagine, pubblicato in ottobre, come “testimonianza dell’impegno di un comitato ‘sui generis’”. Sui generis? E che vuol dire? Ogni comitato di questo tipo ha le sue peculiarità. Cambiano i territori, cambiano le battaglie, le imposizioni e le opere. Non c’è nemmeno bisogno di precisarlo. Per quale motivo, invece, questo comitato si sente in dovere di enfatizzare la sua differenza? È venuto il momento di conoscerlo meglio.
Scopri sempre che c’è un’alternativa
Cominciamo dal nome, che non è un dettaglio. A leggere con attenzione i volantini si scopre che il Comitato contro il passante nord non è mai stato un “Comitato contro il passante nord”. Quando debutta, nel 2003, ha il nome plurale di “Coordinamento dei gruppi spontanei contro il passante nord”. In poco tempo aggiunge: “(e proponenti soluzione Alternativa in sede)”. Più che una ragione sociale, un film di Lina Wertmüller: 14 parole più le parentesi. Dal 2005 si stabilizza in “Comitato per l’Alternativa al passante autostradale nord di Bologna”. Qual è il motivo di questa irrequietezza identitaria? Forse lo stesso che lo spinge a definirsi “Comitato sui generis”. Il Comitato è “per l’Alternativa” perché cerca un modo alternativo di praticare il culto di Asfalto, Mattone, Tondino e Cemento, senza mettere in discussione il dogma che per ridurre il traffico sia necessario fare più strade. Ed è “sui generis”, e quindi atipico, perché si differenzia dagli oppositori di infrastrutture per antonomasia, i No Tav: “Per noi il no e basta non esiste: noi portiamo avanti una proposta alternativa sul Passante, quindi noi prendiamo atto che c’è questo movimento [in Val di Susa] non abbiamo però parentele con questo tipo di atteggiamento e, diciamo, questo modo di comportarsi”.
Il Comitato “sui generis” mette tra i suoi princìpi la critica a un “modello di sviluppo superato”. Eppure, tanto quel modello quanto la loro Alternativa si basano sul culto della mobilità privata e del trasporto su gomma, senza metterlo davvero in discussione. Quest’incoerenza rimane sottotraccia fino al 2016, quando l’Alternativa viene fatta propria dalle istituzioni. Allora il Comitato dimentica di essere “sui generis” e si mette a combattere contro gli oppositori dell’allargamento in sede, che si sono dati il nome di No passante di mezzo, e sono soprattutto quei “cittadini della tangenziale” blanditi dal comune pochi anni prima. A quel punto, la critica al “modello di sviluppo”, già prima puramente formale, viene dismessa: “Non è corretto […] gridare all’improvvisazione […] né invocare una visione generale dei problemi. […]. È significativo che ancor oggi i comitati dei residenti non abbiano indicato la loro preferenza tra le ‘tante soluzioni’ a cui fanno spesso riferimento nei loro interventi senza mai elencarle esplicitamente. Diciamo la verità: il nopassantedimezzo in pratica nasconde un torniamoalpassantenord, e senza badare troppo per il sottile, visti gli interventi che vengono applauditi a scena aperta […] sommessamente suggeriamo a questi signori ed ai loro esperti di informarsi meglio, con meno faziosità negli slogan, nell’esposizione e nell’uso dei dati ed essere capaci anche di ascoltare, in un sereno confronto […]”.
A distanza di pochi anni e chilometri, il Comitato “sui generis” ha dimenticato cosa significa vedersi piombare addosso ettari d’asfalto e non riconosce la propria immagine nello specchio delle vittime del nuovo patto tra Pd e Autostrade. Così, elegge i propri pari – i No passante di mezzo – a principali nemici. Li invita a indicare la loro preferenza, tra le tante soluzioni possibili, e ciò significa, visto il pulpito, a trovare qualcuno su cui gettare addosso l’infrastruttura. Ed è qui che esce il peggio di questa storia bolognese. Perché le nuove vittime stanno al gioco, si oppongono all’opera lì da loro, cercando di scaricarla su un altro territorio. Certo, non tutti: abbiamo sentito di persona chi, parlando a nome del No passante di mezzo, lo fa senza cedere a questa tentazione. Ma nel complesso la visita al loro sito, passantedimezzonograzie.it, è sconfortante, ed è piena di “soluzioni alternative”. La più gettonata è quella del Passante sud – il buco sotto le colline bolognesi già perforate da variante di valico e alta velocità ferroviaria. Tra i tecnici che la sostengono sulle loro pagine (“i nostri esperti”) spicca un negazionista del riscaldamento climatico, nemico dei “talebani dell’ambientalismo”, che coglie l’occasione per un’invettiva contro i No Tav: “Occorre serietà, equilibrio, elasticità mentale, e non si addice neppure la posizione di chi dice solo e sempre no a qualsiasi intervento […]. In un paese montuoso e sismico e di ineguagliata qualità paesaggistica come la nostra Italia […] la mobilità […] va sviluppata nel sottosuolo. […]. Questo orientamento è già stato positivamente attuato anche nel Bolognese con l’Alta Velocità […], e con la Variante di Valico […] opere necessarie, osteggiate e ritardate a lungo dai soliti negazionisti puri che ne avevano pronosticato anche l’impopolarità, come si ostinano ancora oggi a fare i valsusini”. La sintonia tra i comitati “nemici” è, su questo punto, perfetta. La postura è identica, ed è quella che predispone al lancio dell’infrastruttura contro qualcun altro. Più indifeso è, meglio è. Non a caso, i No Tav della val di Susa attirano odio e strali da entrambi, perché dimostrano che è possibile e necessario sottrarsi a questa pratica.
Stasera pago io
Uno degli insegnamenti che si possono trarre da questa triste vicenda bolognese è che lo scaricabarile tra territori, una volta partito, infetta la discussione in maniera irrimediabile. Diventa così molto più difficile confrontarsi sui vantaggi e gli svantaggi di un’opera: traffico, inquinamento, rumore, consumo di suolo e paesaggio. Nelle prossime due puntate della nostra inchiesta, vi racconteremo quanto sia stato fuorviante il “confronto pubblico” su questi temi.
Ora, invece, vogliamo affrontare un altro elemento. Anche questo comporta vantaggi e svantaggi, ma come spesso accade, è stato messo in ombra dalle altre questioni. Il denaro. Nicholas Hildyard, nel suo ultimo libro su infrastrutture e finanza, Licensed larceny (Manchester University Press, 2016), sostiene che nessuna discussione sull’impatto ambientale di una grande opera è davvero efficace se non si capisce in che misura genera profitti e a vantaggio di chi. Strappare qualche chilometro in più di barriera antirumore è una vittoria di Pirro, se rende accettabile un’autostrada che per molti decenni succhierà ricchezza pubblica per trasformarla in ricchezza privata. Quindi occorre chiedersi: chi lo paga, il Passante di Bologna? Chi ci guadagna?
L’idea che va per la maggiore, a proposito dei costi progettuali della nuova opera, è condensata nello slogan “paga Autostrade”. Ma è davvero così? Possibile che una società per azioni “paghi e basta”? Autostrade per l’Italia gestisce quasi tremila chilometri di strade a pagamento. La sua fonte di reddito sono i pedaggi, la sua prospettiva economica è data dalla durata delle concessioni che le consentono di incassarli. Vediamo, in quattro passaggi successivi, come sono stati fissati entrambi i parametri.
a) Nel 1997, quando la società Autostrade è ancora di proprietà pubblica all’87 per cento, la concessione viene prorogata di vent’anni, “in cambio” di opere come la variante di valico e il “potenziamento del nodo bolognese”. Ciò significa che Autostrade incasserà i pedaggi fino al 2038 e non più “solo” fino al 2018. Inoltre, nella formula con cui si calcola l’importo da richiedere al casello è incorporato un provvidenziale fattore X. “È difficile pensare ad altri casi in cui sia possibile per uno stato dispensare regali tanto generosi, senza che l’opinione pubblica nemmeno se ne accorga, come con la regolazione delle tariffe e l’estensione della durata delle concessioni autostradali”, scrive Giorgio Ragazzi autore di I Signori delle autostrade, (Il Mulino, 2008).
b) Tutta la generosità dimostrata nel 1997 è finalizzata a rendere appetibile la società Autostrade, che due anni dopo viene privatizzata. La quota di controllo di Autostrade passa in mano ai Benetton. Le tariffe remunerano abbondantemente una rete già in gran parte ammortizzata: comincia un travaso di ricchezza – da pubblica a privata – che durerà decenni.
c) Negli anni che seguono il fattore X fa il suo lavoro, che è principalmente quello di consentire aumenti del pedaggio a fronte di investimenti in nuove opere. Ma, “la pluralità delle formule concretamente operanti, la definizione poco precisa di alcune delle variabili considerate e le difficoltà riscontrate nel riesame dell’adeguatezza delle tariffe di base […] hanno creato una certa opacità regolamentare. […] Negli ultimi venti anni i ricavi delle concessionarie sono più che raddoppiati, passando da 2,5 miliardi di euro nel 1993 a oltre 6,5 miliardi nel 2012. Tale crescita è prevalentemente da attribuire alla dinamica delle tariffe unitarie, cresciute più della dinamica generale dei prezzi […]”, come spiega Paolo Sestito di Bankitalia ai deputati dell’8ª commissione, nel 2015.
d) Ad Autostrade per l’Italia non basta un fattore X di aumenti, per quanto generosi. Vuole rimettere in discussione la fine della concessione, e il governo Renzi (e Delrio) sembra essere d’accordo. Dall’inizio del 2016 si parla a più riprese di un’ulteriore proroga della scadenza, dal 2038 al 2045. Sulle prime, il mercanteggiamento ruotava attorno alla costruzione della “gronda di Genova” e del Passante nord. Ora, in luogo del secondo, il governo potrebbe accontentarsi del Passante di Bologna, che ad Aspi costerà la metà.
E poi, il colpo finale. Chi entra o esce dai quattro caselli del nodo bolognese è gravato da un sovrapedaggio di circa 50 centesimi (la tariffa per 6,9 chilometri, un quarto dello sviluppo dell’attuale tangenziale). Il balzello serve a pagare Aspi per la manutenzione della tangenziale e a evitare che sia usata dai mezzi in transito come alternativa gratuita all’A14. Sono però esentati gli automobilisti che percorrono le autostrade entro un raggio di 40 chilometri dal capoluogo. Insomma: chi si muove per piccoli spostamenti e pendolarismo. L’accordo di aprile 2016 stabilisce invece che, dopo il completamento del nuovo Passante, il sovrapedaggio sarà applicato “senza alcuna deroga”, e sarà calcolato in modo differenziato casello per casello. Quindi qualcuno spenderà un euro in più al giorno, per altri l’aumento sarà maggiore. E per la concessionaria? Su 40 milioni di transiti all’anno dai caselli bolognesi, quanti sono i pendolari? E a quanto ammontano i costi di manutenzione della tangenziale?
Luglio, Agosto, Settembre (nero)
I profitti crescenti e i costi ridotti di Aspi, probabilmente determinanti nell’abbandono del Passante nord, non hanno avuto spazio nel dibattito. Le semplici domande su quanto incassi Benetton ai caselli bolognesi non hanno trovato risposta nel “confronto pubblico”, dove invece risuonava la falsa e consolatoria certezza del “paga Autostrade”. Nessun incontro specifico è stato dedicato a questo tema, nei due mesi di ascolto e partecipazione.
Due mesi? Ma non avevano detto quattro? In effetti sì. In tutti gli interventi, in tutti i materiali e in tutte le propagande del comune, si parla sempre di “quattro mesi di confronto pubblico”: Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre. Ma il progetto preliminare, come abbiamo visto, è stato presentato il 22 luglio, a mese già finito. Agosto, Passante mio non ti conosco. Il primo incontro al quartiere San Donnino è datato 7 settembre. L’ultimo, con la presentazione dei “suggerimenti per migliorare l’Opera”, è del 7 novembre. Due mesi esatti. Del resto, non c’era da aspettarsi molto di più, da un percorso di partecipazione illustrato con una foto fasulla. I bolognesi hanno risposto con scarso entusiasmo. Chi per pigrizia, chi per disillusione, chi fiutando l’ipocrisia degli interlocutori.
Noi siamo andati a vedere il bluff. Appuntamento alla prossima puntata.
 «Campidoglio a 5 Stelle. Raggi avverte il suo assessore all’Urbanistica, contrario al progetto della As Roma. Con un falso scoop delle agenzie di stampa, la prima cittadina pone l’aut aut all’urbanista». il manifesto, 7 dicembre 2016 (c.m.c.)
«Campidoglio a 5 Stelle. Raggi avverte il suo assessore all’Urbanistica, contrario al progetto della As Roma. Con un falso scoop delle agenzie di stampa, la prima cittadina pone l’aut aut all’urbanista». il manifesto, 7 dicembre 2016 (c.m.c.)
Un avvertimento. Lanciato tramite agenzia di stampa, con uno stile apparentemente in contraddizione col principio grillino della trasparenza ma poi non così inusuale nell’era pentastellata della Capitale. «Paolo Berdini potrebbe presto lasciare la giunta Raggi»: il lancio dell’Adnkronos è lapidario e non usa condizionali.
La decisione di fare fuori il più indipendente e a sinistra degli assessori, quello all’Urbanistica, «sarebbe stata presaa [sic]– riporta il take di agenzia – nel corso di una riunione» tenuta lunedì sera «alla quale ha partecipato la sindaca Virginia Raggi e i suoi più stretti collaboratori». Ma, appunto, è solo un avvertimento. La prima cittadina e il suo cerchio magico vogliono mettere alle strette Berdini e costringerlo a fare un passo indietro sui suoi no al progetto dello stadio della As Roma.
L’urbanista infatti – che peraltro fu tra i primi ad essere chiamato in giunta da Raggi proprio per la sua lunga e riconosciuta esperienza e, a differenza degli altri assessori, non venne sottoposto a imbarazzanti esami da commissioni grilline – aveva da subito sollevato obiezioni sul progetto della società sportiva. Berdini è contrario soprattutto a violare il Piano regolatore di Tor di Valle per costruire, oltre allo stadio, anche tre «Torri» da 650 mila metri cubi di cemento che coronerebbero il sogno di James Pallotta.
Da tempo Berdini aveva fatto notare che quel progetto conteneva anche vere e proprie trappole per l’amministrazione capitolina, come ad esempio un «impianto di pompaggio gigantesco da 3 milioni di euro contro i rischi di un’eventuale esondazione del Tevere», la cui gestione rimarrebbe poi al Comune. Ma il patron della Roma deve aver usato argomenti molto convincenti quando, a settembre scorso, ha incontrato la sindaca e il suo vice Daniele Frongia. Non a caso, il tycoon di Boston uscì dal Campidoglio «ottimista». E la stessa Raggi, che da allora ha preso in mano il dossier, definì «positivo» l’incontro.
L’ordine di Grillo però era di congelare tutto fino al referendum, per evitare di compromettere la campagna. Tanto che Raggi ha annullato l’ultima riunione sullo stadio che avrebbe dovuto tenersi venerdì scorso, con Berdini e con il numero due della Roma, Baldissoni. E ha chiesto all’avvocatura del Comune di studiare le conseguenze legali di un’eventuale modifica del progetto.
«Che c’è malcontento è risaputo», ammette il consigliere 5S Angelo Diario, a capo della commissione Sport. D’altronde il meno irreggimentato degli assessori è stato anche il primo ad opporsi alle «Olimpiadi del mattone», invitando però Raggi a cogliere l’occasione per contrattare con il governo Renzi il finanziamento di un «Patto per Roma», al quale Berdini continua ovviamente a lavorare.
E ora, passato il referendum, arriva l’avvertimento. La velina trasmessa alle agenzie spiega che ci sarebbe anche «il via libera della maggioranza» per il ritiro delle deleghe. In realtà questa volta i dardi avvelenati partono da Palazzo Senatorio, non dall’Aula Giulio Cesare: «Ieri c’è stata una riunione di maggioranza e non si è parlato dell’assessore Berdini che è un membro di questa giunta. Ci sono almeno 29 persone che vi hanno partecipato e possono confermarlo», dichiara il capogruppo M5S Paolo Ferrara che bolla il resto come «chiacchiere da vecchia politica».
Ma mentre nel corso della giornata i rumors capitolini danno già per scontata l’ennesima «epurazione» o «rimpasto di giunta, a seconda dei punti di vista, dalla giunta nessuna comunicazione ufficiale. E sarebbe stata necessaria, questa volta. L’unica smentita dal Campidoglio invece viene fatta trapelare – anonima – su un’altra agenzia, Omniroma: Berdini «è regolarmente al lavoro sul dossier stadio della Roma». E, intercettato dai cronisti, l’assessore al Bilancio Andrea Mazzillo nega: «Di strappi non so nulla. Non mi risulta nulla di questo».
Le polemiche però ci sono da tempo, veicolate da social blog e testate on line vicine al movimento. Qui, qualche settimana fa, si ventilava lo scioglimento imminente del «Tavolo di coordinamento dell’Urbanistica», a causa delle dimissioni in blocco dei membri «in rivolta» contro Paolo Berdini, accusato di aver rifiutato di seguire il modello pentastellato di lavorare «come attuatore delle politiche di indirizzo che sarebbero dovute venire dalla commissione urbanistica».
L’argomento stadio e «Torri dell’Eur» – con annessa mediazione con i «palazzinari» romani – è però poco spendibile nel movimento grillino. E così spuntano fuori anche le polemiche sulla metro C e sugli sfratti agli inquilini dei «Piani di Zona». A Longoni, dove ci sono alcuni di questi immobili inizialmente destinati ad affitti agevolati, l’Unione sindacale di base oggi organizza un presidio. Nel comunicato di convocazione l’Usb se la prende anche con l’assessore all’Urbanistica che «aveva assunto l’impegno alla revoca delle convenzioni». Ed esalta il ruolo della deputata 5S Roberta Lombardi, che oggi sarà presente per continuare la sua difesa di una famiglia di sfrattati.
Paolo Burgio intervista Giancarlo Consonni, che con numerosi colleghi urbanisti, architetti ed ecologisti ha firmato l’appello al Comune per protestare contro gil modo in cui si procede a decidere la trasformazione degli scali FS a Milano. z3xmi.it online, 6 dicembre 2016
1.Professor Consonni cosa l’ha spinta a sottoscrivere questo appello?
Si sono travisati gli impegni assunti nella delibera del Consiglio Comunale che prevedeva un concorso pubblico: la procedura scelta esautora l’amministrazione pubblica e i cittadini dal governo del territorio e dei destini della città. Si sta ripetendo quello che è accaduto negli ultimi trent’anni per interventi di rilevanza cruciale in cui il progetto è stato redatto su incarico dell’operatore immobiliare proprietario delle aree (da Bicocca, che ha fatto da apripista, alle altre grandi aree dismesse: Innocenti, Om, Porta Vittoria, Montedison-Rogoredo, fino a Porta Nuova e Citylife). Il bilancio è sotto gli occhi di tutti: seguendo questa prassi, si sono via via perse straordinarie occasioni per migliorare la qualità urbana.
In tutti questi casi il Comune non ha mai espresso una linea strategica, un’idea di città. Emerge un limite culturale di fondo, oltre che politico (le due cose sono strettamente collegate).
La storia si ripete ora con una mistificazione in più. Se nel caso di CityLife il problema era che l’ente Fiera doveva trovare le risorse per il trasferimento a Rho-Pero, qui FS-Sistemi Urbani maschera la politica immobiliarista con l’esigenza di dover reperire risorse per un nuovo passante ferroviario o altri interventi sulla rete regionale dei trasporti su ferro. Non vi è dubbio che occorra rivedere la politica del trasporto pubblico in Lombardia con particolare attenzione agli spostamenti pendolari; ma che, per conseguire dei miglioramenti su questo fronte, si debbano reperire risorse dalla speculazione immobiliare su aree sostanzialmente pubbliche, è un modo di procedere assurdo.
2. In Italia da tempo assistiamo a continue deroghe delle norme che impongono di bandire concorsi pubblici, una pratica che non trova spazio in Francia, in Germania e in altri paesi europei. Così facendo si nega in effetti un principio di democrazia e di trasparenza. Ne conviene?
Certamente. Fare un concorso pubblico vuol dire redigere un bando; operazione che comporta non solo la definizione degli indici di edificabilità, certo importanti, ma soprattutto la messa a fuoco degli obiettivi strategici: tutte scelte che non possono essere delegate al proprietario delle aree e agli investitori. Il bando serve a definire le finalità sociali della trasformazione. Sul terreno degli obiettivi strategici si registra una grave lacuna nelle politiche del Comune di Milano, come della gran parte dei comuni italiani, del tutto impreparati e disattenti sulla questione del rilancio della qualità urbana degli insediamenti e delle relazioni. Qui è il punto. La democrazia non si misura solo sui modi di formazione delle decisioni ma sugli esiti delle trasformazioni: nel loro rispondere o meno alla necessità di assicurare le migliori condizioni materiali della convivenza civile. Un terreno, questo, su cui l’Italia, che pure è stata maestra nell’arte di costruire città, mostra da tempo una grave carenza a confronto con l’Europa più avanzata.
Nel Bel Paese le politiche di governo del territorio manifestano il totale disinteresse circa le ricadute degli interventi urbanistici sul medio-lungo periodo. Dall’agenda politica sono completamente uscite questioni relative ai modi dell’abitare e ai modi di strutturarsi delle relazioni. Una carenza vistosa che ha radici profonde in un analfabetismo diffuso sul tema del fare città. Si spiegano così trasformazioni urbanistiche e architettoniche che nulla hanno a che vedere con modalità inscrivibili nelle politiche di Rinascimento urbano perseguite altrove (penso in particolare a Barcellona). Basta una visita a CityLife: due grattacieli (un terzo previsto non è stato realizzato) in un deserto di relazioni, una spianata pavimentata su cui si affacciano anche due raggruppamenti insediativi di residenze di lusso, nei quali è incamerato la parte preponderante del verde pubblico previsto per l’intero intervento. Si respira un’aria da gated communities che non va certo in direzione della convivenza civile.
A cavallo del 1900 Edmondo De Amicis ci ha restituito una Torino in cui, in certe zone della città borghese, artigiani, operai e impiegati convivevano nella stessa casa, o nello stesso isolato, con i più abbienti (un principio che valeva anche per Milano e le altre città italiane). Oggi si va decisamente in direzione opposta: si assiste al dilagare di forme esasperate di segregazione sociale, favorite da zonizzazioni selettive e da tipologie insediative concepite secondo logiche sempre più esclusive. Gli ultimi sviluppi sono all’insegna di un ritrarsi delle residenze dei più facoltosi in nuovi ‘castelli’, edifici alti su palafitte con i piani terra non più abitati. In altri termini per questi ceti si predispongono modalità abitative ossessionate dal problema della sicurezza, diffidenti e difese dalle relazioni con l’intorno. Si fa avanti un vivere asserragliato in torri in cui sembrano riaffacciarsi le città puntaspilli del Medioevo. Che cos’altro è il celebratissimo “bosco verticale”? Un caso, questo, nient’affatto isolato. Già prima, Renzo Piano per le aree ex Falck a Sesto San Giovanni ha proposto una sequela di grattacieli su pilotis alti 15 metri e i primi tre piani non abitati, in mezzo a un verde genericamente definito. Un modo di abitare egoistico, che è l’opposto della città. La città è condivisione, nella tutela e nel rispetto reciproco.
Negli ex scali ferroviari si deve dare spazio al verde? D’accordo, ma è sul come che va portata l’attenzione. Se il verde (anche qui imprecisato) ha come prezzo un bordo di grattacieli di residenze di lusso – tanti “boschi verticali” come suggerisce un rendering recentemente ‘regalato’ da Stefano Boeri al «Corriere della Sera»– è già delineato uno scenario preoccupante. Da cancro antiurbano.
Stiamo mimando in modo ridicolo Central Park e i suoi grattacieli in una città come Milano che non ha questi principi nella sua logica costitutiva e nella quale, per fortuna, le relazioni socializzanti sono ancora un fatto primario. Del resto, solo nel continuo connettere presenze e ritrovare punti di convivenza civile si può pensare di salvaguardare processi in cui la cura della democrazia e la costruzione della città vanno di pari passo.
Ci sono poi le quantità e su questo si sta mistificando. Sergio Brenna ha fatto dei calcoli precisi: non ha senso partire dall'ipotesi del verde al 50% con indici volumetrici elevati: poiché nell’insieme del progetto devono rientrare le dotazioni di servizi e spazi verdi, non si può pensare che ci siano logiche compensative per cui il verde e i servizi di interesse generale si possano realizzare altrove: devono essere contestuali. Lo dico per esperienza: se si va oltre l’indice di 0,50 mq su mq (superficie lorda di pavimento su superficie fondiaria), non si potrà mai far tornare i conti: si dovrà forzare il gioco con le tipologie edilizie (vedi il rendering di cui sopra) e una dotazione inadeguata di servizi urbani e territoriali.
3. Spesso si giustificano queste scelte con le esigenze economiche, occorre recuperare risorse sfruttando i processi di riconversione di aree pubbliche perché i soldi non ci sono e dobbiamo contenere il debito pubblico. È questa una vera soluzione?
È una questione centrale. Il Comune, per quello che si è visto negli ultimi decenni, mira unicamente a incamerare oneri di urbanizzazione. Risorse che, dopo la riforma Bassanini, possono venire utilizzate per coprire qualsiasi spesa o buco di bilancio, quando invece, come era nella legge originaria, dovrebbero servire a realizzare i servizi complementari che rendono l’abitato equilibrato. Mentre dimostra disinteresse sulla questione centrale del fare città, l’amministrazione comunale ambrosiana punta a favorire qualsiasi realizzazione purché il flusso degli oneri di urbanizzazione, destinati ormai per il 30-40 % alla spesa corrente, non si interrompa.
In altri termini, vendiamo il futuro per far fronte ai bisogni quotidiani (compresi il mantenimento di una macchina burocratica farraginosa).
L’assenza di visione strategica, e di pratiche conseguenti, mette evidenza in cosa consista l’attuale crisi della democrazia:. Non si può monetizzare la perdita di qualità degli aggregati insediativi e accettare l’aumento di segregazione urbana pur di assecondare operatori immobiliari che, per conseguire il massimo sul piano della rendita, si rivolgono a una sola fascia di mercato, con prezzi ormai superiori ai 10.000 euro/mq.
Il verde, poi – ce lo insegnano le migliori esperienze europee (Parigi, Barcellona ecc.) –, svolge pienamente il suo ruolo se è abitato, se è frequentato intensamente dalla collettività. Perché questo accada, si deve predisporre un’offerta oculata di opportunità. Il parco urbano non può essere un generico spazio rinaturalizzato: deve essere frequentato, presidiato in modi d’uso in cui la contemplazione degli elementi naturali e la cultura devono andare di pari passo.

Una nuova proposta per portare i flussi del turismo "mordi e fuggi" a corrompere la città e i grattacieli del mare a distruggere la Laguna. Ma il nuovo progetto ha ancora più criticità dei precedenti, quindi verrà ugualmente bocciato. La Nuova Venezia, 2 dicembre 2016 (m.p.r.)
Il Patto per Venezia firmato tra il presidente del consiglio e il sindaco di Venezia ci ha [Lidia Fersuoch è presidente di Italia nostra - Venezia] preoccupato notevolmente per quanto concerne soprattutto l’inserimento nello stesso Patto del progetto di escavo del canale Tresse nuovo, un collegamento (proposto dal sindaco e dall’autorità portuale) tra il Canale dei Petroli e il Vittorio Emanuele, per far giungere in Marittima le navi crocieristiche. Il progetto appare dunque avere il sostegno e l’avallo di Renzi, nonostante il ministro delle infrastrutture nella sua recente visita non l’avesse preso in considerazione. Nel patto, inoltre, a rendere più “pesante” l’appoggio della Presidenza del consiglio compare l’asserzione della centralità di Venezia nel panorama nazionale e i molti milioni di euro finalmente sbloccati.
A ben guardare, però, recentemente la stampa ha dato notizia di un altro patto, stipulato con Milano. Entrambe le città - si può pensare - hanno gravi problemi, e probabilmente entrambe, per motivi diversi, sono centrali per il governo e lo Stato. Ma a scorrere le notizie di stampa degli ultimi mesi ci si accorge che Renzi ha firmato un patto per Genova, un patto per Firenze, un patto per Torino, per Palermo, per Cagliari, Reggio Calabria, Messina, Catania, Bari, Napoli (il presidente del consiglio si è perfino dichiarato pronto a firmare un patto per Roma). Sono stati firmati anche patti per regioni intere: c’è un patto per la Campania, la Sicilia, la Basilicata, la Puglia, il Molise, la Sardegna, l’Abruzzo, il Lazio.
Dimentico qualcosa? Tutti questi patti prevedono opere infrastutturali, grandi interventi, finanziamenti cospicui. Un vortice di milioni. E sono stati sottoscritti in questi ultimi mesi. L’opposizione - il senatore Casson - ha l’impressione «che il premier fino al prossimo 4 dicembre firmerebbe qualunque cosa». Ma anche altrove in molti sono critici: «quei soldi per interventi importanti a Marsala erano stati già previsti anni fa», mentre per la Calabria «non c’è alcun finanziamento aggiuntivo rispetto ai fondi europei e nazionali già stanziati» e per Milano «hanno spacciato come novità il prolungamento della M5 fino a Monza, che praticamente è già in costruzione». Inoltre, qualcuno ha quantificato i bonus elargiti da Renzi: si tratterebbe di una somma che supera i 12 miliardi a carico dello Stato.
Questo e altro si legge sui quotidiani nazionali, ma forse - è prudente considerarlo -, si tratta di organi di stampa politicamente avversi a Renzi. In ogni caso si può considerare l’appoggio al progetto del sindaco con meno preoccupazione. Brugnaro sulle Tresse sostiene: «quello è il progetto della città … lo ha capito Renzi che ha detto chiaro “è la città che decide”, lo capirà anche la Sambo».
Peccato però che se anche tutti i cittadini concordemente si dichiarassero sostenitori convinti del progetto Tresse ciò non basterebbe: il progetto non passerà la VIA. Questo progettato canale, infatti, presenta tutte le criticità del Contorta e ne aggiunge altre, come ad esempio il fatto di essere tracciato attraverso l’Isola delle Tresse, una mega discarica di fanghi inquinati (realizzata in regime commissariale, essendo vietatissima la realizzazione di imbonimenti in Laguna, ancor più di discariche).
Ma la criticità maggiore, che Italia Nostra contesta a qualunque progetto mirante a conservare le navi croceristiche in Laguna, è quello che deriva dal transito nel Canale dei petroli. Come tutti ormai sanno, il Canale dei petroli è responsabile della spaventosa erosione del bacino centrale, che ha distrutto la morfologia lagunare approfondendo i fondali e cancellando la rete naturale dei canali. Nella mostra Venezia 1966-2016. Dall’emergenza al recupero del patrimonio culturale. Storie e immagini dagli archivi della città (organizzata dalla Biblioteca Marciana e dall’Archivio di Stato nel mese di novembre presso le Sale monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana, e di cui sarà presto on-line il catalogo) Italia Nostra ha presentato uno scenario progettuale di ripristino di funzionalità idraulica e morfologica dell’area del Canale dei Petroli, curato da Lorenzo Bonometto e di prossima pubblicazione. La Laguna, patrimonio naturale e culturale dell’umanità, necessita di progetti volti al restauro morfologico e idraulico, e non certo di nuovi, devastanti canali.
Lidia Fersuoch è presidente della sezione di Venezia di Italia Nostra
 «Non ci si deve sorprendere, che di questi tempi di neoliberismo, si trovi sempre chi è disposto a sostenere candidamente che chi solleva il problema del consumo di suolo sia un "nemico della libertà"». Casa della cultura, Milano, online, 2 dicembre 2016 (c.m.c.)
«Non ci si deve sorprendere, che di questi tempi di neoliberismo, si trovi sempre chi è disposto a sostenere candidamente che chi solleva il problema del consumo di suolo sia un "nemico della libertà"». Casa della cultura, Milano, online, 2 dicembre 2016 (c.m.c.)
Le vicende urbanistiche che Firenze ha vissuto negli ultimi anni sono illuminanti riguardo ai tempi che viviamo, ma anche abbastanza dense e intricate da indurre a rinunciare al tentativo di offrirne una sintesi nello spazio di un articolo. Anche per questo è prezioso il libro curato da Ilaria Agostini, Urbanistica resistente nella Firenze neoliberista (Aión Edizioni, 2016), nel quale una serie di interventi lucidissimi ricostruiscono e discutono gli scenari più rilevanti in cui si sono svolte queste vicende.
Due, comunque, sono i casi cui maggiormente il lettore è chiamato a rivolgere la sua attenzione: il primo (sul quale si soffermano soprattutto la stessa Agostini e Antonio Fiorentino) è quello di un'alluvione cementizia nell'area di Castello, proposta negli anni con insistenza e diverse variazioni sul tema; il secondo (cui dedicano i loro approfondimenti Alberto Ziparo e Tiziano Cardosi) è quello del progetto di sottoattraversamento della città mediante un tracciato di circa sette chilometri di ferrovia ad alta velocità, le cui origini risalgono a più di vent'anni fa e che oggi è ancora in fase di incerta realizzazione.
Il libro non offre semplicemente una ricostruzione precisa, oltre che radicalmente critica, di questi casi e degli approcci al territorio di cui essi sono espressioni paradigmatiche; il volume propone questa stessa ricostruzione come frutto e testimonianza di un'esperienza esemplare di cittadinanza attiva: quella del gruppo perUnaltracittà che dal 2004 al 2014 ha promosso e sostenuto, da un lato, la puntuale contestazione di questi approcci e, dall'altro, l'elaborazione di prospettive alternative, facendo leva soprattutto - ma non solo - sulla sua rappresentanza in Consiglio comunale.
I contributi di Ornella De Zordo (consigliera comunale lungo tutto il decennio), Maurizio Da Re e Cristiano Lucchi sono particolarmente interessanti in proposito, come lo sono quelli di Giorgio Pizziolo e Roberto Budini Gattai sulle possibilità di rovesciare le politiche urbanistiche dominanti rimettendo nelle mani dei cittadini le risorse storiche, paesaggistiche ed ecosistemiche di Firenze, prima che sia troppo tardi. Altrettanto degni di lettura sono, inoltre, gli scritti di Maurizio De Zordo e Daniele Vannetiello sulla città pubblica in svendita e sull'erosione della democrazia urbana, cui perUnaltracittà ha opposto costantemente resistenza.
I vari approfondimenti proposti nel volume fanno emergere, in particolare, il ruolo da comprimario nelle decisioni riguardanti l'assetto della città che il grande capitale immobiliare assume di fatto nel 2005, quando Salvatore Ligresti, a nome di Fondiaria SAI, celebra pubblicamente con il sindaco Domenici e l'assessore all'urbanistica Biagi la firma della convenzione del piano particolareggiato per l'area di Castello, dei cui suoli la Sai all'epoca è proprietaria. Il piano - oggi stravolto dal compresente progetto per il nuovo aeroporto previsto al di fuori di ogni atto di pianificazione regionale - rimane solo sulla carta a causa sia delle iniziative di contestazione di perUnaltracittà e di altri movimenti cittadini, sia dell'intervento della magistratura sulla presunta disponibilità alla corruzione di almeno alcuni dei protagonisti della vicenda.
Il libro aiuta a comprendere che fatti come questo, in realtà, non sono riducibili a espressioni, semplicemente più smaccate di altre, della complicità fra amministratori e costruttori, che - pur in forme meno ostentate - non è mai stata assente dalle cronache del nostro paese; il libro sollecita soprattutto a rendersi conto che fatti come questo sono il frutto maturo di un mutamento "strutturale" delle pratiche urbanistiche, verificatosi ormai da alcuni decenni - in Italia e altrove - sotto il segno del neoliberismo.
Da questo punto di vista, che gli amministratori pubblici si concedano comportamenti censurabili sul piano giudiziario è meno rilevante del fatto che ai soggetti economici privati sia ormai riconosciuta la facoltà di determinare apertamente le strategie urbanistiche dei governi locali; tutto questo viene loro concesso nella misura in cui essi sono considerati i soli soggetti in grado di attivare e attrarre risorse per la modificazione radicale del territorio urbano, ritenuta ormai perennemente necessaria per "modernizzarlo", "riqualificarlo" o "rigenerarlo".
Il fatto stesso che amministratori di una città come Firenze, eredi di una tradizione tutt'altro che liberista, assumano come pacifica la condivisione delle loro scelte con la grande imprenditoria privata, è solo la prova più eloquente di questo mutamento profondo: alla sua radice sta la rinuncia sostanziale - da parte dei ceti politici di sinistra, non meno che di quelli di destra - a privilegiare le esigenze pubbliche e comuni delle città rispetto agli interessi privati o, addirittura, l'identificazione fra la promozione attiva di questi interessi e il beneficio presunto che essa produrrebbe prima o poi a vantaggio di tutti.
Si tratta dell'applicazione - approssimativa quanto si vuole, ma ormai decisamente "strategica" - dell'idea che la libera iniziativa economica debba avere la possibilità di esprimere le sue miracolose capacità di produrre sviluppo e benessere anche mediante l'adattamento dell'uso del territorio alle sue esigenze. Il che dovrebbe essere immediatamente smentito dal fatto che il territorio è una risorsa finita e non riproducibile. Ma questa evidenza è talmente abbagliante che spesso - per così dire - fa perdere la vista proprio a chi dovrebbe farsene carico a nome di tutti.
Gli autori del libro mostrano che di questa tendenza ormai dominante, a Firenze si sono date e si danno anche declinazioni più astute di quelle praticate nell'era Domenici, conclusasi nel 2009. È questo il caso della successiva gestione amministrativa guidata da Matteo Renzi il quale - dopo il suo insediamento da sindaco - proclama di voler inaugurare una fase radicalmente diversa facendo proprio persino lo slogan dei "volumi zero" e proponendo una nuova pianificazione in sostituzione di quella cui il suo predecessore aveva dovuto soprassedere; al tempo stesso egli mantiene nelle sue mani l'assessorato all'urbanistica e, più o meno tacitamente, assume come un dato acquisito le volumetrie previste nelle pianificazioni precedenti - comprese quelle gigantesche dell'area di Castello - e altre si dispone a concederne con lo strumento delle varianti.
Egli evita l'esibizione pubblica del ruolo da protagonisti riconosciuto agli interessi di proprietari e costruttori nelle scelte urbanistiche, ma di fatto manda - per così dire - "a regime" il netto privilegiamento di questi interessi soprattutto mediante tre linee strategiche: la prima è la conferma - come si è detto - delle massicce volumetrie già previste in passato; la seconda è la rinuncia sostanziale alla tutela del territorio e del paesaggio, derivante - per esempio - dalla previsione nelle zone collinari di ogni sorta di attrezzature, infrastrutture, servizi pubblici o privati e, più in generale, di una grande varietà di tangenziali, passanti, circonvallazioni ipogee e di superficie, parcheggi interrati, sottopassi, sovrappassi e così via; la terza, infine, è l'assunzione della dismissione di edifici comunali, caserme, tribunali, uffici postali e industrie come occasione di liberazione e di trasformazione in senso edificatorio di molte delle rispettive aree, che esclude qualunque programma organico di recupero: la vendita, o la svendita, del patrimonio pubblico ne consegue come esito naturale; il che accade - per esempio - con la cessione del Teatro Comunale, destinato probabilmente ad essere trasformato in complesso residenziale, o con le strategie di marketing immobiliare che il successore di Renzi promuoverà coniando l'apposito slogan: "Florence city of the opprtunities".
La prospettiva aperta, o riaperta, da Renzi dunque è quella di una città in eterna crescita edilizia che potrà continuare ad espandersi anche mediante il sistema della cosiddetta "perequazione urbanistica" che riconosce ai privati il "diritto" di edificare altrove, nel caso in cui tale "diritto" sia loro negato all'interno del territorio già urbanizzato per qualche fondata ragione.
Non a caso, lo stesso Renzi - una volta divenuto "sindaco d'Italia" - non esiterà ad impugnare la nuova legge per il governo del territorio della Toscana, che Anna Marson - assessore regionale indisponibile ad assecondare le strategie dominanti a Firenze - riesce a fare approvare nel 2014. In quella legge, infatti, l'idea di limite all'espansione dello spazio urbanizzato campeggia come principio indigeribile per chi - come Renzi - riconosce a ipermercati e centri commerciali il diritto "ovvio" di occupare il territorio rurale residuo che abbraccia le città.
Naturalmente, alla luce di questo libro, non si deve credere che Firenze rappresenti un concentrato più denso di altri di questi problemi. La sua situazione è esemplare, ma non eccezionale, rispetto alla maggior parte delle città italiane e non solo. Non ci si deve sorprendere, perciò, che di questi tempi si trovi sempre chi è disposto a sostenere candidamente che chi solleva il problema del consumo di suolo sia un "nemico della libertà". Qualcosa del genere si è potuto leggere anche in un dotto intervento pubblicato di recente su questo sito.
Purtroppo, però, la questione della libertà è talmente importante e complessa riguardo ai destini del territorio e dello spazio urbano da non poter essere ridotta alla semplice facoltà, di chi si trovi a disporne, di usare proprietà immobiliari e capacità edilizie a proprio piacimento. Molte altre sono le libertà che andrebbero apprezzate al giorno d'oggi in proposito: per esempio quella di praticare la cittadinanza provando spudoratamente a dire la verità sulla città come bene comune.
Che non si tratti di una bestemmia è ciò che il libro curato da Ilaria Agostini ci aiuta a capire.
Il maschio di quasi tutte le specie viventi, per attirare la femmina, riprodursi e provare a diffondere così il proprio patrimonio genetico... (segue)
Il maschio di quasi tutte le specie viventi, per attirare la femmina, riprodursi e provare a diffondere così il proprio patrimonio genetico, ostenta qualche forma simbolica di potenza. C'è chi gonfia piumaggi, chi si percuote il petto villoso, e chi come noialtri scimmie nude di epoca industriale, preferisce l'ostentazione
paleotecnica della macchina: io ce l'ho più grossa di quell'altro, scegli me e vai sul sicuro. Si parla tanto di superamento della fase di sviluppo culturale meccanico-industriale, ma a quanto pare questi meccanismi sociali sono in qualche misura e modalità vivi e vegeti. Solo qualche giorno fa mi è capitato di fare due chiacchiere informali con la responsabile comunicazione di un'agenzia di
car sharing, operante nel segmento di mercato più innovativo, che punta soprattutto sull'idea di sostenibilità, insomma a quelle cose di cui spesso leggiamo nei nuovi stili di vita dei
millennials. E mi ha colpito ascoltare, proprio dal suo punto di vista, una frase che suonava più o meno: «Anche i nostri più convinti e affezionati clienti maschi, mi dicono che non andrebbero mai a prendere la fidanzata la sera con una delle nostre auto tanto prive di idea di potenza, in quei casi quasi sempre preferiscono un altro operatore». Il che, oltre a farmi un po' calare le speranze nel futuro prossimo dell'umanità intera, mi ha anche fatto capire il senso di tante cose altrimenti incomprensibili, nel mondo dell'auto in condivisione.
Per esempio il motivo per cui entrano in campo gestori di servizi altrimenti inspiegabili, senza tener presente quell'aspetto diciamo così sessuale, del gonfiare le piume meccaniche: auto più voluminose senza alcun riferimento al carico da trasportare, più costose sia per l'operatore che per la clientela, inutilmente più impattanti dal punto di vista ambientale, locale e non. Apparentemente sembrerebbero senza mercato, e invece non solo ce l'hanno, ma potrebbe essere addirittura prevalente: qualcuno che l'auto status symbol non ce l'ha, ma vuole lo stesso ostentarla a tempo parziale. Di tenore analogo a queste vaghe riflessioni, la notizia recente che dal 31 dicembre l'operatore Car2Go (quello con le Smart bianche presente anche in diverse città italiane) chiuderà il servizio a Minneapolis, dopo essere uscito da altri mercati locali, come Miami, San Diego, ma anche Londra. Più in generale, un articolo del periodico di settore Transportist si chiede se il car sharing abbia un futuro, visto che osservando i grafici si nota sul mercato nordamericano un picco di iscrizioni due anni fa, a cui segue un deciso calo. L'ipotesi, almeno una delle ipotesi, è che la pura ripresa economica dopo la recessione metta in dubbio tutti quei ragionamenti che si sono fatti sulla fine del modello proprietario, vuoi per motivi ambientali, vuoi per evoluzioni organizzative delle imprese, vuoi per innovazioni tecnologiche, in testa a tutte quella dell'auto senza pilota, per cui anche nell'Unione Europea di recente la Commissione sembra aver fissato il traguardo massimo del 2020, cioè dopodomani.
Insomma, invece della auspicata demotorizzazione (che va a braccetto, o andrebbe a braccetto, con altri processi virtuosi, dalla smaterializzazione alla ri-urbanizzazione degli stili di vita), il rischio è che ci si ritrovi con un settore auto, e tutto l'insieme degli operatori che danno forma all'ambiente e al territorio, assai fortemente intenzionato a non cambiare affatto modello. Diventerebbero realtà quelle ipotesi molto conservatrici di tanti «futurologi» che dalla stampa in questi anni ci hanno raccontato scenari da cartone animato dei Pronipoti, dove cambiano alcuni dettagli per lasciare identico il resto. La casetta suburbana, magari alimentata a energia solare, ma pur sempre la vecchia villetta, da cui ogni mattina esce l'auto pure elettrica del capofamiglia, rigorosamente in proprietà anche se senza pilota, che lo porterà all'ufficio rigorosamente in un posto diverso e lontano, consumando tempo, spazio, energia, per uno stile di comportamento che pareva e pare ancora privo di senso con le possibilità attuali, anche se caro a certi investitori. E tanti saluti alle aspettative suscitate dagli esordi del car sharing. Ma non può non tornare in mente, però, la vecchia vicenda dello Stereo8, a chi ne conserva qualche memoria, vicenda legata sia all'automobile che al mondo in cui si aggirava facendola da padrona.
La sigla si riferisce a un sistema di ascolto musicale comparso e presto tramontato in Italia a cavallo tra la fine degli anni '60 e i primi '70. Tra le tante cose che a quel tempo si stavano evolvendo, possiamo senza dubbio metterlo al centro, l'abitacolo dell'auto, e insieme quel ruolo di status symbol. Straordinaria ad esempio la memorabile scena del sesso in auto in La Classe Operaia va in Paradiso, di Elio Petri (1971), in cui il protagonista tornitore modello Lulù Massa, interpretato da Gian Maria Volontè, per sedurre la collega Adalgisa squaderna tutti gli attributi erotico-simbolici del caso, dal modello utilitaria ma trendy «che dopo due anni la guardo ancora», al piccolo bar nel cruscotto, alla musica e via dicendo. Il sesso in sé, insomma, all'epoca è poca cosa se lo paragoniamo a tutti i parafernali di contorno, di cui il mitico Stereo8 rappresenta la punta di diamante. Poi le cose si evolveranno diversamente, perché quel particolare tecnico sarà sostituito da un altro lievemente quanto fondamentalmente diverso, l'audiocassetta poi arrivata fino al CD e poi ancora allo streaming eccetera. Entreranno in campo operatori diversi, ma quella rapida sparizione dello Stereo8 in sé e per sé salvo dettagli da elettrotecnici o da speculatori non significa sparizione dell'universo automobile sul territorio: non più semplice mezzo di trasporto, ma vero e proprio prolungamento dell'abitare, dell'essere, senza la quale l'uomo del XX secolo non si sente realizzato.
Ecco: se il car sharing attuale fosse un po' come quel sistema di ascolto musicale in auto di tanti anni fa, intuizione giustissima ma che si trascina qualche tara di cui liberarsi, magari facendo anche finta di estinguersi, tutto tornerebbe a posto. Perché adesso l'intuizione della sostenibilità, degli stili di vita urbani, non legati al possesso ma al valore d'uso, potrebbe benissimo produrre una mobilità assai diversa, dove i veicoli non occupano tutto lo spazio come accaduto per decenni, non sputano veleni nell'aria, non stanno fermi immobili a fare il totem per il 95% della propria esistenza, e non pretendono di fissare per legge a questo scopo infinite superfici asfaltate. Se un operatore di car sharing si ritira, se addirittura ci sono segnali evidenti di calo dell'interesse per quel comparto, certo vuol dire che da qualche parte bisogna cambiare. Ma potrebbe essere, forse dovrebbe essere, anche fuori dall'auto in sé e per sé, magari nell'organizzazione urbana, dei trasporti più intermodali (pare che le nostre Ferrovie ci stiano investendo, in quella direzione), del lavoro e delle comunicazioni. C'è tanto Stereo8, per nulla morto e sepolto, in tutto il nostro attuale casuale frugare in rete alla ricerca di quel passaggio musicale, mentre stiamo sul traghetto delle vacanze. E ci sarà allo stesso modo tanto, tantissimo car sharing in qualche futura pedalata verso un magazzino automatico di mobili ingombranti, che te li carica sul furgone driverless seguendo le indicazioni dello smartphone, o chissà.
Su La Città Conquistatrice il tag Car Sharing (quello Stereo8 non ancora)

Il Fatto Quotidiano, 30 novembre 2016, con postilla (p.d.)
Nonostante il freddo polare e la prima tempesta di neve in arrivo, i membri della tribù Sioux del Nord Dakota assieme ad altre migliaia di persone tra nativi americani e attivisti per i diritti umani e la protezione dell'ambiente, hanno ribadito al governatore repubblicano che non se ne andranno dal campo di Standing Rock. “Il governatore Jack Dalrymple ha emesso un ordine di evacuazione urgente per il peggioramento delle condizioni atmosferiche, ma è un pretesto per farci desistere dalla protesta contro l'oleodotto. Noi però da questo campo, che è peraltro sul suolo federale, non ce ne andremo anche se la polizia ricomincerà a prenderci di mira con gli idranti, le pallottole di gomma, i pesticidi o ci arresterà come già successo a molti di noi durante questi sei mesi di lotta”, ha detto al Fatto Dave Archambault II, portavoce della campagna.
Dallo scorso aprile in questa prateria da giorni flagellata da un vento glaciale che scende dal Canada, a due ore di macchina da Bismark – la capitale del Nord Dakota – i nativi e gli ambientalisti provenienti da tutti gli Usa hanno alzato le tipiche tende, quelle che abbiamo imparato a conoscere dai film western, cucine da campo e bagni chimici allo scopo di occupare 24 ore su 24 la zona dove dovrebbe passare il segmento locale dell'oleodotto che nella sua interezza misura 2.047 chilometri.
Considerata sacra dai Sioux, questa terra è inoltre ricca di falde acquifere che garantiscono acqua potabile non solo alle tribù native. E ora tocca proprio a loro, pur decimati dall'alcolismo, dalla malnutrizione e dai suicidi dovuti alle pessime condizioni di vita causate dalla disoccupazione, difendere l'oro blu anche per gli usurpatori. Perché anche secondo Greenpeace International, questo oleodotto costruito dalla Dakota Access LLC potrebbe inquinare le riserve idriche.
Qualche giorno fa i più autorevoli media statunitensi e inglesi, nel sottolineare il conflitto di interessi in cui sarà coinvolto il neo presidente Trump, che ha investito circa un milione di dollari nella Energy Transfer Partners, la casa madre della Dakota Access LLC. Kelcy Warren, l'amministratore delegato della società non a caso si è detto “fiducioso al 100 per cento che l'oleodotto verrà costruito sotto la nuova amministrazione”. L'entourage di Trump ha smentito dicendo che il magnate-presidente ha già venduto le proprie quote. Phyllis Young, una delle fautrici della protesta vorrebbe però vedere le carte, pur restando il fatto che, Trump o non Trump, l’opera non s'ha da completare perché “questo è territorio Lakota e a nessun altro, tranne a noi, appartiene la giurisdizione di queste terre”. Amnesty International ha denunciato in questi mesi la violazione del diritto costituzionale di protesta pacifica da parte delle autorità statali e gli arresti arbitrari oltre a numerosi episodi di violenza delle forze di sicurezza.
Un attivista ha perso un braccio e molti altri sono stati ricoverati per ipotermia e intossicazione dopo che la polizia e le guardie private della società costruttrice hanno usato cannoni ad acqua e polveri urticanti per sgomberare il campo. “La cosa che mi fa incazzare di più è che Obama ha fatto tante promesse ai nativi ma non ha bloccato questo oleodotto – dice Prince, un ragazzo di colore che da tre settimane sta manifestando con i nativi – solo Bernie Sanders, che avrei voluto votare, aveva dichiarato che questo ennesimo sopruso contro i nativi andava fermato.
Non solo perché è come se facessero passare un oleodotto in una chiesa o in un cimitero, ma perché potrebbe causare un disastro ambientale di cui milioni di americani subirebbero le conseguenze”. Nella serata di ieri l’US Army Corps of Engineers, l'Agenzia federale composta da civili e soldati che provvedono alla costruzione di infrastrutture nei territori sotto l'egida statale, hanno dichiarato di aver revocato l'ordine di sgombero forzato del campo previsto per il 5 dicembre. Intanto, oltre a un gruppo di soldati veterani di guerra e l'attrice Jane Fonda, anche il musicista Neil Young ha chiesto, attraverso il suo sito, al presidente Obama “di fermare immediatamente le violenze contro i pacifici protettori dell'acqua di Standing Rock”.
postilla
Il disinteresse per le popolazioni locali e i loro diritti, e per gli impatti ambientali; la benedizione da parte del governo nazionale a difesa di interessi unicamente privati; il ricorso alle forze dell'ordine pubbliche in sostituzione dei processi di confronto e partecipazione nelle scelte. Sono tutti scenari che in Italia abbiamo già sperimentato ma che il referendum del 4 dicembre sulla riforma/de-forma costituzionale ha intenzione di istituzionalizzare.
Gli eventi riportati nell'articolo accadono negli Stati Uniti d'America, da molti osannati come la più grande democrazia del mondo. Emerge dalle cronache quotidiane come la democrazia americana non sia affatto perfetta, ma nonostante ciò nessun politico statunitense si è mai permesso di bollare la propria Costituzione come vecchia (anche se è più antica della nostra di oltre 150 anni), da rottamare, da modernizzare per rendere la propria nazione più competitiva (si legga attraente) nel mondo globalizzato.
Per migliorare la nostra democrazia e il governo (non la governabilità) della nostra nazione non occorre una riforma della Carta ma sarebbe sufficiente la piena applicazione dei suoi principi fondamentali contenuti nei primi 12 articoli.

Mentre si procede a tappe forzate verso la legittimazionedella più grande variante in deroga nella storia dell’urbanistica milanese, una lucida riflessione critica sulla perdurante latitanzadell’amministrazione locale che non fa quello che le compete. Arcipelago Milano, 29 novembre 2016 (m.c.g.)
Chi viene dafuori, se vuol capire bene dove è arrivato, deve affidarsi alla saggezza deipopoli: i proverbi. Chi viene a Milano ne ha a disposizione moltissimi ma duesono fondamentali: “Var pussee un andàche cent andemm” e “Ofelè, fa el to mestè”, Arcipelago Milano,29novembre 2016.
“Varpussee un andà che cent andemm” – meglio andare che dirsi andiamo – è ilritratto dei milanesi sempre di corsa, spicci nelle loro decisioni. È questo ilmotto dell’attuale Giunta a proposito degli scali? O l’ansia di tener fede a unimpegno elettorale? Non lo so ma questa volta farei volentieri a meno di quelproverbio perché tutta questa fretta sugli scali è decisamente inspiegabile,salvo che Fs Sistemi Urbani non abbia avuto ordine dalla capogruppo diconsolidare un valore immobiliare che oggi non c’è fin tanto che l’accordo diprogramma non sarà sottoscritto dalle tre parti: Fs, Comune di Milano, RegioneLombardia. Fino a quel momento le aree non valgono nulla.
Vorreiricordare che l’approvazione di un accordo di programma comporta, a norma delcomma 6 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, la dichiarazione di pubblicautilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e che questi trerequisiti sono inscindibili. Vorrei sbagliarmi ma almeno l’indifferibilità el’urgenza non li vedo proprio, sopratutto nell’attuale situazione del mercatoedilizio e per le ragioni ben illustrate dalla ricerca condotta nel 2015 dalPolitecnico di Milano: «E infine i vincoli e le opportunità rintracciabili neiprofili amministrativi, dovendosi ancora precisare se l’attuazione degliinterventi opererà in variante o meno alla pianificazione vigente e quali sianole condizioni di fattibilità procedurale di eventuali “usi temporanei”. Lalunga prospettiva temporale della trasformazione, infine, che va ben oltrel’arco decennale di cogenza dello strumento pianificatorio – conformativo,suggerisce l’adozione di una strategia di “manutenzione continua e programmata”la cui gestione sia affidata a un qualificato Collegio di Vigilanza» (Bazzani).(1)
Vorrei anchericordare che gli accordi di programma costituiscono anche deroga allostrumento urbanistico in vigore e dunque un’eventuale adozione perpetua ilmalcostume, anche milanese, di procedere nella gestione urbanistica della cittàper varianti continue, rinviando sempre un’operazione complessiva di ridisegnourbano: quest’atteggiamento rispecchia forse l’inesistenza della cosiddetta“visione”, l’araba fenice della politica milanese. Spero che il tutto non siaqui
“Ofelè fael to mestè”. Questo proverbio invece fa proprio al caso nostro: bellosarebbe se ognuno facesse il proprio mestiere a cominciare da Ferrovie delloStato e non si impancasse a essere il pensatoio dell’urbanistica milanese.L’operazione Dagli scali, la nuova città è francamente imbarazzante perMilano perché mescola ruoli che dovrebbero essere ben distinti: che cosa vuoldire che FS Sistemi Urbani «promuove un processo partecipato, inclusivo ecollaborativo, di rigenerazione urbana sostenibile delle aree ferroviariedismesse nella città di Milano.»? In nome di chi? In sostituzione di unruolo che dovrebbe essere proprio dell’amministrazione comunale e dei suoiorganismi? Nell’interesse di chi? Suo evidentemente.
«Grazieal coinvolgimento di cinque team multidisciplinari [?] - otto architetti e unsociologo – guidati da architetti di fama internazionale, il processo siconclude con la presentazione di cinque scenari di sviluppo urbano». Eccoquel che vuol fare Fs Sistemi urbani. Il tutto con leggerezza vien classificatonella categoria “contributo alla discussione”. Io lachiamerei indebita pressione su un’amministrazione locale da parte dello Statonell’interesse di una sua Azienda, schierando in campo professionisti dirilievo per utilizzare la loro autorevolezza, o il ruolo giocato negliorganismi di categoria, a sostegno dei propri interessi travestiti da bene perla città.
Il tipo dibene da parte delle Ferrovie dello Stato verso Milano lo sperimentano tutte lemattine i viaggiatori che partono e arrivano alla Centrale (Grandi Stazioni)nel labirinto dei percorsi commerciali.
Saper fareil proprio mestiere: il Comune quello del committente nei confronti del mondodi tutte le professioni e i saperi, anche i più innovativi, ben sapendo che uncommittente deve sapere prima di tutto quello che vuole e quello che mette adisposizione in termini di risorse, conoscenze e aspettative, il suo software:il software politico costituito da un’idea di città, dalla conoscenzadei suoi bisogni, dalla sensibilità dei suoi desideri, dalla percezione dellesue opportunità, dei suoi diritti e dal confronto tra questi quattro elementi ela disponibilità di mezzi che fanno scegliere tra bisogni che si possono omeno, tra desideri realizzabili e, per finire, quali siano le opportunità dacogliere e i diritti da tutelare ad ogni costo.
Aiprofessionisti la cura dell’hardware senza debordare dal progetto versoil piano politico. Ai consulenti l’affinamento degli strumenti e l’eventualeallestimento di scenari e relativi modelli di simulazione: politicamenteneutrali.
(1) Nota a valle del Seminario “Un progetto per gli scali ferroviari milanesi” tenutosi lunedì 20 aprile 2015, presso il Politecnico di Milano