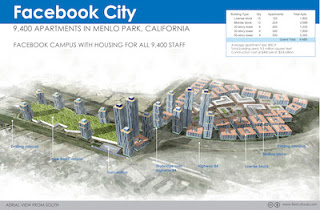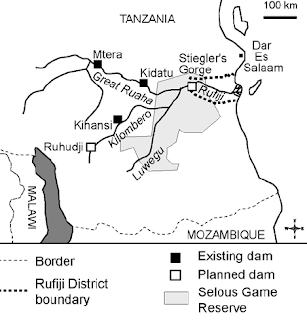L'inesorabile marcia dell'obsolescenza programmata, il potente strumento dell'ideologia e della prassi dello sviluppismo, la Peste dei nostri anni. comune-info.net, 14 luglio 2017, con riferimenti (p.d.)
«La costante sostituzione di merci utili per nessun altro motivo che la “modernità” è piuttosto evidente nell’industria dell’abbigliamento, nota come industria della “moda”. Ma l’obsolescenza programmata e sua sorella la pubblicità restano forze particolarmente potenti prima di tutto nell’alta tecnologia. Per questo dalla base non solo si moltiplicano ovunque le proposte per leggi sul diritto alla riparazione e campagne contro i Trattati di liberalizzazione del “libero scambio” (quelli che favoriscono le delocalizzazioni) ma si diffondono i “caffè di riparazione” non a fini di lucro. Queste iniziative locali rafforzano i valori della parsimonia e dell’autonomia erosi dal consumismo; collegano le persone con le loro comunità, ridimensionano l’uso di risorse e riducono la quantità di materiali gettati nelle discariche».
Un mio amico indiano racconta una storia riguardo all’aver guidato una vecchia Volkswagen Beetle dalla California alla Virginia durante il suo primo anno negli Stati Uniti. In una singolare tempesta di ghiaccio in Texas è finito fuori strada, lasciando l’auto col parabrezza rotto e portiere e parafanghi malamente ammaccati. Quando è arrivato in Virginia ha portato l’auto in una carrozzeria per una stima della riparazione. Il proprietario le ha dato un’occhiata è ha detto: “È irrecuperabile”. Il mio amico indiano è rimasto sconcertato: “Come può essere irrecuperabile? L’ho appena guidata fin qui dal Texas!”.
La confusione del mio amico era comprensibile. Anche se “irrecuperabile” suona come una specie di termine meccanico, è in realtà un termine economico: se il costo della riparazione è superiore a quanto varrà l’auto dopo, la sola scelta economica “razionale” è portarla dallo sfasciacarrozze e comprarne un’altra.
Nelle “società a perdere” del mondo industrializzato, questo è uno scenario sempre più comune: il costo di riparazione di stereo, elettrodomestici, utensili elettrici e apparecchi di alta tecnologia supera il prezzo di comprarne di nuovi. Tra i risultati di lungo termine ci sono crescenti pile di rifiuti elettronici, discariche che straripano e sprechi di risorse ed energia. È uno dei motivi per cui lo statunitense medio genera più del 70 per cento di rifiuti solidi in più rispetto al 1960. [1] E i rifiuti elettronici – i componenti più tossici degli scarti domestici – stanno aumentando quasi sette volte in più rispetto ad altre forme di rifiuti. Nonostante gli sforzi di riciclaggio, un numero di telefoni cellulari stimato in 140 milioni – contenenti metalli preziosi pari a 60 milioni di dollari in valore e una quantità di materiali tossici – sono gettati ogni anno nelle discariche statunitensi. [2]
Assieme a questi costi ambientali ci sono anche impatti economici. Non molto tempo fa la maggior parte delle cittadine statunitensi aveva calzolai, gioiellieri che aggiustavano orologi da polso e da tavolo, sarti che riparavano e modificavano vestiti e attività di riparazione che rimettevano a nuovo tostapane, televisioni, radio e dozzine di altri elettrodomestici casalinghi. Oggi la maggior parte di queste attività è scomparsa. “È un commercio moribondo”, ha detto il proprietario di un negozio di riparazione di elettrodomestici del New Hampshire. “Elettrodomestici di basso livello che si possono comprare per 200 o 300 dollari sono fondamentalmente apparecchi a perdere”. [3] La storia è simile per altre attività di riparazione: negli anni ’40, ad esempio, gli Stati Uniti ospitavano circa 60.000 calzolai, un numero ridottosi a meno di un decimo oggi. [4]
Un motivo di questa tendenza è la globalizzazione. Le imprese hanno delocalizzato le loro attività di fabbricazione a paesi a bassi salari, rendendo le merci artificialmente a basso prezzo quando vendute nei paesi a salari più elevati. Quando quelle merci devono essere riparate, non possono essere rispedite in Cina o in Bangladesh, devono essere riparate dove i salari sono più elevati e le riparazioni sono perciò più costose. Il mio amico è rimasto confuso riguardo alla condizione della sua auto perché in India c’è la situazione contraria: la manodopera è a basso costo mentre sono costose le merci importate e nessuno si sognerebbe di buttare un’auto che potrebbe essere riparata.
È allettante scartare il declino delle riparazioni in occidente come un danno collaterale – semplicemente un altro costo non intenzionale della globalizzazione – ma l’evidenza suggerisce che in realtà è una conseguenza intenzionale. Per comprendere il perché è utile guardare alle particolari necessità del capitale nell’economia della crescita globale, necessità che hanno determinato la creazione della cultura consumistica appena più di un secolo fa.
Quando la prima auto Modello T uscì dalla catena di montaggio di Henry Ford nel 1910, gli industriali compresero che la tecnica poteva essere applicata non solo alle auto ma a quasi ogni altro prodotto fabbricato, rendendo la produzione di massa possibile in dimensioni in precedenza inimmaginabili. Il potenziale di profitto era praticamente illimitato, ma c’era un inghippo: non aveva senso produrre milioni di articoli – non importa quanto a basso costo – se non c’erano abbastanza compratori per essi. E nella prima parte del ventesimo secolo la maggioranza della popolazione – classe lavoratrice, rurale e varia – aveva scarso reddito disponibile, una vasta gamma di imposte e valori che imponevano frugalità e autosufficienza. Il mercato di merci manifatturiere era largamente limitato alle classi media e alta, gruppi troppo piccoli per assorbire una produzione di massa a tutto gas.
La pubblicità fu il primo mezzo cui l’industria ricorse per aumentare i consumi affinché corrispondessero all’enorme balzo della produzione. Anche se le pubblicità semplici erano in circolazione da generazioni non erano certo sofisticate come gli annunci nascosti di oggi. Attingendo alle idee di Freud la nuova pubblicità si concentrò meno sul prodotto e più sulla vanità e le insicurezze dei potenziali consumatori. Come segnala lo storico Stuart Ewen, la pubblicità contribuì a sostituire i consolidati valori statunitensi che sottolineavano la parsimonia con nuove norme basate su consumi cospicui. La pubblicità, a quel punto di portata nazionale, ha anche contribuito a cancellare differenze regionali ed etniche tra le diverse popolazioni locali degli Stati Uniti, imponendo in tal modo gusti di massa adatti alla produzione di massa. Mediante tecniche di commercializzazione sempre più sofisticate ed efficaci, dice Ewen, “gli eccessi sostituirono la parsimonia come valore sociale” e intere popolazioni furono investite di “un desiderio psichico di consumare”. [5]
In altri termini, era nata la cultura consumistica moderna, non come risposta all’avidità umana innata o alla domanda dei clienti, bensì alle necessità del capitale industriale.
Nel corso della Grande Depressione i consumi non riuscirono a tenere il passo con la produzione. In un circolo vizioso, la sovrapproduzione portò a fabbriche chiuse, lavoratori persero il posto e la domanda di produzione industriale scese ulteriormente. In tale crisi del capitalismo, nemmeno la pubblicità più ingegnosa avrebbe potuto stimolare i consumi in misura sufficiente a rompere il circolo.
Nel 1932 una nuova soluzione fu proposta da un mediatore immobiliare di Bernard London. Il suo opuscolo “Por fine alla depressione mediante l’obsolescenza programmata” plaudiva agli atteggiamenti di consumatori che la pubblicità aveva creato durante gli anni ’20, un periodo nel quale “il popolo statunitense non aspettava fino a quando da qualsiasi bene fosse ricavata l’ultima briciola di utilità. Sostituiva gli articoli vecchi con nuovi per motivi di moda e di modernità. Rinunciava alle case e alle auto vecchie ben prima che fossero logore” [6]. Al fine di aggirare i valori di parsimonia e frugalità che si erano riaffacciati durante la Depressione, London sosteneva che il governo doveva “registrare l’obsolescenza dei beni capitali e di consumo all’epoca della loro produzione … Dopo che il tempo assegnato era scaduto, quelle cose sarebbero legalmente ‘morte’ e sarebbero controllate dall’agenzia debitamente nominata dal governo e distrutte” [7]. La necessità di sostituire tali prodotti ‘morti’ avrebbe assicurato che la domanda sarebbe rimasta per sempre alta e che il pubblico – indipendentemente da quanto parsimonioso o soddisfatto dai suoi beni materiali – avrebbe continuato a consumare.
L’idea di London non attecchì immediatamente e la Depressione alla fine terminò quando le fabbriche inattive furono convertite alla produzione di armi e munizioni per la seconda guerra mondiale. Ma il concetto di obsolescenza programmata non scomparve. Dopo la guerra il suo maggior promotore fu il progettista industriale Brooks Stevens, che la considerò non come un programma governativo bensì come una caratteristica integrale della progettazione e della commercializzazione. “Diversamente dall’approccio europeo del passato che cercava di produrre il bene assolutamente migliore e farlo durare per sempre”, disse, “l’approccio negli Stati Uniti consiste nel rendere il consumatore statunitense insoddisfatto del prodotto che gli è piaciuto usare e … [e fargli voler] ottenere il nuovissimo prodotto con l’aspetto più nuovo possibile” [8].
La strategia di Brooks fu abbracciata da tutto il mondo industriale ed è tuttora in vigore oggi. Accoppiata a una pubblicità mirata a rendere i consumatori inadeguati e insicuri se non hanno il prodotto più recente o gli abiti alla moda al momento, l’enigma del parallelismo dei consumi con una produzione sempre crescente è stato risolto.
La costante sostituzione di merci altrimenti utili per nessun altro motivo che la “modernità” è più chiara all’apice dell’industria dell’abbigliamento, significativamente nota come industria della “moda”. Grazie al costante fuoco di sbarramento di messaggi mediatici e pubblicitari, persino i ragazzi più giovani temono di subire l’ostracismo se indossano abiti che non sono “fighi” abbastanza. Le donne, in particolare, sono state indotte a sentire che saranno sottovalutare se i loro abiti non sono sufficientemente all’ultimo grido. Non è solo la pubblicità che trasmette questi messaggi. Una delle trame di un episodio della serie televisiva degli anni ’90 “Seinfeld” aveva per protagonista una donna che commette il passo falso di indossare in diverse occasioni lo stesso abito, resa oggetto di una quantità di risate preregistrate. [9]
L’obsolescenza è stata una forza particolarmente potente nel mondo dell’alta tecnologia, dove l’arco di vita limitato delle apparecchiature digitali è spesso la conseguenza più dell’”innovazione” che del malfunzionamento. Con la potenza di calcolo raddoppia ogni diciotto mesi per molti decenni (un fenomeno così affidabile da essere noto come legge di Moore) i prodotti digitale diventano rapidamente obsoleti: come ha scritto uno scrittore di tecnologia: “In due anni il vostro nuovo smartphone potrebbe essere poco più che un fermacarte” [10]. Con i pubblicitari che bombardano il pubblico di annunci che affermano che questa generazione di smartphone è la definitiva per velocità e funzionalità, il tipico utente di cellulari acquista un telefono nuovo ogni ventuno mesi [11]. Superfluo dirlo: questo è grandioso per l’ultima riga del bilancio delle imprese dell’alta tecnologia, ma tremendo per l’ambiente.
L’innovazione può essere il mezzo principale attraverso il quale i prodotti di alta tecnologia sono resi obsoleti, ma i produttori non disdegnano l’uso di altri metodi. La Apple, ad esempio, rende intenzionalmente i propri prodotti difficili da riparare, salvo per la stessa Apple, in parte rifiutando di fornire informazioni sulle riparazioni riguardo ai propri prodotti. Poiché il costo della riparazione in fabbrica spesso si avvicina al costo di un prodotto nuovo, la Apple si assicura un sano flusso di entrate indipendentemente da ciò che il cliente decide di fare.
La Apple si è spinta anche oltre. In una causa collettiva contro la società è stato rivelato che gli iPhone 6 della società sono programmati per smettere di funzionare – in gergo “murati” – quando gli utenti li fanno riparare in laboratori non autorizzati (e meno costosi). “Non hanno mai rivelato che il vostro telefono potrebbe essere murato dopo riparazioni semplici”, ha detto un avvocato dei querelanti. “La Apple aveva intenzione … di forzare tutti i suoi consumatori a comprare prodotti nuovi semplicemente perché si recavano in un laboratorio di riparazione” [12].
In reazione a questa furfanteria dell’industria un certo numero di stati ha cercato di approvare leggi sulla “riparazione equa” che aiuterebbero i laboratori indipendenti a ottenere le parti e gli strumenti diagnostici di cui hanno bisogno, nonché gli schemi di come i dispositivi sono assemblati. Una legge simile è già stata approvata dal Massachusetts per agevolare i riparatori di auto indipendenti e agricoltori del Nebraska stanno lavorando per far approvare una legge simile relativa alle macchine agricole. Ma, eccettuata la legge del Massachusetts, una pesante attività di pressione dei fabbricanti – dalla Apple all’IBM a gigante delle macchine agricole John Deere – ha sinora ostacolato l’approvazione di leggi sul diritto alla riparazione. [13]
Dalla base un’altra reazione è stata l’ascesa di “caffè di riparazione” non a fini di lucro. Il primo è stato organizzato ad Amsterdam nel 2009 e oggi ce ne sono più di 1.300 altri in tutto il mondo, ciascuno con strumenti e materiali per aiutare le persone ad aggiustare abiti, mobili, elettrodomestici, biciclette, vasellame e altro, assieme a volontari specializzati che possono offrire aiuto, se necessario [14]. Queste iniziative locali non solo rafforzano i valori della parsimonia e dell’autonomia intenzionalmente erosi dal consumismo; collegano le persone con le loro comunità, ridimensionano l’uso di risorse ed energia scarse e riducono la quantità di materiali tossici gettati nelle discariche.
A un livello più sistemico c’è un urgente bisogno di mettere le redini al potere dell’industria ridisciplinando il commercio e la finanza. Trattati di liberalizzazione del “libero scambio” hanno dato alle imprese la capacità di localizzare le loro attività dovunque nel mondo, contribuendo ai prezzi distorti che rendono più economico comprare prodotti nuovi piuttosto che riparare quelli vecchi. Questi trattati rendono anche più facile per le imprese penetrare non solo le economie del Sud globale, ma anche la psiche delle loro popolazioni, contribuendo a trasformare miliardi di altre persone autonome in consumatori insicuri avidi dei beni standardizzati, prodotti in massa dall’industria. La diffusione della cultura consumistica può aiutare il capitale globale a soddisfare la sua necessità di una crescita infinita, ma certamente distruggerà la biosfera; il nostro paese non è in grado di sostenere sette miliardi di persone che consumano al ritmo folle del nostro mondo “sviluppato”, e tuttavia tale obiettivo è implicito nella logica dell’economia globale.
Dobbiamo anche opporci – con le parole e gli atti – alle forze del consumismo nelle nostre stesse comunità. La cultura consumistica globale non è solo motore del cambiamento climatico, dell’estinzione di specie, di zone oceaniche morte e di molte altre aggressioni alla biosfera; alla fine non soddisfa reali bisogni umani. Il prezzo della cultura consumistica non si misura in beni a buon prezzo che riempiono le nostre case e poi, sin troppo presto, la discarica più vicina. Il suo costo reale è misurato in termini di patologie alimentari, epidemie di depressione, accresciuta conflittualità sociale e tassi crescenti di dipendenza, non solo dagli oppiacei, ma dagli ‘acquisti’, dai videogiochi e da Internet.
È ora di concepire – e compiere passi per creare – un’economia che non distrugga le persone e il pianeta solo per soddisfare gli imperativi di crescita del capitale globale.
NOTE
[1] EPA Report on the Environment, Municipal Solid Waste, https://cfpub.epa.gov/roe/indicator_pdf.cfm?i=53; Center for Sustainable Systems, “Municipal Solid Waste Factsheet,” http://css.snre.umich.edu/factsheets/municipal-solid-waste-factsheet
[2] National Public Radio, “The Continent that Contributes the Most to E-Waste is…”, January 26, 2017. http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2017/01/26/511612133/the-continent-that-contributes-the-most-to-e-waste-is
[3] “Irreparable Damage”, Washington Times, Jan 9, 2007. http://www.washingtontimes.com/news/2007/jan/9/20070109-121637-4917r/
[4] Morris, Natalie, “Fewer shoe repair shops mean business for those remaining”, Wall Street Journal, March 5, 2012. http://www.sj-r.com/x1644228326/; “Shoe Repair in the US: Market Research Report”, IBIS World, Apr 2017, https://www.ibisworld.com/industry-trends/market-research-reports/other-services-except-public-administration/repair-maintenance/shoe-repair.html
[5] Ewen, Stuart, Captains of Consciousness: Advertising and the Social Roots of the Consumer Culture(New York: McGraw-Hill, 1976).
[6] London, Bernard, 1932, “Ending the Depression Through Planned Obsolescence”. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/London_(1932)_Ending_the_depression_through_planned_obsolescence.pdf
[7] Ibid.
[8] Pyramids of Waste: The Light Bulb Conspiracy, 2010, a documentary film by Cosima Dannoritzer. Viewed at FilmsforAction.org. http://www.filmsforaction.org/watch/pyramids-of-waste-2010/
[9] Seinfeld, “The Seven”, episode 13, season seven. Aired February 1, 1996.
[10] Walton, Andy, “Life Expectancy of a Smartphone”, Houston Chronicle, http://smallbusiness.chron.com/life-expectancy-smartphone-62979.html
[11] ibid.
[12] Beres, Damon, and Andy Campbell, “Apple is Fighting a Secret War to Keep You from Repairing Your Phone”, Huffington Post, June 9, 2016. http://www.huffingtonpost.com/entry/apple-right-to-repair_us_5755a6b4e4b0ed593f14fdea
[13] Solon, Olivia, “A Right to Repair: Why Nebraska Farmers are Taking on John Deere and Apple”, The Guardian, March 6, 2017, https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/06/nebraska-farmers-right-to-repair-john-deere-apple. Beres, Damon, “Big Tech Squashes New York’s ‘Right to Repair’ Bill”, Huffington Post, June 17, 2016. http://www.huffingtonpost.com/entry/apple-right-to-repair_us_5755a6b4e4b0ed593f14fdea
[14] https://repaircafe.org/en/about/
Riferimenti

Crescono gli atti di ferocia delle amministrazioni locali contro chi non ha nulla. Togliere le panchine, tranne quelle destinate ai turisti, aumenta il degrado degli spazi pubblici e non risolve nessun problema. Ma porta voti. La Nuova Venezia, 16 luglio 2017 (p.s.)«San Donà. Continua l’emergenza casa anche per i residenti Appello di un 50enne che vive da oltre cinque mesi in auto. Via le panchine, ma i senzatetto restano davanti all’ospedale di via Nazario Sauro. E non solo in questa zona della città».
Un’emergenza che si è aggravata dall’inizio dell’estate. Tanti indigenti, spesso stranieri, ma anche italiani, stanno girando senza meta in città, chi a chiedere l’elemosina chi a importunare la gente a causa della propria disperazione e solitudine. Un cittadino stranieri è stato più volte controllato dalla polizia locale, dopo che è anche entrato in chiesa durante una messa a gridare. La situazione è complessivamente sotto controllo, ma potrebbe peggiorare anche perché tante famiglie non hanno i soldi per mutui e affitti, gli sfratti sono sestuplicati in pochi anni.
Intanto, infuria la polemica dopo che il vicesindaco, Luigi Trevisiol, ha deciso di eliminare le quattro panchine di via Nazario Sauro in cui trovavano giaciglio un paio di senzatetto ogni notte. «Per me era una questione di sicurezza e ordine pubblico», ha detto, «adesso diventa un problema sociale che va risolto al di là delle polemiche e strumentalizzazioni». Ad attaccarlo, la Lega Nord, con il vice governatore del Veneto, Gianluca Forcolin, che ha parlato di brutta imitazione del sindaco Gentilini a Treviso, poi Fratelli d’Italia, molto critica, e Sinistra Italiana che ha attaccato l’amministrazione per non aver risolto il problema. Anna Maria Babbo di Scegli Civica ha evidenziato il tentativo di sorpasso a destra della Lega da parte di Trevisiol e della giunta di centrosinistra.
Poi ci sono situazioni al limite, come quella di Daniele Rossi, 50enne veneziano, che dorme da oltre cinque mesi in auto, vicino al pronto soccorso: «Chiedo aiuto, non ce la faccio più. Adesso per il caldo, d’inverno per il gelo, non so dove andare». Spesso le soluzioni sono difficili da trovare e anche quelle suggerite dal Comune e i servizi sociali non combaciano con le esigenze di chi vorrebbe un’abitazione tutta per sé e non può realizzare questo sogno.
Le abitazioni comunali o dell’Ater non sono in quantità sufficiente per il momento e la burocrazia complica le cose per le assegnazioni. Il sindaco, Andrea Cereser, sta riflettendo sul problema ormai da tempo. «L’emergenza dei senzatetto», spiega, «riguarda purtroppo ogni città sopra un certo numero di abitanti. Noi non possiamo passare davanti a famiglie che hanno diritto di avere una casa perché partecipano a determinate graduatorie e selezioni previste per legge. Una soluzione dovrà essere trovata, anche se di certo non possiamo scavalcare chi ha maturato dei diritti per legge»
 l'Espresso, 15 luglio 2017 (c.m.c.)
l'Espresso, 15 luglio 2017 (c.m.c.)
Il Pd di Berlusconi, pardon, il Pdl ha varato nel 2009 il famoso piano casa: più cemento per tutti, senza regole e senza piani urbanistici, sfruttando un sistema di aumenti automatici di volume per la massa dei fabbricati esistenti. Ora la giunta del Pd che governa la Sardegna progetta un inatteso bis, sotto forma di piano alberghi: via libera con un'apposita legge a nuove costruzioni turistiche, ecomostri compresi, perfino nella fascia costiera finora considerata inviolabile, cioè spiagge, pinete, scogliere e oasi verdi a meno di trecento metri dal mare.
Il programma di questo presunto centrosinistra sardo è di applicare proprio il sistema berlusconiano degli aumenti di volume in percentuale fissa (che premia con maggiori quantità di cemento i fabbricati più ingombranti) a tutte le strutture ricettive, belle o brutte, piccole o enormi, presenti o future, compresi ipotetici hotel non ancora esistenti. Una deregulation edilizia in aperto contrasto con la legge salva-coste approvata dieci anni fa dall'allora governatore Renato Soru e dal suo assessore all'urbanistica Gianvalerio Sanna, cioè con una riforma targata Pd che nel frattempo è stata presa a modello da una generazione di studiosi, architetti, urbanisti e amministratori pubblici non solo italiani.
La contro-riforma odierna è nascosta tra i cavilli del disegno di legge approvato il 14 marzo scorso dalla giunta regionale presieduta da Francesco Pigliaru, il professore di economia eletto nel 2014 alla testa del Pd. La normativa ora è all'esame finale della commissione per il territorio: l'obiettivo della maggioranza è di portare in consiglio regionale un testo blindato, da approvare in tempi stretti, senza modifiche, subito dopo l'estate.
Sulla carta avrebbe dovuto trattarsi della nuova legge urbanistica che la Sardegna attendeva da un decennio per completare la riforma di Soru, con impegni precisi: stop all'edilizia speculativa, obbligo per tutti i comuni di rispettare limiti chiari anche fuori dalla fascia costiera, per difendere tutto il territorio, fermare il consumo di suolo e favorire il recupero o la ristrutturazione dei fabbricati già esistenti.
All'articolo 31, però, spunta il colpo di spugna: «al fine di migliorare qualitativamente l'offerta ricettiva», si auto-giustifica il testo di legge, «sono consentiti interventi di ristrutturazione, anche con incremento volumetrico, delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive». Il concetto chiave è l'incremento volumetrico: la norma approvata dall'attuale giunta di centrosinistra, proprio come il piano-casa del governo Berlusconi, autorizza aumenti di cubatura del 25 cento «anche in deroga agli strumenti urbanistici» in vigore, compresa la legge salvacoste. Insomma, se siete in vacanza in una spiaggia immacolata della Sardegna, fatevi un bel bagno: potrebbe essere l'ultimo.
Hotel, alberghi, pensioni, residence, multiproprietà e lottizzazioni turistiche di ogni tipo vengono infatti autorizzati non solo a gonfiarsi di un quarto, cementificando nuovi pezzi di costa, ma anche a sdoppiarsi, spostando gli aumenti di volume in «corpi di fabbrica separati». «In pratica si può costruire un secondo hotel o residence in aggiunta al primo anche nella fascia costiera in teoria totalmente inedificabile», denuncia l'avvocato Stefano Deliperi, presidente del Gruppo d'intervento giuridico (Grig), che per primo ha lanciato l'allarme. «Ma non basta: i nuovi aumenti di volume si possono anche sommare agli incrementi autorizzati in passato, ad esempio con il piano casa o con le famigerate 235 deroghe urbanistiche che furono approvate tra il 1990 e il 1992 dall'allora giunta sarda», sottolinea il legale, che esemplifica: «Un hotel di 30 mila metri cubi che deturpa una spiaggia, per effetto dei due aumenti cumulativi del 25 per cento ciascuno, sale quasi a quota 50 mila: per l'esattezza, si arriva a 46.875 metri cubi di cemento».
L'ex presidente della Regione, Renato Soru, spiega all'Espresso di essere «molto preoccupato per la cecità di una classe dirigente che sta mettendo in pericolo il futuro della Sardegna». «Con l'assessore Sanna eravamo partiti da una constatazione pratica», ricorda Soru: «Grazie ad anni di studi e ricerche abbiamo potuto far vedere e dimostrare che più di metà delle coste della Sardegna, parlo di circa 1.100 chilometri di spiagge, erano già state urbanizzate e cementificate. Di fronte a una situazione del genere, in una regione come la nostra, qualsiasi persona di buonsenso dovrebbe capire che i disastri edilizi del passato non devono più ripetersi.
Oggi tutti noi abbiamo il dovere morale e civile di difendere un territorio straordinario che è la nostra più grande risorsa e la prima attrattiva turistica: le bellissime spiagge della Sardegna sono la nostra vera ricchezza, che va conservata e protetta per le generazioni future. Per questo la nostra legge prevede una cosa molto semplice e logica: nella fascia costiera non si costruisce più niente. Zero cemento, senza deroghe e senza eccezioni per nessuno. E in tutta la Sardegna bisogna invece favorire la riqualificazione dell'edilizia esistente, il rifacimento con nuovi criteri di troppe costruzioni orrende o malfatte. Quindi via libera alle ristrutturazioni, alle demolizioni e ricostruzioni, al risparmio energetico. Con regole certe e uguali per tutti, perché l'edilizia in Italia può uscire veramente dalla crisi solo se viene tolta dalle mani della burocrazia e della politica».
A questo punto Soru confessa di essere uscito dai palazzi della regione, alla fine della sua presidenza, proprio «a causa dei continui scontri sull'urbanistica». E dall'altra parte della barricata, a tifare per il cemento, non c'era solo il centrodestra, ma anche «quella parte del Pd che ora è al potere». Da notare che Soru, per eleganza o per imbarazzo, evita di fare il nome dell'attuale presidente, anche se sarebbe legittimato ad accusarlo di tradimento politico, visto che Pigliaru era stato suo assessore ai tempi della legge salva-coste.
Oggi però lo stop al cemento sulle spiagge più belle d'Italia rischia di trasformarsi in un bel ricordo. Gli avvocati del Grig hanno già catalogato «ben 495 strutture turistico-ricettive della fascia costiera che potrebbero approfittare dell'articolo 31. Stiamo parlando di milioni di metri cubi di cemento in arrivo», rimarca Deliperi, evidenziando che il disegno di legge ha una portata generale, per cui si applica anche, anzi soprattutto alle strutture più contestate, quelle che si sono meritate l'epiteto di ecomostri. Come il residence-alveare "Marmorata" di Santa Teresa di Gallura, l'albergone "Rocce Rosse" a picco sugli scogli di Teulada, la fallimentare maxi-lottizzazione turistica "Bagaglino" a ridosso delle spiagge di Stintino, i turbo-hotel "Capo Caccia" e "Baia di Conte" ad Alghero e troppi altri. Il premio percentuale infatti non dipende dalla qualità del fabbricato, ma dalla cubatura: più l'ecomostro è grande, più è autorizzato a occupare terreno vergine con nuove colate di cemento.
Il progetto di legge, per giunta, equipara agli alberghi da allargare, e quindi trasforma in volumi gonfiabili di cemento, addirittura le «residenze per vacanze», sia «esistenti» che ancora «da realizzare», cioè quelle montagne di seconde case che restano vuote quasi tutto l'anno, arricchiscono solo gli speculatori edilizi, ma deturpano per sempre il paesaggio. Con la nuova dirigenza del Pd, insomma, il vecchio piano casa è diventato un piano seconde case, secondi alberghi e seconde lottizzazioni. E tutto questo in Sardegna, la regione-gioiello che tra il 2004 e il 2006 aveva saputo cambiare il clima politico e culturale sull'urbanistica, spingendo decine di amministrazioni locali di mezza Italia a imitare la legge Soru, fermare il consumo di suolo e limitare finalmente uno sviluppo edilizio nocivo e insensato.
Gianvalerio Sanna, l'ex assessore regionale oggi relegato a fare politica nel suo comune d'origine, ama parlar chiaro: «Questo disegno di legge è una vera porcata. La giunta del Pd sta facendo quello che non era riuscito a fare il governo di centrodestra. Le nostre norme, ancora in vigore, favoriscono con incentivi e aumenti di volume solo la demolizione e lo spostamento dei fabbricati fuori dalla fascia costiera dei 300 metri. Questo vale già adesso anche per gli alberghi e i campeggi. Per allargarli e rimodernarli con criterio non c'è nessun bisogno di cementificare le spiagge».
I dati sono allarmanti già oggi. «Le coste della Sardegna sono invase da oltre 210 mila seconde case: appartamenti sfitti, che mediamente restano disabitati per 350 giorni all'anno», enumera Sanna: «Il nostro obiettivo, condiviso da migliaia di cittadini che proprio per questo hanno votato Pd alle elezioni regionali, era di liberare dal cemento, gradualmente e armonicamente, tutta la zona a mare, che è la più preziosa. La nuova giunta sta facendo il contrario. L'edilizia è tornata merce di scambio: il piano casa, che fu giustificato da Berlusconi come rimedio eccezionale contro la crisi dell'edilizia, diventa la norma. La deroga diventa la regola. Così la politica si mette al servizio delle grandi lobby, degli interessi di pochi, a danno della cittadinanza e di tutte le persone che amano la Sardegna».
Quando allude a scambi, Sanna non usa parole a caso. Nella minoranza del Pd rimasta fedele a Soru sono in molti a evidenziare una singolare coincidenza: la controriforma urbanistica sta nascendo proprio mentre gli sceicchi del Qatar, i nuovi padroni miliardari della Costa Smeralda, annunciano l'ennesima ondata di progetti edilizi per super ricchi, per ora bloccati proprio dalla legge Soru. Per ingraziarsi la classe politica sarda, lo stesso gruppo arabo ha comprato dal crac del San Raffaele anche il cantiere fallimentare del nuovo ospedale di Olbia. E ora gli sceicchi sembrano aspettarsi che i politici, in cambio, aboliscano proprio i vincoli ambientali sulla costa.
«Con questa legge vergognosa il presidente Pigliaru sta contraddicendo anche se stesso», commenta amaramente Maria Paola Morittu, la combattiva avvocata di Cagliari che oggi è vicepresidente nazionale di Italia Nostra: «Per smentire la sua giunta, al professor Pigliaru basterebbe rileggere le proprie pubblicazioni accademiche, in cui scriveva e dimostrava che il consumo di suolo è disastroso non solo per l'ambiente, per il paesaggio, ma anche per lo sviluppo economico».
Carte alla mano, l'avvocata di Italia Nostra e il suo collega Deliperi passano in rassegna la successione di leggi edilizie della Sardegna, per concludere che oggi il Pd sardo sta facendo indietro tutta. La buona urbanistica insegna come e dove costruire case sicure in luoghi vivibili senza distruggere il territorio. In Italia se ne parla solo quando si contano le vittime evitabili di alluvioni, frane, valanghe, terremoti e altri disastri che di naturale hanno solo le cause immediate.
In Sardegna, dopo decenni di edilizia selvaggia, la legge Soru e il conseguente piano paesaggistico regionale – studiato da un comitato tecnico-scientifico presieduto da Edoardo Salzano, un gigante dell'urbanistica – hanno fissato per la prima volta due principi fondamentali: basta cemento a meno di 300 metri dal mare; solo edilizia regolata e limitata in tutta la restante fascia geografica costiera, che di norma si estende fino a tre chilometri dalle spiagge. «In campagna elettorale il Pd guidato da Pigliaru aveva promesso di estendere la legge Soru a tutta la Sardegna, obbligando anche i comuni interni ad applicare i piani paesaggistici», osservano desolati i due avvocati. Passate le elezioni, il vento è cambiato.
In Italia, prima della recessione, venivano cementificati a norma di legge oltre 45 milioni di metri quadrati di terra all'anno. Nel 2015, nonostante la crisi, si è continuato a costruire nuovi appartamenti e capannoni per oltre 12 milioni di metri quadrati (dati Istat). «Con la legge salvacoste la Sardegna ha saputo lanciare un nuovo modello di sviluppo sostenibile», rivendica Soru. Ora la grande retromarcia della giunta seduce le lobby dei grandi albergatori, che organizzano convegni esultanti contro «l'ambientalismo che danneggia il turismo». Resta però da capire se, alle prossime elezioni, la maggioranza dei cittadini sardi si fiderà ancora di un Pd che imita il berlusconismo, col rischio di riabilitaro
 «Vivere nell’emergenza significa inseguire gli eventi, farsi coinvolgere e trasportare come una canna al vento da ciò che accade ». il manifesto, 14 luglio 2017 (c.m.c.)
«Vivere nell’emergenza significa inseguire gli eventi, farsi coinvolgere e trasportare come una canna al vento da ciò che accade ». il manifesto, 14 luglio 2017 (c.m.c.)
Vorrei scrivere un articolo sugli incendi a gennaio, in mezzo alla neve, quando è il momento per pensarci seriamente ed attrezzarsi. Come fa l’industria della moda, che presenta i nuovi abiti una stagione prima, come succede in generale in un’ impresa di medie dimensioni che programma le innovazioni. E invece se ne parla d’estate, come è successo tante volte in passato: nel 2001, nel 2003, la peggiore stagione per gli incendi in Europa, nel 2007 e nel 2010.
Ogni estate gli incendi, un fenomeno sociale e non naturale (non esiste l’autocombustione se non in circostanze eccezionali), colpisce il nostro paese distruggendo foreste, macchia mediterranea e terreni coltivati, ma l’opinione pubblica se ne accorge solo quando viene superata una certa soglia e scatta la parola magica: emergenza.
Vivere nell’emergenza significa inseguire gli eventi, farsi coinvolgere e trasportare come una canna al vento da ciò che accade. Il termine “emergenza” evoca situazioni eccezionali, abnormi, destinate a suscitare paura e preoccupazione generale.
E serve, in primo luogo, a spostare l’attenzione dell’opinione pubblica, a bloccare o a rallentare quel processo di obsolescenza dell’informazione, a riportare verso l’alto la curva di Vernon applicata alla merce “informazione”.
E così si è parlato di “emergenza” per: il maltempo, il terrorismo, la disoccupazione giovanile, l’inflazione (anni ’70), la deflazione (in questo decennio), la radioattività, i terremoti, la siccità, le alluvioni, l’immigrazione (over all), e chi più ne ha più ne metta.
Emergenza e normalità si scambiano spesso le parti: ciò che sarebbe normale in quanto conseguenza di un certo modello di sviluppo diventa eccezionale, e viceversa ciò che è eccezionalmente grave e insostenibile (come la corsa agli armamenti o il salvataggio delle banche mentre una parte rilevante della popolazione vive sotto la soglia di povertà) diviene del tutto scontato e regolare. E’ normale che siano morti 6 milioni di congolesi per guerre intestine e fame nell’ultimo decennio, o centinaia di migliaia di yemeniti vittime di una guerra devastante quanto ignorata dai media, ed invece è «emergenza sempre più urlata ogni sbarco di migranti sulle nostre coste.
Scriveva profeticamente un noto politologo nordamericano : «L’esistenza di emergenze da fronteggiare è per la classe politica nel suo insieme condizione della sua stessa esistenza : l’unico mezzo per conquistare spazio e legittimità e contrastare il declino della partecipazione politica, la crisi delle ideologie, la tendenziale omogenizzazione dei partiti, la concorrenza rappresentata dalla molteplicità degli stimoli e delle informazioni» (A. Wolfe, 1981).
E così accade che ogni volta, all’arrivo di un’estate più calda del solito, all’estendersi delle terre bruciate dal fuoco, per qualche giorno tutti si occupano degli incendi per poi voltare pagina e dimenticarsene fino alla prossima, bollente estate.
Personalmente questo fatto mi è ancora più insopportabile per avere sperimentato con successo, nel Parco nazionale dell’Aspromonte, un metodo di lotta agli incendi che costa poco ed è efficace. In passato ne parlarono tutti i telegiornali nazionali ed i principali organi di stampa, ma senza che servisse a modificare l’approccio prevalente. Si tratta di un principio semplice: ricreare quel rapporto tra popolazione e territorio, che c’era in passato prima dello spopolamento delle campagne e montagne, attraverso i «contratti di responsabilità territoriale» che puntano ad uno spegnimento immediato dei fuochi. Recita un proverbio francese più o meno così : per spegnere un incendio dopo dieci secondi basta un bicchiere d’acqua, dopo un minuto ci vuole un secchio d‘acqua, dopo un’ora bisogna chiamare i pompieri.
Contratti di responsabilità territoriale che avevamo esteso anche alla raccolta rifiuti nei boschi, ma che dal 2005, quando il ministro Matteoli mandò un commissario, furono cancellati con la motivazione esilarante: di incendi e rifiuti se ne deve occupare la Regione Calabria. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: le foreste aspromontane sono ridotte a pattumiera ed il controllo degli incendi con il metodo della responsabilità territoriale è ripreso solo negli ultimi anni, ma con un budget fortemente ridotto.
Dopo la tragedia del 2003 che causò oltre 25000 morti in Francia per l’anomala ondata di calore e provocò incendi spaventosi dal Portogallo fino all’Italia e Grecia, fui invitato a Bruxelles da una Commissione istituita ad hoc, che espresse grande interesse per il metodo Aspromonte, me lo rinnovò nel 2005 e poi non ne seppi più niente.
Non si tratta di un metodo perfetto, ma perfettibile, che nel tempo ha aggiunto al coinvolgimento delle associazioni ambientaliste e di protezione civile quello di un rapporto di responsabilità con contadini e pastori nella difesa territoriale.
E’ una sfida che ci riguarda tutti ma che richiede una uscita/liberazione dalla catena delle emergenze. Abbiamo bisogno di programmare la difesa territoriale in tutti i campi, tenendo conto che registreremo sempre più “eventi estremi” legati al mutamento climatico in corso con cui fare i conti. E’ un’altra politica unitamente ad un’altra informazione , che non stia solo sul pezzo, quella di cui abbiamo estrema necessità.
 «Intervista realizzata il 29 giugno a Bologna, dove Harvey era presente per la Summer School "Sovereignty and Social Movements"organizzata dall’Academy of Global Humanities and Critical Theories». connessioniprecarie, 14 luglio 2017 (c.m.c)
«Intervista realizzata il 29 giugno a Bologna, dove Harvey era presente per la Summer School "Sovereignty and Social Movements"organizzata dall’Academy of Global Humanities and Critical Theories». connessioniprecarie, 14 luglio 2017 (c.m.c)
Cominciamo dalle origini della tua elaborazione, che parte da Cambridge ‒ dove non ti muovevi all’interno di un approccio marxiano – e a fine anni Sessanta muove sulla sponda opposta dell’Atlantico, a Baltimora. Qui hai modo di osservare la scaturigine o l’affermarsi di un plesso di processi che negli anni a venire e sino a oggi formano i principali vettori di analisi dell’urbano. Baltimora è infatti piuttosto emblematica per quanto riguarda i processi di razzializzazione inscritti nella geografia urbana e le forme di conflitto che a essi si accompagnano, come nei riot dei Sessanta «riapparsi» nel 2015 dopo la morte di Freddie Gray; è una tipica città duramente segnata dalla post-industrializzazione; caso emblematico di gentrification del centro cittadino col rifacimento del porto; nonché esempio iconico di sprawl urbano nella cosiddetta BA-WA, la metropoli diffusa che lega Baltimora a Washington. Sono questi elementi che ti conducono a concentrarti sulla «città» quale lente analitica privilegiata, tanto da arrivare anni dopo a dichiarare che «il mio obiettivo è la comprensione dei processi urbani sotto il capitalismo»?
come mai decidi di dedicarti allo studio di Marx e di usarlo assieme alla città quali framework della tua analisi? C’entra forse l’analisi di Henri Lefebvre?
«Sono andato a Baltimora un po’ perché ero interessato alle lotte sociali che erano in corso nelle zone urbane degli Stati Uniti nel corso degli anni Sessanta, mentre era in pieno svolgimento quella che veniva definita come Urban Crisis. Quella era davvero una crisi, o volendo una serie integrata di crisi, che toccava l’urbano così come i soggetti dimenticati e marginalizzati, la questione razziale… Quindi sono partito con l’idea di curvare il mio lavoro verso la ricerca urbana.
«Quando sono arrivato stavano succedendo anche molte altre cose: il movimento conto la guerra, il movimento per i diritti civili… Erano tempi duri per la storia americana, ed era impossibile non rimanere coinvolti in quel contesto. E io rimasi profondamente coinvolto in quanto stava avvenendo a Baltimora, in particolare nel 1968 dopo l’assassinio di Martin Luther King, quando gran parte della città venne data alle fiamme, venne in pratica cacciato il governo civile dalla città e ci fu un’occupazione militare della città.
Ci fu davvero un’insurrezione della popolazione, non solo a Baltimora ma anche a Los Angeles, Detroit, Chicago, dappertutto. Ho dunque cominciato a sviluppare dei progetti di ricerca per l’università per comprendere le condizioni che avevano portato a questa eruzione. Mi confrontai col problema di come scrivere di quei fenomeni in un modo che avesse un qualche senso, accorgendomi che la maggior parte dei discorsi proposti dalle scienze sociali di fatto non funzionava, parlando sia degli studi sociologici, sia di quelli economici o psicologici.
«Quindi andai alla ricerca di altri framework interpretativi, e assieme ad alcuni studenti decidemmo di leggere Marx per vedere se poteva avere una qualche utilità. Quindi cominciai a leggerlo, scrivendo dei testi sulla questione abitativa della città, adoperando alcuni suoi concetti come quelli di "valore d’uso" e "valore di scambio", e mi accorsi che le categorie che si possono prendere da Marx potevano essere davvero utili per spiegare la situazione. Fu davvero interessante che, iniziando a scrivere numerosi rapporti di ricerca con un linguaggio marxista e presentandoli a banchieri, persone della finanza o delle istituzioni, tutti mi dicevano che erano lavori eccellenti (perché non sapevano che venivano da Marx!).
«Fu lì che capii definitivamente che Marx aveva ragione e dunque proseguii in quella direzione, facendo lentamente emergere il progetto dello sviluppo di un approccio marxista all’urbanizzazione, cosa per nulla comune al tempo se non per qualche sociologo francese come Henri Lefebvre, ma io a quel tempo non l’avevo ancora letto. Conoscevo Manuel Castells e lo incontrai nel 1967, cosa che mi aiutò a conoscere ciò che stava accadendo in Francia a quel tempo. Tutto ciò mi ha portato alla pubblicazione del mio primo libro, Social Justice and the City, che è diviso tra una parte formulata in termini liberali e una marxista. […] Baltimora era una città industriale quando arrivai lì e la classe operaia bianca impiegata nei motori, nell’acciaio, nella costruzione di navi era molto sindacalizzata e stava piuttosto bene, potendosi permettere la casa nei suburb e uno stile di vita piuttosto privilegiato.
«Questa suburbanizzazione era intrecciata a una politica reazionaria legata a doppio filo a una dimensione razzista, implicata in ciò che stava accadendo nel centro città – che veniva letto sostanzialmente come un’insorgenza razziale. In parte ovviamente lo era, ma più che altro quel fenomeno indicava una divisione all’interno della working class tra pezzi di classe operaia bianca privilegiata e tutto il resto, che veniva lasciato davvero molto indietro».
Hai fatto accenno a Castells, e mi pare interessante il fatto che tra voi due ci sia una sorta di parallelismo, anche se segnato da nette e molteplici divergenze. Il primo tuo libro di cui parlavi segue di un anno La questione urbana di Castells (1972). Nel 1989 escono due vostri testi ‒ The Urban Experience (Harvey) e The Informational City (Castells) – mentre più di recente avete affrontato entrambi il tema dei «movimenti urbani» con Rebel Cities (Harvey, 2010) e Networks of Outrage and Hope (Castells, 2012). Avresti voglia di spendere qualche parola rispetto a convergenze e differenze tra il tuo approccio e quello di Castells?
«In qualche modo dovresti chiederlo più a lui che a me, perché io ero molto vicino a lui durante gli anni Settanta, ma con The City and the Grassroots (1983) egli iniziava a ritenere che i movimenti urbani non fossero movimenti di classe, abbandonando quindi la prospettiva marxista. Io invece non vedevo il motivo di tale abbandono, e non ho mai capito cosa lo portò a tale cambio di direzione. Probabilmente ha a che fare col lavoro politico che stava facendo con il Partito Socialista, che aveva il suo istituto di ricerca col quale collaborava, e lavorare all’interno del filone socialdemocratico avrà sicuramente influito sul condurlo verso modelli interpretativi socialdemocratici.
«È un passaggio che ha coinvolto molti comunisti spagnoli, come ad esempio Jordi Borja. Più tardi, ai tempi degli scritti sulla città informazionale, Castells rientra in qualche misura all’interno di una posizione marxista, di quelle che ritengono che sono le forze produttive a guidare la storia. Ma questa non è la mia posizione, e credo che nemmeno Marx abbia mai assunto questa postura teorica. Ritengo dunque che Castells abbia avuto un’interpretazione di Marx piuttosto limitata, relativa appunto alle sole forze produttive e molto legata a quello che si potrebbe definire come il dogma dei Partiti comunisti europei (penso a quello francese, a quello spagnolo, a quello italiano ecc…). Lui è sempre stato molto coinvolto in quei mondi. Io ho invece sempre pensato che ciò che accade nella produzione debba costantemente essere messo in parallelo con l’analisi di classe e con le dinamiche della riproduzione.
«E da questo punto di vista ritengo che l’urbano sia il quadro all’interno del quale questi vettori possono essere meglio interpretati congiuntamente. Ho sempre interpretato Marx in questa direzione: c’è una politica della produzione, e c’è una politica per la realizzazione del valore, che avviene nelle città. E il processo complessivo è importante tanto quanto il momento produttivo. Diciamo che cerco di tenere assieme quella che potremmo definire come la "totalità" marxiana, mentre la posizione di Castells è molto più ristretta, esclusivamente produttivista […] e in questa direzione si capisce come si possa arrivare ad abbandonare Marx. […] Ciò non vuol dire che alcuni concetti di Castells non siano comunque molto rilevanti».
A partire dagli anni Ottanta vieni definendo uno dei temi che contraddistingueranno la tua ricerca, ossia l’analisi critica del neoliberalismo. Potresti mettere questo tema in relazione alle mutazioni dello Stato nel suo rapporto con la città? Quali sono le implicazioni del trasformarsi di questa relazione?
«Quando lo Stato ha iniziato a ritirarsi dalla fornitura di servizi sociali, il progressivo declino del welfare state, si sono aperte una serie di questioni rispetto a chi e come si dovesse sviluppare la distribuzione dei servizi sociali. E uno dei modi coi quali lo Stato si è relazionato a tale problema è stato quello di ributtare tutte queste funzioni addosso ai governi delle città dicendo: "non è un mio problema, risolvetevela voi". E chiaramente a quel punto non è che lo Stato ha inviato maggiori risorse alle città, nonostante queste stessero affrontando un numero crescente di problematiche come il social housing, l’aumento delle povertà ecc… Le municipalità vennero abbandonate, dovendo cominciare a trovare le risorse in maniera autonoma.
«È quello che ho definito come il passaggio da una forma manageriale del governo locale a una governance urbana di tipo imprenditoriale. A quel punto il tema dello sviluppo urbano è divenuto centrale, con un peso sempre più rilevante acquisito dai developer, di fatto gli unici soggetti a garantire un gettito fiscale per il bilancio delle città per poter affrontare i problemi sociali. Purtroppo ciò ha prodotto uno spostamento netto delle risorse, che sono andate sempre meno a coprire i costi necessari per il sociale e sempre più a sussidiare le corporation, proprio mentre i fondi statali diminuivano. E nessuno si oppose a ciò. Qualcuno disse che si poteva costruire una città in cui i bisogni sociali sarebbero stati affrontati col gettito proveniente dallo sviluppo urbano.
«Ad esempio Bloomberg a New York diceva che solo le industrie che versavano contributi alla città sarebbero potute rimanere in città. Ma il retro-pensiero di tutto ciò è che la stessa regola sarebbe dovuta valere anche per le persone… E quel modello si è realizzato, come abbiamo da poco visto rispetto a quel terribile incendio che c’è stato a Londra alla Greenfell Tower. È stato l’emblema di come un municipio ricco tratta e considera i poveri, di come di fatto ci si occupi di disfarsi di loro non preoccupandosi del tema della sicurezza abitativa. È questo il tipo di gestione che si è sviluppato nella città imprenditoriale, un modello contro i poveri che si è diffuso nella maggior parte dell’Europa occidentale e del Nord America».
Colleghiamoci a quest’ultimo tema per porre una domanda sui movimenti sociali, in particolare in relazione alla loro possibilità di incidere su queste dinamiche, dunque rispetto a un nodo che per molti anni è stato rimosso, ossia quello della relazione tra movimenti e la questione del potere. Nello specifico, negli ultimi anni si stanno confrontando diverse esperienze ed elaborazioni teoriche. Giusto per menzionarne alcune, si potrebbe citare una posizione che guarda all’"assemblea" quale forma specifica dei movimenti sociali (penso ai recenti scritti di Judith Butler o a Negri e Hardt), ci si potrebbe riferire a un’esperienza come il Rojava, dove una forma-partito piuttosto tradizionale si è misurata con una dimensione inedita (riassumibile a livello teorico nell’incontro della riflessione di Abdullah Öcalan con le idee municipaliste di Murray Bookchin), passando infine per una spinta a riconsiderare il ruolo dello Stato (soprattutto, ma non solo, all’interno del cosiddetto "populismo di sinistra"). Ti chiederei dunque qualche riflessione in proposito, legandola magari al discorso di prima sullo Stato.
«Io sono stato molto d’accordo con quanto diceva ieri sera Sandro [Mezzadra, all’evento "Critical Dialogue" che ha visto un confronto tra i due, nel contesto della Summer School bolognese "Sovereignty and Social Movements"], ossia che lo Stato ha un ruolo davvero importante in qualsiasi tipo di trasformazione radicale dell’ordine sociale. Ossia non dobbiamo essere Stato-fobici, con ciò intendendo che non vogliamo avere nulla a che fare con lo Stato. Allo stesso tempo, se si assume una postura Stato-centrica ci si allontana dalla possibilità di realizzare effettivamente una trasformazione radicale.
«L’unica possibilità è che si costituiscano una serie di poteri al di fuori dello Stato, che siano però in grado di intrattenere una relazione forte con esso. Ma appunto, senza questo "fuori" dallo Stato, non ci sono possibilità. È quanto abbiamo visto ad esempio con l’esperienza di Syriza e il suo progressivo identificarsi col potere dello Stato, che ha prodotto un drastico esaurirsi dei poteri dal basso. Anche in Spagna credo che Podemos sia in qualche modo di fronte allo stesso dilemma, non che siano nella stessa posizione di Syriza, ma potrebbero arrivarci. Io penso ci siano grandissime potenzialità in questa relazione: lo sviluppo di movimenti sociali indipendenti dall’apparato politico e come questi possono interagire sullo Stato.
«Un’organizzazione politica davvero forte non può che svilupparsi assemblando differenti strutture e molteplici livelli, cosa che in qualche misura si sta determinando in Rojava, nel nord della Siria. In questo senso credo sia necessario trovare un bilanciamento rispetto a questo continuo timore di rapportarsi allo Stato, proprio nel momento in cui gli Stati sono sempre più dominati dal potere finanziario che lavora di continuo contro i movimenti sociali».
Proprio rispetto a questo, tu in passato hai adottato la formula del "Partito di Wall Street" per indicare come lo Stato fosse sempre più colonizzato dalla finanza. Non è un rischio, o una potenziale contraddizione, guardare allo Stato proprio in questo contesto?
Bisogna considerare che il Partito di Wall Street è stato recentemente sfidato dal movimento che si è prodotto attorno alla candidatura di Bernie Sanders, anche se probabilmente da quando lui ha deciso di accettare la politica corrente l’emergenza che si era prodotta attorno alla sua figura è in qualche modo rientrata. Ma il punto è che bisogna chiedersi il perché il Partito di Wall Street controlla il Congresso, di fatto comprandoselo. Poi ci sono chiaramente altri livelli dove le cose possono andare in modo differente.
I municipi possono essere luoghi per una possibile rivalsa di una politica di sinistra, e ciò sta accadendo a Seattle, Los Angeles, e in molte altre città. Anche a livello amministrativo ci sono molti governi urbano estremamente più radicali delle stesse forme a livello nazionale. A questo livello Wall Street non ha lo stesso tipo di presa, anche se ovviamente esistono altri tipi di poteri che contrastano questa possibilità. Penso in primo luogo ai developer e alle loro lobby, in generale al mondo delle costruzioni (anche i sindacati dei costruttori in fondo hanno posizioni pro-development).
È dunque in corso una battaglia in molte città. Per esempio a New York c’è un sindaco molto di sinistra, ma di fatto non è in grado di contenere il potere delle lobby del real estate (che qui sono davvero forti, più che da ogni altra parte), anche perché bisogna considerare che l’attuale piano di sviluppo urbano è stato per lo più disegnato dal precedente sindaco Bloomberg, con una forma tutta protesa verso la speculazione. Quindi c’è anche un problema di tempo, per cui anche una posizione molto di sinistra come quella di De Blasio fatica a incidere per davvero.
Facendo un salto nel discorso per arrivare alle ultime due domande, potresti sviluppare una riflessione rispetto alla proliferazione di teorie che negli ultimi decenni sempre più stanno mettendo in relazione la città e il globale. Dalla rete di città-mondo di Allen J. Scott alla nota città globale di Saskia Sassen, passando per la più recente concettualizzazione sull’urbanizzazione planetaria proposta da Neil Brenner e Christian Schmid, fino ad arrivare alla relazione tra urbano e antropocene sulla quale riflettono Ash Amin e Nigel Thrift in Seeing Like a City o alla Connettografia basata sul ruolo geopolitico delle mega-città proposta da Parag Khanna, la relazione tra urbano e globale pare in qualche modo ormai costitutiva. Cosa ne pensi? Come interagiscono per te queste due dimensioni soprattutto in una prospettiva politica?
Penso che in effetti questa concezione di un’urbanizzazione planetaria sia un fatto indubbio. Siamo di fronte a una configurazione di poteri politici locali che possono essere giocati nei termini di una mobilitazione di massa per incidere nella politica. Credo che l’esempio più recente cui possiamo guardare rispetto a questo tema è relativo a ciò che avvenne nel 2003, il 16 febbraio, quando milioni e milioni di persone scesero in strada contro la possibilità di una guerra.
In milioni per le strade di Roma, Madrid, Londra, New York… E ovviamente senza nessun tipo di organizzazione specifica né tanto meno una sorta di grande mano invisibile cospirazionista alle loro spalle! Si trattava di una rete complessa che aveva generato un movimento globale di massa. E fenomeni del genere hanno luogo anche a livello nazionale, come accaduto in Turchia quando, dopo la sollevazione di Istanbul, moltissime altre città si sono mobilitate. O ancora in Brasile, quando dopo San Paolo in tantissime altre città le persone sono scese per strada.
Quando succedono cose simili non si può far finta di nulla, o pensare che non ci sia una qualche dinamica in atto nel profondo… Sarebbe una pura fantasia sennò. Il punto, ovviamente difficile, ma che andrebbe pensato, è cosa sarebbe successo se tutte quelle persone scese in strada nel 2003 contro la guerra fossero rimaste in strada… Cosa sarebbe successo? Cosa sarebbe successo, politicamente, se si fosse realizzato uno sciopero di massa di quello dimensioni e in tutto il mondo? Se tutte quelle persone avessero detto: "Basta, questa guerra non la farete, noi rimaniamo per strada finché non capitolerete".
Credo davvero ci sia una concreta possibilità in ciò. Al contempo non è che voglio romanticizzare, parlando troppo delle reti di città liberate o cose simili… Ma comunque su questo non bisogna sminuire. Voglio dire: l’insorgenza brasiliana è iniziata una settimana dopo quella di Gezi, e quello che mi ha colpito quando ho parlato con alcuni attivisti coinvolti in quella protesta è mi hanno detto: "Certo, stavamo guardando ciò che stava accadendo a Gezi!". Insomma, l’"effetto contagio" può davvero essere molto forte e veloce. Ora, la domanda difficile è: quale politica è possibile costruire su tutto ciò? Quale politica sta dietro a questi movimenti di sinistra? […]
Ma il punto è che, per me, in questo momento c’è un’enorme alienazione della popolazione urbana, a causa di una sempre minor democrazia, sempre minor potere, il declino della qualità della vita, l’austerità e il taglio dei servizi sociali, un mercato immobiliare divenuto totalmente pazzo, fuori dal controllo e totalmente speculativo, coi prezzi che sono schizzati a livelli ridicoli… Abbiamo tutti questi temi ai quali vanno aggiunti il declino degli investimenti nell’educazione e tanti altri fattori… E i partiti non rispondono a questi temi, i governi sono guidati dai developer e dalla finanza… Ecco, credo davvero ci sia la possibilità che accada qualcosa di molto rapido per una trasformazione urbana.
Ultima domanda. Tu sostieni che il modo nel quale organizziamo le nostre città dev’essere legato al tipo di persone che vorremmo essere e, da un punto di vista in qualche misura analogo, che dobbiamo sempre più chiederci se le città debbano essere spazi per l’investimento o luoghi per l’abitare. A me questa «scissione» riporta in mente l’antica distinzione latina tra urbs e civitas, tra la città intesa come infrastruttura fisica e la città come insieme dei cittadini, elementi che per i romani rappresentavano un campo di tensione e che invece la modernità ha progressivamente separato fino a rendere la città meramente un urbs. Si potrebbe dire che sarebbe oggi necessario riconnettere i due termini?
«Sì, penso che il punto stia esattamente qui. Sarebbe decisivo rivitalizzare l’idea di cittadinanza nei termini della città, un qualcosa che si è assolutamente perso. In qualche modo penso sia possibile ripartire dalle forme di democrazia praticate dai «movimenti delle assemblee» per recuperare quella concezione. Allo stesso tempo sarebbe necessario riuscire a esercitare una qualche forma di influenza sugli investimenti urbani e sui progetti che su di essi vengono elaborati, insistendo sulla direzione di questi investimenti: da dove vengono? A quali interessi rispondono? Stanno funzionando per migliorare l’ambiente nei quartieri e la vita delle persone? Danno una possibilità egualitaria di accesso all’educazione? Consentono una eguale distribuzione delle possibilità di vita nella città? Sono orientati all’integrazione delle popolazioni migranti all’interno della città (mentre le attuali politiche migratorie stanno attualmente distruggendo le città)?
«Invece gli urbanisti stanno per lo più producendo e riproducendo il modello della gated community, e l’isolamento di questa popolazione segregata dentro le loro mura… Ronald Regan disse a Gorbačëv ¨abbatti quel muro!", ma avrebbe dovuto dirlo ai costruttori americani dei suburb, dei veri e propri costruttori di muri. Adesso le mura sono ovunque in America, questi spazi chiusi alla città dove non c’è nessuna possibilità di sviluppare un’idea di appartenenza alla totalità della città, e dunque non si realizza nessun interesse rispetto a ciò che in essa accade, non c’è nessuna attenzione nemmeno a ciò che succede al proprio fianco.
Questo discorso rimanda a quanto scrisse in uno dei suoi ultimi articoli Henri Lefebvre, che nel 1989 in Quand la ville se perd dans la métamorphose planétaire uscito su Le Monde Diplomatique chiudeva, facendo in qualche modo il punto sulla sua intera prestazione intellettuale, dicendo: "Il diritto alla città non implica nulla di più che una concezione rivoluzionaria della cittadinanza politica".Esatto, penso ci sia ancora molto da pensare proprio partendo da lì».
«Ieri l'arringa delle parti civili: chiesti 6,4 milioni di danni, ma la somma aumenterà. L'avvocato del Comune, Ravagnan: "La città è la vera grande vittima della ruberia"». la Nuova Venezia, 14 luglio 2017, con postilla
Il grido di dolore di Venezia, di una città oltraggiata nellasua immagine e depredata delle sue ricchezze, si è levato forte ieri,nell'udienza del processo per le tangenti del Mose dedicata alla richiestadelle parti civili. Sei milioni 430 mila euro la somma complessiva sollecitatada Comune, Città Metropolitana, Regione e Consorzio Venezia Nuova agli ottoimputati accusati a vario titolo di corruzione e finanziamento illecito. Sitratta di un conteggio provvisorio visto che sono stati chiesti per lo più idanni non patrimoniali (da immagine e disservizio), mentre si è rinviato algiudice civile per il calcolo di quelli patrimoniali. Ai 6 milioni, inoltre,vanno aggiunti gli 8 (uno ad imputato) contestati nella precedente udienzadall'Avvocatura dello Stato.
Predoni e api operaie. La somma è destinatapertanto ad aumentare anche se sarà difficile dare ristoro a «un dannogigantesco, incomparabile, forse non misurabile», ha detto ieri l'avvocatoLuigi Ravagnan, legale del Comune di Venezia, in un'appassionata arringa con laquale ha ricostruito la sofferenza di una città violata. «In 37 anni diprofessione non ho mai visto una ruberia di queste proporzioni», ha affermato,«Venezia è la vera grande offesa, la vera grande vittima di questi fatticriminali. Chi ha lucrato illegalmente sulle somme destinate al Mose, ha rubatoi soldi alla città». Ruberie, anzi razzie: l'avvocato ha usato il termine di"raiders", razziatori appunto, per l'ex ministro all'Ambiente e alleInfrastrutture Altero Matteoli e per l'imprenditore romano Erasmo Cinque suo amico.
«Risorse sono state rapinate a Venezia a cui ilministro ha fatto un'offesa diretta: soldi sottratti alla città per interessipersonali». Il legale si è poi soffermato sugli imprenditori del Mose, quellidelle sovrafatturazioni, definendoli «le api operaie della corruzione». Quantoall'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni: «Lui non è un raider, ma si è lavatole mani come Pilato», ha affermato Ravagnan secondo cui bene aveva fatto bene achiedere il patteggiamento, «Sono certo che non ha trattenuto un euro, ma hauna cattedra di diritto e non poteva non sapere che il Cvn non potevafinanziare la campagna elettorale. Bisognava e si poteva dire di no, ilprofessor Orsoni non ha avuto la forza di farlo».
Il Comune ha chiesto un risarcimentodi 2,3 milioni di euro in solido «perché tutti hanno tolto risorse a Venezia»,a Orsoni, Matteoli, Cinque, all'ex Magistrato alle Acque Maria Giovanna Piva eall'imprenditore Nicola Falconi; 9 euro di ristoro per ciascun veneziano.Dannocon estensione planetaria. Due euro per abitante della provincia di Venezia,per un totale di 1,2 milioni, li ha chiesti invece la Città Metropolitana conl'avvocato Giuseppe Chiaia che ha parlato dello scandalo Mose come di un eventocon «estensione planetaria». Il legale ha calcolato in 100 milioni il costo peril territorio dell'affidamento dei lavori al Cvn senza gara. «La nostra'ndrangheta». «Lo scandalo Mose è la nostra 'ndrangheta», ha detto l' avvocatodella Regione Dario Bolognesi chiedendo 2,5 milioni di euro (500 mila a testaper Falconi, Piva, Turato, Matteoli e Cinque) .Gli intrecci Matteoli-Piva.«L'immagine del Cvn ha subito un devastante degrado, è stato indicato come unricettacolo di malaffare e spreco pubblico, percepito dall'uomo della strada comeun covo di farabutti». Così l'avvocato del Cvn Paola Bosio presentando larichiesta risarcitorie di 430 mila euro a titolo di provvisionale (10 milaall'ex europarlamentare Lia Sartori, 10 ad Orsoni e 10 a Falconi più 100 mila aPiva, Falconi, Matteoli e Cinque).
Il legale ha ricostruito in unadettagliatissima arringa di tre ore tutti i meccanismi dello scandalo Mose,soffermandosi in particolare sulle responsabilità di Matteoli: lui haautorizzato (pur non avendone titolo) lo sblocco dei lavori su Porto Margheracon assegnazione al concessionario unico Cvn; lui ha influito sulla nomina diPatrizio Cuccioletta a presidente Mav; lui ha imposto al Consorzio la societàSocostramo di Cinque. L'avvocato Bosio ha parlato delle mazzette che avrebbeintascato sia da Mazzacurati per la campagna elettorale, sia da PiergiorgioBaita (550 mila euro). Un extrastipendio e collaudi importanti, invece, ilcompenso al presidente del Mav, Piva, per non controllare. L'avvocato Bosio hasottolineato la confusione di ruoli tra le parti, con gli atti redatti dalConsorzio e il Mav inerte. Il Cvn avrebbe scritto addirittura la relazione dirisposta del Magistrato alle contestazioni della Corte dei Conti nel 2007.
postilla
Un processo davvero singolare. Tutti i protagonisti del più grande scempio perpetrato sulla Laguna e la più efferata rapina ai danni del contribuente di oggi e di domani da parte dello Stato, la Regione le banche e loro fondazioni, le Università e loro dirigenti, e soprattutto il Consorzio Venezia Nuova si trasformano, da colpevoli, ad accusatori di quanti si sono appropriati di pingui briciole del comune banchetto.
«In un Paese democratico i cittadini hanno libertà di parola, e il “potere” ha il dovere di ascoltare. Se non si ascolta non c’è democrazia, meno ascolto meno democrazia». arcipelagomilano, 12 luglio 2017 (m.c.g.) con postilla
Sentire o ascoltare. La lingua italiana, forse una delle più belle del mondo, è umiliata dall’uso che ne vien fatto soprattutto dai social e nella comunicazione politica. Il guaio maggiore è che insieme alla lingua si sono persi i pensieri ma forse non tutto è andato perduto almeno nel significato delle parole: il sindaco Sala e l’assessore Maran nella vicenda scali hanno certamente “sentito” molte voci ma poche o nessuna ne hanno “ascoltata”. Per il momento almeno confrontando il testo del vecchio Accordo di Programma con il nuovo, quello firmato dal sindaco il 22 giugno scorso, di ascolto non se ne vede e non se ne vedrà perché ormai è un testo immutabile: sottoscritto com’è dalle parti va ratificato entro il 22 luglio.
Sentire, nella lingua italiana, tra gli altri significati che lo riconducono a quello di avvertire una sensazione, ha anche quello delle sensazioni colte col senso dell’udito: sentiamo rumori, sentiamo parole, sentiamo suoni. Un atteggiamento passivo.
Ascoltare è tutt’altro. Ascoltare vuol dire due cose essenzialmente, udire con attenzione ma anche accettare consigli, suggerimenti, cogliere pensieri altrui. Ascoltare in tutte le sue accezione è un atteggiamento attivo.In un Paese democratico i cittadini hanno libertà di parola, possono farsi sentire, è un loro diritto ma non sempre ne hanno gli strumenti necessari. In un Paese democratico il “potere” ha il dovere di ascoltare. Se non si ascolta non c’è democrazia, meno ascolto meno democrazia. Che altro?
In un Paese democratico il potere ha anche il dovere di rispondere quando viene interpellato. Certo il potere chiede di essere interpellato nelle forme e nelle sedi previste dai regolamenti ma vi sono anche interrogativi sollevati in altre sedi e pure di questi va tenuto conto. Sugli scali nessuna risposta a fronte di tante domande “fuori sede”.L’irritazione degli inascoltati si coagula attorno ad iniziative di contrasto destinate a percorrere vie giudiziarie spesso coronate da successo soprattutto nel nostro Paese, tanto attento più alle forma che alla sostanza: ci sono appigli per tutti.
Perche non ascoltare? Chi è, se c’è, l’anima nera in questa vicenda? Chi suggerisce di non ascoltare? Milano ha dunque la sua Aracne?
Il dito, la luna e il sindaco Sala – Lette le carte della Procura il sindaco Sala dichiara: ” Mi sembra tutto molto trasparente, il Consiglio di amministrazione ha approvato il tutto” e a seguire il suo avvocato Salvatore Scuto: “Tutta l’azione da lui svolta è stata improntata alla più assoluta trasparenza”. La domanda preliminare resta un’altra: lo scorporo della fornitura del verde dall’appalto della piastra per come è stata fatta rispetto al codice degli appalti è un atto legittimo? E ancora: quali sono le ragioni dello scorporo? Nell’interesse di chi si è proceduto alla scorporo? Se è vero, come appare dai giornali, che a scorporo avvenuto non vi è stata riduzione dell’ammontare dell’appalto principale, lo scorporo è doloso in quanto non solo costituisce illecito arricchimento dell’appaltatore ma danno evidente per il committente.
Se dunque nella vicenda dello scorporo vi è stato dolo, il fatto che una decisione dolosa sia stata presa non solo da un singolo ma da un intero consiglio di amministrazione di una SpA pubblica, regolarmente trascritta nei verbali di Consiglio e dunque”trasparente”, non sposta di una virgola il vero quesito: fu un atto legittimo? Non inquinato da pressioni esterne e fatto nell’esclusivo interesse pubblico? La trasparenza di un atto non ne legittima la correttezza. Se poi tutti i consiglieri hanno approvato l’atto risultato doloso potrebbe persino configurarsi l’associazione a delinquere. Se poi non vi fu dolo ma solo “leggerezza” dovremo parlare di danno erariale.
Dalle carte della Procura emerge comunque uno spaccato della società che ruotava attorno a Expo 2015 molto si avvicina al “mondo di mezzo” di Mafia Capitale. La visita negli uffici di Expo di Greganti e Frigerio la dicono lunga e avrebbero dovuto essere un campanello d’allarme. Da chi siano andati ancora non si sa. Chi aveva l’obbligo di garantire con ogni mezzo la legalità delle procedure e la lealtà e onestà dei propri collaboratori?
postilla
Un convincente commento critico a due vicende di ‘malaurbanistica’ che non sembrano intaccare le certezze della gioiosa macchina da guerra dell’amministrazione milanese: la approvazione dell’Accordo di Programma sugli scali ferroviari, ormai in dirittura di arrivo malgrado le numerose voci che si sono levate contro la cementificazione delle ultime grandi risorse territoriali disponibili nel cuore della Città Metropolitana di Milano; e la vicenda giudiziaria del sindaco Sala la quale, al di là degli esiti, lo delegittima agli occhi dei cittadini consapevoli, di chi ha a cuore il bene comune e non gli interessi degli immobiliaristi.
Nel frattempo, dall’8 al 23 luglio, è in corso alle scalo Farini la “Festa metropolitana” del PD, dall’incomprensibile titolo “Oggi Milano, domani Lombardia”. Insomma, già dal titolo si evince che, in questa sedicente ‘Festa metropolitana’, agli amministratori e responsabili politici del PD della Città Metropolitana non importa nulla; ma delle occasioni di speculazione immobiliare molto. E infatti, Pietro Bussolati, segretario del Partito Democratico di Milano, nella enfatica e trionfalistica pagina introduttiva al calendario della Festa, scrive: “Dopo lo scalo di Porta Romana dell’anno scorso, quest’anno è la volta dello scalo Farini, oggi un fantastico sito di archeologia industriale, destinato a diventare il terzo parco – per estensione – della città, che ospiterà verde, spazi di aggregazione, terziario e social housing. La riqualificazione degli scali cambierà il volto urbanistico di Milano e il progetto è il simbolo di una città che corre verso l’innovazione”. Peccato che la festa sia totalmente disertata dai cittadini. Ma nelle giornate conclusive sono previsti anche alcuni oratori illustri che certamente ne risolleveranno le sorti: Luca Lotti, Stefano Boeri, Marco Minniti, Roberta Pinotti e Maria Elena Boschi.
 Baro s. m. (prob. dalla forma di nominativo del lat. baro -onis «briccone, cialtrone»).– Chi bara al gioco delle carte, e in genere truffatore, imbroglione.(Dizionario Treccani). Definizione che si attaglia perfettamente al governo Renzi-Gentilonie al Ministro Gian Luca Galletti..(segue)
Baro s. m. (prob. dalla forma di nominativo del lat. baro -onis «briccone, cialtrone»).– Chi bara al gioco delle carte, e in genere truffatore, imbroglione.(Dizionario Treccani). Definizione che si attaglia perfettamente al governo Renzi-Gentilonie al Ministro Gian Luca Galletti..(segue)
Baro s. m. (prob. dalla forma di nominativo del lat. baro -onis «briccone, cialtrone»). – Chi bara al gioco delle carte, e in genere truffatore, imbroglione. (Dizionario Treccani). Definizione che si attaglia perfettamente al governo Renzi-Gentiloni e al Ministro Gian Luca Galletti
, autori del Decreto Legislativo 401 cheabolisce di fatto la VIA per le grandi opere pubbliche e rende discrezionali esoggette all’arbitrio dei proponenti e dell’esecutivo le eventualiprescrizioni.
In effetti, sarebbe stato meglio che il governo avesse cancellato ogniobbligo di Valutazione ambientale, facendo cadere l’ultimo velo di ipocrisia. Purtroppola nostra ancora appartenenza all’Unione Europea non lo consente, ma hapermesso, utilizzando furbescamente la Direttiva europea 2014/52/UE, di ribaltarne spirito e obiettivi nel Decreto che entrerà invigore il 21 luglio.
D’ora in poi: i) sarà sottoposto aVIA non il progetto definitivo, ma quello “di fattibilità”: ii) i proponenti el’autorità competente potranno in ogni momento mettersi d’accordo sul grado didefinizione del progetto, iii) la verifica di assoggettabilità a VIA non saràpiù aperta alla consultazione del pubblico; iv) la commissione VIA saràintegrata da 30 “esperti” di nominaministeriale, con l’unico requisito di avere prestato per 5 anni servizio nellapubblica amministrazione, ovverosia la “tecnica” (si fa per dire) agli ordini della(probabilmente cattiva) politica. E molte altre nefandezze già descritte inprecedenti scritti apparsi su eddyburg e in un ottimo articolo di AntonioFiorentino pubblicato su la città invisibile».
E se qualcuno non ottempera alleprescrizioni VIA? Qui il Decreto mostra la sua faccia feroce: «Salvo che il fatto costituisca reato, siapplica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro neiconfronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verificadi assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva lecondizioni ambientali». Come dire che con qualche spicciolo si possono risparmiarediversi milioni di euro trascurando le prescrizioni della VIA, dato che non è esplicitamenteprevisto l’annullamento degli atti contrastanti o omissivi. Inutile dire che discrezionalitàe contrattazione – i principi informatori del Decreto - lo rendono noninnocentemente carico di potenzialità criminogene.
Ma tornando all’aeroporto diFirenze, ciò che costituisce una ghiotta occasione per i suoi improvvidipromotori è una norma transitoria che permette, nei procedimenti in corso e su istanza del proponente, di applicare lanuova disciplina o di ritirare il progetto presentato e proporne uno nuovo.Improvvidi, infatti, sono stati ENAC e Toscana Aeroporti, perché avendo findall’inizio violato la legge “per prassi consolidata”, hanno presentato unprogetto pieno di lacune e contraddizioni, avvitandosi in un succedersi diintegrazioni - richieste o volontarie- che hanno avuto come esito di prolungareoltre ogni limite i lavori della Commissione, conclusi con ben 142 prescrizioni:alcune estremamente pesanti, altre che puntano il dito sul conflitto diinteressi di ENAC, controllore-controllato, altre che mettono in luce larischiosità di un aeroporto incastrato tra autostrada, Università e periferianord-ovest di Firenze. Di fatto, una vera e propria bocciatura che il MinistroGalletti ha tenuta nascosta da diversi mesi. Ci si chiedeva le ragioni di tantalentezza e opacità, ma l’approvazione del Decreto “libera tutti” chiarisce lastrategia del governo e dei suoi sodali, in primis le lobby di Confindustria edelle associazioni dei costruttori. E’ facile prevedere che ENAC ritirerà ilprogetto formalmente approvato e formuleràla richiesta di “provvedimento unico in materia ambientale” ai sensi dellanuova normativa, facendo decadere tutte le prescrizioni della Commissione, checolpevolmente non si era dimostrata prona ai voleri della politica nonostanteogni genere di sollecitazioni e pressioni, e che per questo sarà rimpiazzata eintegrata con 30 esperti al servizio del Ministro.
Naturalmente, l’annunciodell’entrata in vigore del Decreto Legislativo è stato accolto con esultanzadalla stampa locale che derubrica la Valutazione di Impatto ambientale ainutile burocrazia, da aggirare o azzerare. «Con ilnuovo decreto vengono eliminati tanti elementi di dubbio presenti nella normasin qui in vigore. Fra questi, il mai risolto nodo sulla necessità di averdepositato il progetto definitivo per il completamento della valutazione diimpatto ambientale per gli aeroporti, sebbene tutte le VIA fossero statefirmate sulla base di progetti preliminari. Il nuovo decreto taglia la testa altoro: è nero su bianco che è sufficiente il Masterplan» (La Nazione Firenze11 luglio). Dove non si sa se sia maggiore l’insipienza o la cattiva fededell’articolista che esulta perché finalmente vengono legalizzate le violazioni“per prassi consolidata” delle leggi (si attende un simile provvedimento per sanarele malefatte dei nostri rappresentanti in Parlamento). L’entusiastica velina segueannunciando che entro un anno sarà tutto approvato e quindi potranno iniziare ilavori.
Sfugge all’articolista, ma, ciòche è molto più grave, ai tanti politici che si battono “senza se e senza ma” afavore del nuovo aeroporto di Firenze (perché? Perché Firenze deve avere il suoaeroporto), che prescrizioni o non prescrizioni – i problemi reali rimarrannotutti in piedi. Si potrà abolire l’obbligo dello spostamento del lago di Peretola,ma non il pericolo di bird-strike se il lago rimarrà nella posizione attuale.Si potrà abolire la prescrizione di valutare il rischio di incidentecatastrofico secondo la direttiva Seveso, ma non il rischio catastrofe; sipotrà abolire la prescrizione di presentare un programma di smaltimento per i 3milioni di tonnellate di terra inquinata, ma non la terra inquinata; si potràabolire l'obbligo di sopraelevare l’autostrada per permettere ilsottoattraversamento del nuovo Fosso Reale, ma non il fatto che il Fosso debba passare sotto l’autostrada: eciò vale anche per tutte le altre 138 prescrizioni. Con il rischio, data ladubbia legittimità del decreto e l’evidente contrasto rispetto alla normativaeuropea, di avvitarsi in una spirale di ricorsi e contro ricorsi. A volte aibari le cose non filano lisce come sperano.
 «Il grande progettista si racconta alla vigilia dei novant’anni “Tutto è cambiato. Chiudo lo studio”». la Repubblica, 12 luglio 2017 (c.m.c.)
«Il grande progettista si racconta alla vigilia dei novant’anni “Tutto è cambiato. Chiudo lo studio”». la Repubblica, 12 luglio 2017 (c.m.c.)
Il 10 agosto compie novant’anni, ma il motivo non è solo anagrafico.
«L’architettura non interessa più», dice persino sorridendo nel salotto della sua casa milanese – Casa Candiani, un edificio eclettico di fine Ottocento, un po’ neogotico, un po’ neorinascimentale, fra San Vittore e Santa Maria delle Grazie. Fino a qualche mese fa al pianterreno c’era la Gregotti Associati, fondata nel 1974, lavori in Italia e nel mondo, dalla Germania al Portogallo alla Cina. Ora, di là dal vetro, si scorgono scaffali vuoti e la luce spenta. «Abbiamo tre progetti ancora in piedi, ad Algeri, in Cina e poi a Livorno, dove facciamo il piano regolatore. Li cura il mio socio Augusto Cagnardi».
E niente più?
«Niente più. D’altronde compio novant’anni, ma cosa sta succedendo nel nostro mondo? Una società immobiliare decide se, con i soldi dell’Arabia Saudita, investire a Berlino, a Shanghai o a Milano, a seconda delle convenienze. Stabilisce il costo economico, compie un’analisi di mercato, fissa le destinazioni. E alla fine arriva l’architetto, a volte à la mode, al quale si chiede di confezionare l’immagine».
Lei fa questo mestiere dall’inizio degli anni Cinquanta: ne avrà visti di periodi bui. O no?
«Certo. Ma non è un caso che nella mia vita sia stato amico più di letterati, di artisti e di musicisti che di architetti. Da Emilio Tadini a Elio Vittorini, da Umberto Eco a Luciano Berio. E poi ho sempre concepito l’architettura come un prodotto collettivo: un valore che si è perso».
Dove l’ha appreso?
«Lavorando da operaio in uno stabilimento di proprietà della mia famiglia, a Novara ».
Lei si è occupato tanto di letteratura, di filosofia, di musica. Ha fatto il conservatorio. Eppure lamenta che i suoi colleghi oscillano dall’iperspecialismo alla tuttologia.
«Ma mantenere relazioni fra filosofia, letteratura e architettura non è tuttologia. I miei modelli sono il capomastro medievale e il suo sguardo d’insieme. Capii questo a Parigi, nel 1947, dove lavorai nello studio di Auguste Perret. Dovunque girassi incontravo intellettuali che incrociavano le diverse competenze. Tornato a Milano, appena le lezioni del Politecnico me lo consentivano, andavo a sentire Enzo Paci che parlava di filosofia teoretica».
Studiava architettura, ma non le bastava.
«La svolta fu nel 1951, quando partecipai a Hoddesdon al convegno dei Ciam, il Comitato internazionale per l’architettura moderna. C’erano Le Corbusier e Gropius. Si rifletteva sul rapporto con la storia e il contesto. E a chi insisteva che il contenuto del nostro futuro sarebbe stato la tecnologia, si contrapponeva la dialettica con il passato, con i luoghi in cui si realizzava un’architettura. Ciò che preesisteva non andava ignorato, anche nel caso in cui il nuovo fosse un’eccezione».
E i rapporti con gli scrittori?
«Rimasero intensi. Ho anche partecipato al gruppo 63: si ragionava su come vivere il tempo libero senza finire preda del mercato, una questione cruciale per un architetto».
Comunque sempre pochi architetti.
«Gli architetti erano divisi in due categorie. Una prediligeva la natura d’artista e considerava la letteratura o la filosofia discipline distanti. L’altra era quella dei professionisti, che interpretavano il mestiere onorevolmente, ma che non andavano al di là del dato tecnico».
Comunque sia, lei ha sostenuto che allora ci si confrontava con una società in cui prevaleva l’industria. E che oggi, invece, poco ci si rapporta con quella post industriale.
«Oggi non ci si preoccupa di rappresentare una condizione sociale collettiva. È andato smarrendosi il disegno complessivo della città, che viene progettata per pezzi incoerenti, troppo regolata da interessi».
Questo è dovuto all’irruzione del postmoderno?
«Il postmoderno è un’ideologia tramontata. Ma ha avuto effetti significativi. Si è interpretato in modo ingenuo il rapporto con la storia, non ponendosi nei suoi confronti in termini dialettici, ma adottandone lo stile. E l’involucro è stato considerato indipendente dalla funzione di un edificio. Poi il postmoderno ha incrociato il capitalismo globale».
E che cosa è successo?
«Sono saltate le differenze fra culture. Ora ovunque si distribuiscono prodotti uguali. Prevale il riferimento a un contesto globale, che diventa moda, più che a un contesto specifico. Avanzano lo spettacolo, l’esibizione, l’ossessione per la comunicazione».
Mi fa un esempio?
(Sul tavolo davanti al divano pesca una rivista, c’è la foto di un edificio che sembra accartocciato) «Guardi, questo è il centro di ricerca progettato a Las Vegas da Frank Gehry. Gehry è un mio amico, ma ha superato ogni limite nel rapporto fra contenuto e contenitore. È l’ammissione che l’architettura è sfascio».
Le piace la Nuvola di Fuksas?
«Assolutamente no».
E il Maxxi di Zaha Hadid?
«Il suo fine è la trovata, la calligrafia, senza rapporto con la funzione. Queste sono architetture popolari, d’altronde se non fossero popolari non potrebbero esistere. Contengono un messaggio pubblicitario. Anche nel Seicento le facciate barocche delle chiese lo contenevano, ma si riferiva a un universo spirituale. Qui è la moda a dettare le prescrizioni».
Lei ha realizzato il quartiere Bicocca, a Milano, e a Pujang, in Cina una città da centomila abitanti. Ha fatto il piano regolatore di Torino e il Centro culturale Belem a Lisbona. Ha collaborato con Leonardo Benevolo al Progetto Fori a Roma, mai realizzato, purtroppo. Ma le viene spesso rinfacciato il quartiere Zen a Palermo: c’è chi ne invoca la demolizione.
«Lo Zen avrebbe dovuto essere diverso da quel che è stato, una parte di città e non una periferia. Palermo ha il centro storico, le espansioni otto-novecentesche e poi doveva esserci lo Zen, con residenza, zone commerciali, teatri, impianti sportivi. Doveva possedere un’autonomia di vita che non si è realizzata».
È il problema di molte periferie pubbliche italiane. Qualche responsabilità ce l’avete voi progettisti?
«Io non sono per demolire lo Zen o Corviale. Sono per demolire il concetto di periferia, non basta il rammendo. Ci siamo illusi in quegli anni di poterlo realizzare? È vero, ci siamo illusi di costruire quartieri mescolati socialmente, dotati delle attrezzature che ne facevano, appunto, parti di città e non luoghi ai margini. Rispondevamo a un’emergenza abitativa. Ma se noi ci siamo illusi, quello che contemporaneamente si costruiva o quello è venuto dopo cos’è stato se non la coincidenza fra interessi speculativi e l’annullamento di ogni ideale progettuale? Corviale ha un’idea, che andava realizzata. Non è solo un tema d’architettura».
Lei è stato insegnante a Palermo e ad Harvard, a Venezia e a Parigi. Come guarda ai futuri architetti?
«Mi preoccupa il loro disorientamento. Vengono spinti a coltivare una pura professionalità, a saper corrispondere alle esigenze del committente, oppure ad avere una formazione figurativa stravagante e capace di essere attraente. È pericoloso l’abbandono del disegno a mano. Con il computer si è precisi, è vero, ma non si arriva all’essenza delle cose. I materiali dell’architettura non sono solo il cemento o il vetro. Sono anche i bisogni, le speranze e la conoscenza storica».

La Sardegna suo malgrado si trova a fronteggiare un'ulteriore insidia ambientale con pesanti risvolti economici e sociali, che si assomma a quelle già presenti e irrisolte: si tratta di tre (per ora) progetti per impianti CSP, cioè campi di specchi per l'ottenimento di energia elettrica dal termodinamico solare, ciascuno abbinato alla sua relativa centrale termoelettrica, ai serbatoi per il fluido termovettore, nonché alle strutture e opere connesse. Dobbiamo evitare che queste proposte divengano un futuro reale, vediamo perché.
Se a prima vista tali progetti possono sembrare un positivo progresso per la sostituzione dell'approvvigionamento energetico dalle fonti fossili a quelle rinnovabili, un esame più attento ne mostra pesanti criticità, insostenibili per l'ambiente: gli impianti andrebbero a ricoprire oltre 570 ettari complessivi di suoli attualmente in uso all'agricoltura o all'ambiente naturale, areale che inoltre andrebbe sottoposto a una irreversibile trasformazione geomorfologica per ospitare le opere, tra imponenti sbancamenti per l'appianamento in vasti terazzamenti, e gli scavi per le fondazioni di tipo profondo.
Esplicitiamo i problemi: la conversione di terreni da agricoli-naturali in urbani-industriali realizza la perdita di un'importantissima matrice ambientale, il suolo: le dimensioni della perdita di suolo nel mondo, in Europa, in Italia e anche in Sardegna, rappresentano un'ulteriore drammatica emergenza ambientale alla quale da tempo si cerca di dare risposte anche a livello legislativo; tuttavia resta ancora poco nota e poco compresa rispetto ad altre, come il cambiamento climatico, mentre la perdita dei suoli potrebbe essere un processo addirittura più difficilmente reversibile: infatti per generare uno spessore di suolo di pochi centimetri sono necessarie diverse centinaia di anni, qualunque azione mettiamo in campo, mentre un comportamento virtuoso dell'umanità a partire da adesso, potrebbe ripristinare un clima ante-crisi in poco più di un secolo, secondo gli studi. Nel caso di specie, gli areali richiesti rappresentano l'estensione di una cittadina di 50-70000 persone con media densità abitativa, creata ex-novo in tre aree da 227, 269 e 70 ettari, più servizi connessi.
Perché tali suoli sono così importanti, anzi preziosi, qui in Sardegna? Perché la Sardegna ha pochi suoli profondi, mentre il clima spesso siccitoso rende poco produttive le vaste estensioni rocciose, i monti e i colli acclivi che caratterizzano una buona parte dell'isola. Questi impianti porterebbero con sé altre criticità, ne citiamo brevemente alcune: problemi per la circolazione delle acque superficiali e sotterranee, problemi più generali di assetto idrogeologico, problemi per la fauna, problemi di pianificazione territoriale per i comuni coinvolti, nonché l'esproprio dei terreni per allevatori, agricoltori, e le aziende agricole e zootecniche presenti!
A fronte di ciò, va ribadito che il passaggio dai combustibili fossili alle energie che provengano da fonti che siano, allo stesso tempo, rinnovabili e sostenibili, va attuato il più velocemente possibile, con i mezzi già oggi disponibili sul mercato, senza aggiungere ulteriori danni ambientali come quelli che apporterebbero questi impianti, mal collocati, mal programmati, insufficientemente progettati, che approfittano dell'etichetta di “rinnovabile”: valida però per la fonte energetica, il sole, e non per tutte le altre matrici ambientali coinvolte, che verrebbero perse una volta e per sempre. Gli impianti in questione inoltre sono di tipo ibrido, ovvero nei periodi in cui non è possibile l'utilizzo degli specchi o di insufficiente insolazione o durante i fermi programmati, per la produzione energetica interverranno come vicarianti gli impianti a combustibili fossili. Rispetto alla tecnologia odierna i CSP non rappresentano più proposte d'avanguardia per il prossimo futuro ma strumenti già superati e legati al passato: l'unico vantaggio che il CSP presentava rispetto alle altre fonti rinnovabili, era la possibilità di erogare energia anche in assenza d'insolazione, distaccandosi quindi in parte dall'aleatorietà della fonte, ma oggi sono disponibili sul mercato nuovi sistemi d'immagazzinamento dell'energia altrettanto o anche più efficienti del CSP.
Sui due progetti più impattanti sono stati chiamati a esprimersi il Ministero dell'Ambiente (MATTM) e quello dei Beni Culturali (MiBACT), che hanno dato parere divergente sull'argomento, sarà quindi deciso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Proprio il Ministero dell'Ambiente ha dato parere positivo per entrambi i progetti, tramite un proprio organo che si esprime a maggioranza (la Commissione Tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale) composto da diverse figure professionali: da una disamina delle competenze si rileva che nell'insieme compongono un assortimento non commisurato alla valutazione di impatti di questa portata. Tuttavia tali pareri positivi sono stati emessi, benché condizionati da prescrizioni e richieste di adempimenti obbligatori, difficilmente realizzabili, anche preliminari agli impianti; adempimenti che appaiono piuttosto stringenti, ma, come dimostrano tanti casi, compreso il caso Fluorsid, la procedura dei controlli è sempre piuttosto lasca, e le eventuali mancanze sono sanzionate con poco; inoltre, seppure accadesse il caso fantascientifico che si comminasse la sanzione del blocco del progetto, a lavori iniziati il ripristino dello stato dei luoghi sarebbe virtualmente impossibile. In altri termini: gli adempimenti richiesti non sono effettivi, appaiono più un “coprirsi le spalle” da parte della Commissione VIA.
Per progetti di così ampia portata sarebbe stato d'uopo che il Ministero dell'Ambiente chiedesse una consulenza direttamente a un suo istituto che da anni si occupa per l'appunto anche delle ricerche e dei controlli sull'ambiente e sui suoli, pubblicando annualmente un interessante rapporto sul consumo dei suoli in Italia completato da saggi divulgativi: è proprio quell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) chiamato in causa anche in questi ultimi giorni per l'affare Fluorsid (l'Istituto ha svolto sull'impianto controlli concordati, e non a sorpresa, trovando tuttavia elementi di illegittimità ai quali non si diedero però conseguenze reali): tuttavia tale ente non è stato coinvolto dal Ministero nelle valutazioni relative ai progetti. Per evitare però che tale Istituto possa negare di essere a conoscenza di quanto è in ballo, si è deciso di inviare all'ISPRA delle comunicazione ufficiali: per impulso del comitato scrivente da gennaio più comitati e associazioni, nonché singoli, hanno inviato mail e PEC (Posta Elettronica Certificata) ai vertici dell'Istituto, e infine il 23 maggio 2017 una PEC è stata indirizzata ai vertici dell'ente, cioè al Commissario pro tempore prof. Bernardo De Bernardinis, al Direttore Generale e nuovo presidente designato dott. Stefano Laporta, ma anche, per conoscenza, a tutta la dirigenza dei vari dipartimenti dell'ente, in particolare ai dipartimenti dell'ente che si occupano della salvaguardia e monitoraggio del suolo, nonché alla Presidenza del Consiglio e al MATTM; la comunicazione è stata firmata da cittadini (tra cui vari proprietari dei terreni coinvolti e di aziende agro-zootecniche), professionisti, comitati e associazioni. Finora dall'ente nessuna risposta: ci si augura che abbia almeno messo in campo qualche azione, e che le professionalità al suo interno non contraddicano quanto affermato nei vari scritti ed eventi divulgativi.
Ci si potrebbe domandare se all'ISPRA sia riconosciuta la capacità esprimersi autonomamente oltre l'impulso ministeriale: ebbene sì, sia secondo lo Statuto dell'ISPRA (promulgato con Decreto Interministeriale 28 dicembre 2013), vedi comma 1 dell'art. 1, art. 2 c.1, c.3, c.4, nonché nella recente legge 132/2016 istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, entrata in vigore il 14.01.2017, del quale l'ISPRA fa parte perfino con la qualità di coordinatore delle agenzie regionali e varie: dice la legge all'art. 4 comma 3 che: “L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche […] sia a supporto del Ministero […], sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione […].”: “Per quanto attiene alle attività conoscitive ed ai compiti di controllo, monitoraggio e valutazione, l'Istituto [...] svolge, direttamente e [...con altri enti...], attività di monitoraggio e controlli ambientali [...]”. Anche il Dott. Stefano Laporta, presidente designato dell'ISPRA dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, nell'audizione di candidatura presso la Commissione marca l'orientamento verso l'autonomia dell'Istituto dal Ministero.
Si noti infine che all'art. 2 c.5b dello statuto dell'ISPRA, all'ente vengono assegnati anche compiti di consulenza strategica e assistenza tecnica e scientifica verso altre amministrazioni dello Stato nonché le regioni, quindi la Regione avrebbe potuto chiamarlo in causa per una consulenza scientifica sulla vicenda (può farlo ancora per irrobustire il rigetto già ampiamente espresso in sede di valutazione di impatto ambientale, anche corroborato dai restanti enti e servizi che fanno capo alla stessa Regione, finanche dai comuni coinvolti), consulenza che verosimilmente avrebbe necessariamente cambiato il parere espresso dalla CTVIA. Ora l'ISPRA dovrebbe solo mettere in pratica quanto gli è prescritto e consentito, nonché quanto gli dovrebbe appartenere come “spirito”, per puro orgoglio professionale e dirittura morale dei suoi dipendenti, ed esaminare con cura la problematica di questi oltre 570 ettari complessivi destinati a diventare tre nuove zone industriali, assolutamente non necessarie, invise e osteggiate dalle comunità nelle quali dovrebbero essere insediate.
La questione della valutazione dei progetti, che scorre sotterranea mentre si sviluppano i processi decisionali, è tornata d'attualità il 5 luglio scorso, a seguito dell'interrogazione del parlamentare Roberto Capelli al ministro Galletti sull'argomento; l'interrogazione è stata incentrata solo su uno degli impianti a esame ministeriale, inoltre si è limitata a interpellare il parere del ministro, che, come ampiamente previsto, non poteva che uniformarsi (forse con intima soddisfazione di commercialista dell'ambiente) al parere positivo della Commissione Tecnica VIA. Eppure la questione seguiva una domanda allo stesso ministro sul precariato all'interno dell'ISPRA, e precedeva un'altra domanda sul dissesto idrogeomorfologico in Italia: occasione quanto mai propizia per collegare i temi, e chiedere in modo assai più penetrante al ministro come mai su un problema che interessa una pianificazione di così ampia portata ed estensione, e con risvolti sulle problematiche dell'assetto idrogeologico, non fosse stata chiesta una consulenza proprio all'ISPRA, e anzi richiederne un intervento attivo. Nella replica dell'on. Capelli, successiva alla risposta del ministro, sarebbe inoltre stato bene contestare alcune scorrettezze da egli proferite: ad es. il ministro Galletti ha parlato della presenza di misure di compensazione ambientale che in realtà non lo sono (la compensazione ambientale è definita per legge), poiché riferite a opere parte integrante del progetto, inoltre ha svalutato il parere negativo del MiBACT come dovuto a un insufficiente informazione, mentre questo si è espresso con parere motivato in tutte le sedi.
Sarebbe stato interessante vedere il comportamento dell'Istituto che, pur in crisi attualmente per quanto riguarda i posti di lavoro e il precariato, ha fatto della difesa dei suoli e del dissesto idrogeologico alcuni dei suoi argomenti preferiti di divulgazione e discussione, misurando anche i suoli sottratti all'ambiente dalle installazioni fotovoltaiche industriali e dai CSP.

Evviva, l’Unesco ha deciso di aggiungere alla lista del patrimonio dell’umanità altri due siti italiani: alcune faggete primordiali dell’Appenino e le opere di difesa della Repubblica veneziana, dalle mura di Bergamo alla meravigliosa forma di Palmanova. Così l’Italia raggiunge la cifra di 53 luoghi, e il ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini esulta per un risultato che «consente al nostro Paese di mantenere il primato del numero di siti iscritti alla Lista e di esercitare un notevole ruolo nella diplomazia culturale nel contesto internazionale».
Benissimo. Ma prima di pensare alla diplomazia dovremmo forse pensare alla responsabilità che il mondo ci riconosce. Non c’è bisogno dell’Unesco per sapere cosa custodiamo, ed è terribile che nelle stesse ore in cui gioiamo arrivi la notizia del crollo che, nel Duomo di Acireale, ha seriamente ferito un bambino. Il sindaco ha amaramente commentato che «alcune delle nostre meravigliose e antichissime basiliche hanno bisogno di manutenzione straordinaria».
Ma la verità è che quella che non si riesce più ad assicurare è la manutenzione ordinaria: la sola che possa evitare disastri, e che se seriamente pianificata e opportunamente finanziata permetterebbe di risparmiare rispetto agli interventi in emergenza, e di creare occupazione.
Come sempre in Italia le emergenze dei terremoti svelano impietosamente le gravissime carenze strutturali: e così basta pensare che da otto mesi il mirabile crocifisso quattrocentesco di Johannes Teutonicus (per non citarne che un’opera tra centinaia) giace sotto la macerie della chiesa di Santa Maria Argentea a Norcia per capire che lo Stato italiano si è tolto di mano da solo gli strumenti per difendere, curare, tutelare questo famoso patrimonio dell’umanità.
Né si può pensare di rimediare ai tagli ormai decennali concentrando tutto il (poco) denaro e tutto il (pochissimo) personale sui celebrati supermusei, o sui grandi progetti eccezionali (tanto pericolosi anche sul piano della corruzione). Qualcuno ricorderà che il primo maggio del 2017 l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi annunciò l’attribuzione di un miliardo a questi grandi siti. Solo 150 milioni venivano riservati a quello che si continua a definire il “patrimonio minore”, e che è invece il 90% del tessuto storico e paesaggistico del Paese.
Allora Renzi andò in televisione, da Fabio Fazio, per esortare i cittadini a segnalare (alla mail bellezza@governo. it) i siti da salvare. Finito lo storytelling, tuttavia, nessuno si è chiesto cosa di concreto sia scaturito da quella brillante idea. La risposta è che sono arrivate 140.000 email, con la preghiera di curarsi di 7.540 monumenti, distribuiti in 3.197 comuni. Troppe perché qualcuno decidesse cosa fare: e così il 29 aprile scorso, a un anno esatto dall’annuncio, Renzi ha mestamente comunicato che «il sottosegretario Maria Elena Boschi con il vice segretario generale di Palazzo Chigi, Salvo Nastasi, stanno gestendo da qualche giorno il dossier che io avevo lasciato indietro». Entro il 2017 dovremmo riuscire a decidere cosa fare: figuriamoci poi quanto ci vorrà per farlo.

Un'altra prevaricazione dell'economia (capitalistica) sul diritto. L'erogazione dell'acqua è un servizio pubblico di "rilevanza economica" che deve assoggettarsi alle regole di mercato, non c'è diritto che tenga. economiaepolitica, 10 luglio 2017 (i.b)
Qualche settimana fa il Consiglio di Stato ha respinto, in via definitiva, i ricorsi presentati dal Codacons, da Federconsumatori e dall’Associazione Acqua Bene Comune Onlus contro il metodo tariffario approvato nel 2012 dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) per calcolare la tariffa che gli utenti devono pagare ai loro gestori per la fornitura e il trattamento delle acque.
Le associazioni dei consumatori e i proponenti dei referendum per l'acqua pubblica del 2011 lamentavano il fatto che l’Aeegsi non avesse rispettato, nell’elaborazione dei metodi di calcolo, gli esiti del secondo referendum che aveva abolito dal calcolo delle tariffe idriche l’«adeguatezza della remunerazione del capitale investito» con il voto di oltre 26 milioni di italiani.
Volendo riassumere brevemente le motivazioni del Consiglio di Stato, si potrebbe dire che, secondo il supremo giudice amministrativo, ai sensi della normativa italiana ed europea attualmente in vigore il servizio idrico è un servizio ‘a rilevanza economica’ e, dunque, anche per tale servizio vale la regola per cui tutti i costi devono essere coperti dalla tariffa secondo il principio del “full cost recovery”. In presenza di tale principio, il diritto deve fare un passo indietro e lasciare il campo alla scienza economica che è la sola legittimata a stabilire quali voci di spesa rientrino effettivamente tra le nozioni di costo e, di conseguenza, debbano essere coperte dalla tariffa e pagati dagli utenti finali.
Non è un caso, dunque, che per stabilire la correttezza del metodo di calcolo delle tariffe, il Consiglio di Stato abbia affidato a un collegio peritale composto da tre professori di economia industriale il compito di stabilire se le formule e i parametri adottati dall’ Aeegsi, per disciplinare la componente tariffaria relativa agli “Oneri finanziari del gestore del Servizio idrico integrato «rientrino, o meno, entro i limiti di attendibilità e di ragionevolezza del settore tecnico-scientifico che qui viene in rilievo, sotto il profilo della loro idoneità a riflettere la componente tariffaria strettamente limitata alla copertura dei costi di capitale proprio investito» [1]
Il collegio peritale – composto da tre professori uno della Sapienza Università di Roma, uno dell’Università di Roma Tor Vergata e uno dell’Università LUISS “Guido Carli”, designati dai rispettivi Rettori – ha stabilito che «le formule e i parametri diretti a calcolare il tasso di interesse di riferimento e la componente di copertura della rischiosità rientrano nei limiti di attendibilità e di ragionevolezza del settore tecnico-scientifico dell’economia industriale, sotto il profilo della loro idoneità a riflettere la componente tariffaria strettamente limitata alla copertura dei costi del capitale investito. Inoltre, sono in linea con le pratiche della regolamentazione in ambito nazionale ed internazionale» [2]
Insomma gli interessi sul capitale proprio investito si devono pagare in ogni caso perché rientrano nel principio di totale copertura dei costi come ci insegna la scienza ‘esatta’ dell’economia industriale.
Non vi può essere, dunque, alcuna attività a rilevanza economica che escluda dai propri conti il costo del capitale proprio investito e nessun referendum popolare potrebbe stabilire il contrario.
Del resto il quesito referendario del 2011, secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato, è stato pienamente rispettato, dal momento che la remunerazione del capitale investito non deve essere più «adeguata» e, dunque, non assicura una posizione di ‘rendita’ prefissata una volta per tutte dal legislatore, ma è stabilita direttamente dai mercati finanziari e trasferita poi nella tariffa idrica attraverso la complicata formula matematica elaborata dall’Aeegsi che garantisce agli utenti finali l’assenza di aggravi o duplicazioni e cioè la piena economicità del servizio.
Insomma il secondo quesito referendario del 2011 è stato del tutto inutile: il servizio idrico è un servizio pubblico locale a rilevanza economica da gestire secondo le leggi del mercato. Non basta eliminare l’adeguatezza della remunerazione del capitale per rendere il governo e la gestione dell’acqua estranei alle logiche del profitto.
Ciò è il segnale di un processo molto preoccupante e ancora in corso: il progressivo appiattirsi del diritto sulla scienza economica. Tale processo avviene in due modi: da un lato attraverso un’interpretazione della normativa in vigore che privilegia le ragioni dell’efficienza economica su quelle della natura del servizio pubblico, dall’altro con l’ingresso diretto della scienza economica, attraverso lo strumento della consulenza tecnica, all’interno della decisione giudiziaria.
Il primo punto è stato messo in luce già qualche anno fa dal giurista francese Alain Supiot che ne aveva individuato le ragioni nel fatto che «La struttura linguistica e il mercato appaiono dunque oggi come i due punti di riferimento attorno ai quali le scienze sociali strutturano la loro ricerca delle leggi sotterranee che governano le questioni umane» [3]. La prova di ciò sta nel fatto che proprio la locuzione “rilevanza economica” applicata al servizio idrico integrato funge da paradigma linguistico attraverso cui il mercato entra prepotentemente nel settore dell’acqua. Tale locuzione dal punto di vista del diritto ha una duplice funzione, da un lato, serve a far rientrare anche i servizi idrici all’interno dei servizi pubblici locali in regime di libera concorrenza sia pure di concorrenza per il mercato e non di concorrenza nel mercato; dall’altro, serve a far rientrare la materia dell’affidamento dei servizi idrici all’interno della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Sono questi i motivi per i quali il legislatore italiano nel 2003 ha sostituito il concetto di «rilevanza industriale» con quello più ampio e indefinito di «rilevanza economica» per definire le caratteristiche di quei settori nell’ambito del servizio pubblico locale nei quali si doveva procedere con affidamenti mediante procedure ad evidenza pubblica [4].
Il secondo punto, cioè quello che si riferisce all’ingresso diretto della scienza economica nelle decisioni che riguardano la gestione del servizio idrico, trova la sua prova inconfutabile proprio nel fatto che i giudici del Consiglio di Stato si affidano alla consulenza tecnica di tre economisti per definire se le tariffe idriche vengono calcolate correttamente attraverso il metodo elaborato dall’Aeegsi. Solo la scienza economica può dire, infatti, al diritto come comportarsi per il calcolo delle tariffe determinando così una vera e propria identificazione della razionalità giuridica con quella economica.
La scelta politica viene così affidata esclusivamente al mercato senza lasciare alcuno spazio per una allocazione alternativa delle risorse affidata ad una diversa gerarchia di valori come quella che sta alla base della scienza giuridica.
Anche questo rischio era stato identificato qualche anno fa da un sociologo da poco scomparso, Ulrich Beck, il quale aveva sottolineato come le decisioni su come guidare i processi di investimento non sono tanto il risultato di una decisione diretta dei vertici imprenditoriali, quanto un effetto collaterale: «È importante sottolineare che il metapotere di indirizzare gli investimenti non dipende da vertici manageriali che perseguono attivamente un disegno politico. Piuttosto, accade loro di fare “politica” come effetto collaterale. Il loro coinvolgimento non è né politico né non-politico è una sorta di sub-politica globale» [5].
Resta il problema di capire fino in fondo quali siano i modi per evitare la concentrazione delle risorse finanziarie in un settore quale quello dell’acqua in cui la progressiva “depubblicizzazione” ha permesso l’ingresso di un numero rilevante di operatori privati. La strategia finora messa in campo dal Forum dei movimenti per l’acqua è stata quella di contrastare i processi di privatizzazione attraverso tutti gli strumenti giuridici a disposizione: prima con il ricorso a una legge di iniziativa popolare, che non è stata mai discussa dal Parlamento, poi promuovendo i referendum popolari del 2011, i cui esiti sono stati neutralizzati dal legislatore. Anche l’ultima forma di resistenza, quella di rivolgersi alla magistratura amministrativa contro le decisioni dell’Aeegsi ha portato a una sonora sconfitta.
Insomma si potrebbe dire che se gli italiani con il referendum del 2011 avevano provato a tirar fuori l’acqua dal sistema di mercato, ma l’intento non è stato raggiunto anche perché il collegio degli esperti di economia aziendale ha contribuito a far rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta: la teoria microeconomica dominante riconosce anche la remunerazione del capitale come esito spontaneo del mercato.
Si potrebbe dire, con Karl Polanyi, che una volta istituito il sistema di mercato «deve essere lasciato funzionare senza interferenze esterne. I profitti non sono più garantiti ed il commerciante deve realizzarli sul mercato. Si deve anche permettere che i prezzi si regolino da soli, ed un tale sistema autoregolato di mercati è ciò che intendiamo per economia di mercato» [6].
Tenendo conto del fatto che i referendum sull’acqua sono stati in grado di portare alle urne ventisei milioni di italiani in un periodo di elevata astensione politica, l’idea di una gestione pubblica dell’acqua potrebbe essere ancora in grado di smuovere una vasta partecipazione politica diretta a realizzare la redistribuzione dei benefici derivanti dall’utilizzo di una risorsa che va facendosi sempre più scarsa e, per questo, sempre più preziosa per l’intera comunità degli utenti, compresi quelli delle generazioni future.
Note
[1] Consiglio di Stato, sent. n. 2481 del 26 maggio 2017.
[2] Consiglio di Stato, sent. n. 2481 del 26 maggio 2017.
[3] A. Supiot, Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto, Milano, 2006, p. 92.
[4] Mi si consenta di rinviare sul punto a S. Marotta, Le tariffe del servizio idrico integrato dopo il referendum, in «Munus», n. 3/2012, pp. 657-666.
[5] U. Beck, La società cosmopolita. Prospettive dell’epoca postnazionale, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 233.
[6] K. Polanyi, La grande trasformazione, Einaudi, Torino, 1974, p. 56.
Riferimenti
Nelle cartelle di eddyburg
"Clima e risorse" e
"Clima e risorse*" si possono leggere gli articoli relativi sia alla campagna referendaria che alle conseguenze della privatizzazione dell'acqua pubblica.
"Creare comunità" è la nuova "mission" annunciata da Facebook che sta avviando di 1500 appartamenti in una cittadina di sua proprietà. Una volta si chiamavano company town. la Repubblica, 10 luglio 2017 (p.s.) con postilla
Adesso nella Silicon Valley inizieranno presto i lavori di una nuova cittadina. Ci sarà una farmacia, un negozio di alimentari, trasporti efficienti, e 1500 appartamenti. A delimitarne i confini, forse, un cartello con stampato un pollice in su. Perché stiamo parlando di Willow Park, il primo villaggio di proprietà Facebook. A metà strada tra quartiere residenziale e luogo destinato agli uffici. La compagnia ha appena annunciato di aver presentato il piano al consiglio comunale di Menlo Park, sede dell'azienda di Mark Zuckerberg.
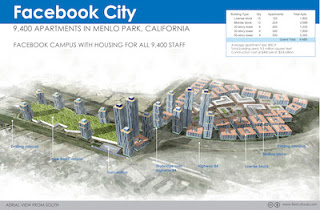
È proprio alle spalle del quartier generale che si snoderà questo piccolo paese, a poco più di 40 chilometri da San Francisco. Data di fine dei lavori prevista: 2021. Gli alloggi targati Facebook saranno a disposizione di tutti e non solo dei dipendenti della rete sociale. E un 15 percento di loro verrà concesso a prezzi inferiori a quelli di mercato.
Una scelta necessaria, spiega in un post sul blog ufficiale del social network John Tenanes, responsabile degli immobili e delle infrastrutture di Facebook. Le ragioni sono facili da capire. Negli ultimi anni il boom delle aziende hi-tech con radici nella valle del silicio ha moltiplicato la forza lavoro presente nell'area. Con conseguente congestione del mercato immobiliare. I prezzi degli affitti sono schizzati alle stelle. E una delle città più penalizzate è stata Menlo Park. Qui, stando alle stime di una compagnia immobiliare riportate dal Guardian, la somma mensile necessaria per aggiudicarsi un appartamento con due stanze da letto è più che triplicata dal 2011 a oggi, raggiungendo quota 3,349 dollari. Una delle più alte degli Stati Uniti e considerevolmente maggiore di quella necessaria a New York.

Il governo ha fallito negli investimenti infrastrutturali, è il j'accuse di Facebook. Da qui la scelta di fare da sé. Anche perché più di 9mila persone lavorano già a Menlo Park. Il numero è più raddoppiato in un anno e ci si aspetta che cresca ancora, in fretta. Il nuovo villaggio promette di essere da "like": tutti i servizi necessari, tanto verde (stando alle prime foto a disposizione), trasporti efficienti. "La nostra speranza è di creare uno spazio fisico che supporti la nostra comunità", ha spiegato Tenanes.

Un'iniziativa ben accolta dalle autorità locali. "Spero che sempre più compagnie hi-tech facciano proposte di questo tipo", ha twittato Kirsten Keith, sindaco di Menlo Park. Si tratta dell'ennesimo passo che possiamo contestualizzare all'interno della nuova mission annunciata da Facebook qualche settimana fa: creare comunità appunto. Ma se tutto ciò vi ricorda un po' la società distopica tratteggiata nel romanzo di Dave Eggers, Il Cerchio, potreste non essere in torto.
postilla
Le "company towns" non sono certo una novità nello sviluppo del capitalismo. Nei soli Usa sono 3.500, e sono numerose in tutte le regioni del mondo. Nella piccola Italia le "città aziendali" sono le seguenti: Metanopoli, sede della ENI, fu creata da Enrico Mattei per i lavoratori dell'azienda e per i laboratori allora all'avanguardia legati allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi della Padania; Crespi d'Adda, costruita per i lavoratori del cotonificio Crespi, è entrata a far parte della Lista del Patrimonio dell'umanità dell'Unesco; così la seteria San Leucio, manifatture reali dei Borboni, sono oggi anch'esse ‘patrimonio dell'umanità dell'Unesco; la “città sociale di Valdagno" fu realizzata ai margini dell’omonima cittadina in relazione all’allargamento e alle razionalizzazione fordista dei lanifici Marzotto. Rosignano Solvay, creata dalla Solvay Group per i lavoratori dello stabilimento, fu costruita a fianco della città stessa; Zingonia, tra Milano e Brescia, fu realizzata dall’imprenditore Renzo Zinconi, in relazione al boom economico della regione. (e.s.)
 ». il manifesto, 11 luglio 2017 (c.m.c.)
». il manifesto, 11 luglio 2017 (c.m.c.)
La recente notizia che alcune opere di difesa militare realizzate da Venezia, tra il XVI e XVII secolo a Bergamo e Palmanova, in provincia di Udine, oltre che in Croazia (Zara e Sebenico) e in Montenegro (Cattaro) sono state inserite dall’Unesco tra i beni «patrimonio dell’umanità», si presta a varie considerazioni. Per una volta, intanto, appare giustificato un po’ di compiacimento nazionale. Compiacimento per il nostro passato storico, ovviamente, non certo per la cura con cui i nostri contemporanei preservano l’immenso e impareggiabile patrimonio artistico di questo Paese. Venezia merita ampiamente tale riconoscimento, anche se assegnato a opere fuori dalla Laguna. Vale la pena di ricordare che la Serenissima realizzò nel XVIII secolo un’opera formidabile di difesa, non militare, ma contro le mareggiate, i cosiddetti Murazzi. Una imponente diga in pietra d’Istria di diversi chilometri, che ancora resiste alle tempeste dell’Adriatico, nonostante le rovine del tempo e dell’incuria e la cementificazione degli anni recenti.
Ma si dovrebbe premiare Venezia anche per un’opera suprema di difesa: quella della salvezza della Laguna dal processo di interramento cui la condannavano i fiumi che vi sfociavano. Senza quest’opera gigantesca della Repubblica, durata diversi secoli (fatta dallo scavo quotidiano del fango dei rii, della deviazione di grandi fiumi dalla loro foce naturale, di una lungimirante politica di tutela) noi oggi non avremmo avuto il gioiello urbano che ancora possiamo ammirare. Poco prima del riconoscimento di tali opere, l’Unesco aveva assegnato un posto nel patrimonio dell’umanità anche alle antiche faggete del nostro Paese, da quelle del centro Italia, scendendo al Parco Nazionale d’Abruzzo, agli antichi boschi della Foresta Umbra, in Puglia, e poi in Calabria.
Questo premio fa subito scattare di riflesso di ingenue rivendicazioni, del tipo: le antiche faggete sì, e perché no la Sila? Forse la più vasta foresta di conifere del bacino del Mediterraneo, un frammento di Nord Europa a due passi dall’Africa, ricca di esemplari pluricentenari, una specie di miracolo ecologico che resiste al tempo, in gran parte incontaminato. Ma le rivendicazioni si spengono subito, non solo per ragioni di stile, di fronte al dono appena ricevuto. Soprattutto perché si fa strada un pensiero: quanto facciamo noi italiani, uomini di cultura, docenti, insegnanti, esponenti politici per promuovere la conoscenza e l’amore per il nostro patrimonio artistico e naturale?
Faggete? Che cosa sono le faggete? Vi immaginate quale imbarazzato stupore si disegnerebbe sul volto della maggioranza degli italiani, se un intervistatore solerte andasse in giro a porre la domanda: che cos’è una faggeta? E tuttavia nessuno si deve stupire dell’imbarazzo e dell’ignoranza. Perché questi sono esiti perseguiti da decenni dal più rozzo e ignorante ceto politico della nostra storia recente.
Perché le persone comuni, a meno che non siano botanici o agronomi, dovrebbero sapere che cosa sono le faggete? La geografia è stata bandita dalla scuola, le scienze naturali sono insegnate su poche paginette dei manuali, i nostri ragazzi non vedono mai un albero, un bosco, una campagna, un paesaggio agrario, con l’aiuto di un insegnante capace di spiegarne storia, morfologia, ragioni ambientali. Si parla mai di tali temi, in Italia, quando si mettono in atto le varie riforme della scuola? E, naturalmente, non meno perseguita è l’ignoranza artistica dei nostri ragazzi, che in gran parte escono dalla scuola secondaria senza alcuna nozione di storia dell’arte, delle vicende di bellezza e di civiltà che contrassegnano il nostro millenario passato.
Il Paese dotato del più ricco patrimonio artistico del pianeta alleva generazioni incapaci di riconoscere e apprezzare un’eredità sontuosa. Viene il sospetto, troppo sontuosa e ingombrante per stare dentro gli schemi rozzi dell’economicismo e dello sviluppismo dominanti: la sola cultura che orienta un ceto politico senza visione e senza memoria.
del gruppo di ricerca "Emidio di Treviri", che riflette sulle modalità distorte attraverso cui si intende provvedere al bisogno abitativo nelle aree terremotate, compiacendo i costruttori e spostando le popolazioni. 10 luglio 2017 (p.d.)
“Lo spazio è diventato uno strumento politico di primaria importanza per lo Stato. Lo Stato usa lo spazio per garantire il controllo sui luoghi, la sua stretta gerarchia, l’omogeneità del tutto e la segregazione delle parti”
Henri Lefebvre, 1974
Sono passati ormai dieci mesi dalla prima scossa di terremotoche ha sconquassato l’Alta Valle del Velino, del Tronto e poi il resto. Diecimesi da quando la geografia di quello spazio che dalla catena dei Monti dellaLaga attraversa i Sibillini è scomparsa sotto la fredda, uniformante e genericadenominazione di “cratere”. Ma i luoghi conservano traccia anche del temposospeso. Mentre il futuro di chi è stato parcheggiato nelle strutturericettive della costa resta appeso al rimpallo di responsabilità traUnioncamping, Federalberghi, Protezione civile ed enti regionali, ad esserecerto è il fatto che delle decine di migliaia di casette SAE (Strutture Abitativedi Emergenza) ordinate per i terremotati se ne vedono davvero poche. Il 5giugno ne è stata assegnata la prima manciata sul lato Marche, visto che leuniche 97 ad oggi abitate sono state inaugurate tra Amatrice e Norcia. Ancheper le casette di Pescara del Tronto (le prime che saranno abitate nelleMarche) è toccato l’esito di essere estratte a sorte tra le molte famiglie inattesa: anche stavolta - come ad Amatrice e Norcia - l’esasperazione deiterremotati si è trasformata in tensione, lacrime e rabbia durante ilsorteggio.
Sulla base delle esperienze pregresse e grazie agli strumenti contrattuali messi in campo” [1] dalla Protezione Civile, l’attesa sarebbe dovuta durare appena sei mesi. Il dato certo è che ad oggi, nelle Marche, la regione che registra il numero più alto di sfollati e sfollate in attesa di una sistemazione nei SAE (5.040, secondo i dati ufficiali), nessuno ha ancora ricevuto le chiavi dei moduli abitativi e nella maggioranza dei comuni interessati non sono neanche partite le opere di urbanizzazione. Ora più che mai è evidente la condizione di affanno in cui versano le istituzioni circa la gestione della questione abitativa dei terremotati. In questo tempo immobile che perimetra l’emergenza, catturato e scandito dal succedersi di decreti ed ordinanze, il Governo mette in campo l’ennesima opzione per cercare di raddrizzare i dati.
L’articolo 14, titolato “Acquisizione d’immobili ad uso abitativo per l’assistenza della popolazione” ed inserito per la prima volta nel Decreto n.8 del 9.11.2017 (convertito in legge lo scorso 7 Aprile), autorizza infatti le Regioni a comprare unità immobiliari da destinare in maniera provvisoria ai terremotati e, in un secondo momento trasformarle in “case popolari”. Una notevole operazione di acquisizione al patrimonio pubblico residenziale, dunque, come non succedeva da decenni e compiuta attraverso il Fondo nazionale per le Emergenze (ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225). Costituirebbe un importante passaggio di riflessione ragionare sul fatto che a) la “domanda di casa” costituisca un tema all’ordine del giorno solo in una situazione straordinaria come il post-terremoto, b) che lo Stato cerchi di tamponare parte della questione del disagio abitativo solo grazie all’emergenza, nonché c) che le istituzioni individuano, tra le molte categorie sociali in affanno, quella dei terremotati quale target-group meritevole di un intervento - al contrario di tutti gli altri -. Ma tralasciando per il momento questi interrogativi e stando a una superficiale lettura del fenomeno, l’operazione dell’art.14 sembrerebbe quasi rappresentare un’inversione di tendenza rispetto alla grande ritirata dello Stato dal sociale delle ultime decadi.
«4. Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 può essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni nel cui territorio sono ubicati.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie che sono rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la gestione della situazione di emergenza.»
L’articolo 14 della legge avrebbe potuto rappresentare, oltre a una simbolica inversione di tendenza rispetto all’interesse pubblico per chi ha necessità reali, anche un argine alla bolla speculativa del mercato degli affitti nelle zone terremotate. Una situazione che colpisce soprattutto le aree periferiche del cratere e i territori ad esso immediatamente adiacenti, gonfiata nel corso dei mesi dal meccanismo del contributo di autonoma sistemazione (CAS). Il CAS, inizialmente pensato come una misura per sostenere chi aveva perso tutto, in alternativa alle altre forme assistenziali, si è trasformato infatti in un’ iniqua forma di sostegno al reddito [2] che - nelle sue distorsioni - ha anche contribuito a deformare il mercato degli affitti. Ma se rubrica legis non est lex ed il disastro rappresenta sempre più spesso un’occasione privilegiata per una diversa redistribuzione delle risorse, facilmente è possibile notare quanto l’aleatorietà e la poca specificità con cui la norma è stata redatta abbia lasciato ampi margini interpretativi alle quattro Regioni coinvolte, chiamate ad applicarla attraverso l’emissione di bandi pubblici. I bandi regionali, indipendenti l’uno dall’altro, hanno operato in maniera diversa, come se i confini amministrativi rappresentassero una reale spartizione dei luoghi. Come se i terremotati di Accumoli (Rieti, Lazio) abbiano caratteristiche così diverse rispetto a quelli di Arquata (Ascoli P., Marche) o di Ceppo (Teramo, Abruzzo) o di Norcia (Perugia, Umbria), tutti compresi nello stesso raggio di 20 chilometri.
Analizzando le specifiche degli avvisi di manifestazione di interesse pubblicati finora, salta subito all’occhio quanto l’implementazione della legge abbia assunto di regione in regione forme dissimili e, in alcuni casi, pericolose. La prima evidenza, conferma la straordinaria efficacia riscossa dai Tavoli tecnici permanenti di confronto coordinati dal Direttore dell’Ufficio speciale per la Ricostruzione, ed avviati, ad esempio nel caso della Regione Marche, con l’Associazione dei Costruttori (ANCE - Confindustria). Scorrendo le specifiche del bando emanato dalle regioni adriatiche, è facile ravvisare quanto le modalità di applicazione di una misura potenzialmente virtuosa in linea di principio, corrano il rischio di scadere nella possibilità di implementare i meccanismi di speculazione e di rendita del mercato immobiliare. In base alla regolamentazione stilata dalla Regione che è stata coinvolta in due terremoti e che annovera 27.046 terremotati, le abitazioni devono essere preferibilmente nuove, prioritariamente mai utilizzate e possono trovarsi anche fuori dai comuni del cratere (al contrario di Marche e Abruzzo, l’Umbria [3], ad esempio, non prevede quest’ultimo punto). Il pensiero corre immediatamente alle cementificazioni della costa:
«12. Non essere mai stati abitati
[...]
Le offerte potranno riguardare anche gli alloggi ubicati in immobili in corso di realizzazione, acondizione che l'offerta riguardi un gruppo di alloggi compresi nello stesso stabile e che questi vengano ultimati e resi disponibili entro 3 mesi dalla data di adozione dell'atto di formale di adesione all'acquisto da parte del COR, e comunque alla stipula dell'atto notarile di acquisto.»
A ribadire il concetto, le regioni adriatiche chiariscono che non sono interessate alle abitazioni di tipo rurale. Ma per il costruttore più esigente il regalo arriva negli ultimi passaggi del bando: l’offerta di acquisto delle istituzioni è valida anche per quelle case e quegli edifici ancora non ultimati, previa consegna entro i tre mesi dalla stipula dell’acquisto [4]. Vengono quindi compresi gli scheletri che gli speculatori hanno abbandonato sul territorio, a patto che siano ultimati a firma del contratto avvenuta. Una simile applicazione dell'art. 14 rappresenta un assist senza precedenti agli impresari edili che, favoriti nelle graduatorie rispetto ai singoli proprietari e alla logica delle ristrutturazioni, possono piazzare l’invenduto storico alle Regioni.
Il primo bando pubblicato dall’Erap [5], l’ente marchigiano per l’abitazione pubblica, che si è chiuso lo scorso 3 Aprile, ha ammesso 654 offerte di vendita (85 nella provincia di Ancona, 148 ad Ascoli Piceno, 109 a Fermo e 312 a Macerata) per un totale di 95.749.743,72 milioni di euro [6]. All’indomani della chiusura del bando, commentava così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli: “è un ulteriore tassello che, insieme con altri provvedimenti, ci consente di agevolare il processo di rientro delle persone le cui abitazioni hanno subito danni gravi dal sisma, in attesa della ricostruzione pesante”. Ma la prassi sembra essere direzionata proprio nel verso opposto, incentivando le urbanizzazioni incompiute, favorendo così lo spopolamento dei territori interni colpiti dal sisma. Infatti, come si nota dalla mappatura, la maggior parte degli immobili individuati dal bando è collocata nelle zone dove negli ultimi anni si sono verificati i maggiori incrementi di densità urbanistica, ben lontano dalle aree interne.

Mappatura delle proposte di acquisto valutate idonee all’acquisizione (in arancione) e dei comuni colpiti dai terremoti del 24/agosto, 26-30/ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (in blu). Dati pubblicati da graduatoria “Erap - Marche” a seguito del primo avviso pubblico di manifestazione di interesse scad. 03/04/2017.
L’articolo 14 non è che l’ennesimo tassello di una politica imposta dall’alto, senza il coinvolgimento delle popolazioni interessate. Pensare di trasferire i terremotati e le terremotate lontano da casa, ospiti di soluzioni che potenzialmente sono destinate a durare anni, non collima con una una ricostruzione immaginata insieme alla gente per ridare un futuro alle aree interne. Al tempo stesso rappresenta una delle più intense operazioni di trasferimento della popolazione dai tempi dello sfollamento sulla costa domiziana degli abitanti dei quartieri centrali di Napoli cacciati per far posto al Centro Direzionale. Solo che stavolta, in virtù della retorica progressista dello Stato che finalmente torna a fare edilizia pubblica per chi ha bisogno, bisognerà anche ringraziarli di questo favore fatto ai costruttori ai danni di terremotati e aree interne.
per “Emidio di Treviri”
Gruppo di Ricerca sul post-sisma del Centro Italia
EMIDIODI TREVIRI
Il gruppo di ricerca"Emidio di Treviri" è un progetto di inchiesta sul post-sisma delCentro Italia. Nasce nel Dicembre 2016 da una Call for Research lanciata graziealle Brigate di Solidarietà Attiva, un’associazione che interviene in contestid’emergenza promuovendo solidarietà dal basso e autogestione. Decine didottorandi, ricercatori e professori universitari hanno aderito all’appellodando vita a una significativa esperienza di ricerca collettiva e autogestita.Scienziati sociali, architetti, psicologi, urbanisti, antropologi, ingegneri, giuslavoristietc. si sono impegnati a coordinarsi in maniera orizzontale per costruireun’inchiesta sociale critica sul post-sisma dei Sibillini che ha colpitoquattro regioni durante tre momenti intensi (Agosto 2016; Ottobre 2016; Gennaio2017).
Nulla di fatto per il progetto del sindaco Brugnaro di spostare le grandi navi a Marghera. In questo articolo si tutte le difficoltà e a chi giova perdere tempo e mantenere lo status quo. la Nuova Venezia, 8 luglio 2017 (m.p.r.)
Il sindaco Brugnaro aveva
anticipato ai giornali il disegno che doveva dare - stando alle parole del ministro Delrio - risposta risolutiva al permanere delle navi da crociere nella Laguna di Venezia. La proposta finale sembra essere un disegno che vede le navi da crociera risalire i canali industriali dalla bocca di Malamocco per attestarsi, alcune, in più siti interni all'area di Porto Marghera, altre invece proseguire per raggiungere la Marittima attraverso il canale Vittorio Emanuele. Vi hanno lavorato l'Autorità portuale e gli uffici della Struttura di missione del Mit a stretto contatto con le Compagnie che erano sedute alla stesso tavolo con le pubbliche amministrazioni in ripetute riunioni. L'ultima riunione si è svolta nei giorni scorsi e si è conclusa con la presa d'atto del nulla di fatto e con il rinvio del Comitatone a fine settembre. L'ultima sospensione sembra assumere quindi i contorni dell'ennesimo annuncio seguito da nessuna decisione.
È utile esaminare perché, e quali sono gli ostacoli, non ignoti, che sul piano tecnico delle approvazioni si oppongono, al momento delle verifiche a questo ultimo disegno, prodotto al di fuori di ogni procedura codificata. Per scavi e qualità ambientale, attiva e passiva, allo stato attuale questo è solo un disegno, non ancora un progetto, tanto meno un progetto definitivo: manca ogni dettaglio tecnico e ogni stima numerica e, soprattutto, manca il proponente. Possiamo comunque già dire che, una volta individuato il proponente (necessariamente privato) e sviluppato il progetto, questo dovrebbe essere assoggettato necessariamente alla "Via" se non altro perché il primo requisito della Via è l'impatto sulla salute e sicurezza umana. Il disegno si sviluppa in zona industriale ad altro rischio di incidente rilevante.
È una ipotesi talmente imponente in scavi e stravolgente in logistica, che sembra difficile che coloro che lo stanno sviluppando possano pensare di evitare di sottoporre il progetto alla valutazione per la sicurezza, alla valutazione sull'impatto ambientale delle modifiche territoriali previste, sui cambiamenti delle dinamiche idrauliche, sulla natura dei fanghi da scavare, allo smaltimento dei medesimi, sulla modifica di antiche banchine da sbancare, sulla discarica dei fanghi delle Tresse da dragare, sulle recenti strutture di contenimento del canale industriale da disfare. Infine non sembra nemmeno evitabile la valutazione ambientale strategica riservata ai Piani e Programmi. Il Contorta, chiamato alla Via dal Comitatone, era un progetto di ambizioni molto inferiori rispetto a questa proposta: e non ha superato l'esame della Valutazione di impatto ambientale.
Dico questo perché compito di una Pubblica amministrazione è anche quello di non incorrere - o far incorrere - in azioni temerarie. Aggiungo che il MinAmbiente non sembra sia stato interessato ancora a questo disegno per la valutazione di assoggettabilità alla Via e alla "Vas". Ìl diverso uso delle aree di Porto Marghera, infatti, dovrebbe essere sottoposto a Vas (Valutazione ambientale strategica) in un nuovo e diverso Piano regolatore portuale dato che questo diverso uso comporta una modifica al Piano regolatore vigente e manca di essere compreso nelle recenti indicazioni del progetto di Piano assegnato con bando di gara appena l'anno scorso.
L'Autorità portuale, a firma del precedente presidente, Paolo Costa ha bandito la gara per il nuovo Piano regolatore portuale e queste diverse destinazioni e attività oggi ipotizzate per le crociere nelle aree del porto commerciale non sono comprese nel bando di gara, anche perché, in molti e precedenti Atti ufficiali della stessa Autorità portuale, erano state scartate come incompatibili con le funzione portuale commerciale e industriale. Per l'area Syndial, poi, la bonifica è stata appena finanziata dal Cipe per sistemare la nuovo area container in funzione di "on-port". Ora l'area dovrebbe essere riconvertita nel progetto approvato negli Atti del Cipe ad altra funzione privata e rimarrebbe da chiarire nel Piano portuale dove andrebbero i container e chi pagherebbe la bonifica.
Non è azzardato supporre che questo nuovo disegno per le navi da crociera non possa arrivare ad alcun esito positivo. Tutte le ipotesi sulle aree e sullo scavo del Vittorio Emanuele che questo disegno riunisce, sono state in precedenza più volte valutate, una per una, dall'Autorità marittima e considerate negativamente dal punto della sicurezza della navigazione, per la presenza di impianti industriali ad alto rischio, e per la commistione dei traffici. Il disegno ora preannunciato, stando alle dichiarazioni dei comparti produttivi, porta ad affossare l'attività del Porto commerciale che, a vederla anche dal lato occupazionale, conta migliaia di addetti effettivi e ben strutturati.
Alla fine proporre soluzioni, che sono destinate alla bocciatura, avrebbe l'unico effetto che le navi dovrebbero restare - sine die - sulla rotta di San Marco. Rotta percorsa ora in modo illegittimo: infatti, caduto il Contorta, cui era legata la deroga al divieto del Clini-Passera, non vi è altra soluzione individuata (che deve essere con Via positiva di compatibilità ambientale), cui la Capitaneria di porto può legare la deroga al divieto. L'unica soluzione individuata disponibile rimane il progetto della Duferco. L'esistenza di questo progetto non potrà essere ignorata a lungo, pena l'insistenza di una violazione di legge, come ho avuto modo di segnalare anche alle Autorità responsabili della tutela della legge.
I posti di lavoro della crocieristica dei quali si danno volta per volta numeri diversi, possono essere sicuramente salvati in modo certo spostando la crocieristica nel distretto esterno alla laguna. Certo, sarebbe utile un'indagine - con uno studio dedicato - circa la qualità e natura dei contratti dei lavoratori, dei fornitori dei servizi e dei guadagni dei concessionari e raccomandatari che hanno goduto finora della concessione esclusiva della Marittima che ora le Compagnie hanno monopolizzato con l'ingresso in Vtp. Quali sarebbero gli sviluppi futuri in un ambiente concorrenziale aperto?
Andreina Zitelli è docente Iuav, già membro commissione "Via" nazionale
Concedendo un contentino, un piccolo tratto libero nella spiaggia libera dell'ex Ospedale al Mare, si determins la privatizzazione di tutte le spiagge del Lido. la Nuova Venezia, 6-7 luglio 2017 (m.p.r.)
la Nuova Venezia, 7 luglio 2017
LIDO: C'È L'INTESA SULLE
AREE LIBERE IN SPIAGGIA
di Enrico Tsbtucci
Lido. Spiagge un po' più «libere» nel nuovo Piano degli arenili del Lido. La commissione consiliare di ieri ha visto infatti una parziale retromarcia della Giunta - con l'assessore all'Urbanistica e Ambiente Massimiliano De Martin - sulla "privatizzazione" delle spiagge e l'aumento delle metrature delle concessioni ai gestori degli stabilimenti. La Giunta presenterà infatti un emendamento che consentirà una fascia di 30 metri dalla battigia, in cui - se i gestori dei vari stabilimenti saranno d'accordo - i clienti potranno stare con ombrelloni, asciugamani o sdraio senza dover pagare nulla. Una situazione che servirà soprattutto per spiagge come la Zona A - dove è consuetudine che molti clienti della capanne si spostino in riva - ma che non cambierà invece in altre come quelle di Excelsior e Des Bains, dove i gestori lo consentiranno. In ogni caso, anche aumentando le concessioni di oltre il 30 per cento di spazi, i gestori non potranno aumentare le attrezzature di più del 20 per cento.
Accolta in linea di principio anche la proposta del consigliere comunale della Lista Brugnaro Maurizio Crovato di creare una nuova spiaggia libera nell'ultimo tratto della Zona A - adiacente all'ex Ospedale al Mare - dove chiunque potrà sostare liberamente, anche se dovrà pagare i servizi che deciderà di utilizzare. Una svolta motivata anche dalla consapevolezza che la Lega (con la consigliera Silvana Tosi) e Forza Italia, con il capogruppo Saverio Centenaro, non avrebbe altrimenti votato il Piano degli arenili in Consiglio comunale.
«La proposta originaria della Giunta era, tra l'altro», commenta la consigliera M5S Elena La Rocca, «di vietare agli utenti delle spiagge della zona A e di San Nicoletto di portare in riva propri ombrelloni e seggioline. Per due commissioni abbiamo insistito sull'impatto sociale che questa scelta avrebbe avuto, visto che sono spiagge frequentate da famiglie e persone anziane per le quali il proprio ombrellone in riva è indispensabile. Se si vuole aumentare l'affluenza, basta aggiungere collegamenti acquei verso San Nicolò e gli Alberoni, in modo da rendere il viaggio più comodo e incrementare l'affluenza da Mestre e da Marghera. La nostra proposta prevederebbe sia migliori collegamenti con i battelli sia una pista ciclabile che faccia l'intero giro dell'isola in sicurezza in tutte le sue parti». «Dobbiamo rendere il Lido la spiaggia anche dei mestrini», ha sottolineato Nicola Pellicani del Pd, «e per questo servono collegamenti migliori con la terraferma»
la Nuova Venezia, 6 luglio 2017
LIDO LA SPIAGGIA
NON È PIU' PER TUTTI
di Enrico Tantucci
Lido. Il nuovo Piano particolareggiato degli arenili del Lido predisposto dal Comune - che tornerà in Commissione consiliare dopo le polemiche dell'ultima seduta riguardo alla "privatizzazione" delle spiagge, a cominciare da quella del Blue Moon - prevede complessivamente un aumento delle spiagge in concessione di oltre il 33%. Si passa da 450 mila metri quadri a oltre 600 mila metri quadri.
Ma scorrendo le superficie di concessione previste per i vari stabilimenti, si scopre che in molti casi l'aumento delle spiagge non più libere ma destinate ai servizi attrezzati dei gestori, ha percentuali ben superiori. Ad esempio per la concessione a Venezia Spiagge relativa alla spiaggia di Lungomare d'Annunzio (che comprende anche il Blue Moon oltre alla Zona A) passa da circa 69 mila a oltre 111 mila metri quadri con un aumento di oltre il 60%. Quasi il 55% di aumento di concessione per la spiaggia del Des Bains che passa da oltre 33 mila a oltre 52 metri quadrati e percentuali di crescita simili per la spiaggia dell'Excelsior da passa da poco meno di 29 mila a quasi 44 mila metri quadrati di spiaggia non più libera.
La spiaggia di fronte all'Ospedale al Mare, ora interamente libera, prevederà 75 mila metri quadri di nuove concessione, per i gestori dei nuovi resort del Club Mediterranée e di Th Hotels che dovrebbero recuperare a fini turistici il complesso con Cassa depositi e prestiti. Proprio in quest'area il consigliere della Lista Brugnaro Maurizio Crovato ha proposto di ricavare una porzione di spiaggia libera e vedremo cosa risponderà l'assessore all'Urbanistica e Ambiente, Massimiliano De Martin.
In pratica al Lido per poter trovare un pezzettino di spiaggia libera bisognerà andare fino a San Nicoletto (3 chilometri) oppure ai murazzi (quattro chilometri e mezzo). Ma c'è anche chi, con il nuovo piano degli arenili, vede ridurre la propria spiaggia, come lo stabilimento Sorriso, che passerà da circa 14 mila a circa 11 mila metri quadri di arenile in concessione. Il consiglio di municipalità del Lido, (critica anche la Lega), ha già dato parere contrario al Piano - pur ritenendolo necessario - in particolare per la "privatizzazione" della spiaggia del Blue Moon.
«Il rischio», commenta il consigliere comunale del Pd, Nicola Pellicani, tra i più critici sui contenuti del nuovo Piano anche in commissione, assieme ai consiglieri del Movimento Cinque Stelle, «è che questa operazione si risolva esclusivamente in un aumento degli spazi riservati alle attrezzature da spiaggia, con conseguente aumento del volume di affari degli stabilimenti con aumenti di costi per gli utenti. I vari bagni in concessione potranno, dove c'è spazio, installare nuove capanne oppure ombrelloni, andando anche a snaturare il profilo panoramico della spiaggia dopo decenni. Inoltre la previsione dell'amministrazione di lasciare completamente libera una fascia di 30 metri, a partire dalla battigia verso l'interno, creerà grossissimi disagi in Zona A, dove tradizionalmente tutti coloro che hanno la capanna in seconda, terza, quarta fila, si portano in avanti nella spiaggia per cercare refrigerio con sdraio e ombrelloni. Quello che invece dovrebbe fare l'amministrazione è una politica di turismo balneare, promuovendo la spiaggia del Lido tra gli abitanti della terraferma».

il Fatto Quotidiano on line, 7 luglio 2017 (m.p.r.)
Il progetto dell’Anas per unire con una superstrada il polo siderurgico di Terni con il porto di Civitavecchia risale agli anni 60, mentre i lavori partirono dieci anni dopo. Attualmente è ancora incompiuto il tratto che va da Orte al porto laziale, circa un terzo del percorso. Di questo terzo, la tratta finale, la più problematica dal punto di vista ambientale, è quella che corre da Monte Romano a Tarquinia, tratta soggetta a Valutazione di impatto ambientale (Via), il cui iter è iniziato il 3 agosto 2015.

Il percorso individuato dall’Anas si snoda per 18 chilometri e prevede 9 viadotti, 1 galleria e 2 svincoli, ed è localizzato nella vallata del fiume Mignone, una delle aree più incontaminate e ricche di bellezza del Centro Italia, tutelata dalla direttiva Habitat, volta alla conservazione degli habitat naturali di particolare pregio nel territorio europeo. Nell’ambito dell’iter della Valutazione di impatto ambientale, in data 20 gennaio, la Commissione tecnica di verifica del ministero dell’Ambiente ha espresso parere negativo al progetto, mentre, in data 15 marzo, in sede di Conferenza dei servizi tutti gli altri soggetti chiamati ad esprimersi, tranne il comune di Tarquinia ed appunto il ministero, hanno dato parere favorevole, inclusa la regione Lazio.
Adesso, la decisione finale spetta al Consiglio dei ministri che pare la adotterà in data 20 luglio. Andiamo più nel dettaglio della vicenda: ne vale la pena. Nel progetto presentato dall’Anas, secondo i tecnici del ministero dell’Ambiente che hanno redatto una corposa relazione di oltre 120 pagine, non sono stati valutati adeguatamente né l’impatto paesaggistico, né quello ambientale, compresi i rischi connessi all’inquinamento atmosferico e acustico.
Ecco alcuni significativi passi delle conclusioni del parere rilasciato dalla Commissione: “L’intervento modificherà in modo sostanziale, permanente e irreversibile il paesaggio dell’area, distruggendone la naturalità attuale. Dai foto inserimenti, si evidenzia infatti un impatto visivo insostenibile per il contesto specifico della valle del Mignone, l’arteria andrà a tagliare in due una continuità naturale, territoriale e storico culturale che invece deve essere conservata come bene di alto valore ambientale […] Il rumore e le vibrazioni, date le caratteristiche di grande valore ambientale dell’area in oggetto, si ritengono troppo elevati per poter essere accettati all’interno dei siti di importanza comunitaria (Sic) e nelle Zone di protezione speciale (Zps)”.
La stessa opinione del ministero è stata espressa dalle associazioni ambientaliste e dai comitati locali con motivate osservazioni che evidenziano, tra l’altro, come l’Anas si sia sempre di fatto rifiutata di redigere una seria Valutazione di incidenza ambientale relativa sia all’area Zps sia al Sic della valle del Mignone, cioè non abbia voluto valutare i danni che sicuramente ci sarebbero sui siti qualora l’opera fosse realizzata. Vale la pena ricordare, infatti, che la direttiva Habitat prevede la Valutazione come “un passaggio che precede altri passaggi, cui fornisce una base. In particolare, l’autorizzazione o il rifiuto del piano o progetto”. Uno studio d’incidenza incompleto, le cui conclusioni ottimistiche sono state contestate nel parere Via, ha evitato ad Anas il rifiuto o quanto meno il rischio che un approfondimento avrebbe dato risultati diversi da quelli sperati, bloccando l’iter del progetto.
Ma perché l’Anas avrebbe scelto una soluzione così impattante? Non c’erano alternative? Nel 2004, l’azienda di Stato sviluppò un diverso progetto che aggirava l’abitato di Monte Romano a Nord per poi seguire l’attuale tracciato della Aurelia bis. Progetto che, adeguato alle prescrizioni Via che ne avevano richiesto il passaggio in galleria per quasi la metà del percorso, avrebbe lasciato maggiormente integro il paesaggio che invece il progetto attuale taglierebbe in due. Nel 2007 l’Anas inoltrò il progetto al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) per il finanziamento, ma il Cipe non lo finanziò perché lo ritenne troppo costoso. Singolare, perché per altre opere sommamente costose e perfettamente inutili come l’alta velocità e il Terzo valico, il Cipe ha chiuso non uno, ma ambedue gli occhi. Allora cosa fece l’Anas? Concepì questo nuovo progetto molto meno costoso, che infatti definì essa stessa low cost e andò avanti su di esso. Quindi, l’alternativa c’era ma costava. E allora ecco un progetto che costa di meno, che sarebbe finanziato e pazienza se è sommamente impattante.
Oggi le pressioni perché l’opera sia completata ed in breve termine sono molteplici: comunità locali, Confindustria, i soliti sindacati, Associazione dei costruttori edili (Ance) e altri, compresi organi di stampa autorevoli quali Il Corriere della Sera. La solita commedia che viene recitata ogni volta che c’è una grande opera da realizzare. Qualora il Consiglio dei ministri desse il via libera nonostante il parere negativo dello stesso ministero dell’Ambiente, questa sarebbe a tutta evidenza una decisione di carattere politico e non già di compatibilità ambientale. Sarebbe lo sviluppo purchessia. E la Valutazione di impatto ambientale una barzelletta, come del resto, diciamolo, è stata quasi sempre fino ad oggi.
Anche l'Unesco fa finta di non sapere niente di Venezia: l'ennesimo ultimatum è accompagnato da apprezzamenti per il 'lavoro' fatto dai governi per la salvaguardia di Venezia. Blog Il Sole 24 Ore, 6 luglio 2017, con riferimenti (i.b)
Il bicchiere è sempre mezzo pieno o mezzo vuoto. In questo caso caso potremmo dire che è a metà. Da un lato l’Unesco apprezza i progressi per difendere Venezia e chiede continui aggiornamenti, dall’altro dice che bisogna far presto a mettere in campo interventi miranti entro dicembre 2018. Insomma la città lagunare – presa sempre più d’assalto dal turismo, almeno in alcune parti – resta sorvegliata speciale, e a fine 2018 si valuterà se inserirla nella lista dei beni in pericolo del patrimonio dell’umanità.
Di seguito la nota Mibact-Maeci-Comune Venezia sulla posizione Unesco.
Il Comitato del Patrimonio Mondiale, riunito a Cracovia per la sua 41a Sessione, ha adottato la Decisione sullo stato di conservazione del sito “Venezia e la sua laguna”.
La Decisione esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo in stretta sinergia con il Comune di Venezia e le autorità locali che hanno pienamente collaborato con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.
L’UNESCO prende dunque atto dei progressi già realizzati e, riconoscendo la complessità delle tematiche inerenti lo stato di conservazione del Sito, conferma la necessità di disporre di tempi adeguati per verificare tecnicamente le soluzioni già individuate e in corso di definizione relativamente alle principali questioni all’attenzione dell’UNESCO (progetto di governance del turismo, alternativa al passaggio delle grandi navi in Bacino San Marco, tutela dell’identità locale e delle tradizioni).
Sottolinea altresì l’opportunità che venga raggiunto un ampio consenso tra le istituzioni e i molteplici portatori d’interesse.
Tra le raccomandazioni incluse nella Decisione la richiesta di un aggiornamento del rapporto sullo stato di conservazione del Sito che illustri i progressi ulteriormente raggiunti, entro il 1 dicembre 2018, affinché sia valutato nella 43a sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale del 2019.
Si tratta di un importante risultato che rafforza l’impegno del Governo e delle autorità locali a proseguire gli sforzi già in atto per la tutela di “Venezia e la sua laguna”, a trenta anni dalla sua iscrizione nella World Heritage List.
Ed ecco – in inglese – quanto l’Unesco ha pubblicato sul proprio sito www.wch.unesco.org
The World Heritage Committee,
1. Having examined Document WHC/17/41.COM/7B.Add,
2. Recalling Decisions 38 COM 7B.27 and 40 COM 7B.52, adopted at its 38th (Doha, 2014) and 40th (Istanbul/UNESCO, 2016) sessions respectively,
3. Notes with appreciation that the State Party and all the institutions involved, having recognized the major risks to the property, are working collaboratively and in an engaged manner to protect the Outstanding Universal Value (OUV) of the property;
4. Notes that progress has been made towards the implementation of some of the 2015 Reactive Monitoring mission recommendations endorsed by the Committee and reiterates its request that the State Party continue to implement all the recommendations put forward in the Decision 40 COM 7B.52, including immediate, short, medium and long-term measures;
5. Acknowledges the drafting of the Climate Plan and encourages the State Party to take into account the “Policy on the Impacts of Climate Change on World Heritage Properties” in the development of the plan, considering that ‘Venice and its Lagoon’ is in a privileged position and might have the potential to influence monitoring and adaptation processes that can be applied elsewhere;
6. Welcomes the details submitted regarding the new sustainable tourism strategy that will make use of the consultative model proposed by the UNESCO Sustainable Tourism Programme;
7. Also notes that the State Party is exploring an option of using existing port channel (Canale Vittorio Emanuele III) with a view to halt the passage of large ships through the San Marco basin and the Giudecca canal, and to avoid the excavation of new ones and requests the State Party to submit detailed plans and a detailed timeframe for the implementation of the selected solution;
8. Also reiterates its request that the State Party submit, in conformity with Paragraph 172 of the Operational Guidelines, details of any newly proposed projects, together with all relevant cumulative Heritage Impact Assessments (HIAs) and Strategic Environmental Assessments (SEA), with a specific section focusing on their potential impact on the OUV of the property;
9. Also acknowledges progress made towards the completion of the MOSE defence system and also requests the State Party to provide detailed and updated information on this project, including its management and maintenance systems;
10. Further reiterates its request that the State Party update the Management Plan and revise its planning approach in order to sustain in the long term the OUV of the property, its landscape and seascape;
11. Further requests the State Party to provide a much clearer detailed road map for the way forward, with measurable benchmarks and a detailed Action Plan to deliver what is needed, commensurate with the major threats to the property;
12. Requests furthermore the State Party to submit to the World Heritage Committee a detailed report on the state of conservation of the property and the implementation of the above, including a detailed road map on the way forward, by 1 December 2018 for examination by the World Heritage Committee at its 43rd session in 2019, with a view to considering, if adequate progress in the implementation of the above recommendations has not been made, the inscription of the property on the List of the World Heritage in Danger.
Riferimenti
E lo chiamano ultimatum? È del luglio 2016 l'ultimatum dell'Unesco (più precisamente del Comitato del Patrimonio Mondiale) che perentoriamente raccomandava di fermare il passaggio delle grandi navi e limitare il numero di turisti entro febbraio 2017 come alcune delle strategie per salvaguardare Venezia e la sua laguna. Si veda a proposito l’artico di Francesco Erbani. Del tutto inascoltati gli altri “portatori di interesse”, istituzionali e non, Municipalità di Venezia, Italia Nostra, Associazioni, che avevano inviato all'Unesco i propri punti di vista e preoccupazioni, raccolti su eddyburg.
«Nelle ultime settimane diversi impianti di trattamento sono andati a fuoco. Un caso o una strategia per fare affari?» il Fatto Quotidiano, 7 luglio 2017 (p.d.)
A chi giovano i roghi dei rifiuti?
6 aprile, La Loggia (To) La Cmt, piattaforma di trattamento e stoccaggio dei rifiuti appartenente al Gruppo San Germano al 100%, si incendia per la terza volta negli ultimi quattro anni. Il gruppo San Germano detiene Pluricart al 65% tramite CMT e la Tirreno ambiente Spa per una quota pari al 2%. La Tirreno ambiente Spa è detenuta per un 10% dalla Gesenu (incendiatasi nel 2015) appartenente alla galassia Cerroni e per un 3% dalla A2A. Il gruppo San Germano ha sede a Mazzarà Sant’Andrea (Messina) e il suo ex presidente Giambò è stato condannato per associazione mafiosa. Procedimenti penali per reati contro la Pubblica amministrazione sono in corso a carico di amministratori, presenti o passati, della Tirreno ambiente Spa.
12 aprile, Grosseto Incendio impianto trattamento rifiuti di Futura Spa alle Strillaie, tra Grosseto e Marina di Grosseto. A fuoco i rifiuti destinati a diventare combustibile da rifiuti.
16 aprile, Follo (Sp) Un vasto incendio scoppia all’interno dell’azienda Ferdeghini, l’impianto di trattamento rifiuti che si occupa della selezione, del recupero e dello stoccaggio di materiali pericolosi e non, situato a Cerri, nel Comune di Follo. Già il 5 luglio 2015 l’azienda aveva preso fuoco nonostante gli abitanti vicini avessero presentato una diffida per l’enorme accumulo di rifiuti nei giorni precedenti l’incendio.
5 maggio, Pomezia (Rm) Scoppia l’incendio della Eco X, presso cui risultavano stoccate ingenti quantità di rifiuti. Caso ampiamente trattato dalla stampa nazionale e su cui sono in corso indagini della Procura di Velletri.
24 maggio, Bedizzole (Bs) Incendio alla Faeco già interessata da simili episodi nel luglio 2013, e nel marzo 2017. L’incendio èavvenuto nell’area sottoposta a sequestro due mesi prima.
25 maggio, Malagrotta (Rm) Le fiamme hanno interessato un deposito di combustibile prodotto con i rifiuti che poi viene mandato nei termovalorizzatori.
5 giugno, Casale Bussi (Vt) Incendio nell’impianto di trattamento rifiuti di Casale Bussi, a Viterbo. La Procura della Repubblica di Viterbo ha aperto un fascicolo per incendio doloso.
7 giugno, Fusina (Tv) Incendio alla Eco Ricicli Veritas, il più grande centro comprensoriale del Conai Corepla in Italia con oltre 2500 tonnellate al mese di multimateriale che poi vengono aggiudicate mediante asta Corepla per divenire combustibile da rifiuti, conferito ad impianti nei 300 km di distanza. Eco ricicli Veritas conferisce rifiuti a Montello spa e a Idealservice. Quest’ultima azienda nel 2015 ha subito un incendio.
11 giugno, Battipaglia (Sa) A Battipaglia si sviluppa un incendio presso la Sele Ambiente, già precedentemente posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria, per il coinvolgimento in una inchiesta su un vasto giro di smaltimento illecito tra la Campania e la Puglia.
14 giugno, Villacidro (Ca) A fuoco la discarica Villaservice di Villacidro, discarica di servizio del Tecnocasic, altro impianto fuori uso per un incendio da fine aprile.
19 giugno, Angri (Sa) A fuoco l’impianto di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi di Sea Srl, con sede legale a Scafati.
Certo, tutto è possibile: incidenti, autocombustione, intimidazioni locali ecc. Ma, francamente, così tanti incendi, in tre mesi, in impianti di trattamento rifiuti sembrano un po’troppi. Tanto più che questa epidemia di incendi sembra ricorrente, e proprio quando la stagione calda e le alte temperature possono giustificare gli incendi con l’autocombustione.Sorge, quindi, spontaneo il sospetto che almeno alcuni di questi incendi servano a risolvere situazioni divenute ingombranti o pericolose per le stesse imprese andate a fuoco. Tanto più che, come abbiamo visto, spesso l’incendio è collegato ad altre attività del settore che hanno subito o un’ispezione o un sequestro o un altro incendio e fanno capo a persone già note per illegalità connesse al trattamento e alla raccolta dei rifiuti.
In questo quadro, le motivazioni più probabili sono quelle collegate al profitto derivante dal contributo economico erogato dai consorzi obbligatori di settore, per cui le imprese “riceventi” possono trovare più conveniente incamerare il contributo e disfarsi in qualche modo del materiale senza sostenere i costi che la sua lavorazione/smaltimento legale comporterebbero. Emblematico in tal senso è il caso del consorzio nazionale tedesco degli imballaggi, il DSD, il quale, nella seconda metà degli anni 90, inviava in tutta Europa rifiuti di plastica, spesso di scarsissima qualità e quindi difficilmente riciclabili, accompagnati da un sostanzioso contributo economico. Molti furono allora i casi, anche in Italia, di imprese che, incassati i contributi e riempiti capannoni spesso affittati ad hoc, trovarono più conveniente “chiudere la pratica”appiccando il fuoco piuttosto che affrontare i costi necessari per tentare ardue e in certe operazioni di riciclo o di smaltimento.
Un incendio, in particolare, può servire a evitare controlli su combustibile da rifiuti prodotto al di fuori delle specifiche di legge, per cui l’impresa ha, tuttavia, già percepito contributo all’ingresso del rifiuto. O a evitare che si scopra che l’impresa ha ricevuto contributi per rifiuti non idonei o non autorizzati fatti figurare in ingresso con falsi codici. Non a caso, la termovalorizzazione viene incentivata a 220 euro alla tonnellata mentre per il riciclo l’incentivo è di 170 euro.
E probabilmente questi incendi sono aumentati da quando la Cina ha stretto i freni sulla qualità dei rifiuti italiani che prima accettava senza problemi. Peraltro, incendiare un rifiuto significa trasformarlo in rifiuto pericoloso che deve essere smaltito in apposite discariche, spesso di proprietà delle stesse imprese da cui deriva. Ma la conseguenza più grave riguarda, ovviamente, la salute e l’ambiente, per la produzione di diossina e altri inquinanti altamente pericolosi. Proprio per scoraggiare questi eventi, nel 2013 un decreto legge ha stabilito finalmente che chi appicca il fuoco a rifiuti rischia la reclusione da 2 a 5 anni con aumento da 3 a 6 anni se i rifiuti sono pericolosi.
Tuttavia, questa pena si applica solo se si tratta di rifiuti “abbandonati, ovvero depositati in maniera incontrollata”. Trattasi di una specificazione veramente singolare e poco comprensibile, perché un incendio di rifiuti stoccati ordinatamente produce gli stessi effetti dannosi di un incendio di rifiuti abbandonati. E potrebbe portare addirittura alla conclusione che questo delitto non può applicarsi a chi appicca il fuoco, appunto, a rifiuti non abbandonati ma depositati non in modo incontrollato nel suo impianto.
Forse sarebbe il caso di intervenire al più presto per correggere questa evidente stortura legislativa invece di dedicarsi, coma fa il governo nel recente decreto legge sul Mezzogiorno, a “graziare” rifiuti fino a oggi ritenuti pericolosi, con palese violazione del principio di precauzione.
«Un dialogo tra il fisico Fritjof Capra e il giurista Ugo Mattei su ecologia, scienza, politica e tutela dei beni comuni». il manifesto, 7 luglio 2017 (c.m.c.)
Fritjof Capra è un fisico austriaco, oggi responsabile del Centro per l’Ecoalfabetizzazione di Berkeley, notissimo anche al pubblico più largo per il suo Il Tao della fisica (Adelphi), in cui condannava radicalmente l’approccio meccanicistico del metodo scientifico moderno, sviluppando un pensiero antiriduzionista, ispirato al pensiero sistemico e alle teorie della complessità. Questo Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni (Aboca, euro 18, traduzione dall’inglese di Ilaria Mattei) è il frutto del suo incontro con Ugo Mattei, giurista impegnatissimo sul fronte dei beni comuni, ben noto sia per il suo lavoro teorico che per la partecipazione a un gran numero di esperienze militanti.
I due studiosi hanno obiettivi più ambiziosi che registrare lo stato dell’arte dei rapporti tra ecologia e diritto: la posta in gioco è, infatti, la critica radicale dei paradigmi fondativi che accomunano la scienza naturale e la scienza giuridica moderna. Bacone, Galileo e la fisica newtoniana distruggono l’interpretazione olistica del mondo. Alle differenze qualitative che orientavano il kosmos medioevale, sostituiscono l’omogeneità quantitativa di corpi che agiscono reciprocamente attraverso semplici rapporti di causa-effetto: un universo che diviene muto dal punto di vista etico, e sul quale, proprio per questo, il soggetto potrà infine, con Cartesio, imprimere il sigillo del suo ordine.
La metafora vincente, in questo passaggio alla modernità, sarà quella della macchina. La visione meccanicistica è il punto di congiunzione delle nuove scienze sperimentali con il mondo del diritto: anche la politica infatti si meccanicizza, passando dalla rete di comunità, organismi intermedi e connessi propri del medioevo, alla machina machinarum dello Stato moderno. Sovranità, con Hobbes, e proprietà, con Locke, saranno i due lati della «doppia morsa» all’interno della quale sarà stritolato l’ordine antico: attraverso il potere centralizzato sovrano e la proprietà assoluta, lo Stato potrà attaccare, con le enclosures, le recinzioni delle terre, il mondo dei beni comuni, e trasformarlo in capitale necessario all’accumulazione.
La potenza dell'astrazione, che caratterizza simultaneamente il metodo scientifico sperimentale e la nascente scienza giuridica, nasce così perfettamente funzionale all’estrazione capitalistica: la produzione di un ordine normativo unitario, fondato sul comando del sovrano, che fa piazza pulita degli ordinamenti plurali amministrati dalla saggezza pratica di giuristi ancora custodi degli usi, nasconde nel suo cuore la violenza dell’accumulazione originaria, per dirla nei termini in cui Marx racconta questa stessa storia. La crisi ecologica contemporanea pertanto, secondo gli autori, richiede una radicale fuoriuscita dal modello meccanicistico e cartesiano, per abbracciare uno stile di pensiero ecologico: uno sguardo che sostituisca alla forza moderna della separazione e dell’astrazione, la diversa potenza dell’interconnessione e della relazione, grazie a un paradigma sistemico che guarda al modello della rete, abbandonando finalmente quello della macchina.
Negli ultimi capitoli, questa impostazione offre preziosi materiali per sviluppare concreti esperimenti nel segno di una concezione generativa e non più astraente/estrattiva del diritto: da un diritto dell’impresa che ne imponga la responsabilità ecologica e ne impedisca lo sfruttamento senza vincoli delle esternalità ambientali, a una disciplina della responsabilità che elimini lo scudo del comportamento colpevole e imponga obblighi risarcitori, a una valorizzazione degli aspetti antiproprietari della gestione dei beni comuni.
Di particolare interesse, poi, l’insistenza sulla centralità del mondo della riproduzione sociale, del welfare e dei servizi: se davvero non si può oggi «astrarre» da qualcosa, è dalla centralità della riproduzione della vita, non più astrattamente separabile dalla produzione e occultabile negli ambiti del privato e del familiare. È molto interessante, e questo testo giunge di grande aiuto, osservare come questo paradigma generativo-ecologico apra così uno spazio per tenere insieme lotte sui beni comuni, sulla riproduzione, sul welfare: la centralità antiproprietaria dei beni comuni, la critica ecologista a una visione lineare dello sviluppo, la rottura femminista dell’invisibilità dei processi riproduttivi ,possono insieme costruire una strategia politica per il «comune».
Resta però aperto il problema di come organizzare tutto questo in modo che tale ricchezza pluralistica, autopoietica e relazionale, che è indubbio merito dei paradigmi ispirati alla complessità sistemica riuscire a cogliere, non ceda ad una pura e semplice logica della frammentazione. Le modalità di estrazione del capitalismo, nel capitalismo finanziario globale, hanno acquisito una grande capacità di cattura anche e soprattutto delle differenze, mettendo a valore direttamente le forme di vita: il neoliberalismo ha complicato alquanto la contrapposizione binaria tra olismo e comunitarismo da un lato, meccanicismo e individualismo dall’altro. e quindi costringe ancor di più chi si muove dentro le reti della cooperazione sociale ad affrontare il compito politico – ancora tutto aperto – dell’emersione ed organizzazione di un comune, oltre l’orizzonte semplicemente «comunitario», capace di potenziare e connettere esperienze e soggettività.
 «Condofuri sta cercando di evitare che il suo litorale venga sacrificato al modello Rimini».
«Condofuri sta cercando di evitare che il suo litorale venga sacrificato al modello Rimini». il manifesto
, 7 luglio 2017 (c.m.c.)
L’Italia unita è un paese malato di autolesionismo, che ha ingaggiato una guerra senza quartiere contro la bellezza del proprio territorio ammirata in tutto il mondo, dilapidando una ricchezza formata da capolavori di interazione tra l’uomo e l’ambiente, depositati strato su strato generazioni dopo generazioni.
Il pesce purtroppo puzza dalla testa: soprattutto negli ultimi decenni lo Stato si è fatto sostenitore di interessi particolari, quelli del partito del cemento, a scapito degli interessi generali legati alla difesa del suolo, al risanamento idrogeologico, alla cura del paesaggio e dei segni della storia, alla salute dei cittadini.
Si sono succeduti governi con denominazioni varie, alcuni di centro destra, altri di centro sinistra e gli ultimi di centro sinistra destra, tutti però ammantati dallo stesso colore grigio cemento: la “Legge obiettivo” del governo Berlusconi (n.443/2001) e il più recente decreto “Sblocca Italia” del governo Renzi n.133/2014 esprimono la stessa filosofia e manifestano la stessa incoscienza.
Il risultato è che in Italia si consumano 55 ettari al giorno, pari a circa 7 metri quadrati al secondo, con opere spesso capaci di incrementare a dismisura il già cospicuo debito pubblico, senza alcun riguardo per i più gravi problemi del Pianeta: la siccità e il riscaldamento globale.
Soltanto alcune realtà municipali hanno provato a contrastare questo andazzo scriteriato affermando il principio che la terra non è risorsa infinita a disposizione di qualsiasi interesse economico immediato, ma bene limitato da preservare per le future generazioni, da coccolare per produrre cibo sano con tecniche agricole non energivore né inquinanti e per costruire il senso di appartenenza delle comunità in contesti meno sterili e amorfi di quelli attuali. Si sono affermati qua e là (fiori nel deserto arido della mercificazione) percorsi di democrazia partecipata e le Amministrazioni sono giunte a decisioni importanti confrontandosi con gruppi di cittadini informati e responsabili.
Ci sono state per esempio le esperienze di Cassinetta di Lugagnano (MI), di Grottammare (AP), di Pollica in provincia di Salerno (dopo il contrasto tra cementificatori e innovatori che ha portato all’assassinio del sindaco Angelo Vassallo).
E’ ora il caso di seguire le vicende di Condofuri (RC), la cui Amministrazione guidata da Salvatore Mafrici ragionando con i cittadini riuniti nel “Laboratorio Territoriale”, sta cercando di evitare che il suo litorale venga sacrificato al modello Rimini imperversante sulle coste di tutta la Calabria, per ripristinare invece l’ecosistema dunale e il paesaggio ormai raro delle spiagge “non attrezzate”.
Il tutto nell’ambito di una visione del territorio che cerca di ritrovare e valorizzare le sue qualità primarie (fertilità della terra, biodiversità, bellezza storica dei luoghi) puntando anche su una destagionalizzazione del turismo. Il 7 luglio, nell’aula del Consiglio comunale, si svolgerà un episodio decisivo del confronto democratico che sta portando all’approvazione di un progetto di riqualificazione costiera i cui orientamenti sono racchiusi nel concetto di “Parco a mare”.
Carlo Rovelli, famoso fisico e autorità morale, come cittadino onorario di Condofuri è intervenuto nella faccenda con un accorato parere sulle scelte che si stanno per compiere.
Lo mettiamo a disposizione dei lettori come prezioso strumento di riflessione generale.
La lettera aperta di Carlo Rovelli
Carissimi amici e concittadini di Condofuri, e caro Sindaco,
due anni fa mi avete fatto un regalo immenso, offrendomi la Cittadinanza Onoraria e accogliendomi fra voi con un calore e un affetto che ancora mi scaldano il cuore. Permettetemi di mandarvi oggi il mio parere riguardo alle difficili decisioni che Condofuri sta affrontando riguardo alla sistemazione della sua costa.
Non conosco i dettagli tecnici di una questione così complessa e purtroppo non sono lì con voi per discuterne, ma credo di poter offrire lo stesso qualche considerazione utile, perché ci sono anche aspetti della questione che si vedono forse meglio da lontano che da vicino.
Condofuri, ho continuato a ripeterlo ogni momento passato con voi, è meravigliosa, e dispone di una ricchezza immensa: da lontano, confrontandola con il resto del mondo, è evidente: la natura strepitosa e magica che vi circonda, rimasta miracolosamente intatta fino ad ora. È una ricchezza che sarebbe un errore tragico mettere in pericolo.
Quello mi preme dirvi, forse anche correggendo quello che ho letto al riguardo, è che il motivo primo per il quale Condofuri deve difendere la sua natura, non è il senso di responsabilità rispetto al pianeta o rispetto al resto del mondo. È per Condofuri stessa. La decisione è quanto rovinarsi diventando una delle innumerevoli tristi e povere cittadine balneari, o quanto invece diventare luogo privilegiato di natura e bellezza.
La scelta mi è particolarmente chiara proprio per il luogo dove vivo: in Francia, sul mare, nella cittadina di Cassis, che sta al bordo del Parco Nazionale dei Calanques. A differenza di tante altre località della Costa Azzurra, che hanno distrutto la natura riempiendosi di cemento e stazioni balneari, Cassis ha difeso la sua costa selvaggia e intatta. Sono state scelte difficili, ma oggi è chiaro a tutti che sono state le scelte vincenti: oggi Cassis è la meta più ambita e uno dei luoghi più privilegiati dell’intera costa francese.
Condofuri ha le stesse potenzialità. Non distruggetele, ve lo chiedo con il cuore. Non solo perché fareste male alla Terra, ma sopratutto perché fareste male al futuro tanto economico quanto estetico di Condofuri. Quando sono stato a Condofuri due anni fa sono tornato a vedere quel meraviglioso piccolo bosco di Eucalipti lungo il mare, accanto alla foce. Ho camminato lungo la spiaggia verso Condofuri e ho percorso lunghi tratti di costa senza cemento e stabilimenti balneari. Avete un paradiso.
Non fatevi incantare dalle sirene di un facile guadagno vicino o da interessi particolari, guardate alla ricchezza molto più grande che sta nascosta nella vostra natura, non ve ne pentirete certamente, e il futuro sarà fiero delle vostre scelte di oggi. Questo è il mio parere. Con immenso affetto,
Carlo Rovelli
Orgogliosamente cittadino onorario di Condofuri

Una riflessione lucida sui disastri provocati nella Città Metropolitana milanese dalla Delrio, una legge inadeguata, scaturita da obiettivi incongrui e potenzialmente dannosa. arcipelagomilano.org, 4 luglio 2017 (m.c.g.)
Si continua a parlare di Città metropolitana, in questo ultimo mese sono stati pubblicati tre interventi (1). Provo a aggiungere qualche considerazione e a richiamare le argomentazioni sviluppate negli ultimi due anni, che sono oggi ancora attuali nella generale situazione di stallo che caratterizza l’ente da quando nel gennaio 2015 è stato istituito.
Come noto il Decreto Salva Italia all’inizio, e a seguire la Legge Delrio e le Finanziarie degli ultimi anni, hanno fortemente ridimensionato risorse, ruolo e capacità di azione di province e città metropolitane, fino alla situazione critica che si può constatare oggi, ampiamente descritta nei tre interventi citati.
È certo difficile governare in una situazione di così grave carenza di risorse, che è stata voluta per smantellare le strutture provinciali ancora prima di avere portato a compimento la Riforma Costituzionale, ma che è stata ciecamente applicata anche alle città metropolitane, di fatto tarpandone le ali già sul nascere, nonostante la loro istituzione sia stata sbandierata come uno degli obiettivi importanti della legge. La situazione, a parte qualche piccolo e marginale palliativo, continua paradossalmente anche dopo la bocciatura della Riforma.
È certo difficile governare quando la Regione vede la Città metropolitana come un ingombrante concorrente nel controllo del territorio. Già ai tempi della Provincia di Milano, appena si è presentata l’occasione la Regione ne aveva favorito il ridimensionamento affrettando l’istituzione della nuova Provincia di Monza e Brianza. La Città metropolitana è oggi molto più piccola del sistema metropolitano reale (2), e la Regione si oppone a ogni richiesta di allargamento che viene dai comuni confinanti, come mostra il recente caso di Vigevano (3).
È certo difficile governare quando il Sindaco di Milano – e della Città metropolitana – ha intuito i vantaggi operativi e politici del doppio incarico, che per legge gli assegna la disponibilità di un territorio molto più ampio senza dovere rispondere, nella verifica elettorale, ai cittadini dei comuni di cintura, e quindi interpreta questo secondo incarico esclusivamente come ancillare alle finalità del primo. Non è un caso che l’elezione diretta inserita nello Statuto della Città metropolitana venga posposta a data da destinarsi, il più possibile lontana nel futuro.
È certo difficile governare quando ANCI, l’associazione dei comuni, si oppone con tutto il suo peso a ogni tentativo di regolare il consumo del suolo nei piani comunali, che è uno degli argomenti sui quali le province hanno negli anni fondato la propria competenza di pianificazione del territorio. La recentissima (fine maggio) modifica alla Legge Regionale 31/2014 sul consumo di suolo permette ai comuni di attuare direttamente questa legge, autocertificando il rispetto dei generali e generici criteri del PTR (piano territoriale regionale), e allontanando molto in là nel tempo la redazione del PTM (piano territoriale metropolitano), che dovrebbe contenere regole rivolte ai comuni più dettagliate di quelle del PTR.
È certo difficile governare quando la già citata modifica di legge, invece di contenere il consumo di suolo come dichiara nel titolo, finisce in modo paradossale, ma probabilmente voluto, per accelerare l’attuazione di quanto già programmato. In che modo? Regalando un plusvalore ai fortunati proprietari delle aree già programmate nei Piani dei comuni, anteponendo il riequilibrio dei bilanci di società e banche al governo del suolo come bene comune.
È certo difficile governare quando la Regione con il nuovo PTR condiziona il futuro delle aree urbane più rilevanti, compresa buona parte del territorio metropolitano, alla preliminare approvazione di accordi negoziali di interesse regionale (quindi di iniziativa e guidati dalla Regione), limitando in questo modo l’autonomia degli strumenti di pianificazione territoriale della Città metropolitana, delle province, e degli stessi comuni capoluogo (4).
È certo difficile governare quando diventa sempre più sistematica la marginalizzazione della Città metropolitana sui temi strategici del territorio, come già sperimentato per esempio nelle vicende inerenti le aree Expo, o di recente le aree ferroviarie dismesse (i famosi scali), che sono patrimonio pubblico e dovrebbero servire alle esigenze dell’intera comunità metropolitana, non solo di chi vive entro i confini di Milano.
L’elenco potrebbe continuare. Se certo è difficile governare in queste condizioni, tuttavia almeno in quelle poche occasioni in cui ci sono i poteri e qualche risorsa si deve cercare di usarli il meglio possibile. Vedo invece in alcuni interventi recenti ancora citato il Piano strategico approvato un anno fa come buona pratica della Città metropolitana, nonostante le numerose critiche pubblicate, anche su questo sito, che ne hanno evidenziato la pochezza. Basta andare a rileggerne alcune del 2016, sono sempre attuali (5).
Il Piano strategico è stato affidato ad una struttura esterna, quando invece ci sono valide competenze interne, ed è stato tenuto separato dal PTM (Piano territoriale metropolitano), nonostante i due strumenti siano complementari e dovrebbero procedere assieme, il più integrati possibile. Gli uffici di pianificazione territoriale della Città metropolitana, anche se ridotti nei ranghi, possiedono solide competenze tecniche, ed una pluriennale esperienza nel rapporto con gli uffici tecnici dei comuni, quindi una conoscenza approfondita e puntuale dei problemi territoriali, che nessuna struttura esterna può neppure lontanamente eguagliare.
Il Piano strategico è stato attivato e approvato in tempi abbastanza rapidi, mentre il PTM deve ancora partire. Ma le indicazioni del Piano strategico rimangono nel libro dei sogni se non sono accompagnate e integrate con le regole e modalità di governo del territorio che solo il PTM può possedere. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2921 del giugno 2016, proprio sul caso di un comune del Milanese, ha riaffermato il ruolo di coordinamento della pianificazione territoriale provinciale e metropolitana, e ne ha ribadito la centralità rispetto alla pianificazione dei comuni. I contenuti di questa sentenza sono lì a disposizione, hanno efficacia immediata, vanno semplicemente usati.
Se andare avanti nelle sfavorevoli condizioni di contorno attuali è difficile, almeno partiamo cercando di fare bene quel poco che norme, risorse, competenze, giurisprudenza e altre condizioni ci consentono oggi di affrontare (6).
(1) Si vedano gli interventi su ArcipelagoMilano di Valentino Ballabio del 7 giugno 2017, di Arianna Censi del 13 giugno e di Ugo Targetti del 20 giugno.
(2) Sulla questione delle dimensioni di città e sistema metropolitano segnalo i miei interventi su ArcipelagoMilano del 16 settembre 2016 e dell’11 maggio 2016. Se l’ampliamento della Città metropolitana fino a coincidere con il Sistema metropolitano reale è troppo complesso e irrealistico, bisogna quantomeno immaginare un sistema di governance che coinvolga nelle decisioni sul sistema metropolitano almeno capoluoghi e polarità urbane delle province confinanti.
(3) Sulla stampa locale il Presidente della Regione ha dichiarato recentemente la propria contrarietà alla domanda del Comune di Vigevano di annessione alla Città metropolitana; si veda per esempio l’articolo sulla Provincia Pavese del 15 giugno 2017.
(4) Si veda il mio intervento pubblicato su
Millennio Urbano del 30 marzo 2016.
(5) Alcuni interventi sono stati pubblicati su ArcipelagoMilano il 12 aprile 2016, si vedano per esempio quelli di Giorgio Goggi e di Riccardo Cappellin. Cito anche un mio intervento sempre su ArcipelagoMilano del 24 maggio 2016.
(6) Per un riassunto dei contenuti della sentenza si veda il mio intervento su ArcipelagoMilano del 13 luglio 2016.

Un altra diga in Tanzania modificherà il sistema idrico privando le regioni delle inondazioni stagionali, vitali per le popolazioni. Ambientalisti, gestori di Safari e abitanti contro il progetto, greenMe.it, 28 giugno 2017, (i.b.) con postilla
Non si arresta la protesta delle popolazioni indigene contro la costruzione di un’enorme diga idroelettrica in uno dei più grandi polmoni verdi dell’Africa. Accanto a loro gli ambientalisti che temono che la costruzione causerà danni irreversibili alla riserva Selous in Tanzania. Sono sempre più minacciati gli indigeni, costretti a lottare contro multinazionali e governi compiacenti, pur di difendere le loro terre ancestrali, diventate ormai solo fazzoletti invivibili.
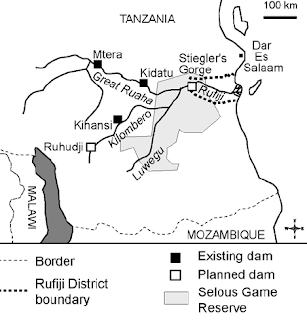 |
| Il fiume Rufiji con dighe esistenti e future. Estratto da un articolo di Duvail et at (2013) |
Non si arresta la protesta delle popolazioni indigene contro la costruzione di un’enorme diga idroelettrica in uno dei più grandi polmoni verdi dell’Africa. Accanto a loro gli ambientalisti che temono che la costruzione causerà danni irreversibili alla riserva Selous in Tanzania. Sono sempre più minacciati gli indigeni, costretti a lottare contro multinazionali e governi compiacenti, pur di difendere le loro terre ancestrali, diventate ormai solo fazzoletti invivibili. Dopo anni di ritardo e false partenza, in questi giorni il presidente della Tanzania John Magufuli ha annunciato che la diga Gola Stiegler sul fiume Rufiji, si farà.
E non c’è da stare tranquilli perché dalla sua elezione nel 2015, Magufuli soprannominato ‘il bulldozer’, è conosciuto soprattutto, per il suo record di infrastrutture costruite.Dopo anni di ritardo e false partenza, in questi giorni il presidente della Tanzania John Magufuli ha annunciato che la diga Gola Stiegler sul fiume Rufiji, si farà. E non c’è da stare tranquilli perché dalla sua elezione nel 2015, Magufuli soprannominato ‘il bulldozer’, è conosciuto soprattutto, per il suo record di infrastrutture costruite. Poca attenzione per l’ambiente, a fronte del profitto. La diga sorgerà, infatti, nel cuore del Selous, una riserva naturale che ha una superficie pari a quella della Svizzera. Un’oasi per elefanti, ghepardi, coccodrilli e giraffe che vivono a due passi dalle popolazione indigene.
Un luogo diventato Patrimonio Unesco, ma dichiarato anche in pericolo, a causa del bracconaggio. Adesso, arriva questa ennesima scure: la diga che fornirà 2100 MW di energia elettrica in un paese che sta soffocando. “Siamo molto preoccupati per la costruzione della diga che avrà un impatto negativo sul sito. Bisogna già lottare contro tutte le attività illegali che mettono in pericolo la vita degli animali, tra cui il rinoceronte nero e degli indigeni”, dice Remco van Merm dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.
“Questo tipo di progetti vengono giustificati dal fatto che forniranno energia elettrica e vengono inquadrati come misure poco impattanti. In realtà, che senso ha una costruzione che distrugge la riserva e limita la sopravvivenza dei popoli locali?”, dice Thabit Jacob, specialista in Energia e Ambiente.“Questo tipo di progetti vengono giustificati dal fatto che forniranno energia elettrica e vengono inquadrati come misure poco impattanti. In realtà, che senso ha una costruzione che distrugge la riserva e limita la sopravvivenza dei popoli locali?”, dice Thabit Jacob, specialista in Energia e Ambiente.
A luglio, il Comitato del Patrimonio mondiale si riunirà insieme al governo della Tanzania per trovare una soluzione e per chiedere ancora una volta che il progetto venga abbandonato perché non è compatibile con lo status di riserva protetta.
postilla
Con il nuovo boom delle dighe idroelettriche, anche i buoni propositi per una gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche, che tanto consenso hanno avuto, vengono messi da parte. Questa gestione che dovrebbe promuovere lo sviluppo e la gestione coordinata dell'acqua, del suolo e delle risorse correlate, al fine di massimizzare un benessere sia economico che sociale senza compromettere la sostenibilità degli ecosistemi vitali e dell'ambiente, da grande importanza ai flussi e alle portate dei fiumi. Non solo riguardo al mantenimento dei flussi minimi, ma anche al mantenimento dei flussi di punta e a tutti quei ecosistemi legati alle inondazioni.
Sono proprio la diminuzione delle inondazioni che modificheranno profondamente il funzionamento dei laghi della regione, mettendo a rischio la sopravvivenza delle popolazioni circostanti.
Meno male che oltre agli interessi delle popolazioni povere circostanti sono a rischio anche il turismo legato ai Safari e un Patrimonio Unesco, altrimenti di questi “dannati dello sviluppo” non ne sapremmo mai l’esistenza. (i.b.)