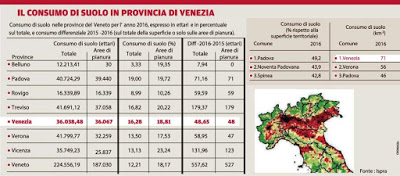il Manifesto - Alias, 16 dicembre 2017. Un elogio al lavoro e un commovente ricordo di Marina Zanazzo, fondatrice della casa editrice Corte del Fontego e della collana Occhi aperti su Venezia, che ripartirà sotto la direzione di Lidia Fersuoch. (i.b.)
Una casa editrice militante, capace di portare al grande pubblico tematiche specialistiche. Un laboratorio di cittadinanza, che dà spazio a pratiche alternative, a modi diversi di raccontare e vivere una città bellissima e fragile, Venezia. Rappresenta questo e molto altro Corte del Fontego, l’editore fondato da Marina Zanazzo nel 2005, storica e archivista, scomparsa lo scorso luglio dopo una lunga malattia. Che ha espresso con questo mezzo il suo grande amore per la città che l’ha adottata, lei che veniva dalla terraferma, e che in laguna ha deciso di stabilirsi. E combattere. Perché Venezia, ecosistema delicatissimo e luogo dal fascino unico al mondo, è perennemente preda degli appetiti insaziabili di gruppi di interesse potenti e pervasivi, che la svendono, la rovinano, ne causano abbandono e spopolamento.
Da qui l’esigenza di pubblicare saggi e pamphlet, inchieste, ricerche documentate e riflessioni su una città che non vuole morire e che, per ritrovarsi, deve partire dal conoscere se stessa. Ad accompagnare Marina in quest’impresa coraggiosa e un po’ folle, l’amica di una vita Lidia Fersuoch, oggi presidente della sezione veneziana di Italia Nostra, e Edoardo Salzano, gigante dell’urbanistica italiana, da sempre schierato contro gli interessi di palazzinari e speculatori. «Sono convinto» spiega Salzano, «che qui ci siano molto piccole isole di resistenza, affogate però da un mare di ignoranza. Bisogna aiutarle a sopravvivere, a espandersi, cercando al contempo di superare la mancanza di consapevolezza su quello che Venezia è realmente. Una città cioè ineguagliabile, unica perché viva e abitata da gente comune. In questo consiste la grande modernità di Venezia».
Assieme ai fondatori i molti autori, specialisti in vari campi, dall’architettura alla filosofia, dalla storia all’economia, sono stati coinvolti nell’opera di divulgazione intelligente e con un occhio costante all’attualità. Argomenti come le grandi navi, il Mose (ben prima dello shock del processo), il turismo fugace e di massa che va adattato ai limiti della città e ripensato qualitativamente, scempi deliberati come il Fontego dei Tedeschi (diventato un centro del lusso, con un progetto che stravolge completamente l’identità di un palazzo storico). Libretti agili, densi, alla portata di tutte le tasche. E dai titoli geniali e accattivanti:
A che ora chiude Venezia?, Il ponte di debole Costituzione, sul progetto dall’archistar Calatrava,
Benettown, sulla «conquista» della città da parte della famiglia di imprenditori trevigiani. O come in
Lezioni di piano, testo che racconta la nascita del piano paesaggistico voluto da Soru, considerato un esempio da seguire e la cui pubblicazione Marina Zanazzo ha seguito in prima persona, recandosi per un periodo in Sardegna, viaggiando in camper con i suoi cani, per realizzare interviste e ricerche. Alcuni di questi testi sono stati pubblicati anche in inglese e tedesco, per far sì che queste voci arrivino anche a turisti e viaggiatori meno distratti, che vogliano approfondire aspetti di Venezia poco trattati dalle guide tradizionali.
L’avventura della Corte del Fontego, ora che Marina non c’è più, è nelle mani dell’amica Lidia Fersuoch, che porterà avanti la casa editrice con l’aiuto degli amici che hanno sostenuto il progetto in questi anni. «L’ultimo regalo che mi ha fatto Marina è stato aiutarmi a finire un libro cui lavoravo da venticinque anni, una storia della laguna ricostruita attraverso l’uso di documenti processuali. Marina mi ha spinto a concluderlo e ho potuto così pubblicarlo» racconta la Fersuoch. «Ora siamo pronti a ripartire. E il primo titolo potrebbe essere dedicato alla vicenda di Poveglia, un’isola da tempo abbandonata rinata grazie al lavoro di un’associazione che ha deciso di rimetterla a disposizione di tutti. Marina si era appassionata a questa storia, ovviamente, e aveva deciso di farne un libro. Impegno che onorerò al più presto. Mancheranno il suo spirito battagliero e il suo estro, ma ci proveremo».

Sbilanciamoci.info, newsletter 12 dicembre 2017. «Come il capitalismo, con le sue polarizzazioni tra oppressi e oppressori, colonizzati e colonizzatori, ha cambiato il rapporto uomo-natura: Antropocene, Capitalocene, Ecocapitalismo e Cthulhucene»
A 550 km dal circolo polare artico, sulle coste orientali della Groenlandia, si trova la Warming Island (‘l’isola del riscaldamento globale’), riconosciuta come tale nel 2005, quando il ghiacciaio che la univa alla terraferma, ritirandosi a causa dell’aumento della temperatura globale, ne provocò il definitivo distacco.
Quello del riscaldamento globale è uno dei fenomeni che appare oggi in cima alla lista delle principali emergenze ambientali del nostro pianeta. Il progressivo aumento della temperatura terrestre è dovuto all’emissione nell’atmosfera di crescenti quantità di gas serra, strettamente correlate ad attività umane industriali e a politiche economiche imperialiste. Tra gli altri fenomeni antropogenici di mutamento ambientale, la comunità scientifica annovera l’inquinamento (con l’immissione nell’atmosfera, nell’acqua e nel suolo di sostanze contaminanti), il buco dell’ozono, l’effetto serra, l’elettrosmog e l’estinzione di numerose specie naturali (con i suoi annessi fenomeni di deforestazione e desertificazione).
La portata di tali fenomeni ha convinto la maggioranza quasi assoluta della comunità scientifica (parliamo del 97%) a parlare di una nuova vera e propria era geologica, successiva all’Olocene, di cui attualmente le attività industriali dell’essere umano rappresenterebbero appunto i motori costitutivi delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche del pianeta: questa nuova era è definita «Antropocene», termine coniato negli anni anni ’80 dal biologo Eugene F. Stoermer e diffuso nei 2000 dal Premio Nobel per la chimica Paul Crutzen, con la pubblicazione del suo saggio Benvenuti nell’Antropocene.
Tuttavia la riflessione sugli effetti geologici delle attività industriali sull’ambiente ha portato alcuni sociologi, filosofi e analisti politici a indagare le possibili cause storiche del fenomeno. La postulazione di una colpa universale dell’uomo (in quanto specie) non tiene conto infatti delle ragioni storiche e sociali sottese, incentivando di fatto un processo di deresponsabilizzazione collettiva e ignorando del tutto il discorso sui modelli culturali e sociali tramite cui l’essere umano si è sviluppato nelle diverse epoche.
Se infatti per alcune culture non occidentali il rapporto con la natura è paritario e di profonda comunione e alleanza, per quelle tecnicamente più avanzate la netta separazione tra natura e cultura è condizione necessaria a garantire la propria sopravvivenza e il proprio modello di sviluppo. A tal proposito il sociologo Jason W Moore suggerisce di sostituire il termine «Antropocene» con quello di «Capitalocene». Secondo Moore e i suoi sostenitori, la teoria antropocenica, infatti, assumendo l’umanità come totalità omogenea e indistinta, indurrebbe in una vera e propria mistificazione della storia, poiché tralascerebbe di fatto l’analisi della relazioni di potere e dei rapporti di capitale scaturiti da un preciso modello economico (appunto quello capitalistico, sorto nel XVI secolo in Occidente, che avrebbe radicalmente mutato il rapporto tra uomo e natura). Nell’ottica di Moore, capitale e natura si troverebbero pertanto in una relazione dialettica, mutando e influenzandosi a vicenda.
L’oggetto di critica della teoria capitalocenica non sarebbe dunque la storia dell’umanità (in quanto specie), ma quella del capitalismo, con le sue polarizzazioni tra oppressi e oppressori, colonizzati e colonizzatori, con l’obiettivo ultimo di individuare le ragioni storiche e politiche che hanno portato allo sviluppo dell’attuale crisi ambientale.
Tra i sostenitori della teoria capitalocenica figura uno dei più importanti filosofi marxisti tedeschi, c professore di Scienze Politiche presso l’Otto-Suhr-Institut dell’Università Libera di Berlino e co-direttore del Journal for critical sciences. Abbiamo deciso di fargli qualche domanda.
Domande e risposte
Dario Giovanni Alì: Attraverso la teoria dell’Antropocene, gli scienziati hanno segnato il momento di inizio di una nuova era geologica, ponendo particolare attenzione a tutti quei fenomeni geologici distintivi della nostra attuale crisi ambientale: gli inediti livelli di CO2 presenti nella nostra atmosfera e il conseguente fenomeno del riscaldamento globale, le estinzioni di massa di svariate specie, l’aumento del livello dei mari ecc. Nonostante ciò, il termine “Antropocene”, prendendo in considerazione solo le cause e gli effetti geologici di questa crisi, rischia di indurre in una vera e propria mistificazione storica: considera infatti l’umanità (intesa in quanto specie) responsabile dei mutamenti ambientali e globali. A tal proposito, invece, perché il termine “Capitalocene”, coniato da Jason W Moore, sembra più appropriato a descrivere proprio quei rapporti socioeconomici e quelle relazioni di potere che restano fuori dalla teoria antropocenica?
Elmar Altvater: Non c’è alcun dubbio sul fatto che nel corso degli ultimi secoli il genere umano abbia trasformato la Terra in qualcosa di profondamente diverso rispetto al passato. I mutamenti sono evidenti e incisi nelle sfere terrestri, nella biosfera per via dell’influenza degli esseri umani sull’evoluzione, nella litosfera a causa degli effetti delle attività umane sulla struttura sedimentaria della crosta terrestre ecc. Per questo motivo il 29 agosto 2016 l’International Geological Association ha proclamato la fine dell’Olocene e l’inizio di una nuova età della storia terrestre. A seguito di una proposta fatta all’inizio del nuovo millennio dal premio Nobel Paul Crutzen e da altri scienziati naturali, questa nuova età è stata definita come Antropocene. Non vi è alcuna teoria dietro a questa asserzione, e il nome riflette semplicemente l’empirico factum brutum di una profonda influenza del genere umano sulle sfere del pianeta Terra, nello specifico e in modo più sensibile sull’atmosfera, attraverso l’effetto serra. Non andrebbero dimenticati nemmeno gli effetti dell’azione umana sulla biosfera, l’idrosfera, la criosfera ecc., che si sommano al crescente impatto dell’uomo sulla Terra: l’estinzione delle specie, l’acidificazione degli oceani, lo scioglimento delle calotte artica e antartica ecc. Nel complesso significa che per la prima volta nella storia terrestre, cioè in più di 4 miliardi di anni di vita, l’essere umano ha dimostrato di essere in grado di mutare l’evoluzione naturale del pianeta Terra.
Tuttavia, l’umanità rappresenta davvero quell’attore collettivo responsabile del drammatico cambiamento globale? Ovviamente l’umanità non è un’unica entità che agisce collettivamente, ma è invece suddivisa in uomini e donne, in nazioni, tra cui molte sono povere e deboli e alcune ricche e molto potenti. Esistono classi sociali e differenze o divisioni etniche ecc. L’impatto di differenti classi sociali, nazioni e sessi sulla natura del pianeta Terra è diverso. È questa la ragione per cui vi sono delle perplessità sull’appropriatezza o meno del concetto di Antropocene. Alcune autrici femministe preferiscono l’etichetta “Fallocene”, per via della predominanza dell’influenza maschile sulla Terra. Altri parlano di “Necrocene” a causa della tragica accelerazione dell’estinzione delle specie sulla Terra. In modo ironico Donna Haraway ha proposto il termine “Chthulucene” poiché non solo gli esseri umani determinano la direzione dell’evoluzione planetaria ma anche altri importanti attori non umani. Inoltre secondo alcuni autori l’Antropocene tra i suoi effetti collaterali negativi avrebbe il Misantropocene.
La società internazionale geologica rinuncia a tali questioni. I suoi membri sono in cerca di “segni” geologici significativi all’interno dei depositi della crosta terrestre e nelle altre sfere del pianeta, per valutare lo stato in cui si trova la Terra e il nome da dare a questa nuova età. Il caso del concetto di “Capitalocene” è diverso. Non sono l’uomo e la donna, Adamo ed Eva, a rappresentare le dramatis personae, e nemmeno gli altri esseri viventi. Tuttavia, uomo e donna agiscono come esseri sociali all’interno di un dato sistema sociale, e la costruzione sociale dominante del XX secolo è il capitalismo. Quando si schiera a favore del termine “Capitalocene” al posto di quello di “Antropocene”, Jason W Moore ha in mente proprio questo. Forse è stato il primo a utilizzare questo termine all’interno di una pubblicazione scientifica. Tuttavia si sentiva “nell’aria” ed era già stato usato da altri. L’aspetto fondamentale è che il concetto di Capitalocene include la costruzione sociale del capitalismo, così come l’accumulazione capitalistica, all’interno della trasformazione geologica della Terra. In linea teorica ciò conduce in maniera diretta al concetto marxiano del “duplice carattere” di ogni azione economica, del lavoro e della produzione, dello scambio, della distribuzione o del consumo. Trasforma materia ed energia, come per esempio la natura, e in modo coincidente trasforma il valore producendo plusvalore.
G. A: La Rivoluzione Industriale del XVIII secolo è considerata da molti scienziati come il momento d’inizio dell’Antropocene. Tuttavia un primo momento chiave di svolta nel rapporto tra uomo e natura risale probabilmente alle origini del capitalismo, nel XVI secolo, quando si verificò una netta separazione tra l’uomo, da un lato, e una natura oggettivata, dall’altro. In che modo – se è possibile – le pratiche artistiche sono in grado di ricucire questo strappo tra uomo e natura e generare nuovi modelli di conoscenza e consapevolezza?
A.: Si tratta di una questione determinante. Il discorso sull’Antropocene deve essere inteso come una sfida per la comprensione di sé come individui, come esseri sociali e come parti umane del pianeta, estremamente distinte e per lo più natura non umana. Pertanto la relazione sociale tra uomo e natura è importante. Occorre interpretare tale relazione come il complesso metabolismo dell’uomo con la natura. È impossibile un’esistenza umana al di là del circuito metabolico di input e output, di nutrimento e scarto, di sostanze nutritive ed emissioni ecc. Tuttavia dobbiamo ricordarci il significato cruciale della categoria marxiana di “duplice carattere” del lavoro, e in ultima istanza di tutti i processi economici all’interno di una costruzione sociale capitalista. Tutte le azioni umane al medesimo tempo trasformano materia ed energia, per esempio nella produzione agricola o nell’estrazione di carbone o di petrolio, o nella produzione industriale, e si tratta di trasformazioni di valore, come per esempio la produzione di valore e plusvalore. Pertanto il metabolismo dell’uomo con la natura è guidato dal meccanismo capitalista di plusvalore e dalla sua accumulazione. È questo il motivo principale per cui lo sviluppo economico emerge come una potente norma della società in grado di penetrare tutti i sottosistemi della vita sociale.
Dovremmo tenere presente che questa, all’interno della storia umana, è pur sempre una novità. Uno sguardo alle statistiche a lungo termine del millennio, realizzato dall’OECD nel suo Millennium Report del 2001, compilato dallo studioso di statistica Angus Maddison, mostra che nel corso dei secoli il tasso di crescita economico nella storia dell’uomo è sempre stato vicino allo zero. La stagnazione era un fenomeno normale, e i tassi di crescita inferiori non rappresentavano il segno di una crisi, di un cattivo risultato economico o di un fallimento delle politiche economiche. Soltanto a partire dalla rivoluzione industriale della seconda metà del XVIII secolo i tassi di crescita aumentarono di una media globale del 2% annuo. Le conseguenze di ciò furono rivoluzionarie. Tra una generazione e l’altra, il reddito pro capite medio raddoppiò. L’impatto sulle condizioni di vita, sull’esperienza quotidiana del tempo e dello spazio, e quello sulle ideologie furono enormi, molto più incisivi di quelli della rivoluzione francese o di quella russa.
A causa dell’influenza crescente di coloro che guidavano il capitalismo anche il metabolismo dell’uomo con la natura si espanse. Di conseguenza ricollegare l’inizio dell’Antropocene a un evento in particolare, a un “segno” storico, non ha alcun senso. Esso emerge infatti da un lungo processo storico che si svolge nel corso di millenni e che diventa maturo nell’Olocene. Nicholas Georgescu-Roegen, uno dei pochi economisti moderni che assume le fondamenta bio-fisiche dei processi economici, parla di due «Rivoluzioni prometeiche» nella storia dell’uomo. La prima avviene all’inizio dell’Olocene. Si tratta della rivoluzione neolitica dell’agricoltura stanziale che sostituisce la lunga era di caccia e raccolta. La seconda si verifica invece nel XVIII secolo, quando il genere umano comincia a dipendere energeticamente quasi al 90% dai combustibili fossili. Le fonti esterne di energia, come ad esempio le radiazioni solari, sono state sostituite da una fonte interna, le riserve fossili situate nella crosta terrestre, dapprima il carbone, in seguito petrolio e gas. Sfortunatamente le emissioni di combustibili fossili e della loro combustione rimangono nelle sfere terrestri, soprattutto nell’atmosfera. Le conseguenze sono funeste: la possibilità di un collasso climatico.
È ragionevole distinguere alcune fasi nel passaggio dall’Olocene all’Antropocene. La storia moderna antropocenica dell’umanità ha inizio con la rivoluzione neolitica e con i suoi effetti sulla cultura e le grandi civiltà moderne, soprattutto in Asia e Medio Oriente. La fase successiva è costituita dalla nascita delle grandi religioni monoteiste, il giudaismo, il cristianesimo e l’islam. Esse danno forma alla particolare logica dell’accelerazione nel tempo e dell’espansione nello spazio. Il risultato è lo sviluppo della scienza, di una specifica razionalità di conquista della Terra (anche fisica) e di cattura degli esseri umani e delle risorse a partire dal «lungo XVI secolo», com’è stato definito da Fernand Braudel. Vi sono buone ragioni per affermare che l’Antropocene abbia inizio con l’emergere della modernità e del capitalismo, all’epoca del Rinascimento.
Infatti, la fase successiva è quella della rivoluzione industriale, cioè il momento in cui la produzione capitalista di plusvalore assoluto e la sussunzione formale del lavoro (e della natura) sotto il dominio capitalista sono state trasformate in produzione di plusvalore relativo e sussunzione reale del lavoro (e della natura) sotto il Capitale, per usare le parole di Karl Marx.
Quella successiva è la fase della cosiddetta Grande Accelerazione, che si verifica dopo la seconda guerra mondiale. Le emissioni presenti in tutte le sfere del pianeta aumentano fino a un carico eccessivo ben oltre “i confini dello sviluppo”. Non c’è da stupirsi che lo studio del 1972 del Club di Roma sia stato così affascinante. Ancora più importante, comunque, è la capacità umana di distruggere il pianeta utilizzando l’arsenale di bombe atomiche e a idrogeno prodotte dalle superpotenze del pianeta. Il vero dominio del pianeta oggi permette anche la sua distruzione fisica e l’autodistruzione del genere umano. Di certo ciò segna una nuova era della storia umana e planetaria.
G. A.: Uno dei modi tramite cui il capitalismo sembra interessarsi alle questioni ecologiche è il cosiddetto «ecocapitalismo» (o “capitalismo verde”), una visione politica ed economica che estende il concetto di “capitale” all’intero ambiente naturale, con l’obiettivo di indicare le risorse naturali come uno strumento da usare in modo sostenibile e all’interno di un’economia di libero mercato. Possono capitalismo ed ecologia coesistere ed essere compatibili? O piuttosto l’ecocapitalismo rappresenta solo un ulteriore tentativo di sussumere la grande questione ecologica nel capitale?
A.: Visto dalla logica del capitalismo, il pianeta appare come un deposito di risorse e una miniera di inutili emissioni solide, liquide o gassose. Ma non tutto il mondo fa parte di questo deposito, sulla Terra ci sono molte erbacce inutili. Le risorse utili costituiscono l’obiettivo per le strategie del capitalismo di trasformare la natura per quanto redditizia in valore, di creare capitale naturale al di fuori della natura. Vi sono ancora economisti e politici ‘verdi’ che interpretano la trasformazione della natura in capitale come un positivo atto ecologico di difesa ambientale. Il concetto di green economy, di un capitalismo ‘verde’, non è altro che un tentativo ecologico di riconciliare economia ed ecologia, per giustificare la «liberazione del carbonio» come la definisce McKenzie Wark in Molecular Red. Dobbiamo considerare che di un milione d’anni di presenza umana sulla Terra solamente cinquecento anni hanno visto una coesistenza tra uomo e carbonio. Oggi si presenta come necessaria la cattura dell’anidride carbonica per arrestare l’impatto negativo che ha sul clima. La questione decisiva è se la cattura dell’anidride carbonica debba avvenire prima della combustione o, dopo, in forma di CO2. Si tratta solo in parte di una questione di natura tecnica. In fondo, pone i modelli di produzione e consumo in cima all’agenda politica: «Ende Gelände».
G. A.: In Anthropocene or Capitalocene? Donna Haraway presenta una teoria chiamata Cthulhucene. Secondo Haraway «gli esseri umani non sono gli unici attori importanti» coinvolti nei processi di trasformazione, «accanto a tutti gli altri esseri in grado solo di reagire», ma «sono le altre forze biotiche e abiotiche di questa Terra a essere la main story». Tale teoria sembra prendere in prestito alcuni elementi di certa letteratura visionaria e fantascientifica, e presenta una realtà ipercomplessa in cui vi sono interazioni (o intra-actions per usare le parole di Karen Barad) co-costitutive tra ogni cosa e ciascuna creatura. Come analista politico ed economista che cosa ne pensa di questa teoria?
A.: Prima le cose importanti, e ciò significa tradurre il linguaggio di Haraway, Barad e altri in un discorso che possa essere riconnesso ad altri discorsi comuni alle scienze e alle arti. Fatto questo, il concetto di «intra-action» è molto simile a quello hegeliano (ed engeliano) di Gesamtzusammenhang, o al concetto di totalità negli scritti di Marx. Tali concetti sono totalmente anti-individualistici e persino anti-neoliberali. Tuttavia le conseguenze politiche dipendono dalla visione del sistema sociale, del mondo contemporaneo e futuro. Pertanto include necessariamente elementi utopici (o distopici).
G. A.: A giugno 2017, il 45° presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la decisione di ritirarsi dagli Accordi di Parigi siglati da 195 paesi a dicembre 2015 con l’obiettivo di ridurre le emissioni annuali di CO2 e arrestare il fenomeno del riscaldamento globale. Questa notizia, che potrebbe causare disastrose conseguenze sul clima, è rimbalzata sulle prime pagine di tutti i giornali dando inizio a una serie di proteste in Europa e in USA. Tuttavia, generalmente i mass media, soprattutto in Italia – un paese poco attento alle questioni ambientali –, affrontano gli argomenti che riguardano l’ambiente con superficialità o con eccessivo sensazionalismo. Pensare alla crisi ecologica e a quella finanziaria come strettamente connesse l’una all’altra può costituire un modo per stimolare l’interesse pubblico nei confronti delle tematiche ambientali (ma a questo punto diremmo anche politiche e sociali)? Il sistema capitalistico può davvero essere rimesso in discussione e sconfitto? Una volta individuate le cause di questa crisi, che cosa possiamo fare per contrastare i suoi effetti?
A.: Hai ragione nel menzionare la comune origine delle crisi finanziaria e climatica. Si tratta di una delle ripercussioni del “duplice carattere”, che Marx delinea come punto cruciale («der Springpunkt») nell’analisi del lavoro del sistema capitalista. A causa del duplice carattere è impossibile concepire la merce o il denaro e il credito come fenomeni virtuali. Si tratta invece di fenomeni realmente esistenti (e in modo coincidente nella loro struttura sociale con tutte le conseguenze, incluso il feticismo della merce e del denaro). Ciò significa che una merce esiste come cosa materiale e fisica e come relazione sociale immateriale. Tuttavia entrambe le facce della merce sono reali. La crisi finanziaria irrompe per via dello sviluppo contrastante di benessere e debito, di capitale reale e capitale monetario, del mondo del lavoro e di quello della speculazione. I crediti monetari oltrepassano il reale benessere monetario prodotto, di modo che i crediti monetari o finanziari vengono cancellati. Quando le perdite diventano un fenomeno di massa, scoppia la crisi. Aumenta la disoccupazione, così come il numero di bancarotte, il capitale perso diventa visibile e quantificabile, come ad esempio la gradita riduzione delle emissioni di CO2.
Il benessere monetario può essere prodotto solo trasformando materia ed energia e perciò producendo CO2 e altre emissioni. Dato che la vera accumulazione non può essere fermata a causa dei fautori del capitalismo che applicano il sistema per produrre surplus, persino le emissioni di CO2 tecnicamente possono essere ridotte. Tuttavia, come già sappiamo, i margini tecnici della manovra sono limitati. Il duplice carattere è importante anche nei riguardi della soluzione alla crisi. Vi è l’alternativa tecnica di intervenire sul metabolismo grazie alla geoingegneria, mettendo in pratica modelli di gestione delle radiazioni o di cattura e deposito di anidride carbonica. Paul Crutzen, che ha coniato il termine Antropocene, è un fervido sostenitore della geoingegneria. Non a caso. Tecnicamente il genere umano ha trasformato il mondo nel pianeta antropocenico. Il genere umano è inoltre responsabile dei cambiamenti, e l’uomo è in grado di riparare il danno commesso. Tuttavia vi sono seri dubbi che gli interventi o le «intra-azioni» umane riescano ad avere successo su scala planetaria. Qui, come in molte altre aree dell’azione sociale, la portata conta. Con l’incremento di scala, gli investimenti negli impianti di geoingegneria aumentano, così come, secondo la logica dei profitti, la forza del capitale. La geoingegneria non è pertanto sostenibile né socialmente né ecologicamente.
Tuttavia, a causa del duplice carattere vi è un’altra via d’uscita dallo stallo della crisi antropocenica e geopolitica. La vediamo all’orizzonte quando interpretiamo l’Antropocene come Capitalocene. Questo perché la crisi climatica, l’estinzione delle specie, le minacciose catastrofi atomiche e le guerre non possono essere intese come un risultato dell’azione umana in quanto tale. La crisi del nostro mondo contemporaneo e antropocenico va intesa come la crisi della forma sociale, dell’insieme di forme sociali (come ad esempio della costruzione sociale) e dei suoi modelli di produzione. Pertanto la costruzione sociale e ogni sua emanazione possono e devono essere cambiate per superare le molteplici crisi capitaloceniche del sistema sociale e della natura del pianeta Terra, come ad esempio la crisi economica, finanziaria e sociale dell’accumulo di capitale e la propensione alla crisi del clima, dell’evoluzione, delle acque globali e della cultura umana. I primi passi per mettere in salvo il pianeta dal disastro dell’Antropocene vengono fatti all’alba di una rivoluzione.
Questo articolo, ripubblicato da Sbilanciamoci.info, è raggiungibile nella pagina di Kabulmagazine.com, dalla quale lo abbiamo ripreso
Non solo una nuova città e neppure solo un nuovo stato, ma l'anticipazione di un mondo così orrendo che nessun mostro avrebbe potuto immaginarlo; se non, appunto, il capitalismo
Il catalogo dei progetti di città “nuove” continua ad ingrossarsi con proposte destinate a specifici gruppi di popolazione. I modelli che più sembrano congruenti con l’organizzazione della società al tempo della globalizzazione capitalistica sono le smart cities, che promettono scenari di vita idilliaci alle élite della finanza e della tecnologia avanzata; le città galleggianti, isole artificiali per i ricchi che intendono rompere, anche fisicamente, ogni forma di contratto sociale; i territori recintati, dove milioni di esseri umani che non possiedono nulla sono concentrati e messi a disposizione degli investitori. Esempi di questi tre tipi di insediamento compaiono di frequente sulla stampa quotidiana e, quando sono firmati da famose archistar, sulle riviste di architettura.
Il recente annuncio del piano per una nuova città in Arabia Saudita, quindi, potrebbe sembrare di scarso interesse, anche in considerazione del fatto che molti progetti avviati negli ultimi anni in quel paese non si sono concretati. Ma Neom, che il principe Mohammed bin Salman al-Saud ha presentato nel corso della Future investment initiative, un evento che ambisce ad essere la “Davos nel deserto”, ha caratteristiche che meritano qualche attenzione, a partire dall’ambizione di non voler essere (solo) un grande progetto immobiliare, ma “un nuovo capitolo… un salto… nella storia della civiltà umana”. E non a caso il nome scelto, che fonde la radice latina, neo, con la lettera M, iniziale di mustaqbal, che in arabo significa futuro, intende evocare un “nuovo futuro”.
Situata nella parte nordoccidentale del paese, al confine con la Giordania e l’Egitto e poco distante da Israele (stato che il principe, amico di Trump e del governo israeliano, vorrebbe riconoscere) Neom è collocata in una posizione strategica, sia come “porta” verso l’Africa, grazie al previsto collegamento con la penisola del Sinai, da realizzare con la costruzione di un nuovo ponte, che come tappa della cosiddetta One belt one road, la sequenza di infrastrutture che la Cina sta costruendo per rafforzare la sua penetrazione nei mercati europei e africani.
Con i suoi ventisei mila cinquecento chilometri quadrati (Israele ne ha poco più di ventimila e il Libano circa diecimila) Neom ha più la dimensione di uno stato che quella di una città. Nel suo enorme territorio saranno in vigore speciali leggi fiscali e sul lavoro, nonché un sistema giudiziario autonomo, come già avviene in altre zone economiche speciali della regione- la prima delle quali, Jebel Ali free zone, è stata creata a Dubai nel 1985. A differenza che in altre zone economiche speciali, però, a Neom saranno ammesse solo produzioni e attività di pregio, concentrate in nove settori di investimento: energia e acqua, trasporti, biotecnologie, cibo, scienze tecnologiche e digitali, manifattura avanzata, mezzi di comunicazione, divertimento. Formalmente, la sovranità territoriale rimarrà a Riyadh, ma Neom non dovrà rispondere alle strutture governative saudite bensì ”agli investitori, alle imprese e agli innovatori” che saranno consultati in ogni fase dello sviluppo, affinché norme e regole siano sempre basate sulle “necessità delle imprese e degli investitori”.
Il disegno di nuovi insediamenti umani è sempre finalizzato alla predisposizione di scenari fisici che facilitino l’affermazione di determinate forme di organizzazione della società. Non è irrilevante, perciò, in un’epoca nella quale il capitale ha scatenato una guerra di sterminio nei confronti del lavoro, chiedersi cosa significherà vivere nella nuova “vibrante comunità che preannuncia il futuro della civiltà umana”. A questo proposito, nel corso di un’intervista a Bloomberg, il principe ha chiarito, innanzitutto, che l’ingresso non sarà consentito a tutti, ma solo a tre categorie di persone. “Questa sarà la prima app-based society, nessuno potrà venire senza avere la neom application e senza dimostrare di essere “un investitore, un impiegato in un progetto o un turista”. Gli investitori stranieri saranno i benvenuti, ma devono sapere che “non c’è posto per investitori qualsiasi o per imprese convenzionali, ma solo per sognatori”.
Alla domanda, poi, circa gli eventuali effetti positivi sull’attuale altissimo livello di disoccupazione giovanile del paese, il principe ha risposto che compito di Neom è di diventare uno hub di investimenti mondiali e di “generare denaro”, non quello di creare posti di lavoro per i sauditi disoccupati. Anche i sauditi potranno venire, ma ovviamente “non potranno dormire per strada” e dovranno o comprar casa o affittare una camera d’albergo, diventando anche loro “o turista o investitore”.
In ogni caso, Neom dovrà attirare solo “risorse umane di alto livello e con competenze uniche” in grado di occuparsi a pieno tempo di innovazione, decisioni e leadership degli affari.
I lavori ripetitivi e pericolosi saranno completamente automatizzati ed eseguiti da robot, il cui numero potrà superare quello della popolazione umana, col risultato che il reddito medio pro capite sarà il più alto del mondo. Dal servizio postale alla raccolta dei rifiuti tutto sarà automatizzato, non ci saranno negozi o supermercati, tutto sarà connesso all’intelligenza artificiale all’”internet delle cose”.
“Vogliamo che il primo robot sia Neom stessa”, ha detto il principe, e che diventi la culla della FIR (fourth industrial revolution) la quarta rivoluzione industriale che “annulla i confini tra la sfera fisica, quella digitale e quella biologica”. Il suo straordinario livello di efficienza e sicurezza, unito ad uno stile di vita lussuoso e ad un certo rilassamento dei costumi reso possibile dalle “riforme” (nel video promozionale si vedono giovani donne che corrono sul lungomare poco vestite) lo renderà “il posto migliore al mondo dove scegliere di vivere”.
La supervisione del progetto è stata affidata ad un’autorità speciale, di cui è stato nominato amministratore delegato Klaus Kleinfeld, già a capo di grandi gruppi multinazionali, tra i quali Siemens e Alcoa Arconic. Prototipo della “città capitalista del futuro”, Neom sarà anche la prima città quotata in borsa. Il suo costo, stimato al momento in 500 miliardi di dollari, sarà sostenuto, oltre che dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita, che intende procurarsi il denaro privatizzando e vendendo una quota della compagnia petrolifera di stato Aramco, da investitori internazionali.
Fra i circa quattromila partecipanti convenuti alla Future investment initiative per assistere alla illustrazione della Vision 2030, la strategia con la quale l’Arabia Saudita intende trasformare la propria economia per ridurre la dipendenza dal petrolio, c’erano padroni di grandi fondi di investimento (dagli americani di Blackstone ai giapponesi di SoftBank Vision), uomini d’affari ed esponenti di grandi multinazionali come Alibaba e Amazon, la direttrice del fondo monetario internazionale. Tutti hanno espresso apprezzamento e promesso di partecipare all’operazione. Ad esempio, il rappresentante del fondo di investimento diretto della Russia ha detto che porterà imprese high tech, mentre il padrone della Virgin, Richard Branson, si è dichiarato entusiasta all’idea di costruire alberghi lungo i quattrocento sessantotto chilometri di costa sul mar Rosso, con cinquanta isole, destinati ad attrezzature turistiche.
Nel poco più di un mese trascorso dall’annuncio della nascita di Neom, la propaganda mediatica si è intensificata ed il 29 novembre la compagnia discoverneom.com ha comprato un’intera pagina pubblicitaria del Financial Times.
Nello stesso tempo sono stati anche avanzati dubbi sulle concrete possibilità che il progetto venga realizzato, e in ogni caso non entro il 2025 come annunciato dal principe, pur se tutti convengono sul fatto che Neom sia un tassello importante del complesso processo di rimescolamento del potere in corso in Arabia Saudita, nel quale motivazioni di natura geoeconomica e di politica sovranazionali si intrecciano a faide e regolamenti di conti interni.
Comunque, al di là della realistica possibilità di realizzazione di Neom, il fatto stesso che i concetti che stanno alla base del progetto vengano analizzati, esplorati e discussi ha un indubbio impatto, e giustamente è stato osservato che il dibattito avviato rischia di esercitare uno sconvolgimento dell’urbanistica, come sistema di regole, simile a quello che uber ha provocato nel settore tecnologico.
Qualche anno fa molti urbanisti sono rimasti affascinati dalla metafora della città impresa, nella quale i diritti dei cittadini sono equiparati a quelli degli azionisti. Ora Neom chiarisce una volta per tutte che i cittadini sono azionisti di minoranza, senza diritto di voto, e che compito degli amministratori delegati è liberarsene per far spazio a droni, robot e investitori. “Pensate”, ha detto il principe, “cosa potrebbe fare il governatore di New York se, invece di dover rispondere alle richieste degli abitanti, potesse occuparsi solo delle necessità delle imprese e del settore privato”.
Nessuna cifra è stata fornita circa il numero di abitanti previsto a Neom, che qualcuno ha già definito la Blade runner del Golfo, e forse non è casuale che, in concomitanza con la presentazione del progetto, l’Arabia Saudita abbia concesso la cittadinanza ad un robot di nome Sophia/saggezza. Lei ha visto cose che noi umani non possiamo immaginare!
Gentilissimo Walter Veltroni, leconsiglio di ascoltare con attenzione il proclama letto dal giovane nazi skinche è entrato nei locali di Como senza Frontiere. Se loascolta con attenzione capirà che quel povero ragazzo esprimela frustrazione di milioni di persone che i “democratici” hanno consegnato allaviolenza finanziaria, e trasforma la frustrazione in rabbioso razzismo deiperdenti.
Qui il link all'articolo
La nuova formula adoperata per definire le porzioni del patrimonio immobiliare da destinare ai turisti nasconde un pesante inganno. È comunque un premio alla rendita immobiliare: una sommatoria di piccole speculazioni che, come la grande, toglie alloggi alla disponibilità dei residenti per darla ai turisti (e.s.).
Qui il link all’articolo
 Come uno zombie riemerge dal passato - peggiorata - una vicenda che sembrava sepolta dalle buone intenzioni della sindaca Raggi. Ma il rullo compressore degli affari cementizi non si arresta mai.
Come uno zombie riemerge dal passato - peggiorata - una vicenda che sembrava sepolta dalle buone intenzioni della sindaca Raggi. Ma il rullo compressore degli affari cementizi non si arresta mai.
Nessuno ha più parlato del famigerato stadio della Roma, ci eravamo illusi che fosse su un binario morto, è invece prossimo all’approvazione. Come abbiamo scritto a suo tempo si tratta della più grossa operazione di urbanistica contrattata del nuovo millennio. La capitale non si smentisce, è sempre quella dell’Hilton e chiunque sia insediato al Campidoglio non sa resistere al richiamo degli interessi immobiliari. Il M5S, quando era all’opposizione, durante l’amministrazione Marino, si era tenacemente battuto contro, presentando addirittura una denuncia penale per fermare lo scempio. Adesso, con spregiudicata e sospetta inversione di marcia, ha dato l’assenso. Queste sono le credenziali di chi si accinge a governare l’Italia.
Il nuovo progetto dello stadio e degli annessi business park, centinaia di negozi e attività commerciali è all’esame della conferenza dei servizi decisoria convocata dalla regione Lazio che sta per dare il via libera. Rispetto al primo progetto, bocciato dalla conferenza dei servizi dell’anno scorso, la principale novità è la consistente riduzione delle previsioni relative alle attività direzionali e commerciali, un volume comunque superiore a quanto consentito dal piano regolatore. Ma alla riduzione della cubatura corrisponde un drastico ridimensionamento delle infrastrutture a servizio dello stadio e degli insediamenti connessi. Con la conseguenza che la viabilità di accesso è limitata alla sola via Ostiense-via del Mare senza una seconda uscita indispensabile in caso di emergenza.
A questo punto, in soccorso di James Pallotta (presidente della Roma e proponente) e di Paolo Parnasi (che costruirà lo stadio e il resto con l’impresa Eurnova), accorre il ministro Luca Lotti che suggerisce di realizzare a spese dell’erario un nuovo ponte sul Tevere (previsto nel primo progetto e cancellato a seguito della riduzione delle cubature) che risolverebbe i problemi dell’accessibilità e della sicurezza. Circa cento milioni, questo il costo del ponte, a esclusivo servizio di un insediamento privato, perché privati sono lo stadio, il business park, ecc. Il tutto, tra l’altro, in contrasto con le prescrizioni di legge che pongono a carico del proponente tutte le opere necessarie alla funzionalità degli interventi. Una soluzione che ci pare inaudita. E inquietante è l’assoluta latitanza della politica e dei mezzi d’informazione.
Politica e mezzi d’informazione sono stati assenti anche nei mesi scorsi quando il Mibact ha fermato il vincolo sulle tribune dell’ippodromo di Tor di Valle (costruito per le Olimpiadi del 1960) proposto dall’allora soprintendente Margherita Eichberg. Vincolo fermamente condiviso dai comitati di settore del Mibact per l’archeologia, per il paesaggio, per le belle arti, per l’arte e l’architettura contemporanea. Secondo Ugo Carughi, presidente di Docomomo Italia – associazione per la documentazione e la conservazione degli edifici e dei complessi urbani moderni –, le tribune sono state ottenute “attraverso l’accostamento aereo di pensiline, travi a mensola, pilastri sagomati, gradonate, vetrate […] composti in un miracoloso quanto precario equilibrio”.

Un ultimo appello perché non si compia una scelta urbanistica utile solo agli interessi immobiliari. Qui le pesanti critiche di due "opinionisti" di eddyburg: Insieme allo stadio si approvano 10 Hilton di Vezio De Lucia, e Uno stadiosalverà Roma, di Piero Bevilacqua. Molte altre pesanti critiche digitando "Stadio Roma sul "cerca"

Nigrizia
, 1 dicembre 2017 «Un progetto di sviluppo fallimentare e distruttivo sta portando alla progressiva scomparsa di un ecosistema millenario e delle antiche popolazioni che lo abitano». Colpevole impunito: Impregilo, Italia
 |
| Ragazzini Hamar con il corpo dipinto di cenere bianca. (Magda Rakita/Survival) |
La valle del fiume Omo, in Etiopia, e in particolare la sua parte finale, conosciuta come bassa valle, è una delle pochissime parti dell’Africa, e del mondo, in cui si trovano ancora popoli nativi che vivono seguendo costumi e tradizioni ancestrali. E’ stata abitata fin dagli albori dell’umanità. Vi sono stati trovati resti di un australopiteco, uno dei nostri lontani antenati, risalenti a 2 milioni e mezzo di anni fa. La valle è stata una culla dell’evoluzione umana. Vi sono stati scoperti anche resti di altri ominidi e segni della permanenza dell’homo sapiens, cioè il nostro diretto progenitore, quali quarzi scheggiati, risalenti a circa 190.000 anni fa.
La valle, dicono gli studiosi del settore, è stata sempre un crocevia di popoli migranti portatori di diverse culture, provenienti da diverse zone del continente. Questa è la ragione della diversità dei popoli nativi che vi sono ancora oggi stanziati: circa 200.000 persone appartenenti ai gruppi Mursi, Suri, Karo e numerosi altri. La valle è anche l’habitat di flora e fauna indigene, talvolta in via di estinzione in altre aree della regione. Per questo è il paradiso di archeologi, antropologi, botanici e altri scienziati, ed è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. E’ un territorio dal delicato equilibrio ecologico che si estende per centinaia di chilometri nel sud dell’Etiopia. Le acque, raccolte dal fiume Omo, finiscono nel lago Turkana, un grande bacino - 6.405 Kmq, profondità media 30 metri - che si estende per la maggior parte oltre il confine etiopico, in Kenya, nella Rift Valley. Delle sue risorse vivono centinaia di migliaia di persone.
Dighe e land grabbing
In molti ormai si chiedono fino a quando questo patrimonio di tutti potrà sopravvivere. E’ infatti gravemente minacciato dai progetti del governo di Addis Abeba per produrre energia e prodotti agricoli per l’esportazione. Il basso corso dell’Omo e il lago Turkana sono infatti il teatro di trasformazioni rapidissime provocate dalla costruzione di una cascata di dighe sul maggior affluente dell’Omo, il fiume Gibe, che ha cambiato in modo radicale e permanente il regime delle acque, mettendo a serio rischio l’intero ecosistema e la vita stessa della popolazione e della fauna che vive delle sue risorse.
La situazione è aggravata dai progetti di sfruttamento dell’acqua, raccolta nei vasti bacini formati dalle dighe, per l’irrigazione di smisurati territori dati in concessione, per cifre risibili, a compagnie straniere dell’agribusiness per la coltivazione di prodotti come il cotone o la canna da zucchero. Sono prodotti destinati all’esportazione e dunque al sostegno del bilancio statale da impegnare in un programma di sviluppo economico rampante, secondo un modello industriale che ha già rivelato enormi limiti nei nostri paesi. Non sono certo intesi al rafforzamento della sicurezza alimentare del paese, che annualmente dichiara crisi che colpiscono milioni di persone nelle aree rurali più isolate, appellandosi ogni volta alla solidarietà internazionale per evitare vere e proprie carestie.
L’acqua e la terra che sono la base dell’economia, e della stessa sopravvivenza, dei popoli nativi e rivieraschi in genere, sono insomma oggetto di accaparramento - water and land grabbing - per uno sviluppo che non li prevede. La più grande delle dighe in programma - la Gilgel Gibe III, la più imponente dell’Africa fino alla costruzione della Gerd (Grand Ethiopian Renaissance Dam) in via di costruzione sul Nilo Blu, entrambe ad opera della ditta italiana Salini Impregilo - è entrata in funzione nel 2015, e ha già cambiato in modo radicale e permanente il regime delle acque del fiume Omo, determinando la riduzione drastica delle alluvioni stagionali che permettevano la coltivazione dei terreni lungo le rive per la produzione di ortaggi, cereali e legumi, base alimentare della popolazione della bassa valle.
Quasi desertificati anche i pascoli che non riescono più a sostenere l’allevamento del bestiame, altra risorsa della popolazione locale. Per non parlare del pesce, che costituiva un’importante fonte di cibo per le popolazioni della valle dell’Omo e di risorse anche monetarie per quelle che vivono attorno al lago Turkana, di cui si osserva già una notevole diminuzione del livello. Inoltre, organizzazioni internazionali come Survival International - ascolta, a destra della pagina, la nostra intervista alla direttrice, Francesca Casella - denunciano frequentemente abusi e violazioni gravissimi dei diritti delle popolazioni locali, allo scopo di cacciarli dalle proprie terre ancestrali per far posto ad attività di agricoltura meccanizzata.
Un disastro annunciato
Per dire la verità, tutto era stato ampiamente previsto fin dall’inizio del progetto. Ma non sono bastate combattive e documentate campagne internazionali, con forti radici in loco e attività competenti e continuative in molti paesi europei - e in particolare in Italia per via della ditta costruttrice - a fermare il programma. I timori espressi dalla società civile, basati su studi di esperti riconosciuti a livello internazionale, non sono stati presi in considerazione. Ma, a soli due anni dall’inaugurazione della diga, i risultati già possono essere visti chiaramente. Il cambiamento drammatico dell’ambiente e l’assottigliarsi delle possibilità di sopravvivenza delle popolazioni interessate sono stati descritti nelle ultime settimane in ricerche sul campo, in numerosi reportage (Rai, New York Times, The East African) e in articoli di riviste autorevoli come il National Geographic.
La valle dell’Omo è ormai una regione sul precipizio, si legge nell’articolo del New York Times, mentre il lago Turkana sembra destinato a fare la fine del lago Ciad, di fatto quasi scomparso. Un impatto funesto sull’ambiente, sulle comunità locali e sul nostro patrimonio comune in nome di un modello di sviluppo economico già fallito nel nord del mondo e perfino in Etiopia. Il governo, infatti, dimostra di non essere in grado di assicurare condizioni minime di sopravvivenza a milioni di cittadini e a centinaia di comunità, nonostante la crescita vertiginosa del Pil, o più probabilmente proprio a causa del modo nel quale questa crescita è originata.
L'originale dell'articolo è reperibile a questo indirizzo, corrispondente a una pagina del sito web della rivista Nigrizia
dal quale lo abbiamo tratto. Raggiunto il sito indicato è possibile ascoltare la conversazione con la direttrice di Survival International Italia, Francesca Casella. Ringraziamo Nigrizia per la concessione

La presentazione del progetto denominato (piuttosto pomposamente, per adesso) Human Technopole si è svolta, in fondo come suggerivano gli uffici stampa congiunti dei vari interessi coinvolti (segue)
La presentazione del progetto denominato (piuttosto pomposamente, per adesso) Human Technopole si è svolta, in fondo come suggerivano gli uffici stampa congiunti dei vari interessi coinvolti, ovvero puntando su un cocktail nazionalpopolare tra rendering di architettura e ariose metafore da centro studi di settore. E lo svarione del top manager di lungo corso leghista di nomina regionale, che ha reinterpretato l'ex Decumano Expo a verde chiamandolo con dizione comico-celodurista «il parco più lungo d'Europa», a suo modo conferma l'impressione. Impressione per nulla positiva se si esce da certi aspetti contingenti (come il sollievo generale per avere a quanto pare trovato uno sbocco al pasticcio finanziario con le aree combinato in epoca formigoniana) e si entra in considerazioni più ampie sulla cosiddetta idea di città che ne esce: soggetti, scenari, equilibri, e anche le forme, pur al netto delle importanti ma qui di secondo piano questioni architettoniche. Il fatto è che da lustri ormai si discetta qui e là del ruolo di punta delle economie della conoscenza nel delineare la città futura, e su cui si basano tante altre riflessioni su lavoro, ambiente, sostenibilità, e giù giù fino al ruolo dei trasporto o delle comunicazioni o della composizione funzionale.
Per capire che posto occupa questo costosissimo quartierino periferico ai confini autostradali tra Milano e hinterland metropolitano, nel dibattito sulla città futura in generale, forse val la pena di introdurlo in un processo più generale che potremmo tranquillamente chiamare «impresa e territorio», e che negli anni recenti si è arricchito dell'abbastanza noto scontro, più o meno dialettico, tra i fautori di una opzione urbana, e i sostenitori di modelli vari più meno legati all'antico decentramento produttivo, declinato in forme contemporanee. L'opzione urbana più nota e pubblicizzata da un individuabile filone tecnico e immobiliarista è quella delle nuove professioni creative, coi quartieri vivi su 24 ore 7 giorni la settimana, che confondono tempo di lavoro e tempo libero, dove tutti si aggirano a piedi in bicicletta coi mezzi pubblici o su veicoli elettrici, compulsandeo su qualche diavoleria elettronica il flusso di informazioni che si chiama «lavoro», e che naturalmente fornisce il reddito adeguato a viverci, in quei posti. Fatti di negozi esclusivi, gallerie d'arte, ambienti ibridi libreria-caffè-ufficio, e complessi residenziali più o meno densi costituiti da microappartamenti, simili più a uno studentato che a un condominio, perché tanta parte di quella vita post-adolescenziale si svolge negli «spazi pubblici» esterni. Inutile sottolineare come nella pratica questi quartieri o interi settori urbani siano diventati una variante della gated community, dove alle pareti fisiche si è sostituito uno zoning socioeconomico esclusivo, molto esclusivo.
 |
| La gerarchia spaziale capitale-lavoro a Crespi d'Adda (foto F. Bottini) |
La seconda opzione è quella classica del castello simbolo di potere sul territorio, già incarnata dalla tipologia dello office park suburbano e che alcune grandi aziende continuano pervicacemente a perseguire, come simbolicamente e su precisa
eredità di Steve Jobs la Apple, nell'astronave toroidale posata dallo studio Norman Foster nell'ex terreno della Hewlett Packard a Cupertino. Se la scelta urbana nascondeva lo strapotere dei soldi e dell'impresa frammentando spazi, tempo di lavoro, aspirazioni e incarnazioni individuali, la fortezza suburbana dichiara la sua autorità, direttamente discendente dalla classica
company town delle ciminiere ottocentesche, magari addolcita dal paternalismo strumentale di questo o quel CEO. Le forme insediative e architettoniche restano però praticamente quelle classiche con rigida separazione funzionale tra fabbrica e territorio, segregazione socioeconomica, e ruoli familiari, per non parlare della estrema difficoltà o impossibilità di introdurre aspetti di maggiore sostenibilità ambientale nei trasporti, nell'agricoltura e consumo di suolo, nei servizi.
Alle opzioni in qualche modo estreme corrisponde però una infinita serie di varianti possibili, dove si mescolano in equilibri diversi vari fattori, sia spaziali che sociali che di potere. Due esempi recenti e significativi riassumono molto bene due percorsi opposti ma in qualche modo convergenti. Il primo è il quartier generale che Amazon vuol collocare nella città che si mostrerà più accogliente, per approfittare delle economie esterne garantite dall'ambiente urbano in termini di mercato del lavoro prossimità e stimoli. Il rovescio della medaglia di questa scelta di insediamento centrale sta nel mantenimento del formato accentrato, che si traduce in un trasloco di fatto del grande campus suburbano autosufficiente dentro un ambiente centrale che si classifica in qualche modo di rango inferiore, e ovviamente senza alcuna contaminazione funzionale. Il percorso opposto è quello scelto dalla Microsoft per il proprio centro direzionale nell'area metropolitana di Seattle, dove nello stile della densificazione suburbana promossa da certa scuola New Urbanism, si cerca invece di introdurre pedonalità, multifunzionalità, pratiche sostenibili e modalità di lavoro più elastiche, in pratica tendenzialmente rendere più simile il campus di impresa a un normale quartiere dove si è insediata anche l'impresa.
Possiamo dire che la strategia insediativa dello Human Technopole in qualche modo appartiene di diritto a questa «terza via», del percorso misto, quanto a metodo (indipendentemente quindi da alcune osservazioni che si possono fare sul rapporto con la città e specie con le forme urbane italiane correnti). C'è una collocazione decentrata ma non troppo verso cui confluiscono funzioni di varia provenienza a costituire una massa critica di parco scientifico, a cui si aggiungeranno presto anche altre funzioni residenziali e di servizio, a discutibile ma effettivo riuso di un'area periferica ma fortemente integrata al tessuto urbano e metropolitano. Entra qui, proprio pensando alla dimensione metropolitana spesso evocata dagli stessi proponenti, il dubbio sull'inserimento organico o no, nell'equazione, delle dismissioni di altri spazi per le funzioni trasferite, e in particolare per dimensioni rilevanza e prossimità quella dell'Università Statale dal suo quartiere attuale a Città Studi, nel cuore di Milano. Sostanzialmente due le possibilità: la prima è che analogamente a una dismissione sul modello industriale, anche l'università in questo caso si faccia tentare dall'approccio puramente immobiliare-finanziario (e che in sede di contrattazioni varie nessuno possa correggere questa tendenza); la seconda è che il ruolo delle economie della conoscenza fisiologicamente orientate a interazioni di tipo urbano «alla Richard Florida» per usare una definizione schematica, riesca a cogliere i vantaggi di un approccio effettivamente a scala di regione urbana, facendo dialogare i due poli e cercando integrazione. Forse non si arriverà a cittadelle ideali del capitalismo più o meno illuminato del terzo millennio, ma si darà un segnale culturale importante.
Qualche considerazione in più su La Città Conquistatrice e un link alla descrizione puntuale del progetto Microsoft dal Seattle Times; specificamente su alcuni aspetti dell'operazione milanese il blog del lunedì sul quotidiano online Today

Corriere della Sera, 30 novembre 2017. La recensione al saggio di Bruno Maida L’infanzia nelle guerre del Novecento. «I bambini con il fucile in mano rappresentano il fallimento degli adulti e della cultura dell’Occidente ». (m.p.r.)
Bruno Maida L’infanzia nelle guerre del Novecento, Einaudi 2017.p.360, €10,99
È difficile dimenticare «la bambina della foto», Phan Thi Kim Phúc che l’8 giugno 1972 corre corre, bruciata dal napalm durante la guerra del Vietnam. Si è strappata la vestina che aveva preso fuoco, urla e piange, le braccine spalancate, immortalata dal fotografo Nick Ut che la porterà all’ospedale dove sarà salvata.
I bambini e la guerra. Il dolore e la pietà. La violenza e l’aggressività. La vita appesa a un filo traballante. La gratuità della morte. Le stragi belluine. Le guerre patriottiche e quelle di rapina. I bambini vittime. I bambini soldato. I bambini protagonisti. I bambini testimoni di genocidi e di altri fatti atroci che non dimenticheranno mai, non diversamente dagli adulti. (La guerra, risulta da tanti segni, memorie, diari, è forse il fatto che per tutta la vita non smette di pesare sul cuore dell’uomo) .
Bruno Maida, ricercatore dell’Università di Torino, ha scritto per Einaudi un corposo saggio sui bambini e i conflitti nel mondo: L’infanzia nelle guerre del Novecento un libro importante e partecipe, fondato su una ricchissima documentazione. Autore di uno studio sulla Shoah dei bambini, Maida articola ora il suo nuovo libro in una serie di capitoli tematici: il rapporto tra infanzia e guerra, la legislazione sui civili diventati i veri attori dei conflitti, la Prima guerra mondiale, il fascismo, il nazismo e lo stalinismo, la Seconda guerra mondiale, i processi di decolonizzazione postnovecenteschi, le eredità delle guerre, i ricordi dei bambini e quelli sui bambini.
Le guerre nascono col mondo e con loro anche i bambini soldato, non sempre costretti, ma affascinati non raramente dalle divise e dalle armi. Il gioco della guerra.
Napoleone creò il Reggimento dei Pupilli della Guardia; nella guerra civile americana avrebbero combattuto centomila ragazzi di età inferiore ai 15 anni. Tra i Mille di Garibaldi risultano un undicenne, due tredicenni, tre quattordicenni e altrettanti quindicenni. Nel Cuore di De Amicis - Il tamburino sardo, La piccola vedetta lombarda - i fanciulli sono ansiosi di prender parte, le armi in pugno, alle guerre risorgimentali.
Nelle guerre del Novecento il numero dei morti è raccapricciante: 100 milioni, di cui 62 milioni di civili, senza contare quasi 100 milioni uccisi in altre stragi. Numerosi i morti bambini e ancor più gli orfani, con la conseguente degenerazione di intere comunità.
Nel 1945 si pensava che dopo la bomba atomica, dopo la Shoah, si sarebbe vissuti serenamente, al riparo dalle bombe. In Europa è accaduto, o quasi - se non si considera il terrorismo - ma si calcola che in quel secolo i conflitti siano stati nel mondo quasi 250. Soltanto negli anni Novanta del Novecento - scrive Maida - sono scoppiate 30-40 guerre. L’80 per cento delle vittime sono civili, moltissimi tra loro i ragazzini: una stima indica che tra il 1985 e il 1995 ne siano stati uccisi circa due milioni.
Fin dalle origini il fascismo è portatore della sua dottrina militaresca anche per gli innocenti pargoli. A sei anni gli scolari indossano la divisa di figlio della Lupa, il fucilino del balilla moschettiere è il gran miraggio. I maestri, che indossano la sahariana nera col pugnaletto alla cintura, predicano la fede nella grandezza imperiale di Roma. Il desiderio di arruolarsi, piccoli soldati, soprattutto al tempo della guerra d’Etiopia, è cocente. Mussolini è il mito vivente: «Giuro di eseguire gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e se necessario col mio sangue la causa della Rivoluzione fascista», recita l’obbligato giuramento. Poveri bambini, si sa come andrà a finire.
Il nazismo segue la stessa via, ogni bambino deve essere un cittadino-soldato al servizio del Führer, «da prima del suo concepimento». «A scuola - scrive Maida - le lezioni di religione terminavano con il saluto al Führer. (...) I bambini dovevano esclamare all’inizio: “Heil Hitler! Sia lodato Gesù Cristo in eterno, amen”, per concludere con: “Sia lodato Gesù Cristo in eterno, amen. Heil Hitler!”».
In Unione Sovietica le cose non andavano diversamente. I giovani pionieri dovevano essere sempre pronti alla lotta per la classe operaia: giuravano di esser fedeli ai precetti di Lenin, di voler combattere con fermezza per il comunismo. Ordine e disciplina. Libri e moschetti anche qui. Alla vigilia della Seconda guerra mondiale i pionieri erano 11 milioni. Nella figura del generale Kutuzov che nel 1812 aveva sconfitto le armate di Napoleone, i piccoli russi dovevano intravedere le virtù leggendarie di Stalin.
Furono i nazisti, forse, i bambini che impararono meglio la lezione. Un esempio. Nel 1943 fu creata la 12ª SS Panzer Division Hitlerjugend, 10 mila ragazzi. Combatterono su più fronti, soprattutto in Normandia. «Fanatici e motivati», scrive Maida, «ne sarebbero tornati a casa solo seicento».
Dei sei milioni di ebrei uccisi durante la Seconda guerra mondiale almeno un milione erano bambini. Pochissimi riuscirono a salvarsi nei lager di Treblinka, Sobibór, Belzec, Chelmno. «La condizione dell’infanzia ad Auschwitz è incarnata in Hurbinek, che era un nulla, un figlio della morte, un figlio di Auschwitz, dimostrava tre anni circa, nessuno sapeva nulla di lui, non sapeva parlare e non aveva nome»: lo racconta Primo Levi nel suo La tregua. «Nulla resta di lui: egli testimonia attraverso queste mie parole».
Poi nella seconda metà del Novecento e nel Duemila affliggono il mondo guerre spesso sconosciute, portatrici di fame, di povertà, di disperazione, di marginalità.
Le fabbriche di armi sono sempre al lavoro. Lo insegna Trump. Ma anche negli anni passati non sono mai mancate le commesse: dal 1997 al 2000 sono state vendute nel mondo armi leggere per 51 miliardi di dollari.
Maida racconta storie di bambini che non hanno mai visto una scuola, come in Colombia; di bambini palestinesi che conoscono soltanto il campo profughi dove sono nati; di bambini che in Rwanda, secondo una ricerca dell’Unicef, sono stati testimoni di assassinii, hanno visto uccidere i famigliari, sono stati minacciati di morte. In Siria, tra il 2011 e il 2013, sono stati uccisi più di 10 mila bambini; in Pakistan, nel 2014, i Talebani hanno ammazzato in una scuola 132 bambini; in Cambogia, tra il 1975 e il 1979, morirono in guerra circa 2 milioni di persone, innumerevoli i bambini, spesso con il kalashnikov al collo. Nella guerra tra Iran e Iraq, negli anni Ottanta del Novecento, persero la vita centomila bambini iraniani, con in tasca il «passaporto per il Paradiso»; in Uganda, secondo un documento del Congresso americano del 2009, oltre 66 mila bambini.
L’Asia, l’Africa, il Sudamerica sono stati i luoghi della geografia della morte. I diamanti in Sierra Leone, il coltan, un minerale prezioso, in Uganda, la cocaina in Colombia sono serviti e servono ad arricchire i capi delle milizie armate e a procurarsi armi.
Quali sono state e quali sono le manchevolezze del Diritto Internazionale, della vecchia Società delle Nazioni, dell’Onu, della Unione Europea?
Scrive Maida: «I bambini con il fucile in mano rappresentano il fallimento degli adulti e della cultura dell’Occidente che produce armi, le vende e ci si arricchisce dopo avere avuto una responsabilità non secondaria nella povertà e nel caos di quei Paesi che vivono in uno stato di guerra perenne».
L'articolo è tratto dal Corriere della Sera on line. L'originale è accessibile qui
la Nuova Venezia, 30 novembre 2017. «Venezia. Il professor D’Alpaos: il livello del mare nei prossimi 30 anni crescerà di 50 centimetri: il porto sarà a lungo fuori uso intervista di Alberto Vitucci» con postilla
VENEZIA. «L’idea di mettere le grandi navi a Marghera è morta in partenza. È una soluzione impossibile. Perché fra vent’anni il porto non sarà più agibile, per l’aumento del livello del mare e le chiusure del Mose. Dunque per non penalizzare la portualità, le crociere devono andare fuori. Come anche il traffico commerciale».
Il professor Luigi D’Alpaos, 74 anni, ingegnere idraulico di chiara fama, stronca sul nascere l’ipotesi di una nuova Marittima dentro la laguna. Da anni si batte da tecnico per dimostrare quali danni irreversibili gli interventi dell’uomo stanno provocando all’equilibrio lagunare. Oggi pomeriggio sarà alle 18 in sala San Leonardo, per spiegare in un dibattito pubblico organizzato dalla Municipalità, la sua idea su cosa si intenda per salvaguardia.
Professor D’Alpaos, perché Marghera non va bene?
«Marghera, come la Marittima e il Vittorio Emanuele, sono interventi che non tengono conto di come sarà lo scenario nei prossimi vent’anni. Il porto non sarà più agibile. Dunque bisogna portare all’esterno della laguna non solo le crociere, ma anche il traffico commerciale. Di questi fattori mi pare non si sia tenuto conto nella scelta annunciata».
Lei è d’accordo con l’off-shore.
«Non si può dire che io sia un amico dell’ex sindaco e presidente del Porto Paolo Costa. Ma quella mi sembra un’idea che guarda al futuro. È stata scartata con troppa fretta».
Perché, lei dice, il porto non sarà più agibile?
«Per l’innalzamento del livello medio del mare, che nei prossimi trent’anni aumenterà di almeno 50 centimetri».
Tra gli scienziati ci sono sfumature diverse sulle previsioni.
«Sì, ma ormai è certo che l’aumento sarà di quell’ordine di grandezza. Il Consorzio Venezia Nuova e il Corila avevano vergognosamente sottovalutato questo aumento quando hanno progettato il Mose. Non tenendo conto tra l’altro del vento di bora che aumenta il livello dell’acqua in laguna centrale anche a bocche di porto chiuse.
Dunque?
«Ho fatto uno studio sulle maree degli ultimi dieci anni. Con l’aumento del livello del mare di 50 centimetri la laguna sarebbe chiusa per 4500 ore, senza contare l’anticipo e i falsi allarmi. Dunque, per metà anno. Impossibile».
Poi c’è l’aspetto ambientale.
«Lo ripeto da troppo tempo ormai. L’ho detto e scritto in tutte le salse. Ma la politica non sempre ascolta la scienza. Quando in laguna passa una nave da 150 mila tonnellate, il suo dislocamento induce fenomeni indotti secondari come l’erosione e la perdita di sedimenti di una laguna già al collasso. Più grandi sono le navi, più grande è il danno. Per fare arrivare le navi a Marghera bisognerebbe anche raddoppiare il canale dei Petroli. Non bastano i danni che ha già fatto così»?
Allora qual è la soluzione?
«Il porto turistico deve stare fuori della laguna. Al Lido, a Pellestrina. Con limitazioni alla grandezza delle navi».
Le compagnie armatrici non saranno d’accordo.«Pazienza. Io proporrei anche di fare dei corsi per i turisti che vengono a Venezia. Insegnare loro la storia, la particolarità di una laguna unica al mondo che vogliono visitare. Finché non imparano, devono restare in quarantena»
l'articolo è tratto da la Nuova Venezia online, e l'originale è accessibile qui:Le mega navi solo fuori della Laguna
postilla
Se per mega navi s'intendono quelle che, insieme ai treni e agli aerei, portano masse sterminate di turisti a Venezia allora ogni soluzione (anche quella proposta dal prof D'Alpaos) è inutile, ai fini della tutela di ciò che rimane della città. L'Urbs rimane, ricorda D'Alpaos, ma senza Civitas, e Polis è andata a remengo, finendo con un clown di nome Brugnaro.
il Salvagente, online, 28 novembre 2017. L'accorato appello della comunità degli scienziati consapevoli per tentar di scongiurare la morte del nostro pianeta. Le 13 cose da fare subito
La scienza unanime continua predicare, inascoltata, che il tempo rimasto per salvare il pianeta su cui abitiamo è poco. Secondo le informazioni e testimonianza raccolte da il sito “il salvagente”«se continuiamo così, finiremo per uccidere il nostro sistema». Già nel 1992, del resto, la Union of Concerned Scientists (una (Ong che raccoglie più di 1700 scienziati) sosteneva che l’impatto delle attività umane sulla natura avrebbe presto distrutto il pianeta irrimediabilmente.
Un quarto di secolo dopo, purtroppo, le cose non sono cambiate. Anzi sono peggiorate. Disponibilità di acqua potabile, deforestazione, diminuzione dei mammiferi, emissioni di gas serra: questi indicatori sono in rosso dal 1992 e le risposte sono ad oggi deludenti.Da qui la necessità di un secondo avvertimento lanciato dai 15mila scienziati. Essi non si limitano a denunciare il rischio, ormai immanente. indicano 13 azioni virtuose che potrebbero, se non annullare la tendenza, almeno rallentarla dicono e nel manifesto indicano 13 azioni da mettere in atto subito. Eccole come le riporta il quotidiano Le Monde:
1. creare riserve interconnesse ben collegate e correttamente gestite per proteggere una proporzione significativa dei vari habitat terrestri, aerei e acquatici; 2. preservare i servizi della natura attraverso gli ecosistemi fermando la conversione delle foreste naturali, delle praterie e di altri habitat;3. ripristinare le comunità vegetali endemiche su larga scala, compresi i paesaggi forestali; 4.riqualificare aree con specie endemiche, in particolare super-predatori, per ripristinare le dinamiche e i processi ecologici; 5. sviluppare e adottare adeguati strumenti politici per combattere la sconfitta, il salvataggio, lo sfruttamento e il traffico di specie minacciate; 6. ridurre i rifiuti alimentari attraverso l’istruzione e migliorare le infrastrutture; 7. promuovere una riorientazione della dieta verso prodotti alimentari di origine vegetale;
8.ridurre ulteriormente il tasso di fertilità assicurando che gli uomini e le donne abbiano accesso ai servizi di istruzione e di pianificazione familiare, in particolare nei settori in cui questi servizi mancano ancora; 9. moltiplicare le escursioni per i bambini per sviluppare la loro sensibilità alla natura e generalmente migliorare l’apprezzamento della natura in tutta la società; 10. incoraggiare un cambiamento ambientale positivo; 11. progettare e promuove nuove tecnologie verdi e rivolgersi in maniera massiccia verso fonti energetiche verdi, progressivamente riducendo il sostegno alla produzione di energia con combustibili fossili; 12.e soprattutto rivedere la nostra economia per ridurre le iniquità della ricchezza e garantire che i prezzi, le tasse e gli incentivi tengono conto del vero costo dei nostri modelli di consumo per il nostro ambiente;13. determinare a lungo termine una dimensione umana sostenibile e scientificamente difendibile, assicurando il sostegno dei paesi e dei leader mondiali a raggiungere questo obiettivo vitale.
Internazionale, 24 novembre 2017. Gli abitanti e la vita a Cosmopolis, una delle tante gate community per la middle class di Bucarest, lontana dalla città, recintata, vigilata, verde, sicura, e socialmente omogenea. (i.b)
Ai margini di Bucarest cinquemila persone vivono in un invitante universo parallelo, lontane dalla confusione della città. Casette dai tetti color turchese, come nel Monopoly, si affacciano su un lago e, più avanti, palazzi gialli di dieci piani incorniciano grandi piscine piene d’acqua limpidissima. Tutti lasciano i telefonini e i portafogli in vista sulle sdraio. Un pallone rimbalza sull’acqua. Un ragazzo abbronzato con un braccialetto rosa al polso si tuffa per prenderlo, schizzando le persone a bordo piscina. Tutti portano lo stesso braccialetto di plastica. Indica che hanno il permesso di stare qui.
 |
| Il complesso residenziale Cosmopolis |
Cosmopolis è uno dei più grandi complessi residenziali della zona di Bucarest, premiato perfino a livello internazionale. Qualche anno fa qui c’erano solo terreni abbandonati lungo le rive del lago Creţuleasca. Oggi c’è un quartiere che appartiene al comune di Ştefăneştii de Jos. L’ingresso ricorda una frontiera: muri, cancelli e guardie. Uno dei vigilanti, con occhiali da sole, maglietta azzurra e pancia d’ordinanza, fa la stessa domanda a tutti gli sconosciuti: dove va? Qui possono entrare solo i residenti, altrimenti bisogna essere annunciati con una telefonata in portineria.
La crisi è passata, gli stipendi crescono, e sempre di più gli abitanti di Bucarest vogliono comprare casa in uno degli oltre cento complessi residenziali costruiti alla periferia della città. Queste strutture hanno servizi di vigilanza, parchi e piscine, e le case non costano più dei vecchi appartamenti del centro. Molti hanno fretta di comprare perché temono che i prezzi tornino a salire e raggiungano i livelli precedenti alla crisi. I dati di Eurostat mostrano che la Romania è il paese dell’Unione europea con la più alta percentuale di proprietari di casa. L’affitto è considerato una soluzione transitoria, che sul lungo periodo serve solo a buttar via soldi. Per questo abbiamo cercato di capire perché i romeni sono così legati alla proprietà della casa, e soprattutto che vantaggi e che svantaggi hanno a vivere in quartieri periferici chiusi e mal collegati alla città. Abbiamo viaggiato tra passato e futuro, tra campagna e città, tra comunità reali e virtuali. E abbiamo capito che il modo in cui abitiamo dice molto su chi siamo e su chi vogliamo diventare.
Alice e Răzvan. È domenica prima dell’ora del pranzo e via Europa, nel complesso Cosmopolis, è deserta. Qualche alberello spunta dal cemento. Siamo a venti chilometri dal centro di Bucarest, fuori dal raccordo. Davanti al cancello c’è la fermata del minibus che porta in città; se non c’è traffico in mezz’ora si arriva alla prima fermata della metropolitana. La sala d’attesa ha le pareti gialle. Sotto un grande specchio è disegnato un divano azzurro, e dal soffitto pende un candelabro di finto bronzo. In fondo alla strada principale, in una casetta circondata da una palizzata bianca, abitano Alice e Răzvan Petrescu insieme alla loro figlia. Prima di lasciare la città sono stati in affitto a Cosmopolis per un periodo di prova. Quando Alice è rimasta incinta si sono decisi: hanno venduto l’appartamento di Bucarest e hanno comprato qui. In giardino hanno il barbecue, le sdraio, alberi da frutta e lillà. Alice ha piantato le erbe aromatiche che le ha dato la nonna. “Quando sei cresciuta in città e improvvisamente hai un pezzo di terra ti sembra una magia”, dice. Al piano di sopra ci sono le camere da letto, mentre al piano terra la cucina e il salotto, che si è trasformato in un parco giochi per la bambina. È stato il suo arrivo, raccontano, a convincerli a prendere una decisione radicale e a cercare un quartiere simile a quelli che avevano visto in Europa occidentale.
 |
| Alcune palazzine di Cosmopolis |
A differenza che in città, qui Alice può andare tranquillamente in giro con il passeggino e non deve preoccuparsi per quello che può succedere alla bambina. Quando era piccola, Alice voleva diventare ginnasta, come Nadia Comaneci. “Solo che esercitandomi una volta ho battuto la testa sull’asfalto. Qui c’è l’erba”. I coniugi Petrescu hanno entrambi tatuaggi del gruppo musicale tedesco Rammstein sulle braccia e durante le vacanze vanno in giro per festival e concerti. La scorsa estate sono stati a un festival a Cluj, l’Electric castle, e a vedere i Depeche Mode, sempre con la figlia. Alice ha 37 anni, indossa una salopette a fiori e ha i capelli neri e lunghi, legati in una coda. Ha lavorato per otto anni e mezzo come consulente legale per una multinazionale, senza riuscire a occuparsi delle sue passioni: l’astronomia, la musica e l’arte. Alla fine ha deciso di mettersi a studiare pianoforte e di lasciare il lavoro. Insieme alla sua migliore amica ha aperto una scuola d’arte, Artskul, che aiuta le persone a sviluppare il proprio talento. Ed è soddisfatta. Con la nascita della figlia si è presa una pausa, e ora si prende cura della bambina, va in piscina e cucina.
A volte non esce dal complesso per settimane, perché qui ha tutto quello che le serve: supermercato, campi sportivi, bar, negozi. Perfino il dentista. Anche Răzvan è laureato in giurisprudenza. Indossa pantaloncini corti e una maglietta beige su cui è disegnato un topolino. Nella stanza da letto ha un diorama di Star Wars che si è costruito da solo con i mattoncini del Lego. Răzvan e Alice raccontano di essere scappati da Bucarest perché era troppo caotica e perché ai loro vicini non importava della pulizia e dell’ambiente. C’era chi gettava gli avanzi nelle condutture per la raccolta comune della spazzatura, chi gli scrollava la tovaglia sul balconcino. Loro si sforzavano di fare la raccolta differenziata, gli altri non capivano. “E quelli strani eravamo sempre noi”, spiega Alice. Le discussioni con i vicini erano quotidiane. A Cosmopolis, invece, tutti sono aperti alle novità, s’interessano di ecologia e stanno attenti a non disturbare. “Voglio vivere in una comunità di persone come me. La differenza di età comporta anche una differenza in materia di istruzione. La nostra generazione è molto più responsabile”, dice la donna.
Una vera comunità
Sempre a Cosmopolis, a pochi passi da Alice e Răzvan, in un appartamento di tre camere con terrazzo vivono Ramona e Cătălin Ivan, insieme a Puiu, il loro gatto, che hanno raccolto per strada. Dopo aver abitato per dieci anni in una casa in affitto, volevano avere un posto tutto loro. Ramona insegna inglese in una scuola privata di Greenield, un altro complesso residenziale che si trova al nord della capitale, e Cătălin lavora in un’azienda di comunicazioni al centro della città. Vivono qui da due anni e mezzo. Hanno deciso di trasferirsi perché passando in autostrada vedevano le casette del quartiere, con i loro tetti turchesi, e sognavano di viverci. “Quando siamo entrati per la prima volta nell’appartamento, abbiamo capito subito che era quello che volevamo”, dice Ramona. Consigliano anche ai loro amici di venire a vivere qui, perché Cosmopolis “è un posto più civile di Bucarest”. “Un autista della scuola dove lavoro mi ha raccontato che una volta è venuto a prendere un bambino a Cosmopolis”, racconta Ramona. “Appena ha passato l’ingresso, un altro bambino che era sul bus gli ha chiesto: ‘Signore, in che paese siamo qui?’”.
La persona che li ha convinti a trasferirsi a Cosmopolis è Gabriel Voicu, che dirige l’ufficio vendite del complesso. Porta la giacca, ma non la cravatta, e guarda continuamente l’orologio. Il suo telefono non smette di squillare, ma lui non risponde. Dice che l’85 per cento degli abitanti del complesso sono giovani, alcuni con bambini piccoli. Anche lui prima viveva a Bucarest, poi si è trasferito con la moglie e il figlio. “Il primo shock l’ho avuto quando è nato il bambino”, racconta. “Per arrivare al parco più vicino, quello di Herăstrău, mia moglie doveva camminare venti minuti in mezzo alle macchine. Allora ho capito che non avevo nessun motivo per restare in città. Ricordo il frastuono dei tram e delle macchine che passavano di notte a tutta velocità. Non riesco a credere di non sentire più quel rumore”. Voicu è cresciuto in un quartiere operaio a Costanza. Dice che somigliava a Cosmopolis perché “era una vera comunità”: gente della stessa età, con lo stesso status sociale e gli stessi ideali. Oggi è convinto che quasi tutti quelli che vivono a Cosmopolis siano felici della scelta fatta, tranne poche persone che si lamentano su Facebook per la qualità delle rifiniture, la polvere che entra dalle finestre e gli insetti.
Mille nuovi muri
Cosmopolis, Greenield, Militari Residence, Confort City e gli oltre cento complessi residenziali chiusi di Bucarest e dintorni, nel distretto di Ilfov, devono il loro successo ai romeni della classe media, spesso dipendenti di multinazionali. In alcuni casi questi inquilini hanno cercato di applicare allo spazio in cui vivono le regole del loro lavoro. In un complesso nel quartiere di Titan, per esempio, c’è chi ha proposto di introdurre un sistema per definire i problemi da risolvere e poi stabilire le priorità. Per entrare nel complesso Area Residence bisogna invece sostenere un colloquio. “Se non gli piaci, non ti vendono casa”, ci racconta al telefono compiaciuto un rappresentante degli inquilini. Quasi tutti i complessi residenziali hanno un ingresso sorvegliato, sono circondati da recinzioni o laghi e sembrano separati dalla città. All’interno le persone raccontano di sentirsi sicure, parte di una comunità in cui lo stato e altri fattori esterni intervengono il meno possibile.
Gli antropologi chiamano questi complessi residenziali gated communities. La loro diffusione si spiega con la mancanza di fiducia dei cittadini nelle autorità. Più precisamente, secondo gli studiosi europei e statunitensi, chi vive in queste strutture non crede che lo stato possa offrire servizi di qualità. Qui gli abitanti si gestiscono da soli. Come spiega l’urbanista statunitense Peter Marcuse nel suo saggio Walls of fear and walls of support (muri di paura e muri di sostegno) queste cittadelle offrono servizi di vigilanza, piscine, campi da tennis e da golf, aree gioco, ristoranti e palestre di cui gli inquilini usufruiscono in comune.
Le
gated communities sono apparse per la prima volta negli anni settanta negli Stati Uniti, e poi si sono diffuse, verso la metà degli anni novanta, in Europa occidentale. Negli Stati Uniti oggi comprendono più di dieci milioni di abitazioni. Secondo i sociologi, la loro diffusione è legata alla crescita delle disuguaglianze sociali. In Romania questi complessi sono arrivati alla fine degli anni novanta e si sono moltiplicati dopo il duemila.
“Siamo passati dal controllo assoluto dello stato sull’edilizia abitativa degli anni del comunismo all’anarchia totale”, spiega l’architetto Ştefan Ghenciulescu, docente all’università di architettura e urbanistica Ion Mincu di Bucarest e direttore della rivista Zeppelin. Ghenciulescu è nato e cresciuto a Bucarest e da sempre osserva lo sviluppo della città. Negli anni novanta – racconta – i romeni odiavano la vita nei condomini, rifiutavano tutto quello che gli ricordava una dimensione collettiva. “Ognuno voleva la casa di proprietà. Con il giardino”, ricorda Ghenciulescu. Poi spiega che chi si sposta nei nuovi palazzi in periferia cerca di tenere insieme i vantaggi della vita di città con quelli della campagna. Ma alla fine non ha né gli uni né gli altri: “ Sei isolato dalla città e dai suoi benefici, ma non godi neanche della natura e del silenzio, perché in questi posti la densità abitativa è elevatissima. Si è costruito tantissimo, non ci sono veri spazi verdi né intimità”. Il motivo è che questi comprensori sono stati realizzati senza un vero progetto, senza pianificazione o infrastrutture. “In un sistema che funziona a volte è il comune che costruisce le infrastrutture”, dice Ghenciulescu, “altre volte è il costruttore stesso, che poi le cede alla città, altre volte ancora il pubblico e il privato collaborano. Da noi non succede nulla di tutto questo”. Dopo la rivoluzione del 1989 a Bucarest sono stati costruiti molti palazzi di oltre dieci piani. Parchi e spazi verdi sono stati restituiti ai vecchi proprietari, che li hanno usati per farci soldi e hanno cementificato tutto. Il risultato è che oggi gli spazi verdi sono pochi, meno di quelli previsti dagli standard dell’Unione europea. Inoltre, secondo i dati del produttore di dispositivi GPS TomTom, Bucarest è la quinta città più trafficata del mondo.
I complessi residenziali ai margini della capitale sono una conseguenza di questi problemi, “a prescindere dal fatto che le persone se ne rendano conto o meno”, dice Ghenciulescu. Molti li scelgono per sfuggire ai fastidi della città e per vivere in maniera più sostenibile. Ma non si rendono conto che, anche facendo scelte ecologiche, alla fine consumano più risorse lì che in città. I palazzi, infatti, occupano meno spazio delle case, sono più facili da riscaldare e consumano meno energia.
Un altro motivo che spinge i romeni a trasferirsi nelle gated communities è la presenza di guardie e sistemi di vigilanza. Tuttavia, contrariamente alla percezione generale, secondo i dati Eurostat sui furti denunciati, la Romania è uno dei paesi più sicuri d’Europa, allo stesso livello del Lussemburgo e meno pericolosa di Spagna e Francia. Ma non è l’unica nazione dell’Europa orientale in cui le strutture abitative protette da cancelli e recinti sono sempre più numerose. Sonia Hirt, preside della facoltà di architettura dell’Università del Maryland, negli Stati Uniti, ha studiato le gated communities di Soia, in Bulgaria. Dopo il crollo del muro di Berlino, racconta, i paesi dell’ex blocco sovietico hanno cominciato a erigere nuovi piccoli muri. Costruite intorno a case e palazzi, queste barriere sono di fatto la conseguenza di “forti tensioni sociali. E la quantità di ferro, cemento, mattoni e malta usati per costruirle è infinitamente maggiore di quella usata per tirare su il muro di Berlino”.
Disuguaglianze e traslochi
Cosmopolis e gli altri complessi del genere sono spazi impersonali, che offrono l’illusione dell’indipendenza. Chi ci abita non vuole avere i fastidi legati alla vita nei condomìni, con le regole imposte dai vicini e dagli amministratori, spiega Bogdan Iancu. Si fugge dalla città per sentirsi parte di una comunità con un livello di sviluppo più elevato. Iancu insegna antropologia visuale e sociologia della vita quotidiana e s’interessa alle modalità abitative della classe media e alle comunità recintate. È cresciuto in un palazzo nella città di Râmnicu Vâlcea e oggi vive in un appartamento di due camere in una zona semicentrale di Bucarest. Davanti ha i grandi edifici costruiti per gli operai ai tempi del comunismo e dietro le ville borghesi di inizio novecento. Iancu racconta che i complessi residenziali chiusi non si trovano solo a Bucarest, ma anche, seppure in numero minore, in altre grandi città del paese. Gli abitanti di Cluj-Napoca, tuttavia, sembrano preoccupati più per la chiusura degli spazi pubblici, che per la tutela di quelli privati.
Qualche anno fa l’associazione dei condomini di un palazzo ha fatto erigere una grande porta per limitare l’ingresso a uno dei punti più pittoreschi della città, lungo il canale del mulino, dove i bambini vanno da sempre a vedere le anatre. Adrian Dohotaru, un attivista poi eletto deputato con il partito Unione salvate la Romania, è stato tra quelli che si sono battuti per eliminare la porta. “Alla fine, dopo l’intervento del comune, la barriera è stata demolita, in quanto illegale. I muri non incoraggiano la mescolanza sociale”, dice Dohotaru, che ricorda come in Romania il problema delle disuguaglianze sia particolarmante serio. Per questo è convinto che le autorità dovrebbero cercare di limitare il fenomeno delle gated communities. “Il proliferare di queste strutture indebolisce la città.
Una democrazia efficace ha bisogno di spazi pubblici, non di luoghi chiusi in cui le persone si isolano sempre di più”. Più di altri centri romeni, oggi Bucarest è un aggregato di comunità recintate, separate dalla città da cattive infrastrutture. Spesso le strade di nuova costruzione non sono state pensate per far fronte al traffico generato dai grandi palazzi sorti in periferia. Oltre a quello delle infrastrutture, alcuni abitanti dei complessi recintati hanno anche un altro problema: dopo essersi trasferiti si rendono conto che la nuova vita non fa per loro e che il silenzio li disturba. Il cambiamento dello stile di vita riguarda anche chi decide di andare a vivere nei paesi poco fuori Bucarest. Carmen Mihalache, etnologa del Museo del contadino romeno ha lasciato il suo appartamento in città per trasferirsi nel comune di Chiajna.
Subito dopo il trasloco ha cominciato a studiare la storia di questa comunità, cercando di capire come i nuovi arrivati ne stiano cambiando le abitudini. Nel centro di Chiajna ci sono le case vecchie, ognuna con il suo orto e il suo giardino; in periferia si vedono invece i muri in cemento voluti dai nuovi abitanti per recintare i loro prati. Mihalache racconta che chi arriva dalla grande città non è interessato a entrare in contatto con la gente del posto e le sue tradizioni. In questo modo il divario tra i vecchi e i nuovi abitanti si allarga. “È come se venissero i colonialisti e si sedessero accanto ai nativi”, commenta Bogdan Iancu. Alcuni “cittadini” gli hanno confessato che a volte si mettono a guardano con il binocolo cosa fanno gli abitanti più poveri, come fosse “una specie di safari umano”, aggiunge l’antropologo.
I vantaggi del proprietario
Per comprare una casa spesso gli abitanti di Bucarest accendono un mutuo. E molti si rivolgono a Dragoş Nichifor, che dirige una delle più vecchie società di intermediazione finanziaria della città. Nel 2006 Nichifor ha comprato un appartamento in un quartiere semiperiferico della città. Allora il mercato immobiliare era in rapidissima crescita, tanto che era difficile anche solo riuscire a visitare delle case in vendita. Nessuno immaginava che presto sarebbe arrivata la crisi e i prezzi sarebbero crollati. “Ho visto l’appartamento per un paio di minuti, non sono nemmeno arrivato sul balcone. E ho subito detto all’agente immobiliare che l’avrei preso”, racconta. “È assurdo. Perfino per comprare una bicicletta ci si mette di più”. L’ideale, aggiunge, sarebbe “poter passare qualche ora nell’immobile, magari affittarlo per un giorno, passarci la notte”.
Nichifor segue il mercato immobiliare da quando era adolescente. Nel 2002 a Bucarest un appartamento di due stanze costava circa 15mila euro. Sei anni dopo, all’apice della bolla immobiliare, per lo stesso appartamento potevano volerci anche 120mila euro. La crisi ha fatto crollare i prezzi di oltre il 50 per cento, ma da qualche anno il mercato ha ripreso a crescere. Nel giro di cinque anni si potrebbe tornare ai livelli pre-crisi. Nichifor è convinto che i romeni non vogliano vivere in affitto per motivi economici, ma anche per colpa della burocrazia e delle falle nella legislazione che regola i rapporti tra proprietario e locatario. “Quando il mercato è caotico e non regolamentato, con ognuno che fa come vuole, è chiaro che possedere una casa offre certezza e stabilità”. In Romania la maggior parte degli affittuari non ha contratti registrati e non conosce i propri diritti. Il risultato è che, quando ci sono problemi, di solito si risolvono a favore del proprietario.
A quanto pare, continua Nichifor, i giovani sono quelli che hanno più fretta di comprare. Ma prendere un prestito prima dei trent’anni può essere un rischio, perché a quell’età è difficile prevedere che direzione prenderà la propria vita. E con la prima casa si può rimanere in trappola, senza la possibilità di rivendere o di affittare per cinque anni. Bogdan Suditu, esperto di pianificazione territoriale, è d’accordo. Anche lui crede che i giovani dovrebbero stare in affitto per un po’ prima di diventare proprietari. Tra il 2006 e il 2013 Suditu ha guidato l’ufficio per i servizi urbanistici, lo sviluppo locale e le politiche abitative del ministero dello sviluppo economico, e ha anche lavorato alla riforma dell’Agenzia nazionale per la casa (Anl), che dovrebbe offrire soluzioni abitative ai giovani senza mezzi economici. “Chi si occupa di politiche pubbliche in questo paese non si è mai concentrato sull’affitto”, dice Suditu, convinto che in Romania manchi un dibattito serio sulle politiche abitative, “forse perché l’edilizia è uno dei settori che ‘muovono l’economia’”.
Con qualche eccezione, in Europa occidentale e negli Stati Uniti è normale vivere in affitto, almeno in dai tempi della rivoluzione industriale. I proprietari controllano interi palazzi che amministrano come vere e proprie aziende. In alcuni paesi, poi, lo stato interviene a tutela degli inquilini. In Germania, dove quasi la metà della popolazione vive in affitto, i prezzi sono regolamentati dalle autorità e i proprietari non possono aumentare il canone prima della fine del contratto. In più, se vogliono riaffittare l’appartamento ad altri, devono prima parlare con i vecchi locatari.
Domicilio instabile
“Tre traslochi equivalgono a un incendio per quanto riguarda i danni che fanno a una casa”, dice Pompiliu Sterian. A 98 anni, Sterian recita nello spettacolo di teatro documentario Domicilio instabile accanto ad altri anziani della casa di riposo della comunità ebraica Moses Rosen, a Bucarest. In scena indossa una cravatta dorata e una giacca azzurra e racconta ai giovani come si viveva in città tra le due guerre e durante il comunismo. “I proprietari aumentavano continuamente l’affitto. Se non eri d’accordo, ti buttavano fuori. E non potevi farci niente perché non avevi un contratto”. Gli altri anziani snocciolano le loro storie, sempre influenzate dalla classe sociale di appartenenza. Alcuni ricordano con piacere il periodo prima della seconda guerra mondiale, quando erano proprietari di grandi case, e si lamentano del comunismo, che li ha costretti a vivere accanto a nuovi inquilini; altri raccontano che il comunismo gli ha permesso di vivere in appartamenti in affitto. Lo spettacolo è messo in scena dal regista David Schwartz, che lavora da tempo con gli anziani della casa di riposo. È un tentativo di raccontare i modi dell’abitare a Bucarest negli ultimi ottant’anni e di capire come siano stati percepiti dai cittadini i cambiamenti dell’ultimo secolo.
Schwartz ha 32 anni, è alto, porta i capelli corti e indossa una canottiera gialla larga e dei pantaloni corti di cotone. Ci incontriamo al Macaz, un teatro-bar gestito da una cooperativa di artisti. Il regista spiega di aver cominciato a interessarsi al tema della casa nel 2006, quando molti, tornati proprietari delle case che erano state nazionalizzate, hanno cominciato a sfrattare le famiglie povere che ci abitavano in aitto. Colpito dall’ingiustizia, insieme ad alcuni compagni di università Schwartz ha realizzato uno spettacolo teatrale per raccontare la sorte degli sfrattati. Da allora non ha mai smesso di occuparsi di povertà e disuguaglianze sociali. Katia Pascariu, una delle attrici che lavorano con lui, racconta che in Domicilio instabile è stato sorprendente vedere come i racconti degli anziani non coincidessero. Ognuno credeva che la sua esperienza fosse condivisa da tutti. Lo spettacolo è quindi un tentativo di mettere insieme punti di vista opposti sul tema dell’abitare. E si chiude con Sterian in , sul palco, che recita i seguenti versi:
Che ognuno abbia una casa,
con tante prelibatezze sulla tavola.
E, perché no?
Diciamolo chiaramente:
che sia anche proprietario.
Come in vacanza
In un appartamento di due camere nel quartiere di Drumul Taberei, la madre di Răzvan, l’avvocato che abbiamo conosciuto a Cosmopolis, tira fuori da un cassetto un servizio da cafè proveniente da Kaleh, l’isola sul Danubio che fu sommersa dall’acqua nel 1970 durante la costruzione della grande diga sul fiume, all’altezza delle Porte di ferro. Mariana Petrescu conserva anche altri oggetti della casa dei genitori, a Craiova: vasi di porcellana, candelieri e vassoi d’argento. Costruita dal nonno, la casa aveva due piani e dieci camere. Ai tempi del comunismo fu demolita per far posto a dei palazzoni. “Sono cose che non si dimenticano”, dice la donna. “Ci soffro ancora”. Mariana è piccola di statura, ha i capelli neri e porta un paio di occhiali con la montatura dorata. È ingegnera e fino a pochi anni fa insegnava all’università. Prima che l’edificio fosse demolito, i comunisti le avevano messo degli inquilini in casa e sequestrato gli oggetti di valore. “Allora avevo paura di invitare i colleghi: temevo che potessero vedere quello che avevamo”, dice. “E ancora oggi vivo con questo terrore: far entrare sconosciuti in casa”. Anche il padre di Răzvan, Sorin Petrescu, veniva da una famiglia considerata borghese ai tempi del comunismo. Avevano una casa e una piccola fabbrica di prodotti chimici: fu tutto confiscato. E lui fu mandato ai lavori forzati perché non aveva consegnato una collanina d’oro.
I genitori di Răzvan si conobbero alla stazione Obor di Bucarest. Erano entrambi pendolari e si resero subito conto di avere tante cose in comune. Lui la invitò al ristorante e dopo un anno si sposarono. All’inizio andarono ad abitare in un monolocale di 18 metri quadrati ricevuto dallo stato. Tenevano aperte porte e inestre perché gli sembrava di sofocare. Dopo la nascita di Răzvan riuscirono ad avere un appartamento di due stanze. Ma erano al piano terra e d’inverno si gelava. Dal 1987 Mariana ha cresciuto Răzvan da sola. “Da quando mio marito è morto non sono nemmeno più andata in vacanza. Non sono più stata da nessuna parte. Ho solo lavorato”. Răzvan era il suo unico appoggio. “Gli ho sempre detto che eravamo noi due soli. Anche se era un bambino, parlavo con lui di tutto quello che mi preoccupava”.
I soldi bastavano a malapena per arrivare alla fine del mese. Dopo il 1989 Mariana ha comprato dallo stato l’appartamento di due camere in cui abitava, prendendo un prestito alla Cassa di mutuo soccorso, alimentata dai contributi dei lavoratori. Lo stesso hanno fatto anche molti altri romeni, approfittando della misura che permetteva a tutti i cittadini di comprare dallo stato l’appartamento in cui abitavano (in quegli anni sono stati venduti più di 1,8 milioni di appartamenti, ciascuno per un prezzo equivalente a qualche stipendio mensile). Dal suo appartamento di Bucarest Mariana Petrescu pensa spesso al figlio che vive a Cosmopolis. Ricorda che in da piccolo Răzvan sognava una casa con giardino. Quando va a trovarli le sembra di “stare in vacanza”, anche se la loro casa non è “nemmeno un quarto di quella che avevano i miei genitori a Craiova”. All’ora di pranzo di una domenica qualsiasi la strada principale di Cosmopolis è deserta. Al cancello i vigilanti fermano le macchine che non riconoscono. Alice e Răzvan raccontano che a Cosmopolis speravano di trovare maggiore sicurezza per la figlia.
 |
| Una delle piscine di Cosmopolis |
E per un certo periodo hanno creduto di aver fatto la scelta giusta. Ma le grandi manifestazioni contro la corruzione organizzate a Bucarest all’inizio del 2017 gli hanno fatto cambiare idea. A febbraio sono scesi in piazza anche loro e si sono resi conto che, per quanto cerchino di tenersi lontani dall’incompetenza delle autorità, vivere isolati non è possibile. Neanche dietro le barriere del loro complesso residenziale. Oggi pensano di lasciare il paese, magari per trasferirsi in Portogallo. “Quando penso che a un certo punto nostra figlia dovrà andare a scuola mi vengono i brividi”, dice Alice. Anche l’inefficienza della sanità pubblica le fa paura. Verso sera arriva la nonna per giocare con la nipotina. Sta con loro in giardino, all’aria aperta. Dice che Răzvan ha tutto quello che ha sempre desiderato: sicurezza, una famiglia, una casa. Lei l’ha aiutato come ha potuto e gli ha dato i soldi ricavati dalla vendita di alcuni terreni recuperati dopo il 1989. “Non importa quello che ho passato io. Questa è la mia ricompensa”.
Tutta la famiglia è riunita intorno alla bambina e ognuno vuole insegnarle qualcosa. Sul divano è appoggiata una bambola nera, sul tablet ci sono applicazioni sull’igiene e la salute, e sul tappeto sono sparsi pezzi di Lego che aspettano solo di essere assemblati. Ma la bambina vuole tornare in piscina. Prende la ciambella e, insieme al papà, attraversa il recinto bianco del giardino.
Riferimenti all'articolo originale: Internazionale 1232, pp. 62-69.
il manifesto, 23 novembre 2017. Un nuovo supplemento de il manifesto, interamente dedicato a un ambientalismo nuovo, anticapitalista. Inizia con l'inizio della storia dell'uomo: la storia del grano. Articoli di Piero Bevilacqua, Luca Fazio, Monica di Sisto, Saverio De Bonis
UN AMBIENTALISMO
NUOVO, ANTICAPITALISTA
di Piero Bevilacqua
In principio era il grano, un seme coriaceo che piantato nella terra generava una spiga con sei o sette chicchi, buoni per essere macinati e fare farina e a loro volta capaci di tornare a germinare, di avviare un ciclo produttivo che si rinnovava ogni anno. Grazie a questo cereale, negli altipiani della Mezzaluna Fertile, intorno a 10 mila anni fa, i primi gruppi umani cessavano di migrare e cominciavano la vita stanziale in attesa del raccolto, costruivano dimore stabili, adunavano villaggi, edificavano città, inventavano la scrittura. Dal seme del grano sorgevano le civiltà umane, aveva inizio quel che noi chiamiamo storia. E in questa storia, per millenni, un ruolo preminente, non solo alimentare, ma anche religioso e simbolico ha giocato il suo prodotto fondamentale: il pane. L’alimento che si spartiva con solidarietà tra gli uomini e che si spezzava nei riti delle religioni rivelate.
Che cosa di più storicamente e simbolicamente significativo del grano per iniziare un inserto dedicato specificamente all’ambiente? Forse nessun altro elemento – simbolo di rigenerazione della fertilità, di pace, di fratellanza – può sintetizzare le ragioni e le intenzioni di fondo del nostro progetto.
La nostra ambizione, infatti, non si limita a rinverdire i temi consueti dell’ambientalismo per offrirli con più frequenza ai lettori del manifesto. Non intendiamo coltivare un settore di studi e di problemi fin troppo trascurato dalla cultura nazionale. Vogliamo andare oltre, forti di acquisizioni ormai consolidate, che hanno tratto l’ambientalismo fuori dal recinto di una tematica elitaria, da paesi ricchi, dalla sua pur nobile e importante difesa dell’esistente.
Inserire la natura nella storia, quel mondo vivente che il pensiero economico ha cancellato con i suoi astratti edifici teorici, che ha occultato per volontà di dominio, comporta un sovvertimento radicale del nostro modo di pensare le società contemporanee. Per noi la natura non è fuori, ma dentro la società, non è solo l’aiuola fiorita, il parco, il fiume. È anche e forse prima di tutto la fabbrica, costruita con il ferro sottratto alle viscere della terra tramite scavi minerari devastanti, che produce merci utilizzando minerali, acqua, petrolio, un gran numero di risorse non rigenerabili.
È ancora natura la fabbrica che sfrutta l’energia del lavoro umano, che rovescia rifiuti, che inquina cielo, suolo ed acqua perché anche noi siamo natura e quegli scarichi ci coinvolgono nel generale metabolismo che si svolge sulla superfice del pianeta. Non dimentichiamolo: la nostra salute, il lavoro, la fecondità delle donne, il nostro tempo di vita sono fra le risorse naturali più sfruttate.
Dunque non vogliamo rinverdire una tradizione riparatoria e rivendicazionistica: l’ambientalismo che denuncia il danno esterno e che chiede rimedi ex post. La nostra vuole essere una nuova modalità di critica radicale del capitalismo, un nuovo sguardo sul più distruttivo modo di produzione della storia dal punto di vista degli equilibri naturali. Il mondo fisico è messo in pericolo non dall’uomo in astratto, ma da modelli di dominio storicamente determinati.
È questo punto di vista, tuttavia, questa nuova visione radicale e olistica, che consente di fornire una nuova universalità alla politica e al tempo stesso di scorgere i processi che già oggi prefigurano nuovi modi di produrre e di fare economia, pratiche alternative nell’utilizzare le risorse naturali, forme cooperative del lavoro che anticipano assetti nuovi della vita sociale.
LA PASTA È «MADE IN ITALY»,
IL GRANO NO
di Luca Fazio
«Il fatto della settimana. Un pacco su tre è prodotto con grano importato. Ma anche quello italiano non è garanzia di qualità. E ora ci si prepara allo sbarco dei canadesi»
«Maccarone, m’hai provocato e io te distruggo, maccarone! Io me te magno», e questa è storia. La nostra. Eppure anche l’Albertone nazionale oggi si farebbe qualche domanda prima di affondare la forchetta in una montagna di maccheroni.
La pasta italiana è mediamente buona ed ha già vinto la sfida globale essendo uno dei cibi più ricercati e consumati al mondo, ma è inutile nascondere che nel piatto c’è qualcosa che non funziona.E che in futuro potrebbe restarci sullo stomaco. I numeri per ora sono l’unica certezza e forniscono il quadro di un mercato mondiale che è teatro di interessi non sempre confessabili, soprattutto al consumatore.
Nel 2015 nel mondo sono state prodotte 14,3 milioni di tonnellate di pasta. Sono 48 i paesi che ne producono più di 1.000 tonnellate all’anno (e 52 i paesi che consumano almeno 1 chilo pro capite di pasta all’anno). L’Italia è paese leader tra i produttori con circa 4 milioni di tonnellate all’anno (seguono Usa con 2 milioni, Turchia con 1,3, Brasile con 1,2 e Russia con 1,1).
L’Italia è anche il paese con il più alto consumo pro capite del mondo: gli italiani mangiano più di 25 chili di pasta all’anno (16 i tunisini, 12 i venezuelani, 11 i greci e 9 gli svizzeri). Con questi numeri è anche leader del mercato: nel 2016, per il dodicesimo anno consecutivo, l’export della pasta ha avuto il segno più (6%). L’Associazione delle industrie e della pasta italiane (Aidepi) certifica che nel 2016 l’Italia ha esportato 2 milioni di tonnellate di pasta per un valore che supera i 3 miliardi di euro.
Tutto bene? Non proprio.
C’è un problema che ne richiama altri e che fa della pasta uno degli alimenti più significativi per comprendere le insidie di un mercato agroalimentare globale che per sua natura non può convergere con la sostenibilità ecologica del sistema produttivo: all’Italia manca circa il 40% di grano duro per soddisfare la produzione di pasta necessaria al mercato interno (e all’export).
Negli ultimi 15 anni le coltivazioni di grano duro si sono ridotte di 500 mila ettari. Per questo, spiega Coldiretti nel suo atto d’accusa contro il grano straniero, l’Italia nel 2015 ha importato dall’estero circa 4,3 milioni di tonnellate di frumento tenero e 2,3 milioni di tonnellate di grano duro (utilizzato per la pasta).
Il risultato, denuncia l’associazione, è che un pacco di pasta su tre è fatto con grano che arriva dall’estero, senza obbligo di indicare la provenienza sull’etichetta (alcune tra le marche più famose miscelano grano italiano e straniero). Non è solo una questione di sovranismo cerealicolo per tutelare gli agricoltori nostrani strozzati dai prezzi imposti dal mercato globale, è anche un problema di salute e di politica internazionale.
I principali paesi che forniscono grano all’Italia sono europei. La Francia, con 350 mila tonnellate nel 2015, poi l’Austria con 176 mila tonnellate nel 2015 e l’Ungheria che nel primo semestre del 2016 ce ne ha vendute 165 mila tonnellate. Seguono Romania, Polonia, Ucraina, Turchia, Cipro. Complessivamente dal resto del mondo (dati 2015) l’Italia ha importato 2,3 milioni di tonnellate di grano duro e ne ha esportate più di 181mila, soprattutto verso il Maghreb (per il cous cous).
L’Italia, dunque, anche se non produce abbastanza grano duro per soddisfare il suo mercato, è un paese che comunque ne esporta. Un paradosso facile da spiegare: il frumento nostrano è molto richiesto e viene venduto a prezzi più alti, mentre il grano importato costa meno ed è qualitativamente meno pregiato. E in qualche caso anche dannoso per la salute, come denunciano numerose associazioni ambientaliste che puntano il dito contro il grano canadese.
La questione canadese introduce scenari preoccupanti anche in virtù del fatto che il paese di Justin Trudeau si sta imponendo tra i primi fornitori di grano all’Italia: dal Canada abbiamo importato 329 mila tonnellate nel 2015 e 383 mila tonnellate nel primo trimestre del 2016.
Problema numero uno.
In Canada, per accelerare la maturazione della spiga, prima della raccolta viene utilizzato il glifosato come disseccante, una pratica vietata in Europa (il glifosato è l’ingrediente principale dell’erbicida Roundup della Monsanto che secondo l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro è potenzialmente cancerogeno e che è al centro di una controversia internazionale: entro la fine di quest’anno l’Unione europea dovrà decidere se vietarlo o meno).
Tracce di erbicida, questa la preoccupazione, potrebbe essere presente nei prodotti alimentari derivati dal grano – pasta “made in Italy” compresa. In più, il grano canadese per via dell’umidità del clima viene aggredito dalle micotossine, un fungo patogeno contaminante che ad alti livelli di concentrazione può agire a livello gastrointestinale.
La presenza, pur nella norma, di questi contaminanti – glifosato, micotossine e cadmio – è stata riscontrata in un test effettuato su alcuni campioni di pasta italiana dall’associazione GranoSalus.
Il problema numero due, oltre a complicare la faccenda sul piano della sicurezza alimentare, introduce una questione di politica internazionale. Con l’entrata in vigore del Ceta (l’accordo commerciale tra Unione europea e Canada che non è ancora stato ratificato dal parlamento italiano) le grandi aziende nord americane dell’agro-business avranno a disposizione nuovi strumenti per attaccare i rigorosi standard europei a tutela della qualità del cibo.
È evidente, come spiega l’Associazione italiana agricoltura biologica (Aiab), che una futura armonizzazione delle norme canadesi ed europee potrebbe rimettere tutto in discussione. Le criticità da affrontare a livello parlamentare non riguardano solo il grano duro al glifosato: «L’armonizzazione delle norme verso un minimo comune denominatore, previsto nell’accordo, accetta di fatto lo spostamento verso il basso delle regole di produzione e degli standard di sicurezza alimentare. In particolare ci verrebbero imposti gli ormoni della crescita nelle carni, l’uso di antimicrobici nel lavaggio, una liberalizzazione degli Ogm e un’etichettatura ancora meno trasparente».
Gli stessi industriali canadesi del resto non ne fanno mistero. Cam Dahl, presidente di Cereals Canada, ha minacciato ritorsioni (un’azione legale al Wto) qualora l’Italia dovesse imporre l’etichettatura d’origine sui pacchi di pasta.
Di fatto il contenzioso è già aperto perché in Italia l’obbligo di etichettare la provenienza del grano dovrà, o dovrebbe, scattare il 17 febbraio.
Il decreto però è stato impugnato dall’Aidepi con un ricorso al Tar del Lazio che somiglia a un’arrampicata sugli specchi. L’associazione delle industrie dei pastai ritiene che «l’obbligo dell’indicazione di origine del grano nella pasta sia sbagliato: promette trasparenza ma disorienta il consumatore e invece di sostenere una filiera di grande valore per la nostra economia, come quella della pasta, rischia di affossarla».
Nel frattempo Barilla (azienda leader in Italia con ricavi consolidati per 3,4 miliardi di euro e nel 2016 e utile netto in salita a 371 milini di euro) si è affidata a Bebe Vio per riorientare il consumatore con uno spot che ammette il ricorso al grano straniero, che però è buono e di qualita: “Ottimo, grande, mi hai convinto, dammi cinque…”. Paolo Barilla, vice presidente dell’omonimo gruppo, su Rai1 è stato meno simpatico: «Per l’industria tutto dipende da che tipo di prodotto produrre e a quali costi, perché se noi dovessimo fare un prototipo di pasta perfetta, in una zona del mondo non contaminata, senza bisogno di chimica, probabilmente quel piatto di pasta invece di 20 centesimi costerebbe 2 euro. Una pasta a glifosato zero è possibile ma solo alzando i costi di produzione».
Più chiaro di un’etichetta.
«IL GLIFOSATO C’È,
BASTA CONTROLLARE»
intervista a Saverio De Bonis
Critiche a 360 gradi: «Gli agricoltori italiani accettano la filiera capestro imposta dalle multinazionali, che dettano il prezzo del grano».
Saverio De Bonis, 52 anni, lucano, è un produttore di grano duro e presidente dell’associazione GranoSalus. I suoi attacchi alle industrie – supportati da analisi di laboratorio – continuano a scatenare polemiche furibonde tra i pastai più noti. La controversia non è ancora risolta.
Lo scorso ottobre il tribunale di Roma ha dato ragione a GranoSalus che ha riportato articoli secondo cui la pasta di alcuni marchi contiene sostanze contaminanti e quindi, per deduzione, sarebbe lavorata anche con grano importato dal Canada. Perché avete commissionato quei test che hanno scovato glifosato, micotossine e cadmio?
Sette anni fa un microbiologo che partecipava alle attività dei nostri circoli ha lanciato l’allarme sulla presenza di micotossine. È un fungo patogeno che si sviluppa sul grano a causa dell’umidità. Le istituzioni non ci hanno ascoltato e così abbiamo deciso di cambiare strategia per parlare anche ai consumatori. GranoSalus nasce così: piccoli produttori locali si associano per tutelare il diritto alla salute e alla produzione di qualità. Lo scorso febbraio abbiamo effettuato i primi test prendendo la pasta sugli scaffali e abbiamo trovato tracce di glifosato e cadmio in otto campioni esaminati, sono perturbatori endocrini e quindi dannosi a prescindere dalla quantità rilevata. Le analisi sono state condotte da un laboratorio di Cuneo certificato e utilizzato anche dall’Unione europea.
Quali paste avete fatto analizzare?
Barilla, La Molisana, De Cecco, Divella, Garofalo, Granoro, Voiello e Coop. Le industrie che hanno presentato ricorso (Coop non lo ha fatto ma ha precisato con una nota) sono state condannate a risarcire le spese processuali perché negli articoli non c’era diffamazione.
Avete fatto controlli sulle navi.
Due a Manfredonia e due a Bari, dove arriva il 60 per cento del grano duro importato. Anche in quel caso i test hanno confermato la presenza degli stessi contaminanti sulla materia prima: micotossine, cadmio e glifosato.
I vostri test però sono stati duramente criticati dalle industrie della pasta. Vi hanno accusato di allarmismo ingiustificato.
Gli articoli in questione, come scrive la prima sezione civile del Tribunale di Roma, costituiscono legittima espressione del diritto di critica e manifestazione del pensiero, trattandosi di temi di tale delicatezza e rilevanza per la salute pubblica. Le industrie dicono di avere accusato il colpo con un calo delle vendite, ma hanno solo cercato di riposizionare la propria immagine vantando la bontà degli approvvigionamenti dall’estero, come fa Barilla: hanno imposto agli agricoltori italiani un disciplinare su cui scrivere che il grano venduto non contiene glifosato, ma è del tutto superfluo poiché in Italia nessuno spruzza diserbante sulle spighe.
Le sostanze rilevate però sono presenti in quantità che rispettano i limiti previsti dalla legislazione europea, dunque qual è il problema?
Sono nei limiti, però non ci sono prove scientifiche che dimostrino che tutti questi contaminanti, assunti insieme, non provochino danni alla salute. Sui limiti ci sarebbe da discutere. La Fao fissa la presenza della micotossina DON (deossinivalenolo) a 1.000 ppb (parti per miliardo), solo che in Europa a partire dal 2006 questa soglia è stata portata a 1.750. In Canada il grano che supera la soglia di 1.000 ppb non viene dato nemmeno agli animali: è questa la roba che finisce in Europa. Quanto al glifosato, nel 2016 l’Europa, essendo impossibile stabilire una soglia di pericolosità, si è messa al riparo vietandolo del tutto. Quindi, teoricamente, le paste con tracce di glifosato dovrebbero essere fuorilegge. Abbiamo rivolto la questione al ministero della Salute, ma non ci hanno saputo rispondere.
Se il grano che già oggi importiamo dal Canada è inquinato, cosa cambierebbe qualora venisse approvato il Ceta?
Con il mutuo riconoscimento della legislazione, l’Europa sarebbe costretta ad accettare l’impalcatura giuridica canadese. Il legislatore italiano, per fare solo un esempio, non potrebbe più rifiutare la pasta contaminata al glifosato, quindi verrebbe neutralizzato il principio di precauzione.
Chi utilizza solo grano italiano produce pasta non contaminata?
Il grano italiano non garantisce nulla. La vera garanzia sarebbe scrivere su un’etichetta che nella pasta non ci sono sostanze contaminanti. Anche nel grano prodotto in Italia possono trovarsi elementi di tossicità, nelle zone più umide del paese per esempio è più facile che si sviluppi la micotossina. Comunque va detto che in Italia si producono ottime paste a 0 ppb fatte con grano secco dove il fungo non si sviluppa. Che prendano il grano dove vogliono, ma le industrie devono dire al consumatore cosa contiene a livello di residui tossici. Del buon grano turco, o spagnolo, può avere le stesse caratteristiche qualitative di quello italiano.
Il grano duro italiano di alta qualità viene anche esportato. Eppure la produzione totale non soddisfa il fabbisogno interno.
Il nostro grano è prezioso e viene venduto all’estero a prezzi più alti. Noi abbiamo l’oro e lo esportiamo, poi per soddisfare il mercato interno a volte lo tagliamo con un po’ di argento. Sta succedendo questo. Nel Maghreb vogliono il nostro grano, non quello canadese: oggi è più tutelato un marocchino che mangia cous-cous di un italiano che mangia la pasta.
Cosa potrebbe fare il governo per tutelare produttori e consumatori?
Dotarsi di una politica di settore che non ha mai avuto. Il cibo, invece, continua ad essere utilizzato come merce di scambio per trattati internazionali e per incrementare l’export. Il governo dovrebbe decidere cosa è strategico per il paese e poi potenziare i controlli. Un esempio: il ministero ha un elenco di sostanze da cercare negli alimenti stoccati nei porti italiani e tra queste non figura il glifosato. Come mai? Servono controlli seri su tutti i derivati dai cereali: pasta, pane, pizze, dolci.
Tutti gli agricoltori italiani sono impegnati in questa campagna?
Non tutti nello stesso modo. Il sistema agricolo italiano accetta supinamente la filiera capestro imposta dalle multinazionali dei pastai che fissano i prezzi minimi e massimi. Con la complicità del governo.
«NOI, PADRI DEL BIO ITIANO,
CONTRO IL CETA»
di Monica di Sisto
«Reportage. Per Girolomoni la pasta è un progetto politico. Il fondatore portò il biologico in Italia. Ora spiegano come si può produrre senza glifosato»
Naturalmente No Ceta: «Perché produciamo anche per il mercato estero e sappiamo che, adeguandoci ad esso, potremmo farlo a costi decisamente inferiori. Ci rimetterebbero la qualità, i consumatori, il territorio, l’ambiente, noi stessi. Dovremmo rinunciare a principi e valori, e non valgono così poco».
Giovanni Battista Girolomoni, poco più che trentenne, ha gli occhi accesi da un sogno e una grande eredità sulle spalle. Con suo fratello Samuele e sua sorella Maria sono le gambe sulle quali cammina ancora, tra i campi di Isola del Piano di cui è stato sindaco per dieci anni, Gino Girolomoni, il padre del biologico italiano, spentosi all’improvviso nel 2012. Gino nel 2006 aveva lanciato un appello agli abitanti della provincia di Urbino perché sostenessero alle elezioni politiche «quei candidati che si adopereranno affinché in un territorio non si compia alcuna scelta senza il consenso della maggioranza dei suoi abitanti».
Per questo avrebbe apprezzato la scelta dei suoi figli di ospitare nel loro festival Ville e castella una delle tappe del No Ceta tour, sostenuto dalla Campagna Stop Ttip Italia in piazze e città italiane per fermare la ratifica del trattato di liberalizzazione commerciale tra Europa e Canada da parte del Parlamento italiano.
Per i Girolomoni la pasta, prodotto di punta dell’azienda che porta il nome di Gino e viene gestita in forma cooperativa nel cuore delle Marche, non è solo cibo e denaro ma un progetto politico: «Nel 1980 un’ispezione dei Nas gliene sequestrò 400 quintali per frode commerciale, perché la definiva biologica quando in Italia non c’era ancora una legge che riconoscesse questa produzione», racconta Giovanni. «Mio padre vedeva un futuro che le normative hanno faticato a definire, ma che noi vogliamo continuare a scrivere» sostiene, camminando tra le macchine a trafila di bronzo e le celle statiche dove la pasta lentamente essicca, preservando qualità e profumo speciali.
Ma se il trattato di liberalizzazione tra Europa e Canada dovesse passare la ratifica, il Ceta porterebbe a contraddire e a concorrere slealmente con quella filosofia di vita e produzione. Per il trattato tra Europa e Canada,1057 pagine dove si affronta un po’ di tutto – dagli investimenti alla finanza, dalle professioni ai brevetti, fino al cibo – l’unico criterio che conta è che il commercio tra le due sponde dell’Atlantico sia il più facile possibile.
Già al momento, soprattutto per il grano, è decisamente fluido: l’Italia è il principale produttore europeo di grano duro, destinato alla pasta, con 4,9 milioni di tonnellate su una superficie coltivata pari a circa 1,3 milioni di ettari.
Nonostante ciò sono ben 2,3 milioni le tonnellate di grano duro che arrivano dall’estero in un anno (dal Canada 1,2 milioni di tonnellate) senza che questo venga reso noto ai consumatori in etichetta. Per Girolomoni, invece, nonostante venda anche in Nuova Zelanda e Giappone, «sono un centinaio le aziende agricole coinvolte direttamente e il grano è comunque tutto italiano, principalmente di filiera marchigiana», elenca Giovanni Battista.
Chi sale attraverso i colli di solchi e viti verso la collina di Montebello, 150 ettari a pochi chilometri da Urbino, incontra un mondo contromano rispetto alle regole che il Ceta vorrebbe imporre, ma economicamente vincente.
La Gino Girolomoni Cooperativa Agricola è una realtà che va dal campo alla pasta ma resta ben integrata nelle colline circostanti. A una passeggiata di distanza si staglia l’ex monastero di Montebello, strappato alla rovina da Girolomoni padre, che ha ospitato negli anni incontri con intellettuali e artisti come Sergio Quinzio, Ivan Illich, Guido Ceronetti, Paolo Volponi, e dove ogni anno passano centinaia di ospiti appassionati da accoglienza, cucina e un intenso calendario di eventi.
Con i suoi 200 agricoltori, 37 dipendenti e con i suoi oltre 11,5 milioni di fatturato, l’azienda cooperativa Gino Girolomoni, «che è voluta rimanere tale perché così si è tutti responsabili e partecipi», spiega ancora Giovanni Battista, ha contribuito in modo sostanziale allo sviluppo del biologico in Italia.
Nei pressi del monastero, circondato da circa duemila ettari di foresta demaniale, ha sede l’attività della Cooperativa con i suoi magazzini, la stalla, il pastificio. Oggi, dopo oltre trent’anni, buona parte della superficie agricola del comune di Isola del Piano è coltivata con il metodo dell’agricoltura biologica.
«Facciamo in casa anche l’energia – spiega ancora Girolomoni jr – Quella che usiamo è tutta da fonti rinnovabili: in parte acquistata certificata e per circa un terzo ricavata da un sistema composto da un parco di pale eoliche e da un tetto fotovoltaico».
È anche in corso uno studio di fattibilità per la produzione di energia termica da biomasse. Il Canada del giovane premier Justin Trudeau invece ha sbloccato, con l’aiuto del presidente americano Donald Trump, la costruzione dell’oleodotto transfrontaliero Keystone XXL che gli consentirà di immettere sul mercato internazionale 173 miliardi di barili di petrolio da sabbie bituminose canadesi che, se bruciati, secondo i conti di Oil change international, genererebbero quel trenta per cento di anidride carbonica che ci porterebbe oltre l’obiettivo di 1,5 gradi centigradi di incremento di temperatura atmosferica stabilita come soglia massima di aumento con l’accordo di Parigi contro i cambiamenti climatici.
Il Ceta introduce anche l’applicazione del principio di equivalenza delle regole sanitarie e fitosanitarie tra il Canada e l’Europa, che consentirà ai prodotti canadesi di non sottostare a nuovi controlli una volta arrivati alle nostre frontiere.
Un rischio annunciato visto che in Canada sono impiegate nell’agroalimentare 99 sostanze vietate in Unione europea tra cui il glifosato, attualmente sotto processo in Europa, e il mortale Paraquat, illegale da noi da oltre vent’anni.
Nel Canada del Ceta il grano, ad esempio, non solo è trattato con il glifosato, l’erbicida di casa Monsanto sospettato di essere cancerogeno e oggi vietato in Italia, ma arriva nel nostro Paese già vecchio di un anno, visto che la raccolta avviene in settembre. Perché si irrora il grano con il glifosato? Per seccare le piante in un Paese in cui abbastanza sole non c’è, abbattere le tossine e garantire artificialmente un livello proteico elevato nelle spighe, concentrando più nutrienti ma anche tutti i residui chimici.
Nel mondo di Girolomoni, invece, la semina del grano avviene verso i primi di novembre. Raggiunta un’altezza di circa dieci centimetri, il germoglio si ferma per tutto l’inverno. La pianta di grano, infatti, torna a crescere velocemente dopo la pausa invernale.
A luglio, essendo ormai il grano secco e maturo, si procede con la trebbiatura, che separa i chicchi della spiga dalla paglia e dalla pula. Il grano raccolto viene controllato e, una volta accertata la qualità, la pulizia e un’umidità non superiore all’undici per cento, collocato nei silos di stoccaggio.
Prima del riempimento i silos vengono puliti con cura e trattati con polvere di diatomee che uccide gli insetti per disidratazione. Successivamente si deve muovere e arieggiare costantemente il prodotto fin verso la fine di settembre: questo, infatti, è il periodo in cui calore e umidità in eccesso possono creare muffe, germinazioni e infestazioni di insetti e le si combatte con lavoro e natura.
«Gli investimenti futuri e le idee vanno nel costruire una filiera della pasta sempre più sicura per qualità e sostenibilità ambientale», è il programma di Giovanni, il cui ultimo passo è stato un centro di stoccaggio da 10 mila quintali a Isola del Piano per la raccolta del grano locale, e il prossimo, «se le cose vanno come sembra – suggerisce – sarà un mulino, che ci permetterebbe controllo della qualità e autosufficienza totali. Senza contare che potremmo aumentare la produzione locale strappando ancora più territorio all’abbandono».
«Il Ceta ci offre l’occasione di sorpassare tutti i nostri concorrenti. Il governo deve lavorare nella sua applicazione per superare gli ostacoli rimanenti, legati alle condizioni poste in Europa ai trattamenti su produzioni e colture e alle biotecnologie; questioni importanti che devono essere affrontate perché l’accordo possa offrire il proprio potenziale», è invece l’agenda d’azione dei suoi colleghi d’oltreoceano, rappresentati dalla potente Canadian Agri-Food Trade Alliance (Cafta).
Visioni da avere ben presenti per decidere da che parte di futuro stare.

la Nuova Venezia, 23 novembre 2017. «Lo studio dell'Ispra presentato all'università Iuav: “Il Veneto risulta una delle regioni con maggiore consumo di suolo.(m.p.r.) riferimenti in calce
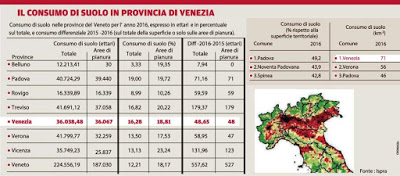
«La Regione non può più fare finta di nulla». È questo quanto emerso ieri alla presentazione del Report sul consumo del suolo 2017, presentato all'Università Iuav e disponibile sul sito dell'Ispra. Dai dati emersi, nel 2016 si è consumato tre volte più suolo nel Comune di Venezia (45,1%) di quanto invece sia avvenuto in provincia (17%). Il suolo viene cementificato a scapito dei terreni agricoli: si aumenta così il rischio di alluvioni o allagamenti, causati dalla riduzione della ritenzione idrica del terreno. Tra i numeri che vengono snocciolati città per città, colpisce quello del Comune di Venezia che, da novembre 2015 a luglio 2016, ha consumato ben 71 chilometri quadrati di suolo. In pratica il 45,1% del suolo è stato edificato, ma se si pensa che una buona parte del territorio comprende la città storica, il dato deve fare riflettere perché riguarda la terraferma.
Oltre 300 Comuni in Italia presentano un consumo di suolo inferiore al 15%; 23 invece hanno una percentuale di suolo consumato superiore al 30%. Padova è al primo posto (49,2%), seguono Venezia (45,1%), Treviso (39,7%) e Vicenza (31,8%). Per capire il rapporto con le altre città: i maggiori valori di superficie consumata si riscontrano a Roma (31.564 ettari), con una crescita di ulteriori 54 ettari nei primi sei mesi del 2016 (+0,17% rispetto al 2015) e in molti comuni capoluoghi di provincia: Milano (10.424 ettari), Torino (8.548), Napoli (7.408), Venezia (7.126, 47 ettari cioè +0,8% rispetto al 2015), Ravenna (7.088).
«Il Veneto risulta una delle regioni con maggiore consumo di suolo» spiega la docente di Pianificazione del Territorio Anna Marson «Una quantità solo in parte attribuibile all'autostrada Pedemontana in corso di costruzione perché, ad esempio, la provincia che registra i valori più elevati è Padova. Questo consumo ci toglie sempre di più terreni agricoli, proprio quelli di maggiore qualità». Dal 2012 al 2016 sono stati consumati nel Veneto circa 1.950 ettari, pari all'1,1% del territorio regionale.
Nell'ultimo periodo analizzato (da novembre 2015 a luglio 2016) il suolo consumato è stato pari a 557 ettari. Sempre in questo periodo, tra le province venete, Venezia ha consumato 36 mila ettari di sola pianura, mentre nelle altre città la pianura è stata solo in parte toccata. In pratica in provincia si è edificato per il 14,79%, meno che a livello comunale. Al 2016 la provincia di Treviso registra una percentuale di suolo consumato del 16,83%, Venezia del 17%, Vicenza del 13,13% e Padova del 19%, per rispettivamente 471 mq/abitante di suolo pro capite consumato nel caso della provincia di Treviso, 421 mq/abitante di Venezia, 412 mq/abitante di Vicenza ed infine 435 mq/abitante nel caso di Padova. Valori stabili rispetto al 2015 nel caso di Padova, in leggero aumento nel caso di Treviso e Vicenza, maggiori nel caso di Venezia.
riferimenti
eddyburg è stato promotore di iniziative e leggi per fermare il consumo di suolo. Al tema è dedicato un'intera sezione, che si può percorrere agevolmente attraverso la visita guidata Consumare stanca.
Sul finto stop al consumo di suolo della nuova legge regionale del Veneto si veda di Monica Zicchiero Stop al consumo del suolo, c’è la legge «Voto storico». «No, troppe deroghe» e di Chiara Mazzoleni Consumo di suolo e dissesto territoriale. Istruzioni per come attuarli.
Uno degli argomenti più caldi in discussione alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP23), tenutasi a Bonn tra il 6 e il 17 novembre, sono stati gli aiuti finanziari per coprire i danni e le perdite (loss & damage) legati alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Questione urgente e troppo a lungo rimandata, divide i Paesi sviluppati e in via di sviluppo in una lotta che resta irrisolta. C’erano molte aspettative per quest’anno in cui le Fiji avevano la presidenza della conferenza, dato che le isole del Pacifico sono una tra le aree del mondo più colpite dal riscaldamento globale e a rischio di scomparsa per l’innalzamento del livello dei mari. Nonostante ciò, la questione è rimasta irrisolta, rimandata al 2018.
Cos’è il loss & damage
Non esiste una definizione condivisa per i danni e le perdite legati alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Quella più citata risale al 2012, di Warner et al.: “Per danni e perdite si intendono gli impatti negativi della variabilità del clima e dei cambiamenti climatici che le popolazioni non sono state in grado di gestire o a cui non sono riuscite ad adattarsi”. Mentre il concetto di danno implica la possibilità di riparazione, rientra tra le perdite ciò che non può essere recuperato o ricostruito, ma solo eventualmente compensato. Ci sono due tipi di perdite: quelle economiche, ovvero di risorse, beni e servizi di mercato, che hanno quindi un valore monetario facilmente definibile, e quelle non economiche, il cui valore economico è difficile da stabilire ma che hanno nondimeno un impatto sugli individui e sulla società. Un documento tecnico redatto nel 2013 dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulle perdite non economiche include tra queste la vita, la salute, gli sfollamenti e la mobilità, il territorio, l’eredità culturale, le conoscenze indigene e locali, la biodiversità e i servizi ecosistemici.
Le conseguenze dei cambiamenti climatici causati dall’uomo si diversificano a seconda delle aree del mondo e possono essere divise in due categorie. La prima sono gli impatti immediati, ovvero quelli causati da eventi estremi come inondazioni, ondate di calore, siccità, precipitazioni intense, tornado e uragani: nel periodo tra 1995 e 2014, gli eventi climatici estremi hanno causato danni per 2.97 miliardi di dollari e più di 525.000 morti. La seconda sono gli impatti di lungo termine, come la perdita di biodiversità e degli ecosistemi, la degradazione della terra e la desertificazione, il cambiamento della circolazione oceanica e atmosferica, l’innalzamento del livello dei mari e l’erosione costiera, che si traducono in riduzione della sicurezza idrica e alimentare, sfollamenti forzati, diffusione di malattie tropicali, e così via.
Azioni di mitigazione e adattamento possono contribuire a ridurre questi impatti, ma è inevitabile che, soprattutto nella seconda metà del secolo, comporteranno dei danni e delle perdite. È perciò cruciale parlare di questo problema, in special modo dal momento che colpisce in particolare i Paesi meno sviluppati, che hanno contribuito meno ai cambiamenti climatici e sono meno preparati a farvi fronte.
Il concetto di loss & damage nel dibattito internazionale sui cambiamenti climatici
Dalla prima proposta effettuata dall’Alleanza dei piccoli Stati insulari (AOSIS) per l’istituzione di un meccanismo internazionale che fornisse un’assicurazione finanziaria contro le conseguenze dell’innalzamento del livello dei mari, lanciata nel 1991 durante le negoziazioni della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), il dibattito sulle perdite e i danni è progredito notevolmente. Se infatti nei primi anni gli aiuti finanziari per il clima erano previsti soprattutto per azioni di mitigazione, successivamente si è fatto spazio il concetto di supporto per l’adattamento alle conseguenze inevitabili dei cambiamenti climatici. La progressiva realizzazione che, nonostante gli sforzi, è impossibile evitare tutti gli impatti negativi sulla società e sugli individui del cambio del clima ha portato all’emergere nel dibattito internazionale del concetto di compensazione dei danni e delle perdite.
Nel 2013 è stato istituito nell’ambito dell’UNFCCC il Meccanismo Internazionale di Varsavia per i danni e le perdite associate agli impatti dei cambiamenti climatici (WIM), con il compito di approfondire le conoscenze sul tema, creare contatti tra gli attori rilevanti e rafforzare le azioni e il supporto per gestire le perdite e i danni. Il meccanismo è stato successivamente posto sotto l’egida della Conferenza delle Parti dell’Accordo di Parigi, che all’articolo 8.1 riconosce l’importanza di prevenire, minimizzare e gestire le perdite e i danni legati agli impatti dei cambiamenti climatici.
Tuttavia, anche se il problema è da molto tempo conosciuto e discusso, non sono state ancora adottate misure pratiche per aiutare chi subisce questi impatti. Il meccanismo di Varsavia, a quattro anni dalla sua istituzione, non è ancora completamente operativo, specialmente per quanto riguarda l’aspetto del rafforzamento delle azioni e del supporto nel campo. Le motivazioni dietro questo ritardo sono complicate, ma possono essere ricondotte in ultima analisi alla riluttanza dei Paesi sviluppati di ammettere la propria responsabilità per gli impatti che le popolazioni del Sud del mondo stanno subendo, per timore di doverle ripagare.
Cosa è successo durante la COP23?
Durante la conferenza sul clima di Bonn, invece di progredire il dibattito è rimasto fermo. I Paesi sviluppati si sono opposti alla richiesta dei rappresentanti delle popolazioni più vulnerabili di coprire con la finanza climatica i costi dei danni e delle perdite associati agli impatti dei cambiamenti climatici. L’Unione Europea e l’Australia si sono giustificate dicendo che non ogni disastro è causato dai cambiamenti climatici.
Ciò è successo a pochi giorni dalla pubblicazione di un rapporto della rivista indipendente The Lancet, che registra per il 2016 797 eventi climatici estremi che hanno causato 129 miliardi di dollari in perdite economiche. Rispetto a ciò, un progetto di Carbon Brief lanciato nel 2012 sta studiando singoli casi di eventi estremi per collegarli alle attività antropiche. Dei 144 casi studiati finora, per il 63% l’influenza umana ha aumentato la probabilità o la gravità dell’evento, per il 14% non ha causato cambiamenti rilevabili e per il 18% non ci sono abbastanza dati per trarre conclusioni definitive. La scienza che collega attività umane, cambiamenti climatici e aumento dei fenomeni estremi sta quindi progredendo e potrebbe essere una base per la relativa compensazione finanziaria. Inoltre, come spiegato sopra, i danni e le perdite non si esauriscono a fenomeni immediati, ma riguardano anche e soprattutto processi lenti già in corso, la cui relazione di causa-effetto con l’influenza umana è innegabile.
Hasan Mahmud, ex Ministro dell’Ambiente del Bangladesh, che attualmente presiede la commissione parlamentare permanente per il Ministero delle Foreste e dell’Ambiente, ha espresso durante una conferenza stampa la sua preoccupazione per il rifiuto dei Paesi sviluppati di riconoscere il bisogno di fondi pubblici e aiuti per l’adattamento. La critica era soprattutto collegata all’iniziativa della Presidenza Fiji, che ha promosso lo strumento assicurativo come una soluzione alla questione del loss&damage, lanciando il secondo giorno dei negoziati la InsuResilience Global Partnership, un’iniziativa finanziata dal settore privato che mira a estendere l’assicurazione climatica a 400 milioni di persone povere entro il 2020. In parallelo, il Comitato Esecutivo dell’UNFCCC per il meccanismo di Varsavia ha lanciato un database online che mira a mettere in contatto gli assicuratori con potenziali clienti nei Paesi vulnerabili. Entrambe le iniziative lasciano al settore privato e a logiche di mercato il compito di compensare le perdite e i danni, senza affrontare il problema di chi pagherà i premi assicurativi.
In breve, i Paesi ricchi hanno trovato un modo per evitare di riconoscere le proprie responsabilità per le conseguenze dei cambiamenti climatici e quindi ripagare i Paesi meno sviluppati e più vulnerabili per gli impatti negativi che stanno subendo. Sembra così che il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle diverse capacità, riconosciuto nell’articolo 2 dell’Accordo di Parigi, sia condiviso solamente quando non si tratta di soldi.
comune-info.net, 22 novembre 2017. «Esiste un altro modo di intendere il “possesso” in forma collettiva, condivisa, solidale, partecipata». (p.d.)
Udite, udite! Aggiornate i manuali di diritto, le forme della proprietà si arricchiscono di una nuova fattispecie, non sono più due, ma tre: privata, pubblica e collettiva. Una vera rivoluzione nella cultura giuridica e anche politica. «In attuazione degli articoli 2, 9, 42 e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie». Così recita l’articolo 1 della nuova legge Norme in materia di domini collettivi, approvata definitivamente il 26 ottobre alla Camera dei deputati (A.C. n. 4522) e ancora in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La proposta che dieci anni fa la Commissione Rodotà fece di considerare “comuni” alcune categorie di “beni” da inserire nel Codice Civile, trova oggi una parziale, ma significativa attuazione di fatto.
Certo, gli Assetti fondiari collettivi sono una fattispecie giuridica ben determinata e delimitata dal lavoro svolto in novant’anni dai Commissari speciali creati in epoca fascista allo scopo di liquidarli, ma ora, per una buffa eterogenesi dei fini, la nuova legge ne sancisce l’esistenza come titolari di beni collettivi indisponibili, inalienabili, indivisibili, inusucupibili, persino inespropriabili e di perpetua destinazione d’uso agro-silvo-pastorale, soggetti a vincolo paesaggistico nazionale (secondo il disposto del Codice dei beni paesaggistici e culturali). Costituiscono i “domini collettivi” quei boschi, pascoli, terreni seminativi, malghe, corsi d’acqua e relative pertinenze e diritti d’uso che siano amministrati da istituzioni comunitarie consuetudinarie, spesso plurisecolari, sicuramente pre-capitaliste, pre Codici napoleonici, pre-unitarie. Nelle regioni italiane prendono nomi diversi: Consorterie (Val d’Aosta), Società di Antichi Originari (Lombardia), Regole (Veneto), Comunelle, Viciníe, Interessenze (Friuli), Comunanze (Umbria), Comunioni familiari montane (Toscana), Università agrarie (Emilia e Lazio), Partecipanze ed altro ancora. In Svizzera si chiamano Patriziati; Baldios in Portogallo; Montes Viciñais in Spagna.
Secondo il censimento Istat del 2010, gli ettari di “terre di collettivo godimento” appartenenti alle proprietà collettive sono più di un milione e mezzo, quasi il 10 per cento della Superficie Agraria Utile in Italia. Il 3 per cento dell’intero territorio nazionale. La loro gestione è affidata agli enti esponenziali storici della collettività-comunità locale che assumono personalità giuridica di diritto privato con autonomia statutaria. Il patrimonio è fondativo dei sistemi territoriali eco-paesaggistici e deve essere utilizzato a favore della collettività degli aventi “diritto reale”, cioè delle persone residenti discendenti dalle famiglie originarie del luogo e – secondo le norme dei vari statuti – dei proprietari di immobili residenti. Una sorta di ius soli civico, con obbligo di custodia del bene. La legge prevede che le Regioni debbano controllare gli statuti degli enti per garantire la partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio. È accaduto, infatti, che alcune “regole chiuse” del Cadore discriminassero le discendenze femminili.
La nuova legge supera un regime provvisorio che si prolungava dal 1927, quando lo stato tentò di sciogliere gli usi civici e di sfaldare i loro patrimoni. La lunga resistenza è ora risultata vincente per merito della testardaggine di alcune popolazioni direttamente interessate (specie dei territori montani) e dell’opera della Consulta nazionale della proprietà collettiva. Decisivo anche il contributo di insigni giuristi, tra cui Pietro Nervi del Centro studi sui demani civici e le proprietà collettive dell’Università di Trento (
www.usicivici.unitn.it) e Paolo Grossi, ora presidente della Corte Costituzionale, che quarant’anni fa scrisse un fondamentale tomo: Un altro modo di possedere (ora ristampato e ampliato da Giuffré). Ma la nuova legge di iniziativa parlamentare, proposta dal senatore del Partito democratico Giorgio Pagliari, docente di diritto amministrativo di Parma, è stata possibile anche grazie alla riscoperta dei
commons avvenuta tramite i lavori della premio Nobel Elinor Ostrom e la nascita di un vasto movimento sociale che rivendica la gestione comunitaria e partecipata dei beni indispensabili al benessere “di tutti e di ciascuno”.
Come afferma Grossi, la proprietà privata non è solo quella individuale, venerata e mitizzata dalla civiltà borghese, tassello fondamentale dell’antropologia individualista e fondamento del sistema di mercato liberale, ma esiste un altro modo di intendere il “possesso” in forma collettiva, condivisa, solidale, partecipata. Più in radice ancora, nel caso dei “domini collettivi” viene superata la sovranità antropocentrica sul bene naturale (il diritto divino di disporne a piacimento dei beni del creato), ma, al contrario, si delinea un primato del bene sui soggetti che lo usano. Il possesso, quindi, non solo è collettivo, ma è anche finalizzato e vincolato alla custodia e alla preservazione del bene. Il diritto di proprietà si allarga anche al “popolo dei non proprietari”, ma ne viene limitato. Le terre d’uso comune smettono così di essere “cose”, oggetti di scambio, strumenti per fini ad esse estranee, e diventano realtà viventi portatrici di un sistema di valori intrinseco. Metavalori ambientali, storici, culturali, identitari, ecologici oltre che economici in senso pieno. I territori sono considerati nel loro potenziale di sostentamento e produzione permanente, nel rispetto delle capacità di carico antropico e nel rispetto dei tempi di rigenerazione delle risorse rinnovabili. Vi è qui l’idea che non vi possa essere discrepanza di interesse tra le «formazioni sociali» ove si realizza la personalità di ogni essere umano (ecco il rimando all’art.2 della Costituzione) e la buona qualità dell’ambiente naturale (rimando all’art. 9 reinterpretato dalla Corte costituzionale) in cui le popolazioni sono insediate. Da qui la necessità di vincolare la proprietà dei beni territoriali ad una «funzione sociale e di renderla accessibile a tutti» (articoli 42 e 43 che riconosce le «comunità di lavoratori e di utenti» quali soggetti abilitati a realizzare un «preminente interesse generale»).
Nella nota dei Servizi studi legislativi della Camera si legge che: «Le difficoltà di inquadramento sistematico dei domini collettivi, appartenenti originariamente ad una comunità, derivano anche dall’irriducibilità dell’istituto all’attuale concezione privatistica, di derivazione romanistica, basata sulla proprietà privata. Si consideri, a tal proposito, anche il contenuto dell’art. 42, primo comma, Cost. secondo il quale “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati”». Con questa nuova legge si viene quindi a prefigurare un terzo tipo di proprietà ricco di possibili sviluppi nella prospettiva dell’autogoverno delle comunità che rompe un antico recinto giuridico dottrinale; una vera eresia rispetto al dogma proprietario del paradigma classico pubblico/privato, dicotomico nella teoria, concorrente nei fatti. Ambedue, infatti, nei comportamenti pratici dello stato liberale sono funzionali al buon funzionamento del mercato, all’appropriazione privata delle risorse, all’accumulazione dei profitti.
Non nascondiamoci comunque i pericoli nascosti tra le pieghe della legge. Si tratta pur sempre di proprietà collettive inserite in un regime di diritto privato e bisogna dare molta fiducia agli “aventi diritto”, alle popolazioni locali insediate, affinché facciano buon uso di questo antico/nuovo potere e non si facciano catturare dalle logiche della “valorizzazione” dei loro meravigliosi beni. Ad esempio, la legge prevede che le Regioni possano autorizzare cambi di destinazione d’uso dei terreni. Le esperienze in atto in tante parti d’Italia sono di straordinario interesse e positività. Vi sono Regole che hanno fermato impianti sciistici distruttivi e cave; Comunalie che hanno realizzato filiere integrate del legno e dei cereali; Partecipanze che hanno fermano la captazione di acque minerali; Viciníe che ripopolano paesi abbandonati (leggi anche
Un antico mulino rivive con la Regola). Molti altri buoni esempi che possono diventare modelli economici e sociali. Si è quindi aperto un varco ed è interessante notare che le delibere (l’ultima è la n.446 del 2016) attraverso cui il Comune di Napoli hanno avviato la «ricognizione degli spazi di rilevanza civica ascrivibili nel novero dei beni pubblici (…) percepiti dalla comunità come “beni comuni” e suscettibili di fruizione collettiva», si ispirano proprio all’idea degli usi civici collettivi.
 Internazionale, 13 novembre 2017. Inaugurata a Bologna la "Disneyland del cibo": grazie all''alleanza fra pubblico e privato in cui, come eddyburg ha rupetutamente denunciato, il privato si arricchisce con i soldi del pubblico, ossia del contribuente, ossia di noi creduloni (m.c.g.) con riferimenti in calce
Internazionale, 13 novembre 2017. Inaugurata a Bologna la "Disneyland del cibo": grazie all''alleanza fra pubblico e privato in cui, come eddyburg ha rupetutamente denunciato, il privato si arricchisce con i soldi del pubblico, ossia del contribuente, ossia di noi creduloni (m.c.g.) con riferimenti in calce
L’olandese Randstad è una delle principali agenzie al mondo di lavoro interinale. È finita nel mirino delle proteste studentesche del 13 ottobre 2017 per un progetto intitolato “Un giorno da Fico”. I ragazzi contestavano una delle novità più importanti della legge del governo Renzi sulla Buona scuola: il principio dell’alternanza scuola-lavoro, che prevede l’obbligo per gli studenti dell’ultimo triennio delle superiori di fare un’esperienza formativa - tra le 200 e le 400 ore a seconda che si tratti di un istituto tecnico o di un liceo - in un’azienda, un’istituzione, un’associazione sportiva o di volontariato, perfino in un ordine professionale.
Nell’elenco c’è pure Fico Eataly World, la Fabbrica italiana contadina di Oscar Farinetti - una società partecipata da Eataly World, Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno - che aprirà il 15 novembre. La Randstad è finita sul banco degli imputati perché accusata di reclutarle manodopera gratuita.
Per capirne di più chiedo ai diretti interessati. Negli uffici dell’ex Mercato ortofrutticolo alla periferia di Bologna, negano accuse e sospetti. Spiegano che il progetto è della Randstad, si svolgerà nelle scuole e alla fine da loro arriverà solo un pugno di ragazzi, “non più di sette o otto”, e comunque “non verranno a fare i lavapiatti”.
A Bologna tutti i poteri cittadini, istituzionali e privati, sono in qualche misura coinvolti
L’amministratrice delegata Tiziana Primori dice che c’è un protocollo “sulla tutela dell’occupazione, la qualità del lavoro e la valorizzazione delle relazioni sindacali” firmato con i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil e il comune di Bologna, per “favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, l’agibilità sindacale, il diritto d’assemblea e la trasparenza della filiera delle aziende presenti nel parco”. Fico, spiega, darà lavoro stabile a settecento persone, mentre altre tremila lavoreranno nell’indotto.
Ne parlo con Marta Fana, ricercatrice all’università Sciences Po di Parigi, autrice di Non è lavoro, è sfruttamento. “Bisognerà vedere quante saranno le assunzioni stabili e quanti i contratti di somministrazione, dunque precari”, dice. Fana contesta a Farinetti la “gestione politica” della nascita di Fico: “Perché la regione ha speso 400mila euro per la formazione di persone per le quali non c’è la certezza di assunzione?”. A suo parere, le istituzioni locali, guidate dal Partito democratico, non avrebbero dovuto mettersi al servizio di quello che definisce solo “l’ennesimo centro commerciale”.
Dalla Randstad rendono noti i contenuti dell’accordo con la nuova impresa di Farinetti: i dipendenti della multinazionale olandese gireranno le scuole di tutta Italia per “illustrare ai ragazzi i nuovi trend del mercato del lavoro, guidarli in un tour virtuale di Fico Eataly World e lanciare un project work” sul tema dell’innovazione nella filiera agroalimentare. Il progetto coinvolgerà 20mila studenti, appunto, e prevede 300mila ore di alternanza scuola-lavoro, ma a Fico i ragazzi ci passeranno appena una giornata, per assistere a un convegno sul tema della “Food innovation”, al termine del quale saranno premiate le scuole vincitrici.
Istituzioni, università, entusiasti
Gli studenti non sono andati molto per il sottile, accomunando Fico ad Autogrill e a McDonald’s. Ma alla Fabbrica contadina bolognese respingono anche questi paralleli. Nello staff di Fico molti hanno lavorato a Slow food o hanno studiato all’università di Scienze gastronomiche fondata da Carlo Petrini a Pollenzo, in Piemonte, molti hanno lavorato a Eataly. L’amministratrice delegata Tiziana Primori arriva invece da Coop adriatica ed è l’anello di congiunzione tra Eataly e il mondo cooperativo. Mi riceve nel suo ufficio, dove campeggia una frase di Italo Calvino: “Se alzi un muro, pensa a cosa lasci fuori”. Su un grande tavolo di legno apre una mappa del progetto e spiega: “Questo non è un luogo dove si viene esclusivamente per comprare o per mangiare, ma per conoscere”.
I visitatori, dice, potranno seguire l’intera filiera del prodotto. Prima di sedersi a tavola per mangiare un piatto di pasta, per esempio, saranno condotti da un “ambasciatore del gusto” a vedere un campo di grano, la macinazione in uno dei due mulini a pietra e la nascita di una tagliatella di Campofilone in uno dei tre pastifici. A supervisionare il tutto saranno le facoltà di veterinaria e agraria dell’università di Bologna.
Fico sarà un esempio dell’Italia che riparte? O è un modo furbo per capitalizzare la tendenza a mangiar bene, pulito e sano?
A Bologna tutti i poteri cittadini, istituzionali e privati, sono in qualche misura coinvolti. Il comune ci ha messo la struttura, che varrebbe 55 milioni di euro. Per la ristrutturazione sono stati raccolti 75 milioni di euro di fondi privati: 15 milioni sono arrivati dal sistema cooperativo, dieci da imprenditori locali e altri 50 da casse previdenziali professionali. Al progetto partecipano centocinquanta imprenditori grandi e piccoli (da piccoli artigiani a grandi consorzi come quello del Parmigiano reggiano), i ministeri dell’ambiente e dell’agricoltura, l’associazione dei borghi più belli d’Italia e l’Ente nazionale italiano per il turismo (Enit), Slow food, le università di Bologna e quella di Napoli, la Suor Orsola Benincasa .
Nelle ambizioni dei fondatori, la “Disneyland del cibo”, com’è stata soprannominata, dovrebbe attirare quattro milioni di visitatori il primo anno e arrivare a sei milioni nel giro di tre. Il sindaco Virginio Merola è così entusiasta che è andato a Manhattan per presentarla alla stampa americana sulla terrazza del Flatiron building, il grattacielo all’incrocio tra Broadway e la Fifth avenue che oggi ospita Eataly New York. Per portare i turisti che immagina diretti a frotte verso la periferia bolognese, ha annunciato un servizio di bus elettrici.
Dentro il parco

Mi portano a visitare la struttura: centomila metri quadrati, di cui 80mila coperti, percorribile a piedi o su piste ciclabili con l’immancabile carrello della spesa. Ci sono due ettari di campi e stalle con più di duecento animali, dal maiale calabrese alla pecora di Altamura, e duemila
cultivar. Solo un piccolo agrumeto è coperto, per ragioni climatiche. All’interno, 40 fabbriche contadine producono carni, pesce, pasta, formaggi e dolci. C’è anche una torrefazione del caffè. A ricordare che siamo a Bologna ci pensano una fabbrica di Grana Padano e un intero padiglione dedicato alla mortadella. Al centro ci sono un auditorium, un teatro e un cinema che sarà gestito dalla Cineteca di Bologna.
Qui, fino all’altro ieri, sorgeva il Centro agroalimentare di Bologna (Caab), nato negli anni novanta ma progettato nei settanta. Il presidente era Andrea Segré, ex professore di politica agraria all’università di Bologna e ideatore del Last minute market, un mercato nato per recuperare e riciclare i prodotti invenduti. A quattro mesi dalla nomina, capito che il Caab languiva e non avrebbe avuto futuro, Segré aveva contattato Farinetti “per sviluppare l’idea del parco agroalimentare che da anni mi frullava nella testa”.
Era il novembre del 2012 e, ora che tutto si è realizzato, sarà lui a presiedere la fondazione Fico, che dovrà promuovere programmi di “cultura della sostenibilità economica, sociale, ambientale ed alimentare”. Il comitato scientifico, presieduto dall’europarlamentare Paolo De Castro, ex ministro delle politiche agricole nei governi D’Alema e Prodi, ha già messo in cantiere le prime iniziative: una giornata sulla dieta mediterranea e la creazione di un frutteto della biodiversità.
L’architetto ferrarese Thomas Bartoli ha rimesso a nuovo la struttura, salvando pure un pezzo del vecchio mercato, che non chiuderà del tutto. Bartoli è un fedelissimo del fondatore di Eataly. Mi spiega di aver mantenuto la vecchia architettura industriale, ma con l’obiettivo di creare una “sensazione contadina”, creando un continuum tra l’interno e i campi, e che il suo progetto è a “cemento zero”, anzi ha recuperato due ettari “per aumentare la superficie verde”. Ma, si schernisce, “l’idea di Fico è talmente forte che la realizzazione architettonica è passata in secondo piano”.
Una Disneyland del cibo

Tutto bene, dunque? Fico sarà un esempio dell’Italia che riparte da cibo e turismo, cioè due dei suoi punti di forza? O, come sostengono i critici, è solo un modo furbo per capitalizzare la tendenza a mangiar bene, pulito e sano, come sostiene un fortunato slogan coniato dal fondatore di Slow food, Carlo Petrini?
In un libro intitolato La danza delle mozzarelle, lo scrittore Wolf Bukowski prende di mira il modello di narrazione del cibo che parte da Slow food, e prima ancora dal Gambero rosso, per finire a Coop, a Eataly e alla sua ultima evoluzione: la Fabbrica contadina di Bologna, appunto. “Fico non è solo un parco giochi per rudi cooperatori e costruttori edili, ma è proprio una Disneyland, un mondo dove fantasia e realtà del capitale si rispecchiano reciprocamente”, scrive Bukowski, che attacca frontalmente l’ideologia di Renzi e Farinetti, improntata al marketing e all’ottimismo, in politica come al supermercato, in cui il conflitto è visto come qualcosa di anormale.
Bukowski vede in Fico la saldatura tra il pensiero di Farinetti e il capitalismo emiliano di derivazione postcomunista: una sorta di socialdemocrazia economica in una regione dove il pubblico governa e le cooperative rosse prosperano. Definisce Bologna “la città coop”, portando come esempio il fatto che nel giro di poche centinaia di metri, in pieno centro cittadino, sono nati negli ultimi anni il Mercato di mezzo, che è stato voluto dall’amministratrice delegata di Fico, Primori, e può essere considerato un prototipo del Parco, e una libreria Coop con annesso punto vendita Eataly. Tutto attorno, una teoria di super e ipermercati Coop.
I due alleati
Oscar Farinetti ci scherza, ma si intuisce che non gli va di essere contestato sia da destra sia da sinistra, di essere dipinto come un compagno e allo stesso tempo come una specie di Berlusconi nei cui negozi il quarto stato marcia con i sacchetti della spesa, come mostrava qualche tempo fa una parodia del celebre dipinto di Pellizza da Volpedo esposta all’interno di Eataly Roma. Al contrario, ci tiene a mostrare di conoscere i suoi dipendenti uno per uno. All’ingresso dell’ex Air terminal vicino alla stazione Ostiense, a Roma, si compiace dei clienti che lo avvicinano e della sua popolarità. Stringe mani e parla della qualità dei prodotti e di come diffonderli ancora di più.
Da quando quelli con il marchio Slow food sono finiti sugli scaffali di Eataly, la loro diffusione è decuplicata. La richiesta di collaborazione è arrivata pure per Fico, e dall’associazione di Petrini hanno risposto sì, pur mantenendo uno sguardo critico.
Ne parlo con Carlo Petrini, l’uomo incoronato da Time tra gli “eroi del nostro tempo”, in quanto guru di una filosofia e di un movimento nel frattempo divenuti globali. A suo avviso il problema, a questo punto, è di “governare il limite”. Spiega che qualsiasi produzione, se supera una certa soglia, diventa “invasiva”, pur se buona, pulita e giusta. Il fondatore di Slow food ritiene invece che si debba evitare il “rivendicazionismo sui prezzi”, altra critica frequente. A suo parere va bene che un alimento di qualità costi di più se tutti sono pagati meglio, dal contadino al trasportatore.
Farinetti concorda su quest’ultimo punto. Spiega che “il 15 per cento di quello che vendiamo lo produciamo noi, il resto arriva da piccoli, medi e grandi produttori”, selezionati da un gruppo di giovani provenienti dall’università di Pollenzo e spediti in giro per l’Italia. Accorciando la filiera, dice, “riusciamo a pagare la carne il 31 per cento in più e a venderla a un prezzo decente”.
Sulla questione della produzione ritiene invece che ci siano margini ulteriori di crescita. “In Italia ci sono 14 milioni di ettari di terreni coltivati, negli anni ottanta erano 19, anche se oggi si produce di più”, dice. Vuol dire che l’agricoltura di qualità (convenzionale a residuo zero, biologica, biodinamica, simbiotica) può svilupparsi ancora molto e puntare al mercato italiano (tuttora gastronomicamente poco educato a dispetto delle apparenze) e soprattutto a quello estero.
È su quest’ultimo punto che il patròn di Eataly ha trovato l’intesa con Coop Alleanza 3.0. Sebastiano Sardo, che ha selezionato i produttori del neonato Parco agroalimentare, dice che l’obiettivo è “creare una piattaforma dei prodotti italiani da esportare” per contrastare i cosiddetti italian sounding, il mercato dei prodotti venduti come italiani ma che non lo sono. Secondo i dati dell’Assocamerestero, l’associazione che raggruppa le 78 camere di commercio italiane all’estero, l’italian sounding ha un giro d’affari di 54 miliardi di euro, mentre l’ industria alimentare italiana si aggira sui 132.
L’accusa di monopolio
A opporsi a questo clima di consenso generale ed entusiasmo diffuso sono stati gli anarchici e gli antagonisti che il 12 dicembre 2016, mentre nell’aula magna dell’università di Bologna si presentava il progetto, hanno lanciato letame e caramelle a forma di vermi contro una coop e una pizzeria biologica di Alce Nero. Quel che contestavano era la grande illusione denunciata da Wolf Bukowski: pensare che si possa trasformare la società educandola a fare la spesa e a cucinare in maniera corretta. I contestatori ritengono che nei padiglioni dell’ex mercato ortofrutticolo il renzismo di Farinetti si saldi con gli affari delle coop, creando un monopolio di fatto nella distribuzione e nel consumo di cibo.
Gli anelli istituzionali di congiunzione sarebbero il sindaco di Bologna Virginio Merola, già nel mirino per gli sgomberi di spazi occupati e centri sociali, e il ministro del lavoro Giuliano Poletti, ex presidente di Legacoop e ideatore insieme al governo di Matteo Renzi del Jobs act. Questo contribuisce a spiegare le proteste studentesche e lo scetticismo di un pezzo di sinistra radicale.
Al fondatore di Eataly si imputa di essere diventato il “braccio imprenditoriale di Slow food” e non gli si perdona l’infatuazione per Matteo Renzi, culminata nella partecipazione alle manifestazioni organizzate dal segretario del Pd all’ex stazione ferroviaria fiorentina della Leopolda.
La prima volta è stata nel 2012, quando ha detto che “la politica è come la maionese impazzita e Renzi vuole rifarla da zero”. Nel 2013 l’allora sindaco di Firenze ha tagliato il nastro di Eataly Firenze e nel 2014 l’ha accolto come “l’amico Oscar”. Lui ha ricambiato dimostrando sintonia con lo spirito della Leopolda. “Questo è un posto dove ci si lamenta poco, mentre ciascuno esprime con sintesi le proprie idee di soluzione”, ha dichiarato a La Stampa.
Un anno fa, alla vigilia del referendum costituzionale del 4 dicembre che è costato le dimissioni a Renzi, fiutando il clima sfavorevole ha affermato: “Dobbiamo tornare a essere simpatici”. Un anno dopo, appare più disincantato ma non ha cambiato opinione. “Renzi è stato tradito dal suo carattere, però è onesto”, dice. Nel frattempo, a inaugurare Fico è stato invitato il più mite Paolo Gentiloni.
riferimenti
su eddyburg seguiamo da tempo le imprese di Oscar Farinetti, abile imprenditore, che all’insegna della modernità e della “cultura”, contribuisce al saccheggio dei beni comuni anche con il supporto della pianificazione urbanistica. A questo proposito si veda Fico, la Disneyland del cibo pronta al debutto di Mara Monti, Un tram chiamato Farinetti.“Gli fanno una linea ad hoc” di Ferruccio Sansa, Qui si mangia di Carlo Tecce. Sul fronte della cultura si veda di Tomaso Montanari Carta e bellezza non fanno rima, Santa Lucia Farinetti, incinta tra le mortadelle, Milano e Firenze, chiese a uso privato (m.p.r.)
 Nigrizia online, 21 novembre 2017. Una visita, sia pure tardiva, a uno dei tanti slum (Korogocho, nella capitale del Kenia) aiuta a capire meglio la miseria costruita dall'ideologia e dalla prassi dello "sviluppo" che alimenta il nostro benessere.
Nigrizia online, 21 novembre 2017. Una visita, sia pure tardiva, a uno dei tanti slum (Korogocho, nella capitale del Kenia) aiuta a capire meglio la miseria costruita dall'ideologia e dalla prassi dello "sviluppo" che alimenta il nostro benessere.
Con un ritardo di cui mi rammarico, perché venirci prima mi avrebbe aiutato a inquadrare il mondo nella giusta prospettiva, sono andato anch’io a Korogocho, la baraccopoli di Nairobi dove scelse di vivere trent’anni fa, nel febbraio 1988, Alex Zanotelli.
So che Alex non apprezza l’eccesso di personalizzazione intorno alla sua esperienza, ma mi sono davvero emozionato quando il suo confratello comboniano Maurizio Binaghi mi ha mostrato quel suo primo misero alloggio, posto sul bordo dell’immensa discarica di Dandora. Ci siamo avventurati in quella lugubre distesa di rifiuti per incontrare le migliaia di persone che ogni giorno pagano un pizzo di venti scellini pur di contenderne la prima scelta ai cani randagi e ai minacciosi uccellacci chiamati marabu. Abbiamo potuto così filmare i poveretti che si affollano intorno ai camion che rovesciano di continuo ogni genere di scarti, velenosi o commestibili, metallici o di plastica che bruciando sprigiona diossina, e scambiare qualche parola con loro. Per poi visitare la sede del progetto Napenda Kuishi (Voglio vivere), in cui ci si prende cura dei ragazzi di strada ladri e tossicodipendenti che aspirano a una difficile redenzione.
Alla vicina parrocchia di Kariobangi ho riabbracciato l’ex direttore di Nigrizia, Franco Moretti. Mentre un’altra collaboratrice del nostro giornale, Bruna Sironi, mi ha accompagnato a visitare il tugurio senza acqua corrente né servizi igienici dove abita da venticinque anni il falegname Peter insieme alla moglie e agli otto figli, nel mezzo del gigantesco slum di Kibera.
È iniziata così la mia visita in Kenya, e la tardiva scoperta del modello di sviluppo africano che insieme ai punti di Pil ha visto crescere i grattacieli di una metropoli dove l’arricchimento di pochi coincide col dilagare delle baracche, in cui vivono ormai circa due milioni di diseredati. Ho toccato con mano, e spero di essere capace di mostrare in televisione, il meccanismo economico che incentiva la formazione di queste immense riserve di manodopera a basso costo da sfruttare. Lusso e miseria che avanzano di pari passo, delineando un futuro da incubo, che da un momento all’altro potrebbe deflagrare con conseguenze al momento imprevedibili.
A questo punto, mi sono spostato nella colonia italiana di Malindi, dove il futuro del turismo esotico comincia a scricchiolare. Si assottiglia il numero dei vacanzieri dei resort a cinque stelle e dei residenti che con centomila euro si erano comprati la villa con piscina. Aumentano i cartelli “vendesi”, scritti nella nostra lingua. L’inquietudine comincia a serpeggiare tra i pensionati tricolori che grazie all’Inps credevano di avere trovato qui il paese del bengodi, perché il loro reddito gli consente di stipendiare cuoco, domestico, giardiniere e guardiani notturni (li chiamano “ascari”) con stipendi da cento euro al mese. Cedono il passo ai nuovi ricchi africani, detentori di patrimoni spesso accumulati grazie a traffici illeciti e a un sistema politico corrotto.
A Malindi, così com’è già successo a Mombasa, il paradiso dei ricchi circondati dai poveri rivela le sue crepe. Altro che “aiutiamoli a casa loro”. L’acuirsi delle disuguaglianze produce instabilità anche là dove pareva che il denaro occidentale distribuisse benessere.
L'Espresso, 14 Novembre 2017. Dopo avere spacciato il turismo come un'irrinunciabile risorsa economica e lasciato a divorare le nostre città, le proteste di cittadini e il degrado forse faranno cambiare tattica, con Barcellona che ci prova (i.b).
Da Brescia arriva una sentenza che può esser rivoluzionaria. Qualche giorno fa il comune è stato condannato a pagare 50.000 euro a due cittadini che l’avevano denunciato per non aver controllato gli schiamazzi della movida del centro. Fiorita nel linguaggio (si appella al “rumore antropico per gli schiamazzi di avventori di alcuni locali che stazionano nei pressi dei plateatici o dei locali su suolo pubblico”), la sentenza dà finalmente ragione ai cittadini angariati dal fracasso. Se dovesse fare giurisprudenza, avrebbero di che tremare i comuni di mezza Italia, anzi di mezza Europa.
Da tempo, da città diverse e lontane (dalla Liguria a Barcellona, da Venezia a Firenze, dalle Cinque Terre al Salento, da Roma come dal lago di Garda) arrivano ruggiti di protesta nei confronti delle invasioni di turisti, di vacanzieri e di frequentatori di festival: folle incontrollabili, danni a monumenti e spazi pubblici, fracasso, indisciplina e molestie, risentimento e ira dei residenti.
A Barcellona, i residenti e le autorità si sono coalizzati e per la prima volta in luglio si sono avute manifestazioni di piazza contro l’orda turistica: «vogliamo i rifugiati, non i turisti», dicevano i cartelloni, che si son visti in giro almeno fino a che il terribile attentato di metà agosto non ha spostato l’attenzione. Nel contempo, a Venezia, Firenze e Roma si segnalano numerosi i casi di danneggiamenti e esibizioni hot prodotti da visitatori fuori controllo. Venezia perde a vista d’occhio residenti e converte le abitazioni in stanze da affittare. In alcune città di mare si studiano regole per limitare gli accessi alle spiagge pubbliche. Proteste dello stesso tipo si levano da più parti a proposito dell’occupazione notturna delle città, ormai soffocate da festival, musiche, gente sbronza e code di automobili. Perfino in montagna si segnalano folle di scalatori improvvisati, che danneggiano l’ambiente e si cacciano in situazioni spesso fatali.
Questi fatti minuti rivelano una metamorfosi profonda di alcuni aspetti del vivere nella modernità. Siamo stati abituati per decenni a considerare turismo e entertainment come risorse economiche e forme importanti di socialità e cultura. Ora scopriamo che stanno cambiando natura e diventando intrusivi e distruttivi. Invece di servire alla cura e alla protezione dell’ambiente in cui si hanno luogo, lo lasciano degradato e danneggiato.
Come si spiega questa svolta? Alle spalle di tutto sta la metamorfosi dell’idea diffusa di tempo libero e di divertimento, che è cominciata negli anni Ottanta e continua ancora. Fino a tre generazioni fa, il tempo libero era un intervallo, di durata variabile, ricavato tra due fasi del lavoro. Serviva soprattutto per riposarsi, cioè non far niente e ritrovare così le forze e la voglia di ricominciare. Grandiosa conquista delle democrazie occidentali con la spinta del socialismo umanitario, il tempo libero si deve alle lunghe lotte sindacali sviluppate tra Otto e Novecento per assicurare ai lavoratori dei giorni di riposo a paga intera. Inevitabilmente, anche nell’uso del tempo libero si riflettevano le differenze di classe: gli umili lo passavano nello stesso posto in cui abitavano, magari mandando i figli da uno zio o da una nonna; i benestanti andavano in vacanza o (come si diceva allora) in villeggiatura cambiando sede e ambiente.
Come in altri ambiti, anche qui la modernità ha cambiato le carte in tavola. Anzitutto, una cospirazione di fattori ha trasformato il tempo libero in tempo-sempre-occupato. Al non far niente s’è sostituito il divertimento. «Sentire la vita, divertirsi» precisa Kant nella sua “Antropologia pragmatica” «non è altro che sentirsi continuamente spinto a uscire dalla condizione presente (la quale deve quindi essere un dolore che spesso ritorna)». Sarà per il bisogno di uscire da questo “dolore” che il riposo è stato sostituito dalla spinta a partire a ogni costo e in ogni momento, cioè, in fondo, a stancarsi sotto altra forma? La villeggiatura (prima di sparire anche come termine) si è trasformata in viaggio, experience e quasi diritto politico; le plaghe più impervie e remote del pianeta sono diventate improvvisamente desiderabili per effetto delle culture alternative.
Negli anni Settanta giovani alternativi, figli dei fiori, rasta o new age hanno inventato la cultura del viaggio estremo, aprendo piste verso paesi del tutto ignoti fin allora. A loro si sono poi aggregati anche i borghesi, medi e piccoli, e perfino piccolissimi, incoraggiati dalla nascita delle compagnie low cost. A quel punto (siamo agli anni Novanta del secolo scorso) il viaggio, il movimento, lo spostamento nei minimi intervalli di tempo è diventato un fenomeno frenetico, travolgente, inarrestabile, che coinvolge tutti e tutto. Inoltre, se il viaggio di un tempo si concludeva con un ritorno (alla maniera di Ulisse: come racconta Eric J. Leed nel suo bellissimo “La mente del viaggiatore”, il Mulino), ora sfocia in un altro viaggio. I paesi che non hanno risorse adatte, se le creano. Si inventano dal nulla ambienti fake con la neve in pieno deserto o isole artificiali per costruirci grattacieli (come ad Abu Dhabi).
La rete ha esaltato questo schema oltre misura: fornisce all’istante informazioni su paesi sconosciuti, offre sistemazioni di ogni tipo, confronta prezzi e favorisce amicizie per scambi di case e magari di coppie. In sostanza, erode il senso del reale, del distante e del diverso, banalizza la storia e la geografia, rende il pianeta ovvio e fake, fa sembrare tutto facile e elimina l’elemento di ignoto e di pericolo che il viaggio ha sempre contenuto. Oggi “si fa” (il termine tecnico è questo) la Thailandia o il Nepal con la stessa scioltezza con cui una volta si andava da Roma a Ostia; si sverna a Cuba o in Costa Rica; si fanno viaggi di nozze nelle foreste del Belize; si approfitta di ogni ponte per “fare (o farsi)” una riviera corallina australe o pernottare in mezzo al deserto. La funzione di scoperta è estinta: tolta forse la foresta pluviale e il centro del Congo, si parte sapendo già tutto. Naturalmente, quando il remoto e l’arduo diventano prossimo e banale, ci si arriva con la stessa sciatta incoscienza con cui si frequenta ciò che è prossimo e usuale, anche se Rangoon o il Nepal non sembrerebbero poter essere affrontati con lo stesso spirito, le stesse aspettative e lo stesso piglio con cui si va a Riccione o a Genzano.
A quest’impetuoso trend si sono accodate le amministrazioni pubbliche, che, sviluppando con malagrazia un’idea geniale di Renato Nicolini (Roma, anni Settanta), hanno deciso di trasformare le città in scenari di eventi di ogni tipo, preferibilmente fragorosi. Alcune città (come Gallipoli in Italia, Magalluf a Mallorca, Santorini in Grecia e tante altre) si sono immolate deliberatamente, proclamandosi luoghi di movida h24. A Parigi, la sindaca Anne Hidalgo ha creato perfino un “delegato alla notte”, anche se la cittadinanza comincia a non poterne più delle feste continue.
È la completa carnevalizzazione del mondo: ogni luogo, momento, monumento, risorsa, paesaggio è fatto per divertirsi. Il divertimento è ininterrotto, anche se dovesse produrre rovine, oltre che mostri. Sarà forse per il motivo che suggeriva l’acuto Kant (che non era mai stato in vacanza in vita sua), cioè per evitare «il vuoto di sensazioni in sé», che «desta orrore (horror vacui) e quasi il presentimento di una lunga morte»? Blaise Pascal sosteneva che «tutte le infelicità dell’uomo derivano da una sola cosa, cioè dal non saper restare in riposo in una stanza». Di certo esagerava. Ma con uguale certezza esagerano i milioni di turisti e movidari che, con la complicità di molti amministratori, trattano il resto del mondo come la loro stanza (a volte come la loro latrina) e non si curano neanche di lasciarla in ordine quando escono.

il Fatto Quotidiano, 21 novembre 2017. «"Cosa possiamo fare se un luogo che amiamo non sa più prendersi cura di sé?" Cosa dovremmo fare, se questo luogo si chiama Italia?». (p.d.)
Giulio Tremonti, che sta ora lanciando con Vittorio Sgarbi un qualche loro rinascimento elettorale, passerà alla storia per qualcos’altro. Per una frase scolpita tra i Fatti e Detti Memorabili del berlusconismo: “Con la cultura non si mangia”. L’antico ministro del Tesoro sostiene di non aver mai pronunciato quelle parole, e possiamo anche credergli anche se, nei suoi anni al governo, a quel principio egli sempre si attenne, come a un Vangelo privato.
A lui risale, con la passiva complicità di Sandro Bondi, il dimezzamento del bilancio dei Beni culturali, le cui conseguenze ancora si sentono; a lui, con l’attiva complicità di Mariastella Gelmini, gli irresponsabili tagli ai bilanci di università e ricerca che costringono all’esilio migliaia di giovani ricercatori, accolti a braccia aperte in tutto il mondo, e a nostre spese (la formazione l’abbiamo pagata noi). E il degrado dei patrii costumi non si arresta: forse per mostrare che con la cultura si mangia, a Montepulciano il famoso paramento murario di palazzo Bucelli, che schiera in facciata decine di urne etrusche come biglietto da visita di un collezionista settecentesco, serve ormai ad appenderci salami e prosciutti. La foto, scrive l’egittologo Francesco Tiradritti, parla più di mille parole. Segnala una gerarchia, prima gli affari e poi gli etruschi; e mette in soffitta la storia sotto una coltre d’insaccati. Col permesso o col silenzio, s’immagina, delle “autorità preposte”. E sì che gli Statuti di Montepulciano del 1337 stabilirono chiaramente “che siano conservate e mantenute in buono stato tutte le strade pubbliche, e non sia permesso ad alcuno di occuparle abusivamente”, punendo severamente chiunque vi faccia per proprio vantaggio qualcosa d’improprio. I contravventori, proseguono gli Statuti (art. VI, 194) dovranno essere obbligati dal sindaco a riparare ogni danno.
La stessa identica gerarchia di valori (prima gli affari, poi la bellezza, l’arte, la storia, il paesaggio) governa dappertutto le scelte politiche. Per restare in Toscana, da poco il Comune di Viareggio ha annunciato l’intenzione di asfaltare una striscia al centro del parco urbano, a sud dello stadio dei Pini, creandovi un’ampia strada verso il mare. Contestata dalle associazioni ambientaliste, questa nuova viabilità distrugge una pista ciclabile e spacca in due il parco urbano che è tra le caratteristiche più amate e celebrate di Viareggio: definendola “asse di penetrazione”, i comunicati comunali fanno uso di una metafora a dire il vero assai più adatta a etichettare uno stupro. Ma a quel che scrive la stampa locale la decisione è presa, e le “categorie produttive” sono invitate a esultare. I ciclisti, forse perché improduttivi, un po’ meno.
Il bello è che questa lenta agonia delle nostre città e dei loro parchi si gioca in nome della bellezza e del turismo. Altro esempio toscano, Cortona. Un recentissimo film della regista americana Sarah Marder e di Olo Creative Farm (The Genius of a Place / L’anima di un luogo) racconta la storia assai istruttiva di questa meravigliosa piccola città, sul confine con l’Umbria, da quando un libro di enorme successo nel mondo anglofono, Sotto il sole della Toscana di Frances Mayes (con relativo film hollywoodiano), ne ha fatto la meta obbligata di un turismo di massa che rischia di distruggerne proprio quelle caratteristiche che fino a qualche anno fa la rendevano unica, attrattiva, piacevole. In questi giorni, il Touring Club Italiano ha scelto e lanciato questo film come rappresentativo di un processo di degrado che minaccia molte città italiane: “Di turismo si può morire. Succede quando una località piccola assurge per motivi diversi alla notorietà. Orde più o meno pacifiche invadono le strade di luoghi altrimenti tranquilli, qualcuno odora l’affare e inizia ad aprire ristoranti e negozi di souvenir a misura di turista, le case diventano b&b, le stanze vengono messe su Airb&B e interi palazzi vengono venduti a stranieri facoltosi che ci vivranno se va bene una settimana l’anno. Così il turismo, benedetto e cercato, finisce per essere tanto invasivo da snaturare l’anima di un luogo e compromettere il suo equilibrio: una quantità esorbitante di macchine e di rifiuti durante l’alta stagione, per esempio, insieme a un utilizzo eccessivo delle riserve idriche”. È quello che si è cominciato a chiamare over-tourism, per analogia con l’over-booking dei viaggi aerei: con la differenza che con l’over-booking qualcuno resta a terra, con l’over-tourism tutti salgono a bordo e la nave affonda.
La nave che affonda è la forma e lo spirito delle città: inseguendo le aspettative (vere o presunte) dei turisti, la qualità di vita dei residenti passa in secondo piano. Anzi, secondo una specie di pulizia etnica in base al censo, molti residenti non reggono più il gioco, e i centri storici si spopolano (Venezia in laguna ha perso 120.000 abitanti negli ultimi cinquant’anni, passando da 175.000 a 54.000). Intanto le periferie si gonfiano di pessime architetture, e i meno abbienti non hanno altra scelta che di andarci a vivere, rendendo il centro sempre meno “vero”, meno autentico, meno civile. E si diffonde l’idea che il futuro delle nostre città non è più (come negli ultimi tremila anni) la creatività e l’inventività dei cittadini, ma la loro abilità di servire i flussi turistici, chiudendo occhi orecchi e cervello a qualsiasi altro stimolo. Come si chiede Sarah Marder nel suo film, “cosa possiamo fare se un luogo che amiamo non sa più prendersi cura di sé?”. Cosa dovremmo fare, se questo luogo si chiama Italia?
la Nuova Venezia, 21 novembre 2017. «Aumentati in centro storico, esplosi in terraferma. Murray Cox: “Servono regole o la città diventa solo scenario”». (m.p.r.)
Decuplicati. In due anni, gli appartamenti a uso turistico offerti sulla piattaforma Airbnb non sono solo cresciuti a Venezia (passando dai 2.672 del 2015 ai quasi 4 mila di oggi), sono più che raddoppiati nelle isole (da 147 a 391) e addirittura moltiplicati per dieci volte a Mestre e Marghera, dove erano solo 309 due anni fa e oggi sono oltre 3 mila: il che significa, che l'espulsione dei residenti per mancanza di case in affitto è un fenomeno che da Venezia si sta allargando, ammorbando anche la terraferma.
Il business. L'affare, per i proprietari, è troppo ghiotto: un appartamento affittato ai turisti - dicono i dati elaborati da Reset e Venice Project - a Venezia rende una media di 3 mila euro al mese, a Marghera 1700, a Mestre centro 1800 euro. E la copertura è superiore all'80 per cento dei giorni dell'anno. «Venezia deve decidere cosa vuole diventare: una città autentica o un hotel», dice Murray Cox reporter, fotografo, informatico. Australiano con casa a New York, sa bene di cosa parla: è stato il primo a studiare il fenomeno Airbnb e a vedere quello che gli altri ancora non conoscevano. In questi anni, ha collaborato con le amministrazioni di San Francisco, New York, Amsterdam, Minneapolis e altre città, proprio per gestire il fenomeno Airbnb e il suo impatto sociale sulle città.
Cox è a Venezia per due mesi: per imparare l'italiano e studiare sul campo il caso-Venezia, ospite dell'associazione Reset (che di residenza e turismo si occupa da tempo) e del VeneziaProject del professor Fabio Carrera (che da 25 anni fa studiare i fenomeni veneziani ai suoi studenti del Worchester Polyetechnic Institute). «In Usa per offrire una casa sul mercato turistico devi chiedere il cambio di destinazione d'uso da residenziale a commerciale, è più complesso rispetto a quanto accade qui», racconta Cox, che in questi giorni sta incontrando anche comitati e associazioni che si occupano dell'emergenza abitativa: «A Venezia, più della metà degli appartamenti è offerta da proprietari che hanno più case: un'operazione imprenditoriale che ha totalmente perso lo spirito originario».
Le regole mancanti. Il turismo è una risorsa, ma senza regolamentazione determina il crollo di una città», commenta Emanuele Dal Carlo, di Reset, «in questi anni siamo andati in Regione con proposte di legge concrete, per chiedere - ad esempio - che chi affitta più di una casa sia considerato attività imprenditoriale e debba avere una partita Iva. Che almeno paghi le tasse. In questi giorni, abbiamo cercato case in affitto per residenti su Airbnb: ne abbiamo trovate 20 a Venezia, contro 3 mila turistiche. Le istituzioni non vogliono toccare questa fascia perché è un ammortizzatore sociale in un momento di crisi». «Una legge utile e facile da fare», osserva Fabio Carrera, «sarebbe obbligare Airbnb a dare trasparenza ai dati, per sapere chi c'è e se paga le tasse. La situazione sta peggiorando, perché il problema dell'espulsione dei residenti si sta allargando a Marghera».
I rimedi. Quali le soluzioni proposte da Cox? «L'aumento del costo degli affitti è il danno principale, toglie case al mercato residenziale, provocando una spoliazione culturale e residenziale di un posto: chi arriva trova solo uno scenario, non più le persone. Sto cercando di capire le leggi e i regolamenti a Venezia e nel Veneto, per cercare alcune soluzioni. La prima è fissare delle regole: come l'obbligo di affittare su queste piattaforme solo una parte della casa dove si vive o quando si è in vacanza, e per non più di 90 giorni l'anno. E trovare il modo di rendere trasparenti i dati, la contabilità. Oggi ci sono troppe zone grigie».
il Fatto Quotidiano, 20 novembre 2017. «Padroni a casa nostra, esultava il governatore Zaia dopo la vittoria al referendum autonomista. Ma tra la città svenduta ai turisti e i miraggi post-industriali di Marghera si vedono i disastri compiuti dai poteri locali di ogni colore». (p.d.)
“Padroni a casa nostra”. Lo slogan pronunciato da Luca Zaia a Palazzo Balbi, la notte della vittoria nel referendum per l’autonomia, ha un che di paradossale. Quello stesso palazzo si affaccia infatti su un Canal Grande e su una città che perdono centinaia di abitanti all’anno, e hanno ceduto a danarosi forestieri anche i propri luoghi più simbolici: Ca’ Corner a Prada, Palazzo Grassi e Punta della Dogana a Pinault, il Fondaco dei Tedeschi al gruppo del lusso francese di Lvmh, Ca’ Garzoni e Moro ai ricchi acquirenti stranieri che inseguono appartamenti da un milione di euro; e lo scorso giugno perfino lo stesso Palazzo Balbi, sede del proclama (e della Regione Veneto ormai in procinto di trasferirsi a Santa Lucia, in uno stabile profumatamente comprato a Benetton), è stato messo in vendita a 30 milioni di euro, insieme ad altri edifici storici.
Tra questi c’è il palazzo dell’antica trattoria Vida, in campo San Giacomo de l’Orio a Santa Croce, appena ceduto dalla Regione e dunque candidato a passare – se non vinceranno le proteste dei residenti – da potenziale luogo di aggregazione civica a ennesimo spazio commerciale o turistico; il tutto in una zona che ha già visto una banca trasformarsi in ristorante e una sede universitaria in hotel di lusso. Ben poco ci si può aspettare dalla politica liberista e privatista del sindaco Luigi Brugnaro che deve parte della sua popolarità, alla vigilia dell’elezione, alla gara per accaparrarsi a suon di dobloni l’isola lagunare di Poveglia, che migliaia di veneziani provarono a trasformare in un bene comune tramite crowdfunding. Certo Brugnaro, sceso in politica da poco, può dirsi non responsabile del sacco di Venezia, perpetrato in gran parte sotto giunte di sinistra, più o meno filosofiche (si pensi agli sventramenti del Lido, sotto l’egida della holding EstCapital guidata da un ex assessore di Massimo Cacciari; o alla proliferazione dei b&b mentre i libri di Marsilio decantavano la rinascita della città). Ma ben poco, al di là di proclami in nome di una “nuova Manhattan” o di una “Dubai europea” (!), è venuto dal sindaco anche sul caso principe del declino veneziano, Porto Marghera, luogo sacro e maledetto di un’industria ormai defunta.
È di luglio l’abbattimento delle torri ex-Vinyls del Petrolchimico: il panorama è ora monco. Sul centenario dello stabilimento di Marghera (1917-2017), verte una mostra nell’appartamento del Doge di Palazzo Ducale: mostra minata da un malposto intento estetico, ma che ha il merito di far risuonare nel cuore storico del potere veneziano le voci, le canzoni e le lotte dei lavoratori, a cominciare dal mitico operaio Gabriele Bortolozzo che nel 1983 per primo denunciò in procura i veleni al giudice Casson (lo stesso Casson sconfitto nel 2015 nella corsa a sindaco da Brugnaro). Tuttavia, in quelle stanze ovattate del Palazzo dei Dogi si tace sulle responsabilità dell’industria nazionale nell’avvelenamento di terreni e operai, si sorvola sul problema delle bonifiche, non si parla degli incidenti che decimano le maestranze delle ditte appaltatrici dei limitrofi cantieri navali.Non si vuole parlare di “ciò che è rimasto”, come dichiara la direttrice Gabriella Belli.
Così, al di là della retorica del sindaco (figlio di Marghera e di un poeta operaio di quella fabbrica), la mostra disegna come lembo di futuro la nuova bioraffineria dell’Eni (sponsor della mostra), appena visitata in premier Gentiloni e purtroppo alimentata in via quasi esclusiva con olio di palma (dopo il divieto del Parlamento europeo, Eni sta ora cercando di ampliare la gamma degli oli trattabili). Rimangono al rango di belle idee le promesse di impiantare una nuova industria aeronautica o di un terziario avanzato, sbandierate dal sindaco. Secondo il ministro Delrio, il futuro di Porto Marghera si legherà alla funzione di punto d’attracco delle grandi navi da crociera, per sgravare il bacino di San Marco. Ma in cambio di questa devoluzione al turismo d’assalto dei forestieri, si dovrà riconfigurare tutto il canale che dalla bocca di porto di Malamocco conduce a Fusina e a Marghera.
Di cosa saremmo dunque padroni, a casa nostra? La battaglia identitaria del Veneto, che si risolve per ora in operazioni propagandistiche (la bandiera di San Marco obbligatoria negli uffici pubblici; il dialetto veneto e la storia veneta privilegiati nell’insegnamento; la priorità ai Veneti “doc” negli asili e in certe graduatorie), sembra poco interessata al possesso comune, alla memoria e alla gestione dei luoghi fisici, al discorso pubblico sugli spazi della storia. E il Pd locale non sa proporre una visione alternativa, né sa inchiodare una Regione così avida di potere e di competenze alle proprie responsabilità, tutte legate alla gestione del “territorio”: dallo scandalo dello smaltimento dei rifiuti nel Veneziano (il dirigente del settore ambiente, secondo la Commissione parlamentare, avrebbe malversato nel ramo fino al 2014) al fiasco della Pedemontana Veneta, dal project-financing taroccato per l’Autostrada del Mare a quelli assai discussi per gli ospedali di vari capoluoghi; per non parlare del coinvolgimento della Regione nell’inchiesta sul Mose, con l’arresto dell’assessore alle Infrastrutture Renato Chisso e dell’ex governatore Giancarlo Galan.
Tutte malefatte avvenute, per carità, all’insaputa di Zaia, che fa politica nella sua terra da un quarto di secolo e ora, non pago, rivendica indisturbato il “modello veneto”, e più poteri per sé e per i suoi.