

il manifesto, 3 febbraio 2018. «Je so' pazzo. Gli attivisti dell'Ex Opg ripuliscono l'edificio cinquecentesco, lasciato privo di manutenzione dai proprietari, per ospitare chi non ha una dimora fissa». Giustizia contro legalità formale. (m.p.r.)
Ieri all’alba sono entrati nella chiesa di Sant’Antonio a Tarsia (abbandonata da anni) e, sotto lo sguardo curioso del quartiere, hanno cominciato a portare dentro brandine e materassi. I ragazzi dell’Ex Opg di Napoli Je so’ pazzo, che hanno dato vita alla lista Potere al popolo!, hanno attrezzato un’area lungo la navata per ospitare almeno una ventina di senza fissa dimora. Si tratta di una delle attività che l’Ex Opg porta avanti con la Rete di Solidarietà popolare, di cui fanno parte ad esempio Don Franco, parroco di Poggioreale, e Napoli insieme, un’associazione che distribuisce pasti agli homeless. «Avevamo chiesto al comune e alla Curia la gestione di uno spazio abbandonato, a spese nostre, per dare asilo nei mesi invernali a chi non ha una casa – spiega Viola Carofalo, capo politico di Potere al popolo! -. Nessuno ci ha risposto e allora abbiamo deciso di fare da soli. Dall’inizio del 2018 già cinque persone sono morte di freddo in Italia. Otto l’anno scorso.
La Curia di Napoli è il maggior proprietario immobiliare della città. Vanno poi aggiunti gli immobili delle circa 150 arciconfraternite e quelli delle parrocchie. Per non parlare dei beni in mano ai singoli ordini religiosi».
La polizia si è presentata in mattinata ma non è intervenuta, non erano riusciti a contattare la proprietà per procedere eventualmente allo sgombero. L’edificio cinquecentesco è stato lasciato privo di qualsiasi manutenzione dalla confraternita dei Redentoristi, gli ultimi proprietari dell’antico complesso nel cuore popolare di Napoli. Il quartiere racconta che avrebbero provato a vendere il bene, un convento con vista verso la collina del Vomero, ai privati. Hanno persino aperto un varco nelle mura perimetrali per permettere l’accesso alle automobili. Al primo piano sono ancora visibili gli antichi soffitti a volta, la balaustra in piperno intarsiato e il cortile interno, lasciato in totale degrado. Agli ultimi due piani invece una recente ristrutturazione ha cancellato ogni traccia delle architetture barocche, lasciando pareti squadrate, orribili mattonelle a fiori accanto a infissi anodizzati.
«Stasera porteremo i pasti cucinati all’Ex Opg – prosegue Viola -, cercheremo di coinvolgere il quartiere in attività per la comunità e proveremo anche a contattare l’università Suor Orsola Benincasa, che ha il dipartimento di Conservazione dei Beni culturali, per cercare di evitare che la struttura vada in malora».
Chiara Capretti, candidata di Pap e attivista di Je so’ pazzo, legge l’occupazione anche come risposta al decreto Minniti-Orlando: «Siamo qui per ribaltare il concetto di decoro, che utilizza il daspo per relegare nelle periferie chi vive in condizioni di disagio e povertà estrema. Il nostro decoro è la solidarietà. Il governo Pd ha aperto la strada ma i comuni si sono accodati con le squadre di vigili addette all’applicazione della norma, dai 5S a Torino e Roma a Como, Bologna e Milano. Domani avremo iniziative in molte città: lavoreremo ad attività come attrezzare il verde pubblico o liberare le panchine dai dissuasori».
Tra gli scranni della chiesa c’è anche lo storico Giuseppe Aragno, anche lui candidato con Pap: «La norma firmata da Minniti e Orlano ha un precedente: il decreto fascista sul ‘decoro urbano’ del 1934, le similitudini sono evidenti già nel nome. I disoccupati dell’epoca minavano il concetto di ordine e l’immagine delle città fascista, così dovevano essere allontanati verso i paesi di origine. È grave che chi viene dal Pci utilizzi gli stessi strumenti del Ventennio. L’iniziativa a Tarsia è un modo per dare una risposta politica alle aberrazioni delle classi dirigenti, tutte genuflesse al liberismo».
NENA news, 2 febbraio 2018. Prosegue senza tregua, rafforzato dall'intervento del bulldozer Donald Trump, il tentativo di Israele di cancellare cultura, storia e popolazione dalla Palestina
«Secondo lo studio, i progetti di Tel Aviv nelle parti occupate di Gerusalemme est sono usati come “mezzo politico per modificare la narrativa storica e promuovere la colonizzazione”. Un documento dell’Onu, intanto, identifica 206 aziende internazionali che fanno affari con gli insediamenti illegali israeliani»
Nello studio è citato in particolare il progetto “La città di David”, un parco archeologico finanziato dallo stato nell’area palestinese di Silawan che offre “tour” nelle rovine dell’antica Gerusalemme. Peccato però che Silwan sia casa di 10.000 palestinesi e che da anni sta subendo un costante processo di de-arabizzazione il cui obiettivo palese è quello di cancellare qualunque traccia della presenza autoctona palestinese. La Città di David è diretta da una organizzazione di coloni, scrivono i diplomatici, che presenta una “narrativa esclusivamente ebraica separando il luogo dalle vicinanze palestinesi”.
Ma le brutte notizie per Tel Aviv non finiscono qui. Un rapporto dell’Ohchr (Alto Commissariato delle Nazioni Uniti per i diritti umani) pubblicato mercoledì ha identificato 206 compagnie internazionali che fanno affari con le colonie israeliane costruite nella Cisgiordania occupata in barba al diritto internazionale. Lo studio dell’Ohchr avrebbe dovuto riportare originariamente anche i nomi delle aziende implicate, tuttavia, dopo intense pressioni statunitensi e israeliane, è stato deciso di indicare solo il numero delle compagnie che violano il diritto internazionale. “Gli affari – si legge nel testo – giocano un ruolo centrale nella fondazione, mantenimento ed espansione delle colonie israeliane. Agendo in questo modo, [le aziende] stanno contribuendo alla confisca di terra da parte d’Israele facilitando il trasferimento di popolazione nei Territori Occupati palestinesi e rendendosi complici dello sfruttamento delle risorse naturali palestinesi”.
Duro il commento dell’inviato d’Israele all’Onu Danny Danon che ha parlato di “una vergognosa e scandalosa lista nera”. Della stessa idea è Raz Shechter, ambasciatrice e rappresentante permanente d’Israele all’Onu: “E’ al di là delle competenze e autorità del Consiglio dei diritti umani compilare blacklist. Ma ciò rientra nei tentativi di provare a delegittimare Israele”. “Le compagnie – ha sottolineato Shechter – non stanno facendo alcuna attività illegale”. A darle man forte è l’ambasciatrice Usa all’Onu, Nikki Haley, secondo cui il rapporto è figlio del “cronico pregiudizio anti-israeliano” ed è l’ennesima “dimostrazione dell’ossessione anti-Israele del Consiglio”.
Sul piano politico, intanto, i ministri degli esteri arabi riuniti al Cairo hanno chiesto la creazione di un “meccanismo multilaterale” sostenuto dall’Onu per ravvivare il processo di pace tra israeliani e palestinesi. Il vertice di due giorni nella capitale egiziana, che ha avuto al centro delle discussioni il recente riconoscimento di Gerusalemme come capitale d’Israele da parte del presidente Usa Trump, ha quindi proposto la convocazione di una conferenza internazionale per ravvivare i negoziati tra le due parti e per riconoscere lo stato di Palestina con Gerusalemme est come sua capitale. Non è chiaro quale sia questo “nuovo meccanismo” di cui parlano, ma il ministro degli esteri palestinese Riyad al-Malki ha ribadito che quello “vecchio ha smesso di esistere, è storia”. I palestinesi si muovono però anche sullo scenario internazionale: il 20 febbraio il presidente palestinese Abbas parlerà al Consiglio di Sicurezza dell’Onu.
Ieri notte, intanto, l’aviazione israeliana è tornata a colpire la Striscia di Gaza. Secondo i palestinesi, i jet di Tel Aviv hanno colpito le al-Nada Tower nella zona nord orientale di Beit Lahiya. Non si registrano feriti. In precedenza, l’esercito israeliano aveva riferito che alcuni razzi erano stati lanciati dalla piccola enclave palestinese sotto assedio verso il territorio israeliano senza causare danni.
Nigrizia, 31 gennaio 2018. Una pesante accusa di landgrabbing e d'inquinamento ambientale (imputato "lo squalo" Vincent Bolloré, amico di Sarkosy), che definisce calunniose le accuse. Il tribunale deciderà
Soprannominato “lo squalo” per la sua ferocia negli affari, il miliardario Vincent Bolloré, al decimo posto tra gli uomini più ricchi di Francia e amico dell’ex presidente Nicolas Sarkozy, è al centro di un processo per diffamazione intentato dalla Società finanziaria del caucciù (Socfin, con sede in Lussemburgo) contro l’organizzazione non governativa Sherpa e diversi giornali francesi. La prima udienza si è svolta il 25 gennaio davanti al tribunale di alta istanza di Parigi.
La questione verte sulle accuse di accaparramento di terre in Camerun. Accuse mosse dagli abitanti delle aree confinanti con le piantagioni della Società camerunese di palme (Socapalm), filiale di Socfin di cui il gruppo Bolloré è azionista. Ora i problemi fondiari sono stati riconosciuti nel 2015 dal gruppo Bolloré davanti al punto di contatto nazionale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in seguito alla denuncia depositata nel 2010 da Sherpa e da altre ong, che hanno anche denunciato i problemi sociali dei dipendenti della piantagione e problemi ambientali (inquinamento delle acque) dell’area. Il gruppo Bolloré e Sherpa avevano anche trovato una convergenza su un piano d’azione che avrebbe dovuto porre rimedio ai problemi. Ma il piano non è stato attuato dal gruppo Bolloré che, nel dicembre 2014, ha dischiarato che a bloccare ogni iniziativa era la Socfin.
Va rilevato che, secondo quanto riportato da Le Monde il 19 agosto del 2017, la Socpalm è anche accusata di deforestazione e di dure condizioni di lavoro imposte ai suoi dipendenti. E nel settembre 2017, un gruppo di donne camerunesi che fanno capo alla Rete degli attori di sviluppo durevole (Radd) ha denunciato aggressioni sessuali e maltrattamenti di cui sarebbero vittime. Il problema è noto alle autorità camerunesi che già nel 2005 avevano chiesto a Socfin di restituire 20 mila ettari di terra alle popolazioni confinanti con le piantagioni.
The Submarine, 29 gennaio 2018. L'Italia è un paese che sta andando a pezzi, a partire dal a struttura geologica che ne è la base naturale. Lo si Sto arrivando! da secoli, ma non si fa nulla: le risorse servono ad altro. Con postilla
«Il prefetto Boffi: “Tutti possono venire a Venezia, ma non tutti assieme”»
Prima prova generale fallita, dunque. I controlli per limitare l'afflusso in rio di Cannaregio e nelle aree limitrofe hanno paralizzato mezza Cannaregio. Transenne e masse di gente accalcata in Lista di Spagna, all'Anconeta, in Ghetto. Qualche situazione di pericolo reale. Veneziani che non riuscivano nemmeno ad andare a casa. Ospiti degli alberghi bloccati, così come gli studenti che abitano in città che non potevano mostrare una carta d'identità. E la sicurezza li fermava.
Controllare i flussi una volta che i visitatori sono già arrivati dentro la città ha provocato disagi e contraccolpi. Anche se il Comune dice di avere «avvisato tutti per tempo».Signor prefetto, forse il problema va affrontato a monte.«Non abbiamo norme che ci consentano di fermare le persone e non farle entrare in città».Ma se mettiamo il semaforo dentro la città, si blocca tutto.«Infatti. Il problema c'è, e stiamo cercando di affrontarlo in queste ore. Abbiamo anticipato a mercoledì la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica.
Controllare i flussi dentro questa città è complicato, le calli sono strette».Domenica c'è il volo dell'Angelo, prima vera domenica di Carnevale.«Il Comune ha accettato la nostra proposta di anticipare la manifestazione di un'ora, alle 11 e non più a mezzogiorno. Cerchiamo di disincentivare, questa è la parola giusta. Cioè di ridurre l'afflusso di pendolari giornalieri che vengono da distanze medio lunghe e arrivano in auto o in treno. All'inizio il Comune ha fatto qualche resistenza, la tradizione parla del Volo dell'Angelo sempre alla stessa ora, a mezzogiorno. Poi hanno capito».
Quante persone saranno ammesse in Piazza domenica?«I vigili del fuoco stanno lavorando per le ultime stime. Ma credo che il numero non potrà essere molto superiore alle 20 mila unità. Dunque, una capienza di molto ridotta rispetto allo scorso anno».Cosa ci dobbiamo aspettare?«Stiamo cercando di informare per bene, dovremo controllare bene i flussi. Tutti vogliono venire a Venezia, ma devono capire che non possono venirci tutti insieme, possono farlo anche in altri periodi più tranquilli dell'anno se vogliono godere la città. È importante che ci sia la consapevolezza che Venezia, città meravigliosa, la più bella del mondo, è vivibile in tanti altri giorni e non solo in occasione di questi grandi eventi».
Certo se si invitano gli ospiti con un programma nutrito e si fanno spettacoli nel cuore della città antica, la gente arriva in massa.«La gente vuol venire a Venezia, certo. Ma forse è ora di ripensare a qualcosa. Ripeto, la capienza della Piazza San Marco per questioni di sicurezza sarà quest'anno molto più ridotta, molto lontana dalle decine di migliaia di persone che arrivavano negli anni scorsi. Forse gli spettacoli in Piazza non hanno più molto senso e vanno ripensati».Ci sono altri provvedimenti in arrivo per domenica?«Le decisioni che saranno prese sono legate al controllo degli accessi e al contingentamento del numero di turisti che potranno essere presenti contemporaneamente in Piazza San Marco».A farne le spese saranno ancora una volta i residenti?«Ne parleremo nella riunione del Comitato per la sicurezza, convocato per mercoledì»
«A CANNAREGIO
TUTTO È ANDATO PER IL MEGLIO»
«Le manifestazioni di sabato e domenica a Cannaregio sono andate bene. All'interno dell'area dove avvenivano gli eventi gli spettatori si potevano muovere tranquillamente e c'erano tutti gli spazi per garantire, in caso di necessità, gli interventi dei soccorritori» sottolinea il questore Vito Danilo Gagliardi «I deflussi sono avvenuti regolarmente senza incidenti in considerazione anche del numero delle persone arrivate. Oggi (ieri ndr) ho in programma una riunione con i miei collaboratori per valutare tutti gli aspetti della manifestazione in vista del prossimo fine settimana. Il numero di spettatori che potranno entrare in piazza San Marco sarà stabilito in base ai criteri previsti dal decreto Minniti. Gli stessi usati per consentire l'accesso agli 11 mila sulle rive di Cannaregio.
Sarà tutto in proporzione».La proporzione vuole che quel numero per domenica, calcolate le varie uscite e corridoi di sicurezza, arrivi al massimo a 20mila spettatori per il volo dell'Angelo. Uno strappo alle regole sarà quello di portare quei 20mila a quota 25mila. Ma nessuna persona in più. Numeri ben lontani dagli 80mila degli anni scorsi, con punte che arrivarono anche a 90mila presenze alle 12 per il volo che tutti vogliono vedere. E che consentirono al Carnevale di Venezia di diventare la notizia di apertura dei telegiornali nazionali. E anche in tempo di terrorismo. Domani, durante la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno individuate le strategie per arrivare a quota 20mila.
Mentre gli anni passati si studiavano strategie per portare più gente possibile in centro storico, organizzando treni speciali. Domani diventerà ufficiale la decisione, studiata con Vela, di anticipare di un'ora il volo dell'Angelo. Questo per scoraggiare gli spettatori che arrivano all'ultimo momento per assistere in piazza allo spettacolo. Considerato che molti utilizzano i treni questo, sperano al Cospa, scoraggerà i meno "convinti" dell'alzataccia. In considerazione che ci potranno essere anche altri momenti in cui la piazza sarà off-limits, si stanno studiando spettacoli alternativi sparsi in altri luoghi della città. Abbozzo di un Carnevale diffuso che potrebbe essere la filosofia della festa del prossimo anno. Al Cospa, tutti, sono convinti che sia arrivato il momento di cambiare e anche Vela e il regista del Carnevale dovranno adeguarsi alle nuove misure di sicurezza considerato il periodo in cui viviamo. Sempre nella riunione di domani sarà deciso se reclamizzare in maniera forte i nuovi spettacoli oppure no. Questo perché c'è qualcuno, tra i responsabili della sicurezza e dell'ordine pubblico, che teme l'effetto contrario e che in città arrivino più spettatori in considerazione dei nuovi pro grammi. Altri invece sostengono che pubblicizzare al massimo le iniziative servirà a far allontanare un maggior numero di persone da Piazza San Marco.
Carnevale: niente caos e tutto bene. È il bilancio tutto in positivo del sindaco Luigi Brugnaro del primo week-end della festa, tracciato ieri a Ca'Farsetti, ridimensionando a «mugugni» di chi non sa divertirsi, le proteste di chi si è trovato bloccato tra la folla dei turisti, soprattutto per l'apertura di sabato con la festa sull'acqua a Cannaregio. «Non ho visto il caos» ha esordito Brugnaro «e non ritengo disastroso se qualcuno è rimasto per qualche minuto intrappolato tra la gente.
È da quando sono ragazzo che durante il Carnevale c'è sempre grande affollamento: se uno non vuole la confusione, vada ad abitare in campagna e non a Rialto o in altre zone centrali di Venezia». E lui - che ricorda compiaciuto il suo travestimento di sabato da Batman - "affonda" ancora contro i "seriosi" contestatori: «Forse manca solo un po'di voglia di prendersi in giro, di voglia di divertimento, di coraggio di prendere iniziative trasversali. Perché a lamentarsi non sono stati tutti, ma sempre i soliti, che sanno benissimo che, tanto più se vivono in quelle zone, nei trenta minuti della manifestazione si può fare fatica a passare.
Personalmente siamo contenti, perché credo che abbiamo gestito benissimo gli eventi: non si era mai sentito lo speaker spiegare le vie di fuga prima dell'evento. Grazie alla collaborazione nell'organizzazione con la prefettura, la questura, i vigili urbani e tutte le forze di polizia abbiamo ottenuto l'obiettivo di avere la massima sicurezza. Le polemiche non sono vere e il Carnevale, è bello e ce lo teniamo ben stretto, cercando di diffonderlo sempre più in tutta la città metropolitana».
Brugnaro rivendica anche l'esperimento sul controllo dei flussi turistici appena avviato. «Siamo i primi che provano a intervenire» ricorda «ed è chiaro che ci possono essere anche errori e che evidente che andremo avanti con miglioramenti continui.
Stiamo sperimentando queste regolamentazioni. Non c'è un numero chiuso ma per certe aree c'è un limite alle persone. Stiamo, con un certo coraggio, iniziando un percorso nuovo di regolamentazione dei flussi. L'anticipo di un'ora - alle 11 - del Volo dell'Angelo in Piazza San Marco di domenica prossima è dovuto a motivi di sicurezza e premia anche chi risiede in città o negli alberghi cittadini. Se poi prevediamo solo 20 mila persone in Piazza è per trovare i giusti numeri affinché chi viene a vedere lo spettacolo stia anche comodo: non possiamo pensare di limitare i numeri della gente che viene al Carnevale, ma anche l'anticipo dell'orario aiuterà ad impedire un massiccio afflusso in Piazza San Marco e ulteriori intasamenti». Anche a un concerto di Vasco Rossi, ha aggiunto il sindaco, «quando sono finiti i biglietti non si accettano ulteriori ingressi. E noi facciamo manifestazioni gratis per i turisti e per chi vive la città, perché il Carnevale è una tradizione centenaria, un fatto culturale di Venezia, in cui è bello perdersi». Confermata anche l'entrata in servizio di 40 nuovi vigili urbani, che saranno utilizzati in pattuglia in servizio notturno, dalle 19 all'una.
I flussi turistici a Venezia negli ultimi decenni hanno avuto «proporzioni inimmaginabili» e sarà necessario, sul fronte delle possibili soluzioni, «alla fine pensare in termini di sicurezza non penalizzando i cittadini più fragili», come può essere una famiglia che organizza una gita per portare i figli a vedere il Carnevale. Nel dibattito riaperto in città dalla massiccia presenza di turisti sabato scorso per il prologo della manifestazione è intervenuto ieri anche il Patriarca Francesco Moraglia . Una questione, quella del numero eccessivo di presenze, da contemperare con il tema della sicurezza, che investe anche la Basilica di San Marco. «La Basilica» ha aggiunto Moraglia «è certamente un obiettivo sensibile, è sotto gli occhi di tutti più di altre realtà, anche se tutta Venezia è sotto l'occhio ingigantito del mondo. La Basilica cerca di fare il possibile, di attrezzarsi. Certe cose vengono studiate, non vengono dichiarate, e poi si cercano soluzioni che garantiscano sicurezza». Questioni che sono da tempo all'attenzione della Procuratoria di San Marco che sta studiando specifiche opzioni sul piano delle nuove tecnologie che possano garantire nel contempo la sicurezza e una presenza di persone che non sia penalizzante. «Anche noi» ha concluso il Patriarca «dobbiamo stare a quelli che vengono dichiarati i parametri di vivibilità di una piazza o di una struttura».
Ambiente Venezia. Da uno dei maggiori conoscitori critici della folle avventura del progetto MOSE la risposta rigorosa e drammatica al problema: abbiamo speso inutilmente 6000 milioni di euro, ogni euro in più sarebbe un'aggiunta allo spreco. Con postilla
AmbienteVenezia - NOTA SUL PROGETTO MOSE – La Vera Alternativa
Il "che fare" di fronte ad una grande opera sbagliata e costosa qual è il Mose che si rivelerà a breve anche inutile per l’aumento del livello del mare che i cambiamenti climatici già prevedono per il prossimo futuro. Oggi il Mose appare contrassegnato dallo scandalo che lo ha coinvolto, da quella realtà fatta di corruzioni, tangenti, rapporti tra controllori e controllati, fondi neri che la Magistratura è riuscita a far emergere.
Un impressionante sistema di potere malavitoso e criminale che coinvolge politici, amministratori, imprese, magistrato alle acque, ministeri, guardia di finanza, corte dei contiLa meritevole azione collegiale degli organi preposti al ripristino della legalità che tanta attenzione mediatica sta provocando rischia però di relegare in secondo piano la sostanza del sistema che interessa il Mose.
Si sta assistendo ad un atteggiamento diffuso di non voler sapere, di non approfondire, dimenticare o volutamente ignorare cos’è e cosa è stato tecnicamente il Mose nel suo divenire. Ed è sulla base di questa per alcuni versi morbosa attenzione verso l’operato della Magistratura che rimane sullo sfondo o addirittura scompare la contrarietà motivata a questa opera, alla sua natura, alla sua struttura, alla sua funzionalità; sembra quasi che un destino ineludibile debba far portare a compimento questa opera datata così com’è stata voluta dai progettisti e da coloro che l’hanno approvata.
Tutto procede senza ripensamenti: il rigore scientifico, il “cogito ergo sum “, l’eustatismo incipiente che cancellerà definitivamente quest’opera non ”rientrano” nello stato di avanzamento dei lavori.
Così sulla questione del Mose si continua a ignorare o fraintendere quanti interventi possibili ed alternativi alle bocche si potrebbero realizzare fin da subito evitando così il perseverare di azioni il cui effetto peggiorerebbe i vari livelli di criticità dell’opera con ricadute negative sull’equilibrio lagunare , sulla portualità e sui bilanci pubblici.
Nell’ambito degli interventi per la difesa di Venezia dalle acque alte, va applicata una linea di azione (costruita sulla base di una modellistica matematica - modelli bidimensionali a fondo fisso e mobile - applicata all’idrodinamica ed alla morfodinamica lagunare il cui riferimento scientifico rimane la scuola idraulica padovana –dipartimento di ingegneria idraulica, marittima, ambientale e geotecnica) che dimostra:
- che si può operare alle bocche di porto con la riduzione parziale delle sezioni attraverso il rialzo dei fondali e l’inserimento di opere di restringimento trasversali sia fisse che removibili stagionalmente in modo da aumentare le resistenze al flusso delle correnti di marea con una significativa riduzione dei livelli marini in laguna rispetto al mare;
- che si può ottenere con una riduzione permanente degli attuali scambi mare-laguna un migliore regime idraulico della laguna permettendo fra l’altro di contrastare la perdita sistematica di sedimenti attraverso le bocche, ultimo anello dei drammatici processi erosivi in atto che stanno devastando la morfologia lagunare
- che va separata la logica degli interventi delle acque medio-alte da quelle necessarie per la difesa dalle acque alte eccezionali
-che va ridotta la penalizzazione della portualità veneziana attraverso la differenziazione delle funzioni portuali delle tre bocche, con la chiusura parziale dei varchi mobili per le acque medio-alte e con la chiusura totale per le sole acque alte eccezionali
-che si può così impiegare il tempo necessario per perfezionare e sviluppare i metodi di difesa più idonei, anche a più vasta scala territoriale, conseguenti ai cambiamenti climatici prevedibili (interventi di iniezioni di fluidi su strati geologici profondi volti al sollevamento antropico).
L’immediato l’inserimento di opere removibili stagionalmente ha il vantaggio di permettere di operare sulle bocche di porto con due diversi gradi di restringimento: meno spinto nel periodo estivo, quando in linea di principio è auspicabile un maggiore scambio tra mare e laguna, più spinto nel periodo tardo autunnale ed invernale durante il quale le acque alte si presentano con maggiore frequenza e un meno vivace ricambio delle acque è più sopportabile dalla laguna.
Per quanto riguarda poi quelle strutture che provvederanno alla chiusura dei varchi mobili vanno individuate quelle soluzioni tecnologiche (per esempio pontoni sommergibili removibili con paratoie a gravità) che escludano quei fenomeni legati alla risonanza ed alla instabilità dinamica che le paratoie del Mose presentano e che ancora oggi incomprensibilmente si evita di verificare.
Questi interventi rappresentano una una prima fase che consente una forte riduzione dei colmi di marea, in particolare per quanto attiene a quelli medio-alti che sono quelli che si verificano con maggiore frequenza in città, il che ha anche l’effetto, fondamentale, di fornire il tempo necessario per perfezionare e sviluppare in una seconda fase i metodi di difesa più idonei, anche a più vasta scale territoriale, conseguenti ai cambiamenti climatici prevedibili.
Tutto ciò rappresenta una radicale variante del progetto Mose, di fatto un suo abbandono. Ed il nuovo onere finanziario da sostenere, pur beneficiando di un drastico abbattimento degli alti costi di manutenzione e gestione che la struttura del Mose impone e di un parziale recupero di materiali già esistenti e messi in opera per il Mose, deve prendere atto della perdita di danaro speso per tutti quegli interventi che non possono a nessun titolo venir recuperati e che sono figli di una sciagurata impostazione progettuale avvalorata da un regime malavitoso.
Qualora si insista nel proseguimento dell’opera senza tener conto delle criticità denunciate , e dal momento che la sua non funzionalità si potrà constatare solo in futuro ad opera ultimata, bisogna prefigurare un danno erariale a fecondità ripetuta mettendo sotto sequestro cautelativo il patrimonio di tutti quei soggetti, politici e tecnici, che con la loro firma su specifici documenti ( documentazione depositata dal Comune di Venezia presso tutte le istituzioni interessate all’iter procedimentale del Mose ) hanno contribuito a far sì che il Presidente del Consiglio Prodi e parte del suo governo respingessero le proposte alternative indicate dal Comune di Venezia nel 2006 ( che sviluppano peraltro concetti scientifici propri del “Progettone” del 1981 a cui fanno seguito autorevoli pareri del Consiglio Superiore dei LL.PP. degli anni successivi o della Valutazione di Impatto Ambientale del 1998), il cui impianto ancora oggi può verosimilmente rappresentare soluzioni più funzionali, anche per il riequilibrio lagunare oltre che per la portualità, con un’ottica di diminuire drasticamente gli alti costi di manutenzione e gestione del Mose e di una maggiore consapevolezza dell’evoluzione dell’aumento dei livelli del mare.
Tutto questo però non può sfuggire alla domanda che tanti si pongono: ma vale la pena bloccare i lavori di un’opera che sta volgendo al termine e che è già costata quasi 6000 milioni di euro?
Una legittima domanda a cui ne potrebbe far seguito un’altra: ma vale la pena, anche in nome di un rigore scientifico che ha sempre caratterizzato le azioni della salvaguardia, voler ultimare un’opera che si sa già che non raggiungerà gli obiettivi per cui è stata concepita e che comporterà ingenti oneri di manutenzione e gestione nei prossimi 100 anni (tanto è il tempo di vita previsto dell’opera) che graveranno peraltro sul nostro debito pubblico? Ultimare un’opera sbagliata, che si sa sbagliata per la conoscenza di critiche fondate e documentate, rappresenta in uno stato di diritto un altro delitto punibile.
Ed ancora: a fronte di uno scenario di riscaldamento globale con l’innalzamento dei livelli marini in Adriatico in base alle previsioni del 4° Rapporto IPCC presentato alla Conferenza sui cambiamenti climatici di Parigi del 1° dicembre 2015 perché insistere come una sorta di accanimento terapeutico sul proseguimento di un’opera che i valori di quello stesso Rapporto mettono già all’indice?
Il riscatto dello scandalo Mose può passare solo attraverso il riconoscimento degli errori commessi, la sua sostanziale messa in discussione progettuale e con la rivincita-affermazione di quel sapere scientifico indipendente che la storia malavitosa della “grande opera” ha volutamente respinto ed ignorato.
Un giusto riconoscimento alle mobilitazioni ed a quella Assemblea Permanente NO MOSE che aveva coniato l’indovinato slogan “ Il Mose: un’opera utile solo a chi la fa”
Armando Danella per l’ Associazione Ambiente Venezia - gennaio 2018
___________________________________________________________
Scheda sintetica
Un’opera sbagliata che è stata approvata e ha potuto evolversi avvalendosi di un sistema corruttivo diffuso e ramificato, come è stato accertato dalle indagini della Magistratura del 2013 e 2014.
Il sistema MoSE è :
- inutile perché esistevano ed esistono efficienti alternative,
- pericoloso come dimostrano gli studi di “Principia” sul rischio di tenuta delle paratoie in particolari condizioni di mare, (pericolo di collasso),
- dannoso e incompatibile con il sistema lagunare e le attività portuali per le previsioni sul numero delle chiusure e sui danni alle attività portuali e sull’aumento dei livelli di inquinamento delle acque lagunari.
Numerosi sono gli incidenti, le anomalie, i danni, che si sono verificati in questi anni e che mostrano i molti punti critici del progetto che erano già stati evidenziati e segnalati nel documento della Commissione Tecnica VIA che il 10 dicembre 1998 esprimeva un parere di compatibilità ambientale negativo, che bocciava il progetto MoSE.
Bisogna bloccare i lavori del MoSE, con varianti in corso d’opera, riconvertendo le opere marittime realizzate, attraverso soluzioni progettuali delle bocche sperimentali, graduali e reversibili.
Se il drammatico trend di aumento del livello medio marino risultasse confermato non c’è progetto alle bocche di porto e in laguna che tenga!
Bisognerebbe chiudere le paratie quasi tutti i giorni (due volte al giorno d’inverno). Quindi per la riduzione dei livelli di marea in Laguna vanno:
-ridotte le profondità dei fondali alle bocche di porto- posti pennelli traversali alle bocche per ridurre ulteriormente la portata idraulica- eseguito ilcurvamento dei tratti terminali dei moli e scogliere a mare di fronte alle bocche per ridurre l'onda montante da vento di scirocco
postilla
Nell’Eddytoriale 174 abbiamo raccontato la storia vergognosa del MoSE, degli errori clamorosi chefurono compiuti nella scelta di quella soluzione, delle ragioni perverse percui altre soluzioni, migliori da tutti i punti di vista, furono scartate, delgigantesco edificio corruttivo che ha permesso di realizzarsi. E deicosti che la collettività aveva pagato e avrebbe continuato a pagare per un’operache giù allora appariva inutile e dannosa. Armando Danella riprende e completala narrazione della triste vicenda. La arricchisce con un suggerimento checondividiamo pienamente, e che qui riprendiamo testualmente:
Un'occasione d'oro per tentare di dare ordine, vivibilità e tutela delle qualità naturali e storiche del territorio e delle comunità che lo abitano. Ma si impegneranno su questo terreno le forze alternative ai «poteri forti dell’avidità speculativa e della sopraffazione»?
Com’è noto, la “legge Delrio”, la n. 56 del 2014, ha modificato radicalmente consistenza e procedure di formazione degli organi elettivi delle province, sostituendo queste ultime, per gli ambiti dei 9 più grandi capoluoghi regionali, con un nuovo ente, denominato appunto “città metropolitana”.
Esso è amministrato ope legis dal sindaco del capoluogo con l’ausilio di un consiglio metropolitano eletto fra di loro, con voto ponderato in relazione alla dimensione demografica dei comuni, dai soli sindaci e consiglieri comunali dell’ambito coincidente con il territorio della preesistente provincia. Una rappresentanza indiretta di questo genere determina una straordinaria debolezza politica del nuovo ente, percepito come lontano dagli interessi sociali dei territori e percorso da accordi feudali fra i partiti. La legge ammette il passaggio ad un ente con organi eletti direttamente a suffragio universale subordinandolo però a condizioni non facilmente conseguibili, quali la suddivisione del territorio metropolitano in “zone omogenee”, definita d’intesa con la regione, e quella del territorio comunale del capoluogo in municipalità, le une e le altre dotate di significative autonomie amministrative. A valle del conseguimento di tali condizioni, sarà poi necessaria l’approvazione di un’apposita legge elettorale statale.
A Napoli lo statuto metropolitano è stato approvato dalla conferenza metropolitana (l’assemblea di tutti i sindaci), su proposta del consiglio metropolitano, con qualche ritardo, solo al termine della primavera 2015. In aderenza alle indicazioni della legge Delrio, esso considera centrale per l’ente e le sue attività il “piano strategico” triennale (da aggiornarsi annualmente), con il quale deve rapportarsi, fra gli altri strumenti, il “piano territoriale metropolitano”, articolato in una componente strutturale, valida a tempo indeterminato, ed una operativa, di validità triennale.
A quasi tre anni di distanza dall’approvazione dello statuto, a conferma dei limiti politici del nuovo ente, le attività per la formulazione del piano strategico stentano ancora ad avviarsi, mentre si presenta meno arduo il percorso relativo al piano territoriale. Quello ora pubblicato, infatti, è in sostanza il piano territoriale di coordinamento proposto nel 2008 e aggiornato nel 2014 dalla provincia di Napoli. La città metropolitana aveva già deciso di adottarlo con delibere del sindaco metropolitano del gennaio e dell’aprile 2017, che avevano incontrato reazioni contrastanti dei comuni e delle forze sociali. Va sottolineato, innanzitutto, che la legge regionale sul governo del territorio, la 16/2004, cui sono state apportate più volte modifiche parziali, non è stata adeguata in merito, ragion per cui non sono ancora formalmente definiti né i contenuti del piano territoriale metropolitano né le procedure per la sua approvazione. In riferimento a tale situazione di incertezza giuridica, gli atti della città metropolitana dichiarano con chiarezza la volontà di interpretare l’iniziativa in corso come l’avvio di un percorso “ponte” verso il futuro strumento di governo territoriale.
La coincidenza temporale con la campagna elettorale per il parlamento nazionale non sta, tuttavia, facilitando il dibattito sul piano, pressoché ignorato dagli organi di informazione e considerato finora assai poco anche dalle amministrazioni comunali. Ed è una circostanza negativa perché esso può indubbiamente costituire un utile base di partenza, dal momento che la sua impostazione denota adeguata consapevolezza della complessità delle questioni con cui misurarsi e della necessità di un approccio strategico olistico e integrato. Le sue opzioni fondamentali mirano infatti ad intrecciare fra loro:
- la tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale come scelta strategica per un diverso sviluppo, liberato dalle mistificazioni della crescita quantitativa e basato sulla valorizzazione economico-sociale delle qualità identitarie, intese prima di tutto come fattori di benessere per le comunità insediate;
- il drastico contenimento del consumo di suolo, non consentendo le tradizionali espansioni urbane su territori agricoli, ma solo calibrate densificazioni insediative di aree già parzialmente urbanizzate o edificate con basse densità edilizie, e promovendo invece l’alleggerimento demografico degli ambiti vesuviano e flegreo a più elevato rischio vulcanico;
- il superamento degli squilibri fra il distretto centrale del capoluogo e i territori periferici dell’hinterland in direzione di una riorganizzazione policentrica e reticolare del sistema urbano verso “una città di città”, basata sulla riqualificazione ambientale, sulla complementarità funzionale e sull’integrazione socio-culturale di tutti gli aggregati insediativi;
- il perseguimento di un sistema intermodale di mobilità che valorizzi il trasporto collettivo e riduca il traffico automobilistico privato, integrando inoltre le reti di trasporto in modo da temperare l’antica polarizzazione radiocentrica sul capoluogo con nuove connessioni dirette fra i settori esterni dell’area metropolitana;
- la protezione e la riqualificazione paesaggistico-ambientale dei territori agricoli, tutelati anche per la loro elevata produttività, innervandoli inoltre mediante una adeguata rete di corridoi ecologici agganciati al sistema dei parchi (parco naturale nazionale del Vesuvio; parchi naturali regionali dei Campi Flegrei, dei Camaldoli, del Partenio, dei Monti Lattari e del fiume Sarno; parco agricolo dei Regi Lagni);
- la qualificazione polisettoriale delle attività produttive puntando su energie rinnovabili, tecnologie avanzate e interdipendenze settoriali, nel cui contesto ruolo prioritario viene riconosciuto alla rigenerazione urbana.
È evidente che l’anticipazione di fatto, rispetto al piano strategico, di uno strumento urbanistico così connotato determinerebbe qualche garanzia in più circa la sostenibilità delle prossime politiche di sviluppo. Diventa perciò decisiva, ora, la questione delle modalità di costruzione del piano strategico, soprattutto in rapporto alla necessità di coinvolgimento autentico, oltre che delle istituzioni elettive, anche di tutte le forme sociali di autorappresentazione e di tutti i soggetti che stanno animando le numerosissime vertenze dal basso oggi in atto, specie per la difesa dei beni comuni e il recupero sociale di immobili e spazi abbandonati o violati. Il confronto dovrà insomma assicurare non solo l’efficacia dell’elaborazione, ma anche una sua più sostanziale democraticità.
il Fatto Quotidiano, 26 gennaio 2018. il drammatico e cruento incidente ferroviario, derivante dalla decisione di privatizzare le periferie e di privilegiare le linee redditizie risparmiando su quelle di lavoratori, studenti, casalinghe
La tratta è gestita da Trenord, società partecipata da Ferrovie nord Milano, tra i cui soci c’è la Regione Lombardia. Mentre la rete, ovvero i binari, sono in carico a Rfi. Attualmente risulta indagato per disastro colposo il responsabile della sicurezza di Rfi, mentre i vertici di Fnm ieri sera sono stati convocati in Prefettura. L’attenzione è massima nell’attribuire le varie responsabilità.
Secondo le ricostruzioni della Polfer e dei tecnici di Rfi a provocare l’incidente sono state due cause coincidenti. Da un lato il pezzo di rotaia che tecnicamente viene definito un giunto isolato e incollato. Dall’altro uno (e uno solo) dei carrelli con le ruote che è uscito dal suo alloggiamento. È chiaro che al netto delle cause ancora da attribuire l’incidente è provocato comunque da una mancata manutenzione. Nel momento in cui il carrello si sposta, il treno sta viaggiando a 140 chilometri orari. Il macchinista frenerà fino a 70, l’impatto avviene a questa velocità. A guardare bene il percorso si comprende che il deragliamento riguarda solo quel carrello che fa inclinare il convoglio. Un’inclinazione che però non viene segnalata al macchinista. Questi treni, infatti, non sono dotati di allarmi specifici. C’è dunque da capire se quel pezzo di rotaia fosse già rotto oppure se sia stato il carrello già staccato a romperlo.
Su questa tratta, da Bergamo a Milano, passano ogni giorno 500 treni. Mentre i giunti sono posti ogni 1.350 metri. Stando a quanto emerge dalle prime indagini solitamente la rottura di un giunto viene rilevata dal macchinista che comunica il guasto. A quanto risulta, però, su quel particolare giunto non vi era stata nei giorni scorsi alcuna segnalazione. L’ipotesi, dunque, è che si sia rotto ore o minuti prima dell’impatto. Sul tratto in questi giorni alcune rotaie dovevano essere sostituite. Allo stato, quindi, le responsabilità sono attribuibili in ipotesi a metà tra Trenord e Rfi, anche perché di mezzo ci sono risarcimenti importanti. Nei prossimi giorni la Procura eseguirà una perizia tecnica sul giunto e sul treno posto sotto sequestro. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha già disposto il sequestro della scatola nera e dei registri della manutenzione del treno.
Camminando ieri pomeriggio sulla massicciata erano evidenti i tagli sulle traversine e oltre le rotaie. Secondo qualche addetto, però, appare difficile pensare che un treno, che ha vagoni da 40 tonnellate l’uno, possa deragliare su un avvallamento di 23 centimetri. Più probabile, ma resta una ipotesi, che il carrello staccatosi con gli urti alla fine abbia provocato lo schianto finale.
Il convoglio comunque ha viaggiato per tre chilometri fuori dalle rotaie, tranciando qualsiasi cosa, dai cavi alle traversine e scaraventando ai lati i sassi. Tanto che i testimoni hanno parlato di una sorta di “sassaiola”. Quando è passato nella stazione di Limito di Pioltello ha divelto le grate di acciaio vicine alle banchine. Le prime immagini sequestrate dalla Procura mostrano il treno passare per la stazione facendo delle scintille (a causa dello sfregamento contro il muro di cemento) mentre un uomo osserva terrorizzato. In quel momento le carrozze sono già pericolosamente inclinate verso sinistra e cioè verso la massicciata. Poco più di un chilometro dopo, il carrello salta via definitivamente, tanto da essere ritrovato intero accanto ai binari. In tarda serata si contano tre morti e 47 feriti, di cui cinque gravi.
Internazionale, 22 gennaio 2018. Un'altro esempio, meno famoso dell'Ilva, dell'incapacità di tenere insieme lavoro e qualità ambientale. Tra promesse e disattese continua il disprezzo per la difesa dell'ambiente e della salute di lavoratori e cittadini. (i.b)
La montagna offre invece l’accoglienza delle osmice, osmize, piccoli ristori a conduzione familiare dove il proprietario, e solo in certi mesi, offre i prodotti della sua terra, dal vino al formaggio, ai salumi. Niente scontrini e un’atmosfera di frontiera che si percepisce già nel nome sloveno.
L’arrivo in città è un’ennesima sorpresa: ignorando i pochi mostri dell’edilizia più recente e tralasciando quel che si trova dietro i muri che nascondono la ferrovia e il vecchio porto, i primi palazzi otto-novecenteschi del capoluogo guidano il visitatore fino al lungomare, annunciato dalle rive – i canali che portano il mare fin dentro la città – e poi dal molo Audace, una lunga e antica gettata di cemento, costruita sul relitto di una nave affondata nel 1740, che si protende nel golfo come se la città si proiettasse in mare.
Il rovescio della medaglia
Come tutte le cartoline e tutte le medaglie, anche Trieste ha però il suo rovescio. Ma chi capita in città potrebbe non accorgersene, soprattutto se ci resta tre o quattro giorni, abbastanza per vedere musei e palazzi e aggirarsi tra osmize e ristorantini dove fanno pescetti fritti o sardoni in savòr (alici marinate). Tutto è ben nascosto sotto il tappeto del salotto buono di piazza Unità.
Se con l’auto si percorre il lungomare per tornare a prendere l’autostrada verso est, cioè verso Lubiana, fatto qualche chilometro che costeggia il porto nuovo e un esteso polo della logistica che un tempo era appannaggio di Fincantieri, si è proiettati in una sorta di inferno industriale. Mentre il cavalcavia sale all’altezza dei piani più alti degli edifici sulla sinistra, sul lato destro appare una sorta di mostro ferroso male in arnese da cui escono fumi e vapori dall’aria minacciosa.
Complice la posizione e il vento, i fumi prodotti dall’impianto industriale di Servola, un’acciaieria che qui chiamano ferriera, restano tutti ben nascosti dietro la curva, un vero e proprio spartiacque tra una città paradisiaca e un inferno dantesco.
L’acciaieria di Trieste, assai meno nota della sorella tarantina, non ha nemmeno quel piccolo braccio di mare che a Taranto divide l’impianto dalla città. La ferriera qui è circondata da tre piccoli nuclei urbani cresciuti nel tempo fino ad accogliere trentamila persone, quasi un sesto della popolazione della città.
Scarica i suoi fumi e i suoi vapori sulle case piccole e grandi della periferia, sugli asili, sui rari parchetti, su finestre e balconi e, ovviamente, nel sangue e negli alveoli polmonari di chi abita o lavora da quelle parti. Così tanti fumi e veleni che i parchi pubblici sono stati chiusi per un periodo perché troppo inquinati; e 83 operai sarebbero morti a causa di tumori, dal 2000 al 2013.
Storia di un ex gioiello
La ferriera ha una storia antica come antichi sono i tentativi, sia dei cittadini sia delle amministrazioni pubbliche, di affrontare il problema dell’inquinamento. Lo stabilimento si estende su un’area di più di 500mila metri quadri con cokeria, due altiforni, l’impianto di agglomerazione e la macchina a colare per la solidificazione della ghisa.
Nata nel 1896, in origine è il fiore all’occhiello di un’azienda di Lubiana. È di proprietà austroungarica, ma negli anni venti diventa italiana. All’inizio la affitta un gruppo locale, ma poi la assimila l’Ilva. Negli anni ottanta la acquista il gruppo Pittini, poi Lucchini. Ma la ferriera è sempre un problema: rimodernarla costa e la siderurgia perde pezzi in tutto l’occidente.
Agli imprenditori si alternano i commissari, poi nel 2015 arriva Giovanni Arvedi: cremonese, cattolico, imprenditore cresciuto in una famiglia di commercianti di acciaio. Rileva l’impianto e si impegna a mettere le cose a posto. Il primo punto dell’accordo è che l’area a caldo (quella che inquina di più) venga chiusa se non scenderanno i livelli di benzo(a)pirene, un idrocarburo cancerogeno, cosa che Arvedi rivendica di aver fatto.
Le proteste
Tutto a posto? Secondo Legambiente no, perché il benzo(a)pirene non è l’unico inquinante. Le associazioni di cittadini lamentano la scarsa trasparenza: NoSmog, storica organizzazione ambientalista di Servola, denuncia l’assenza di centraline di monitoraggio e stima che chi vive vicino alla ferriera sia esposto a livelli di benzo(a)pirene e polveri Pm10 che superano i limiti massimi sostenibili.
La federazione Gilda-Unams chiede conto di un aumento di patologie oncologiche e spiegazioni sul fatto che agli alunni sia stato impedito l’accesso al giardino della scuola. I più arrabbiati, del comitato 5 dicembre, hanno organizzato un lunghissimo presidio in città.
Sono preoccupati anche gli operai, sebbene tra loro ci sia chi difende l’impianto per paura di perdere il lavoro. In uno studio dell’azienda sanitaria locale, fatto per conto della procura della repubblica di Trieste, risulta che tra il 1995 e il 2007, chi di loro ha lavorato alla ferriera, si è ammalato di tumore molto di più rispetto alla media della popolazione locale.
“Finora è stato trattato e spesso percepito come un problema di polvere sui davanzali. In effetti, potrebbe essere qualcosa di peggio, soprattutto per chi ci lavora”, ha detto il sostituto procuratore di Trieste Federico Frezza durante un’audizione alla camera nel giugno 2016.
Ma la ferriera sembra un muro di gomma. Il piano di copertura del parco minerale (una massa di polvere compatta che si allunga in mare e che svolazza nell’aria) va a rilento, le centraline di monitoraggio sono insufficienti, la trasparenza e la ricerca sui dati dei veleni sono scarse.
Arvedi dal canto suo ha gettato il guanto di sfida minacciando di chiudere la fabbrica. Il suo piano di scalata all’Ilva di Taranto, che gli avrebbe permesso in teoria di chiudere l’area a caldo di Servola, è rimasto un sogno. La ferriera resta un nervo scoperto.
Il sindaco
Tra gli interessi dell’industriale e la salute delle persone c’è di mezzo l’amministrazione pubblica, con un comune e una regione governati rispettivamente da un sindaco di destra, Roberto Dipiazza, e una governatrice di sinistra, Debora Serracchiani.
Dipiazza è un signore dall’aria simpatica e rassicurante: giacca blu e cravatta regimental su pantaloni di vigogna, scarpa Oxford liscia e lucida. Piace alle signore bene di Trieste, ma ha fatto razzia di voti anche nel quartiere operaio di Servola. Il suo asso nella manica è stato proprio la ferriera. Aveva infatti promesso di chiudere in cento giorni l’area a caldo. Promessa per altro ciclica, che ritorna a ogni tornata elettorale. Adesso i cento giorni sono diventati sei mesi.
Ricollocare almeno 300 operai, uno dei grandi temi sindacali che hanno sempre salvato l’impianto che ne impiega circa 600, non è più un problema. “Sono appena tornato da Roma con 18 milioni”, spiega il sindaco, “e altri 65 ne arriveranno dagli austriaci che vogliono investire a Trieste, e poi ci sono i cinesi”.
Già, i cinesi. Vorrebbero fare della città un hub della nuova via della seta e inoltre, dice Dipiazza, “è chiaro che i lavori pesanti di un’acciaieria li faranno loro a prezzi più bassi. Non servirà più produrre ghisa: la compriamo in Cina e la lavoriamo a Trieste”. Cinesi o no, la chiusura dell’area a caldo e la revisione dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) sono le richieste che ambientalisti, cittadini e associazioni continuano a fare.
L’area a caldo della ferriera è dunque da sempre anche l’area a caldo della politica triestina, come si sente dire qui. Ma secondo qualcuno è solo un gioco di parole che serve a tener buoni i residenti e a pescare voti. Sia nel cuore della città, ricco e diviso tra conservatori e progressisti; sia in periferia, tra gli operai che questa volta hanno premiato la destra.
“Del resto”, dice una componente di un’associazione ambientalista che preferisce rimanere anonima, “di chi possiamo fidarci? Tutti promettono la chiusura dell’area a caldo ma nessuno lo fa. Dipiazza ha già fatto due mandati e niente. Poi c’è stato un sindaco del Partito democratico, Roberto Cosolini, e niente. Vediamo se stavolta Dipiazza sarà di parola. Al momento non abbiamo altra scelta”.
La regione
Alla regione la pensano diversamente. La scelta c’è, eccome. E riguarda, ancora una volta, la Cina. Il consigliere Giulio Lauri, un geologo prestato alla politica, elenca i segnali positivi che negli ultimi anni hanno cambiato il porto vecchio, una struttura gigantesca affacciata sul mare all’inizio della città.
In completa rovina e ormai inservibile, è un’area di capannoni dismessi e una discarica a cielo aperto di traversine ferroviarie, vecchie pavimentazioni urbane, masserizie e gatti selvatici, tutto nascosto da una fitta palizzata di cemento e rampicanti. Bloccato da una gestione conservatrice – per anni nelle mani di Marina Monassi, allora presidente dell’Autorità portuale – dal 2015 il porto vecchio ha voltato pagina: con il passaggio dal demanio statale al comune di Trieste, una parte è stata assorbita dal porto nuovo, ed è stata resa più efficiente.
“Tanto efficiente”, spiega Lauri, “che i cinesi hanno capito che la nostra città è la punta più a nord dove far arrivare le merci nel cuore del vecchio continente, con un risparmio di almeno tre giorni di viaggio rispetto ai porti dell’Europa occidentale. Il traffico del porto nuovo è già cresciuto, perché abbiamo snellito procedure e cercato alleanze”.
“Questa”, conclude Lauri, “non è più la città del no se pol”, alludendo a un’espressione locale usata per opporsi alle novità. Insomma, da porto fermo a porto franco, con più merci e più lavoro. “Ma c’è altro. Il turismo è in aumento, così come le attività culturali, e la città sta consolidando il suo polo scientifico e tecnologico, il più grande d’Italia”.
Lauri fa riferimento anche a quel che dovrebbe essere la Città della scienza 2020, un progetto che prevede la trasformazione di parte del porto vecchio, la costruzione di cinque auditorium e sale convegni, l’organizzazione di esposizioni, mostre, nuovi uffici, e la nascita di centri di ricerca e istituti nazionali e internazionali. Se ne fa un gran parlare, in città, e molti attendono che la data arrivi per sapere se sarà stata una scommessa vinta o un’altra promessa.
Intanto, lasciandosi alle spalle Servola, un certo senso di malessere rimane nelle ossa. E resta la domanda sul futuro delle persone che ci vivono e su quello di Trieste: industriale, postindustriale, hub logistico, polo tecnologico o meta turistica e culturale? In attesa delle risposte, dei cinesi, dei sei mesi per chiudere l’area a caldo, il vecchio mostro continua a sbuffare i suoi fumi sulla città, adombrando la sua immagine da cartolina.
Testo tratto dal'Internazionale, qui raggiungibile in originale
Unavalutazione fortemente critica del modo in cui la camera dei deputati intendevaaffrontare il problema delle periferie, vitale per la città d'oggi. Che deciderà il Parlamento cheeleggeremo il 4 marzo? con postilla
postilla
Le propostedi intervento per restituire umanità e vivibilità alle periferie, puntualmentecriticate da Sergio Brenna, sono di fatto decadute con lo scioglimento delParlamento e l’indizione delle elezioni del nuovo Parlamento. Ma restano unaeredità “culturale” alla quale sarà difficile sottrarsi se non si avranno leidee chiare sul cosa fare. Per assicurare un’effettiva soluzione del problema drammaticodelle periferie e soprattutto dei loro abitanti, occorrerà seguire un percorsoradicalmente diverso.
Questo percorso dovrà iniziare con le elezioni del 4 marzo, portando inParlamento persone che conoscano dall’interno le condizioni di vita delleperiferie, persone competenti sulle questioni dell’abitazione, della città edel territorio, persone non coinvoltecon le politiche in materia che hanno dominato fino a oggi nel parlamento e nel governo:politiche orientate a difendere e agevolare l’abbandono della pianificazione el’aumento dell’affarismo immobiliare, a promuovere e accrescere “la città dellarendit”a, non a costruire, come è necessario e possibile, “la città deicittadini”.
casadellacultura.it, 19 gennaio 2018. Recensione al nuovo rapporto Ecomafia, che annualmente riporta i reati ambientali accertati e le connivenza tra illeciti ambientali, mafia e politica. L'efficacia punitiva migliora, ma con la prevenzione c'è ancora molto da fare.
Puntuale come ogni anno è stato pubblicato dalle Edizioni Ambiente il rapporto Ecomafia 2017. Le storie e i numeri della criminalità ambientale, curato dall'Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente.
Il rapporto Ecomafia, dunque, ha il merito di tentare una descrizione dettagliata ed anche una quantificazione del fenomeno di questo intreccio tra criminalità e devastazione ambientale. È d'obbligo precisare che, sia nel titolo che nel testo, il termine "mafia" è usato in modo estensivo, sta per criminalità e non si limita ai reati contemplati dall'articolo 416 bis del codice penale come criminalità organizzata di stampo mafioso. Questa distinzione ha sicuramente un rilievo importante nei tribunali, meno per identificare quell'intreccio perverso che precipita nei cosiddetti "ecoreati". La particolare propensione criminale in campo ambientale nel nostro Paese ha peraltro diverse cause che occorre rammentare: pesa il fatto che la nostra sorprendente scalata nella graduatoria dei principali Paesi industriali del mondo, fino al quinto posto, avvenuta nel secondo dopoguerra, ha goduto del vantaggio competitivo di disporre a titolo gratuito delle risorse ambientali (suolo, acqua, aria); da qui è discesa una strutturale inadeguatezza delle normative di tutela, fino al recente Sblocca Italia; va ricordato, a titolo d'esempio, che il reato ambientale è stato inserito nel codice penale solo nel 2015; in ogni caso la struttura istituzionale dei controlli, in particolare il sistema Ispra e Arpa, è molto carente e, spesso, condizionata dalla politica; infine, a questo quadro oggettivamente critico va associato il retaggio del tradizionale costume degli italiani, il diffuso "familismo amorale" che si traduce nel disinteresse per ciò che è al di fuori del perimetro della famiglia e della propria dimora e proprietà, la disponibilità corruttiva in nome del particulare e la conseguente noncuranza per l'ambiente naturale e per la casa comune, l'oikos, appunto.
Non possono quindi stupirci più di tanto i dati del rapporto predisposto da Legambiente. Nel 2016 i reati ambientali accertati delle forze dell'ordine e dalla Capitaneria di porto hanno toccato il ragguardevole numero di 25.889, pari a una media di 71 al giorno, circa 3 ogni ora. A questi corrispondono 225 arresti, 28.818 denunce e 7.277 sequestri. Il fatturato delle ecomafie è valutato attorno a 13 miliardi, in netta diminuzione rispetto ai 22 miliardi del 2014, a testimoniare una sempre maggiore efficacia dell'azione investigativa e repressiva. Vengono inoltre evidenziati il fenomeno della corruzione, che continua a dilagare in tutta la Penisola con ben 76 inchieste in cui le attività illecite in campo ambientale si sono intrecciate con vicende corruttive, la questione dell'abusivismo edilizio con 17mila nuovi immobili abusivi nel 2016, il ciclo illegale dei rifiuti in crescita con 5.722 reati contestati (+ 12%), il fronte incendi segnato da 4.635 roghi che hanno mandato in fumo 27mila ettari. Per quanto riguarda la distribuzione geografica le quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso si confermano ancora ai primi posti nella classifica per numero di illeciti ambientali: in vetta la Campania con 3.728 illeciti, davanti a Sicilia (3.084), Puglia (2.339) e Calabria (2.303). La Liguria resta la prima regione del Nord, il Lazio quella del Centro. Su scala provinciale, quella di Napoli è stabilmente la più colpita con 1.361 infrazioni, seguita da Salerno (963), Roma (820), Cosenza (816) e Palermo (811). Il rapporto 2017, comunque, segnala un trend positivo, sia per la diminuzione del numero dei reati, sia per la maggior efficacia delle sanzioni, che potrebbe essere ascrivibile ai primi effetti dell'introduzione delle legge che punisce i reati ambientali. Questi, infatti, mentre erano 29.293 nel 2014, sono scesi a 27.745 nel 2015 e a 25.889 nel 2016. Cresce, invece, il numero degli arresti 225 (contro i 188 del 2015), di denunce 28.818 (a fronte delle 24.623 della precedente edizione di Ecomafia) e di sequestri 7.277 (nel 2015 erano stati 7.055).
Nella parte finale del testo, Legambiente indica opportunamente gli ulteriori interventi necessari a rendere ancor più incisiva l'azione repressiva. Alcune riflessioni, tuttavia, si possono aggiungere. Indubbiamente colpire i responsabili di reati ambientali è importante, anche agli effetti preventivi: forse si comincia a percepire che non sempre si può farla franca. Ma occorre ricordare che l'azione penale arriva sempre a posteriori, quando il disastro è stato compiuto e spesso, per le caratteristiche intrinseche dell'inquinamento ambientale, gli effetti nefasti sono irreversibili. Non solo. L'azione penale incontra difficoltà oggettive: molto spesso gli effetti sull'ambiente e sulla salute dei cittadini indotti dall'inquinamento si scoprono molti anni dopo l'evento che li ha provocati e dunque la prescrizione è spesso in agguato. D'altro canto, in particolare per i danni alla salute, dimostrare il nesso di causalità, che nel penale ad oggi è di tipo individuale, risulta estremamente difficile. Va inoltre considerata la difficoltà strutturale del sistema giustizia nel nostro Paese, che dopo la stagione eccezionale di "Mani pulite" e del maxiprocesso alla Mafia, sembra regredire nell'alveo rassicurante di una grande cautela nei confronti del potere, economico e politico. Sembra, insomma riemergere la logica, appunto, di un "Sistema", nell'accezione che la storia del nostro Paese ha ampiamente sperimentato e da cui tuttora è attraversato: la "chiesa istituzione", il regime fascista, la "democrazia bloccata" del secondo dopoguerra, la mafia, la corruzione politica…
Ogni "sistema" per perseguire i propri fini ha bisogno di "vittime sacrificali" che vanno accettate in nome di interessi superiori. E per questo è del tutto illusorio e impensabile che un simile "sistema" sia in grado di autogiudicarsi ed autocondannarsi in modo radicale: le vittime dell'inquisizione di ieri e della pedofilia ecclesiastica di oggi attendono ancora giustizia; i criminali fascisti, sfuggiti ad un tribunale "altro" come quello di Norimberga, hanno goduto di un "salutare" colpo di spugna; le stragi per "bloccare" la democrazia restano in gran parte impunite; oggi sembra "impossibile" estirpare le mafie e la corruzione politica. Paradossalmente, tra l'altro, è proprio "l'intermediazione della vittima" che rende forte il "Sistema" (J.-P. Dupui, Per un catastrofismo illuminato, 2011). Cosicché, la mancata giustizia viene "compensata" celebrando le vittime, monumentalizzandole. Nei casi dei grandi ecoreati in gran parte impuniti (per tutti, il caso dell'amianto) il "sistema" è il capitalismo industriale italiano, così come si è costruito nel corso del Novecento. Una sorta di "supersistema", perché animato dalla "superideologia" dello sviluppo (Pier Paolo Poggio), comune a tutte le ideologie novecentesche (liberaldemocratica, fascista, comunista). La legittimazione di quell'immane scempio compiuto in Italia tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta, opera ancora in profondità, è un dato strutturale dell'industrializzazione italiana ancora oggi. Perché il "supersistema" in versione italiana, in generale, salvo poche eccezioni, rimane un gigante con i piedi di argilla, ancora oggi dipendente dalle quelle condizioni che ne determinarono le fortune nel secondo dopoguerra: bassi salari; energia importata a basso costo grazie all'Eni di Mattei; imitazione creativa delle innovazioni altrui senza dover sviluppare in proprio costose strutture di ricerca; risorse ambientali concesse a titolo gratuito e senza alcun vincolo. Nella congiuntura attuale e nel contesto di una globalizzazione senza regole, emerge con ogni evidenza la sua strutturale fragilità: quelle condizioni di un tempo si incontrano oggi molto più vantaggiose in tante regioni del mondo, mentre l'energia fossile non ce la regala più nessuno. E l'Italia manifatturiera, in molti settori, arranca, inevitabilmente.
Dunque, può il nostro "supersistema", in queste condizioni di grande difficoltà, fare i conti con i disastri ambientali che ne hanno determinato le fortune? No, anzi, il "supersistema" chiede alla politica, se possibile, un ulteriore balzo in avanti nell'illusione che si possano ricreare oggi le condizioni di un nuovo "miracolo economico", "riagganciandoci", finalmente, alla mitica "crescita". La ricetta è semplice: mortificare ancor più il sindacato e i diritti dei lavoratori per deprimerne le pretese salariali; rilanciare la ricerca di idrocarburi sul territorio nazionale e nei nostri mari in spregio alla loro naturale fragilità; destinare le poche risorse pubbliche, non all'unica grande opera necessaria di manutenzione e risanamento del territorio disastrato del Paese, ma a benefici fiscali per le imprese distribuiti a pioggia, dunque qualitativamente inefficaci; "sbloccare" grandi opere inutili, rimuovendo per l'ennesima volta l'intralcio dei vincoli ambientali (Sblocca Italia).
La mancata giustizia per i disastri ambientali del passato è quindi coerente con la cultura e la politica attuali, sostanzialmente dominate dalla logica totalitaria del "supersistema". Si tratta della versione italiana di una sorta di "oscurantismo progressista. Un oscurantismo di cui il 'negazionismo' degli assassini della memoria dei campi non era altro che un segno premonitore", e che consiste nel "non prendere in conto i danni di un progresso tecnico crescente, senza limiti e senza alcun freno" (P. Virilio, L'università del disastro, 2008). A quasi 80 anni dalla Shoah, in particolare noi italiani ci ritroviamo ancora con molti conti in sospeso per le nostre responsabilità in quella catastrofe. Sconfiggere il "negazionismo" del "supersistema" è dunque un'impresa improba e di lunga lena. Ed è un'impresa che non può essere, a mio parere, delegata alla magistratura. Un cambio di mentalità e la prevenzione sono fondamentali e possono camminare solo su due gambe. Da un canto la mobilitazione partecipata e consapevole delle popolazioni sul territorio per contrastarne il degrado e per salvaguardane la bellezza e l'integrità. E bisogna constatare che, a questo livello, si registra una nuova effervescenza, fioriscono a migliaia i comitati, i gruppi spontanei, le associazioni di cittadini attenti a quello che accade nei loro territori. Insomma, sembra che quel tradizionale costume italico "menefreghista" cominci ad essere scalfito, in parte superato, in particolare tra i giovani. Dall'altro, però è imprescindibile che si determini negli indirizzi del governo della cosa pubblica, dal livello centrale a quello locale, quella svolta paradigmatica, quella conversione ecologica dell'economia e della società che non è più rinviabile e in cui il nostro Paese mostra ritardi inaccettabili, anche rispetto al resto dell'Europa. E qui le cose non vanno bene.
È impressionante come, anche di fronte ad allarmi sempre più evidenti, come la spaventosa siccità della scorsa estate, si reagisca solo con interventi emergenziali, senza por mano a un progetto strategico di fuoriuscita, già ora tecnicamente possibile, dalla civiltà termoindustriale basata sui combustibili fossili per avviarci verso la civiltà solare. Insomma, come a proposito della corruzione, anche dell'ambiente non devono occuparsi solo le Procure, ma innanzitutto una politica profondamente rinnovata, emancipata dalla subalternità al "supersitema" e dal giogo degli interessi immediati, in certi casi persino personali, e capace di riconquistare il proprio ruolo di guida lungimirante della comunità.
Avvenire, 18 gennaio 2018. Prosegue la lottacontro un attentato al paesaggio e alla stabilito geologica dell'intera dorsale appenninica. vedi riferimenti in calce
«Salento, il cantiere contestato: ora la contesa è sull'applicazione del protocollo Seveso per il rischio di incidente rilevante. Ma tutti aspettano l'esito delle urne»
Gli otto chilometri «più lunghi del mondo » iniziano in località San Basilio, nel Comune di Melendugno, e arrivano alla Masseria del Capitano. Siamo in Salento, nel cantiere più discusso d’Italia, il 'cantiere No Tap' recita beffardamente una scritta all’ingresso dell’area presidiata da militari e forze dell’ordine. Gli otto chilometri non si vedranno a occhio nudo, perché saranno interamente realizzati sotto terra; per adesso, a vigilare sul progetto ci sono 40 persone tra ingegneri e operai e il cuore delle operazioni è rappresentato dalle attività di scavo del pozzo di spinta del microtunnel, che procederà in direzione del mare. A mezzo chilometro da qui c’è la spiaggia di San Foca, un piccolo gioiello difeso a spada tratta da ambientalisti e abitanti del posto.
L’impressione è che nei prossimi due anni (il traguardo per il completamento dell’opera è fissato nel primo trimestre 2020) il consorzio di imprese nato con l’obiettivo di portare nel nostro Paese il gas proveniente dall’Azerbaigian, attraverso Georgia, Turchia, Grecia e Albania, dovrà sudarsela, la realizzazione dell’opera. Conquistarsela metro dopo metro, giorno dopo giorno, superando veti, denunce e qualche intimidazione. Troppo alta è l’ostilità della comunità locale, sedimentata in anni di lotte ed equivoci, troppo evidente la distanza tra le parti, troppo diversa la prospettiva in cui due mondi paralleli si muovono.
 |
| Ulivi espiantati dal percorso del gasdotto |
Nelle stesse ore in cui la squadra guidata dall’ingegnere Gabriele Lanza, project manager di Tap per l’Italia, coordina gru, camion e macchine per il movimento terra, un gruppo di sindaci concorda a pochi chilometri di distanza, nel centro di Lizzanello, le contromosse per bloccare tutto. «Il mare e la spiaggia di San Foca sono il nostro presente e saranno il nostro futuro. Cosa diremmo sennò ai nostri figli? Che abbiamo tradito la terra in cui siamo cresciuti noi da piccoli?», dice il primo cittadino Fulvio Pedone. Con lui ci sono tra gli altri Marco Potì, sindaco di Melendugno, e Fabio Tarantino, che guida il Comune di Martano, da sempre in prima linea nel fronte 'no Tap'. L’alleato dell’ultim’ora (anche se il corteggiamento dura da tempo) si chiama Michele Emiliano, governatore della Puglia, con cui «si è deciso di fare un pezzo di strada insieme», in nome della totale contrarietà al gasdotto.
I terreni di battaglia sono tanti e tali da far risultare impossibile qualsiasi mediazione, si parli di impatto ambientale o di sicurezza, di condivisione delle scelte con la popolazione, di investimenti e possibili compensazioni per il territorio. La vera contesa adesso è sulla normativa Seveso: va applicato o no all’impianto che sorgerà il protocollo di regole sul rischio di incidente rilevante? Tap dice di no, partendo da una serie di sentenze della magistratura favorevoli all’azienda, e ricordando che la questione riguarda «un impianto di ricezione e misurazione fiscale» del gas immesso, non assoggettabile a criteri di pericolosità. Non un conglomerato industriale, non una piccola Porto Marghera, per intenderci.
Va valutata la qualità dell’impianto, secondo il consorzio, non la quantità di gas che in esso transiterà, come vorrebbero invece i detrattori, secondo cui la differenza potrà essere fatta dai numeri: oltre le 50 tonnellate la direttiva Seveso entra in vigore e Tap ha dichiarato che a regime il quantitativo di metano trattato si fermerà a quota 48,6. Cosa succederebbe, si chiedono però i comitati, se nel computo finale dovesse rientrare anche l’impianto interconnesso della Snam, cui toccherà in un secondo momento collegare il gasdotto con la rete nazionale di distribuzione, a partire da Brindisi? La magistratura si sta muovendo e una decisione è attesa a giorni.
 |
| Protesta dei sindaci "no Tap |
In realtà, mentre i lavori nel cantiere procedono secondo la tabella di marcia, il territorio è convinto di avere un asso nella manica: il voto del 4 marzo, con la possibile sconfitta del Pd e dell’attuale maggioranza di governo. Il centrodestra e la strana coppia Cinque Stelle-Liberi e Uguali (che qui vuol dire soprattutto Massimo D’Alema) stanno catturando facili consensi tra i 'no Tap'. «A Lecce noi sindaci abbiamo detto che sfideremo chiunque si candiderà a rappresentarci a Roma, a dire pubblicamente cosa pensa dell’opera». L’azienda per ora osserva con distacco: il traguardo più importante, al momento, è un altro. È lontano 'solo' otto chilometri.
Riferimenti
Alla mega grande opera, che scasserà l'Appennino dal Salento alle Alpi, vedi su eddyburg l'articolo di Ilaria Boniburini: La favola dell'energia pulita e gli affari sporchi dei padroni del TAP
Salviamo il paesaggio, 8 gennaio 2018. Decine di ex soprintendenti e di cattedratici importanti smentiscono Franceschini: dov’è precipitata la tutela? (c.m.c)
La situazione di caos e di paralisi creata dalla “riforma” Franceschini separando la valorizzazione (nel senso di monetizzazione) dalla tutela e privilegiando la prima a discapito della seconda passa praticamente sotto silenzio – con pochissime lodevoli eccezioni – nella stampa e nella televisione nazionale.
Ciò è grave in sé. Ma è anche dovuto al fatto che i soprintendenti e gli altri tecnici della tutela non possono assolutamente fare dichiarazioni, denunciare lo stato di confusione fra Soprintendenze, Poli Museali e Fondazioni di diritto privato, di depotenziamento strutturale, di esasperata burocratizzazione in cui versano gli organismi e gli uffici che per oltre un secolo hanno operato per difendere dalle aggressioni speculative, dall’abbandono, dall’incuria il patrimonio storico-artistico-paesaggistico.
Tocca quindi a noi – in luogo dei tecnici imbavagliati e minacciati di sanzioni – denunciare pubblicamente la gravità di una situazione in cui ministro e Ministero continuano a magnificare conquiste straordinarie, mentre la spesa statale per la cultura rimane una delle più basse d’Europa, un terzo di quella francese, metà di quella spagnola, e i suoi recenti relativi incrementi, beninteso rispetto al minimo dello 0,19 % del bilancio statale toccato nel 2011 (governo Berlusconi IV) rispetto al 39 % del 2000 (governo Amato II), vengono indirizzati su obiettivi futili o sbagliati.
Ad esempio, si investono ben 18 milioni di euro nell’arena Colosseo per chissà quali spettacoli gladiatorii (dopo la farsa grottesca dell’ opera rock “Divo Nerone” sul Palatino) e si lascia agonizzare, senza mezzi né personale, lo strepitoso parco archeologico dell’Appia Antica o si istituisce un biglietto d’ingresso al Pantheon per poterne curare la manutenzione.
Si organizzano gare di canottaggio nella vasca della Reggia di Caserta o si propagandano al suo interno prodotti tipici della zona e intanto la vasca risulta ingombra di rifiuti e l’intonaco cade a pezzi in una sala importante.
Mentre, tanto per corroborare i vantati incrementi degli ingressi, si organizza al grande Museo Archeologico Nazionale di Napoli una mostra sul Napoli Calcio con magliette, ricordi e gadget di Maradona.
Non si tiene in alcun conto il pesante conflitto di interessi sancito dall’Autorità Nazionale Anti-Corruzione per un concorso tecnico-scientifico a Pompei, creando così un grave precedente. Si declama ad ogni passo la Bellezza dei paesaggi italiani, sempre più aggrediti da speculatori e abusivi, e per contro si lascia che la stragrande maggioranza delle regioni (17 su 20) non predisponga, d’intesa col Ministero, e poi approvi, i Piani paesaggistici previsti dal Codice per il Paesaggio del 2007. Nel contempo si tace sul tentativo dissennato – stornato per questa legislatura dalle opposizioni – di svuotare la legge Cederna-Ceruti n. 394/91 sulle aree protette (il 12 % ormai del territorio nazionale, montano soprattutto, con 23 Parchi Nazionali rispetto ai 4 ante 1991) anziché aggiornarla al Codice per il Paesaggio e applicarla seriamente.
A colpire è la strategia di fondo del MiBACT: da una parte si trasferisce dagli stessi Poli museali a fondazioni di diritto privato la valorizzazione sempre più commerciale del patrimonio e dall’altra si prospetta con la legge Madia la sottomissione delle Soprintendenze, decisamente indebolite, ad un organo di governo locale come la Prefettura. Una offensiva, antistorica scemenza.
Le denunce sullo stato penoso della tutela piovono ormai da tutta Italia e quindi il nostro elenco potrebbe continuare a lungo. Ci fermiamo qui per chiedere con forza ai partiti, al futuro Parlamento che questa deriva disastrosa venga fermata e ai media di ogni genere di cominciare almeno ad indagarla, a raccontarla seriamente – non limitandosi alle cifre di facciata, sempre più discutibili – ridando voce alle più collaudate competenze tecnico-scientifiche.
A questo punto la rete dissestata della tutela va letteralmente ricostruita. con la scelta strategica di far di nuovo prevalere l’interesse pubblico sugli appetiti privati, premiando i capaci e meritevoli, riempiendo i vuoti negli organici dei beni culturali, evitando la chiusura per “vecchiezza” di archivi e biblioteche dove l’età media del personale supera i 60-65 anni e i trentenni rappresentano lo 0,6-1,6 % degli addetti.
Il Ministero per i Beni Culturali non può, non deve diventare il Ministero del Turismo (attività chiaramente indotta dal patrimonio culturale e paesaggistico), né si possono sottomettere ai Prefetti le Soprintendenze. Un autentico oltraggio alla tradizione ammirevole dei nostri studi e degli interventi di restauro e di recupero sul territorio e un continuo danno inferto agli stessi interessi del Paese. Per il quale la cultura e la ricerca, in sé e per sé, cioè senza finalità economiche immediate, scolpite nell’articolo 9 della Costituzione, rappresentano il motore fondamentale.
Adriano La Regina, già soprintendente Archeologia Roma, Accademico dei Lincei
Francesco D’Andria, professore emerito di Archeologia greca e romana, Università del Salento
Andrea Emiliani, già Soprintendente ai Beni storici e artistici Bologna, Ferrara e Romagna, Accademico dei Lincei
Mario Torelli, già docente a Perugia di Archeologia, Accademico dei Lincei
Desideria Pasolini dall’Onda, fondatrice di Italia Nostra nazionale
Licia Vlad Borrelli, archeologo, già Istituto Centrale del Restauro
Giorgio Nebbia, ambientalista, professore emerito Università di Bari
Fausto Zevi, già Soprintendente archeologico Napoli e Caserta e docente alla Sapienza, Accademico dei Lincei
Pietro Giovanni Guzzo, archeologo, già Soprintendente in Puglia e a Pompei, Accademico dei Lincei
Maria Luisa Polichetti, già direttrice del Catalogo centrale e Soprintendente ai Beni architettonici delle Marche
Jadranka Bentini, già Soprintendente ai Beni storici e artistici di Bologna, Ferrara e Romagna, presidente di Italia Nostra a Bologna
Germana Aprato, già Soprintendente ai Beni Architettonici dell’Umbria
Lucia Fornari Schianchi, già Soprintendente ai Beni Storici e Artistici di Parma e Piacenza
Antonio De Siena, già Soprintendente archeologico della Basilicata
Anna Gallina Zevi, già Soprintendente archeologico ad Ostia Antica
Elio Garzillo, già Soprintendente ai Beni architettonici di Bologna e regione
Gianfranco Amendola, ex magistrato, docente di Diritto Ambientale
Carlo Alberto Graziani, già presidente del Parco Nazionale dei Sibillini e ordinario di Diritto Civile a Siena e Camerino
Valerio Magrelli, poeta, ordinario di Letteratura francese all’Università di Cassino
Bruno Toscano, professore emerito di Storia dell’arte Roma Tre
Ebe Giacometti, presidente Italia Nostra Lazio, delegata ai Parchi
Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, presidente emerito Corte di Cassazione
Claudio Meloni, coordinatore nazionale della FpCgil del MiBACT
Andrea Camilli, responsabile Assotecnici del MiBACT
Maria Teresa Filieri, già direttore dei Musei Nazionali di Lucca
Gianni Venturi, già ordinario di Letteratura italiana all’Università di Firenze
Paolo Liverani, archeologo, ordinario all’Università di Firenze
Sandro Lovari, professore emerito di Ecologia, Università di Siena
Carlo Alberto Pinelli, professore al Suor Orsola Benincasa di Napoli, presidente di Mountains Wilderness
Lucia Lepore, archeologa della Magna Grecia, già docente a Firenze
Carlo Pavolini, archeologo, già docente Università della Tuscia
Giovanni Losavio, magistrato, già presidente nazionale di Italia Nostra, ora della sezione di Modena
Vezio De Lucia, urbanista
Pier Luigi Cervellati, architetto e urbanista
Bernardino Osio, ambasciatore
Orio Ciferri, genetista, fondatore del primo corso interdipartimentale sui beni culturali a Pavia
Giorgio Boscagli, Gruppo dei 30 per i Parchi, già direttore Parco Nazionale Foreste Casentinesi
Katia Mannino, associato di archeologia classica, Università del Salento
Francesco Pardi, studioso del paesaggio, “Liberacittadinanza”
Luciana Prati, già direttrice Musei Civici e Biblioteca comunale Forlì
Francesca Valli, storica dell’arte, già coordinatrice delle raccolte storiche Accademia di Brera
Lucinia Speciale, storica dell’arte, Università del Salento
Francesco Mezzatesta, fondatore della LIPU, naturalista, coordinatore Gruppo dei 30 per i Parchi
Corrado Stajano, giornalista scrittore
Paolo Maddalena, giurista, già giudice della Corte Costituzionale
Benedetta Origo, presidente Comitato per la Val d’Orcia
Stefano Deliperi, presidente Gruppo di intervento giuridico Onlus, Cagliari
Maurizio Chierici, giornalista scrittore
Salvatore Bragantini, economista, editorialista
Gianandrea Piccioli, consulente editoriale
Fernando Ferrigno, giornalista tv e scrittore di Beni culturali
Ugo Mattei, professore di Diritto civile e dell’Ambiente, Università di Torino
Alberto Abrami, già ordinario di Diritto Forestale e Ambientale, Università di Firenze
Simona Agostini, ricercatrice Urbanistica, Università di Bologna
Andrea Buzzoni, già dirigente Ferrara Arte e delle Attività culturali del Comune, Ferrara
Luisa Bonesio, già associato di Estetica Università di Pavia, direttore dei Musei dei Sanatori di Sondalo (Sondrio)
Alessandro Gogna, alpinista, storico dell’alpinismo
Simona Rinaldi, Università della Tuscia
Pino Coscetta, giornalista scrittore
Luisella Battaglia, Istituto italiano di Bioetica
Matteo Righetto, scrittore, comitato scientifico Mountains Wilderness
Italo Sciuto, professore di Filosofia Morale, Università di Verona
Stefano Sylos Labini, ricercatore scientifico ed economista
Tomaso Montanari, ordinario di storia dell’arte moderna, Università Federico II Napoli e presidente di Libertà e Giustizia
Maria Pia Guermandi, archeologa, responsabile progetti europei sul patrimonio culturale
Natalia Piombino, docente Syracuse University Florence
Gaia Pallottino, coordinatrice Comitato residente città storica, Roma
Cristiana Mancinelli Scotti, Forum Salviamo il paesaggio
Angelo Maria Ardovino, già soprintendente archeologico di Milano, Salerno, Campobasso
Fabio Grasso, giornalista, storico dell’arte
Franca Arduini, già dirigente biblioteche MiBACT
Giovanni Solimine, ordinario di Biblioteconomia Università La Sapienza e già componente (dimissionario) del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici
Linda Giuva, Professore Associato di Archivistica, Università La Sapienza, Roma
Irene Berlingò, ex Soprintendente ABAP Cosenza
Aglia Englen, storica dell’arte in pensione
Elena Lattanzi, gia’ Soprintendente ai Beni archeologici della Calabria
Elisabetta Mangani, già direttore archeologo del MiBACT
Giuseppina Cerulli Irelli già Soprintendente Archeologo
Cecilia Ghibaudi già funzionario Soprintendenza Beni Storici e Artistici di Milano
Gabriella Pescatori già Funzionario del MIBACT
Giovanna Nepi Sciré già soprintendente al Polo Museale Veneziano
Adriano Maggiani, Archeologo, già professore ordinario di Etruscologia e archeologia italica all’Università Ca’ Foscari di Venezia
Rosalba Antonini, docente emerita Università degli Studi di Urbino
Gianfranco Madori, già Sindaco di Perugia e Professore Ord. nell’Università di Perugia
Enzo Marzo, presidente Fondazione Critica Liberale
Anna Maria Amonaci, docente di storia dell’arte e di fotografia all’Accademia di Brera
Andreina Draghi, storica dell’arte medievale
Nicola Cimini già direttore del Parco Naz. della Maiella, Gruppo dei 30
Vittorio Emiliani, giornalista e scrittore Beni culturali
Un'analisi ineccepibile, e riccamente documentata nel testo integrale dell'articolo (allegato in .pdf), della tragedia che sta distruggendo Venezia, come altri luoghi-simbolo di una civiltà che va scomparendo. Con riferimenti
1. Grandi Navi a Venezia: la corsa all'oroL'evoluzione economica del porto di Venezia si inserisce nel panorama più ampio delle trasformazioni urbane iniziate nel secondo decennio del Novecento, che hanno condotto alla progressiva delocalizzazione delle attività produttive in terraferma e alla conversione ad uso turistico e culturale della città storica insulare. È infatti in seguito all'espansione dei traffici portuali a Porto Marghera a partire dagli anni '60 che la Stazione Marittima entra in una prolungata fase di crisi, in cui si rende necessaria una ridefinizione del suo ruolo in rapporto alla città. Essa vede progressivamente ridursi il traffico commerciale, dal 50% del totale negli anni Sessanta, al 40% del 1970, al 22% del 1975, in parallelo all'emergere delle strutture ricettive destinate al traffico passeggeri come possibile nuova funzione per il porto.
Nel momento in cui il turismo crocieristico diventa di massa, grazie all'introduzione delle fun ships a basso costo, e punta ad espandersi nel Mediterraneo per diversificare la propria offerta, Venezia dispone quindi di un immaginario turistico consolidato e di uno spazio acqueo in pesante deficit da ricapitalizzare con urgenza. Il connubio non potrebbe essere migliore ed Alessandro di Ciò, presidente del Porto di Venezia dal 1986 al 1993, non tarda ad abbracciare il crocierismo come destino dell'intera area della Marittima.
Alla fondazione nel 1997 della società privata a partecipazione pubblica VTP S.p.A., incaricata di "gestire ed incrementare il traffico passeggeri", seguirà più di un decennio di lavori infrastrutturali volti all'ampliamento di banchine e servizi necessari ad ospitare l'ormeggio dei giganti del mare. I risultati sono immediati: in questo breve lasso di tempo Venezia diventa il nono porto crocieristico nel Mondo, il terzo in Europa ed il primo home port italiano, con una crescita complessiva del 436% ed un aumento annuale medio dei crocieristi tra 2005 e 2016 del 6,7%.
Nonostante l'emergere di istanze critiche nei confronti di tale sviluppo già dai primi tempi, lo sforzo di ampliamento della Marittima prosegue senza sosta, con la celebrata inaugurazione del teminal Isonzo 1 nel 2009 ed Isonzo 2 nel 2011, verso l'obiettivo dichiarato dei 2,5 milioni di crocieristi in transito all'anno, cifra stimata come limite massimo dell'offerta. Anno dopo anno, il crocierismo lagunare diviene così un business più ampio, il cui indotto si estende nell'intero Alto Adriatico e la cui legittimità pare tautologicamente asserita dalla propria stessa potenza economica.
Un momento di arresto simbolico si ha nel 2012 con il naufragio della Costa Concordia e la promulgazione del Decreto Clini-Passera, che vieta il passaggio in Bacino di San Marco e nel canale della Giudecca alle navi di stazza lorda superiore alle 40.000 tonnellate. Il provvedimento, sorto sull'onda emotiva per affrontare solamente la parte più evidente del problema delle Grandi Navi in Laguna, ovvero il transito all'interno della città storica, rinvia però la propria applicazione al momento in cui sarà trovato e realizzato un percorso d'ingresso alternativo. Nel confuso rimpallo di proposte, stalli, progetti e ricorsi che ne consegue, la provvisorietà diventa definitiva e, in attesa di una decisione univoca, nel 2015 le compagnie di crociera scelgono di posizionare a Venezia solo unità fino a 96.000 tonnellate.
A pochi anni dalla privatizzazione dell'aereoporto Marco Polo, si assiste quindi al consolidamento di un grande polo privato che gestisce l'accesso navale e aereo alla città. Un'abdicazione del settore pubblico ai compiti pianificatori e direttivi che ha prodotto "un porto crocieristico estraneo alla città, anche se costruito con capitale pubblico. Un porto basato su una enclave extraterritoriale (le navi), gestito in regime di monopolio da compagnie di navigazione straniere, che hanno interesse a fare apparire pochi profitti in loco, trasferirli all'estero, con una corsa al ribasso dei costi ed un'alta precarizzazione dei rapporti di lavoro" (Tattara).
2. L'impatto sulla città
Esiste però una componente ulteriore dell'impatto del crocierismo sulla città sulla cui centralità per la realtà urbana si tende a sorvolare: l'impatto antropico. Normalmente, infatti, la discussione politica e mediatica si impernia sull'urgenza di vietare il transito nel Bacino di San Marco oppure sulla necessità di allontanare il terminal crocieristico dal cuore della città, decentrandone una parte a Porto Marghera o costruendo una piattaforma off-shore. Entrambe le posizioni, tuttavia, lasciano irrisolto un problema di fondo, che riguarda non tanto la nave in sé, quanto la sua estensione umana, ovvero la quantità e la tipologia di turisti che essa riversa in una città già drammaticamente desertificata dal modello estrattivista promosso dalla monocultura turistica.
3. L'impatto antropico
3.1. Il legame con l'escursionismo
Nonostante i crocieristi rappresentino solo una piccola quantità percentuale del turismo cittadino, essi possiedono una serie di caratteristiche che rendono la loro presenza particolarmente problematica.
Innanzitutto la triplice stagionalità: essi non sono equamente ripartiti durante l'anno, ma si concentrano nei mesi di massima pressione turistica (da Maggio a Settembre), nei fine settimana (in certe giornate scendono dalle navi anche 44.000 persone) e nelle ore di massimo afflusso.
In secondo luogo, sulla base del tempo trascorso in città, essi si configurano per lo più come escursionisti. Tale categoria, oltre al limitato apporto economico che la caratterizza, risulta a causa dei suoi numeri la principale responsabile dell'eccessiva pressione turistica cittadina e a causa delle sue modalità di fruizione dello spazio (necessariamente rapide e di superficie) svantaggiosa per il tessuto urbano e per la comunità locale, in un duplice senso. Dal punto di vista quantitativo, essa genera una presenza concentrata e di massa all'interno di un itinerario specifico in determinate fasce orarie, producendo fenomeni acuti di congestione ed una notevole riduzione di mobilità per gli altri fruitori urbani. Dallo studio condotto da Quinn risulta chiaramente come sia proprio la limitazione della percorribilità individuale nel tempo e nello spazio a costituire per i Veneziani l'aspetto più critico della convivenza con il turismo. Non è un caso che i recenti cortei di protesta abbiano scelto itinerari e orari tipicamente turistici, in una simbolica ripresa di possesso di luoghi e tempi di norma evitati, per rivendicare così proprio a partire dallo spazio, dalla calle, il loro diritto alla città.
Dal punto di vista qualitativo, invece, l'escursionismo genera una proliferazione di esercizi specifici (fast food, take-away, banchetti, negozi di souvenirs a basso costo...) lungo i percorsi di transito, riconfigurando l'intero tessuto commerciale in virtù della propria alta redditività, con un rialzo dei prezzi di affitto degli spazi ed una progressiva desertificazione delle aree marginali. Un processo di esponenziale squilibrio che alza il livello di competizione e costringe i negozi di prossimità destinati ai residenti a traferirsi o cessare l'attività. Questo riduce la qualità complessiva tanto della città "da abitare" quanto della città "turistica", impoverendo la specificità culturale del luogo che via via si omologa al modello di una Disneyland globale.
Come dimostrato da Russo, si entra così nel circolo vizioso dello sviluppo turistico, dove è proprio l'aumento incontrollato dei day-trippers ad accelerare il declino della destinazione nel suo ciclo vitale, facendo lievitare i costi di gestione e mantenimento del sito e crollare il livello di qualità percepita. Un enorme costo economico e sociale cui corrisponde uno scadimento progressivo della tipologia turistica richiamata: una città configurata per soddisfare le esigenze degli escursionisti, infatti, sarà necessariamente meno attrattiva per un pubblico colto, più attento e curioso, più selettivo in acquisti ed attività, di media o lunga permanenza.
In altre parole, sommandosi nei momenti di maggiore afflusso agli escursionisti cittadini, i crocieristi costituiscono tanto una criticità fisica tangibile, quanto, e forse più profondamente, un autentico catalizzatore di cambiamento culturale.
3.2 La Grande Nave come segno
Progressivamente, infatti, le navi da crociera si sono strutturate come vere e proprie città galleggianti, modellando il proprio interno con piazze, viali, ristoranti, boutiques. Come appare evidente nelle réclames e dalle dichiarazioni delle compagnie crocieristiche, è la nave a costituire ormai la vera destinazione. Essa acquista dunque una peculiare autosufficienza, che si traduce in un rapporto sempre più mediato e gerarchizzato tanto con il mare, quanto con i contesti di ormeggio.
L'intera semiosi della nave è costruita intorno ad un'insuperabile verticalità: fin dal suo ingresso in Laguna essa domina completamente il paesaggio, oscurando alla vista interi quartieri e destrutturando il senso topografico della città storica, nel suo caratterizzante equilibrio di forme e proporzioni e nel suo tipico sviluppo orizzontale. Una presenza che rappresenta qualcosa di ben più profondo di una semplice "puzzetta sotto il naso" di "chi dice che sono brutte da vedere", come sostiene l'attuale presidente dell'Autorità Portuale, Pino Musolino. Si tratta piuttosto di un atto che afferma, nella stessa possibilità del suo accadere, un enorme differenziale di potere, non solo economico, ma anche simbolico: la nave annichilisce la città che la ospita, riducendola a mero spazio scenografico, a oggetto rimpicciolito di uno sguardo a distanza in cui l'alterità di Venezia è svilita quale sfondo pittoresco e l'incontro con la sua realtà è per essenza negato. E forse è proprio la costruzione di tale sguardo dall'alto a valere il transito: più della méta finale, più delle facilities portuali, la fonte maggioritaria di plusvalore è l'offerta ai passeggeri di questa visione di dominio, l'ebbrezza di scorrere nelle viscere di un ecosistema antico e delicato come un petalo senza doverne apprendere il linguaggio, senza doversi misurare con la sua complessità. Che poi, detta con le parole di Galliano di Marco, CEO di VTP, significa poter accogliere i passeggeri "in the living room of Venice", anziché "welcoming them in the toilet (sic)", cioè Marghera.
Con la traccia di questo segno, l'estrazione del capitale simbolico e culturale della città è esasperata al punto da coincidere con la licenza di minacciarne la stessa esistenza. Un rischio che, del resto, le compagnie possono correre, data la disponibilità di un portafoglio amplissimo e diversificato di destinazioni cui volgersi in alternativa.
3.3. L'habitus del crocierista
Tali caratteristiche trovano un'ulteriore concretizzazione nelle modalità di visita del luogo cui i passeggeri vengono indirizzati. Secondo la logica del pacchetto che qualifica il crocierismo, l'esperienza a terra è infatti fortemente mediata dalla compagnia di navigazione. Le escursioni si svolgono in gruppi guidati di numero variabile, hanno una durata ridotta (che va mediamente dalle 2 alle 6 ore) e seguono itinerari prefissati. Se, data la sua conformazione urbana, la mobilità di gruppo rappresenta di per sé un fattore altamente problematico per la città di Venezia, la rapidità di fruizione e la convergenza di una grande quantità di gruppi in immediata successione nelle medesime zone aggravano ulteriormente l'impatto fisico dei crocieristi sulla popolazione e sul patrimonio storico-artistico. Per ottimizzare i tempi, inoltre, i passeggeri vengono movimentati tramite mezzi acquei privati (lancioni), trasferiti dalla Marittima a Piazza San Marco, spesso tradotti in una carovana di gondole, infine condotti a Murano e Burano e ritorno, generando un moto ondoso costante ed imponente che mette a rischio la sicurezza delle altre forme di navigazione lagunare ed aumenta il livello - già critico – di usura delle fondamenta veneziane.
È chiaro che, a partire da una simile strutturazione della visita, il grado di autonomia del crocierista nello spazio urbano è, se non del tutto assente, quanto meno fortemente limitato. Difficilmente egli riuscirà ad interagire realmente con il luogo e con i suoi abitanti, ad uscire dalla dimensione di gruppo e dai gusci nautici in cui progressivamente si situa, a costruire una propria esperienza aldilà delle veloci indicazioni della guida. Si tratta perciò di una forma di attraversamento che tende a restituirgli solo un surrogato della città e finisce per privarlo del senso stesso del viaggio: incontrare l'altro, entrare in dialogo con la diversità, affrontare l'imprevisto. Nell'escursione crocieristica le distanze sono infatti rigorosamente mantenute, così in nave come in terra, ed i locali tendono a ridursi a mere figure esotiche in un teatrino. Una modalità di consumo dei luoghi di stampo fordista, tarata sul criterio di massima prevedibilità e ripetitività, che, oltre ad espropriare le comunità ospiti del controllo sulla propria rappresentazione, riplasma lo spazio urbano come semplice scenario, drenandovi ogni significato culturale e sociale profondo e costruendo un mondo-sequenza: una serie di scene in successione prive di ordine interno significante, avulse da quel tessuto connettivo che qualifica l'urbano in sé, ed il veneziano in particolare.
In conclusione, anche quando è fuori dalla nave il crocierista finisce per muoversi in una "tourist bubble" che ne è la complementare estensione. A sua volta la terra toccata, anziché costituire la destinazione del viaggio, è investita da un progressivo processo di integrazione all'interno della nave, ovvero indotta a conformarsi plasticamente alle esigenze del modello disneyano di turismo che essa propugna. Non è una semplice coincidenza che il progetto più marcatamente "tematico" degli ultimi anni, la Veniceland di Antonio Zamperla, fosse pensato proprio per il pubblico delle Grandi Navi: tra la modalità di fruizione di una destinazione che caratterizza il crocierismo e la visita ad un parco dei divertimenti esiste una continuità tutt'altro che trascurabile. Chissà se allora anche ai Veneziani, come ai servitori di bordo e ai Disney-figuranti, sarà chiesto un giorno di sorridere, e porgere la mano.
3. Conclusioni
Se il turismo generato dalle Grandi Navi non può essere ritenuto il solo responsabile della difficile situazione in cui versa la città di Venezia, esso risulta tuttavia la più impattante tra le molte forme di viaggio e visita al momento possibili, ovvero quella dotata di maggiori esternalità negative per la popolazione residente. Infatti, all'ampio e documentato insieme di conseguenze di natura ambientale ed idromorfologica prodotte dal mezzo di trasporto in sé, si sommano la pressione antropica indotta dalle sue prassi escursionistiche (nella duplice modalità, pedestre e ondosa, del moto generato) e l'influenza dequalificante sul tessuto commerciale e culturale urbano.
Come dimostrato da Tattara, nessun'analisi del classico tipo costi/benefici può dunque essere applicata sensatamente alle Grandi Navi, dal momento che solo una parte della diade è calcolabile nel breve termine, mentre l'altra, i costi per la comunità, ha una natura molteplice, in parte immateriale, che solo nel lungo periodo può emergere statisticamente. I danni alla salute dei cittadini, alla struttura edilizia fondante, al patrimonio storico-culturale non riproducibile, lo stress quotidiano dei residenti, lo scadimento esponenziale della qualità della vita e dello spazio urbano, l'abbandono della città non sempre si toccano con mano, ma, come particelle elementari, esistono e determinano la possibilità di sussistenza del (e nel) luogo, il suo destino.
Per questo motivo le soluzioni di compromesso avanzate finora paiono insoddisfacenti: anche nel momento in cui venisse parzialmente mitigato (o semplicemente dislocato) l'effetto ambientale, infatti, l'impatto antropico del crocierismo continuerebbe a gravare sulla città, sia da un punto di vista fisico che antropologico-culturale, e, una volta venuti meno anche i residui limiti dimensionali, ancora più difficile sarebbe arginarne la crescita. In una fase in cui la necessità di contenere la pressione turistica, specialmente degli escursionisti, è divenuta una priorità riconosciuta per la città storica, quando non addirittura la condizione della sua sopravvivenza, il sistema-crociera risulta di fatto insostenibile, tanto on-shore quanto off-shore: il modello di fruizione urbana che esso genera è infatti per sua natura incompatibile con la città lagunare.
Ciononostante, il business delle crociere continua a godere di un appoggio pressoché incondizionato da parte delle istituzioni locali e nazionali, in conformità con il riflesso pavloviano del Paese a rispondere alla profonda crisi economica ed industriale con la manna dello "sviluppo turistico", dimenticando che, "in realtà, l'industria più pesante [...] del XXI secolo è proprio il turismo" (D'Eramo).
Parallelamente il pensiero critico che proviene dalla società civile, lasciato ai margini dal processo decisionale e dal suo balletto di competenze, si trova nella scomoda posizione in cui Günther Anders collocava il filosofo rispetto alle innovazioni tecniche: sempre costretto a dare "la precedenza a qualsivoglia apparecchio", ad essere "ritardatario". Infatti, laddove la discussione si sviluppa nel confine circoscritto delle modalità d'uso di una data tecno-struttura introdotta tramite processi top-down, alla comunità viene sottratta la possibilità di esprimersi anteriormente sulla sua stessa opportunità e desiderabilità. A comitati, associazioni e studiosi spetta pertanto l'ingrato compito di dimostrare solamente ex-post la nocività ed i costi di un dato mezzo e del modello economico che esso incarna, nella frequente ostilità di organi istituzionali ed attori economici coinvolti.
C'è un'immagine che forse, più d'ogni altra, riassume la distanza incommensurabile che intercorre tra questa componente critica dei Veneziani ed il dispositivo integrato dell'economia neoliberista che ne sta minacciando il presente, oltre che il futuro. Sono centinaia di persone lungo la riva delle Zattere che urlano in coro "Fuori le navi dalla laguna", fischiano, battono e con quanta voce hanno in gola tentano di far arrivare il loro messaggio alle navi in transito. Lassù, sul ponte, nell'aria afosa della sera, la band di bordo intona le prime note, il presentatore si lancia nei lazzi consueti ed i passeggeri, assiepati lungo i bordi, si godono divertiti e ammirati il paesaggio. Puntini in movimento, fumo colorato, flebili voci sfumate nel tramonto...uno spettacolo che carezza dolcemente la loro partenza e a cui rispondono agitando la mano in segno di saluto. Pare quasi, da laggiù, di vederli sorridere felici, mentre le grida si stemperano nell'acqua scura e densa dell'estate.
Riferimenti
Il testo integrale del saggio, riccamente integrato da grafici e note, è scaricabile in formato pdf adoperando questo collegamento: Clara Zanardi, Oltre la nave Si avverte che l'articolo è pubblicato su eddyburg con la licenza Creative Commons, che impone la rigorosa fedeltà nella citazione dell'autore, del titolo e della fonte.
ArcipelagoMilano, gennaio 2018. Analisi giustamente impietosa di una città, avvelenata dall'immobiliarismo, che si disfa a furia di distruggere e ricostruire, più brutte e più inique, parti di se stessa
«L’afflusso di capitali nella trasformazione fisica della città è sempre e comunque positivo, un segno della vitalità di Milano»: c’è questo assunto alla base delle scelte urbanistiche delle amministrazioni che si sono succedute a palazzo Marino dal dopoguerra a oggi. Ma è un assunto tutto da dimostrare. È vero che c’è stato un momento, nell’avvio della ricostruzione, in cui mettere mano alla città rispondeva, fra le esigenze vitali, alla necessità di creare lavoro in un’economia bloccata; così come è vero che per i due o tre decenni successivi è potuta apparire fondata l’affermazione per cui «quando l’edilizia va tutta l’economia va»; ma oggi una tale supposizione è sempre meno credibile.
Basti pensare che i grandi complessi edilizi appena realizzati nella città ambrosiana si configurano come assemblaggi di componenti per lo più non prodotti nel territorio sul quale sorgono (i vetri degli ultimi grattacieli, per fare un esempio, vengono dalla Cina). Ma soprattutto non si può non tenere conto dell’invenduto e delle risorse finanziarie che la produzione in eccesso di case e uffici immobilizza sottraendole a investimenti strategici. La crisi delle banche è all’ordine del giorno, ma difficilmente viene in chiaro che, tra le cause prime della crisi, c’è il sostegno incondizionato alla deriva immobiliarista.
A Milano il quadro sembra ora presentare un’impennata (del resto il nuovo skyline che cos’è se non l’istogramma della rendita immobiliare?). Così la messa in campo delle grandi operazioni che caratterizzeranno i prossimi decenni (Expo e Scali ferroviari) ha potuto avvantaggiarsi di un’onda montante: i peana elevati senza sosta dai media tanto al nuovo paesaggio urbano (da Porta Nuova a Citylife) quanto al crescente interesse dei grandi investitori per il capoluogo lombardo. Ma il coro plaudente ha molto della claque.
E che non sia innocente lo dice il silenzio degli stessi media sui grandi fallimenti: Santa Giulia, l’area ex Falck di Sesto San Giovanni, la “Nuova Defense” dello Stephenson Business District, il mancato recupero dell’ex Ortomercato, per limitarci ai casi più eclatanti. Sta di fatto che, invece che rimanere con i piedi per terra, chi ha la responsabilità dell’amministrazione della città preferisce esibirsi in volteggi su quell’onda mediatica, sperando che anche gli elettori finiscano per vedere la realtà attraverso il filtro magico delle sirene incantatrici.
La mistificazione, va detto, è di casa nell’urbanistica moderna. Nel secolo scorso obiettivi come il risanamento igienico e l’efficienza viabilistica hanno fatto velo sulle vere finalità dei piani urbanistici. Se nei bombardamenti della Seconda guerra mondiale Milano ha perso un quarto dell’edificato, in nome dell’igiene e dell’accessibilità automobilistica la città ha conosciuto altre due guerre in tempo di pace: quella ingaggiata dal piccone demolitore mussoliniano e poi quella condotta dal rinnovamento urbano degli anni della ricostruzione e del boom economico (quando si portavano a esecuzione molti dei piani messi a punto negli anni del fascismo).
Risultato: più di tre quarti della città entro i Bastioni ha meno di cent’anni. Ma invano, nelle relazioni di piano, si cercherà traccia del fatto che tutto questo abbia coinciso con un colossale ridisegno della topografia sociale (in senso classista) e con una radicale semplificazione della complessità urbana. Un’eccezione si è avuta sotto il regime fascista quando i rapporti di forza erano tali che non costituiva un problema chiamare le cose per nome. In quel contesto l’autore del piano regolatore del 1934, Cesare Albertini, poteva indicare apertis verbis nel novembre 1931 che l’obiettivo primo del piano per la città centrale era la sistematica rimozione, con «il ferro ed il fuoco», di quel che rimaneva dei quartieri popolari nella zona centrale e la «deportazione degli abitanti» (all’incirca 100.000 persone, secondo i calcoli di Graziella Tonon e di chi scrive).
Il trionfalismo sul successo immobiliarista attuale (che, come si è detto, è solo una faccia della medaglia) è l’ultimo espediente messo in campo per evitare che la pubblica amministrazione si misuri sulla portata strategica delle trasformazioni urbanistiche da essa innescate. Tutta l’attenzione è volta a rendere appetibile l’investimento immobiliare (da cui l’adozione di un irragionevole indice di edificabilità destinato a condizionare negativamente gli interventi sugli ex Scali ferroviari).
Nel contempo si ignora quello che l’esperienza dice in modo incontrovertibile e cioè che l’iniziativa privata è del tutto disinteressata agli obiettivi strategici sui quali dovrebbe invece puntare un responsabile governo della città. Così il destino di Milano viene consegnato nelle mani di operatori che non si porranno il benché minimo problema su due fronti essenziali: 1) la capacità delle trasformazioni urbanistiche di attrezzare la città e il contesto metropolitano alle sfide economiche della globalizzazione; 2) la qualità della civitas (le relazioni sociali) e la qualità dell’urbs (i singoli luoghi come l’edificato nel suo insieme). L’ottimismo che accompagna i quadri previsionali è funzionale all’esclusione di ogni verifica su tutto quanto concorre a definire la sostanza squisitamente civile e politica delle decisioni urbanistiche. Sostanza che si può sintetizzare in quattro punti: coesione del corpo sociale; inclusione; urbanità e bellezza dei luoghi; sicurezza.
Invece che perseguire questi obiettivi, l’amministrazione comunale concentra l’attenzione sulle entrate fiscali in cui hanno un peso rilevante gli oneri di urbanizzazione. Siamo all’ennesima mistificazione: quelle entrate non coprono gli esborsi attuali e futuri per le opere pubbliche e questo non farà che rendere cronico il deficit delle amministrazioni locali.
Ma il deficit più preoccupante è sul fronte del fare città. A Milano si è imboccata la strada del proliferare di spazi pubblici inospitali, presidiati da edifici fuori scala, oscillanti fra l’indifferenza al contesto e l’arroganza; quando invece si dovrebbe puntare su una riqualificazione urbana capillare, a cominciare dalle periferie. Lo scialo di denaro pubblico in un’operazione anti-urbana come quella del recupero dell’area ex Expo (vero e proprio buco nero di risorse collettive) dimostra che non è solo e tanto una questione di scarsità di risorse: fare città (nel senso di difendere e incrementare la qualità urbana dei luoghi) o disfare le città esistenti, è questo, più che mai, il tema centrale della politica.
Avvenire, 6 gennaio 2018. La mitica Befana porta dolciumi e carbone ai bambini. L'Epifania apre ogni giorno ai nostri occhi episodi sempre simili di utilizzazione criminale dei rifiuti velenosi prodotti in quantità crescenti dal micidiale "sviluppo" che cocciutamente perseguiamo
Parole che coincidono in modo inquietante con gli indizi messi in fila da diverse inchieste giudiziarie e giornalistiche, tutte legate da un unico filo rosso: la Somalia come meta costante di spedizioni tossiche senza mittente. Affari oscuri su cui pochi, con molto coraggio e poca fortuna, hanno cercato di far luce. C’è chi ha pagato con la vita, come Ilaria Alpi, uccisa nel 1994 a Mogadiscio. O come il capitano di fregata Natale De Grazia, morto misteriosamente un anno dopo, mentre da Reggio Calabria si stava recando a La Spezia per seguire un’altra pista inquietante, quella delle scorie radioattive affondate in mare.
Uno scenario desolante, che tradisce le responsabilità dell’Occidente.Ed è una magra consolazione sapere che in seguito la situazione in Somalia è migliorata. «Ho avuto modo di constatarlo nel 2009, quando mi sono trovato a navigare da quelle parti – osserva Kaizad –. La missione internazionale anti pirateria ha consentito di pattugliare ampi tratti di mare». Le buone notizie, però, finiscono qui. «I trafficanti non si sono scoraggiati, si sono solo trasferiti altrove. Ad esempio sulle coste dell’Africa occidentale, dove i controlli sono praticamente assenti. Ci sono Paesi come la Guinea equatoriale che hanno solo due motovedette della guardia costiera. Impossibile presidiare centinaia di chilometri di costa... Attenzione anche alla Nigeria. Laggiù ci sono molte industrie del settore petrolchimico e ben poche regole. Facile disfarsi degli scarti senza grandi problemi».
È possibile che dietro questi traffici ci sia la mano della criminalità organizzata o delle organizzazioni terroristiche? «In Somalia i legami con le bande armate erano abbastanza evidenti, in West Africa si tratta di semplici affaristi senza scrupoli». Nella sua carriera Kaizad ha solcato anche il Mediterraneo. Ma preferisce non sbilanciarsi sui segreti custoditi dai fondali del mare nostrum. Si limita a osservare che è più difficile affondarvi veleni: «Forse qualcosa può essere accaduto negli anni Settanta-Ottanta. Ma ora ci sono tanti controlli, l’area è monitorata continuamente ». Meglio andare altrove per fare certe cose. L’Africa è dietro l’angolo.
il manifesto - Gambero-Verde, 4 gennaio2018. Se non vogliamo credere a chi dice che questo "sviluppo" è perverso e ci conduce al disastro almeno adoperiamo qualche cautela
Due metri”, questo lo strano titolo di un recente articolo che parla del possibile innalzamento, di due metri, appunto, del livello dei mari in seguito al riscaldamento dell’intero pianeta Terra. Molti segni indicano chiaramente che esistono alterazioni dei cicli biogeochimici del pianeta interpretabili soltanto con un aumento della temperatura «media» della Terra con una accelerazione dovuta al rapido sviluppo delle industrie, al crescente consumo di fonti di energia, ai mutamenti delle coltivazioni agricole.
Che cosa succederebbe se un giorno il livello dei mari aumentasse davvero di due metri' Molte strade di Bari, Napoli, Genova, Ravenna, New York, e di tante altre città costiere sarebbero invase dall’acqua del mare; la bella Venezia e la ricca Miami scomparirebbero sott’acqua; l’acqua marina salina andrebbe a miscelarsi con le acque dolci sotterranee che non sarebbero più adatte per l’irrigazione. Milioni di persone dovrebbero emigrare dai propri paesi. Ma anche il sollevamento del livello del mare di poche diecine di centimetri provocherebbe danni umani ed economici elevatissimi a cui oggi nessuno pensa perché il fenomeno procede lentissimo, anche se inesorabile. Nessun governo si preoccupa di quello che potrebbe succedere dopo i pochi anni in cui è in carica, sapendo che in tale periodo l’aumento del livello del mare sarebbe di «appena» uno o due centimetri.
Considerare, «oggi», quello che potrebbe succedere se il livello dei mari aumentasse, non dico di «due metri», ma anche soltanto di mezzo metro, è un invito a guardare «lontano», a un pianeta in cui vivranno i nostri nipoti e pronipoti i quali potrebbero rimproverarci per non aver preso in tempo provvedimenti per evitare eventi di cui abbiamo già i segni. Albert Schweitzer, premio Nobel per la pace, scrisse che «l’uomo ha perso la capacità di prevedere e prevenire; finirà per perdere la Terra», la sua unica casa nello spazio. Se cominciassimo già adesso a pensare al futuro?
wumingfoundation.com, 29 dicembre 2017. Sulle mistificazioni dell'architettura fascista e su come porsi nei confronti di questa eredità, in modo che questi artefatti non tornino ad essere propaganda nel presente e per il presente. (i.b.)
In Sudafrica e nel Regno Unito, ad esempio, c’è stata la campagna Rhodes Must Fall per la rimozione dei monumenti al colonizzatore razzista Cecil Rhodes.
 |
| Aprile 2015. La statua di Cecil Rhodes mentre viene rimossa dall’Università di Città del Capo. Fonte: wumingfoundation.com |
Negli USA si rimuovono dagli spazi pubblici i monumenti «confederati», cioè commemorativi della causa sudista nella guerra civile americana. Monumenti spesso nemmeno d’epoca, ma eretti nel ventesimo secolo e alcuni addirittura nel ventunesimo, dunque meramente revanscisti, apologie della schiavitù e simboli del perdurante razzismo contro i neri. Come tali, vengono difesi manu militari da neonazisti e suprematisti bianchi di varie tendenze. Gli scontri di Charlottesville, Virginia, dell’11 agosto 2017, culminati nell’assassinio della manifestante antirazzista Heather D. Heyer, furono scatenati dall’estrema destra per impedire la rimozione di una statua del generale Robert E. Lee.
In Italia, data la monumentalità insita in molte realizzazioni architettoniche e addirittura urbanistiche del fascismo, è difficile distinguere tra architettura e monumenti. I monumenti al fascismo non sono semplici statue, almeno non più.
Di statue del duce e dei gerarchi ce n’erano a bizzeffe, ma molte — purtroppo non tutte — furono distrutte già all’epoca, alcune dopo la caduta del duce, altre dopo la Liberazione. A Bologna, ad esempio, la grande statua equestre del duce al Littoriale (oggi Stadio Dall’Ara) venne decapitata dalla folla la sera del 25 luglio 1943. Dopo la Liberazione venne fusa, e col suo bronzo furono realizzate le statue di partigiani che oggi presidiano Porta Lame.
Statue di fascisti ne esistono ancora, ma in generale i monumenti fascisti sopravvissuti fino a oggi sono edifici.
Scalpellati via — ma nemmeno sempre — i simboli più vistosamente legati all’ideologia del regime (come i fasci littori), quegli edifici oggi sono parte delle nostre città e della nostra vita quotidiana. Solo che la maggior parte degli italiani non ne conosce la storia o, peggio, la conosce in modo parziale, distorto, encomiastico: «Guarda lì, il duce sì che costruiva bei palazzi!» Appunto: il fascismo ha fatto anche cose buone.
Sfruttando questa percezione, i partiti «post»-fascisti e neofascisti usano sempre più quegli edifici per le loro campagne politiche. Come quando a Roma, nel 2015, Fratelli d’Italia ha proposto un paragone del tutto improprio col Foro Italico per chiedere la demolizione del “serpentone” di Corviale.
«è come se la studiosa americana, vedendo che qui in Italia beviamo alcool a qualsiasi ora del giorno, ci avesse chiesto: Non è che avete problemi con l’alcool? E noi, invece di sorriderle bonariamente e spiegarle che vino, grappa, liquori e birra, sono parte integrante della nostra cultura -- come d’altronde l’architettura razionalista - le abbiamo iniziato a sbraitare davanti. “No, che cazzo dici?”, “Sei una mentecatta a pensare una cosa del genere!”, “Ma guardati te!”, “Pensa ai vostri problemi con le armi!”. E forse a questo punto se fossimo in lei, indietreggiando, predicando pace e calma e abbozzando una specie di sorriso, ce ne andremmo pensando che sì, qualche problemino con l’alcool questi ce l’hanno, e pure grosso.»
Che in Italia quel nervo sia scoperto lo dimostrano le bufale diffuse a getto continuo sulla volontà di questo o quell’esponente della sinistra - quasi sempre Laura Boldrini - di demolire il tal o il tal altro monumento. Bufale periodicamente riproposte da siti e giornali di destra: «Ecco i capolavori fascisti che Boldrini vorrebbe abbattere», titolava tempo fa il Secolo d’Italia, in cima a un articolo dove si paventava il rischio che Boldrini riducesse l’Italia a «una città [sic] post-atomica, praticamente un rudere con macerie in ogni angolo delle principali città italiane».
Simili bufale si “viralizzano” e scatenano le solite reazioni violente, facendo crescere la sensazione che di quest’argomento in particolare non sia possibile discutere in modo minimamente sensato.
Al netto delle bufale, a essere sbagliato è il frame, la cornice che inquadra tutti questi discorsi. Per disattivare il frame, dobbiamo porci una domanda, anzi, la domanda: l’«architettura fascista» è davvero fascista?
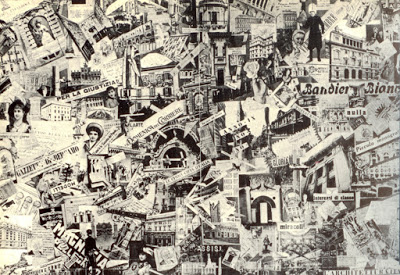 |
| La «Tavola degli orrori», realizzata da Pier Maria Bardi ed esposta alla II Esposizione universale di architettura razionale, 1931. Fonte: wumingfoundation.com |
Nessuna di queste due spinte contrastanti — la neoclassica/monumentale e la razionalista — fu esclusivamente italiana, men che meno fascista.
 |
| Ville Savoye a Poissy, Île-de-France. Progettata da Le Corbusier, 1931. Fonte:wumingfoundation.com |
Il razionalismo rientra nel più vasto Movimento moderno in architettura, che si sviluppò in tutto l’Occidente tra le due guerre. Il razionalismo italiano ha «cugini» in molti paesi, basti guardare gli edifici realizzati dal Bauhaus, a partire dalla sede della scuola a Dessau (1925); la Ville Savoye di Le Corbusier poco fuori Parigi (1928); la Tabakfabrik a Linz (1929), e tante altre realizzazioni dell’epoca.
Quanto al neoclassicismo e monumentalismo, li ritroviamo in altri paesi europei e addirittura nella Washington del New Deal. Si pensi al palazzo della Federal Reserve, costruito nel 1935-1937: è il tempio del dollaro, dell’occhio sulla piramide, eppure ha un aspetto incredibilmente “fascista”.
Si tratta di un’architettura per mezzo della quale lo Stato - ogni Stato - voleva essere fortemente assertivo, soprattutto in reazione alla crisi del 1929. Reazione politicamente trasversale, che andò dalla Francia del Fronte Popolare alla Svezia, passando per gli USA e la Finlandia. Il Palazzo del Parlamento di Helsinki, l’Eduskuntatalo, fu ultimato nel 1931 e potrebbe essere trasportato di peso all’Eur senza sembrare minimamente fuori contesto.
 |
| Eccles Building, Washington DC, sede della Federal Reserve, di Paul Philippe Cret, 1937 Fonte: wumingfoundation.com |
I neofascisti che si vantano dell’«architettura fascista» non solo danno l’ennesima dimostrazione di provincialismo e limitatezza di orizzonti, ma attribuiscono al regime “meriti” e tendenze che lo trascendono di gran lunga.
Ecco come si disinnesca la metonimia storica: sprovincializzando i termini del dibattito. Quel che di “buono” o “bello” fece il fascismo, lo fece perché non poteva non farlo: la fase storica lo richiedeva ovunque, e lo Stato “keynesiano” dell’epoca - dittatoriale o democratico che fosse - ovunque lo realizzò. Vale per le politiche sociali, il welfare state, le opere pubbliche.
O come Giovanni Michelucci, uno degli autori della Stazione di Santa Maria Novella a Firenze.
O come l’istriano Giuseppe Pagano (italianizzazione di Pogatschnig), autore dell’istituto di Fisica della Sapienza a Roma. Fu dapprima ardente fascista, ma divenne oppositore del regime già nel 1942, si dedicò all’attività antifascista clandestina ancora prima del 25 luglio 1943, fu arrestato due volte, torturato dalla banda Koch e infine deportato a Mauthausen, dove morì.
«la damnatio memoriae [aridaje, N.dR.] di una architettura, quella fascista, che, al di là delle considerazioni politiche fu un vero e proprio stile, molto studiato. All’estero»
Gianni Biondillo: - Dopo la guerra, sostanzialmente, tutti gli architetti del ventennio continuarono a lavorare. Persino Piacentini, settuagenario, con commissioni di rilevo, e pubbliche! Altro caso esemplare: Luigi Moretti. Grande razionalista metafisico. Non ha mai nascosto le sue inclinazioni di destra, e nel dopoguerra ha lavorato moltissimo. Il Watergate, quello dello scandalo, è suo.
- E la critica, — ho chiesto a Gianni, — la storia dell’architettura? È vero che c’è stata damnatio memoriae? Che l’architettura “fascista” è stata studiata solo all’estero?
Gianni Biondillo: - Assolutamente no. Già nel 1968 Bruno Zevi, ebreo e antifascista, dedica un omaggio a Giuseppe Terragni, considerato insieme a Piacentini l’architetto “di regime” per eccellenza. E per tornare a Moretti, il più autorevole critico marxista – Manfredo Tafuri – non lo “epura” affatto nella sua fondamentale Storia dell’architettura italiana 1944-1985, che esce a metà degli anni Ottanta.
Nel suo documentario La forma della città, che è del 1974, il comunista Pasolini già scinde regime fascista e architettura del ventennio. Parlando di Sabaudia, città di fondazione sul litorale pontino, dopo averla definita «incantevole» spiega:
«Sabaudia è stata creata dal regime, non c’è dubbio, però non ha niente di fascista, in realtà, se non alcuni caratteri esteriori […] Sabaudia, benché ordinata dal regime secondo certi criteri di carattere razionalistico, estetizzante, accademico, non trova le sue radici nel regime che l’ha ordinata, ma in quella realtà che il fascismo ha dominato tirannicamente ma che non è riuscito a scalfire.»
Dalle mie parti, all’improvviso e come dal nulla, nella pianura spuntano città di fondazione e colonie rurali risalenti al fascismo. L’esempio più noto è Tresigallo, borgo natìo del gerarca Edmondo Rossoni, che negli anni Trenta lo fece trasformare radicalmente.
Di Tresigallo il giornalista di viaggi Folco Quilici ha detto: «In tutti gli anni che sono venuto a Ferrara, nessuno mi ha mai portato a vedere Tresigallo. C’era una specie di barriera.»
Io, che a Tresigallo sono stato molte volte senza accorgermi di alcuna “barriera”, mi chiedo: perché Quilici, un uomo che ha esplorato l’intero orbe terracqueo, a Tresigallo non ci è andato sua sponte? Perché inventarsi interdizioni?
A conti fatti, dunque, che fare degli edifici e monumenti del ventennio?
Io credo esistano tre strade.
2. Nel caso dei monumenti più “carichi” e celebrativi, bisogna agire per risemantizzarli, aggiungervi nuovi significati, incorporare alla loro immagine la critica al significato originario e al loro committente.
In Italia esiste una città-laboratorio dove da tempo si conducono esperimenti di questo tipo. Si tratta di Bolzano/Bozen, dove i monumenti del ventennio sono comunemente chiamati «relitti fascisti» (in tedesco faschistische Relikte). Lo ha raccontato su Giap Flavio Pintarelli già nel 2013. Nel frattempo, la situazione si è ulteriormente evoluta.
 |
| Bolzano, Piazza Tribunale. Il fregio di Hans Piffrader. Fonte: wumingfoundation.org |
Il percorso che ha portato alla musealizzazione del Monumento alla Vittoria può essere di grande ispirazione, ed è di pochi giorni fa l’avvio della nuova installazione che risemantizza uno dei più ingombranti monumenti fascisti d’Italia, il fregio marmoreo di Hans Piffrader col duce a cavallo, di cui ho scritto anche su Internazionale. Oggi sul grande bassorilievo appare, tradotta nelle principali tre lingue dell’Alto Adige/Südtirol, la massima di Hannah Arendt: «Nessuno ha il diritto di obbedire».
Una soluzione bella e suggestiva, forse un po’ criptica. E troppo facilmente reversibile: basta spegnere l’installazione. Basta che alle prossime elezioni vinca un’amministrazione ostile a quel percorso e faccia un’ordinanza per pigiare il bottone. La pietra è durevole, la luce no.
Intanto, però, quella luce ha fatto imbufalire i neofascisti: «Bolzano, i nuovi talebani tentano di oscurare il bassorilievo di Mussolini», ha titolato Il Primato Nazionale, quotidiano on line di CasaPound. È la conferma che si sta seguendo una buona strada.
Bolzano/Bozen è al momento la realtà dove il dibattito è più avanzato. Ciò avviene, sia chiaro, per via di peculiarità non riproducibili altrove, prodotte dalla coesistenza di due comunità distinte, quasi due mondi accostati uno all’altro. Per semplificare al massimo: gli eredi degli invasori e gli eredi degli invasi. Tale situazione rende impossibile a chiunque blaterare con superficialità di «memoria condivisa». Nell’impossibilità di smussare, appianare, edulcorare, si è dunque spinti a cercare nuove soluzioni, in quella che noi Wu Ming chiamiamo da sempre «mediazione al rialzo».
 |
| Affile. Il «Vespasiano» dedicato alla memoria del criminale fascista Rodolfo Graziani, 2012. Fonte: wuming.com |
3. Poi c’è la terza via, che è demolire. Demolire va considerato l’extrema ratio, certo, ma non può essere un tabù. Ad esempio, siamo tutti d’accordo sul fatto che vadano demoliti i monumenti fascisti del tutto indifendibili, quelli nemmeno d’epoca, come il monumento al macellaio Graziani eretto nel 2012 ad Affile. Siamo d’accordo, giusto? Quella roba va demolita col tritolo, e sulle macerie va sparso il sale da lavastoviglie.
Ebbene, non dev’essere ritenuto impensabile nemmeno demolire relitti fascisti d’epoca. Non tutto quel che è durato fino ad oggi merita per forza di durare ancora. Durare non è di per sé una virtù, un manufatto può durare per tanti motivi, per indifferenza, per forza d’inerzia, per ignavia, o per ostinazione dei pubblici poteri.
Ci sono monumenti fascisti che furono imposti a un territorio, veri e propri schiaffi in faccia alla comunità che ci viveva, e diventarono simboli negativi da colpire. È il caso del Monumento all’Alpino di Brunico/Bruneck, eretto per celebrare in un colpo solo la guerra d’Etiopia e l’italianizzazione del Südtirol. Italianizzazione fittizia, s’intende: ancora oggi gli abitanti germanofoni sono il 70% nella provincia autonoma di Bolzano, e l’80% in Val Pusteria, dove si trova Brunico.
L’Alpino fu abbattuto dalla popolazione dopo l’8 settembre 1943, ricollocato al suo posto nel 1951, fatto saltare in aria nel 1966, ricostruito e reinstallato nel 1968, di nuovo distrutto nel 1979, rimesso sul piedistallo nel 1980. È stato preso di mira con azioni più o meno simboliche anche negli ultimi anni.
In pratica, la storia della statua è la storia dei tentativi di sbarazzarsene. C’è molto più genius loci negli attentati che nel monumento, corpo estraneo che pervicacemente lo Stato italiano torna a imporre. Si potrebbe dire, con Simon Levis Sullam sulla scia di Foucault, che si è fatto il «processo al monumento», facendone quindi un documento.
Ancora: un anno fa il comune austriaco di Braunau am Inn, dove nacque Hitler, ha deciso di demolire la sua casa natale. Subito, dall’Italia, Frassineti si è dichiarato contrario. Lo stesso sindaco che risponde – testualmente – di «farsi i cazzi propri» a chi, da non predappiese, scrive di Predappio in un modo che non gli va a genio, poi non ha remore a intervenire, criticando e dando lezioni di memoria, su una decisione presa in Austria. Forse teme che qualcuno proponga di demolire l’ex-Casa del Fascio e dell’Ospitalità? Si tranquillizzi: nessuno pensa che sia quella la strada.
A coloro che, certamente, reagiranno scandalizzati alla mia ipotesi che qualcosa di fascista si possa demolire, a coloro che chiamano «talebano» chi ce l’ha con lo scempio di Affile e persino chi accende una scritta su un bassorilievo perché «è arte», vorrei chiedere: avevate di questi mal di pancia quando nei paesi dell’est buttarono giù le statue di Lenin? Io ricordo che la destra festeggiò. Non erano «arte» quelle statue? Ed eravate così indignati quando nel 2003 avete visto cadere le statue di Saddam Hussein?
— Eh, ma quello era a caldo, durante rivolte e guerre, mica a freddo!
— «A caldo»? Perché, nel 1989 Lenin era vivo?
— No, ma il regime che veniva rovesciato aveva riempito le città di sue statue, buttarle giù era colpire il regime!
— Lo vedi? «Caldo» e «freddo» non dipendono da quanti anni sono passati. Dipendono da cosa significano quei monumenti per chi vive oggi. Negli USA stanno rimuovendo i monumenti del razzismo confederato adesso, ma non certo «a freddo», tant’è che la polemica è rovente. Li rimuovono per il ruolo e il peso che hanno nel presente.
Dopo aver fatto — almeno spero — un po’ di chiarezza sulla questione «architettura e monumenti fascisti», torniamo a Predappio, e all’attitudine: «Non si può demonizzare tutto quel che fece il fascismo, guarda com’è bella la Casa del Fascio!»
Predappio Toxic Waste Blues - I, wumingfoundation.com
Nigrizia, 2 gennaio 2018. per produrre ulteriore energia finalizzata ad accrescere uno sviluppo insensato e terricola si apprestano a distruggere una preziosa riserva naturale e a sfrattare dal loro habitat 200mila persone
Il progetto è stato molto criticato in tutto il suo percorso perché verrà realizzato in una riserva naturale vasta più o meno come la Svizzera, una delle più grandi e importanti di questo genere non solo in Africa, ma nel mondo intero. Vi si trovano alcuni siti noti per essere stati l’habitat di gruppi di ominidi, ed è dunque da considerare come una delle culle dell’umanità.
Ha inoltre una numerosa e differenziata fauna selvatica, tra cui una popolazione di almeno 110mila elefanti, il gruppo più numeroso rimasto al mondo. Tra i critici più accesi è da annoverare il governo tedesco, che, attraverso la Frankfurt Zoological Society (FZS) e il WWF sta finanziando un programma anti bracconaggio e uno di sostegno allo sviluppo ecosostenibile della zona, in cui protagonista è la popolazione locale. Questi gruppi ambientalisti e animalisti, e numerosi altri, temono infatti fortemente che la costruzione dell’impianto metterà in gioco l’equilibrio socio ambientale di un vasto territorio oltre a facilitare l’attività di bracconaggio che già ora è fuori controllo nel paese. Ha espresso timori perfino la Banca Mondiale, che sta finanziando nella zona programmi di sostegno al turismo, attività che genera annualmente un prodotto di 6 milioni di dollari.
Secondo un rapporto diffuso dal WWF nel 2017, la costruzione dell’impianto avrà un impatto negativo per la sopravvivenza di almeno 200mila persone che vivono ora di agricoltura e pesca nel bacino del fiume che verrà devastato dalla diga. Ripercussioni si avranno fino alle coste dell’Oceano Indiano dove saranno messe a grave rischio anche zone umide protette dalla convenzione internazionale di Ramsar.
In molti si sono appellati al governo tanzaniano perché abbandoni il progetto, frutto di un modello di sviluppo decisamente sorpassato, per investire nello sfruttamento di fonti alternative di energia, come ad esempio il gas, di cui il paese sembra essere ricchissimo. Ma almeno per ora gli appelli sono caduti nel vuoto
Effetti perversi del piano casa a Roma che premia la demolizione di edifici storici con aumenti di cubatura. Le amministrazioni cambiano, i palazzinari restano. (m.b.).
 |
| Villa Paolina. L'edificio che sarà demolito |
Dopo la palazzina di Via Ticino, un’altra costruzione in un quartiere novecentesco di Roma è condannata alla demolizione. Si tratta di Villa Paolina di Mallinckrodt, che dal 1922 sino al 1997 ha ospitato l’istituto scolastico delle Suore della Carità cristiana. La società che ha acquistato l’edificio, grazie alla Legge regionale 21/2009 (il cosiddetto “Piano Casa”), potrà realizzare un palazzo di otto piani più un parcheggio interrato. Dopo le proteste dei cittadine e delle associazioni, fonti giornalistiche hanno riferito che la ditta è disposta a rivedere il progetto, concordando con il Comune "le indicazioni di ordine architettonico ed estetico" che verranno segnalate dal Comitato per l'Architettura dell'assessorato all'Urbanistica del Campidoglio.
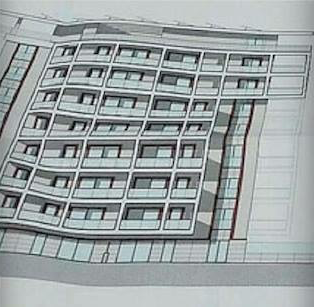 |
| Il progetto del nuovo edificio. Esteticamente rivedibile... |
Ma rispetto all'abbattimento dobbiamo dire la verità: non c’è (più) niente da fare. E la responsabilità non è del Comune di Roma, ma dell’amministrazione di centrosinistra della Regione Lazio. Noi di Carteinregola avevamo lanciato l’allarme nell’autunno 2014, quando ancora qualcosa si poteva fare. Il consiglio regionale del Lazio stava per approvare una nuova versione dello sciagurato Piano Casa, varato dal centrodestra nella precedente consiliatura, nella versione della Giunta dell'attuale Presidente Nicola Zingaretti, che ne riproponeva gli articoli e gli aspetti più discutibili, con ben pochi ritocchi. Inascoltate cassandre, avevamo fatto un presidio di un mese e mezzo presso la sede regionale (fino alle cinque del mattino dell’ultima notte, il 31 ottobre) chiedendo che fossero modificate le norme, che il Piano non fosse prorogato e, soprattutto, in caso di proroga, fosse almeno ridata al Comune di Roma (allora guidato dal Sindaco Ignazio Marino) la possibilità di escludere le demolizioni in molti quartieri storici che il Sindaco Alemanno e il suo Assessore Corsini nel gennaio 2013 avevano lasciato senza protezione.
Abbiamo ricevuto allora un no su tutta la linea e le conseguenze cominciano a vedersi oggi. Uno dopo l’altro piovono progetti, e presto potrebbe essere una grandinata. Le modifiche che chiedevamo, forse oggi sembreranno più comprensibili. La Legge regionale 21/2009 prevede che gli interventi edilizi di abbattimento e ricostruzione con aumento di cubatura, così come quelli di cambio di destinazione, non siano preventivamente sottoposti al parere dei Comuni; se rispondono ai requisiti fissati dalle legge e non confliggono con tutele specifiche, sono approvati in automatico, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati. Per esempio, nel caso di via Ticino, si può demolire l’edifico storico e ottenere, come premio per l’abbattimento, un ampliamento volumetrico del 35%. E’ quindi evidente che la lettera inviata alla Sindaca da Italia Nostra, la petizione lanciata da Liberi e uguali del II Municipio, così come altre lodevoli iniziative promosse da cittadini e associazioni, arrivano troppo tardi. Così come è inutile rivolgersi al Municipio, che ha ancora meno voce in capitolo del Comune.
L’unica cosa che si può chiedere – ma è una magra consolazione – è la pubblicazione di tutti gli interventi analoghi per cui sono state avanzate domande fino al 30 giugno 2017, almeno per sapere quante demolizioni e dove atterreranno. Il registro degli interventi è previsto dallo stesso Piano Casa, “istituito dai comuni al fine di monitorare l’incremento dei pesi insediativi nell’ambito del territorio comunale”, ed è trasmesso annualmente alla Regione. Nessuno finora ha provveduto e, almeno questo, potrebbe essere fatto rapidamente dalla giunta pentastellata, se non altro per coerenza con le posizioni sostenute nel 2014.
Non è questa la rigenerazione urbana di cui c’è bisogno. Gli interventi devono riguardare parti di città da riqualificare, non palazzi storici da gonfiare di cubature per mere ragioni di profitto. Devono portare nuova vivibilità e nuove funzioni sociali e, per questo, devono essere predisposti attraverso il confronto con la cittadinanza e, soprattutto, con il coinvolgimento attivo del Comune e del Municipio. Affidare alla proprietà privata tutte le decisioni su interventi che hanno forti ricadute sull’identità e sulla vivibilità dei quartieri è stato un gravissimo errore.
 la Repubblica, 20 dicembre 2017«La giunta Peracchini ha affondato il Puc già adottato, dal primo gennaio 2018 si potrà costruire dove era vietato. Rimossi gli ostacoli alla costruzione dell’ecomostro di Valdellora, prive di protezione l’area ex Ip e il waterfront»
la Repubblica, 20 dicembre 2017«La giunta Peracchini ha affondato il Puc già adottato, dal primo gennaio 2018 si potrà costruire dove era vietato. Rimossi gli ostacoli alla costruzione dell’ecomostro di Valdellora, prive di protezione l’area ex Ip e il waterfront»
Alla Spezia, dal 1 gennaio 2018, si potrà edificare il 45% in più di quanto sarebbe accaduto se il nuovo Puc, il piano urbanistico comunale, non fosse stato affondato dalla giunta di centrodestra Peracchini. E spunta, già, all’orizzonte, un “ ecomostro” nel quartiere di Valdellora. Così come diventano “appetibili” per il cemento il waterfront e le ex aree Ip, oltre a tutta la cintura ai piedi della colline, così fragile per le frane, e ora così indifesa dagli attacchi edificatori. Via libera anche per nuovi centri commerciali. E le opposizioni stanno consultando i legali per eventuali manovre d’emergenza a tutela del territorio.
Nella seduta straordinaria del consiglio comunale, l’altra sera, convocata su richiesta delle opposizioni, la maggioranza ha infatti votato un ordine del giorno che, di fatto, ha fatto decadere il Puc che era stato studiato e già adottato dalla precedente amministrazione di centrosinistra, guidata dal sindaco Massimo Federici. Il piano era stato dunque “soltanto” adottato, ma non approvato. La sua gestazione era stata lunga, oltre tre anni e mezzo di lavoro dei tecnici comunali - “ un’eccellenza in house”, la chiamava il sindaco Federici - per studiare un documento che proteggesse e tutelasse il territorio dal cemento, dimezzando le possibilità di edificare nuove strutture. Si sarebbe potuto costruire il 45% in meno.
Dopo l’adozione del Puc, però, è cambiata la giunta, guidata dal sindaco di centrodestra Pierluigi Peracchini, che avrebbe dovuto, trascorso il tempo necessario alle osservazioni, approvare lo strumento entro il 31 dicembre, termine ultimo per la sua decadenza. Si trattava di un piano pioniero, non solo confrontandolo con tanti strumenti urbanistici comunali della Liguria, ma a livello nazionale, proprio per la protezione garantita al territorio. Conteneva anche la mappatura aggiornata delle frane attive. E invece, lunedì sera, la giunta lo ha definitivamente affondato.
Adesso La Spezia tornerà ad avere il precedente piano urbanistico comunale, approvato oltre dieci anni fa, quando parole come cementificazione, dissesto idrogeologico, risparmio energetico, mobilità sostenibile, verde pubblico, protezione delle colline, orti urbani erano rimaste fuori dal documento.
E il primo effetto, indicano i tecnici, sarà ancora una volta lo stesso: nuovo cemento su una Liguria che sembra non aver imparato che con il calcestruzzo non si fa lo sviluppo, ma solo l’interesse ( di qualcuno) .
Il primo a ripresentarsi, puntuale, sarà il cosiddetto ecomostro di Valdellora, un quartiere periferico della Spezia, bloccato proprio dal nuovo Puc di Federici. Si tratta di un ampio complesso residenziale , in un settore urbano difficile dove mancano collegamenti viari. I progettisti, che si erano visti sbarrare la strada dall’amministrazione di centrosinistra, avevano fatto ricorso proprio contro le norme del nuovo ( ora defunto) Puc. Adesso, però, ogni ostacolo al progetto è stato rimosso.
La zona ai piedi delle colline risulta essere la più fragile: più appetibile per la fame di nuove costruzioni, è quella, oggi, totalmente priva di ogni vincolo, con la decadenza del Puc Federici. Nello strumento urbanistico cancellato dall’amministrazione Peracchini c’era poi la mappatura, meticolosamente condotta, delle frane attive, in modo da vietare categoricamente ogni intervento nei settori della città a rischio. Ma pure tutta l’area del waterfront e dell’ex area Ip adesso è rimasta senza alcuna restrizione edilizia, invece severamente imposta dal Puc. E così decade anche il recupero, la protezione e la valorizzazione della rete sentieristica dell’Alta via del Golfo, con tutte le direttive che scendono a Spezia, così come le aree destinate a verde pubblico e orti urbani. E così pure sono polverizzate le azioni mirate a trasformare Spezia in una Smart City, con una mobilità sostenibile.
casadellacultura, 15 dicembre 2017.«Se l’urbanità è illuminata dalla bellezza, senza l’urbanità la bellezza civile è impossibile». (c.m.c)
Giancarlo Consonni, Urbanità e bellezza. Una crisi di civiltà, Solfanelli, 2016
Il libro Urbanità e bellezza. Una crisi di civiltà (Solfanelli, 2016) esprime, in modo lucido e con lo stile proprio dell'Autore, la posizione di Giancarlo Consonni sulle trasformazioni della città - specie italiana - nell'ultima fase della storia, sulle cause e le conseguenze di questa trasformazione, mettendo in evidenza quanto di positivo ha caratterizzato - e oggi drammaticamente perduto - la città, con accenni di limitata speranza. Il punto di partenza è un'osservazione del passaggio da una realtà fisica e sociale che era appropriato chiamare 'città', a una realtà di dispersione urbana, senza più nulla di connotabile in modo corrispondente alla struttura fisica della città giunta a noi dalla tradizione di secoli. Con lo stimolo del pensiero di Consonni, riteniamo di esprimere il nostro pensiero sia sulla dispersione urbana e le sue prospettive, sia - in termini ovviamente di estrema sintesi - sulla qualità della città, sul suo divenire e il suo possibile futuro, oltre ad alcune idee per politiche urbane forse perseguibili.
Dalla seconda metà degli anni Cinquanta - a partire dall'immediato Sud Milano e poi verso Nord, nella Brianza, a Ovest, nel Magentino, Abbiatense, Castanese, e a Est, verso Bergamo, nell'area della Martesana - iniziò un grande sviluppo residenziale e industriale. Non tra centri chiusi in se stessi, ma con fortissime interrelazioni. Questa vicenda della trasformazione urbana, economica, umana e sociale della Provincia di Milano in quella che in modo immediato e continuo nel tempo è stata definita "area metropolitana milanese" è stata descritta - anche col mio personale contributo - tantissime volte. Ritengo qui di enfatizzare che non abbiamo mai usato la parola 'metropoli' per indicare quella realtà. Quello che avevamo visto e di cui - studiosi e amministratori uniti insieme - eravamo consapevoli, era di essere di fronte a una realtà di insediamento umano in cui rimanevano presenti strutture e modi di vita ereditati dal passato, mentre ne sorgevano altri del tutto nuovi. E cito, come esempio di rotonda evidenza - la fine dell'agricoltura praticata fin all'interno dei borghi; il nascere e svilupparsi di attività produttive micro-industriali, talune delle quali poi venivano a estendersi nell'ambito urbano, dando luogo a problemi per la compresenza di funzioni che la cittadinanza - cui peraltro dava vita e dalla cui presenza traeva vantaggi - riteneva inaccettabili, incompatibili con le condizioni di vita considerate appropriate.
In quella realtà, in connessione con quelle modalità di crescita, e insieme al diffondersi di una cultura e consapevolezza urbanistica, vennero avviate pratiche di pianificazione, man mano sempre più diffuse. Vale a dire l'avvio di piani urbanistici che prevedevano la specializzazione territoriale per funzioni, ovvero l'azzonamento funzionale. Con l'avvento di un diffuso benessere, si ebbe la realizzazione di nuove residenze e di strutture per funzioni certo non nuove in assoluto, ma con la novità di una diffusione su grandi numeri: per lo sport, il divertimento, la cultura, l'istruzione superiore fino al livello dell'università. Con queste si ebbe anche la diffusione dell'automobile, sempre a livello di massa. Potrei fermarmi qui, prima della fase post-industriale in quest'area metropolitana, dove il dato più evidente è costituito dall'enormità dei flussi di persone, di merci, e di ogni altro bene.
Ora, quella che a suo tempo abbiamo definito, con comune diffuso consenso, "area metropolitana milanese" non è una realtà analoga a quella di Londra, né a quella di New York, e meno che mai a quella di metropoli come Città del Messico, Mumbai o anche solo Cape Town. Non lo è per dimensioni e nemmeno per assenza di polarità alternative al centro principale: la città per molti aspetti dominante da secoli. Infatti, se si passa da un riferimento generico a enormi insediamenti umani quali quelli citati alla realtà di aree metropolitane come quella di Milano - cui va il nostro preciso, puntuale riferimento - ci si può immediatamente rendere conto che, quanto meno per il momento, il confronto è improponibile. In quelle metropoli di varie decine di milioni di abitanti esiste un centro con valori estetici e architettonici significativi, conservati anche con cura dai governi locali. Questo centro, che in taluni casi è 'storico', in altri è la 'down-town' - tipica espressione dell'urbanistica contemporanea - che costituisce una piccola o piccolissima parte dell'agglomerato metropolitano.
Il resto, l'insediamento di decine di milioni di persone, è costituito da 'informal settlements', 'shanty towns' o 'bidonvilles', nelle denominazione dei diversi paesi. È mia precisa opinione e previsione che il fenomeno di espansione delle 'million cities' sopra indicate, come di molte altre nel mondo, continuerà nel tempo. Quali politiche razionali o quanto meno ragionevoli possano venire pensate in termini economici, sociali e anche urbanistici, per affrontare una situazione - che rispetto ai nostri standard di vita è considerabile semplicemente disastrosa - è un argomento che non intendo affrontare qui. Per quanto riguarda l'area metropolitana milanese si può certamente sottolineare che questa è assai più ampia di quella inclusa nel perimetro della ex-Provincia di Milano e che, se si vuole chiamarla 'città', credo proprio sia corretto e accettabile definirla 'città di città'. Possiamo cioè affermare che quella che è stata definita e posta come 'Città Metropolitana di Milano' sia da considerare - con una intuizione interpretativa che deriva da esperienze catalane e sudamericane - una 'città di città'.
Di fatto quest'area - che va da Novara a Bergamo, da Lodi al confine con la Svizzera - è formata da un insieme di diverse centinaia di insediamenti, ovvero: dai 'poli esterni' a Milano che sono appunto le città di Novara, Pavia, Lodi, Varese, Lecco, Como, Bergamo, Monza; da numerosi centri di medie e anche piuttosto piccole dimensioni; e da un cospicuo numero di paesi, anche rurali, ognuno con la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni. Per taluni aspetti conservate gelosamente. Certo, esistono forti relazioni tra questi centri e un'alta mobilità, specie per lavoro e funzioni eccezionali, o comunque di scala non banale e non risolubile alla scala di ogni singolo comune. E comunque, nonostante la complessità della rete dei flussi di persone e di merci, se osserviamo questa realtà, e cerchiamo di comprenderla, credo tutto sommato possibile adottare un modello gerarchico-gravitazionale. Questo per una pur controvertibile visione interpretativa complessiva. Ma se veniamo a osservare fisicamente la qualità di questi centri sul territorio, possiamo e dobbiamo riscontrare una significativa dispersione delle strutture fisiche, che - specie in determinate parti del territorio - impedisce di distinguere l'uno dall'altro centro urbano. Come si può vedere dall'aereo, o - su carta - nei fotopiani, o sullo schermo del computer. Dispersione causata dallo sviluppo economico e demografico e dalla diffusione di massa e totale del mezzo di trasporto su gomma - tanto per la mobilità personale, quanto per il trasporto delle merci - e resa possibile dalla politica urbanistica seguita dai Comuni e dai livelli superiori di governo territorio nel corso di decenni.
Abbiamo detto del fenomeno dell'urban sprawl che negli Stati Uniti, dalla seconda metà degli anni Cinquanta, caratterizza il territorio da Boston a New York a Washington dando vita a un'unica megalopoli. Questo sprawl - ovvero questa dispersione dell'edificato sul territorio - è venuto a caratterizzare quanto meno una parte dell'Italia del Nord. E Milano e il Milanese, nel cuore della Lombardia, ne costituiscono un esempio significativo, sotto i nostri occhi. Di fronte a una simile realtà territoriale e urbana di cui abbiamo definito taluni elementi essenziali di natura geografica e macro-urbanistica, si può tentare anche una lettura di altri aspetti peculiari. Vale a dire una lettura che vada al di là dell'idea che i territori caratterizzati dal fenomeno dello sprawl siano una marmellata urbana di bassa qualità, proprio perchè i centri esistenti, i comuni storici, non hanno più la forma compatta tradizionale. Sottolineiamo subito che gli elementi della grande trasformazione del territorio lombardo sono culturali oltre che fisici; politici, oltre che economici. Noi qui, in prima istanza, intendiamo considerarne soltanto alcuni, legati all'aspetto urbanistico e architettonico. Anche perchè lo stimolo di Consonni è soprattutto in questo senso. E la nostra attenzione e riflessione vanno a un tentativo di spiegazione di ciò che è accaduto e ancora accade nella realtà fisica della città e delle prospettive, sia neutrali, sia ipotizzando azioni politico-amministrative volte a guidare e indirizzare la trasformazione. Perchè la grande trasformazione avviata a fine anni Cinquanta al tempo del cosiddetto 'miracolo economico italiano' non è finita. Anzi ritengo, motivatamente, che ora più che mai ci troviamo nell'occhio del ciclone.
Nella mia, ovviamente opinabile, lettura del libro di Giancarlo Consonni, vedo: a) un giudizio negativo sullo sprawl in quanto tale; b) l'assenza di capacità e volontà da parte dell'amministrazione pubblica di governare urbanisticamente l'insieme delle strutture fisiche che nascono in connessione con le iniziative individuali; c) l'incapacità, da parte di architetti, urbanisti, imprenditori, insieme con politici e amministratori, di elaborare un linguaggio unitario, che riesca a esprimere anche nel nuovo un'alta qualità complessiva dell'habitat. Qualcosa insomma corrispondente a quella che è stata e potrebbe ancora costituire un'espressione di 'magnificenza civile'. Su queste posizioni e tesi, elaborate ed espresse con finezza letteraria e appassionato sentimento da Consonni, mi trovo in sintonia. E intendo dire: sono del tutto d'accordo. Il problema che ho posto nel passato all'Autore, e che ripropongo ora, riguarda da una parte il modo che noi meno giovani abbiamo di guardare il mondo. Vale a dire la validità o meno del nostro modo di giudicare le trasformazioni avvenute e che man mano avvengono. Da un'altra parte, il problema è anche quello di comprendere questo mondo; di capire qual è la sua cultura, che si esprime in vari ambiti e forme; che indirizza le azioni, i tempi, le scelte individuali e collettive, e che porta a un certo modo di realizzare la città, e di viverla. E intendo: di modellare e realizzare l'urbs, e insieme la civitas.
Ora, è di tutta evidenza che ciò che si e verificato su questo territorio nell'arco di mezzo secolo ha determinato una realtà fisica, un territorio, un'immagine dell'habitat profondamente diversa da quella del passato. Quello che, anche mio parere, appare più evidente è che non esiste più, nelle strutture edilizie individuali e collettive, un linguaggio comune. Non solo perché gli edifici di ciascun decennio hanno caratterizzazioni linguistico-stilistiche differenti uno dall'altro, ma proprio per il fatto che oggi ogni soggetto - singolo promotore immobiliare o singolo proprietario di un lotto di terreno che desideri costruirsi la sua abitazione - la vuole non dico uguale, ma nemmeno analoga a quella del vicino. La vuole invece diversa, diversa il più possibile, per lo stesso motivo per cui desidera una peculiare pettinatura, un peculiare abbigliamento, così come i particolari (quanto meno i particolari!) della propria auto. Questo modo di procedere ha portato a una realtà dove in generale - vale a dire probabilmente nella maggior parte dei casi - l'insieme delle strutture, cioè la realtà fisica complessiva del territorio, presenta - agli occhi di chi è adusato a vedere, gustare, apprezzare la città tradizionale e il borgo tradizionale - una visione di disordine e di confusione. Che cosa è accaduto e accade nella società è stato studiato attraverso una grande quantità di ricerche da sociologi e psicologi e, in generale, da studiosi delle trasformazioni culturali, politiche, religiose e di ogni manifestazione di comportamento umano. Secondo molte interpretazioni questa società è caratterizzata da un diffuso individualismo.
Questo significherebbe che la nostra società ha visto la caduta dei valori comunitari. Dove la presenza, l'assunzione dei valori comunitari si traduceva nel cercare di agire come singoli individui, singole persone, singoli cittadini, tenendo conto degli altri, dell'effetto sugli altri, avendo in mente quelli che Consonni chiama 'valori dell'insieme'; definibili, in termini ancor più nobilitanti, 'bene comune'. Ora, anch'io ho visto nel tempo, nell'arco dei decenni, nel nostro paese, questa grande trasformazione antropologica, con le conseguenze e le implicazioni anche sul modo di essere della città. Nell'ambito della grande trasformazione antropologica, culturale, politica, uno degli elementi significativi emersi è stata la scomparsa alla scala individuale - e di conseguenza a una scala collettiva - dei valori etici tradizionali e, accanto a questi, anche dei valori estetici. L'idea di 'buono', 'vero' e 'bello' che si fondono insieme non è che non abbia più senso. Solo ha il senso che ognuno si costruisce, alla scala individuale. E la concezione prevalente è proprio che in una simile società, dove l'unico valore condiviso è quello della libertà, una tale concezione, un tale modo di essere molto diffuso, è che tutte le concezioni del 'vero' del 'bello' e del 'buono' abbiano (e debbano avere) il medesimo valore e la medesima dignità.
Un simile relativismo non appartiene a Giancarlo Consonni e neppure a me. Però una cosa è giudicare che, in base alla nostra formazione estetica, culturale e anche politica, certe espressioni formali - dalle opere pittoriche a quelle architettoniche, dagli assetti urbanistici al paesaggio - sono preferibili ad altre, o magari esaltanti a fronte di molte altre quanto meno insignificanti se non deprimenti. Altro è pensare di riuscire - intervenendo nel dibattito pubblico con le proprie posizioni - a modificare il corso degli eventi. Pensiamo a un fatto sul quale Consonni insiste non poco. Nei centri principali - che comunque si espandono nell'area metropolitana milanese fino a raggiungere grandi dimensioni - ciò che viene realizzato in concreto, pur implicando rilevanti, magari giganteschi investimenti, non riesce - quanto meno nella stragrande maggioranza dei casi, pur in presenza di capacità e disponibilità tecniche, economiche, finanziarie enormemente superiori a quelle del passato - a realizzare qualcosa interpretabile come espressione di 'magnificenza civile'. Quale - per intendersi - quella presente nel cuore di importanti città del passato, a partire programmaticamente dall'iniziativa dei sovrani illuminati del Settecento, per giungere in pratica fino a quanto realizzato in Italia, e anche nel Milanese, fino alla Seconda Guerra Mondiale.
Questo è un punto o elemento cruciale nella riflessione di Consonni. Davvero è molto difficile (o forse impossibile) trovare in Italia, e non solo nel Milanese, espressioni di 'magnificenza civile' negli sviluppi urbani che si sono realizzati nell'ultimo mezzo secolo. Ricordo di aver scritto un saggio mentre ero nel cuore della città di Feltre (Su un'idea di verità nell'arte, nell'architettura, nella città, pubblicato poi nel volume curato da Valerio Corradi e Enrico Maria Tacchi, Nuove società urbane, Franco Angeli, Milano 2013, pp. 183 - 203). Mi domandavo, in quello scritto, perché mai in quel centro, come in molti altri del Veneto, i turisti - in conformità d'altronde a quanto presentato ed esaltato nella pubblicità delle città d'arte - mirassero soltanto al centro storico, al cuore della città ereditata dal passato o a singoli elementi esterni al tessuto urbano ritenuti, soprattutto per motivi estetici, di significativa importanza. Mentre nessuno andava, né va, in quella città, o altre analoghe, a visitare nuovi quartieri residenziali, ancorchè decorosi, bene ordinati, dotati di tutti i servizi individuali e collettivi e con elevata accessibilità anche alle funzioni rare, necessariamente uniche, ubicate nel cuore del centro urbano. La risposta che ho dato e che ritengo di poter immediatamente confermare, è che non basta il decoro e un alto livello qualitativo delle singole strutture e anche del loro insieme a rendere attraente, affascinante, meritevole di attenzione e magari ammirazione una città. È necessario qualcosa di eccezionale. Ora, per realizzare qualcosa di eccezionale significato e qualità, e non meramente il decoro urbano, devono essere presenti alcuni elementi fondamentali. Vale a dire il potere di decisione e le risorse.
Non è un caso che a Milano come a Roma talune decisioni che si inseriscono nell'ambito della 'magnificenza civile' si siano potute realizzare nel periodo fascista, mentre non si sono realizzate nella più lunga era democristiana, nè in quella successiva, dagli anni 1990 a oggi. Certo, in talune realtà - come in Francia, Gran Bretagna e Paesi Bassi - si sono potute realizzare strutture che ritengo possano essere considerate di 'magnificenza civile' anche nell'ultimo mezzo secolo, in contesti politici democratici e liberali. Ma in quelle realtà, quel tipo di democrazia consente a chi governa una dimensione di potere molto superiore alla nostra. Questo per quanto riguarda la 'magnificenza civile'. Ma Consonni non si limita a sottolineare la carenza (o la perdita) di questo modello di riferimento culturale di eccezionale livello nello sviluppo della città contemporanea. Consonni osserva anche la miriade di centri urbani minori, a iniziare da quelli diffusi sul territorio milanese e lombardo, centri che nella loro caratterizzazione, nel loro modo di essere, appaiono disordinati, sciatti e banali nel loro complesso e in generale senza qualità anche nei singoli elementi componenti.
Un ulteriore elemento non irrilevante su cui riflettere è che non è affatto detto che la popolazione che abita il territorio italiano - a iniziare da quello lombardo o milanese - abbia la medesima considerazione, i medesimi orientamenti estetici e in generale culturali di Giancarlo Consonni. L'Autore sottolinea nel modo più forte il fatto della 'crisi di civiltà' che è anche il sottotitolo del suo libro. Su questo non ho il minimo dubbio: siamo certamente in un drammatico tornante della storia; siamo certamente in una crisi di civiltà. E questo è verificabile anche - pur se non solo - per i valori estetici, siano essi riferiti alla città nel suo insieme, piuttosto che agli elementi che la compongono. Mentre scrivo, nel luogo pubblico in cui mi trovo, vedo su un gigantesco schermo televisivo l'immagine della Trinità dei Monti e di Piazza di Spagna. Rimango un attimo in contemplazione. Ma subito mi viene da pensare che non credo affatto che in quella Roma che fece nascere quelle realtà architettoniche la maggior parte della popolazione avesse un senso artistico e una formazione culturale superiore a quella della popolazione - romana o milanese - del nostro tempo. Come ho già enfatizzato, la 'magnificenza civile' nella città era determinata, stabilita, realizzata dai potenti: pontefici, sovrani, nobili; e poi, nell'Ottocento, dai grandi imprenditori delle varie iniziative industriali e finanziarie. E tradotta in concreto da architetti-artisti valenti che possedevano ed esprimevano un sentire condiviso con i loro mecenati e governanti promotori, finanziatori, autorizzatori e guide nella realizzazione dei loro progetti.
Qui emerge l'idea che la realizzazione della città e delle scelte relative che ci concernono oggi non sono state espressione nell'ultimo mezzo secolo di una plebe ignorante come quella di Roma o Milano parecchi secoli fa. Oggi il grande numero dei cittadini è composto di persone molto più istruite che nel passato, anche solo rispetto alla prima metà del XX secolo. L'elemento che mi pare dominante nella nostra società occidentale - con un tendenza a diffondersi in tutto il mondo - è che tutto sommato alla maniera del passato vi è un ethos dominante. Per molto tempo l'ethos dominante è consistito nel rifiuto dell'eredità del passato. Vale a dire le tesi espresse dal Futurismo e dal Razionalismo, di cui le generazioni nate nella prima metà del Ventesimo secolo si sono nutrite e hanno poi tradotto in concreto, con la distruzione di molta parte di quell'eredità culturale che stava nella fisicità delle nostre città. E come conseguenza di quel modello culturale si sono avute realizzazioni che non tenevano assolutamente conto del legame del passato, tranne casi veramente eccezionali, considerato irrilevante. Si pensi al caso delle ville venete, e di molte altri siti e realtà, per lungo tempo volutamente trascurati perché considerati insignificanti.
Oggi siamo in un sistema democratico e liberale in cui le decisioni collettive sull'insieme - piaccia o non piaccia - non consistono nell'imposizione di forme prestabilite in ogni aspetto della realtà, ma essenzialmente nella fissazione di regole di comportamento in vista di esiti generali: tutela della salute; tutela dell'ambiente naturale e storico; conservazione dell'eredità culturale; risparmio di suolo; tutela della biodiversità; diffusione della possibilità di accesso alle funzioni collettive nel modo più ugualitario possibile; 'sostenibilità' in ogni tipo di intervento pubblico o privato modificatore dell'esistente; massima mobilità possibile per tutti i cittadini. Non siamo più, cioè, alla ricerca di una forma prestabilita dello sviluppo urbano; di ciò che risulta o potrebbe risultare dall'insieme di azioni individuali.
Tra i fatti che mi vengono da rimarcare con forza, in questa riflessione stimolata (anzi: determinata) dagli scritti di Giancarlo Consonni, a partire da quest'ultimo, vi è che ci troviamo a vivere e operare in una società disgregata, che ha rotto ampiamente i legami culturali e quindi di ogni tipo coi valori del passato, e che d'altronde è soggetta a una gigantesca trasformazione anche per l'enorme movimento demografico alla scala mondiale. Una società dove - accanto alle conseguenze comportamentali degli autoctoni individualisti alla scala di massa - si uniscono le conseguenze già in atto di questa sorta di pacifica invasione di milioni, diecine di milioni, centinaia di milioni di persone provenienti da tutti i continenti e da centinaia di città del mondo. In tutta Europa, ma già nell'area metropolitana milanese, il recupero dei valori tradizionali, in una fusione unitaria come Consonni auspica e spera, ritengo sia un sogno, o - se vogliamo - un'ardua la speranza. E mi viene in mente qui la conclusione di La chiesa di Polenta di Carducci. Il risorgere di un ruolo unificante della Chiesa, che porta alla realizzazione del Comune, fondendo invasori e vinti, come al tempo della vendemmia, disfacendosi nei tini le uve pigiate, 'il forte e redolente vino matura'. Certo che maturerà, ma penso sia necessario un po' di tempo, e non so assolutamente prevedere che vino sarà.
Questo nel lungo periodo. Qui e ora - e intendo nel breve e medio periodo - mi viene da pensare che rimarrà, alla scala territoriale, una distinzione tra città e campagna; che nei centri minori, nelle aree non-metropolitane italiane che persisteranno, continuerà il modo di procedere oggi presente, con il mantenimento di qualcosa storicamente rilevante alla scala locale, e lo sviluppo senza qualità sperimentato dagli anni dello sviluppo economico dagli anni 1950 fino a oggi. Nelle aree metropolitane - e in quella milanese in particolare - continuerà il modo di procedere in atto oggi, con interventi urbanistici e architettonici del tipo dominante alla scala mondiale. Vale a dire in un contesto in cui si sperimenteranno le più varie, fantasiose e appariscenti modalità espressive, senza alcun nesso l'una con l'altra. Esattamente come gli abiti in una sfilata di moda; come le opere dei creativi nelle grandi exhibitions collettive alla Biennale di Venezia o nei palazzi di esposizione d'arte contemporanea.
N.d.C. - Laureato in scienze economiche, filosofia e architettura, Andrea Villani ha diretto il Centro Studi Piano Intercomunale Milanese. Ha insegnato Economia urbana all'Università Cattolica di Milano ed è stato coordinatore del programma Sulla città, oggi. Ha inoltre diretto "Città e Società", è stato condirettore di "Edilizia Popolare" e attualmente è tra gli animatori e coordinatori di ULTRA (Urban Life and Territorial Research Agency) del Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Tra i suoi libri editi da ISU Universita Cattolica: La pianificazione della città e del territorio (1986); La pianificazione urbanistica nella società liberale (1993); La gestione del territorio, gli attori, le regole (2002); Scelte per la città. La politica urbanistica (2002); La decisione di Ulisse (2000); La città del buongoverno (2003).
Per Città Bene Comune ha scritto: Disegnare, prevedere, organizzare le citta? (28 aprile 2016); Progettare il futuro o gestire gli eventi? (21 luglio 2016); Arte e bellezza delle città: chi decide? (9 dicembre 2016); Pianificazione antifragile, una teoria fragile (10 novembre 2017).
Sul libro oggetto di questo commento, v. anche i contributi di: Pierluigi Panza, Se etica ed estetica non si incontrano più (16 dicembre 2016); Paolo Pileri, Se la bellezza delle città ci interpella (10 febbraio 2017); Vezio De Lucia, Crisi dell'urbanistica, crisi di civiltà (18 maggio 2017).
Del libro di Giancarlo Consonni si è discusso alla Casa della Cultura - nell'ambito della V edizione di Città Bene Comune - martedì 23 maggio 2017, alla presenza dell'autore, con Elio Franzini, Gabriele Pasqui, Enzo Scandurra.
Fino a pochi decenni fa, lo scopo dell’archeologia, come di tutte quelle discipline che rientrano nell’etichetta delle scienze umane, poteva essere sinteticamente definito come l’acquisizione di conoscenza, ottenuta, nel caso specifico, con lo studio e l’interpretazione delle culture del passato attraverso le evidenze materiali. Assieme ad altri fenomeni strutturali, come la globalizzazione, la crisi economica che ha investito il mondo occidentale, ha fortemente circoscritto il ruolo delle scienze umane, che si trovano oggi sollecitate a giustificare la propria autonomia ed importanza secondo parametri inattesi, quelli della sostenibilità non solo culturale, ma economica e sociale. Vi è quindi la necessità, per l’archeologia come per altre discipline affini, di rivolgersi ad un pubblico il più ampio possibile, sperimentando ruoli e pratiche nuovi, quali quelli di mediazione culturale e di inclusione sociale.
All’interno del progetto NEARCH (Nuovi scenari per un’archeologia partecipativa) come altrove in Europa, le esperienze di questo tipo si vanno ampliando: Archaeology&ME ne presenta alcune, tuttora in corso che, a diversi livelli, sono riuscite ad attivare un coinvolgimento reale nei confronti di un pubblico in partenza scarsamente interessato alle tematiche archeologiche. Nelle esperienze descritte, gli attori protagonisti sono, di volta in volta, assieme agli archeologi, gli immigrati che già da molti anni hanno scelto l’Europa come seconda patria, i migranti di recentissimo arrivo, o ancora gli abitanti delle nostre periferie urbane. In generale, quindi, chi solo raramente vive l’esperienza di un contatto non casuale con l’archeologia o le nostre istituzioni culturali. In alcuni degli esempi che presentiamo lo scavo archeologico o un monumento sono diventati l’occasione per conoscere e vivere il proprio ambiente e le sue trasformazioni in modo più consapevole o anche solo più piacevole. In un altro caso il patrimonio archeologico conservato nei nostri musei è diventato la chiave per avvicinare due realtà molto distanti come possono apparire ai migranti quelle del paese di origine e quella del paese ospitante: attraverso oggetti spesso provenienti dai paesi d’origine, i migranti provano a riallacciare dei fili e a riconoscere, assieme agli archeologi, come le distanze che ci separano siano relative e che le nostre storie si sono incrociate fin da tempi remotissimi. A queste esperienze si apparentano anche i progetti descritti nel capitolo dedicato all’archeologia coloniale (pp. 188 ss.). In questo caso gli archeologi europei, nel loro rapporto con le comunità locali, hanno dovuto gestire la dificile eredità di un passato coloniale, nel quale cioè l’archeologia era stata a tutti gli effetti strumento di sfruttamento delle risorse locali e di imposizione del paradigma culturale occidentale.
In tutti i casi presentati, così come per Archaeology&Me, al centro del progetto archeologico è il rapporto con la società, intesa sia come comunità locale, che come pubblico allargato e l’obiettivo primario diventa quello di consentire o favorire un accesso non superficiale alla storia e al patrimonio culturale per gruppi sociali sempre più ampi. Uno dei risultati che ha accomunato tutte le esperienze presentate, è quello di aver innescato un percorso circolare, in cui, cioè, il dialogo di partenza fra archeologi e gruppi sociali ha acquisito un carattere sempre meno asimmetrico. La comunicazione è diventata allora bidirezionale e gli archeologi si sono dovuti confrontare con esigenze, interpretazioni, usi del patrimonio che rivendicano piena dignità e che richiedono risposte che non possono che essere il frutto di un impegno condiviso. Il ‘pubblico interesse’, lungi da essere un dato oggettivo e fissato per sempre, si dimostra sempre più un processo di negoziazione a più voci, sottoposto alla precarietà del contesto ambientale e sociale e bisognoso di un impegno culturale approfondito.
 arcipelagomilano.org n. 41, 12 dicembre 2017.Lo afferma un giurista:l’urbanistica è tecnica, ma prima è politica e dunque diritto. (m.c.g.) con postilla.
arcipelagomilano.org n. 41, 12 dicembre 2017.Lo afferma un giurista:l’urbanistica è tecnica, ma prima è politica e dunque diritto. (m.c.g.) con postilla.
In diritto hanno ragione i ricorrenti – Italia Nostra e gli altri, ciascuno per quanto gli interessa e tutti nell’interesse comune – a far annullare, perché illegittimo, lo sciagurato “Accordo di programma” che il Comune di Milano, la Regione Lombardia e il Gruppo F.S. hanno sottoscritto sulla “rigenerazione” urbana dei sette scali ferroviari che – venuta meno la loro destinazione al servizio ferroviario – sono tornati nel patrimonio pubblico dello Stato o, addirittura, del Comune di Milano.
Nell’accordo di programma ci sono protagonisti in più e protagonisti in meno di quello che sarebbe stato necessario e legittimo: in più ci sono certamente il fondo immobiliare Savills – un soggetto privato che non c’entra con il programma urbanistico oggetto dell’accordo, nel quale avrebbe potuto inserirsi dopo, ma come attuatore (e avrebbe dovuto inserirsi a seguito di pubblico concorso); in meno c’è la neocostituita Città Metropolitana di Milano, direttamente interessata, data la sua competenza concorrente con quella del Comune (e forse addirittura di essa sostitutiva), al governo del territorio insieme alla Regione.
Ma cosa c’entra il gruppo F.S., che invece è parte dell’accordo – e vi fa la parte del leone? Chi mai ha stabilito che sono sue (di sua privata proprietà) le aree dismesse del servizio ferroviario, e che solo a tale scopo, con tale specifica destinazione, le F.S. (allora Azienda dello Stato, ma oggi divenuta SpA “privata”) avevano in uso/concessione?
Ci sono due parole che servono a fissare le idee e a dimostrare che il c.d. “Accordo di programma” è un contratto senza base giuridica, che serve soltanto, in realtà, a privatizzare beni e funzioni pubbliche; e che esso è uno strumento di speculazione edilizia a favore di possenti Signori del mercato, ai quali, per ingenuità o per inesperienza, o per servilismo, i politici/rappresentanti del popolo, e i pubblici burocrati ai loro ordini, cedono le chiavi della Città, a loro delegando le funzioni di governo del territorio. Sono le parole “abdicazione” e “monopolio”.
Anche a prescindere da altre censure (pure pesanti) su sue particolari clausole, delle quali diciamo più avanti, l’Accordo si rivela radicalmente illegittimo se si considerano due effetti fondamentali che esso produce:
1) di abdicare, da parte del Comune/Città Metropolitana (e della Regione), alla loro funzione fondamentale di governo del territorio, e di abdicarvi a favore di un ente formalmente (e sostanzialmente) privato (che, quindi, provvederà a tale governo anzitutto nel suo proprio interesse);
2) di creare, in capo a tale ente (in sostanza, al Gruppo F.S.), una posizione di monopolista: invero, l’edificabilità in Comune di Milano, ora e per i prossimi 30 anni, sarebbe assorbita da quella correlata agli ex scali ferroviari: cosicché chi vorrà costruire dovrà acquisirne i diritti dal “concessionario” individuato dal c.d. Accordo di programma e da tale Accordo promosso a gestore/governatore del territorio e monopolista dei diritti edificatori nella Città di Milano. Per questo aspetto, l’Accordo merita una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Queste sono le anomalie fondamentali dell’Accordo censurato e impugnato. Alle quali vanno aggiunte – perché indiziarie di chi sia l’autore dell’Accordo, donde esso provenga (che esso, che non nasce da un dibattito trasparente e democratico, ha origine in privati colloqui in riservate stanze: ma quali?) e perché sintomatiche della sua non temperata propensione a favore di una parte – due clausole che nessun autorevole e accorto negoziatore della parte pubblica avrebbe accettato, se non “costretto”:
1. Quella che il cessionario, a fronte della proprietà delle aree, assume l’impegno di corrispondere al Comune 50 milioni di euro: allorquando stime attendibili valutano i ricavi dell’uso edilizio delle aree stesse in non meno di 600 milioni di euro;
2. Quella – di evidente importazione da culture giuridiche estranee alla nostra tradizione e al nostro ordinamento costituzionale – che stabilisce che l’impegno del cessionario di dare al Comune quei 50 milioni decade ove mai taluno osasse impugnare l’Accordo in sede giurisdizionale: clausola capestro vistosamente contraria al diritto di ricorso costituzionalmente garantito ai cittadini. Una clausola siffatta basta da sola a squalificare l’Accordo, inficiandone in radice la legittimità.
Ancora una volta è al diritto, e quindi alla Magistratura, che occorre far capo per frenare gli abusi di un’Amministrazione della cosa pubblica asservita dai politici (pseudo rappresentanti del popolo e che di tale “rappresentanza” abusano) ai loro interessi di casta, di tribù, di mercato – come li si voglia qualificare – anziché al bene comune.
postilla
L’articolo di un giurista, Scotti Camuzzi, pone in evidenza con chiarezza le gravi illegittimità procedurali dell’indecente Accordo di Programma sul riuso dei sette scali ferroviari milanesi. Su questo accordo si stanno accumulando molteplici ricorsi ed esposti da parte di associazioni, professionisti e cittadini: - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avanzato da Italia Nostra che ha denunciato la rinuncia del Comune a dirigere la riqualificazione delle aree, cedendo a Ferrovie dello Stato il timone dell’intera operazione, con l’esito che “questo operatore potrà trarre profitto dalla gigantesca speculazione immobiliare che metterà in pericolo la qualità della vita e il futuro della città”; - due ricorsi al TAR della Lombardia, recentemente depositati da parte di cittadini; - cinque esposti, presentati da soggetti interessati a vario titolo, all’Anac, al Garante della concorrenza, alla Commissione europea, alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica. L’articolo conferma altresì il danno erariale per la collettività che scaturirebbe da un accordo sleale quale è quello che si sta configurando: un ricavo netto di ben 600 milioni di euro, come ha cautelativamente calcolato Roberto Camagni, sui quali il Comune dovrebbe ricevere il 50%, sulla base della nuova legge sul contributo straordinario (art. 16 comma 4 del TU sull’Edilizia) e che il Comune sembra intenzionato a non esigere accontentandosi delle briciole (www.arcipelagomilano.org/archives/47304 ). Si annuncia una lunga battaglia in difesa dei beni comuni a rischio di privatizzazione con il consenso inaccettabile dell’amministrazione locale: una amministrazione, quella di Milano, che da lungo tempo ha rinunciato alle sue responsabilità in materia di governo pubblico del territorio. (m.c.g.)