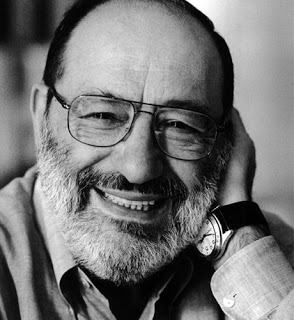«».
il
manifesto, 13 ottobre 2016 (c.m.c.)
Si avvertì d’improvviso uno scoppio tanto potente da far tremare i vetri delle finestre. In pochi minuti sapemmo che a Piazza Venezia era esplosa una bomba. Franca prese il telefono e chiamò la polizia:«Sono stati i fascisti?» – chiese. «Macché fascisti e fascisti, signora»- fu la risposta sprezzante della Questura. Telefonò a Dario, che era a Milano. E così sapemmo della contemporanea bomba di Piazza Fontana, alla Banca dell’Agricoltura. Da allora, e per molti anni, il 12 dicembre divenne la scadenza principale di tutto il movimento: a ricordare la data dell’inizio della strategia del terrore.
Per anni, prima di allora, ci eravamo incontrati nei teatrini dei circoli dell’Arci dove era emigrato quando aveva abbandonato i teatri che lui chiamava «borghesi». Perché, diceva, «non voglio essere l’alcaselzer della borghesia che ride un po’ su se stessa per autoassolversi». In realtà il successo della sua straordinaria invenzione teatrale fu n crescendo, non importa dove lui e Franca andavano a recitare.
Sì, all’inizio dell’avventura del Dario e Franca ci erano stati subito compagni. Un incontro naturale per chi, come loro, e al massimo dell’espressione artistica, si era proposto «di prendere per i fondelli il potere», di «dargli fastidio». Proprio per questo, dopo il travolgente successo di Canzonissima, la Rai emise il bando che li allontanò da tutti i programmi dell’emittente pubblica per ben 15 anni, dal 1962 al 1977!
Fummo proprio noi del manifesto a riportarlo su quegli schermi, surrettiziamente, almeno per mezz’ora: non come regista e/o attore, bensì come partecipe della breve trasmissione televisiva che fu concessa alla nostra lista nelle elezioni del 1972. Parlò, assieme a Rossana e a Lucio, di quanto ci proponevamo con quella (non fortunata) partecipazione alla campagna elettorale – rimettere al centro dell’attenzione politica i contratti operai – e però soprattutto di Valpreda, nostro capolista arbitrariamente imprigionato dagli insabbiatori per deviare l’inchiesta sui responsabili dell’eccidio della banca dell’Agricoltura. Dario aveva peraltro portato in scena la vicenda strettamente correlata: «Morte accidentale di un anarchico».
Non fu la sola partecipazione televisivo-elettorale di Dario con le nostre liste: tornò, come mattatore, a quella per le elezioni del 1976 cui concorremmo come Democrazia Proletaria, e una bellissima immagine la trovate anche su Internet: Dario al centro assieme a Rossana, e accanto una folla di candidati che non tutti riesco più a riconoscere perché sembrano tutti teenager.
Poi ci fu «Soccorso Rosso», la palazzina Liberty a Milano occupata e usata come quartier generale della controinformazione, e tante altre vicende, tutta la storia della nuova sinistra.
Infine il più sovversivo riconoscimento mai concesso dal consiglio che aggiudica il Nobel della letteratura: «Perché, seguendo la tradizione dei giullari medioevali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi».
L’ho visto per l’ultima volta solo pochi mesi fa, in occasione di «Terra madre giovani», a Milano al termine dell’Expo. Non dentro l’Expo, ma fuori, al nuovo mercato di Porta Genova dove si tenne l’inaugurazione del grande raduno che Slowfood aveva voluto con la nuova generazione di agricoltori di tutto il mondo – molti contadini «di ritorno» – per parlare finalmente come si deve del cibo. Eravamo seduti vicini e dopo aver parlato un po’ di quanto era bravo il nostro comune compagno e amico Carlin Petrini (al quale lui era legatissimo), abbiamo anche scambiato qualche battuta sui suoi grillini.
L’avevo trovato un po’ invecchiato, ma sempre militante: e infatti era lì, a testimoniare con la sua autorevolissima presenza, dell’importanza di battersi contro i big dell’alimentazione. Come sempre: dare fastidio al potere.
 Adall'archivio di
Adall'archivio di
eddyburgarticoli che ci sembra meritino oggi di essere riproposti. Questo episodio , raccontato da Lello Parise su laRepubblica del 29 settembre 2007, non ha bisogno di commento.
«Voglio assolutamente avere una copia di quella lettera». Baldina Di Vittorio è emozionata, felice. Suona orgogliosa al telefono da Roma la voce della figlia del mitico "Peppino", l’ immarcescibile leader dalla Cgil: «Quel manoscritto rivela più di qualsiasi altra cosa il carattere di mio padre, onesto e coraggioso». Di Vittorio che gentilmente rifiuta un pacco-dono del conte Giuseppe Pavoncelli, proprietario terriero di Cerignola e che su un paio di fogli di carta intestata della cooperativa " Lafalce" spiega le ragioni di quel rifiuto: «Io e lei siamo convinti della nostra personale onestà, ma per la mia immagine politica non basta l’intima coscienza della propria onestà. E’ necessaria anche l’ onestà esteriore». Ecco perché «a preventiva tutela della mia dignità politica e del buon nome di Giuseppe Pavoncelli che stimo moltissimo, sono costretto a non accettare il regalo. Perciò la prego di mandarmi qualcuno, possibilmente la stessa persona, a ritirare gli oggetti portati». Eppure era un cadeau goloso: pane, formaggio, taralli, olio. «Quella, per la mia famiglia, era l’epoca della povertà assoluta. Sì, insomma, non era facile rifiutare quel po’ di ben di Dio, come scrive papà. Alla vigilia di Natale, poi...».
La data della missiva, che era rimasta inedita fino all’altro giorno, è quella del 24 dicembre 1920. Racconta la signora Baldina: «E’ l’anno in cui io sono nata e per me questo documento acquista un valore particolare. Ne avevo sentito parlare in famiglia, di quelle poche righe indirizzate al conte Pavoncelli, titolare di un’azienda che continua ad essere viva e vegeta e che produce olive la cui qualità è famosa in tutto il mondo: la "Bella di Cerignola", così si chiamano. In fondo è grazie al nipote Stefano che salta fuori questo biglietto da cui emerge la generosità e la correttezza di Giuseppe Di Vittorio». Altri tempi? «No, un uomo diverso rispetto a quelli dei giorni nostri. I tempi, inevitabilmente, cambiano. Non voglio fare paragoni, per carità, con gli uomini politici e i sindacalisti di questo nuovo secolo. Però sono convinta che mio padre avrebbe seguito le stesse regole, soprattutto morali, rispettate scrupolosamente quando era in vita». "Peppino" muore esattamente cinquant’ anni fa. La Rai gli dedicherà un film, che in parte sarà girato proprio a Cerignola. Fa sapere l’ indomabile Baldina, che indossa i suoi 87 anni con la leggerezza di un’adolescente: «Proporrò agli sceneggiatori d’inserire questo episodio nella pellicola. Sì, loro già lo conoscono perché durante i sopralluoghi nella città natale di papà prima di cominciare le riprese hanno incontrato Stefano Pavoncelli, che gli ha fatto vedere l’epistola. Sì, sarebbe bello se fosse immortalata in questo lavoro cinematografico. Perché è istruttiva e mette in risalto comportamenti che devono essere validi perfino nel terzo millennio».
Baldina Di Vittorio è un fiume in piena e l’età non tradisce la freschezza delle sue parole. Insiste: «Comportamenti, visti a distanza di quasi novant’anni, che non sono quelli di un marziano. Piuttosto, sono naturali. Mio padre predicava l’opportunità di avere rapporti con tutti, ma non tollerava l’ incoerenza. Negli altri e meno che mai da parte sua». L’essere e l’apparire, insomma, dovevano rappresentare il "lato A" e il "lato B" della stessa medaglia. Come la moglie di Cesare, bisognava essere al di sopra di ogni sospetto. «è un insegnamento che io stessa non dimentico, ma che tutti dovrebbero ricordare. Più degli altri, quelli che rappresentano il popolo. O la gente, come si dice adesso».

Il Fatto Quotidiano, 29 giugno 2016 (p.d.)
“E' morto un ragazzo in corteo”. È la sera del 20 luglio 2001. Le foto di Carlo Giuliani steso a terra mentre una ragazza della Croce Rossa tenta disperatamente di rianimarlo hanno fatto il giro del mondo. E un uomo prende la sua agenda di pelle scura, consumata. Scrive poche parole – non c’è altro da dire di fronte alla morte di un ventenne – ma con una calligrafia che rivela la passione e l’energia. Perché l’autore di quel diario è don Andrea Gallo. E rileggendo i suoi appunti ti sembra di vederlo nel suo studio, quella stanza affacciata sul porto di Genova con la luce accesa fino all’alba che i genovesi passando avevano imparato a cercare. Come una piccola Lanterna che indicava la rotta. Sì, il Gallo era sveglio, era alla scrivania con il sigaro in bocca.
C’era anche in quei giorni del G8 che hanno cambiato la storia della sua città e dell’Italia. Era lì, e sulle pagine dell’agenda ha lasciato appunti essenziali come un libro di storia. Scritti per se stesso, ma soprattutto forse nella speranza che un giorno qualcuno li trovasse. Non dimenticasse.
E oggi è successo. L’agenda del 2001 è soltanto uno tra le migliaia di documenti che stanno riemergendo dallo scaffale dello studio. Una raccolta sterminata, perché don Gallo non buttava via niente: agende, migliaia di fogli sparsi con gli appunti per le prediche, i discorsi, i funerali di amici scomparsi, da Fabrizio De André a Fernanda Pivano. Non andranno persi: Domenico Chionetti – per tutti Megu – che era sempre a fianco del Gallo ha raccolto tutto. Con l’aiuto dell’archivista Carlo Stiaccini, dell’amico Alessandro Lombardo e della fondazione Ansaldo ha cercato di riordinare quel magma uscito per cinquant’anni dalla penna di don Andrea. E infine eccolo, il grande archivio di don Gallo. L’Archivio di Stato lo ha dichiarato “bene di notevole interesse storico”. Sarà conservato.
“È come rileggere le parole di un padre”, racconta Megu indicando i faldoni dove sono raccolte le carte. Davvero il diario della vita di un uomo, dai primi anni del sacerdozio fino alla nascita della Comunità, per arrivare a quella ribalta che Gallo accoglieva con divertita ironia. Calcandosi appena un po’di più il cappellaccio sugli occhi. Ma insieme il racconto dei grandi avvenimenti del mondo visti da quella piccola stanza. Finché la storia, nei giorni del G8, gli bussò alla porta.
Ecco l’appunto della mattina del 18 luglio, quando i grandi della terra cominciano ad arrivare a Genova: “Città blindata, militarizzata!!!”, scrive don Gallo. Con i punti esclamativi cui la sua voce dava vigore. Poi la speranza che la protesta resti pacifica. Il concerto di Manu Chao, i ragazzi che sfilano per le strade. Fino alla sera del 20 luglio. “Ho tanti amici nelle Forze dell’ordine. Quanti “servitori” dello Stato di Diritto ho stimato e apprezzato in questi ultimi anni! Abnegazione, sacrificio, senso del dovere. Quanti hanno pagato con la vita, lasciando famiglie nel dolore”. Scrivendo il diario di quel venerdì 20 luglio, però, aggiunge: “Cittadini in divisa hanno sperimentato il potere puro, l’arbitrio assoluto”.
Ma è lungo il cammino di un uomo, ci ricordano i diari di Andrea Gallo. A cominciare dalle lettere del giovane sacerdote che scrive ai genitori e al fratello Dino. Parlando di sé e del mondo. Dell’invasione dell’Ungheria del 1956: “Non posso fare a meno di parlare del massacro della gloriosa nazione ungherese!! Avrete sentito dai giornali, dalle radio, quali orrendi crimini sono stati commessi contro una popolazione inerme che chiede siano rispettati i sacrosanti diritti concessi da Dio a tutti gli uomini: libertà, pace, lavoro. Che dobbiamo fare noi cattolici in questa occasione? Seguiamo le direttive illuminate e sagge del nostro Sommo Pontefice…non facciamo tante chiacchiere inutili e soprattutto non provochiamo altro odio nelle nostre contrade!!!”. Non è ancora il sacerdote “angelicamente anarchico”della maturità. Ma c’è già la sua energia. E quel tentativo faticoso, a volte doloroso, durato una vita di mettere insieme l’obbedienza alla Chiesa con la libertà.
Davvero quante cose racconta la scrittura. Proprio la calligrafia. Addio alla macchina da scrivere, addio ai filtri. Gallo ora scrive di proprio pugno, con le linee delle parole che si fanno più morbide pagina dopo pagina. Come se arrivassero la tranquillità della notte o la stanchezza. Scriveva, scriveva, mentre accanto a lui dormivano i “tossici”della Comunità San Benedetto con cui condivideva la stanza. Basta una riga per raccontare chi era don Andrea: “Diecimila lire a una madre musulmana per il latte dei bambini”. Ancora: “Dieci euro a un egiziano. Povero, povero, povero”. Ripetuto tre volte, per far risuonare la rabbia. E l’amore. In tanti hanno lasciato un messaggio nel diario della Comunità (anche questo nell’archivio): “La Ester adesso va a battere”, scrive un ragazzo. “Adesso andiamo a puttanazze!”, aggiunge un altro. Non c’è censura. “Questo era il segreto del Gallo: non giudicare, far sentire tutti amati”. È una galleria di decine di personaggi: tossici – alcuni non ci sono più, altri ne sono usciti, c’è chi addirittura è diventato manager di successo – prostitute, transessuali, immigrati. Ma anche gli amici importanti. Tutti sullo stesso piano. Tutti uguali. Ecco gli appunti per l’addio a De André: “Non voglio dire che Fabrizio abbia indicato una strada per coniugare il proprio riscatto e quello di tutti gli oppressi. Perché Faber riconosce sempre agli altri la libertà della scelta”. Poi Fernanda Pivano: “La Fernanda! Una di quelle persone che ci regala il cielo ogni tanto. Ci ha insegnato un linguaggio universale. Dialogare, ascoltare tutti”.
Poi le fotografie. Centinaia. Dalle immagini di Gallo giovane. Un uomo bello, vigoroso, perché – questo sembra dirci – non c’è proprio contraddizione tra corpo e spirito. Anzi. E gli scatti con gli amici: con un viado brasiliano o Vasco Rossi. Non fa differenza. Nessuna lezione. Forse soltanto qualche consiglio su come “sentire” la vita con i cinque sensi: “Vista: vedere i colori della terra. Olfatto: annusare i profumi del vento. Udito: sentire l’armonia di tante voci. Gusto: assaporare gli aromi del mondo. Tatto: sentire tante dita”. E poi appunti civili, sacerdote e cittadino. Nemmeno questa è contraddizione in don Andrea: “La legge elettorale definita da tutti una porcata… ha prodotto una semplificazione consentendo alla coalizione vincente la tanto auspicata governabilità. Ma l’ultimo governo Berlusconi di quale maggioranza dispone? Altro che semplificazione, è l’inizio della demolizione della Democrazia”.
Ci sono tutti. Non ci sono, o non sono ancora emersi, messaggi scambiati con i suoi cardinali, da Giuseppe Siri ad Angelo Bagnasco, con cui Gallo ha avuto un rapporto molto “dialettico”: obbedienza e libertà, appunto. Ma forse quelle parole schiette don Andrea non ha voluto scriverle. Le ha pronunciate soltanto a voce.
Manca soltanto una persona: lui, don Andrea, che non parla quasi mai in prima persona. Che cerca di scomparire e si definisce soltanto attraverso gli altri. Fino a quell’ultimo messaggio: “Gesù disse…Vi ho tenuta nascosta una cosa che ora non posso più nascondervi: devo proprio partire. Addio”.

«il manifesto e Corriere della Sera
Il manifesto
IL COMPAGNO CHE ERA LIBERALE
di Andrea Colombo
Marco, che se ne è andato ieri stroncato non da uno ma da due cancri, perché l’uomo era così, eccessivo in tutto, suppliva da solo a un vuoto che ha segnato, sempre e solo nel male, la storia italiana: la mancanza di una destra liberale con la quale per la sinistra fosse possibile confrontarsi con reciproco vantaggio. Si parla di destra politica, perché l’albero genealogico della cultura nazionale invece qualche frutto d’oro su quel versante può vantarlo, e quei nomi che tornavano continuamente in ballo nei monologhi fluviali che Pannella aveva l’ardire di spacciare per interviste: da Benedetto Croce al tanto citato quanto disatteso Mario Pannunzio.
A lui, forse, la definizione sarebbe andata stretta, come qualsiasi etichetta avesse preteso di definire la sua personalità straripante. Pannella non si sentiva un uomo di destra e certo con la destra italiana aveva ben poco a che spartire. I radicali non hanno smesso di chiamarsi, tra loro, «compagni». E il «suo» Partito radicale discendeva direttamente dall’ala sinistra del partito originario, quello nato nel 1955 e che contava tra i suoi fondatori l’intera aristocrazia intellettuale del liberalesimo italiano. Pur diviso, quel gruppo di grandi intellettuali concordava nel vedere i «rossi» solo come un pericolo. Non la «Sinistra radicale» di Giacinto detto Marco, che al contrario spingeva per un’unione laica di tutte le forze di sinistra, comuniste, socialiste e liberali. Quando i fondatori abbandonarono il partito, a ereditarlo rimase solo la corrente di sinistra e il suo capo, dal 1963 segretario e padre padrone a vita dell’intero partito.
Nelle sue campagne Pannella era ossessivo e martellante, da giovane così come in tarda età. Ma c’era del metodo, e dell’intelligenza politica raffinata, nella sua ossessione. Per tutti gli anni ’60 caricò a testa bassa sul divorzio senza concedere un attimo di tregua, inventandosi espedienti comunicativi uno via l’altro, adoperando a man bassa l’alleanza con un giornale, Abc, dal quale ogni politico comme il faut si sarebbe tenuto lontanissimo per la tendenza a sciorinare tette abbondanti e mutandine succinte, ma che era in compenso popolarissimo.
Non si trattava però di un caso maniacale. Nell’Italia codina e baciapile di quegli anni, quando persino un galantuomo come il futuro presidente Scalfaro sbottava in pubblico a fronte di una scollatura esagerata e le Kessler rappresentavano la frontiera del proibito, Pannella aveva individuato nel divorzio la leva capace di forzare i limiti culturali di un Paese che di laico non aveva ancora nulla. Il seguito provò che aveva ragione.
Pannella era laico e a tratti, soprattutto a cavallo tra i ’60 e i ’70, anche «laicista», se non proprio mangiapreti. Quel lusso la cultura comunista, che le «masse cattoliche» le aveva ben presenti da molto prima che Berlinguer scrivesse su Rinascita di «compromesso storico», non poteva permetterselo. Il compito spettava a una destra liberale, democratica, laica, e in Italia a rappresentarla c’era quasi esclusivamente la torreggiante figura di Pannella. Ma senza quella spinta, la sua e spesso solo la sua, sarebbe stato impossibile arginare la tendenza del Pci a svendere il divorzio pur di non entrare in rotta di collisione con le masse cattoliche e con il partitone che le rappresentava.
Anche nella battaglia strenua, a volte epica, ingaggiata tra la seconda metà dei ’70 e l’intero decennio successivo, quella per i diritti e le garanzie contro le emergenze e le ingiustizie che venivano quotidianamente perpetrate in nome della giustizia, è tangibile, inconfondibile, un’impronta che risale più alla grande destra liberale che non alla sinistra. Non c’erano solo interessi di bottega dietro lo schieramento del Pci a favore dell’emergenza, allora. C’era anche un intero pensiero che, al fondo, considerava l’interesse di Stato infinitamente superiore alla difesa dei diritti, e che in nome di quell’interesse era pronto a violentare il diritto come avvenne il 7 aprile, o a far passare per matto un leader sequestrato pur sapendo di condannarlo così a morte.
Non è un caso che Pannella sia stato tra i pochissimi a opporsi a quella cultura guidata solo dalla miopia della ragion di Stato, di fronte alla quale capitolarono con scomposto entusiasmo anche tanti sedicenti liberali, Repubblica in testa. Per chi veniva dalla cultura crociana, inutile negarlo, stare dalla parte di Antigone era più facile che per chi arrivava da quella marxista, che si trattasse del terrorismo e Toni Negri o della camorra e di Enzo Tortora, vittima di un «effetto collaterale» della campagna contro le mafie fondata sui pentiti.
Per indole e carattere, per il suo istrionismo innato, Marco Pannella spettacolarizzava al massimo ogni campagna, e nell’uso della comunicazione era anche più astuto ed esperto di quanto apparisse. Così, le sue battaglie potevano sembrare, in superficie, venate da infatuazioni un po’ donchisciottesche per questa o quella causa. Invece erano sorrette da un impianto coerente e rigoroso. Quando muoveva contro la magistratura, il suo non era semplice garantismo: era la consapevolezza che negli ’80 un potere dello Stato aveva preso a invadere aree di altrui competenza, e che i risultati sarebbero stati comunque esiziali. Quando offriva spinelli in giro per le strade, non si trattava solo di una trovata libertaria, ma della coscienza di quanto l’intero impianto costituzionale fosse minato dal disattenderne i princìpi in materia di libertà individuali.
Nell’ultimo scorcio della prima Repubblica nessuno aveva denunciato l’occupazione dello Stato da parte dei partiti più del Partito radicale. Però, quando quel castello venne giù in pochi mesi come una torre di fiammiferi, Pannella non fu tra quelli che brindarono ebbri, a differenza di tanti che quel sistema lo avevano sin lì coperto e supportato senza vergogna. Marco credeva nella Costituzione come pochi. In nome della Costituzione aveva ingaggiato un duello durato 15 anni con l’amico Cossiga. Per difendere la Costituzione era stato il vero regista dell’elezione di Oscar Scalfaro. In quel tripudio che tintinnava di manette, nei giorni di tangentopoli, avvertiva un lezzo che con la Costituzione repubblicana aveva poco a che spartire.
Per noi di sinistra Marco Pannella è un caso unico. Siamo stati al suo fianco e lo abbiamo applaudito tante volte. Ce lo siamo trovati di fronte e ci ha fatto digrignare i denti in altrettante occasioni. E’ quello che capita con la miglior destra, anzi che capiterebbe se ci fosse: ringrazi il cielo perché esistono quando si tratta di diritti e libertà, ti tirano pazzo quando difendono il liberismo. Però sai che se in Italia ci fossero stati più uomini come Marco Pannella, oggi sarebbe un Paese migliore.
Il manifesto
CON PANNELLA UN INCONTRO-SCONTRO DURATO TUTTA LA VITA
di Luciana Castellina
Marco Pannella 1930-2016. Una vita politica insieme, ma io comunista, lui liberal democratico. La sua onestà, la sua cocciuta ostinazione nelle battaglie a favore di cause sacrosante sono una ricchezza politica del nostro tempo

Credo di essere la persona ancora vivente che ha conosciuto da più tempo Marco Pannella, molti dei nostri amici coetanei essendo già passati altrove (sicuramente in paradiso), i più giovani non avendo avuto l’aspro privilegio di una amicizia/inimicizia lunga come la nostra, cominciata addirittura nell’anno accademico 1947/’48.
Ci siamo incontrati al primo anno della facoltà di giurisprudenza di quella che oggi viene chiamata La Sapienza, ma allora semplicemente Università di Roma, perchè a quei tempi ce n’era una sola e non occorreva specificare.
Era ancora piena di fascisti, anche piuttosto picchiatori, riuniti nel gruppo “Caravella”, e un bel po’ di cattolici molto moderati, capeggiati da Raniero La Valle (ora, più a sinistra di me, per fortuna).
Sia io che Marco eravamo dall’altra parte, laici e antifascisti: ma io ero già comunista, lui liberal-democratico.
Siamo restati così per tutta la vita.
Cominciammo subito come avversari: c’erano le prime elezioni per l’Interfacoltà, il parlamentino studentesco, e io concorrevo candidata insieme ad Enrico Manca, socialista (poi dirigente di primo piano del Psi e anche presidente della Rai), per la lista Cudi (centro universitario democratico italiano, in cui si identificava tutta la sinistra), lui per la lista cui aveva dato, come abitudine, un nome stravagante: “Il Ciuccio”. Che era però emanazione della già assai famosa Unione Goliardica, l’Ugi.
Di questa organizzazione Marco fu presidente per un decennio ed ebbe il merito di politicizzarla, sicché è proprio dalle sue fila che uscì negli anni ’60 quasi tutto il ceto dirigente laico della prima Repubblica (per il bene e per il male del paese). Anche noi comunisti finimmo per confluire nell’Ugi a metà degli anni ’50, quando la divisione del mondo, che dopo il 18 aprile ’48 ci aveva confinato nella parte esclusa, si frantumò e anche nelle Università diventammo normali. Vi entrai anche io, superando con qualche difficoltà l’odio che l’Ugi mi aveva lasciato al suo primo incontro importante: al primo congresso nazionale dell’Unuri (il parlamentino nazionale studentesco), quando osai prendere la parola e fui accolta da un coro maschile (di femmine non ce n’erano quasi) che mi gridò «passerella passerella». Intervenire per una donna era come fare lo streap tease, per fortuna avevo la pelle dura altrimenti non avrei più parlato per tutta la vita. Marco, comunque – sebbene presidente – con quelle schiamazzate non solo non c’entrava, ma fu proprio lui a redimere l’organizzazione e gliene rendiamo tutti merito.
Della questione femminile anzi si è per tutta la vita occupato molto, soprattutto da quando nacque il Partito radicale e all’orizzonte comparve Emma.
Proprio per via di divorzio e poi aborto ci siamo ritrovati con Marco, con cui posso dire di aver trascorso quasi l’intera vita fianco a fianco. Prima nelle battaglie universitarie, cui sia io che lui abbiamo partecipato in prima persona fino in tarda età, lui perché insostituibile leader dell’Ugi, io perché direttore di “Nuova Generazione”, cui, essendo il settimanale della federazione giovanile comunista, correva l’obbligo di seguire da vicino le vicende studentesche. In seguito, salvo una breve “vacanza” a cavallo fra i ’50 e i ’60 (quando Marco si trasferì a Parigi e molto e proficuamente si occupò di Algeria) per via, dell’esplodere della questione divorzio, quando i radicali furono la punta di diamante della battaglia a favore del primo progetto di legge firmato dall’onorevole socialista Loris Fortuna.
Combattemmo ancora una volta sullo stesso fronte, ma ancora una volta litigando. Io lavoravo a Botteghe Oscure nella sezione femminile con Nilde Jotti, impegnate a convincere un assai conservatore Pci che la questione era matura, e però ben convinte che se il diritto a rompere il matrimonio non fosse stato accompagnato da una riforma del codice familiare che riconoscesse alla donna qualche diritto (alla casa, al riconoscimento monetario del suo apporto all’economia domestica anche quando casalinga, ecc.) la eventuale vittoria sarebbe stata un disastro per la grande maggioranza.
Non fummo d’accordo neppure sull’aborto, per il quale, tuttavia, ci battemmo di nuovo insieme: i radicali volevano di più, noi del Manifesto-Pdup considerammo la legge ottenuta – la più avanzata di tutta Europa perché l’interruzione di maternità veniva mutualizzata e dunque garantiva le donne prive di mezzi finanziari – come qualcosa da difendere; e infatti così ci schierammo quando poi i clericali promossero il referendum per la sua abolizione.
Nel frattempo, nel 1976, eravamo entrati alla Camera dei Deputati: i radicali con 4 deputati, noi, con la lista di sinistra chiamata Democrazia Proletaria, con 6. Gruppi così minuscoli in parlamento non si erano ancora visti mai e non c’erano nemmeno i locali per alloggiarli. A lungo i funzionari cercarono di convincerci a stare tutti e 10 assieme: rifiutammo con decisione da ambo le parti e l’amministrazione di Montecitorio fu costretta ad erigere un muro divisorio in un ampio ambiente, sfrattando fra l’altro il povero Bozzi, a capo di uno storicissimo partito, quello Liberale, che però, in quella tornata di deputati ne aveva avuto solo 2.
(Battuta, credevamo definitivamente, la Legge Truffa del 1953, eravamo anni luce dall’ipotizzare che sarebbe un giorno arrivato l’Italicum a privare il paese dell’apporto di gente come noi).
Il periodo più aspro del mio rapporto con Marco Pannella ebbe inizio qualche anno più tardi, nel 1979, quando tutti e due ci ritrovammo nel primo Parlamento europeo eletto direttamente.
Anche se per cinque anni, per la prima volta, restammo nel medesimo gruppo. Che tuttavia, per prudenza e ben consapevoli delle nostre differenziate visioni del mondo, decidemmo di chiamare “Gruppo di coordinamento tecnico”. Per sottolineare che quanto ci univa era solo il bisogno, nel senso che il regolamento di Strasburgo non consentiva mini aggregazioni. Insieme anche ai nazionalisti fiamminghi, a Antoinette Spaak dissidente socialista belga e a un deputato irlandese vicino all’Ira, abbiamo attraversato la prima legislatura della nuova istituzione dividendoci su un sacco di cose: su Arafat, contro cui i radicali organizzarono picchetti quando per la prima volta venne al Parlamento europeo ospite del gruppo socialista; e poi sul voto per il riconoscimento dell’African National Congress di Nelson Mandela ( ancora in carcere). Ambedue le volte perché guerriglieri, in paesi – Israele e Africa del sud – dove c’era un bel parlamento.
Sono stati scontri aspri, così come quello sul finanziamento dei partiti e in contrasto con i sindacati, definiti “Trimurti”. Insomma, come avete capito da questo racconto: una vita assieme e però mai d’accordo. Eppure mai nemici davvero, anzi, umanamente amici: con Emma in particolare, ma anche con l’impossibile Marco. Io gli ho voluto bene, e credo anche lui me ne volesse. Eravamo sempre contenti quando ci capitava di incontrarci.
Riconosco i suoi meriti per aver reso popolari, di pubblico dominio, problemi su cui nessuna forza politica si è mai impegnata a sufficienza, la questione carceraria innanzitutto. La sua onestà e la sua cocciuta ostinazione nelle battaglie a favore di cause sacrosante sono una ricchezza politica del nostro tempo.
Se abbiamo molto litigato è perché ci ha diviso una cultura politica che per ognuno di noi era irrinunciabile e l’una dall’altra per molti aspetti distante, ma mai tanto da non vederci, alla fin fine, dalla stessa parte della società. Diversa, per via di una visione della democrazia: come libertà individuale assoluta per lui, il primato del “noi” sull'”io”per me.
Ma santiddio: si è trattato sempre di un confronto politico serio; ed è per questo che ora che è scomparso provo non solo dolore personale, ma anche tristezza politica: per la nostalgia di un tempo in cui noi quasi novantenni abbiamo vissuto, che è stato un tempo bellissimo, perché bellissima è la politica. Quando è veramente politica. Lo è quando ognuno avverte il dovere, la responsabilità, di impegnarsi a rendere il mondo migliore.
Marco Pannella va ricordato per questo; ed è molto.
Il manifesto
«PANNELLA, LO SCOMODO NECESSARIO»
intervista di Daniela Preziosi a Andrea Orlando
Il ministro della Giustizia: sembrava una provocazione e invece la sua intransigenza è stata sempre utile a non accontentarsi prima dell'obiettivo. Per i detenuti è stato un idolo: perché in questi anni, insieme a papa Francesco, è stato l’unico a tenere accesi i riflettori su un mondo su cui la società preferisce spegnerli. Perché le carceri sono un luogo in cui si realizza un esorcismo: segregati i pericolosi, l’ordine è ristabilito. Come se la società fosse una cosa totalmente diversa, e i suoi problemi fossero diversi da quelli che si riversano sul carcere: un’altra delle cose che ci ha insegnato
L’ultima volta che si sono visti è stato lo scorso 26 marzo. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando era andato a trovare Marco Pannella da giorni «ristretto» per la malattia nella sua casa-studio di Roma. Era d’accordo con chi lo accudiva, ma all’insaputa del leone malato. La sorpresa, oltre alla visita del Guardasigilli, era la compagnia: Orlando era accompagnato da quattro detenuti del penitenziario romano di Rebibbia, due ragazze e due uomini, dal vicedirettore del carcere e dalla vicedirettrice del femminile.
C’è una bella foto che testimonia l’allegria di Pannella per quella visita «dei detenuti e dei detenenti, così aveva detto», ricorda Orlando, «me l’aveva proposta Rita Bernardini. Mancava poco a Pasqua, per la prima volta dopo molti anni Pannella non riusciva ad andare a visitare i detenuti durante le feste. E allora gliene abbiamo portato alcuni a casa. Lui parlava a fatica ma era stato illuminato da questa “splendida riunione”, così l’aveva chiamata. Aveva parlato di speranza in quel suo modo torrenziale, e in stretto dialetto abruzzese».
Ministro, chi era Pannella per lei quand’era un giovane militante della sinistra?
Vengo da una famiglia di comunisti che ha vissuto gli anni 70, quelli del terrorismo, della vicenda di Toni Negri (allora leader di Autonomia operaia, condannato per complicità con le Br, poi eletto con i radicali e rifugiato in Francia grazie all’immunità, ndr), che guardava i radicali magari come compagni di strada nelle battaglie per i diritti civili, ma per tutto il resto con enorme diffidenza, conseguenza anche delle loro provocazioni. Una diffidenza che spingeva a contrapporre in modo talvolta frontale diritti civili e sociali. Ho capito fino in fondo l’insufficienza di questa lettura quando ho cominciato a occuparmi di giustizia. Non solo perché il superamento di questa contrapposizione ha segnato tuta la sinistra storica, superando retaggi ideologici, ma anche perché abbiamo capito che il tema dei diritti è un tutt’uno nella trama della società.
Invece, da ministro, chi è stato per lei Pannella?
Prima da responsabile giustizia del Pd e poi da ministro ho apprezzato che i radicali, e Pannella innanzitutto, si sono seduti qualche volta dalla parte del torto, altre dalla parte della ragione, ma comunque non hanno mai scelto dove sedersi per ragioni di opportunismo. Perché ritengono che la loro missione sia rivendicare uno spazio di libertà anche dove si registrano alti tassi di conformismo, soprattutto nei tornanti importanti della nostra storia. Soprattutto dove ci sono quelli più difficili da difendere, le persone oggetto dello stigma sociale. Ho capito l’importanza del loro controcanto che si basa sul riconoscimento della dignità delle persone a prescindere dalla condizione e dal loro vissuto.
Da ministro ha avuto rapporti complicati con Pannella?
Quello che rende difficile il rapporto con i radicali, è il fatto che Pannella ha insegnato loro di rifiutare l’idea gradualistica. Ha sempre posto le questioni con intransigenza. Per me, che concepisco la politica invece come riforme e magari anche come piccoli passi successivi, avere a che fare con loro è sempre complicato: perché è difficile tenerli in squadra. Ma ho capito che segnare la posizione estrema è un modo per ricordare la direzione di marcia, per evitare che ci si accontenti del compromesso. Che è sempre necessario, ne sono convinto, ma non può mai essere considerato un punto di arrivo.
Poi però l’anno scorso lei fece un discorso inedito per un Guardasigilli, a proposito delle carceri che rischiano «di produrre crimine più che ridurlo». E lì Pannella le fece grandi complimenti.
Naturalmente poi i radicali mi hanno contestato per non aver tratto tutte le conseguenze della mia affermazione. Ma per me quella è stata una medaglia, tanto quanto gli obiettivi quantitativi raggiunti e i riconoscimenti internazionali del lavoro che abbiamo fatto. Vede, io vengo descritto come un politico prudente, cauto; e invece in quell’occasione aver incrociato il suo punto di vista è stata la conferma di aver posto una verità scomoda. Cosa che poi ho verificato concretamente nei mesi successivi.
Perché?
Perché parlare di carcere non porta consenso, non è glam, non dà ritorni di immagine in una società, la nostra, profondamente spaventata ed esposta agli imprenditori della paura. Senza nessuna ambizione eroica ho capito che quel riconoscimento era il segno che stavo provando a fare cose giuste. Governare non può essere solo ricerca di consenso facile ma anche farsi carico di persone che non hanno voce, possibilità di incidere, né forse rilevanza politica.
Subito dopo sono arrivate le critiche dei radicali, anche nel corso degli Stati generali dell’esecuzione penale.
(Sorride) È l’ineluttabile condizione di chi interloquisce con i radicali. All’inizio pensavo che non si facevano carico delle compatibilità, dei punti di partenza. Ma ora penso che la loro forza è quella di non farsi imprigionare dalle condizioni date, dal senso comune, dagli elementi di inerzia del sistema. Le loro polemiche, per quanto provocatorie, non sono mai fini a se stesse. Quel po’ che siamo riusciti a fare, che per me è molto, è anche frutto del loro stimolo.
Su alcuni aspetti della società italiana i radicali hanno ’fatto egemonia’, hanno vinto anzi convinto, come diceva Pannella: su aborto, divorzio, diritti civili. Sulla giustizia invece no: oggi il dibattito pubblico è spesso segnato da un profondo giustizialismo. Quella del garantismo è una battaglia che non hanno vinto, o ancora vinto?
È la battaglia più difficile in questo momento. La nostra è una società che resiste a riconoscere diritti che hanno un carattere così lontano dal senso comune. Ma il valore e la credibilità dei radicali sta proprio nel fatto che hanno saputo fare battaglie nella direzione dei tempi ma anche battaglie controvento con la stessa determinazione.
Anche lei frequenta spesso le carceri. Cos’era Pannella per i detenuti?
Un idolo. I quattro che gli ho portato a casa, in quella visita di marzo, erano emozionatissimi. Per venire hanno rinunciato al giorno di permesso. Ma Pannella è un idolo per tutto il mondo del carcere, la polizia penitenziaria, dottori, psicologi. Tutti, diceva lui, «condividono una comunità di destino». Ed è un idolo perché in questi anni, insieme a papa Francesco, è stato l’unico a tenere accesi i riflettori su un mondo su cui la società preferisce spegnerli. Perché le carceri sono un luogo in cui si realizza un esorcismo: segregati i pericolosi, l’ordine è ristabilito. Come se la società fosse una cosa totalmente diversa, e i suoi problemi fossero diversi da quelli che si riversano sul carcere. Un’altra delle cose che ci ha insegnato.
Marco Pannella lascia un’eredità, oppure un vuoto?
Entrambe le cose, perché mentre il riconoscimento di alcuni diritti, spinti dalla trasformazione della società, è un campo arato che continuerà a dare frutti, penso alla recente legge sulle unioni civili, sui diritti più scomodi, sulle battaglie meno corrispondenti al senso comune, quelle in contrasto con ogni demagogia, non vedo molte figure in grado di colmare quel vuoto e di portare le denunce e la testimonianza sino al punto in cui ha saputo portarle Marco Pannella
I CARTELLI E I DIGIUNI COSÌ USAVA IL CORPO
di Pierluigi Battista
Pannella sulla scena italiana era diverso da tutti gli altri. La sua irruenza ha demolito muri di diffidenza e imposto i diritti degli individui a Dc e Pci che li ignoravano
Il nome di Marco Pannella evoca tante conquiste, tante battaglie, tanti eccessi. Tante immagini, soprattutto, legate indissolubilmente a un leader politico che ha combattuto con il corpo, con l’immagine e la materialità del corpo, in quell’agone politico italiano che ai tempi della fragorosa irruzione pannelliana trattava il corpo come un fastidioso impaccio, qualcosa di cui diffidare nel dominio incontrastato del concettismo ideologico. Pannella entrò invece anima e corpo, letteralmente, nella scena politica italiana. Com’era diverso da tutti gli altri, quell’oratore sottile e allampanato, la chioma ancora più arruffata e candida nel contrasto con il maglione nero indossato alla maniera dell’esistenzialismo francese. Diverso con il cartello perennemente attaccato al collo nelle manifestazioni a favore del divorzio. Diverso nella sua scheletrica magrezza nel corso di qualche sciopero della fame e della sete. Diverso quando si faceva immortalare imbavagliato alle telecamere. Con la sigaretta sempre accesa, anche dopo l’operazione al cuore, già avanti con l’età. O quando si concedeva all’arresto della polizia durante qualche manifestazione di disobbedienza civile. Diverso quando passava il Natale e il Capodanno a battagliare per l’amnistia o in compagnia dei detenuti, per rivendicare il rispetto costituzionale della dignità degli individui, anche, anzi soprattutto di quelli che scontano la pena in carcere per i loro errori: «Nessuno tocchi Caino».
Marco Pannella ha commesso moltissimi errori, dettati da quella che con la terminologia cristiana si chiamerebbe superbia e da incontenibile autostima: se ne accorgeva anche lui, anche se non lo avrebbe mai ammesso, orgoglioso com’era. Ma nel computo delle ragioni e dei torti, i primi hanno decisamente surclassato i secondi. Un eccesso di sospettosità lo portava a diffidare delle figure forti che dentro e fuori il Partito radicale, nella nuova guardia o tra gli amici fiancheggiatori, avrebbero potuto offuscarne la splendida solitudine. Si innamorava troppo spesso delle sue stesse parole, senza accorgersi delle modalità vagamente castriste verso cui lo portava la sua oratoria torrentizia. Talvolta non sapeva resistere al suo lato fortemente profetico ed ecumenico, piegando il Partito radicale a un ruolo di testimonianza un po’ sterile nella battaglia, in sé meritoria, contro la fame nel mondo. E non si accorse, attorno agli anni Novanta, del logoramento dell’istituto referendario, schiacciato da una proliferazione di quesiti non sempre sentiti dall’opinione pubblica, stressato da un abuso che alla fine ha portato allo svilimento del referendum stesso.
Ma gli errori costellano inevitabilmente ogni impresa politica che abbia il respiro e le ambizioni delle trasformazioni storiche. E nessun errore potrà offuscare la semplice, elementare constatazione: Pannella ha portato nel cuore della battaglia politica una bandiera sconosciuta prima, o silenziata, o messa ai margini, il vessillo dei diritti civili. Una dimensione estranea alla maggioranza delle culture politiche che si erano cimentate negli anni dell’allora giovane Italia repubblicana, in gran parte insensibili alle tematiche dell’individuo moderno, dell’individualismo, delle libertà individuali, ispirate a forme più o meno intransigenti di collettivismo, di comunitarismo, in cui il primato dello Stato, del pubblico, del partito, della storia, della classe, della chiesa erano dogmi di larghissimo uso.
Con la battaglia per il divorzio, Pannella contribuì a scardinare questo ordine di priorità. I «diritti» degli individui non erano contemplati dalla cultura di matrice cattolica che pure aveva una visione della «persona» che voleva sottrarla dalle spire soffocanti dello Stato. Non erano considerati dalla sinistra di cultura comunista, che li liquidava come superflui, emanazione di una sensibilità borghese estranea ai bisogni «popolari» (mica si divorziava, nelle famiglie della classe operaia!). E non avevano molto spazio nella sinistra di cultura socialista e laica, anche se i firmatari della legge sul divorzio erano in fondo un socialista, Fortuna, e un liberale, Baslini.
Ma Marco Pannella agitò le acque della politica italiana facendo dei diritti civili l’ariete che avrebbe demolito il muro di diffidenza nei confronti degli individui che di quei diritti erano i legittimi portatori. E fece irruzione nella politica italiana con un’irruenza che metteva in gioco ogni frammento della propria presenza pubblica. La sua battaglia per la «giustizia giusta», qualche anno dopo quella sul divorzio e sull’aborto, nel decennio degli Ottanta, quando l’Italia conobbe la mostruosa manipolazione giudiziaria ai danni di Enzo Tortora, fisicamente massacrato da un uso abnorme dei poteri di una magistratura appoggiata dal coro dei media, sfidò il conformismo, il quieto vivere, l’assuefazione di molti italiani alle iniquità di un sistema che non conosceva i contrappesi liberali del diritto e dell’equilibrio. E per fortuna Pannella e i Radicali trovarono in questa battaglia garantista e di civiltà l’appoggio incondizionato di una figura inquieta e irregolare come Leonardo Sciascia, che per questo subì il rito della scomunica da parte di una sinistra prigioniera delle sue ossessioni illiberali.
Anche per questo Marco Pannella fu molto diffamato dal coro dei conformisti e dei pasdaran dei poteri costituiti e delle ortodossie ideologiche che salutarono con entusiasmo l’incidente del Toni Negri che fuggì all’estero dopo essersi munito dell’immunità parlamentare con l’elezione nelle liste dei Radicali. Che si scandalizzarono quando Pannella, con un gusto del gesto imprudente che però faceva parte del suo bagaglio esistenziale e culturale, promosse l’ingresso della pornodiva Cicciolina nelle ingessatissime e perbeniste aule parlamentari. E che non capirono il Pannella che si rifiutava di adeguarsi al furore giustizialista che stava accompagnando la tempesta di Manipulite, quando il leader radicale prese provocatoriamente sotto la sua protezione il «Parlamento degli inquisiti» e si avvicinò al Bettino Craxi, suo vecchio compagno di battaglie universitarie, che in quegli anni stava conoscendo l’onta del linciaggio o dell’abbandono di chi era stato illuminato di luce riflessa all’epoca dei trionfi del Garofano craxiano.
Il Pannella che nella battaglia politica aveva messo tutto se stesso, a cominciare dal corpo continuamente traumatizzato dagli scioperi della fame, può essere ricordato come il campione dei diritti civili e del garantismo nell’Italia che si vorrebbe culla del diritto ma che invece dello Stato di diritto ha voluto scavare la tomba. Un leader ancorato nella sinistra ma che non ha mai sottaciuto i limiti e le meschinità della sinistra storica maggioritaria. Che ha intrattenuto rapporti tempestosi con i suoi stessi compagni, a cominciare da Emma Bonino al suo fianco da decenni, fino a essere accusato di essere un Crono avvezzo a divorare i suoi figli, uno dietro l’altro. Un leader che ha messo in gioco tutto, anche i rapporti personali, anche tutt’intera la sua umanità, il suo corpo, la sua icona, carnale e ascetica insieme. Fuori dagli schemi consolidati, sempre .
«TRA NOI NESSUNA CORSA A CONVERTIRCI MA VOLEVA TENERSI LA CROCE DI ROMERO»
intervista di Gian Guido Vecchi a Vincenzo Paglia
Città del Vaticano «Quando ha visto la mia croce pettorale, mi ha chiesto da dove veniva. Ho spiegato a Marco che era la croce dell’arcivescovo Óscar Romero, del quale avevo seguito come postulatore la causa di beatificazione. Gli raccontavo che Romero era stato ucciso perché si scagliava contro un’oligarchia oppressiva, per difendere i poveri, forte solo della sua parola e della radio che diffondeva i suoi messaggi, tanto che a volte gliela facevano saltare. E questa cosa lo entusiasmava, mi ha preso la croce, se la rigirava fra le mani, se l’è pure messa, non voleva più ridarmela...». L’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente del pontificio Consiglio per la famiglia, sorride con un velo di mestizia. Con Pannella si sono parlati ancora la settimana scorsa, l’ultima volta che l’ha visto è stato mercoledì, in ospedale, «ma non ho potuto salutarlo ancora, era già sedato, ho detto una preghiera per lui».
Chissà che avrebbe detto...
«Ah, ma lui lo sapeva! Gliel’avevo detto: ti seguo con la preghiera, eh? E lui mi abbracciava. Eravamo amici. Non c’era, tra noi, una corsa a convertirci, ma ad approfondire la nostra amicizia rispettosa e fraterna. Noi siamo uno, mi ha detto, “siamo ecclesia!”. Ha voluto bere dal mio stesso bicchiere».
È vero che gli ha portato un messaggio del Papa?
«Aveva scritto una lettera a Francesco, mi ha chiesto di fargliela avere e l’ho portata al Santo Padre. Voleva sapesse che lo stimava molto: capisco e ammiro quello che Francesco sta facendo, diceva. Ne parlava spesso, come pure di Wojtyla. Nel giorno del compleanno di Marco, il Papa come risposta ha voluto mandargli in dono il suo libro sulla Misericordia e una medaglia che raffigurava la Madonna con Bambino. Li ho portati a casa sua, riferendogli le parole di Francesco: anche lui gli ha fatto sapere che lo apprezzava».
La sintonia sul tema delle carceri, l’impegno contro la fame o la pena di morte. Ma c’erano anche motivi di forte divisione, con la Chiesa, dall’aborto all’eutanasia, no?
«Certo, e ci siamo anche contrastati con franchezza, senza che questo incrinasse il nostro rapporto. Però, ultimamente, parlavamo d’altro. Mi aveva chiamato all’inizio di marzo, quando non poteva più uscire di casa: voglio parlare con te, mi ha detto. Da allora andavo a trovarlo più o meno ogni dieci giorni».
E di che parlavate?
«Ci sono cose tra amici che restano nella coscienza. Era interessato soprattutto ai temi spirituali. Ricordo quando il vento muoveva i rami, fuori dalla finestra, e lui esclamò: quello è lo spirito che agisce e muove la storia, è più forte di tutto!, e dobbiamo lasciarci guidare da questo soffio: vedi i gabbiani che volano? E continuava: se penso alla mia vita, ho lottato; la testimonianza è la nostra vera forza. Ecco, gli piaceva riflettere per ore di tutto questo... Con me amava parlare del Vangelo, delle parole di Gesù, della speranza».
Si definì «diversamente credente». Lei che ne dice?
«Talvolta mi diceva: credo sia il Vangelo la fonte che mi ispira e mi guida, del resto era un pilastro anche per Gandhi! Amava una frase di San Paolo, “spes contra spem”: di fronte alle manifestazioni di violenza e di crudeltà di questo mondo, ripeteva, credo che dobbiamo continuare a opporci anche contro ogni speranza, anzi dobbiamo essere speranza».
Personalità complessa...
«Su questo non c’è dubbio. Una volta, scherzando, gli ho detto: il tuo angelo è un po’ come San Marco, un leone! E lui: vero, io mi sento un leone! Non si rassegnava, non era rassegnato».
Poche settimane fa aveva detto: «Non ho paura di morire. E poi altri vent’anni così, sai che palle!». Avete parlato della morte?
«Non in astratto, ma rispetto all’amicizia. Noi siamo anziani, gli dicevo, ma io spero di restare tuo amico per sempre, anche se ci tocca morire ci dobbiamo ritrovare; e sono sicuro, caro Marco, che quando staremo davanti a Chi ci giudica, dalla folla si alzerà qualcuno di quei milioni di affamati che dicono: Marco ha lottato per noi! E questo ti varrà tanto. Lui mi abbracciava, a volte non finivamo di abbracciarci».
Pur nelle ovvie differenze, che cosa ha trovato di ammirevole nella vicenda politica di Marco Pannella?
«Lo spendere la vita negli ideali in cui ha creduto, senza fare di questi ideali un piedistallo per arricchirsi o avere un potere che non fosse quello della sua parola e delle sue idee. Credo sia questo che in lui ha apprezzato anche Francesco. Un uomo che è sempre stato ricco delle sue idee».
 In ricordo di Umberto Eco. Articoli di Claudio Magris, Fabio Mussi, Ezio Mauro e l'intervista di Benedetto Vecchi ad Alberto Asor Rosa.
In ricordo di Umberto Eco. Articoli di Claudio Magris, Fabio Mussi, Ezio Mauro e l'intervista di Benedetto Vecchi ad Alberto Asor Rosa.
Corriere della Sera il manifesto, la Repubblica, 21 febbraio 2016 (m.p.r.)
Corriere della Sera
IL MIO OMAGGIO AL GENIO DI ECO
CHE SAPEVA CAMBIARE (E RIDERE)
di Claudio Magris
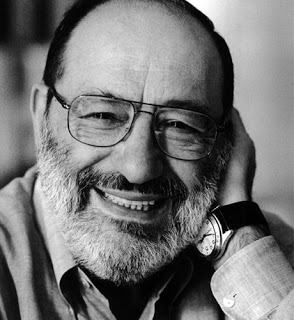
In questo momento non penso solo alla poliedrica genialità di Umberto Eco, ai suoi libri famosi in tutto il mondo, alla sua rara combinazione di creatività letteraria e acutezza analitica. Penso ai nostri incontri, soprattutto anche se non solo agli indimenticabili giorni passati insieme tanti anni fa nella devastata Romania di Ceausescu, alla nostra complicità affettuosamente gaglioffa, alla sua capacità di ricominciare, come stava accadendo con il suo impegno per la fondazione di una nuova casa editrice. Dei suoi libri vorrei ricordare uno che non è il più grande né il più famoso ma che mi ha segnato, Apocalittici e integrati – un libro scritto molti anni fa ma oggi più che mai attuale per affrontare le incredibili, sconvolgenti trasformazioni del mondo e della vita con libero spirito critico, senza ansiosi e ossessivi rifiuti, e senza servile e passiva acquiescenza. E penso a tante fraterne risate che aiutano a vivere meglio.
Il manifesto
RIDERE PER CONOSCERE:
LA RIVOLUZIONE DI ECO
di Fabio Mussi
L'eredità. L’ultima lezione: per una sinistra di alternativa e di governo, sapere è l’indispensabile
«E l’infame sorrise». È Franti, il cattivo di Cuore. Tra le figure della scuola lacrimosa, pia e bigotta del De Amicis a Umberto Eco piaceva Franti. Ha scritto un Elogio di Franti. Perché? Perché rideva. Eco sapeva ridere, Eco rideva. Se volessimo usare il suo fondamentale «Trattato di semiotica generale», e dare una «interpretazione» del «segno» di Eco, eccola: il riso. Nel Nome della rosa - ricorderete - Guglielmo di Baskerville indaga su una catena di delitti consumati in abbazia. I delitti servono a nascondere un documento su un indicibile segreto: Cristo aveva riso. Atto sovversivo, apocalittico, cioè rivelatore. Primo insegnamento da mandare a mente: si è seri solo se si è capaci di ridere, anche di noi stessi.
Ho avuto il piacere e l’onore di incontrarlo più volte. È impressionante quel che sapeva, i collegamenti e i nessi che era in grado di intrecciare. Un aggettivo per la sua cultura? Sterminata. Secondo insegnamento: studiate. Senza studiare la politica non può essere né buona né nuova. Si rafforza per esempio in me l’impressione che noi non sappiamo quasi nulla della ipertrofica macchina economica mondiale che governa gli umani. Esoterica, come la storia del Pendolo di Foucault. Eco si è letteralmente tuffato nel Medioevo. La sua non è stata una ricerca erudita su tempi lontani. Ha fatto scoccare piuttosto la scintilla tra Medioevo ed Evo moderno, nei labirinti di simboli, enigmi, mostruosità, occultismi. Gioco di ombre e di luci.
«Secoli bui» sono stati chiamati quelli antichi. Ma non c’è tanto buio anche nel Moderno? Forse che l’assolutismo del capitale finanziario non sta spingendo la società umana verso un medioevo a più alto livello tecnologico? Non c’è tribalismo, razzismo, antisemitismo, fondamentalismo religioso, fanatismo, pensiero magico, banalità e piacere dello strazio dei corpi che non trovi facile cittadinanza nel mondo globalizzato? Sapete che cosa mi meraviglia, mi sorprende, e mi convince, delle parole lette ed ascoltate da Eco? Il considerare la storia del mondo, almeno dalla scrittura in poi (e non dimenticate che tutto è cominciato in quelle terre che oggi chiamiamo Siria e Iraq), come contemporanea. Si può parlare con il vicino di casa come con Guglielmo di Occam. Lo cito perché è uno degli autori più amati da Eco, ed è noto per il famoso «rasoio».
Una teoria razionalista che qualcuno pone tra i fondamenti della scienza moderna. Dice in sostanza il «rasoio»: non bisogna formulare più ipotesi di quelle necessarie, non bisogna dire più del necessario. Il resto, si direbbe con la moderna teoria dell’informazione, è «rumore», che confonde e maschera l’informazione. Parlo con Guglielmo, e mi chiedo assai spesso quanto devo «tagliare» – faccio un esempio a caso - del diluvio di parole del Presidente del consiglio in carica in Italia per capire esattamente che cosa vuole dire e fare.
Ecco ancora Umberto Eco: Occam e Mike Buongiorno, il basso e l’alto, le profondità della grande cultura e la fenomenologia della vita quotidiana. Egli è stato tra i grandi studiosi della società di massa, e della comunicazione nella società di massa. Il suo Apocalittici ed Integrati è un pilastro. Da cui trarrei per farla breve la terza raccomandazione: se si vuol fare una sinistra che si rispetti non bisogna essere apocalittici. Ma non si può nemmeno essere integrati. E nella comunicazione, se il mezzo non è esattamente il messaggio, tuttavia lo influenza. Sono noti gli scritti di Eco sull’ambivalenza del Web. Ha detto: se un cretino va al bar e spara fesserie, gli astanti lo sfottono. Se va su Facebook, trova legioni di seguaci. Come il leone e la gazzella, intelligenza e stupidità ogni mattina si alzano e si mettono a correre.
Sulla rete circolano entrambe. Ma la stupidità parte con un vantaggio: la velocità. La verità è che l’intelligenza ha bisogno del dubbio, dell’approfondimento, del ripensamento: dell’esitazione. E c’è un Eco politico, impegnato e battagliero. Egli è stato fieramente antiberlusconiano, fino a rifiutare la collaborazione con l’oligopolio editoriale di «Mondazzoli», e aderire al progetto della neonata «nave di Teseo», per la quale - ahimé! - non ha avuto il tempo di scrivere nulla. E voglio dire che, nonostante tante chiacchiere, se nel ventennio di Benito non si poteva dirsi democratici senza essere antifascisti, nel ventennio di Silvio non ci si è potuti chiamare democratici senza essere antiberlusconiani. Sperando naturalmente anche che la serie dei ventenni sia esaurita.
E voglio ricordarlo anche in una particolare occasione: Castello di Gargonza, 1997, governo Prodi da poco costituito. Mi capitò di essere tra i relatori. A favore della coalizione di centrosinistra chiamata «Ulivo». Trovai Eco tra i più convinti sostenitori. Prevalsero i tagliatori d’alberi. Resta il ricordo di ore indimenticabili passate con lui. E il rammarico per una delle molte occasioni gettate al vento. Vediamo di non buttarle tutte al vento. Dipende dalla sinistra che saremo. Una sinistra di alternativa e di governo. Ricordando che, e per l’alternativa e per il governo - traggo quest’ultima raccomandazione dalla vita e dall’opera di Umberto Eco - una cosa è indispensabile: sapere.
La Repubblica
LO STUDIOSO
CHE VOLEVA DIVERTIRE
di Ezio Mauro
Era «una bella mattina di fine novembre, nella notte aveva nevicato un poco» quando frate Guglielmo da Baskerville allo spuntar del sole venne avanti nell’Italia confusa del 1980. Il Paese aveva appena vissuto lo shock del delitto Moro, il punto più temerario della sfida terroristica alla democrazia, e l’inizio della sua caduta. Come su un terreno prosciugato, ripiegavano le Brigate Rosse e si ritiravano le ideologie, e noi entravamo senza bussola in un territorio sconosciuto. Ed ecco quel frate, amico di Occam e di Marsilio da Padova, che si mette in cammino sette secoli fa, procede per sette giorni e 576 pagine insieme al novizio Adso da Melk, viaggia verso settentrione ma senza seguire una linea retta, tocca città famose e abbazie antichissime che incutono paura come fortezze di Dio inaccessibili, masticando le erbe misteriose che raccoglie nei boschi e scrutando di notte, dopo vespro e compieta, le magie stregonesche dell’orologio, dell’astrolabio e addirittura del magnete.
Davanti al successo mondiale del Nome della rosa, tradotto in quarantacinque lingue, Umberto Eco ebbe prima la ritrosia prudente dello studioso di fronte alla contaminazione mondana della scienza, poi seguì divertito il gioco delle sovra-interpretazioni, infine si dedicò alla teorizzazione a posteriori, smontando e rimontando sapere e consumo, letteratura e storia, il caso e il calcolo. Rivelò che tutto era nato da un’idea seminale, perché gli era venuta la strana voglia di avvelenare un monaco. Poi spiegò che scriveva con la pianta dell’abbazia sotto gli occhi, dando ai dialoghi il tempo necessario dei passi per andare dal refettorio al chiostro, perché occorre crearsi delle costrizioni per poter inventare liberamente. Quindi aggiunse che poiché scrivere un romanzo è una faccenda cosmogonica, il suo mondo naturale era la storia e il Medioevo, e questo ricreò nelle pagine. E infine disse l’ultima verità, intima come una confessione: volevo che il lettore si divertisse.
C’è quasi tutto Eco in questa spiegazione di un successo che è una mappa delle intenzioni, perché prima del successo c’è la sfida della grande divulgazione, la scommessa di non cedere alla banalizzazione del sapere ma nello stesso tempo la capacità di costruirsi lettori, accendendo una passione, portandosela dietro fino a scoprire l’eresia estrema, una risata come movente di un delitto. Eco c’è riuscito perché questo percorso rigorosamente controllato nella formazione del romanzo corrisponde perfettamente alla costruzione intellettuale di sé: dunque suona autentico, senza forzature.
Studioso fino alla fine, Eco infatti ha sovvertito l’ordine classico delle strutture accademiche con la nascita del Dams a Bologna, sperimentando sempre ma rimanendo in fondo fedele alla lezione di Pareyson, come se fosse giusto avere un solo maestro. Ma nel 1954 quella generazione un po’ speciale (pensiamo a lui, con Gianni Vattimo e Furio Colombo) ebbe la fortuna di incrociare la Rai nascente, per concorso e non per raccomandazione del sottobosco democristiano: fu naturale prolungare la propria analisi scientifica universitaria con la comunicazione di massa che si affacciava all’Italia, con i nuovi linguaggi, col visivo accanto al letterario, con il divismo sconosciuto del piccolo schermo, con la nuova tecnica che scusava l’ignoranza e la bypassava, fino a fare di Mike Bongiorno il modello perfetto dell’uomo televisivo, che creava per la prima volta un pubblico costituito, la grande tribù italiana del giovedì sera.
Era incominciato il grande incrocio che avrebbe fatto di Eco un personaggio unico, il primo scienziato capace di chinarsi sulla semiologia del quotidiano, curioso di tic e tabù individuali moltiplicati a fenomeni di massa dai nuovi strumenti di comunicazione, linguaggi e modi di dire, attraversati dal gioco di un calembour, riscattati da un paragone letterario sproporzionato perché ironico ma perfettamente coerente, come quando legava Franti con Bresci o portava Mickey Mouse a dormire a Mirafiori, parlando a Minnie in piemontese.
L’alto e il basso del post-moderno trovarono in lui non il primo interprete, ma il nucleo forte, che teneva insieme perfettamente i due registri e li legittimava a vicenda. Quel nucleo centrale, credo si possa nel suo caso riassumere in tre parole: cultura come passione. E il “libro” come strumento universale, il libro capace secondo lui di sfidare anche internet, perché il web in fondo - diceva - è un ritorno dalla civiltà delle immagini all’era alfabetica, alla galassia Gutenberg, all’obbligo di leggere, e non importa quale forma prenderà il supporto che continuiamo a chiamare “libro”.
Leggere «per il gusto di leggere» e non solo per sapere, come Eco scoprirà da bambino. E dietro i libri, borgesianamente e naturalmente, la biblioteca. Cinquantamila libri “moderni”, milleduecento volumi antichi di cui lo scrittore parlava con la passione di una scoperta continua. Senza un catalogo, mossi continuamente dalle emergenze del conoscere, dalla curiosità di un lavoro, dalla memoria che cerca conferma, sapendo che una biblioteca raccoglie i libri che possiamo leggere, e non solo che abbiamo letto, perché è la garanzia di un sapere. Col terrore antico degli organismi che divorano le pagine dei libri, e la vecchia ricetta che consisteva nel piazzare una sveglia negli scaffali, confidando nel rumore regolare e nelle vibrazioni per bloccare il pasto insano dei libri.
L’altro strumento indispensabile alla costruzione del fenomeno Eco sono i giornali, quotidiani e settimanali, mensili, riviste. Li ha criticati duramente, fino al suo ultimo romanzo, ma li ha sempre usati per indagare il quotidiano, per collegare gli scarti di costume della vicenda di ogni giorno con le categorie del suo sapere, capace di ordinare e battezzare i gesti minimi, inserendoli in una sorta di catalogo universale.
Si comincia dal 1959 con quei brevi saggi di costume parodistici pubblicati sul Verri che raccolti in volume daranno poi vita al famosissimo Diario minimo per arrivare finalmente alla Bustina di Minerva dell’Espresso. È come se il registro dell’attualità, grazie ai giornali, desse a Eco la possibilità di un controcanto, un suono appartato ma rivelatore, che scorre a fianco della grande vicenda nazionale ma la sa interpretare rovesciandola spesso nei suoi paradossi, svelandola nell’intimo dei suoi vizi o delle sue verità travestite da miserie del quotidiano.
Pastiches e parodie sono la recitazione in pubblico, ordinata letterariamente, del calembour privato, del motto di spirito che Eco ti diceva per prima cosa incontrandoti, sempre alla ricerca della rivelazione anagrammatica, della saggezza popolare che diventa enigmatica nel nonsense di un proverbio stravolto nel suo contrario, che continua beffardo a dirti qualcosa. Contraffazioni meravigliose, come i falsi rapporti di lettura dei redattori di un’immaginaria casa editrice che bocciano la lettura della Bibbia («un omnibus mostruoso, che rischia di non piacere a nessuno perché c’è di tutto»), di Torquato Tasso («mi chiedo come verranno accolte certe scene erotiche un po’ lascive») e dei Promessi sposi: «tant’è, non tutti hanno il dono di raccontare, e meno ancora hanno quello di scrivere in buon italiano».
Fuori dalla parodia, il sentimento dei giornali ha in realtà consentito a Eco di incrociare l’attualità e di decifrarla coi suoi strumenti, arrivando a un giudizio politico partendo da una notazione estetica, culturale, da un segnale del linguaggio individuale e collettivo. Gli ha consentito, a ben vedere, di prendere parte alla vicenda italiana negli anni più travagliati del Paese. Lo ha fatto senza badare al rischio (ben presente in molti altri intellettuali) di dividere con una presa di posizione politica il grande «fascio indistinto» dei suoi lettori, la somma trasversale della sua popolarità internazionale. Anche qui (e ricordo certe discussioni negli ultimi vent’anni) era come se fosse mosso semplicemente da un obbligo culturale, da un dovere intellettuale, perché la cultura, diceva Bobbio, «obbliga terribilmente ».
Naturalmente quando usò il paradosso, dicendo che la notte prima di addormentarsi preferiva Kafka piuttosto che rincretinirsi davanti alla tv, la muta dei critici di destra gli saltò al collo credendo di inchiodarlo alla sua caricatura. Ci vedemmo in quei giorni, ed era totalmente indifferente agli attacchi perché non lo toccavano, ma credo soprattutto perché quel che aveva detto come battuta, era in realtà profondamente vero. Era vero che i libri lo dominavano come «un vizio solitario». Ed era certo che anche Eco, come i suoi personaggi, diventava in Italia collettivamente “vero” perché la comunità dei lettori aveva fatto su di lui negli anni un investimento culturale e passionale, trasformandolo nell’Intellettuale italiano degli ultimi trent’anni.
Tutto questo lo ha portato all’ultimo atto, il riscatto di una parte del patrimonio di autori Bompiani - partendo da se stesso - dal gigante Mondazzoli per fondare con Elisabetta Sgarbi “La nave di Teseo”. Ne discutemmo a fine novembre, in un salone dell’Accademia dei Lincei. Umberto chiuse la porta e parlò sottovoce, perché confidava uno dei grandi segreti della sua vita, l’ultimo approdo della sua passione, o ancora una volta del suo “obbligo” culturale trasformato in avventura finale, a ottantaquattro anni.
Adesso la nave dovrà salpare da sola, senza il Capitano, ma con il suo nuovo libro
Pape Satan Aleppe, di cui proprio negli ultimi giorni aveva preso in mano la copertina, toccandola e accarezzandola come fa chi ama i libri. Gli avevamo chiesto in tanti che destino voleva avesse la sua biblioteca un giorno, dopo di lui. Adesso che il giorno è venuto, bisogna ricordare cosa rispondeva: non era sicuro che la sua biblioteca gli assomigliasse, perché la passione per i libri ti porta a conservare anche ciò in cui non credi. Tuttavia, non avrebbe voluto che i suoi libri fossero dispersi.
Forse, diceva, verranno comprati dai cinesi: se vorranno, dai miei libri «potranno capire tutte le follie dell’Occidente ».
Il manifesto
QUEL DISINCANTO IRONICO
IN DIFESA DELLA DEMOCRAZIA
intervista di Benedetto Vecchi ad Alberto Asor Rosa
Alberto Asor Rosa non nasconde l’emozione. «Ci ha unito la passione per la parola. Ognuno di noi, a proprio modo, ha cercato nella letteratura e nella comunicazione la chiave per accedere alla comprensione della realtà italiana. Abbiamo seguito sentieri diversi, ma ci siamo molte volte incontrati con la curiosità di capire a che punto eravamo giunti nei nostri percorsi di ricerca».
Raggiunto telefonicamente a Milano, Asor Rosa non si sottrae alle domande. Racconta di discussioni, di pagine scritte, di romanzi letti, di un clima culturale che sembra ormai appartenere a un passato remoto, anche se sono passati solo due, tre decenni. «Scrissi una recensione per la Repubblica a Il nome della rosa. Il libro mi piacque e ne scrissi un elogio. Molti, invece, puntarono l’indice contro il romanzo e Umberto Eco. Operazione decisa a tavolino, pianificata per avere il consenso del pubblico: erano queste le critiche frequenti. Il libro invece a me piacque molto. Ne scrissi citando anche un altro grande scrittore, Italo Calvino. Anche verso Calvino le critiche, siamo agli inizi degli anni Ottanta, non erano tenere. Per entrambi sostenni che si erano molto divertiti a scrivere quei romanzi indicati come mera operazione editoriale».
Già, gli anni Ottanta, il decennio degli integrati, dopo che i vent’anni precedenti avevano vissuto il conflitto con gli apocalittici. Sono gli anni che vedono giungere a maturazione quello che Umberto Eco aveva ipotizzato proprio in Apocalittici e integrati, dove analizzava attentamente il ruolo degli allora nuovi media - la televisione soprattutto - nella formazione dell’opinione pubblica. La pubblicazione de Il nome della rosa diede infatti il via a una polemica che ha visto impegnati lo stesso Eco, Franco Fortini, Asor Rosa, Gian Carlo Ferretti (a quest’ultimo si deve l’espressione di «best seller di qualità» per qualificare proprio libri come Il nome della rosa) e molti altri intellettuali. E come spesso accade, le recensioni furono l’occasione per fare il punto del rapporto tra «letteratura e vita nazionale» e sul ruolo dell’intellettuale in una realtà caratterizzata appunto da un ruolo preponderante della televisione, che dagli inizi degli anni Ottanta in poi, sarà il medium che plasmerà l’opinione pubblica, rispecchiandone e amplificandone i sentimenti più profondi e oscuri. Ed è dalla figura e del lascito intellettuale di Umberto Eco che prende il via l’intervista a Asor Rosa.
Qual è l’eredità intellettuale di Umberto Eco?
Difficile dare una risposta semplice, lineare. Eco è stata una personalità intellettuale complessa. Semiologo, filosofo, letterato, giornalista, appassionato docente. Se si guarda alla sua vita intellettuale e la si confronta con l’attuale povertà della ricerca italiana è difficile fare una sintesi. In lui hanno convissuto una dimensione creativa - i suoi romanzi - e una dimensione scientifica (il semiologo, il filosofo). È stata una personalità fuori dal comune. È il primo intellettuale, in Italia, che ha infranto il confine del consumo di massa. Sapeva produrre romanzi e saggi salutati sempre da alti numeri di vendite. Ed è stato uno dei pochi intellettuali italiani molto letto oltre i nostri confini nazionali. Un personaggio autorevole, dalla Francia agli Stati Uniti, per la sua indubbia capacità di dare voce a un «sentire» diffuso e mai acquiescente verso lo la realtà delle cose. Era già accaduto ad altri intellettuali italiani ma Eco è riuscito a essere intellettuale pubblico internazionale in un’epoca caratterizzata da media sempre più globali.
L’espressione presente in alcuni scritti di Eco è proprio intellettuale pubblico. Non intellettuale organico e neppure intellettuale militante. Ma non è mai stato un uomo di cultura che si è rifugiato dentro le stanze rassicuranti dell’Accademia....
È stato un intellettuale pubblico mai compiaciuto di se stesso e del suo ruolo. L’ho letto sin dai suoi esordi. Il libro che però mi ha colpito profondamente è stato Opera aperta, dove Eco affronta il complesso rapporto tra lettore e pubblico e dove si confronta con il nodo delle ricezioni molteplici dei lettori, che possono rendere un romanzo o un saggio cosa diversa da quella pensata dall’autore. Opera aperta è il libro che manifesta una capacità di innovazione unita a una erudizione massima e un distacco ironico dai cliché accademici dello studioso chiuso in una stanza che tiene fuori quanto accade nel mondo. Questo ironico distacco ha permesso a Umberto Eco di avere un pubblico di massa, facendo sbriciolare il muro dell’insofferenza e dell’indifferenza del pubblico verso temi e argomenti da sempre prerogativa dell’Accademia.
Umberto Eco commentava sempre divertito il fatto che i suoi romanzi fossero best seller. Che ne pensa di questa sua capacità di conquistare l’attenzione del pubblico?
Voglio ricordare un episodio del legame intellettuale che mi univa a lui. Quando uscì Il nome della rosa, le reazioni dei critici non furono generose. Scrissi per Repubblica una recensione dove elogiavo la sua capacità di tessere la trama di un romanzo che catturava l’attenzione senza mai essere banale nella definizione dei personaggi, nella ricostruzione storica del periodo e dei temi che affrontava, come la libertà di ricerca in un clima segnato da dogmatismo. Molti lo criticarono anche aspramente per come era stato prodotto e per l’implicita idea della necessaria indipendenza del letterato dalla contingenza politica. Replicai a molte delle critiche con un altro scritto. Erano due gli autori che erano criticati in quel periodo: Umberto Eco e Italo Calvino. Io sostenni che nello scrivere i loro romanzi si erano divertiti. Questo del divertimento non è una faccenda secondaria, perché denota passione, intenzionalità anche politica. Poi, certo, il divertimento può diventare un limite, diventando anch’esso un vincolo troppo forte, minando la qualità del lavoro di scrittura. Umberto Eco può essere stato discontinuo, ma sarebbe improvvido considerare negativamente i suoi romanzi. Come ho detto è stato una personalità complessa, difficile da definire in maniera tranchant.
Eppure la voce di Umberto Eco è stata meno presente nel corso degli anni. Non crede?
Non sono d’accordo. Ha sempre preso posizione per una difesa delle istituzioni democratiche. Senza nessuna indulgenza per il potere e senza derive populiste. Possiamo dire che è stato meno efficace, ma la perdita di efficacia riguarda tutti gli intellettuali di questo paese. Come non ricordare le settimanali «Bustine di Minerva» apparse su l’Espresso. Sono una vera e propria storia del presente dove non ha fatto sconti a nessuno. Potevi dissentire o esprimere consenso, ma sono comunque esempi di una sua presenza vitale nella vita culturale e politica italiana. L’ultima presa di posizione di Eco ha riguardato il processo di concentrazione editoriale che ha avuto nell’acquisto della divisione libri della Rcs da parte di Mondadori..... Mi sembra che la sua presa di posizione sia stata ammirevole. Si è impegnato in una avventura editoriale dagli esiti incerti quando era già ammalato. Mi sembra che questo riveli la sua coerenza di intellettuale libero, quale è stato per tutta la vita.
 Nel 40° anniversario dell'assassinio di Pierpaolo Pasolini. «Pensatore pessimista e profetico, volle mostrare il vero volto, feroce e repressivo, dell’autorità.,nascosto sotto le spoglie dell’edonismo»
Nel 40° anniversario dell'assassinio di Pierpaolo Pasolini. «Pensatore pessimista e profetico, volle mostrare il vero volto, feroce e repressivo, dell’autorità.,nascosto sotto le spoglie dell’edonismo»
LaRepubblica, 28 ottobre 2015
L’Italia di oggi nacque con il boom economico, la grande trasformazione che ne riplasmò sentimenti, mode, abitudini, comportamenti politici, scelte di vita. Pier Paolo Pasolini ne fu protagonista e testimone e il suo lavoro si propone allo storico come una fonte indispensabile per avvicinarsi al senso profondo di quegli anni. Ma Pasolini ha anche egli stesso uno sguardo da storico, interessato al mutamento,alle brusche impennate della grande storia che rompono la crosta dell’immobilismo,
spezzano equilibri plurisecolari. Così, quando riflette sulla società italiana, lo fa con consapevolezza di chi si misura con una questione — quella della continuità/ rottura tra il fascismo e l’Italia repubblicana — che è tipicamente storiografica. Schierandosi decisamente per la “continuità”, il suo riferimento è a una Democrazia Cristiana che «sotto lo schermo di una democrazia formale e di un antifascismo verbale, ha perpetuato la stessa politica del fascismo», dando vita a un «regime poliziesco parlamentare ». Il blocco sociale su cui si fondava il consenso democristiano era lo stesso del fascismo mussoliniano: la piccola borghesia e i contadini uniti al grande capitale. Identico era anche il cemento ideologico fondato sul cattolicesimo e su valori quali la moralità, l’obbedienza, la disciplina, l’ordine, la patria, la famiglia.
La tesi della “continuità” era in gran parte condivisa dagli storici di allora. A marcarne l’originalità fu piuttosto il film su Salò o le 120 giornate di Sodoma , del 1975. In quel caso davvero si spinse in territori che la stessa storiografia ufficiale aveva fino ad allora complessivamente ignorato, restituendo al fascismo la sua essenza biopolitica, attribuendogli un Potere in cui si incarnava il Male assoluto. In quella Salò, il Potere consumava la sua ultima, parossistica orgia e lasciava affiorare, senza più mediazioni ed orpelli istituzionali, la volontà di impadronirsi — attraverso il sesso — dei corpi dei propri sudditi; una volontà di dominio che era la diretta conseguenza di quella “politicizzazione della vita” attraverso la quale, come avrebbe sottolineato Agamben, nelle esperienze del totalitarismo novecentesco il corpo dell’individuo diventava la posta in gioco delle strategie politiche, la politica si trasformava in biopolitica: la nuda vita, l’esistenza biologica degli individui, fino ad allora confinata in una terra di nessuno, veniva inserita nel circuito della statualità, con la vita e la morte che non erano più concetti scientifici ma politici, occasione per l’esercizio di un potere che si saziava umiliando e profanando i corpi delle vittime.
Ma Pasolini “storico” fu originale anche per altri aspetti. Fu tra i pochi, infatti, ad accorgersi di una “rottura” ben più profonda, avvenuta nell’inconsapevolezza di molti. «La matrice che genera tutti gli italiani è ormai la stessa — scriveva, nel 1974 — Non c’è più dunque differenza apprezzabile… tra un qualsiasi cittadino italiano fascista e un qualsiasi cittadino italiano antifascista. Essi sono culturalmente, psicologicamente, e quel che più impressiona, fisicamente, interscambiabili... I giovani neofascisti che con le loro bombe hanno insanguinato l’Italia, non sono più fascisti... Se per un caso impossibile essi ripristinassero a suon di bombe il fascismo, non accetterebbero mai di ritornare ad una Italia scomoda e rustica, l’Italia senza televisione e senza benessere, l’Italia senza motociclette e giubbotti di cuoio, l’Italia con le donne chiuse in casa e semivelate. Essi sono pervasi come tutti gli altri dagli effetti del nuovo potere che li rende simili tra loro e profondamente diversi rispetto ai loro predecessori». Con le piazze arroventate da uno scontro ideologico ancora tutto novecentesco, queste considerazioni suscitarono un inevitabile scalpore. Pasolini argomentava il suo pessimismo segnalando due “rivoluzioni”, quella delle infrastrutture e quella del sistema di informazione, avvenute proprio negli anni del boom. Le distanze tra centro e periferia si erano notevolmente ridotte grazie alle nuove reti viarie e alla motorizzazione; ma era stata soprattutto la televisione a determinare in modo costrittivo e violento una forzata omologazione nazionale. Il nuovo Potere, nonostante le sue parvenze di tolleranza, di edonismo perfettamente autosufficiente, di modernità, nascondeva un volto feroce e repressivo. «Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello reazionario e monumentale che però restava lettera morta. Le varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili ad uniformasi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava a ottenere la loro adesione a parole... Ora, invece, l’adesione ai modelli imposti dal centro è totale e incondizionata ». Certo, erano giudizi eccessivi, disperati quasi. Pure oggi, alla luce di tutto quello che è successo dagli anni Ottanta, il pessimismo pasoliniano assume i tratti di una lucida profezia.
 La voce limpida di un economista che non ha smesso di pensare alle persone, e ai fini umani dell'economia. «Il neoliberismo ha reso la scienza economica qualcosa di enormemente pericoloso: un virus invisibile che può fare, anzi ha fatto, danni enormi al nostro organismo».
La voce limpida di un economista che non ha smesso di pensare alle persone, e ai fini umani dell'economia. «Il neoliberismo ha reso la scienza economica qualcosa di enormemente pericoloso: un virus invisibile che può fare, anzi ha fatto, danni enormi al nostro organismo».
La Repubblica, 26 aprile 2015
Di Ruffolo ricordo le apparizioni pubbliche. Rare e forbite. I suoi interventi dotti da keynesiano convinto. Ora è un’altra persona. «Il neoliberismo ha reso la scienza economica qualcosa di enormemente pericoloso: un virus invisibile che può fare, anzi ha fatto, danni enormi al nostro organismo». Il volto che mi guarda e mi parla, in un pomeriggio di sabato, dentro una Roma pressoché deserta, mostra un’ansia particolare. Ruffolo vive in una grande casa. Molto borghese. A ridosso di via Veneto. Ma tutto lo spazio ornato di quadri, di libri, di oggetti è come se non lo interessasse. Le tende semichiuse lasciano filtrare una luce fioca. Un uomo in penombra mi è di fronte: «Ora che la parte biologica sta prendendo il sopravvento su quella sociale mi pare di essermi incamminato su un’altra strada, meno certa, meno luminosa, dove tutto ciò che si è amato e sognato resta prigioniero nella mente, non è più condivisibile con gli altri».
Perché non dovrebbe continuare a esserlo?
«Non c’è una ragione precisa. Si entra, dopo una certa età, in una zona in cui il disinteresse assume una sua purezza infantile. E lì accade che i vecchi amano e sognano molto meno. Quei pochi sogni che faccio mi sembrano cani da guardia. Abbaiano, ringhiano, mi lasciano solo. Con i miei dubbi e le mie assenze».
Quanto l’aiuta pensare di essere stato un economista, uno studioso riconosciuto e apprezzato?
«Conta poco o niente. Oddio, se hai fatto poche corbellerie magari ti verrà riconosciuto da qualcuno che ti dirà anche bravo. Ma se getto lo sguardo a cosa è diventata l’economia, la strada che ha intrapreso negli ultimi decenni, non posso non pensare che le nostre voci inascoltate hanno fallito. O meglio sono risultate troppo deboli di fronte all’avanzata impetuosa del capitalismo».
È la parola “capitalismo” che sembra svuotata di senso.
«Forse. Quando mi occupavo di economia la prima cosa che pensavo era: come riusciremo a far star meglio le persone? L’economia che ci ha travolto non ha dato risposte. Come si può pensare che sia equo un sistema in cui per uno che sta bene dieci o cento soffrono?».
C’entra qualcosa questo discorso con la felicità e l’infelicità?
«No, non lo penso. È stato detto che l’economia è una scienza triste. Ma è una tristezza che non c’entra nulla con l’infelicità. Mio padre diceva spesso: se discuti di economia non dimenticare il problema della fame. L’economia non parla di individui, di storie private. Si aggrappa alle statistiche, al calcolo, alla razionalità. La tristezza è nel cercare a tutti i costi di ridurre l’uomo a un numero. Ma la fame, in qualunque forma si presenti, è di nuovo qui, tra noi. I bisogni primari tornano a essere minacciati».
Cosa faceva suo padre?
«Era capo di gabinetto dell’Istituto Internazionale dell’Agricoltura. Questo prima che arrivasse la Fao. Si occupava, insomma, dei problemi legati allo sviluppo e alla fame. Anch’io volevo fare l’economista. Seguire le orme paterne. Mi laureai in Giurisprudenza nel 1947. Ricordo Roma liberata. Sulle facce delle persone c’erano ancora i segni della guerra ».
Come furono per lei quegli anni?
«Avevo 13 anni quando scoppiò la guerra. Due fra- telli più grandi che combatterono. La mamma piena di apprensioni. Ma non ci fu mai pericolo per me. Vivevamo nel quartiere di San Giovanni. Ho un ricordo del bombardamento di San Lorenzo. I morti allineati per strada. La paura che potesse toccare a qualche caro. La ferocia dei tedeschi e dei fascisti dopo il 1943. I miei fratelli Nicola e Sergio, diventati partigiani, furono arrestati. Entrambi furono presi la notte dell’8 maggio dal famigerato Giuseppe Bernasconi ».
Chi era?
«Uno dei capi della Banda Koch. Li bendarono, li fecero salire su una macchina e li portarono alla pensione Jaccarino. Un luogo ribattezzato il “buco” dove si usciva solo per essere fucilati o torturati in via Tasso. Prendevano chiunque fosse sospettato di attività antifascista. Nell’aprile del 1944 la Banda Koch aveva arrestato Luchino Visconti. Riuscì a salvarsi, nonostante fosse stata emanata sentenza di morte nei suoi riguardi, grazie all’intervento di Maria Denis, un’attrice dei telefoni bianchi che si diceva fosse l’amante di Pietro Koch».
Come si salvarono i suoi fratelli?
«Nicola riuscì a fuggire da un camion, che lo trasportava in una località a Nord di Roma, insieme ad altri condannati, per essere fucilato. Rocambolescamente fece perdere le sue tracce nella campagna romana. Sergio sarebbe stato liberato solo con la liberazione. Ricordo i bombardamenti di San Lorenzo, i morti, la paura che potesse toccare ai miei fratelli partigiani. Quando tutto rinacque la città sembrò piena di speranza
 Festa della Liberazione: in ricordo di Claudio Cianca, antifascista contro la speculazione edilizia.
Festa della Liberazione: in ricordo di Claudio Cianca, antifascista contro la speculazione edilizia.
Ilfattoquotidiano.it, 24 aprile 2015
Se ne è andato il 22 febbraio di quest’anno Claudio Cianca, con i suoi 101 anni di vita da antifascista, ribelle, protagonista della Resistenza romana, presente e partecipe della vita dei più deboli.
L’ordigno bellico che fece esplodere, nel giugno del 1933, nel pronao della Basilica di San Pietro, quando non era che un giovane di vent’anni, è stato un gesto simbolico che ricorderanno in molti e compiuto perché calasse l’attenzione proprio su quell’Italia oppressa dal regime fascista, l’Italia che voleva difendere. Dirigente della Cgil, parlamentare con il Pci, consigliere comunale in Campidoglio, Cianca è stato in primo piano anche nelle battaglie contro laspeculazione edilizia. Battaglie che a ripercorrerle ricordano molto quelle dei nostri giorni.
Nel 1956 con Aldo Natoli e Leone Cattani si è battuto contro la costruzione dell’Hotel Hilton. Costruirlo significava abbattere i due terzi di una zona di verde pubblico situata sulle pendici di Monte Mario e perché avvenisse occorreva la modifica del piano regolatore con l’approvazione del consiglio comunale. Il giorno della seduta è stata la Società Generale a mandare un gruppo di lavoratori con l’obiettivo di convincere Cianca a non partecipare con interventi contro la delibera. Eppure i lavoratori, dalla sua parte, lo fecero parlare. Volevano ascoltare il discorso che Cianca poi concluse con fermezza: “La società generale immobiliare paga bene l’approvazione di queste deliberazioni”.
E’ storia vecchia, dunque, molto vecchia, la complicità tra amministrazioni e gruppi privati disinteressati al bene pubblico per favorire logiche private. Roma era già infognata nella speculazione edilizia che si andava a intrecciare con la speculazione fondiaria. “Da mille lire – ha raccontato Cianca in Il mio viaggio fortunoso, a Giuseppe Sircana – terreni agricoli o destinati al pascolo da mille lire potevano arrivare fino a trentamila lire al metro quadro…”
Negli anni in cui è stato alla Camera Cianca si è battuto contro le leggi approvate per gli interessi privati. E’ con l’aiuto di Fiorentino Sullo che nel 1962 è stata varata la Legge 167, perché i comuni potessero acquisire aree demaniali per costruire case economiche e popolari. Una legge che, tuttavia, ha trovato numerose difficoltà di applicazione.
Claudio Cianca è stato anche membro della presidenza dell’Anppia, l’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti. Ha sempre cercato di tenere vivi e trasmettere ai giovani i valori che hanno guidato la sua stessa vita ricordando che “la libertà non si perde tutta insieme un brutto giorno, ma poco a poco giorno per giorno”.
E dalla sua vita, dal modo in cui scelse di condurla dedicandosi a quella dei più deboli, oggi di lui è viva e ricca di sfumature colorate, la fotografia di un uomo, un cittadino, un lavoratore che con gli altri, per usare le sue stesse parole, finalmente, dopo il congresso di Napoli della Cgil nel 1945 si sentiva “cittadino partecipe alla costruzione di una democrazia”. Anche per questo dovere e piacere si mischiano nel ricordare Claudio Cianca nel giorno della Liberazione.

«».Il manifesto, 12 marzo 2015
CORPO A CORPO CON LA DEMOCRAZIA
di Luciana Castellina
Nella prefazione a questi due volumi [vedi riferimenti in calce] Stefano Rodotà scrive che Lucio Magri è stato uno dei protagonisti di questa stagione parlamentare di fine secolo. Una «bella stagione», aggiunge Rodotà, e debbo dire che la rilettura di questi testi suscita nostalgia: perché non solo nel caso di Lucio, ma per tutti in quell’epoca, ogni intervento alla Camera rappresentava un impegno, una riflessione, un esercizio di alto livello. Per questo, del resto, quegli interventi possono essere pubblicati dopo tanti anni.
Protagonista, dunque ma assai anomalo, perché all’inizio, nella legislatura ’76-’79, parte di un gruppo di appena sei deputati su 630 e segretario di un partito, il Pdup, che in quella coalizione elettorale – denominata Democrazia Proletaria – di deputati ne aveva solo tre. E però era in rappresentanza della sola opposizione, come si diceva allora, quando ancora si facevano distinzioni, “dell’arco democratico”.
Nel suo primo discorso parlamentare Lucio si era infatti trovato nella paradossale condizione di dover negare la fiducia a un governo sostenuto da una maggioranza quasi totale: il governo delle larghe intese dell’on. Andreotti. Anche questo dettaglio credo stia ad indicare (ed è bene ricordarlo in un momento in cui proprio di legge elettorale si sta discutendo) quanto importante sia il pluralismo parlamentare, una rappresentanza che esprima davvero tutte le anime del paese.
Che non bloccò affatto l’istituzione, ma consentì anzi inediti e stimolanti intrecci, penso innanzitutto al dialogo che si sviluppò fra il nostro attuale presidente della Repubblica — che davvero ringrazio per la sua presenza — e Magri, in occasione della assai conflittuale ridefinizione, nel 1993, della legge elettorale.
È una buona cosa rileggere gli atti parlamentari ed è una buona cosa che la Biblioteca della Camera sia impegnata a renderlo possibile con le sue pubblicazioni: perché si tratta della testimonianza più autentica e diretta di un periodo storico, e debbo dire che anche io, che pure ho vissuto da parlamentare quegli anni ’76-’99, rileggendo questi volumi sono stata aiutata ad approfondire la riflessione su quella stagione. Che ha peraltro rappresentato un passaggio epocale per il nostro paese, non a caso definito “passaggio dalla prima alla seconda Repubblica”.
Tuttavia, più che ritornare a quella stagione vorrei cogliere quanto di tuttora estremamente attuale ho trovato in questi discorsi di Lucio Magri. E soffermarmi soprattutto sul tema della crisi della democrazia, che a me sembra essere oggi il tema più preoccupante. Lucio ne avverte la drammaticità già allora e denuncia i rischi — con quello che Rodotà ha definito «impietoso realismo» — della deriva dell’antipolitica oggi diventata così macroscopica.
Non un lamento impotente, ma la critica concreta all’autoreferenzialismo crescente dei partiti, alla loro incapacità di intendere quanto andava emergendo nella società attraverso i movimenti e indicando dunque la necessità non, come troppo spesso ora si fa, di offrire un’espressione diretta ad una indeterminata società civile sacralizzata e però frantumata e fatalmente subalterna alla cultura dominante, bensì un impegno a costruire quella che egli definiva «democrazia organizzata».
Non solo partiti chiusi in se stessi più rappresentanza delegata, ma anche una rete di organismi capaci di andar oltre la mera protesta e impegnati a imparare a gestire direttamente funzioni essenziali della società, così da ridurre via via la distanza fra governanti e governati (che poi è la base più salda della democrazia). E così colmare il solco che drammaticamente separa il cittadino dalle istituzioni.
Non a caso il Pdup fu un punto di riferimento per la crescita di queste reti che ebbero, — negli anni 70 — una particolare fioritura. Penso ai Consigli di fabbrica, a quelli di Zona, a movimenti come Medicina Democratica o Psichiatria, o nati attorno alle grandi questioni dell’assetto urbano e sociale.
Io non me la sento di accusare le nostre giovani generazioni per il loro disinteresse alla politica, per la polemica contro la “casta” che fatalmente sfocia nel disinteresse anche per la stessa democrazia, o di questa assume una visione assolutamente riduttiva: un insieme di diritti e di garanzie individuali, non lo spazio su cui si salda ed opera una collettività.
Il terreno della politica si è ormai a tal punto ridotto, come una pelle di zigrino, sì da diventare un esercizio passivo in cui ci si limita ad interrogare il cittadino perché dica «mi piace o non mi piace» a quanto proposto da un vertice, come si trattasse di facebook. E infatti di solito si dice «I
like it, I don’t».
Se la democrazia è solo questa sporadica consultazione, e non invece uno spazio deliberativo che ti rende partecipe e soggetto della costruzione di una società ogni volta innovativa, perché mai un giovane dovrebbe appassionarsi?
Il declino dei grandi partiti politici di massa ha lasciato un vuoto che dai tempi in cui Lucio ne denunciava i sintomi è diventato un oceano. Non li ricostruiremo tali quali erano (e anche loro, del resto, avevano non pochi difetti). Ma è importante tornare a riflettere sul senso della politica, — che non è ricerca di consenso, ma costruzione di senso — così come con questi discorsi, pur pronunciati in Parlamento e non a scuola, Magri ci spingeva a fare, per recuperare la politica, che poi è ricerca della propria identità nel rapporto con gli altri umani e non arroccamento sul proprio io nell’illusione di potersi salvare da soli.
Se non dovessimo riuscire a far capire quanto la lentezza della condivisione, — che è propria della democrazia – sia più preziosa della fretta, solo apparentemente più efficiente, del decisionismo, non ce la faremo nemmeno a far rivivere una vera Sinistra. Per questo sono davvero contenta — e con me tutti i compagni del Pdup — della sollecitazione che da questi testi ci viene per riflettere sull’oggi. E per aiutarci a discuterne con i più giovani.
La lucidità anticipatrice di Magri su questo come su altri temi — che è certamente stata una delle sue più significative caratteristiche — ha avuto una particolare incisività perché lui non era un profeta, un intellettuale separato.
In occasione della sua scomparsa, Perry Anderson, uno dei fondatori della autorevole New Left Review, ha scritto: «Lucio Magri non ha avuto uguali nel panorama della sinistra europea. È stato l’unico intellettuale rivoluzionario in grado di pensare in sintonia con i movimenti di massa, sviluppatisi durante il corso della sua vita. La sua riflessione teorica si è radicata realmente nell’azione, o nella mancanza d’azione, degli sfruttati e degli oppressi».
La ricerca, alla fine quasi ossessiva, del nesso fra teoria e militanza ha finito per essergli fatale. Nel 2004 Magri decise di porre fine alla nuova “Rivista” de il manifesto che era rinata nel 1999 sotto la sua direzione. Era una bella rivista. Ma Lucio non si rassegnava al fatto che mancassero i referenti sociali, non voleva essere solo un intellettuale che scriveva senza la verifica dell’azione politica. E poiché non vedeva nell’immediato le condizioni perché interlocutori consistenti si presentassero e che il dibattito politico in atto si sbriciolava in quisquilie, decise di cessare le pubblicazioni.
Furono motivazioni analoghe che lo condussero alla sua tragica decisione finale. «Non dico che la sinistra non rinascerà — ripeteva — ma ci vorranno molti anni e io sarò comunque già morto. Così come è il dibattito non mi interessa». Ma non era tuttavia pessimista nel lungo periodo. Come del resto prova il titolo del suo libro Il sarto di Ulm — oggi tradotto in Inghilterra, Germania, Spagna, Brasile, Argentina — titolo tratto da un apologo di Bertolt Brecht. Al sarto, che pretendeva che l’uomo poteva volare, — stufo dell’insistenza — il vescovo-principe di Ulm finisce per dire: «Vai sul campanile e buttati, vediamo se è vero quanto dici». Il sarto va e salta, e naturalmente si sfracella.
E però: chi aveva ragione, il sarto o il vescovo? Il sarto, perché poi alla fine l’uomo ha volato. Ecco, diceva Lucio, per ora il comunismo si è schiantato, ma alla fine volerà. Noi continuiamo a provarci
QUELLA LUCIDA DIFESA DEL MATTARELLUM
LEGGEREMAGRI NELL’ITALIA RENZIANA DEL 2015
di Daniela Preziosi
C’è una ragione, forse una in particolare, che ha portato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri mattina nella Sala della Regina di Montecitorio all’affollata presentazione dei due volumi sull’attività parlamentare di Lucio Magri, fondatore de il manifesto poi del Pdup poi ancora fra i protagonisti della prima Rifondazione comunista, deputato dal 1976 al 1994, scomparso per sua volontà non ancora ottantenne il 28 novembre 2011. A raccontarla, questa ragione, in parte a rivelarla, è «l’amico di una vita» Famiano Crucianelli, con Luciana Castellina e Aldo Garzia curatore del libro Alla ricerca di un altro comunismo (2012) con articoli e interventi dello stesso Magri. «Io conosco la storia e so qual era il rapporto fra l’allora onorevole Mattarella e Magri».
La «storia» ha a che vedere con legge elettorale che porta il nome del Presidente, alla quale Magri «prestò una forte attenzione e che fu fertile terreno comune con l’onorevole Mattarella». Il deputato comunista fece parte del gruppo ristretto che discusse intensamente del testo. Un corpo a corpo su una legge difficile da scrivere, a valle del referendum maggioritario votato a furor di popolo qualche mese prima.
Poi la difese in aula con realismo: «Questa intesa avrebbe potuto essere migliore, ma con questi rapporti di forza e questo pulviscolo di interessi in campo e sotto la pressione di un’opinione pubblica appassionata ma male informata sarebbe stato difficile fare meglio», disse. Magri, ricostruisce Crucianelli (anche lui all’epoca deputato Prc, poi con Magri uscì dal partito con i ’comunisti unitari’), «si trovò come sempre a discutere su due fronti: quello di una parte consistente del gruppo dirigente di Rifondazione comunista che come una litania riproponeva il proporzionale, con una straordinaria rimozione della realtà; e quello molto più potente del Pds, dei sostenitori dell’ipermaggioritario che intendevano cancellare il sistema dei partiti.
La legge Mattarella rappresentava il punto più avanzato: per un verso accettava il verdetto del referendum e per l’altro teneva aperto con quel 25 per cento di proporzionale la possibilità di ridare un senso generale ai partiti e a un tessuto democratico che vive nella partecipazione dei soggetti organizzati». Avercela oggi, quella legge, al posto dell’incipiente Italicum.
Già da questo brano si capisce che la sala strapiena non è una riunione di reduci accorsi a omaggiare la famiglia e a rimpiangere i tempi andati. C’è, sì, la comunità dei «compagni del Pdup», la breve ma feconda esperienza del ’partito d’unità proletaria per il comunismo’, del manifesto e delle cinquanta sfumature della sinistra di ieri e di oggi, da Nichi Vendola e tutto il gruppo di Sel a Fausto Bertinotti, da Luciano Pettinari a Paolo Guerrini a Lucio Manisco a Franco Giordano, al giornalista Valentino Parlato; il costituzionalista Gianni Ferrara, gli ex sottosegretari Vincenzo Vita e Alfonso Gianni, l’ex europarlamentare Roberto Musacchio; fino a Stefano Fassina, Roberto Speranza, Nico Stumpo e Valeria Fedeli (Pd); ma anche ai cattolici ex dc Gerardo Bianco e Nicola Mancino (dalla Dc proveniva Magri, iscritto al Pci nel ’57 prima essere radiato nel ’69), il già socialista poi Fi oggi Ncd Fabrizio Cicchitto.
Il ragionamento che si sviluppa negli interventi (Laura Boldrini, Gianni Melilla, Paolo Fontanelli, Bianco, Castellina, Crucianelli) a partire dai discorsi del deputato Magri sulla rappresentanza e sulla «democrazia organizzata» (lui, autore di un saggio su «parlamento o consigli» — i soviet — in risposta a Pietro Ingrao sul manifesto del 1970, così definisce quella che ora con formula fessa si chiama ’società civile’) parla dell’oggi. Coglie già «l’avvio della deriva oligarchica», sottolinea nella prefazione dei volumi il costituzionalista Stefano Rodotà. La presidente Boldrini, padrona di casa, riflette invece su ’quel parlamento’: nel ventennio 76–94 «c’era una curiosità per le opinioni diverse, oggi alla Camera non sempre accade». Si intuisce il riferimento alle polemiche degli ultimi giorni.
A leggere Magri di fine anni 80 si incrocia l’Italia del 2015. Magri «indignato con il nuovismo che caratterizza lo scioglimento del Pci», non perché «non innovatore» ma perché «considerava un grave errore politico la retorica di un nuovo senza radici e senza futuro» (Crucianelli). Il bersaglio di ieri è il «nuovismo» occhettiano; ma le parole non calzano bene per «la rottamazione» renziana?
A leggere Magri del ’93 si incontra il tormento della sinistra di governo: «L’unica strada percorribile è quella non dell’improvvisa scomparsa dei partiti politici ma delle graduali e progressive coalizioni fra gli stessi con piattaforme programmatiche definite». E cosa c’è di più attuale e più coevo della crisi di rappresentanza della sinistra? «Magri rappresenta un punto di vista, una parte certo di minoranza», dice Melilla, già Pdup-manifesto oggi deputato di Sel, «ma non fu mai minoritario. Amava una frase di Teresa di Lisieux: ’so che niente dipende da me, ma parlo e agisco come se tutto dipendesse da me’».
Presentazione dei volumi
“Lucio Magri – Attività parlamentare”
Mercoledì 11 marzo, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, sono stati presentati i volumi “Lucio Magri — Attività parlamentare”.
Ha aperto l’appuntamento il saluto della Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini.
Sono intervenuti Paolo Fontanelli, Questore della Camera, Gianni Melilla, Segretario di Presidenza della Camera, Gerardo Bianco, Luciana Castellina, Famiano Crucianelli.
Presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Guarda il video sul sito della Camera.
 All'indomani della scomparsa del grande intellettuale, noto ai nostri lettori, un articolo di Giuseppe Allegri e un ricordo di Zygmunt Bauman, dalle pagine rispettivamente del
All'indomani della scomparsa del grande intellettuale, noto ai nostri lettori, un articolo di Giuseppe Allegri e un ricordo di Zygmunt Bauman, dalle pagine rispettivamente del
manifesto e della Repubblica del 4 gennaio 2015
Il manifesto
Ulrich Beck, visionario europeo
di Giuseppe Allegri
Con Ulrich Beck se ne va uno dei maggiori studiosi dei processi di globalizzazione, oltre che un visionario militante dell’Europa politica e sociale. Il sociologo tedesco verrà ricordato anche per aver coniato e studiato definizioni divenute di moda nella sociologia contemporanea, come nel dibattito pubblico europeo e globale: «seconda modernità», «modernizzazione riflessiva», «società cosmopolitica» e soprattutto «società del rischio» (
Risikogesellschaft – Risk Society).
Formule, concetti, metafore di chi ha liberamente scelto di affrontare senza timori reverenziali il tramonto delle categorie della prima modernità, sfidando la sonnacchiosa e dogmatica accademica delle scienze politiche e sociali sul terreno più delicato: quello del «nazionalismo metodologico». Altra espressione «inventata» da Ulrich Beck per combattere quell’erronea semplificazione che costringe nelle opprimenti dimensioni dello Stato-nazione tanto l’analisi dei fenomeni sociali e giuridici, quanto i possibili spazi di azione civica e politica.
Il làscito maggiore del suo insegnamento sta nel radicale rifiuto di ogni pregiudizio nazionalista. Questo è il prisma attraverso il quale Beck ha spiegato la connessione tra le dinamiche della globalizzazione e i loro esplosivi effetti sulla divisione del lavoro, sulle forme di vita individuali e collettive, sul presente e sul futuro del vecchio Continente. Questo approccio è inoltre utile per contrastare la recrudescenza dei movimenti intolleranti e xenofobi dei partiti tradizionalisti, autoritari e nazionalisti (Tan Parties) in un’Europa che diventa sempre più «tedesca», stritolata dai diktat delle politiche di austerità volute dalla Bundesbank. Lo ha denunciato lo stesso Beck in uno dei suoi ultimi saggi (L’Europa tedesca, Laterza, 2013).
La militanza intellettuale, politica e civile di Ulrich Beck è sempre stata dalla parte di un’Europa politica e sociale. Un soggetto che, a suo parere, doveva superare le nefaste eredità «sovraniste» degli Stati-nazione, spesso ridotti a algidi gendarmi dell’ordine pubblico locale, e gli incubi monetaristi di un’Eurozona sinonimo di insicurezza e povertà per le persone. Per questa ragione, dal settembre del 2010, ha aderito alle iniziative dello Spinelli Group nel Parlamento europeo, rilanciando lo spirito federalista continentale che dall’antifascismo di Spinelli, Colorni e Rossi oggi può spingersi sino al punto da ripensare l’Europa politica oltre una dimensione meramente monetaria.
Questa visione sociale dello spazio politico continentale ha permesso a Beck di spiegare l’urgenza di un «reddito di cittadinanza continentale» utile per affrancare le persone dai ricatti del lavoro, o della sua mancanza. La creazione di un simile strumento è inoltre essenziale per garantire l’indipendenza dei cittadini da un Welfare State che sta regredendo a Workfare, cioè ad un sistema di costrizione al lavoro, con scarsa tutela della dignità della persona, né garanzia della sua condizione lavorativa. Per Beck il modello sociale europeo è il frutto di un universalismo concreto, fondato sulla tutela dei diritti sociali intesi come diritti fondamentali di una nuova solidarietà pan-europea. Altrimenti non potrà mai esserci alcuna integrazione politica continentale.
«Dobbiamo finalmente porre all’ordine del giorno queste questioni: come si può condurre una vita sensata anche se non si trova un lavoro? Come saranno possibili la democrazia e la libertà al di là della piena occupazione? Come potranno le persone diventare cittadini consapevoli, senza un lavoro retribuito? Abbiamo bisogno di un reddito di cittadinanza pari a circa 700 euro. Non è una provocazione, ma un’esigenza politica realistica».
Questo scriveva Beck sulle colonne de La Repubblica in due successivi interventi del 3 gennaio 2006 e del 22 marzo 2007. Considerazioni scritte a ridosso degli scontri tra giovani e polizia nelle banlieues francesi in fiamme, mentre cominciava la crisi statunitense dei mutui subprime. Sono passati diversi anni e l’«esigenza politica realistica» di un reddito di base sganciato da una prestazione lavorativa, inteso come strumento di solidarietà, resta lettera morta nell’agenda dei movimenti e delle cittadinanze sempre più impaurite ed è completamente assente in quella delle inadeguate classi politiche e sindacali, nazionali e continentali. Tutto questo mentre milioni di persone rischiano di diventare ostaggi della malavita, nei bassifondi delle metropoli europee, o schiavi indebitati del capitalismo finanziario eletto a unico parametro della «società globale del rischio».
Beck è stato il testimone del lungo quarantennio neo-liberista europeo in cui hanno dominato l’individualismo sociale e il «nazionalismo metodologico». «Spesso la retorica dominante afferma che non “c’è alternativa” agli imperativi dell’austerità» disse in un’intervista a Benedetto Vecchi su Il manifesto del 29 agosto 2013.
In questo atroce immobilismo prospera il Merkiavelli, efficace neologismo da lui stesso coniato per descrivere una politica capace di dettare in Europa l’agenda dell’austerità (anche in una impossibile funzione espansiva) funzionale alla difesa del patto socialdemocratico in Germania. In questa cornice gli Stati-nazione, e gli individui, si ripiegano in se stessi. «L’individualizzazione della diseguaglianza sociale», analizzata quasi trent’anni fa da Beck, oggi fa il paio con le miserie nazionaliste di classi politiche inadeguate e dei nuovi populismi presenti anche nel Parlamento europeo.
Torna quindi di attualità il «bisogno di una critica dell’Unione Europea da un punto di vista europeo e non nazionale», per dirla sempre con Beck. In un intervento sul Guardian del 28 novembre 2011 sostenne che la crisi europea può essere «un’opportunità per la democrazia». A patto di avere la forza, intellettuale e politica, per «abbandonare l’euro-nazionalismo tedesco» e far «emergere una comunità europea di democrazie» dove la «condivisione della sovranità divenga un moltiplicatore di potenza e democrazia».
Queste sono le basi di un federalismo radicale che mette in relazione i bisogni delle persone con gli spazi politici nei quali vivono. Rileggere questi insegnamenti alla luce di una visione solidale della società e dell’Europa attenua il senso di vuoto che lascia la sua morte tra chi continua a non rassegnarsi all’ordine esistente delle cose.
La Repubblica
Ci mancherà il suo contributo alla nostra coscienza
di Zygmunt Bauman
Ulrich Beck, scomparso il 1° gennaio scorso all’età di 70 anni, è stato uno dei maggiori sociologi del nostro tempo. E certamente la sua statura era destinata a crescere ancora, come l’inarrestabile impatto della sua influenza intellettuale. Una figura unica per la sua straordinaria profondità, l’acuta capacità percettiva, l’eccezionale sensibilità ai mutamenti sociali e culturali, l’ineguagliabile originalità del suo pensiero. Per gli studiosi del suo campo è stato una fonte di ispirazione e un fervido richiamo all’azione. Ma il suo impatto intellettuale ha trasceso i limiti del suo ambito professionale. La voce di Ulrich Beck – le sue diagnosi, valutazioni, previsioni e avvertimenti, sono stati ampiamente ascoltati, con viva attenzione.
Assai più che uno studioso ligio ai doveri ristretti di un’attività accademica, per vocazione Beck era la personificazione dell’intellettuale pubblico, in ragione del ruolo e delle posizioni che ha assunto: un modello cui gli studiosi di scienze sociali aspirano ardentemente, anche se a pochi è dato raggiungerlo con tanto vigore, efficacia e dedizione.
È difficile, forse impossibile, immaginare la temperie, il tenore dell’attuale dibattito politico, l’ampiezza e la profondità della nostra consapevolezza collettiva senza i molteplici e vari contributi di Ulrich Beck, la sua insaziabile curiosità nell’esplorare i meandri della vita moderna, la sua capacità di individuare prontamente e mettere a fuoco le sue realtà con osservazioni precise e pregnanti, e la sua predisposizione a quella che gli antichi chiamavano “parresia”: a rendere conto dei risultati delle sue ricerche senza cercare giustificazioni né scendere a compromessi, con libertà, fierezza e candore, attenendosi alla coscienza, giudice supremo dei comportamenti umani e guida sicura nella ricerca di verità dello studioso.
Questa morte prematura ci lascia tutti più poveri.
Traduzione di Elisabetta Horvat
Riferimenti
Su eddyburg, vecchia e nuova edizione, abbiamo inserito moltissimi scritti di e su Ukrich Beck. Potete trovarli tutti digitando il suo nome e cognome nella finestrella a destra della testata del nostro sito
 «Roma e la Liberazione. La Resistenza viene conservata come in una teca. Da tenere da conto, sempre, anche se ormai fuori moda». In calce, la postilla con i riferimenti a un evento, l'attentato di via Rasella, attorno al quale fu imbastita una colossale mistificazione.
«Roma e la Liberazione. La Resistenza viene conservata come in una teca. Da tenere da conto, sempre, anche se ormai fuori moda». In calce, la postilla con i riferimenti a un evento, l'attentato di via Rasella, attorno al quale fu imbastita una colossale mistificazione.
Il manifesto, 26 settembre 2014
Nella notte tra il 22–23 settembre qualcuno, qualcuna di noi ha ricevuto questo sms: «Oggi alle 10.30 con il tricolore Anpi… a Ponte Garibaldi fiori per Carla Capponi e Sasà Bentivegna. Vergogna. Solo il Tevere ha accolto ieri le loro ceneri…».
Ciò che era nell’aria da tempo è avvenuto. Ma come? Cerchiamo invano una cronaca. Un Tevere limaccioso inesorabilmente deserto è comparso per qualche secondo sul Tg Lazio del giorno 23, fuori campo la voce del sindaco Marino recitava che Roma non avrebbe mai dimenticato i due protagonisti della Resistenza romana…Le ceneri di Carla Capponi (morta nel 2000) e del suo compagno Sasà Bentivegna (morto nel 2012) erano custodite dalla figlia Elena nella sua casa di Zagarolo (Roma) in attesa di una degna sepoltura.
Si è capito ben presto dal «No» del Cimitero acattolico di Testaccio, su cui Elena contava per esaudire un desiderio dei genitori, che trovare una degna sepoltura per i due gappisti non sarebbe stata un’impresa semplice. Passi da parte delle autorità locali ne sono stati fatti, ma evidentemente privi di quel convincimento interiore necessario per portare a compimento il riconoscimento di un merito che nel clima politico di questi ultimi anni, una sorta di disagio crescente lo creava.
In soccorso dello scoramento di Elena si era mosso all’inizio dell’estate il Museo di via Tasso offrendo ospitalità alle ceneri, finché non si fosse trovata la sede definitiva per la sepoltura. L’Anpi di Roma da parte sua aveva proposto che i due protagonisti della Resistenza romana fossero accolti nel monumento dedicato ai caduti per la Liberazione di Roma…
I vincoli burocratici, l’inerzia che caratterizza da noi ogni procedimento amministrativo divengono un utile alibi quando un’azione è meglio rimandarla: «queta non movere»… Elena, alla fine l’ha capito, e ha dato corso a quella che definiva «la seconda scelta» dei suoi genitori: le loro ceneri affidate alle acque del Tevere.
Nulla sappiamo di come ciò sia avvenuto. Forse quei papaveri rossi che Carla tanto amava saranno stati gettati nel Tevere insieme a ciò che restava di lei, della sua luminosa bellezza, che i meno giovani tra noi ben ricordano….Già negli anni del compromesso storico Carla cominciava a creare imbarazzi: il suo coraggio ardente, il suo indomito antifascismo vissuto «con cuore di donna» suscitava nei comizi l’entusiasmo dei giovani (e lo sgomento palpabile dei segretari delle sezioni del Pci, preoccupati delle reazioni degli scout, i nuovi invitati).
Il clima politico stava cambiando. La cultura sempre più accreditata della non violenza rendeva difficile difendere l’azione dei Gap dall’accusa di terrorismo, sostenere la sua collocazione tra gli atti di guerra, considerare via Rasella un atto di eroismo, uno scatto di dignità contro la ferocia nazifascista sulla popolazione romana che l’aveva determinato.
Carla Capponi fu medaglia d’oro della Repubblica, parlamentare del Pci eletta con un vastissimo consenso, riconosciuta protagonista di quella Resistenza che tuttavia, benché condivisa da donne e uomini di diverse tendenze e idealità uniti nella lotta al fascismo, era divenuta nei decenni sempre più patrimonio rivendicato dalla sinistra.
Furono le forze di sinistra a battersi per il rispetto e l’attuazione dei principi costituzionali, le amministrazioni di sinistra a tenere vivo nei decenni l’esempio di chi aveva dato la vita per la democrazia nel nostro paese. Ma proprio questa fedeltà rischia di essere travolta nel folle volo compiuto dal Pci nella sua corsa verso il «nuovo», un «nuovo» che è sfumatura delle differenze, annullamento di tutto ciò che può rendere meno piatto il presente…
Gli eroi della Resistenza acquistano il sapore di un reperto oleografico: sono da conservarsi in una teca, come i gioielli di famiglia, da tenere da conto, ma rimasti fuori moda. Battersi per una degna sepoltura di Carla e Sasà avrebbe comportato riportare a galla recriminazioni mai sopite, schierarsi in una difesa a tutto campo di valori riconosciuti come attuali… I nostri governanti, i nostri amministratori non se la sono sentita. Questa è la verità. Ha detto bene il presidente dell’Anpi di Roma: «Le ceneri dei due protagonisti della Resistenza romana finite nel Tevere, sono un buco nero per la democrazia»
Per conoscere la reale storia di Via Rasella e comprendere la colossale mistificazione che fu costruita per falsificare la storia e convincere gli italiani che la Resistenza era stata il succedersi di vigliacchi eccidi compiuti dai "comunisti badogliani" , si vedano le informazioni fornite da Repubblica e riprese e integrate da eddyburg da il 6 febbraio 2006 e il 9 febbraio 2006. Qui sotto un'immagine del giornale che, due giorni dopo l'eccidio delle Fosse Ardeatine, invitava i partigiani a presentarsi
 Ecco perchè abbiamo scritto poco fa di un parere autorevole. Riprendiamo da un archivio un testo diUn uomo di un’Italia migliore, che è ancora tra noi e ancora insegna. Dall’archivio de
Ecco perchè abbiamo scritto poco fa di un parere autorevole. Riprendiamo da un archivio un testo diUn uomo di un’Italia migliore, che è ancora tra noi e ancora insegna. Dall’archivio de
La Nuova Venezia, 29 gennaio 2009.
«Quando sono entrato in magistratura, nel 1959, il magistrato era un travet di lusso, dipendeva dal ministero e non osava alzare lo sguardo su politici, istituzioni e potere. Poi è arrivato il Csm, che ha reso liberi pm e giudici, proteggendoli dalle accuse dei potenti: con la caduta del Muro e la fine di Dc e Pci, ci siamo infilati a guardare ovunque ed è esplosa Manipulite. E’ vero, oggi la giustizia è bloccata, ma le riforme sul tavolo sono solo il cavallo di Troia per minare l’indipendenza del pm, non garantiscono giustizia più celere».
Il procuratore generale Ennio Fortuna, sabato 31 dicembre andrà in pensione, mezzo secolo dopo aver vestito per la prima volta la toga: da allora è stato pretore, pubblico ministero, procuratore circondariale a Venezia, membro del consiglio superiore della Magistratura eletto per Magistratura indipendente, procuratore della Repubblica a Bologna e, infine, pg presso la Corte d’appello veneta. Ne ha da ricordare, con la sua voce forte e il tono incalzante, il fluire carico di aneddoti del perfetto raccontastorie e l’entusiasmo di chi crede che «fare il magistrato sia il più bel lavoro del mondo».
Le inchieste. Da quella volta che si è trovato a indagare sull’allora collega, oggi senatore pd, Luciano Violante denunciato di falso per le perquisizioni a tappeto sul sospetto golpista Edgardo Sogno («Due persone degnissime, l’indagine finì in un nulla») a quando si rifiutò, nel 1968, di processare Pierpaolo Pasolini per il film «Teorema» e il Pg di allora lo sollevò dall’inchiesta («Ma poi il regista fu assolto!»). E gli anni Settanta, quelli del terrorismo, quando nel 1974 si ritrovò il garage di casa sventagliato da 21 colpi di mitra: «Negli Anni di piombo i magistrati italiani dimostrarono di non piegarsi, riuscendo a sconfiggere il terrorismo rispettando il codice e senza mai rinunciare al garantismo: i giudici di non molti Stati lo hanno fatto».
Furono anche i tempi dei primi crac dei promotori finanziari, con il caso dell’agente di cambio Marzollo che scosse la Venezia bene che gli aveva affidato milioni di risparmi. Ancora, i primi, veri furti d’arte, un decennio prima che Felice Maniero li usasse come merce di scambio: «Ritrovare arrotolati in un campo dell’isola di Poveglia tre capolavori del Gian Bellini rubati nella basilica di Santi Giovanni e Paolo è stata una soddisfazione enorme». E i delitti. «Il caso Pastres, con l’omicidio di un bimbo di appena 6 anni, a San Donà: fu terribile», racconta ancora Fortuna, «l’assassino lo bloccammo in Crazia: non avevamo prove certe contro di lui, ma durante l’interrogatorio crollò. Devo dire che negli interrogatori sono sempre stato piuttosto bravo: nei confronti psicologici riuscivo a trovare spesso la chiave giusta per la confessione, ma oggi sarebbe impossibile con la presenza dell’avvocato sin dal primo minuto».
Unabomber. Il cruccio finale: «Che dire? E’ stato più bravo di noi. Devo dire che le Procure di Venezia e Trieste hanno fatto il possibile, puntando tutto sull’indagine scientifica. Purtroppo abbiamo perso la partita dall’interno: eravamo convinti di avere la prova che Zornitta fosse colpevole e invece abbiamo scoperto che il lamierino trovato in un ordigno, era stato alterato. L’amarezza è forte».
Dalle Olivetti ai pc. «L’esperienza più esaltante è stata quella alla Procura circondariale», ricorda Fortuna, «abbiamo aperto un ufficio in un’ex scuola dove non c’era nulla: mi feci prestare le macchine da scrivere da Semenzato, che alla fine non le volle neppure indietro tanto erano vecchie. La fortuna fu che al ministero, incuranti del fatto che a Venezia c’è l’acqua, mi assegnarono 5 autisti d’auto: li misi tutti a lavorare al registro generale, anche se all’inizio scrivevamo i reati su alcuni quadernoni che comprai a Mestre, perché non avevamo neppure i libri del ministero. Sei mesi dopo, tutto funzionava perfettamente: fummo i primi ad informatizzare i fascicoli e ad introdurre l’udienza di comparizione». Il periodo nero fu quello successivo, alla Procura di Bologna: «La trovai distrutta, anche sul piano psicologico».
Giustizia malata? «Vado via molto amareggiato per non essere riuscito a dare risposta alle giuste richieste della cittadinanza per una giustizia celere e sollecita», conclude Fortuna, «ma i problemi sono altri da quelli che si vorrebbero risolvere con le riforme sul campo. Sono un appassionato nato difensore della magistratura libera e indipendente, che oggi vedo in pericolo. Gli avvocati dovrebbero capire che la separazione delle carriere tra pm e giudici - di per sé possibile - può essere un grimaldello verso l’assoggettamento del pubblico ministero a una nomina politica: un pm sotto il governo non alza lo sguardo. Senza l’indipendenza del pm viene meno la giustizia».
Il futuro. «Finché il cervello funziona, metterò la mia esperienza al servizio di enti, imprese, studi. La politica? Nel passato mi hanno chiesto di fare il sindaco e ho rifiutato: ora sono libero da ogni impedipento, se la proposta fosse seria, potrei accettare».

Il manifesto, 21 agosto 2014
«Un’altra cosa che vorrei dire, e soprattutto ai nostri compagni che hanno già una certa preparazione, è che lo studio per loro non può consistere e non deve consistere nel mettere faticosamente assieme idee generali in forma più o meno polemica. Questo sforzo non porta di solito a fare niente di serio, e anch’esso non è studio, quando manchi la ricerca attenta, paziente, larga, dei materiali di fatto, quando manchi l’esame critico di questi».
C’è anche questo (tra consigli su come leggere e studiare, in una lettera a «una cellula dell’apparato» pubblicata su Vie nuove del marzo 1949) nella raccolta recentemente pubblicata (Palmiro Togliatti, La guerra di posizione in Italia. Epistolario 1944–1964, a cura di Gianluca Fiocco e Maria Luisa Righi, Prefazione di Giuseppe Vacca, Einaudi, pp. 372, euro 24), selezione inevitabilmente e consapevolmente «arbitraria» di un epistolario vastissimo, parte di un Fondo che attende una piena valorizzazione.
Il titolo discutibile, gramsciano, richiama un’atmosfera successiva al fallimento della rivoluzione comunista in Europa, quella «guerra di posizione» vissuta da Gramsci e Togliatti anche come occasione per ripensare i termini della sconfitta e per impedirne il ripetersi. E nella prima intervista a un inviato speciale della Reuters nell’aprile 1944, con la quale si apre il volume, Togliatti ribadiva: «Nei primi anni della sua esistenza il Partito comunista italiano commise gravi errori di settarismo, non seppe fare una politica di unità del popolo per la difesa delle libertà democratiche contro il fascismo. Di questi errori trasse profitto la reazione e noi oggi ci guarderemo bene dal ripeterli».
Ma il «ventennio togliattiano» (1944–1964), in cui Togliatti esercita il ruolo di costruttore e capo di un grande partito comunista di massa, appartiene ad epoca diversa, in cui guerra di trincea e di movimento si intrecciano in forme ormai lontane dalla fase «bolscevica». Le lettere ci restituiscono, come ha notato Mario Tronti su l’Unità del 7 luglio, «un Togliatti molto gramsciano, ma che non smette mai, nemmeno per un momento, di essere togliattiano». Dove mentalità togliattiana significa indubbiamente realismo, valutazione attenta e costante dei rapporti di forza, non per cristallizzarli ma per modificarli a vantaggio di un fronte ampio di alleanze da costruire, rivolgendosi a tutti gli interlocutori possibili. L’elenco dei corrispondenti rispecchia l’ampiezza di questa propensione al dialogo e alla ricerca di un terreno d’incontro mai subalterno (da Pietro Badoglio a Benedetto Croce, da Alcide De Gasperi a Romano Bilenchi, da Pietro Nenni a Vittorio Valletta e alla famiglia Olivetti, da Stalin a Giuseppe Dossetti).
Il ruolo attribuito alla cultura, da costruire quasi da zero - più che recinto da «egemonizzare» - per chi veniva dalla distruzione operata dal fascismo è uno dei temi fondamentali del volume, una «battaglia delle idee» seguita con cura anche nel dettaglio, quasi maniacale, senza impartire in genere «direttive», anzi rifiutando dirigismi confusi e caporaleschi sul terreno della ricerca storica (la vicenda già nota della difesa di Gastone Manacorda dalla pretesa di «dettare la linea» da parte di esponenti dell’apparato).
Quello che probabilmente colpisce di più il lettore odierno è lo sfoggio – innegabilmente compiaciuto – di erudizione, che si esplica ad esempio nelle polemiche con Vittorio Gorresio attorno a un sonetto di Guido Cavalcanti e alla sua esatta grafia: dove c’è sicuramente la volontà di dimostrare che i comunisti non erano i selvaggi dipinti dalla propaganda avversaria, ma non c’è in alcuna forma la volontà di venire ammessi nei «salotti buoni» della borghesia, che travolgerà lontani eredi di quella tradizione in anni futuri. C’è ancora la volontà di costruire un circuito culturale autonomo e parallelo, che riprende ispirazioni dell’«universo socialista» a cavallo fra i due secoli, ma senza semplificazioni grossolane e interagendo senza rigide separazioni con la cultura nazionale. C’è anche la convinzione che il movimento operaio debba essere, classicamente, «erede» dei punti più alti della cultura borghese (le famose bandiere lasciate cadere nella polvere e che vanno risollevate) e che il superamento possa avvenire solo attraverso assunzione piena delle istanze più alte della tradizione che si avversa.
La scoperta dell'illuminismo
Ma probabilmente c’è qualcosa di più, che attiene alla dimensione strettamente personale di un uomo combattuto in gioventù tra vocazioni che apparvero alternative, tra la dimensione di studioso e quella di politico, e dove la scelta esistenziale, compiuta infine, non si tradusse nel senso un po’ arido che Croce dava al termine di totuspoliticus (coniato appunto in una lettera a Togliatti) ma in una concezione della politica che pur autonoma e con le sue regole era inestricabilmente connessa alla cultura. Quest’ultima coltivata in forma autonoma, e che si era arricchita nel tempo di dimensioni in precedenza ignorate: si pensi al rapporto con l’illuminismo, completamente estraneo alla formazione giovanile torinese e ordinovista. Quel Togliatti che nelle memorie di Giulio Cerreti troviamo intento nei lunghi soggiorni parigini nella ricerca dei classici settecenteschi presso le librerie antiquarie è lo stesso che tradurrà il Trattato della tolleranza di Voltaire (in polemica con le tentazioni «clericofasciste» della nuova Italia) e che qui vediamo impegnato in discussioni su Pietro Giannone e sulla civiltà giuridica dell’illuminismo italiano.
Ma a differenza che nella cultura azionista, l’unica che in quegli anni riscopre in Italia l’illuminismo, questa acquisizione non si traduce in una ripresa del vecchio anticlericalismo, ma anzi in una attenzione più assidua al dialogo con le istanze profonde della sensibilità religiosa. In forma differenziata: sprezzante nei confronti di De Gasperi, affettuoso nei confronti di Don Giuseppe De Luca («lei è per me tra i pochi che, vivendo, della mia vita stati un po’ la compagnia e un po’ la fierezza» gli scrive il prete lucano in punto di morte, nel gennaio 1962). E in una lettera alla sorella di De Luca, a un anno dalla scomparsa, nel febbraio 1963, Togliatti chiariva i termini di questo rapporto: «La sua mente e la sua ricerca mi pare fossero volte, nel contatto con me, a scoprire qualcosa che fosse più profondo delle ideologie, più valido dei sistemi di dottrina, in cui potessimo essere, anzi, già fossimo uniti. Cercava e metteva in luce la sostanza della nostra comune umanità».
Il rigore parlamentare
L’ampiezza degli interessi culturali (unita a gusti in verità retrogradi tanto in letteratura quanto in pittura e musica) non lo spinge a divenire quello che oggi si definirebbe un «tuttologo», e questa consapevolezza del limite si riflette anche nel suo stile di direzione: «Voi mi considerate come quegli apparecchi automatici che ti servono a tua scelta, solo che tocchi un bottone, un pollo arrosto, o un bicchiere di birra o una caramella al miele» protesta scrivendo alla Federazione di Bologna nel marzo 1961. Stile che emerge anche nel rifiuto degli usi «sovietici» che i dirigenti del partito vorrebbero imporgli per celebrare la sua personalità, chiedendogli di posare per un busto: «Questo si fa, da noi, ai morti ed è una cosa ridicola. Il mio busto, per ora, sono io. Non andrò quindi dalla Mafai a posare e se ci vado, (vado) con un bastone per distruggere il già fatto». E non sapremo mai, in verità, fino a che punto credesse alle difese argomentate dell’esperienza sovietica in cui si produceva, avendo però fin dal ritorno in Italia chiarito che quel modello non era importabile né da imitare in forma ingenua e ripetitiva.
Molto significativo è anche quel che emerge sulla concezione della democrazia parlamentare, che fu uno dei cardini su cui il Pci di Togliatti venne costruito. In un momento in cui i leaders politici si esprimono in parlamento come se si trovassero alla Sagra della Fettunta di Rignano, è istruttivo lo scambio di lettere del maggio 1964 con Pietro Nenni a proposito della decadenza della prassi parlamentare. Lo scadimento dello stile di lavoro dei parlamentari si registra nella «decadenza del dibattito e quindi anche dell’istituto parlamentare. Questi discorsi ad aula vuota, nell’assenza totale o quasi dei partiti governativi e dei dirigenti del governo, e i voti che intervengono poi, a corridoi affollati, su posizioni elaborate in altra sede, sono un fatto assai grave». Già in una lettera a Giovanni Leone (presidente della Camera) del 23 luglio 1958 aveva condiviso il personale rifiuto, a norma di regolamento, dei testi «scritti» in precedenza e non sviluppati al cospetto dei deputati, avvertendo però che rispetto all’antica tradizione parlamentare il discorso politico, nell’epoca dei grandi partiti popolari, non poteva che assumere ormai «aspetti ben diversi dalla semplice dotta conversazione», soprattutto per chi rappresentava classi popolari e non proveniva dalle «classi colte, avvocati, docenti universitari, ecc.» e che pertanto nella stesura scritta trovava «assoluta necessità». Tempi molto lontani da noi, come si vede.
E lo si comprende ancor meglio dalla chiusa della lettera, con il ringraziamento a Leone per l’aiuto finanziario a lui concesso dalla Camera per motivi di salute: «purtroppo si riscontra con troppa evidenza, in caso di infermità, quanto grande sia il divario tra la retribuzione che giustamente richiede un libero professionista, anche modesto, e quella cui dà diritto l’attività parlamentare». Non c’era una «casta», anche se l’antiparlamentarismo non mancava di certo negli umori atavici dell’ideologia italiana.
Il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Togliatti e il trentesimo di Berlinguer si sono intrecciati. Sono figure che non vanno contrapposte, e Berlinguer fino alla fine degli anni Settanta si mosse in una linea di evidente continuità con alcuni capisaldi dell’ispirazione togliattiana, per poi intraprendere nell’ultima e breve fase della sua vita una ricerca bruscamente interrotta di cui nessuno può ipotizzare compiutamente gli esiti possibili. Sono stati anniversari che hanno evidenziato il sedimentarsi di «fortune» molto diverse, e quasi di mitologie differenziate, sostanziate spesso di empatia confusa in un caso, di fredda diffidenza (se non damnatio memoriae) nell’altro.
La «questione nazionale»
Probabilmente nessun cantante dichiarerà mai che votava comunista perché Togliatti «era una brava persona». Fu in effetti personaggio assai più rispettato e stimato che «amato» (se pure dopo l’attentato del luglio 1948 e nei funerali dell’agosto 1964 era emerso un profondo legame popolare nutrito anche di affetto). E certamente il mondo di Togliatti dopo mezzo secolo non esiste più, si è completamente dissolto in tutti i suoi presupposti, negli scenari nazionali e ancor più internazionali. Eppure mi sentirei di affermare che ci sono elementi di attualità maggiore nel lascito di Togliatti che in quello di Berlinguer (almeno così come viene vissuto e interpretato).
Se la «questione morale» di Berlinguer è ormai concetto largamente inservibile, esposto a tutti i moralismi e giustizialismi delle piazze, è soprattutto la «questione politica» che Togliatti ha lasciato in eredità ad assumere la dimensione di un enorme nodo irrisolto. Un grande partito di massa che rappresenti il mondo del lavoro, autonomo da poteri forti, gruppi di pressione e mosche cocchiere, incanalato in una democrazia parlamentare non eversiva dell’esistente e mediata da una Costituzione programmatica, un partito in grado di costruire con tenacia rapporti di forza più favorevoli ai lavoratori, e che si fondi su una autentica partecipazione popolare e non su ristrette élites di intellettuali o piccole sette depositarie di dottrine immutabili.
Questo è mancato drammaticamente nel quarto di secolo che ci separa dall’eutanasia della creatura politica ideata da Togliatti, e attorno a questa assenza si consuma il vuoto, muto nella sostanza, chiassoso nelle forme, della politica italiana.
 Ricordando Antonio Cederna, a 17 anni dalla scomparsa. «I temi che portò all’attenzione dell’opinione pubblica sono ancora lì: Parco dell’Appia, Fori, centri storici, difesa delle coste, piani per le città.
Ricordando Antonio Cederna, a 17 anni dalla scomparsa. «I temi che portò all’attenzione dell’opinione pubblica sono ancora lì: Parco dell’Appia, Fori, centri storici, difesa delle coste, piani per le città.
La Stampa, 27 agosto 2013
Sono trascorsi 17 anni da quando, il 27 agosto del 1996, scomparve un pilastro della cultura ambientalista italiana. Il senso di vuoto che affiora ripensando alla passione di Cederna è amplificato da questo periodo, critico e incerto, con l’Italia appesa in uno scenario che non lascia intravedere vie d’uscita dal declino dell’idea stessa di comunità
L’estate permette, con i suoi tempi dilatati, di far correre la mente, ricordando e riflettendo sul passato. Un esercizio della memoria e della volontà per trarre insegnamento dalla storia, comprendendo il senso delle cose e dando il giusto valore a ciò che conta veramente. Sono trascorsi 17 anni da quando, il 27 agosto del 1996, è scomparso Antonio Cederna. Il senso di vuoto che affiora ripensando alla passione di Cederna è amplificato da questo periodo, critico e incerto, con l’Italia appesa in uno scenario che non lascia intravedere vie d’uscita ma, piuttosto, un deterioramento dei valori e il declino dell’idea stessa di comunità.
I valori sono stati il centro della vita di Antonio Cederna: etica, responsabilità, competenza, impegno civile, di volta in volta rivolti alla professione di giornalista, al ruolo di militante ambientalista, all’azione dell’uomo politico, all’essere un esponente del mondo della cultura. Con rigore ha saputo dire cose scomode, non accettando di tacere di fronte ai disastri, alle manomissioni del territorio e del patrimonio culturale del nostro paese.
Argomenti scomodi, un fastidio per la politica diventata strumento di gestione del consenso e oggetto di scambio clientelare: una scomodità che costò a Cederna l’essere posto nell’alveo degli intellettuali, un po’ eccentrici, ma non adatti a governare. Troppo spesso liquidato con l’appellativo di Cassandra, con la superficialità di chi non vuole capire e affrontare realmente i problemi, preferendo l’improvvisazione di soluzioni poco efficaci e di scarso rilievo.
Serve ancora oggi, nell’Italia del 2013, ricordare chi scrisse libri che in realtà erano denunce e testimonianze, come I vandali in casa, La distruzione della natura in Italia, Memorabilia Urbis, … . Serve e sarebbe utile ripercorrere e studiare il suo archivio, vedere le interviste, ascoltare la descrizione di come si costruivano periferie brutte e invivibili: tutto il materiale, raccolto in decenni di attività, è oggi disponibile, grazie alla sua famiglia che lo ha donato, affinché diventasse un patrimonio di conoscenza collettivo. Una scuola dell’esperienza e del metodo di lavoro che mise in cima alle priorità la comprensione dei problemi, studiando le soluzioni e proponendo un modo diverso di affrontare le criticità, guardando all’Europa, restituendo un valore al bene comune e affermando un ruolo ineludibile del decisore pubblico. (www.archiviocederna.it)
L’attualità dei suoi scritti è ancora qui, sotto i nostri occhi: l’incapacità di governare il territorio, di guidare lo sviluppo, attraverso scelte di buon governo, fatti che possono risultare ovvii ma che, ancora oggi, caratterizzano l’assenza di una politica che capace di fare della sostenibilità la base per il futuro dell’Italia. Un’attualità resa ancor più dirompente perché, già negli anni ’60, indicava nell’Europa il modello da imitare, seguendo l’evoluzione dell’urbanistica e delle politiche di gestione del territorio.
I dati relativi al consumo di territorio, alla perdita di biodiversità, all’inquinamento nelle aree urbane, alle emergenze “permanenti” come quelle dei rifiuti, del dissesto idro-geologico sono inquietanti: l’Italia registra un ritardo e un arretramento rispetto agli altri paesi europei, accumulando inefficienze e inadempienze. Non si tratta di una posizione puramente estetica, da “anime belle” come l’avrebbe definita Cederna: è un problema ben più complesso, fondato sul rapporto tra scarsità e disponibilità di risorse. Si tratta, in realtà, di una questione civile e culturale che può fare la distinzione tra una nazione e un’altra per il livello di progresso raggiunto, per il rispetto della legalità e delle opportunità di sviluppo alle quali accedono i cittadini. L’Italia oggi detiene il primato in Europa per le procedure di infrazione alle norme comunitarie in materia ambientale e in molte regioni il circuito economico legato alla criminalità coincide, non casualmente, con un alto tasso di reati ambientali, favorendo un florido settore che abbiamo imparato a chiamare “ecomafie” fatto di traffici illeciti, corruzione e inquinamento.
Si continua a credere che sia sufficiente scrivere le leggi, senza preoccuparsi di come farle rispettare, facendo crescere il capitale sociale e la coscienza di una cittadinanza attiva. Siamo tuttora bloccati a un modello dell’economia slegata dai processi ecologici e dall’impatto delle attività dell’uomo sull’ecosistema dove l’energia diventa un’emergenza se il petrolio raggiunge il prezzo di 100 dollari al barile ma non ci poniamo il dubbio di comprendere quali costi collettivi, legati ai cambiamenti climatici, non sono compresi in quel prezzo, ma pesano come un macigno in termini di ritardo nell’adottare altri modelli fondati sull’innovazione.
Nel frattempo un altro anno è trascorso così, con boschi bruciati, discariche stracolme di rifiuti, città ammorbate dal PM10 e dal monossido, spiagge con divieti di balneazione, alluvioni e frane, …, . Si dirà che tutto questo è inevitabile, che non si può limitare il mercato: eppure gli allarmi si fanno sempre più ricorrenti, il clima si sta modificando e le soluzioni non possono essere sempre improntate all’emergenza, a provvedimenti estemporanei.
Biodiversità, clima, trasporti, energia, acqua, territorio, rifiuti, tutte tematiche che quotidianamente entrano con forza sulle pagine dei giornali e nelle nostre vite ma che, con grande difficoltà, si trasformano in politiche strutturali restando, spesso, inutili grida d’allarme, titoli di giornale che durano pochi giorni, facendoci restare nel rischio dell’emergenza e della catastrofe imminente. Le stesse emergenze di cui scriveva Cederna, avvolte, oggi come allora, nella disattenzione. La disattenzione che potrà essere più o meno colpevole ma sempre ancorata alla convinzione che l’ambiente sia un serbatoio da consumare senza mai porsi il dubbio circa la riproducibilità delle risorse e la responsabilità verso le generazioni future.
Degli incendi estivi, diceva Cederna, bisognerebbe parlarne durante l’inverno, quando è necessario programmare gli interventi, predisporre i provvedimenti, rendere efficienti gli strumenti di tutela e di prevenzione: un’idea alquanto bizzarra in un paese abituato all’emergenza e all’ineluttabilità delle cose che accadono perché il destino è cinico e baro. Un paese dove la regola non è la pianificazione bensì la deroga e il ripetersi di condoni e prescrizioni, frutto di una corruzione diffusa e dell’irresponsabilità di chi dovrebbe controllare. Eccoci quindi fermi nel ritenere che l’ambiente sia un limite, un intralcio per il progresso, un vincolo per la crescita economica misurata dal PIL: i boschi in fiamme, i fiumi inquinati o il traffico congestionato nelle aree urbane sono ancora considerati il costo da pagare per accedere a un maggiore benessere. Il PIL dimostra la sua inadeguatezza nel misurare lo sviluppo di un’economia che non può basarsi soltanto sulla quantità di beni e servizi ma dovrebbe registrare anche il livello di qualità dello sviluppo, creando condizioni di maggior competitività basate su scelte strutturali.
Antonio Cederna queste cose le vide e le denunciò, con forza e fermezza, insistendo affinché l’opinione pubblica prendesse coscienza e rinnegasse uno stato di cose come questo: alcune battaglie di Cederna sono arrivate tal quali fino ai nostri giorni e, tuttora, sembra impossibile ripristinare la normalità. Battaglie che, riascoltando gli accorati interventi di Cederna, sembrerebbe ovvio che lo Stato facesse proprie, oggi più che mai, riaffermando i principi di legalità e di buona gestione, definendo obiettivi e programmi, affidando compiti e responsabilità in modo chiaro.
Eppure non è così: si continua a discutere dello sviluppo delle città e delle condizioni di vivibilità delle periferie; si insiste a mettere in dubbio l’utilità di parchi e riserve naturali; si minano le condizioni minime per tutelare e proteggere il patrimonio storico, artistico e archeologico; si considera il paesaggio come un intralcio per la crescita economica; si resta immersi nella pigrizia e nell’assenza di visione, una poltiglia che avvolge tutto e rende inestricabili i nodi.
Quelli che furono, cinquanta anni fa, i temi che Cederna portò all’attenzione dell’opinione pubblica sono ancora lì, afflitti dal disinteresse e dall’ignavia: il Parco regionale l’Appia Antica, i Fori, la tutela dei centri storici, la difesa delle coste, la pianificazione delle città. Di volta in volta si annunciano programmi straordinari e soluzioni innovative ma, alla fine, restano solo l’abbandono e la precarietà, nell’assenza pressoché totale di una visione di lungo periodo. Anche per Antonio Cederna ha funzionato la regola che vuole che si dia maggior risalto e valore alle idee di coloro che non ci sono più, spesso per un vezzo elitario, per dare solo maggior dignità alle proposte, destinate a restare ipotesi o dichiarazioni di principio. Toccò anche a lui la sorte di restare nella solitudine di chi vuole anteporre l’interesse collettivo al profitto personale, la solitudine di chi scrive e vorrebbe vedere le cose cambiare.
Sono trascorsi diciassette anni dalla sua scomparsa: se Cederna fosse qui continuerebbe a essere una voce pungente e brillante denunciando disastri annunciati e disattenzioni. Ben poco si è saputo apprendere dalla sua intelligenza e dal suo impegno civile: i calendari continuano a essere punteggiati con le date delle alluvioni, degli incendi, delle frane, delle discariche stracolme, del caos sulle strade, delle città invivibili. Continuiamo a ricordare i luoghi con le conseguenze delle nostre disattenzioni, senza intravedere un’alternativa. Restano soltanto gli sprechi irrisolti, i tagli irragionevoli e l’abbandono cronico.
La grande bellezza la vediamo solo nei film, ma, una volta tornati nella realtà, siamo ancora lì, tra l’abbandono e la desolazione, con la rassegnazione che possa cambiare ben poco. Antonio Cederna resta un monito, utile se un giorno si decidesse di cambiare marcia, per davvero.
il manifesto
Il giovane grande vecchio che amava capire il mondo
di Daniele Mazzonis
Marcello Cini è stato il mio maestro, non c'è dubbio.L'ho seguito dai lontani anni Settanta, quando il tema della salute in fabbrica ci ha fatto incontrare in una mini-manifestazione nell'androne della Facoltà di chimica della Sapienza. Era quasi l'inizio delle «150 ore» nelle quali volevamo condividere con i lavoratori quello che avevamo imparato. In verità più che insegnare gli effetti dei residui tossici delle produzioni chimiche o le ricadute del nucleare preferivo andare a sentire Marcello che insegnava, anche a me e a partire della fisica, perché la scienza non è neutrale. Oggi so che sembra impossibile, ma miei professori reputavano l'epidemiologo Giulio Maccacaro (che discuteva della salute in fabbbrica) un medico fallito, Franco Basaglia uno che voleva fare parlare di sé ma non avrebbe mai tradotto le sue fantasie in realtà, Steven Jay Gould uno pseudo-scienziato che contraddiceva la teoria evoluzionista e Marcello un pazzo furioso, visto che da grande fisico era diventato agitprop dei sessantottini .
Marcello invece amava il suo mestiere, amava pensare e pubblicare le sue riflessioni sulla teoria della misura dopo la quantistica, ma non rinunciava a guardare il mondo, a cercare disperatamente di capirlo e spiegarlo, non avendo - diceva - alcuna capacità di cambiarlo. Si autodefinì cattivo maestro in un bellissimo libro in cui un nonno educatore e un filosofo dialogano con la bambina Alice. A parte lo straordinario interesse del libro che spiega in termini semplici i nodi più complessi della fisica quantistica (Lucio Magri disse che finalmente aveva capito il mestiere e i contenuti della fisica), Marcello abborda il suo tema preferito negli ultimi anni: quello del capitalismo che sta trasformando in merce tutte le forme non materiali di soddisfazione dei nostri bisogni, una mercificazione che appiattisce la complessità della conoscenza e toglie valore al bello.
Marcello era giovane anche da vecchio: era curioso e disponibile a sentire chi non la pensava come lui; ma quando lo faceva prima ripensava e dubitava e subito dopo, con qualche colpo di tosse, si arrabbiava. Anche questo lo faceva con gentilezza ma senza mai mediare, né di fronte a colleghi, ministri, rettori. Se non compreso, se la prendeva e diventava irascibile: in un compito alle elementari da bambino suo figlio lo chiamò «il re dell'ira».Non posso chiudere senza parlare della nostra pagina scientifica su «il manifesto». Avevamo convinto il giornale - non era stato difficile con l'aiuto di Michelangelo Notarianni - a uscire ogni mercoledì con una pagina sulla scienza (fummo i primi in Italia anche se pare incredibile), ma doveva essere una pagina diversa alle altre. Non volevamo fare divulgazione, ma «volevamo spiegare» il processo di accumulazione di conoscenza, le scoperte interessanti, le vere e false promesse che i laboratori del mondo sfornavano a ritmo sempre più accelerato.
A Marcello chiedevo una riflessione settimanale e, per anni, ogni martedì, mi ha odiata per la mia telefonata di richiesta del pezzo che arrivava sempre tardi (Marcello nella scrittura era lento quanto serio, misurava la portata di ogni affermazione per poterla sostenere con chiunque). Siamo gli unici in Italia ad avere dato il peso che meritava alla moratoria decisa alla famosa conferenza Asilomar sugli esperimenti sul materiale vivente, in cui i più famosi studiosi del settore chiesero d'interrompere gli esperimenti e aprire una fase di riflessione sulle conseguenze delle manipolazioni genetiche. Grazie alla collaborazione con i compagni del petrolchimico e a qualche collega onesto, fummo i primi a parlare della diossina di Seveso. Oggi Taranto ci ricorda che queste battaglie non sono vinte.Come tutti i compagni, sono davvero triste. Ancora il mese scorso, quando ho discusso con lui l'ultima volta prima della mia partenza per l'Argentina, Marcello a me sembrava giovane, giovanissimo, come sempre.
il manifesto
Il brillante docente e ricercatore che incontrò la storia e la società
di Giorgio Parisi
Durante il '68 Marcello Cini non stava a Roma: aveva preso un anno sabbatico in un'università parigina. In quel periodo sentivo spesso parlare di questo compagno professore, che aveva sempre pronta una citazione raffinata di Marx e che era appena andato nel Vietnam del Nord bombardato dagli americani.Lo incontrai al suo ritorno a Roma, avrei dovuto seguire un suo corso di fisica, ma tra occupazioni e altre vicende le lezioni a cui sono andato si contano sulle punte delle dita. Ma ho ancora impresso in mente lo sforzo che Marcello faceva per non separare i risultati della meccanica quantistica (la formulazione matematica, i teoremi, le previsioni sperimentali) dal come un piccolo numero di uomini era riuscito a fare queste scoperte meravigliose, formulando all'inizio ipotesi insensate e contraddittorie che con gli anni si modificavano e diventavano sempre più sensate e coerenti. Non era affatto facile portare assieme i due discorsi: la storia di un'avventura che si dipanava per un periodo di una trentina d'anni (dal 1900 al 1930) e la descrizione della teoria risultante. Era un modo diverso di raccontare la scienza, che faceva notevole impressione a noi abituati a vedere solo il prodotto finale, bello lucido, senza che ci rendessimo conto della fatica che era stata necessaria per arrivarci.
Era un periodo di transizione nella vita di Marcello. Nel primo dopoguerra era diventato un brillante fisico teorico nella disciplina allora di punta, la fisica delle altre energie, e a soli 33 anni nel 1956 aveva vinto una cattedra all'università di Catania. Aveva continuato a lavorare, pubblicava articoli su prestigiose riviste, era invitato a parlare a importanti congressi internazionali, ma la fisica teorica gli stava diventando stretta. Come lui stesso dice nei Dialoghi di un cattivo maestro, «la fisica teorica stava cambiando. La concorrenza diventava sfrenata. Se avevi un'idea, scoprivi che altre sei persone ci stavano lavorando sopra. (...) Quando eravamo pochi, anche il nostro lavoro aveva un senso. Ma una volta diventati tanti, veniva da domandarsi a che cosa servisse. (...) Questo disagio professionale si accompagnava all'insoddisfazione che provavo da qualche anno nei confronti della politica del Pci».
In quel periodo Marcello stava cessando di lavorare nel filone principale della fisica: riprenderà la sua attività di ricercatore diversi anni dopo, affascinato da uno dei problemi più intriganti e mai ben risolti della fisica: quale sia «il significato» della meccanica quantistica, cosa sia la realtà fisica, quale sia in questo contesto il rapporto tra la l'osservatore e l'oggetto osservato, quanto l'osservazione di un fenomeno modifichi necessariamente il fenomeno stesso. Marcello incominciava a riflettere su i rapporti tra la scienza, la storia e la società, a vedere la scienza come una delle tante attività umane che diventa «comprensibile solo se riferita alla totalità dell'operare degli uomini». La scienza non è più neutrale, ma porta con sé i segni delle ideologie degli scienziati che l'hanno prodotta.
Sono le tesi che confluiscono ne L'Ape e l'Architetto, libro pubblicato nel 1976 e che raccoglie saggi scritti negli anni precedenti da Giovanni Ciccotti, Marcello Cini, Michelangelo De Maria e Giovanni Jona Lasinio. Erano tesi doppiamente eretiche rispetto all'ortodossia dominante, dal punto di vista sia politico che scientifico, e suscitarono una reazione furiosa: Lucio Colletti e Giorgio Bocca furono tra gli oppositori più accesi che cercarono di smontarle con una serie di banalità impressionanti. La reazione del mondo scientifico fu più composta, di grande freddezza in pubblico, ma veementemente negativa in privato. Il libro, che ebbe una notorietà enorme e che è stato recentemente ristampato, ebbe tuttavia, col passare degli anni, una fortissima influenza sul modo in cui concepiamo il rapporto tra scienza e società e molte delle tesi scandalose sono diventate sentire comune.
Marcello non si era però fermato lì: aveva continuato a riflettere sui rapporti tra scienza, tecnologia società e democrazia, su quali fossero concretamente e in dettaglio queste relazioni, come si modificassero con il tempo, su come fossero diverse per esempio fisica e biologia, riflessioni che hanno generato molti libri in cui raffina e approfondisce il suo pensiero. Marcello è stato uno dei pochi grandi intellettuali che ha cercato di capire a fondo il mondo, non solo negli aspetti tecnici di una disciplina scientifica, ma nella sua interezza, riempiendo la propria vita sia dell'impegno politico che dello sforzo per arrivare a una maggiore comprensione e controllo della natura. Era uno dei pochi punti di riferimento che avevamo, sempre pronto a discutere e ad aiutarti a capire. Ci mancherà moltissimo.
il manifesto
Un ottimo cattivo maestro
di Marco D’Eramo
Marcello Cini lo conobbi prima come professore, al terzo anno, quando dall'ottobre del 1968 seguii il suo corso di Istituzioni di fisica teorica. Parlava molto lentamente, con quel tossicchiare a scandire le frasi che avrei imparato a conoscere così bene, e all'inizio trovavo noiose le sue lezioni. Col mio sguardo di 21-enne lo trovavo vecchio. Aveva 45 anni ed era nel pieno fulgore della sua maturità. Non sapevo quanto le nostre vite sarebbero state intrecciate. Infatti nel gennaio di quello stesso anno erano iniziate le agitazioni studentesche a Roma, che erano culminate il primo marzo con quella che fu chiamata «la battaglia di Valle Giulia» ma che continuarono per tutto l'anno successivo. L'istituto di fisica Enrico Fermi fu uno dei centri del movimento romano, insieme a Lettere e Architettura. Leader del movimento erano giovani fisici, assistenti e borsisti, che nel decennio successivo avrebbero seguito traiettorie diverse: Franco Piperno, Gianni Mattioli, Massimo Scalia, Sandro Petruccioli, Mimmo De Maria. E, quando tornò dal suo anno sabatico a Parigi, Marcello fu l'unico ordinario a interloquire con noi, anche a polemizzare, ma stando sempre dalla nostra parte, lui che era noto per la sua militanza nel Partito comunista italiano (da cui sarebbe stato radiato dopo pochi mesi, nel 1969, insieme a tutto il gruppo della rivista il manifesto).
Poi Marcello fu il mio direttore di tesi e dopo la laurea si adoperò perché divenissi borsista nel suo gruppo di ricerca teorica. Quando abbandonai la fisica e andai a studiare sociologia a Parigi, negli anni Settanta, ogni volta che veniva sulla Senna, ci vedevamo, cenavamo insieme con la sua (allora) nuova compagna, Agnese. Poi, nel 1980 per le peripezie della vita, venni a lavorare nel quotidiano di cui Marcello era stato uno dei fondatori e dalle cui colonne ora vi sto scrivendo. Ancora, il figlio di Marcello, il regista Daniele Cini, aveva vissuto per anni nella stessa casa della nostra indimenticata Carla Casalini, e la sua perdita nel 2008 ci ha stretti alla sua figlia Gaia.Non solo, ma negli anni Settanta Marcello aveva animato un gruppo di fisici teorici (di cui oltre a Marcello facevano parte Giovanni Ciccotti, Michelangelo De Maria e Giovanni Jona-Lasinio) che avrebbe prodotto l'unico contributo italiano davvero rilevante alla filosofia della scienza, e cioè L'ape e l'architetto (Feltrinelli 1976, ripubblicato con rivisitazioni degli autori presso Franco Angeli nel 2011). Era la prima volta in Italia che a discutere di neutralità della scienza erano scienziati professionisti.
Fino al fine anni Sessanta infatti la sinistra italiana era stata scientista, d'istinto e di convenienza. Lo scientismo era l'orizzonte filosofico più comodo per coniugare insieme emancipazione sociale e progresso tecnologico, razionalismo antisuperstizioso e laicità. Una versione paludata di quello slogan «Soviet + elettrificazione» in cui cui Lenin aveva condensato tutto il comunismo. Sul versante opposto, le critiche alla scienza venivano tutte da un orizzonte irrazionalista, poetante, nietzscheano, aborrente i numeri («la legge di gravità non renderà mai conto della poesia della luna di notte») e la rivendicazione di un'ineffabilità sostanziale del mondo.Ma già dal sottotitolo, Paradigmi scientifici e materialismo storico, i quattro autori rimescolavano le carte ed esplicitavano il loro obiettivo: affrontare la non-neutralità della scienza, la sua storicità, non dalla prospettiva di un irrazionalismo di destra, ma da sinistra e dall'interno del razionalismo. Non a caso i quattro autori avevano tutti partecipato in modi diversi al '68.
E ci voleva la carica eversiva del '68 per poter formulare - contro tutto l'establishment accademico e contro la corporazione degli scienziati, in primis dei fisici - una visione storicizzata della scienza. Per poter cioè dire che la scienza è prodotto storico, come ogni altra attività umana, e in quanto tale condizionata dalla società in cui viene esercitata. Fino ad allora aveva prevalso la tesi che la scienza di per sé è neutra e a-storica, anche se il suo (buono o cattivo) uso può essere determinato dal contesto sociale. L'ambizione dell'Ape era invece quella di mostrare che la correlazione tra società e ricerca scientifica penetrava fino nelle teorie e nei concetti. Un'ambizione che valse al libro una levata di scudi sul genere becero «la legge di gravità fa cadere i corpi allo stesso modo in un regime socialista e in uno capitalista».
Fu proprio la non neutralità degli stessi concetti scientifici a indirizzare il lavoro giornalistico e di ricerca che facemmo sul manifesto per tutti gli anni '80 sulle pagine culturali e sul supplemento monografico settimanale la talpa. Un lavoro cui partecipavano tra gli altri Michelangelo Notarianni, Franco Carlini, Danielle Mazzonis.Certo Marcello, non sempre andavamo d'accordo tu e io: per esempio non condividevo la sua passione per Bateson, ma è certo che il confronto intellettuale sui temi che ci arrovellavano entrambi ha stimolato la mia mente, come quella di tanti altri, e ci ha consentito di non assopirci nel generale letargo della ragione che ha colpito la nostra società.E come apprezzammo nel 2007 la lettera che dalle colonne del manifesto scrivesti (insieme ad alcuni altri docenti tra cui Giorgio Parisi) al rettore dell'università La Sapienza di Roma per far annullare la lectio magistralis di Benedetto XVI!
Una vita lunga e invidiabile la tua Marcello: non solo sei sempre stato un bellissimo uomo, ma hai fatto un bellissimo lavoro, quello di fisico teorico, hai visitato terre lontane (come quando nel 1967 andasti in Vietnam e in Laos, sotto le bombe americane, come membro della giuria del Tribunale Russell), hai avuto una miriade di amici intelligenti che ti amavano, eri stimato, hai militato per una società migliore, hai contribuito a fondare il manifesto, hai stimolato la discussione filosofica italiana, hai goduto i piaceri della vita. Come scrisse Catullo a suo fratello: et in perpetuo salve atque vale.
Addio a Marcello Cini, fisico e ambientalista
di Piergiorgio Odifreddi
È morto a quasi novant’anni Marcello Cini, influente e discusso scienziatoengagé,nel senso alto della parola: quello portato alla ribalta dalle contestazioni studentesche degli anni ’60, e oggi purtroppo solo un ricordo di tempi passati. Esatta antitesi dell’intellettuale chiuso nel suo laboratorio a osservare le particelle, o rinserrato nel suo studio a cercarne le leggi, Cini era uscito allo scoperto per diventare un “cattivo maestro”, come si era definito con provocatoria civetteria negli autobiograficiDialoghi di un cattivo maestro,appunto.A portarlo alla ribalta nel 1976 fuL’ape e l’architetto,un libro scritto con Giovanni Ciccotti, Michelangelo De Maria e Giovanni Jona-Lasinio, che sollevò un vero e proprio polverone. Cini e i suoi coautori attaccavano infatti la visione di una scienza neutrale e impersonale. Ne mettevano in luce non solo le implicazioni, ma anche e soprattutto le responsabilità sociali. E percorrevano una specie di “terza via”, a metà strada tra gli eccessi acritici dell’accettazione scientista e del rifiuto idealista.
Il linguaggio di quelle pagine oggi suona un po’ arcaico edemodé,con tutti quei riferimenti ai “modi di produzione” e alle “classi dominanti”. Ma la sostanza rimane attuale, se è vero che, come ricordava qualche tempo fa lo scomparso premio Nobel per la pace Joseph Rotblatt, la maggioranza degli scienziati attualmente lavora a ricerche direttamente o indirettamente legate agli armamenti. E una percentuale ancora maggiore, ovviamente, a ricerche direttamenteo indirettamente legate all’industria e alla tecnologia.Sorprendentemente, a scagliarsi contro quest’interpretazione marxista della scienza fu Lucio Colletti, coetaneo di Cini, che in una famosa recensione sull’Espresso scrisse: «Qui la scienza e il capitalismo fanno tutt’uno. Il valore oggettivo della conoscenza scientifica è saltato. Malgrado le intenzioni è saltato anche il materialismo». Quasi quarant’anni dopo, la storia registra la coerenza di Cini, collaboratore fino all’ultimo delManifesto,e il tradimento di Colletti, fiore all’occhiello di Forza Italia dal 1996 alla mortenel 2001.
Politicamente, Cini (nato nel 1923 a Firenze, chiamato alla Sapienza da Edoardo Amaldi per insegnare Fisica teorica e, poi, Teorie quantistiche) aveva fatto parte del Partito Comunista Italiano fino al 1970, quando ne era stato espulso insieme agli altri fondatori delManifesto,appunto. E nel 2010 aveva accettato la candidatura da capolista di Sinistra Ecologia Libertà alle regionali del Lazio. D’altronde, l’ecologia e l’ambientalismo erano due dei grandi temi del suo pensiero, a favore dei quali si era impegnato nella presidenza del consiglio scientifico di Legambiente.
L’ultima zampata da leone l’aveva data il 14 novembre 2007, indirizzando al rettore della Sapienza una lettera di protesta in cui gli chiedeva di annullare l’invito a BenedettoXVI in occasione dell’apertura dell’anno accademico. Decine di docenti dell’università sottoscrissero l’appello di Cini, e centinaia di studenti manifestarono contro la visita del papa, che decise diplomaticamente di cancellare la proprialectio magistralis.Fu in quell’occasione che vidi Cini per l’ultima volta. Partecipammo insieme, la sera del 16 gennaio 2008, a una puntata di Porta a Porta, il giorno prima della mancata visita papale. Monsignor Fisichella e l’onorevole Buttiglione chiamarono a raccolta per la domenica successiva in Piazza San Pietro. Cini intervenne signorilmente e pacatamente, a difesa della scienza e della sua separazione dalla religione. E le sue parole e la sua chioma bianca sono il mio ultimo ricordo del “cattivo maestro”, che quella volta era riuscito a scuotere l’Italia intera.
Corriere della Sera
Addio a Cini, il fisico che si oppose alla lectio del Papa alla «Sapienza»
di Giovanni Caprara
«Sono convinto che anche le conoscenze scientifiche non sono verità assolute ma sono relative e contingenti e debbono essere vagliate da altri punti di vista, tra i quali anche quello della filosofia. Naturalmente anche questi punti di vista sono a loro volta relativi e contingenti: un punto di vista assoluto e immutabile non esiste». Questa era l'idea della scienza di Marcello Cini, scomparso lunedì a Roma all'età di 89 anni. E le sue parole rivelavano il metodo che lui applicava alla vita in generale, sempre, ponendo in discussione tutto pur restando fedele alla sua visione dell'uomo.
L'ultima sua uscita clamorosa risale al novembre 2007, quando scriveva al rettore dell'Università di Roma «La Sapienza» chiedendogli di annullare lalectio magistralisdi Papa Benedetto XVI all'inaugurazione dell'anno accademico, giudicandola inadatta all'occasione. E fu l'ultima volta in cui riuscì a coagulare intorno a sé il consenso di 67 docenti che firmarono con lui, ma provocando fuori dell'ateneo accese reazioni, soprattutto da parte del mondo cattolico. Diventò un caso che sollevò contestazioni e disordini. E il Pontefice tre giorni prima della visita, nel gennaio successivo, rinunciava all'invito. Cini sostenne in modo risoluto la laicità dell'istituzione: considerava la presenza del Papa una violazione. E con questo manifestava anche la sua idea di laicità assoluta. Era uno dei tanti volti di Marcello Cini, il primo dei quali era tuttavia quello dello scienziato: sulla cultura scientifica egli costruiva le sue certezze.
Era nato a Firenze il 29 luglio 1923, arrivando ad insegnare fisica teorica alla «Sapienza» chiamato da Edoardo Amaldi. Poi abbracciava le frontiere più avanzate della fisica quantistica. Nonostante i suoi pensieri di fisico fossero molto astratti e apparentemente distaccati dalla quotidianità Marcello Cini guardò alla Terra e alla difesa della vita con la stessa intensità con la quale difese la laicità.Negli anni Sessanta diventò uno dei padri, il più nobile, degli ambientalisti. Cini era un fine intellettuale le cui idee potevano non essere condivise, ma era stimolante considerarle: il confronto generava sempre un arricchimento. Ma sapeva anche mettersi in discussione come nel libro Dialoghi di un cattivo maestro.
Le sue accese convinzioni, la voglia di incidere sulla realtà lo portò inevitabilmente in politica. Partecipò alla fondazione del quotidiano «Il Manifesto» e negli anni Sessanta fece parte del Tribunale Russell sui diritti dell'uomo, recandosi in Vietnam e raccontando poi le atrocità della guerra. Alla direzione della rivista «SE/Scienza Esperienza», fondata da Giulio Maccacaro, la sua linea fu discutere e diffondere lo stretto rapporto tra scienza e società. Come i suoi articoli, ancor di più facevano discutere i suoi libri, in cui scavava ancora più a fondo la visione sociale della scienza. Per questo L'ape e l'architetto, Il gioco delle regolee Il paradiso perdutosegnarono davvero un'epoca.
N el 1999 proposi a Eric Hobsbawm, l'inventore del «secolo breve», un'intervista sul nuovo secolo che stava per cominciare. Il mio era un tipico giochetto giornalistico: chiedere a uno storico una previsione sul futuro basata su un'analisi del passato. Poiché a Eric piaceva giocare, accettò.
Ne nacque una conversazione di cui l'editore Laterza vendette i diritti in tutto il mondo (in Inghilterra, Usa, Germania, Francia, in lingua spagnola e portoghese, giapponese, turco, romeno… In alcuni Paesi ci furono addirittura delle aste per aggiudicarsi il libro).
A testimonianza della fama planetaria che circondava uno storicoglobal, come si direbbe oggi: per niente eurocentrico, sempre perfettamente a conoscenza degli eventi nei più sperduti posti del mondo, e soprattutto in grado di cogliere i nessi, anche i più singolari, «ciò che legava la nascita del rock and roll, il disfacimento del matrimonio, la bancarotta dell'avanguardia artistica, il declino dell'etica puritana del lavoro o quello del regime parlamentare». Diciamo che era uno al quale non sarebbe sfuggito un battito d'ali di farfalla in Brasile capace di produrre un tornado in Texas.
L'intervista si svolse nell'arco di una decina di giorni, in unafull immersionnella sua casa londinese ai margini del parco di Hampstead Heath. Dalla mattina alle 9 alla sera alle 5,nine to five, ascoltando musica jazz (di cui era recensore professionale) e Bbc Four, facendoci il caffè e i panini da soli. Questo incontro ravvicinato con Eric, fisicamente la più perfetta descrizione dell'aggettivo allampanato che io conosca, fu un'occasione per studiare un personaggio vissuto anche più a lungo del suo secolo breve (era nato nell'anno della Rivoluzione bolscevica) e che in qualche modo ne aveva incarnato ilGeist. Il prodotto era un uomo straordinario e complesso quanto la sua era.
Intanto era difficile definirne l'identità. Si trattava di un ebreo, che la famiglia aveva allontanato con lungimiranza da Vienna e da Berlino per spedirlo lontano dalle camicie brune, cioè di un esule? O era ormai un inglese, perfettamente a proprio agio nelle sue pantofole e nella sua patria d'elezione? Oppure un apolide, come si addiceva a coloro che avevano fatto parte di un movimento di palingenesi internazionale quale era il comunismo mondiale? Oppure ancora un prototipo di europeoante litteram, come poteva far supporre la sua perfetta padronanza del francese, dell'italiano, del tedesco, e la sterminata rete di conoscenti e amici che gli telefonavano ogni giorno da tutto il continente?
Penso che la descrizione migliore di Hobsbawm non fosse nessuna di queste. Egli apparteneva in realtà a una nazionalità sconosciuta sui passaporti: era unlondoner, un cittadino di Londra, di questa specie di città-stato cresciuta lungo il Tamigi tra la City e il West End, che per secoli ha idolatrato la libertà attraendo a sé il moderno. Anzi, per essere più precisi, Hobsbawm era un cittadino di Hampstead, il villaggio collinare dove si erano concentrate alcune tra le migliori menti del Novecento, spesso in fuga dai loro Paesi. Gente strana, erudita, informale, con le case piene di libri e gli armadi pieni di vecchi maglioni con le toppe, arroccatasi intorno a un bosco, su un'altura dove per secoli mercanti, geografi, scienziati avevano scrutato il globo dalla sommità dell'impero.
Poi c'era l'altra grande domanda che la sua vita provocava: Hobsbawm era ancora, o almeno poteva ancora definirsi, un comunista? Da ragazzi lo leggevamo su «Monthly Review», era un intellettuale chiave per chi negli anni 70 coltivava l'illusione che si potesse restare comunisti in Occidente senza accettare la realtà del comunismo sovietico. Lui filosovietico di certo non era, al punto che in Urss non erano mai state tradotte le sue opere. Nel 1956 era cominciato il suo grande freddo con il Partito comunista britannico: «Dissi ai dirigenti — raccontò nella nostra intervista — che non avrei rotto i rapporti con coloro che erano stati espulsi e aggiunsi che, se a loro non stava bene, potevano cacciarmi». Non lo cacciarono, ma lui non lasciò. Cominciò allora quel limbo di ambiguità in cui tanti comunisti occidentali — italiani innanzitutto — si logorarono per decenni, cercando una via al socialismo che fosse diversa. Alla «via italiana» Hobsbawm dedicò anche un saggio, in nome di Gramsci e in ammirazione di Berlinguer, allora protagonista della effimera stagione dell'eurocomunismo.
Non volle riconoscere, nemmeno quando ne parlammo ad Hampstead alla vigilia del Capodanno 2000, che il comunismo era «il passato di un'illusione», per dirla con il titolo di un fortunato e ben più radicale libro di François Furet, che uscì quasi in contemporanea al suoThe Age of Extremes. Con quel lavoro, in italiano tradottoIl secolo breve, per la prima volta nella vita di studioso aveva finalmente scritto del comunismo: fino ad allora si era appositamente tenuto alla larga dal Novecento, diventando paradossalmente il grande storico dell'età della borghesia. Ma la sua utopia non la rinnegò mai. Fu l'orgoglio intellettuale a non permettergli abiure né allora né dopo: «Perché sono rimasto? Perché non volevo finire in compagnia di tutti quegli ex comunisti che erano diventati anticomunisti.
Per lealtà a una grande causa, a tutti coloro che per essa avevano sacrificato la propria vita, agli amici e compagni morti per quella causa, che hanno sofferto carcere e tortura, da parte dei regimi comunisti come di quelli capitalisti. Me ne pento? No. Non penso. So bene che la causa che ho abbracciato ha dimostrato di non funzionare. Forse non avrei dovuto sceglierla. Ma, d'altra parte, se gli uomini non nutrono un ideale di un mondo migliore, perdono qualcosa. Mi sembra che l'umanità non potrebbe funzionare senza le grandi speranze, le passioni assolute».
Rimase così uno storico comunista senza il comunismo. L'ultimo. Orgoglioso al limite della testardaggine, ma pronto a pagarne il prezzo. Una volta mi diede di sé, ridacchiando, una fulminante definizione che solo un inglese può apprezzare fino in fondo: «Io faccio parte della ristretta schiera dei comunisti Tory», che è un po' come dire in Italia «comunisti conservatori». Il suo quasi secolo di vita è stato molto lungo. Solo ora che se ne è andato si può davvero dire che il Novecento è finito.
Al tempo della rivoluzione
di Gianpasquale Santomassimo
All'età di 95 anni, scompare quello che è stato probabilmente il più grande storico marxista del Novecento, certamente il più popolare e noto al grande pubblico. Una popolarità, quella di Eric J.Hobsbawm, relativamente recente e legata in grandissima parte alla fortuna e alle controversie suscitate dal Secolo breve. Come ricordava nella sua autobiografia Anni interessanti, per la stampa inglese era stato a lungo soltanto «quello storico che è rimasto comunista e che ama il jazz».
Nato ad Alessandria d'Egitto nel 1917, dall'incontro fra una ebrea viennese e un ebreo polacco immigrato in Inghilterra e spedito in Egitto quale funzionario - e da questa origine familiare, possibile solo nel mondo degli imperi che andava declinando, trarrà l'incipit per il suo volume The Age Of Empires - seppe utilizzare tanto il lascito cosmopolita quanto quella «posizione leggermente angolata rispetto all'universo», di cui si era parlato a proposito del poeta greco Kavafis, nato nella stessa città. Il suo cognome era il risultato di una serie di travisamenti della burocrazia imperiale attorno all'originario Obstbaum, che il nonno ebanista polacco aveva portato con sé emigrando in Inghilterra.
Il suo rapporto con l'ebraismo, mai praticato religiosamente né riscoperto in età avanzata, come accadde a molti intellettuali, si limitò al rispetto del principio fortemente ribadito da sua madre: «Non fare mai qualcosa né dare l'impressione di far qualcosa che lasci pensare che ti vergogni di essere ebreo»; un precetto che dichiarò di aver sempre cercato di osservare «benché alla luce del comportamento del governo israeliano, la fatica di attenervisi sia a volte quasi intollerabile». Agli ebrei di San Nicandro Garganico è dedicato uno dei suoi ultimi scritti, molto bello, uscito sulla London Review of Books.
Ma era anche consapevole di essere un sopravvissuto della «civiltà ebraica delle classi medie dell'Europa centrale dopo la prima guerra mondiale». Tra Vienna e Berlino, dove visse da giovane, non c'era molta possibilità di scelta, in quella Europa: si poteva diventare o comunisti o sionisti, e il giovane Hobsbawm compi la scelta del comunismo a cui rimase fedele per tutta la vita.
Nell'ambiente di Cambridge, tra grandi storici come Dobb e Cole, maturò rapidamente un personale ventaglio di interessi, uno stile e una forma di marxismo che ne avrebbero contraddistinto l'opera, rendendola immediatamente riconoscibile.
Una visione globale
Chi leggeva negli anni Sessanta The Age Of Revolution, che diverrà il primo volume della grande quadrilogia sul mondo contemporaneo - non voluta né pensata tale all'origine - si rendeva conto subito di trovarsi di fronte a qualcosa di diverso rispetto a ciò che passava in genere per storiografia marxista. In quel libro, che rimane forse il più bello tra i suoi volumi d'insieme, non c'era il plumbeo economicismo di tante trattazioni, pur occupandosi in gran parte di economia, ma non solo: il mondo nuovo emergeva dall'intreccio di una «duplice rivoluzione», quella industriale che muoveva dall'Inghilterra e quella politica che dopo avere debuttato negli Stati Uniti trovava il suo pieno dispiegamento in Francia. Le due rivoluzioni confluivano e cambiavano tutto il mondo, non solo nel modo di produrre, ma in quello di pensare, di vivere, di sentire. Colpivano i capitoli sull'evoluzione della cultura, delle arti, delle scienze, della musica, che poi diverranno caratteristica abituale nella quadrilogia. Colpiva la dimensione internazionale della trattazione, in un libro dove c'era più Toissant Louverture che Danton o Saint-Just, dove si cercava di dar vita a una storia collettiva, basata sull'interdipendenza tra civiltà europea e atlantica e quelle degli altri continenti; effettivamente globale molto prima che qualcuno immaginasse un termine come «globalizzazione».
E in questo modo, soprattutto, si riscopriva il vero Marx del Manifesto, non un filosofo regressista che deprecava un indistinto «capitalismo», ma l'esaltatore della portata rivoluzionaria che l'industrializzazione capitalistica aveva portato nel mondo, e che rendeva possibile anche il suo superamento. A «questo» Marx Hobsbawm si richiamerà anche nelle sue ultime opere, e in particolare nel recentissimo Come cambiare il mondo. Perché riscoprire l'eredità del marxismo.
Colpiva la leggibilità dell'opera, che non derivava da un compromesso con il rigore e la completezza. Né poteva parlarsi di «divulgazione», ma di una nuova interpretazione e di una nuova sintesi, completa anche nel dettaglio ma senza inutili sfoggi di erudizione.
Hobsbawm era del resto uno dei pochi storici che si era posto realmente il compito di «tentare almeno di comunicare con i cittadini comuni», senza che ciò comportasse uno scarto stilistico tra produzione storica e contributi giornalistici. «Mi sembra - affermava in una intervista degli anni Settanta - che sia molto importante scrivere storia rivolta non soltanto all'accademia. Nell'arco della mia vita la tendenza dell'attività intellettuale è stata quella di concentrarsi in modo crescente nelle università e di farsi sempre più esoterica, tanto da consistere nel lavoro di professori che parlano per altri professori, ascoltati distrattamente da studenti che devono ripetere le loro idee per poter superare i programmi di esami fissati da professori. Questo restringe considerevolmente la disciplina intellettuale».
Tra ribelli e banditi
I soggetti privilegiati nella sua lunga ricerca saranno ribelli, rivoluzionari, anche banditi, nell'intreccio tra idee rivoluzionarie e forme primitive di rivolta, dai ribelli del Monte Amiata a quelli del latifondo siciliano. Gente non comune, come recita il titolo di una sua raccolta, ma anche common gentry. E, anche e soprattutto, operai e lavoratori. Anche qui si nota la concretezza dell'approccio di Hobsbawm alla storia sociale, che per lui deve essere pienamente storia della società, e non sociologia retrospettiva.
Respingeva come schematica l'idea di una classe operaia come «una sorta di sottosuolo passivo e qualunquista... o come un immenso ghetto comprendente gran parte della nazione, o al più come una forza capace di mobilitarsi solo in difesa di interessi economici più o meno corporativi».
Era storia anche di «mestieri» e della loro trasformazione, talvolta rapida, a volte lentissima nel tempo; ma era anche storia «culturale», a pieno titolo, evoluzione di forme di coscienza e consapevolezza. La diffusione delle idee di Marx e il loro acclimatamento nei vari ambiti nazionali, di cui aveva parlato in sintesi nella Storia del marxismo Einaudi, erano parte integrante di questa storia.
In quello che è il profilo più aggiornato ed esaustivo in lingua italiana, Aldo Agosti aggiunge che Hobsbawm «vede affermarsi soprattutto dopo il 1890 una forte coscienza di classe nelle aree urbane, non identificabile però semplicemente con quella delle avanguardie di attivisti e militanti socialisti. I caratteri fondamentali di questa emergente coscienza di classe sono un profondo senso della separatezza del lavoro manuale, un codice non formulato ma molto forte basato sulla solidarietà, la "lealtà", il mutuo aiuto e la cooperazione; e si accompagnano alla formazione di modelli di comportamento, di abitudini e di stili di vita sui quali Hobsbawm proietta rapidi ma efficaci squarci di luce: l'affermarsi del football come uno sport proletario di massa, lo sviluppo di un luogo di vacanza frequentato quasi esclusivamente dai lavoratori e dalle loro famiglie come Blackpool, la diffusione degli spacci di fish and chips, e persino l'adozione dell'"inconfondibile copricapo" del proletariato britannico, il berrettino reso poi celebre dalle vignette di Andy Capp degli anni '60» (Aldo Agosti: Il test di una vita: profilo di Eric Hobsbawm, Passato e presente, n. 82, 2011).
Un altro tema assolutamente originale introdotto da Hobsbawm sarà la demistificazione dei miti di fondazione delle nazioni moderne (le tradizioni inventate), che aprirà un filone di interessi e di ricerca tuttora non esaurito.
Abbiamo detto che fu si proclamò comunista per tutta la vita, e rimase anche dopo il 1956 nel piccolo partito comunista britannico: ma nel corso degli anni divenne in patria un consigliere ascoltato del Labour Party, fortemente critico tanto della rigidità «classista» dell'era di Kinnock, incapace di comprendere i mutamenti della società, quanto del New Labour di Tony Blair, null'altro che «un Tatcher con i pantaloni». Ma la svolta di Miliband è frutto anche in parte della sua critica, e di un rapporto personale e familiare (il padre fu valido storico e teorico marxista).
In realtà Hobsbawm dichiarò di essersi considerato a partire dal 1956 un «membro spirituale» del partito comunista italiano alle cui idee si sentiva particolarmente vicino. Le numerose pagine «italiane» testimoniano di un lungo rapporto che fu anche familiarità e condivisione di problematiche con una generazione di storici (Rosario Villari, Ernesto Ragionieri, Giuliano Procacci, Renato Zangheri) e anche di politici (Giorgio Napolitano, in modo particolare, che intervistò nel 1976, quando la breve fiammata dell'«eurocomunismo» aveva acceso interessi e speranze destinate a declinare).
C'è in rete una «videolettera» toccante registrata il 20 marzo 2007 in cui Hobsbawm si rivolge ad Antonio Gramsci, con gratitudine e ammirazione, che più di ogni altro documento attesta il legame «italiano», sentimentale e teorico, dello storico inglese verso una forma di comunismo che sentiva vicina alla sua sensibilità.
La frana dell'Occidente
La sua popolarità presso il grande pubblico, come abbiamo ricordato, derivò in gran parte dal Secolo breve, titolo italiano di The Age Of Extremes, volume che brevemente e forse un po' bruscamente concludeva il ciclo del «Lungo Ottocento» che era stato oggetto dei volumi di sintesi che lo avevano preceduto. È la sua opera più discussa, e forse la più discutibile, per tanti motivi. Di fatto, Hobsbawm passerà gli ultimi anni della sua vita a discutere, limare, correggere quelle interpretazioni, alla luce dei nuovi avvenimenti che cambiavano il quadro del mondo descritto nell'ultimo capitolo: la Frana, che seguiva improvvisamente all'Età dell'Oro dell'Occidente. Ora la frana si è approfondita, rischia di travolgere tutto, e l'Occidente che si sentiva trionfante nell'Ottantanove appare sempre più in declino. Il secolo americano, che Hobsbawm aveva visto nascere, sembra avviato a chiudersi al momento della sua scomparsa, come aveva previsto a conclusione della sua autobiografia dieci anni fa.
In quella che è una delle sue ultime interviste, nel maggio 2012, l'interlocutore gli chiedeva: Cosa rimane di Marx? Lei, in tutta questa conversazione non ha mai parlato né di socialismo né di comunismo... E Hobsbawm rispondeva: «Il fatto è che neanche Marx ha parlato molto né di socialismo né di comunismo, ma neanche di capitalismo. Scriveva della società borghese. Rimane la visione, la sua analisi della società. Resta la comprensione del fatto che il capitalismo opera generando le crisi. E poi, Marx ha fatto alcune previsioni giuste a medio termine. La principale: che i lavoratori devono organizzarsi in quanto partito di classe».
Quanto alla sinistra attuale, il giudizio era molto esplicito:
«Non ha più niente da dire, non ha un programma da proporre. Quel che ne rimane rappresenta gli interessi della classe media istruita, e non sono certo centrali nella società».
EUROPA
L'evaporazione della democrazia
di Gianni Ferrara
Per essere un veterano della critica all'Europa dei Trattati e dei mercati spero che l'intervento di Habermas, Bofinger e Nida-Ruemelin (la Repubblica del 4 agosto) così come la presa di posizione di Balibar (su questo giornale del 20 settembre) assieme alla crisi di rigetto che si estende nella varie nazioni del Continente ridestino la coscienza europea dal sonno delle ragioni della democrazia.
Quelle ragioni che il neoliberismo dei Trattati ha sottratto ai popoli europei istituzionalizzando della democrazia una autentica mistificazione, quella dell'Ue. La cui legittimazione sarebbe derivata dalla democraticità degli stati di appartenenza. Come se la rappresentanza politica dei Parlamenti di questi stati potesse essere trasferita ai rispettivi governi, usati come tramite per una successiva investitura di rappresentatività operata a favore delle istituzioni intergovernative dell'Unione. L'evaporazione della rappresentanza parlamentare si sarebbe poi estesa oltre le istituzioni intergovernative (Consiglio, Consiglio dei capi di stato e di governo).
Perché tali istituzioni, come del resto lo stesso Parlamento europeo, pur se rappresentativo di tutti i popoli dell'Unione, sono a potestà dimezzata. Possono esercitare le rispettive funzioni soltanto per deliberare su proposte di una diversa istituzione, la Commissione europea, disegnata in modo da farla risultare svincolata dagli stati, dai governi, dai parlamenti nazionali e da quello europeo e finalizzata a «promuovere l'interesse generale dell'Unione» (art. 17, Tue). Interesse che fu identificato nella realizzazione di una «... economia di mercato aperta ed in libera concorrenza» (art. 119 del Tfue). Che la rappresentanza acquisita all'origine dai parlamenti nazionali, una volta ridotto quello europeo ad esecutivo dei trattati, possa librarsi nei cieli d'Europa per poi poggiarsi sulla Commissione di Bruxelles e pervaderla col flusso della legittimazione offertale dalla base sociale dei singoli stati è credenza risibile, affermazione mendace, teorizzazione infondata. Con conseguenze tragiche, quelle della crisi che stiamo vivendo.
Che si tratti del fallimento del neoliberismo con l'autoregolazione dei mercati, suo immediato corollario, non possono esserci dubbi. Tanto più che, via via che l'andamento del sistema costruito su quei principi smentiva una ad una le promesse declamate, si è fatto ricorso a misure che, mirando a conservarlo, lo contraddicono radicalmente trasfigurandolo in neoliberismo coatto. Non potevano che essere altrettanto catastrofiche le conseguenze sul tipo di edificazione scelto per fornire a questa Europa le istituzioni necessarie a farla nascere e ad integrarne la configurazione.
Perciò se ne vanno proponendo nuove architetture istituzionali. Ma da sedicenti costituenti quali Bce, Commissione europea, Consiglio europeo. Quindi da soggetti di legittimazione democratica nulla. Ma il problema si pone e drammaticamente. Non credo però che l'enorme ed esaltante questione dell'unità europea si possa affrontare senza ripudi irreversibili e senza assumere come compito inderogabile la costruzione di quella che Balibar chiama democrazia sostanziale. Non credo che lo si possa senza sbarrare gli effetti della rivoluzione passiva che il capitalismo ha condotto contro lo stato sociale e le conquiste di civiltà arrise al movimento operaio e democratico nel secondo dopoguerra. Non credo che lo si possa senza partire dal fattore originario della crisi mondiale - l'abbandono negli anni 70 del sistema dei cambi fissi - senza cioè riconoscere che la liberalizzazione dei capitali dagli stati comportò e comporta la liberazione dei capitali dalla democrazia negli stati, per quanto in essi si fosse realizzata o si potesse sviluppare. L'Unione europea, per il suo principio fondante e il corollario dell'autoregolazione del mercato, è stata ed è la specificazione europea della sottrazione del mercato alla democrazia, e, più ancora, cancellazione della politica, contraffazione e asservimento del diritto a funzione servente dell'economia liberista.
So bene che queste mie convinzioni mi pongono in posizione opposta a quella di Habermas quanto a concezione del mercato (v. la Repubblica del 23 settembre). Credo che possano però convergere sulla necessità di una unità europea legittimamente fondata, da qui la proposta di «un legislatore eletto da tutti i cittadini europei che possa decidere sulla base di interessi generalizzati a livello europeo». Riemerge però il mio dissenso ed ha ad oggetto il ruolo di tale legislatore. Attiene al diverso grado di legislazione che si pensa debba essere esercitata. Habermas la concepisce come interna o almeno compatibile con l'ordinamento vigente, con lo spirito e la logica dei Trattati. Il legislatore sarebbe compartecipe (la Repubblica, cit.) del Consiglio europeo. La mia opinione invece è che, perché eletto da tutti i cittadini europei, non possa che essere titolare di potere costituente. Uso questa qualificazione per una ragione che credo evidente. Il superamento di questa Europa fallimentare implica il superamento delle sovranità nazionali dimezzate dai Trattati ma ancora vincolanti o anche solo condizionanti. A simboleggiarle ma soprattutto ad esercitare, congiuntamente, poteri derivanti dalle sovranità nazionali è proprio il Consiglio europeo. Confermarlo in tale ruolo incrementandogli i poteri con l'aggiunta di quelli di grado costituente contraddice proprio tale grado di regolazione che si pone come necessaria e che è quella costituente.
Ma c'è un motivo in più a favore della discontinuità con la storia dell'integrazione europea finora perseguita. Gli stati, non solo europei in verità, sono responsabili di un'abdicazione concertata insieme per delegare al mercato la regolazione del mercato. Una delega senza limiti, senza criteri direttivi che, quindi ha privilegiato tra masse di esseri umani e contro masse di esseri umani, gli attori del mercato, quello finanziario e non solo. Questi attori si sono rivelati per quelli che erano e non potevano che essere: responsabili dello spostamento più consistente della ricchezza prodotta dai salari ai profitti e della più estesa e massiccia compressione dei bisogni delle donne e degli uomini. Hanno, questi stati, tradito la loro stessa storia, la più recente, quella che li vide accogliere le domande della democrazia di assumere la qualificazione "sociale" rendendola credibile col riconoscimento del principio dell'eguaglianza sostanziale e quello dei diritti sociali. Questi stati a fronte del fallimento del neoliberismo non reagiscono, non revocano l'abdicazione compiuta a favore del mercato autoregolato, non provano a riacquisire ed esercitare i poteri per i quali emersero nella storia e pretesero di legittimarsi, i poteri di garantire la sicurezza di vita dei sottoposti - a questo stadio di regressione si è giunti - sicurezza abbandonata alla devastazione neoliberista.
Perciò questi stati, non possono essere soggetti costituenti della democrazia sostanziale (Balibar) da costruire in Europa assumendo come suo compito l'eguaglianza sostanziale e a suo fondamento i diritti sociali con tutti gli altri che il costituzionalismo ha definito, munendoli di garanzie inderogabili. Certo, attuando il principio no taxation without representation. A condizione che sia una rappresentanza autentica, non distorta, non limitata, controllabile. Perciò aggiungendo: no representation without participation. Ma che sia una partecipazione credibile, cioè regolata, non disponibile per oligarchie irresponsabili. Una democrazia che sia insieme rappresentativa e partecipata. Con la disponibilità per il demos di ambedue le forme di esercizio del potere, distinte solo quanto alla adeguatezza di una delle due alle deliberazioni da compiere. Una democrazia che apra orizzonti alla prospettiva del libero sviluppo di ciascuno come condizione del libero sviluppo di tutti. Un compito enorme ma ineludibile.
Post scriptum. Con tutto quello che comporta di analisi, di riflessione, di approfondimenti, di elaborazione, di invenzione la democrazia sostanziale non potrebbe essere adottata come ragion d'essere di questo giornale? Da qualche parte bisognerebbe pure ricominciare.
CON uno zelo tanto impareggiabile quanto prevedibile è cominciata nella Chiesa l’operazione anestesia verso il cardinal Carlo Maria Martini, lo stesso trattamento ricevuto da credenti scomodi come Mazzolari, Milani, Balducci, Turoldo, depotenziati della loro carica profetica e presentati oggi quasi come innocui chierichetti.
A partire dall’omelia di Scola per il funerale, sulla stampa cattolica ufficiale si sono susseguiti una serie di interventi la cui unica finalità è stata svigorire il contenuto destabilizzante delle analisi martiniane per il sistema di potere della Chiesa attuale. Si badi bene: non per la Chiesa (che anzi nella sua essenza evangelica ne avrebbe solo da guadagnare), ma per il suo sistema di potere e la conseguente mentalità cortigiana. Mi riferisco alla situazione descritta così dallo stesso Martini durante un corso di esercizi spirituali nella casa dei gesuiti di Galloro nel 2008: “Certe cose non si dicono perché si sa che bloccano la carriera. Questo è un male gravissimo della Chiesa, soprattutto in quella ordinata secondo gerarchie, perché ci impedisce di dire la verità. Si cerca di dire ciò che piace ai superiori, si cerca di agire secondo quello che si immagina sia il loro desiderio, facendo così un grande disservizio al papa stesso”. E ancora: “Purtroppo ci sono preti che si propongono di diventare vescovi e ci riescono. Ci sono vescovi che non parlano perché sanno che non saranno promossi a sede maggiore. Alcuni che non parlano per non bloccare la propria candidatura al cardinalato. Dobbiamo chiedere a Dio il dono della libertà. Siamo richiamati a essere trasparenti, a dire la verità. Ci vuole grande grazia. Ma chi ne esce è libero”.
Quello che è rilevante in queste parole non è tanto la denuncia del carrierismo, compiuta spesso anche da Ratzinger sia da cardinale che da Papa, quanto piuttosto la terapia proposta, cioè la libertà di parola, l’essere trasparenti, il dire la verità, l’esercizio della coscienza personale, il pensare e l’agire come “cristiani adulti” (per riprendere la nota espressione di Romano Prodi alla vigilia del referendum sui temi bioetici del 2005 costatagli il favore dell’episcopato e pesanti conseguenze per il suo governo). È precisamente questo invito alla libertà della mente ad aver fatto di Martini una voce fuori dal coro nell’ordinato gregge dell’episcopato italiano e a inquietare ancora oggi il potere ecclesiastico. Diceva nelleConversazioni notturne a Gerusalemme:
“Mi angustiano le persone che non pensano, che sono in balìa degli eventi. Vorrei individui pensanti. Questo è l’importante. Soltanto allora si porrà la questione se siano credenti o non credenti”. Ecco il metodo-Martini: la libertà di pensiero, ancora prima dell’adesione alla fede. Certo, si tratta di una libertà mai fine a se stessa e sempre tesa all’onesta ricerca del bene e della giustizia (perché, continuava Martini, “la giustizia è l’attributo fondamentale di Dio”), ma a questa adesione al bene e alla giustizia si giunge solo mediante il faticoso esercizio della libertà personale. È questo il metodo che ha affascinato la coscienza laica di ogni essere pensante (credente o non credente che sia) e che invece ha inquietato e inquieta il potere, in particolare un potere come quello ecclesiastico basato nei secoli sull’obbedienza acritica al principio di autorità. Ed è proprio per questo che gli intellettuali a esso organici stanno tentando di annacquare il metodo-Martini.
Per rendersene conto basta leggere le argomentazioni del direttore diCiviltà Cattolicasecondo cui “chiudere Martini nella categoria liberale significa uccidere la portata del suo messaggio”, e ancor più l’articolo suAvveniredi Francesco D’Agostino che presenta una pericolosa distinzione tra la bioetica di Martini definita “pastorale” (in quanto tiene conto delle situazioni concrete delle persone) e la bioetica ufficiale della Chiesa definita teorico-dottrinale e quindi a suo avviso per forza “fredda, dura, severa, tagliente” (volendo addolcire la pillola, l’autore aggiunge in parentesi “fortunatamente non sempre”, ma non si rende conto che peggiora le cose perché l’equivalente di “non sempre” è “il più delle volte”). Ora se c’è una cosa per la quale Gesù pagò con la vita è proprio l’aver lottato contro una legge “fredda, dura, severa, tagliente” in favore di un orizzonte di incondizionata accoglienza per ogni essere umano nella concreta situazione in cui si trova.
Martini ha praticato e insegnato lo stesso, cercando di essere sempre fedele alla novità evangelica, per esempio quando nel gennaio 2006 a ridosso del caso Welby (al quale un mese prima erano stati negati i funerali religiosi in nome di una legge “fredda, dura, severa, tagliente”) scrisse che “non può essere trascurata la volontà del malato, in quanto a lui compete – anche dal punto di vista giuridico, salvo eccezioni ben definite – di valutare se le cure che gli vengono proposte sono effettivamente proporzionate”. Questa centralità della coscienza personale è il principio cardine dell’unica bioetica coerente con la novità evangelica, mai “fredda, dura, severa, tagliente”, ma sempre scrupolosamente attenta al bene concreto delle persone concrete.
Martini lo ribadisce anche nell’ultima intervista, ovviamente sminuita da Andrea Tornielli sullaStampain quanto “concessa da un uomo stanco, affaticato e alla fine dei suoi giorni”, ma in realtà decisiva per l’importanza dell’interlocutore, il gesuita austriaco Georg Sporschill, il coautore diConversazioni notturne a Gerusalemme.
Ecco le parole di Martini: “Né il clero né il Diritto ecclesiale possono sostituirsi all’interiorità dell’uomo. Tutte le regole esterne, le leggi, i dogmi ci sono dati per chiarire la voce interna e per il discernimento degli spiriti”. È questo il metodo-Martini, è questo l’insegnamento del Vaticano II (vediGaudium et spes16-17), è questo il nucleo del Vangelo cristiano, ed è paradossale pensare a quante critiche Martini abbia dovuto sostenere nella Chiesa di oggi per affermarlo e a come in essa si lavori sistematicamenteper offuscarlo.
Comincia oggi una serie di pagine dedicate a figure o a opere che hanno avuto un ruolo importante - a volte evidente, a volte più sotterraneo - nella formazione culturale delle diverse generazioni novecentesche e che oggi appaiono marginali: dimenticate o al contrario museificate e prive, all'apparenza, di ogni vitalità. Obiettivo della serie è dunque il tentativo di verificare se e quanto questi personaggi, questi testi, hanno da dire a chi vi si era accostato trenta o quarant'anni fa e, più ancora. a chi non li ha conosciuti. Buona lettura!
Io non sono uno studioso del pensiero di Manlio Rossi-Doria. Chi vuole approfondire l'argomento può leggere almeno uno dei suoi libri o una sua biografia scritta da Simone Misiani e pubblicata recentemente dall'editore Rubettino. S'intitola semplicemente , sottotitolo Un riformatore del novecento.
Non ho alcun titolo per scrivere di lui. Posso vantare solo una contiguità toponomastica. Ho scritto un libro intitolato Terracarne. Ho fatto un film intitolato Terramossa. Organizzo una serie di eventi culturali intitolati Terrascritta. Allora il mio è un contributo inattendibile. Non parlerò dello studioso ma della cosa studiata. Parlerò della terra.
Il mezzogiorno nudo. Rossi-Doria ha studiato e frequentato i luoghi dove vivo. Il suo primo discorso parlamentare fu tutto centrato su una diagnosi dei problemi dell'Alta Irpinia, quella che lui chiamava Terra dell'osso e io adesso chiamo Irpinia d'Oriente.
L'ho visto alcune volte all'osteria di mio padre. Arrivato a tarda sera dopo qualche comizio in zona. Mi piaceva quando arrivava gente che si metteva a parlare di politica. Mi sedevo su una sedia e ascoltavo. Lui veniva coi socialisti della zona. Non mi ricordo una sua frase, non mi ricordo la sua voce. Molti anni dopo, quando ho cominciato le mie scarne letture politiche, ho sentito parlare di terra dell'osso, la famosa formulazione concepita per le nostre zone, contrapposte a quelle costiere definite della polpa. L'ho sentita dire tante volte e mi sono messa a dirla pure io. Forse però andrebbe rimessa in circolazione una sua distinzione pronunciata in un convegno del 1944 tra Mezzogiorno nudo e Mezzogiorno alberato. Una distinzione che a me interessa anche in termini estetici: penso al fatto che il Mezzogiorno nudo somiglia non poco al west che gli americani tanto hanno celebrato nei loro film e che noi poco abbiamo immortalato nei nostri.
Rossi-Doria e Scotellaro. Mi fa sempre impressione leggere che il poeta lucano morì improvvisamente a trent'anni. Morì per un infarto mentre era a Portici, dove lavorava su invito del professore. Io ho pensato tante volte che mi stava venendo un infarto. Rossi-Doria mi ha portato a Scotellaro e dunque alla paura dell'infarto. La poesia, la terra, l'infarto. Questo è il triangolo. Tre lati, tre brani di lettere che il professore scrive al poeta.
Ricominciare cento volte
“A ben guardare nella disperazione dei nostri contadini - che io ho veduto anche di recente in Calabria - non so se è maggiore la rabbia per chi ha pittato la luna o per chi ha sbarrato i portoni. Anche io sono come te: ho profonda fiducia d'un lavoro serio, animato dalla ribellione al conformismo del tempo. Ma, sai, una ribellione fredda; senza fumi, alimentata da un lavoro cocciuto e paziente che alla fine ce la deve fare a riuscire. È in questo senso che ho impostato tutta la mia vita. Dalla politica per ora mi sono ritirato e faccio la politica del mestiere: è uno sforzo lento e lungo.
Il fatto è, caro Rocco, che a vincere e cambiare questa dannata condizione umana dei contadini che ha millenni dietro di sé, occorre molto più che lo sforzo di pochi anni o pochi miliardi. E quando si chiude una fase e tutto tende a ritornare come prima, bisogna avere il coraggio di ricominciare anche dieci, anche cento volte.
È ben vero che il lavoro non si può e non si deve fare al di fuori dei contadini ma coi contadini. E la vera maledizione di quella miserabile nostra riforma è che l'abbiamo voluta fare senza i contadini. Ma il lavoro non è principalmente di sovvertimento, ma di costruzione, di educazione, di selezione, di differenziazione, di creare individui e varietà, di individuare problemi e trovare ciascuno la sua diversa soluzione, di unir gli uomini, ma di lasciarli anche vivere ciascuno a suo modo. Solo l'intelligenza, la cultura, la libertà, la critica, oltre alla solidarietà e al rispetto del legame civile possono risolvere questi problemi.”
Quando lo sentivo nominare non sapevo che l'autore della terra dell'osso era romano. Non sapevo neppure che Pasquale Saraceno era della Valtellina e Danilo Dolci era triestino. Sapevo solo la cosa che sapevano tutti, che Carlo Levi era di Torino. E Carlo Levi nell' Orologio, così ritrae Rossi-Doria: «Stava a cavallo con un piede sulla politica pura e l' altro sulla pura tecnica, ma questa stessa incertezza gli chiariva le idee, gli impediva di fossilizzarsi in una abitudine mentale, lo conservava vivo e appassionato».
Al Palio del grano
“In questo momento a me una sola cosa importa: capir dentro a questo oscuro processo che vedo in atto nelle campagne. Per questo sono preso da una vera frenesia di girare, di vedere, di prender contatto con la terra. E non vedo l'ora di tornare giù nel Mezzogiorno, di girare paese per paese.” Con questo frammento da una lettera all'irpino Guido Dorso posso associare Rossi-Doria alla paesologia. Io gli somiglio nel mio girare paese per paese, purtroppo non ho la sua stessa veemenza nello studiare.
Consiglio di amministrazione dello Svimez, consigliere della Cassa di Mezzogiorno, senatore nel Partito Socialista italiano: la prova, rara, che si può rimanere onesti e occupare poltrone importanti.
Il centro di specializzazione ricerche economico-agrarie di Portici da solo valeva la nomina a ministro dell'agricoltura, che non è mai arrivata.
Ho pensato a Rossi Doria passando nei giorni scorsi a Caselle in Pittari, nel Cilento, dove sono andato a vedere il Palio del grano. Il palio si è svolto di domenica, preceduto da una settimana di alfabetizzazione rurale. Io sono arrivato il venerdì. Ho parlato in un piccolo anfiteatro fatto con le balle di fieno. Quando si arriva in un'esperienza che è già cominciata a volte si fatica a trovare il senso di quello che sta accadendo. È comunque stato bello vedere i computer appoggiati per terra. Sentire parlare ragazzi venuti da tutta Italia, da paesi e città, mi ha fatto pensare alla mia vecchia formula di coniugare il computer e il pero selvatico. Non so se in mezzo a loro c'è un altro Rossi-Doria. Magari qualcuno è venuto semplicemente per inquietudine o per trovare compagnie sessuali. Niente di male. Anzi, molto bene, se si considera quello che è accaduto la domenica. Io non ci credevo, pensavo che il palio del grano fosse una delle tante cose un po' finte che si fanno nelle estati paesane. E invece mi sono trovato dentro una festa contadina semplice e possente, un piccolo miracolo rurale. Volendo essere cattivi si può dire che i falciatori del grano divisi per paesi facevano pensare a una versione alla buona di giochi senza frontiere. E poi che senso ha mettere le persone a falciare il grano quando è una pratica che qui non farà mai più nessuno? E proprio qui la faccenda è curiosa: non ho sentito in alcun momento della giornata il soffio della paesanologia. Vedere un vecchio modo di mietere senza che si producesse un'aria nostalgica. L'aria non era quella di una sagra, l'aria era quella di una nuova alleanza tra i contadini (che ci sono ancora) e i ragazzi delle città e dei paesi, che cominciano a guardare alla campagna perché sentono che il modello capitalistico non promette più nulla di buono.
Rossi-Doria ha lavorato contromano, per tutti gli ultimi trent'anni della sua vita si è occupato di un mondo in fuga da se stesso, ha profuso ogni suo sforzo per frenare la rottamazione del mondo contadino. Adesso non è più così. A Caselle in Pittari, dentro il Cilento, io ho visto qualcosa di importante. Alla fine i giovani organizzatori hanno assegnato un piccolo pezzo di terra a ognuno dei ragazzi che ha partecipato al corso. So bene che tutte le persone, molte centinaia, che mangiavano strette strette sull'aia, in un meraviglioso affresco corale, adesso stanno nelle loro case, magari consegnate alla tristezza dell'autismo di massa, ma qualcosa è accaduto.
Quello che ho capito è che le persone quando stanno in una cerimonia che ha senso danno il meglio di loro stesse: l'ardore dei mietitori era commovente. Forse il disincanto e il cinismo di cui tanto parliamo sono solo un filo di polvere, sotto c'è ancora qualcosa che luccica. Bisogna aggiornare l'agenda del nostro nichilismo: forse siamo meglio di quello che pensiamo, alla fine siamo più vicini a Rossi-Doria che a Craxi. Sarebbe il caso che i terreni demaniali fossero affidati ai giovani, sarebbe il caso di aprire una grande stagione di ritorno alla terra.
Dopo il terremoto
Non sapevo che aveva subito prima l'arresto e poi il confino, a San Fele, non lontano dal mio paese. In galera divideva il tempo equamente tra studio ed esercizio fisico.
Rossi-Doria o Baudrillard? Non ho dubbi, scelgo il primo: cambiare la realtà, stando ben dentro nella realtà, identificare il centro della politica nei territori, immagino politiche diverse per diversi territori, importanza dello studio per pianificare interventi, esaltazione della democrazia vissuta in forma comunitaria.
A me colpisce la sua passione per il lavoro, la sua lontananza da un sud accidioso e amorale che si sceglie classi dirigenti altrettanto accidiose e amorali: Ho l'impressione che a lavorare veramente, oggi, in questa Italia liberata, non ci sia che la gente del mercato nero, le puttane e i contadini, oltre ai preti ed alla gente che ha da salvare le sue vecchie posizioni guadagnate negli anni addietro.
Nonostante le condizioni di salute precarie, nel 1980 si reca in Irpinia e Basilicata per elaborare un piano per la ricostruzione dei paesi colpiti dal terremoto. Non lo ascoltarono. I democristiani che comandavano a Roma comandavano anche nelle zone terremotate, non potevano lasciarsi sfuggire l'occasione di usare la catastrofe per rimpinguare le loro tasche e il loro consenso.
Lui parlava di politica del mestiere. Quelli che contestano i mestieranti della politica dovrebbero studiare il lavoro di un uomo come lui, il suo pragmatismo senza furbizie: “Continuo a lavorare nel Mezzogiorno, convinto come sono che l'unica cosa che conta è lavorare sodo attorno ai problemi concreti, riuscendo a realizzare di mano in mano quel poco che si può, cercando di accumulare esperienze e capacità effettive, per quanto dovesse servire e per quanto si potesse fare qualcosa di importante che cambi un poco seriamente la faccia di una realtà che dura sempre uguale a se stessa.”
Campagne spopolate
Voleva coniugare lo sviluppo economico con la coesione sociale, la salvaguardia delle risorse naturali con l'intensificazione produttivistica, l'infrastrutturazione con la difesa degli equilibri del territorio: e invece abbiamo avuto le acciaierie killer e lo spopolamento delle campagne. Non si può dire che non si è battuto per le sue idee e come spesso accade nella vita le idee migliori germogliano quando chi le ha prodotte non c'è più. Rossi-Doria è uno degli intellettuali del nostro futuro, altri li avvisteremo presto tra i ragazzi che mettono l'agricoltura al centro della loro vita e di quella del pianeta.
«I governi hanno fallito nel loro ruolo, la terra è l'unica salvezza, e va messa in mano a chi la coltiva. Invito i giovani a occupare la terra così come stanno occupando le piazze». Questo invito di Vandana Shiva è un seme gettato nel solco lungamente arato da Rossi-Doria. Forse oggi le sue analisi da economista agrario del novecento possono sembrare troppo condizionate dal tarlo dello sviluppo, ma i politici italiani, compresi i tecnici, molto avrebbero da imparare se trovassero il tempo di chinarsi nel suo solco.
Ieri il collettivo e i lettori del manifesto hanno perso un amico e compagno. Vittorio Tranquilli se n'è andato, aveva la rispettabile età di 87 anni e la carica e la passione di un ragazzino. Il giornale l'aveva incontrato che già sembrava un vecchietto simpatico e ti chiedevi dove trovasse la forza per attraversare tra le due e le quattro volte l'anno i Balcani con una vetturetta che ne aveva viste di tutti i colori. Come lui, del resto, come quando fuggiva rocambolescamente da Brindisi l'8 settembre del '43. Per sfotterlo gli davo del catto-comunista, un modo presuntuoso dei comunisti sedicenti doc di apostrofare i «comunisti cristiani», cioè chi ai miei occhi riusciva a tenere insieme due fedi. E qui sta l'errore, replicava, «io di fede ne ho una sola ed è quella su cui si radicano i valori che ispirano le mie scelte».
Era il '99, le "nostre bombe umanitarie" avevano raso al suolo, oltre a quel che restava, ormai poco, del sogno jugoslavo, anche la Zastava, la storica fabbrica di automobili di Kragujevac. Eravamo andati a raccontare quella storia sepolta sotto le macerie, dando voce a chi ci lavorava e aveva perso il presente e il futuro. Il manifesto lanciò l'idea di organizzare una rete di sostegno alle famiglie degli (ex) operai serbi, perché no, una campagna di adozione a distanza dei loro figli. Ne avevamo parlato con i dirigenti del sindacato dei metalmeccanici serbi che avevano accolto con entusiasmo la nostra proposta. Al nostro ritorno a Roma si presentò al giornale, in via Tomacelli, quel simpatico vecchietto e ci disse semplicemente: «Io ho una piccola ong, Abc solidarietà e pace, che si occupa di adozioni a distanza in Serbia, in Bosnia, in Africa e in America latina. Sono a disposizione».
Non un soldo raccolto tra le centinaia di lettori che aderirono all'iniziativa finirono a finanziare la struttura, non una lira a intermediari: Vittorio partiva con l'interprete - un'operaia serba che lavorava alla Fiat di Cassino - e consegnava a mano ai genitori di tutti i bambini adottati il gruzzoletto. Poi rientrava e metteva tutto in rete, conti, foto, letterine dei bambini ai genitori adottivi e un rapporto sulle condizione disperate in cui arrancava la società serba dopo le distruzioni, non solo materiali, di una guerra sciagurata. Non chiedeva a quella povera gente se stesse con Milosevic o contro, perché «bisogna aiutare chi ne ha bisogno, non chi la pensa come te».
Questa era la filosofia di Vittorio, che fino all'ultimo istante ha radunato intorno a se compagne e compagni per discutere, ma soprattutto costruire un'altra sinistra, perché la sinistra che aveva in mente lui non era fatta di parole ma di piccole azioni e, soprattutto, di coerenza tra idee e comportamenti. Della cultura comunista e di quella cristiana aveva preso il meglio. Ciao Vittorio, ciao compagno catto-comunista.
Ho conosciuto Vittorio molti anni fa, in un altro collettivo. Abbiamo lavorato insieme nelle riviste Il dibattito politico e, più tardi, La Rivista trimestrale , nel gruppo di persone - provenienti da molte storie e diversi mestieri - del quale Franco Rodano era il maestro. Nel gruppo Vittorio si occupava delle questioni che richiedevano di spaziare più alto e più lontano. Ma sapevo che Vittorio (come l’ariostesco ippogrifo, che “Volando, talor s'alza nelle stelle, così quasi talor la terra rade”).aveva saputo intrecciare stagioni e momenti di duro lavoro politico (dalla Resistenza alle lotte bracciantili nel Teramano) con la riflessione sui massimi sistemi di idee che reggono le azioni degli uomini, da Tommaso d’Aquino a Giuseppe Stalin: Sarebbe bello se qualcuno scrivesse la storia della sua vita e della sua ricerca. Magari qualcuno dei giovani che con lui facevano ( e continueranno a fare Il picchio a sinistra, il successore del sito martel.it katciu-martel, “ ticchettio di spunti per ricominciare a pensare”, che era stato il luogo del nostro ritrovarsi dopo tanti anni. Scoprì allora che la fedeltà agli interessi, alle passioni e ai patrimoni che avevamo condiviso si erano sviluppati lungo le stesse direttrici. Avevamo entrambi scoperto che il mondo è molto più grande di quello che avevamo conosciuto e in molte altre regioni si soffriva per le stesse storture che avevamo imparato a conoscere e a combattere. Se avessi avuto la fortuna di rivederlo oltre che dell’assenza di una sinistra capace di affrontare i problemi di oggi guardando al di là, avremmo parlato dell’Africa e dei molteplici Sud del mondo, e magari mi sarei associato alla sua ABC onlus
Titolo originale: Ray Bradbury brought literary respect to science fiction – Scelto e tradotto da Fabrizio Bottini
"Avevano una casa a colonne di cristallo sul pianeta Marte ai margini di un mare vuoto…"
Saggio, sferzante, meraviglioso, così Ray Bradbury iniziava uno dei primi capitolo del suo Cronache Marziane, opera sulla paranoia da era spaziale, meraviglia lirica che negli anni ’50 rese finalmente rispettabile la fantascienza.
La scomparsa di Bradbury a 91anni è stata annunciata oggi dalla figlia a Los Angeles: uno scrittore americano nella scia della tradizione da Edgar Allan Poe a Hawthorne a Hemingway. Al tempo stesso pacato poeta e riluttante profeta, dagli scritti di Bradbury emerge uno stile che è una cascata di immagini e fondamentali verità: il potere nemico della creatività ( ), la paura dell’oscurità ( Paese d’ottobre), i robot non sono sempre nostri amici ( Il corpo elettrico), le cose più spaventose possono essere pagliacci, fiere, giochi ( Qualcosa di sinistro sta per accadere).
Nel 1956, il famoso regista John Huston chiese a Bradbury un adattamento cinematografico di Moby Dick. Alla domanda del giovane e poco pratico Bradbury, “Perché io? Dopo tutto scrivo quasi solo su riviste popolari”. E Huston rispose, “È per via di quella sua storia sul dinosauro e il faro, credo do averci annusato il fantasma di Melville”.
Diffidava della tecnologia — era famoso per non guidare e non salire sugli aerei — ma dotato di un “ottimismo guercio” Bradbury credeva nel futuro, anche se i suoi marziani complottavano di nascosto, e i pompieri fascisti di incendiavano istericamente tutti i libri e i personaggi che ci stavano dentro. “Fahrenheit 451 non l’ho scritto per prevedere il futuro – dichiarò una volta – ma per prevenirlo”. Incanutito, impacciato dopo un ictus nel 1999 e cieco da un occhio, Bradbury ha trascorso i suoi ultimi giorni nella casa a Cheviot Hills, Los Angeles, un paio di chilometri scarsi dagli studi 20th Century Fox. “Stava quasi sempre a letto” racconta Terry Pace, 49 anni, amico e collaboratore che ha passato una settimana con Bradbury in aprile. “Ma era sempre lo stesso dodicenne. Pieno di voglia di vivere, sempre interessato al futuro anche ripercorrendo il passato. In qualche modo sapeva che grazie alla sua opera avrebbe vissuto per sempre”.
Per una intervista al periodico Monsters from the Vault, Bradbury ha raccontato a Pace l’influenza dei film muti di Lon Chaney e dell’horror sulla sua scrittura. E nel corso della visita insieme ai bambini di Pace storpiava le canzoncine di Cantando sotto la Pioggia. “In quegli ultimi tempi la vita gli ripassava davanti” ricorda Pace. Davanti a un vecchio film di Chaney a un’edizione rara dell’Uomo che faceva miracoli, storia non molto nota di Wells, Bradbury poteva scoppiare in lacrime: “Grazie per avermi restituito il mio passato”. Secondo Pace Bradbury “valutava il suo lavoro. Magari prendeva un suo libro dallo scaffale, e chiedeva di leggerne un brano a caso. Piangeva come un bambino: ma chi l’ha scritto? Ottimo, davvero un buon lavoro!”
Nato a Waukegan, Illinois, le sue storie sono impregnate di cultura popolare del Midwest, pubblicate prima su rivistine economiche come Super Space Stories o Thrilling Wonder Stories, ma presto si impongono al pubblico nazionale sulle pagine più prestigiose di Colliers, The Saturday Evening Post e The New Yorker (c’è un suo racconto anche sull’ultimo numero). Il suo punto di forza non sono tanto le idee — qui dopo tutto la concorrenza è numerosa e agguerrita, da Arthur C. Clarke, a Isaac Asimov a Robert Heinlein che percorrono le medesime rotte della fantascienza — ma la qualità della scrittura, che colpisce la sensibilità letteraria.
“Mi pare di sentire ancora i brividi di quella giostra misteriosa e raggelante … Era la qualità della scrittura, fantastica ma al tempo stesso realistica: il mio genere preferito di fantastico” ricorda la scrittrice Erin Morgenstern, che confessa quanto il suo grande successo del 2011,The Night Circus, sia influenzato dall’incontro quando aveva undici anni con Qualcosa di sinistro sta per accadere scritto da Bradbury nel 1962. Lo spirito infantile di Bradbury era equilibrato da una certa scontrosità culturale, specie nei confronti della tecnologia. “Ci sono troppi telefoni cellulari” disse in occasione dell’uscita del primo e-book delle sue storie. “Tutti su internet. Bisogna sbarazzarsi di quelle macchine. Adesso ce ne sono troppe”.
Quando gli scienziati annunciarono di ver trovato prove della possibile esistenza della vita in forma microscopica su Marte nel 1996, Bradbury se ne fece beffe in una intervista sul nostro giornale, era così convinto che si sbagliassero da rifiutare di comparire alla trasmissione Nightline del canale ABC quella sera, nonostante avessero già mandato l’auto a prenderlo. Il più elegante sognatore della fantascienza era politicamente conservatore, al punto da essere turbato quando Michael Moore intitolò il suo lavoro anti-Bush Fahrenheit 9/11. In una introduzione alla raccolta di racconti Shadow Show, tributi all’opera di Bradbury, che uscirà a breve, l’ex first lady ed ex bibliotecaria Laura Bush chiama Bradbury “amico” aggiungendo che “Ray è un eroe delle biblioteche, nonché uno dei più inventivi scrittori di storie d’America”.
Come accade a gran parte degli autori di fantascienza, anche le previsioni di Bradbury non si sono avverate. Ma c’è un racconto del 1951,The Pedestrian, che riecheggia tristemente qualcosa nel nostro mondo post-11 settembre. È sera e un uomo cammina da solo nel suo quartiere. Viene fermato dalla polizia, e quando non riesce a spiegare perché esattamente stava camminando — “tanto per camminare” non basta ai poliziotti — viene portato al Centro Psichiatrico di Ricerche sulle Tendenze Regressive. La storia si conclude: “L’auto ripartì lungo le vie vuote come il letto di un fiume in secca, allontanandosi dal marciapiede vuoto, e non restò nessun suono, nessun movimento, in quella fredda sera di novembre”
Leggere di Federico Caffè è sempre una grande emozione. In queste recenti festività, approfittando della calma, ho piacevolmente letto alcuni profondi scritti di Bruno Amoroso e Daniele Archibugi amici e allievi del Maestro. Sono scritti che letti a pochi giorni da quel fatidico 15 aprile assumono ancora un significato più intimo e riflessivo. Le righe di Amoroso e Archibugi raccontano benissimo chi era Caffè quale fosse il suo rapporto con i suoi amati studenti e quale fosse la sua delusione per l’Italia “che non era più il Paese che sognava” per dirla con una bella frase recente di Carlo Azeglio Ciampi.
Ma perché questo “piccolo uomo” dalla statura intellettuale gigante fa ancora parlare di se? Perché chi lo ha amato e conosciuto (nel mio caso attraverso le sue parole scritte) lo cerca continuamente come bussola in tempi in cui il disorientamento è totale? Caffè non sopportava la decadenza dei suoi tempi e non riusciva a far finta di non vedere. E allora ha compiuto con estrema naturalezza il gesto più umano che un professore deve avere: dare importanza a ciascuno dei suoi allievi e prenderne tutte le risorse nuove attingendo per osmosi l’entusiasmo che allunga la vita. Ricorda Michelangelo Salinetti, un altro suo allievo, «che era l’unico professore che metteva il banchetto fuori dell’Istituto per aiutare gli studenti a comporre il Piano degli Studi. Stava in mezzo a noi e non in una torre d’avorio. Sempre a disposizione dei suoi allievi con consigli e qualche volta rimbrotti. Proverbiali sono stati i suoi sbalzi di umore». E aggiunge Salinetti «insegnava un metodo, deduttivo ed induttivo insieme, come richiede la Politica Economica. Ti insegnava ad esplicitare il tuo “giudizio di valore». Accettava tutte le opinioni, come del resto tutte le scuole di pensiero economiche. Diceva Caffè : “ogni scuola rappresenta un mattone nella costruzione dell’economia e della Politica economica».
Ecco perché uno degli episodi più dolorosi nel percorso terreno del Maestro è stato quando, raggiunti i limiti di età, dovette lasciare l’insegnamento. Perché egli aveva ancora tanto da dire e da dare. Era un grande economista, un grande formatore e un vero riformista. E lo dimostra il fatto che ancora oggi si ricerca e se ne parla, in tempi di crisi finanziaria, ma anche e soprattutto di valori primordiali con il primato delle tensioni sociali sul necessario welfare state che non sarebbe utopico in un Paese illuminato.
Ma nel mezzo dell’aprile 1987 evidentemente la sua depressione lo portò a scomparire alle luci dell’alba. Una scomparsa degna di un grande film d’autore. Nessun elemento che potesse ricondurlo a lui. Un’uscita di scena silenziosa e fragorosa. Un vuoto improvviso e insieme clamoroso. Un dolore immenso del fratello Alfonso, dolore che si è propagato anche ai suoi allievi e che si è trasformato in bisogno di sapere e di conoscere la verità. E di cercarlo. Sempre. E non solo immediatamente dopo la sua scomparsa. Forse, Caffè ha voluto essere discreto anche in questo. Non ha probabilmente voluto mostrarsi ai riflettori e come sempre ha voluto essere e non apparire. Questa è stata la sua forza. La concretezza e la sostanzialità. Gli studi, le affermazioni che non rimangono lettera morta o confinate in una mente ingenerosa; ma invece pragmatismo e poco formalismo e tutto in nome di quel sogno dell’economia di benessere tutta rivolta alla collettività. L’economia al servizio della persona. E la persona al centro, sempre al centro con convinta umanità e capacità di trasmetterla alle generazioni future. Per Caffè il concetto di efficienza non può essere disgiunto da quello di equità. Gli obiettivi di maggiore efficienza e di maggiore equità sono inseparabili.
Scrive Caffè nel saggio In difesa del welfare state: «una efficienza priva di ideali ci riporta al clima intellettuale che ha consentito di designare l’economia come una scienza crudele». L’economia a servizio dell’uomo e a sostegno dei più deboli è la concezione portante del pensiero di Caffè che si riassume e sintetizza nel concetto di “cristianesimo laico”. In questo termine c’è tutto il pensiero e lo stile di vita del Prof. Caffè. Ecco perché le sue parole hanno da sempre assunto tutto un altro valore. Sono parole profetiche, lungimiranti e lucide. La specialità del Maestro era tutta nella sua normalità, una semplicità che lo ha reso unico e inimitabile. Un modello al quale fare riferimento specialmente nei momenti più bui. In realtà, più della scomparsa, occorre oggi parlare della sua presenza. Ed è il modo per farlo vivere e per farlo ancora parlare con il suo linguaggio schietto e diretto tipico di un vero Maestro autentico e prezioso. Per lui sembrano valere queste parole di Italo Calvino tratte dal libro Se una notte di inverno un viaggiatore, soprattutto nell’avvicinarsi del 15 aprile «Ci sono giorni in cui ogni cosa che vedo mi sembra carica di significati: messaggi che mi sarebbe difficile comunicare ad altri, definire, tradurre in parole... Sono annunci o presagi che riguardano me e il mondo insieme: e di me non gli avvenimenti esteriori dell'esistenza ma ciò che accade dentro, nel fondo; e del mondo non qualche fatto particolare ma il modo d'essere generale di tutto».
Federico Caffè non ha mai smesso di volare alto continuando il suo “ viaggio” carico ancora di significati per essere sempre presente anche nell’assenza.
L’articolo, inviato dall’autore che ringraziamo, è pubblicato nel sito della Fondazione Critica Liberale
Nella notte del 15 aprile 1987 il grande economista scomparve nel nulla Si pensò al suicidio, a un incidente oppure a una fuga perfetta per lasciarsi ogni cosa alle spalle. In quei giorni quasi tutti i suoi allievi intrapresero una grande ricerca, perlustrarono tutta Roma e non scartarono nessuna ipotesi Dopo venticinque anni, il racconto di uno di loro
Fu n mercoledì mattina Federico Caffè scomparve di casa con la discrezione che lo aveva accompagnato per tutta la vita. Saranno state le sette quando mi arrivò la telefonata di suo fratello minore Alfonso, anche lui celibe e professore, con cui conviveva. Mi disse «Vinicio (così lo chiamavano in famiglia) è scappato di casa». Ci misi pochi minuti a raggiungere la loro casa di via Cadlolo, dove trovai i suoi nipoti e Nicola Acocella, uno dei suoi allievi che più si era preso cura di lui nelle ultime settimane. Non sapevamo che cosa attenderci: la sua fuga sarebbe stata di breve durata come quella di un adolescente o avrebbe preso una piega ben più tragica?
La domenica prima ero andato a trovarlo a casa. Da tre mesi, Caffè era stato preso da una profonda crisi depressiva e non andava più, come aveva sempre fatto, tutti i giorni in facoltà. Negli anni in cui frequentai l´Università, dal 1976 al 1982, è stato l´amico più vicino, nonostante fossi quasi mezzo secolo più giovane. Come altri affezionati allievi che avevano saputo della sua depressione, cercavo di aiutarlo passando qualche ora nel suo studiolo. La mia amicizia con Caffè è iniziata ben prima che nascessi: mio padre era il suo migliore e forse unico amico, e lui fu il testimone di nozze dei miei genitori. Era un uomo assai riservato e sin da bambino ho pensato che fosse la sua statura - era alto un metro e mezzo - a renderlo così schivo. Celibe, era generosissimo con i figli dei suoi amici: solo pochi mesi fa sono venuto a sapere che gli stessi giocattoli che ci faceva pervenire negli anni Sessanta giungevano anche ai figlioli del suo amico Paolo Sylos Labini e chissà a quanti altri.
Unico tra i miei fratelli, mi iscrissi a economia e commercio, la facoltà nella quale lui passava dodici ore al giorno. Scoprii in quel frangente che l´uomo riservatissimo che avevo conosciuto si trasformava dietro la cattedra e tramite l´eloquio, sempre sostenuto da un sano pragmatismo di mai ripudiata marca abbruzzese, riusciva a persuadere e, soprattutto, ad accendere la curiosità. Mi accorsi presto che ero stato arruolato nella confraternita dei suoi allievi che, senza bisogno di riti iniziatici, si ispirava ai valori coltivati dal Maestro: rigore e sobrietà. Per sopraggiunti limiti di età, Caffè aveva da pochi mesi smesso di insegnare, riportandone un tracollo emotivo. Il circolo di persone che gli era più vicino ne era rimasto sorpreso: come era possibile che lui, l´uomo che aveva sempre sostenuto tutto e tutti, avesse ora bisogno di sostegno? Aveva retto in piedi un´intera facoltà, reclutato i più promettenti insegnanti e contribuito al dibattito politico. Con discrezione, ma anche con passione civica, aveva sempre usato gli strumenti dell´economia per difendere i più deboli. Aveva tempo per tutti e per tutto, e a nessuno aveva negato il suo sostegno e conforto. Eppure, ora, si dimostrava incapace di abbandonarsi alle persone che gli volevano bene.
Da quel mercoledì iniziarono giorni terribili: non volevamo dare la notizia in pasto alla stampa nel timore che, se fosse stato travolto dal clamore dei media, avrebbe potuto compiere atti inconsulti che speravamo fosse ancora possibile scongiurare. Telefonammo ai molti suoi amici sparsi per Roma e per il mondo, nella speranza che si fosse rifugiato a casa di uno loro. Cercammo di immaginare quali potevano essere state le sue mosse e trovammo un interlocutore di rara sensibilità umana nel capo della squadra mobile di Roma, Nicola Cavaliere. Se stava vagando per la città in stato confusionale, aveva bisogno di essere aiutato.
Iniziammo a cercarlo sulle pendici della collina di Monte Mario, dove abitava, e nelle zone limitrofe. Ci fu chi perlustrò gli argini del Tevere, chi cercò nei dintorni della nuova facoltà di via Castro Laurenziano e della vecchia sede di Piazza Fontanella Borghese. Inseguimmo falsi indizi, come quello di un gioielliere che riteneva di averlo visto seduto sui gradini di una stazione della metropolitana. Negli stessi giorni, un altro anziano si buttò nel Tevere da Ponte Marconi ma ben presto, visti gli ingrandimenti delle foto scattate da un passante, escludemmo che si potesse trattare di lui. Bussammo alle porte dei conventi e chiedemmo aiuto al Vaticano. Armati di penna e taccuino, parlavamo con le persone che conosceva ricercando qualche indizio e raccomandando mille volte di mantenere la riservatezza.
Per cinque lunghissimi giorni non abbiamo dato la notizia all´opinione pubblica, per paura che la vita di un uomo sensibile e straordinario come Caffè potesse essere insudiciata. Tramite Marco Ruffolo, uno dei suoi amati allievi, chiedemmo a Eugenio Scalfari di pubblicare su Repubblica un annuncio criptico dettato dal fratello: «Vinicio, torna a casa, sto male. A.». In queste poche parole c´è forse il dramma estremo con cui Federico aveva costruito la sua esistenza: anche nel momento tragico in cui stava probabilmente pensando di porre fine alla propria vita, chi gli era più vicino sperava di convincerlo a cambiare idea richiamandolo ai suoi doveri verso gli altri piuttosto che a quelli verso se stesso. Del resto, era lui che da sempre aveva avuto tanta facilità a dare quanto difficoltà a ricevere.
Portai la notizia all´Ansa una domenica pomeriggio. Fui bombardato di domande e ognuna di esse mi parve una violenza esercitata nei confronti del mio professore. Ci trovavamo in una situazione contraddittoria: da una parte, il clamore suscitato dalla sua scomparsa aumentava la possibilità che fosse rintracciato, dall´altra temevamo la passione per il giallo scandalistico dei mass media. Così nessuno di noi parlò della sua crisi depressiva e per anni e anni siamo stati reticenti nel descrivere lo stato in cui si trovava negli ultimi mesi. La scomparsa del piccolo grande economista non doveva inficiare l´aura che si era meritato con un´esistenza esemplare.
Dopo un quarto di secolo, possiamo solo constatare che, qualsiasi sia stato il destino del nostro maestro, è stato quello che lui si è scelto. La sua vicenda non sarebbe ancora un mistero se nelle ore successive alla sua scomparsa non avesse dimostrato di avere le doti professionali di un agente segreto assai più che quelle di un austero docente. Anche la sua ultima pagina l´ha scritta senza farsi aiutare da nessuno.
Quando la notizia divenne di pubblico dominio, giunsero numerosissimi allievi per aiutarci nelle ricerche. Spesso non ci conoscevamo, ma bastava uno sguardo per capire che appartenevamo alla medesima confraternita. Agli studenti degli ultimi anni si accompagnavano quelli dei decenni anteriori, e ognuno di loro chiedeva che cosa potesse fare di utile. Non era facile trovare una risposta perché neppure la polizia aveva fornito una casistica. Nell´organizzare le squadre che battevano la città palmo a palmo, chiedevo spesso qualche informazione sugli anni in cui lo avevano frequentato all´università. Mi sentivo ripetere sempre la stessa frase: «È stato il periodo più bello della mia vita». Ma lui, Federico Caffè, lo avrà mai saputo?
 «». il manifesto, 13 ottobre 2016 (c.m.c.)
«». il manifesto, 13 ottobre 2016 (c.m.c.)