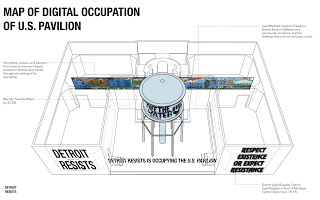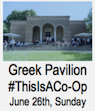Sul "fronte" dell'esposizione si è avuta la conferma del pauroso distacco degli intellettuali dalla realtà. Se il mondo va a rotoli è colpa anche, e in gran parte, del tradimento di quanti sarebbero deputati ad additare le vie per uscire dalla crisi: a raccontare la realtà quale è, a svelare le cause di ciò che è storto, e a proporre i modi per raddrizzarlo. Ma invece di svelare la realtà e raccontare "di che lagrime grondi e di che sangue", troppo spesso si impegnano e celebrare se stessi, e le proprie personali affermazioni (e.s.)
Durante la cerimonia conclusiva della quindicesima Biennaledi architettura, il presidente Paolo Baratta ha esibito i numeri checertificano il successo dell’operazione: oltre 258 mila visitatori e 135accordi con università che da tutto il mondo mandano gruppi di studenti inlicenza a Venezia e, come premio, erogano loro dei crediti di formazione. Nessunragguaglio è stato fornito circa i risultati qualitativi raggiunti in sei mesidi apertura al pubblico. Nessun cenno, inoltre, è stato fatto, né da Baratta nédal direttore Alejandro Aravena, ai casi nei quali gli obiettivi dichiarati sirivelano in stridente contrasto con la situazione sul campo, come dimostrano, perlimitarci a tre esempi, il padiglione della Germania, il progetto speciale un mondo di fragili parti e la scuola diMakoko la cui replica è stata esposta all’Arsenale.
1. Making Heimat, iltitolo del padiglione della Germania, sintetizza l’aspirazione di trasformarele città tedesche da luoghi di segregazione a spazi di assorbimento eintegrazione dei nuovi arrivati. La decisione dei curatori di individuare il “fronte”nel modo di accogliere le migliaia di persone sradicate dalla loro terra e costrettea migrare è stata sviluppata con intelligenza, a cominciare dalla scelta dioccuparsi di città e non solo di edifici per mettere in luce che la sfida politica/progettualeè “cambiare la città per tutti” e non costruire cittadelle per rinchiudere chiarriva.
Succede, però, che mentre visitiamo il padiglione e ammiriamole gigantografie che spiegano le caratteristiche di Arrival City, al fronte si continua a combattere e non tutto va nelmigliore dei modi. Pochi giorni prima della chiusura della Biennale, infatti, èapparsa la notizia che a Monaco di Baviera è stato costruito un muro perseparare gli abitanti del quartiere di Neuperlach Sud da un ostello chedovrebbe ospitare 160 rifugiati, quasi tutti minori non accompagnati.
La vicenda ha avuto inizio nel 2014, quando sei persone residentivicino al futuro ostello hanno protestato per i “fastidi” che la struttura avrebbepotuto arrecare loro e, di fronte al rifiuto delle autorità comunali dicancellare il progetto, hanno intentato e vinto un’azione legale al terminedella quale la città ha dovuto costruire una barriera alta quattro metri emezzo. Non contenti, i residenti hanno anche preteso che il manufatto fosse “insormontabilee resistente ai giochi con qualsiasi tipo di pallone”. La soluzionearchitettonica, quindi, è un muro come quelli che si usano per mitigare l’inquinamentoacustico proveniente dalle autostrade, formato da gabbie di acciaio piene disassi.
“Donald Trump, vuole costruire un muro per separare la nazionedal Messico e noi non possiamo costruirne uno per tenerci al sicuro dairifugiati?,” ha detto uno dei cittadini di Neuperlach che ha poi aggiunto: ”nonabbiamo nulla contro l’ostello per rifugiati, la città in qualche modo deveriuscire a sistemare tutte le persone. Ma 160 ragazzi giovani faranno del rumoreconsiderevole e noi vogliamo continuare a vivere in pace. Mi sarei lamentato,anche se si fosse trattato della costruzione di nuovi campi sportivi”.
Altri abitanti di Neuperlach hanno dichiarato che, inrealtà, la principale preoccupazione è che il valore delle case possa crollarea causa della presenza del centro. Comunque, il muro è stato costruito e non èescluso che, essendo più alto di quello di Berlino, possa diventare “un’attrazione” e, una volta ricoperto diedera e rampicanti, meriti di essere esposto alla prossima Biennale.
Ovviamente, i curatori del padiglione non hanno responsabilitàper l’accaduto. Forse, però, tenuto conto che in guerra la propaganda èimportante, ma alla fine quello che conta sono le conquiste sul terreno, riservareun angolo alle “cattive notizie” nulla avrebbe tolto all’efficacia didattica eall’ottimismo propositivo della loro installazione.
2. Un ben più grave livello di scollamento tra dichiarazioni diprincipio e realtà si riscontra all’interno del progetto speciale realizzatodal Victoria and Albert Museum di Londra, con il quale la Biennale ha siglatoun accordo per l’allestimento di una sezione/padiglione dedicata alle artiapplicate. Il tema di quest’anno, unmondo di fragili parti, intende affrontare la questione della “copia” d’artenon solo come strumento didattico, ma come modo per “preservare” opere che per varieragioni, “dai cambiamenti climatici alle guerre”, sono a rischio di distruzione.Anche a prescindere dai risvolti inquietanti di tale approccio (significa forseche una volta fatta la copia di un’opera d’arte possiamo bombardare l’originalee gli umani che le stanno vicini?) uno dei manufatti esposti è unaagghiacciante dimostrazione del cinismo con il quale istituzioni, che sidefiniscono culturali, si impadroniscono, per trasformarli in merce, dei drammie delle sofferenze delle persone reali.
Si tratta del calco in scala 1:1 di una baracca dellacosiddetta giungla di Calais, che è stata scansionata in 3D e riprodotta in verolith,un materiale a base di perlite. Almomento della scansione, era il ricovero di legno, plastica e lamiera di DarAbu Said, un profugo dal Sudan che da quattro mesi vi abitava insieme a quattroegiziani. Tutti loro speravano di poter arrivare a Londra.
Secondo Sam Jacob, l’artista che ha ideato e realizzato ilcalco, l’installazione ha raggiunto due risultati. Da un lato, “portando lacrisi umanitaria e politica che colpisce il Medio oriente e l’Europa dentro la Biennale,ha aumentato la consapevolezza della crisi dei rifugiati”, dall’altro “usandomoderni strumenti digitali di salvaguardia e riproduzione, contribuisce aldibattito sulla riproduzione come forma di salvaguardia”.
Come è noto, prima della chiusura della Biennale,la giungla di Calais è stata rasa al suolo. Said non abita più lì e nullasappiamo di lui e dei suoi quattro coinquilini. Non risulta che il Victoria andAlbert Museum si sia attivato per procurare loro un permesso di soggiorno a Londrao che Sam Jacob abbia loro ceduto i diritti di autore per le foto dell’installazioneche “ha trasformato un alloggio di fortuna in una scultura monumentale”.
Nemmeno nella conferenza nel corso della quale ilcuratore del progetto Brendan Cormier, e Baratta hanno tracciato ilglorioso bilancio della collaborazione tra le due istituzioni e annunciatol’intenzione di proseguirla, è stato nominato Said, il cui ricordo si perderàfra i molti missing in action / dispersi in guerra. Ma, per nostra fortuna, ciresta il calco che porta il suo nome e che ormai ha lo status di opera d’arte.
3. Infine, la scuola diMakoko, un edificio di legnogalleggiante nella laguna di Lagos, le cui immagini sono riprodotte nelle piùprestigiose riviste di architettura del mondo, è l’emblema perfetto di unaBiennale i cui inviati speciali sembra siano stati dislocati ovunque, tranneche al fronte.
Il progettista, Kunlé Adeyemi, un architetto nigeriano chevive e lavora in Olanda, è stato insignito del Leone d’argento della Biennale che ha fatto arrivare viaacqua una copia in scala ridotta della struttura per ormeggiarla nel bacinodell’Arsenale.
In luglio, la scuola (quella vera, a Lagos) è statadistrutta dalle piogge torrenziali, in uno dei tanti disastri naturali cheflagellano gli insediamenti dei poveri. La stampa internazionale ha dato granderisalto al crollo, nonché al fatto che lacomunità aveva ripetutamente espresso preoccupazioni per la tenuta degliormeggi e da tempo, non potendo affrontare la situazione con le proprie scarserisorse, non mandava i bambini a scuola, temendo per la loro sicurezza.

Solo la Biennale non si è accorta di niente. Il 24 settembrel’architetto Adeyemi ha partecipato ad uno degli “incontri del sabato”, nelcorso dei quali alcuni degli invitati parlano al pubblico del loro lavoro. Ilcoordinatore della cerimonia, Pippo Ciorra, che scrive di architettura su giornali“di sinistra”, si è profuso in elogi e complimenti per la genialità dellatecnica costruttiva, ma del collassodella scuola nessuno ha detto niente. Se è chiaro che in ogniguerra, soprattutto se umanitaria, alcuni dispacci dal fronte non vengonodivulgati per non minare il morale delle truppe, nel caso di Makoko dire laverità non sarebbe stato una manifestazione di disfattismo. Al contrario,chiedersi se il denaro speso perinstallare la replica nelle acque dell’Arsenale, al fine di promuovere l’immagine del progettista e delladitta costruttrice, avrebbe potuto essere impegnato per la manutenzione e ilconsolidamento della scuola, ci avrebbe aiutato a non distogliere l’attenzione dalla comunità dellalaguna di Makoko e dar voce al suo diritto a riavere la scuola per la qualeloro ed i loro bambini si sono già lasciati fotografare.
Il silenzio della Biennale, invece, è una drammatica conferma dell’abisso che separai discorsi sulle opere di architettura, che riempiono riviste che mai gliutilizzatori di tale opere leggeranno, e il mondo reale. Un ben modestorisultato per gli organizzatori che hanno scelto come logo “la vecchia signorache in cima sulla scala guarda avanti a sé”. Forse la vecchia signora (e noicon lei) farebbe bene a girarsi eguardare indietro, in basso, a terra.
eddyburg dalla Biennale di Architettura di Venezia. L'attenzione è rivolta ai padiglioni di Stati Uniti e Portogallo. Il tema è la mistificazione: da messaggio culturale a messaggio pubblicitario.
Nelle fiere commerciali, l’allestimento dei singoli padiglioni ha come obiettivo la diffusione di un messaggio pubblicitario che, magnificando le virtù delle ditte espositrici, aumenti l’appetibilità sul mercato dei loro prodotti. La propaganda è una componente essenziale di tali eventi, ma i visitatori, nonché potenziali acquirenti, ne sono consapevoli.
Meno agevole è individuare il messaggio veicolato dalle esposizioni che si autodefiniscono culturali e hanno come “missione” dichiarata la promozione di conoscenza. Nel caso della Biennale, inoltre, bisogna distinguere fra la sezione curata dal direttore ed i padiglioni nazionali che, essendo di esclusiva competenza dei rispettivi stati, variamente interpretano il tema generale, con il risultato che, accanto a resoconti più o meno accurati e alle legittime soggettive interpretazioni, non mancano le manipolazioni di fatti e vicende storiche. Quest’anno, i due padiglioni dove la distorsione od omissione delle informazioni è più palese sono quelli degli Stati Uniti e del Portogallo, entrambi dedicati a progetti e interventi di “rigenerazione” urbana.

“The architectural imagination” è il titolo del padiglione statunitense. Le curatrici, scelte dal Dipartimento di Stato, hanno incaricato dodici grandi studi di elaborare proposte per “rigenerare quattro aree derelitte di Detroit, parlando con le comunità locali”, e preparare programmi per il futuro della città che “riflettano quello che hanno imparato dai cittadini”. Tale approccio ha suscitato critiche e contestazioni. In particolare “Detroit resists”, un gruppo di attivisti, artisti, architetti, cittadini che lavorano per una città “inclusiva, giusta e democratica”, sostiene che “il padiglione sia strutturalmente inadeguato ad affrontare la catastrofe di Detroit e collabori alla distruzione in corso della città”.
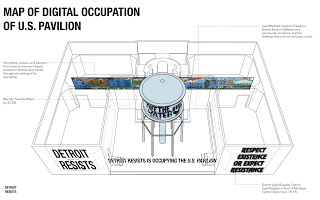
Usando il termine “speculazione” nella duplice accezione di esplorazione teorica e di vantaggioso investimento immobiliare, Detroit resists intende mettere in luce il legame tra “le stravaganti immagini e la violenza dell’urbanistica dell’austerità che ha prodotto spostamenti forzati di abitanti e espropri, ed ora usa il campo urbano che essa stessa ha creato come sito per speculare sull’immaginazione”. Per questo, il giorno dell’inaugurazione della Biennale, Detroit resists ha organizzato una “occupazione virtuale” del padiglione, sovrapponendo a quelle ufficiali altre immagini, fra le quali spiccano la torre dell’acqua, simbolo dell’iniquità degli sgomberi delle abitazioni e della sospensione della fornitura alle famiglie che non possono più sostenerne il costo, e l’ammonimento “respect existence or expect resistance”.
La stampa italiana ha molto elogiato il padiglione e ignorato le proteste. L’approccio “partecipatorio” è stato particolarmente apprezzato dal Manifesto, un cui collaboratore, Pippo Ciorra, è membro della giuria della Biennale di quest’anno. Scrive, ad esempio, Emanuele Piccardo (28 maggio 2016) «il padiglione risponde in modo visionario al fronte contemporaneo della progettualità… pone la questione del riuso delle aree industriali attraverso lo sguardo visionario e formalista dei dodici architetti invitati …. che hanno lavorato con le comunità locali e con le organizzazioni non profit».
Il Portogallo non possiede un proprio padiglione all’interno dei recinti della Biennale e ogni edizione affitta degli spazi in città. La sede di quest’anno è il piano terreno di un edificio progettato da Alvaro Siza in Campo di Marte alla Giudecca.
Campo di Marte era un complesso di edilizia popolare costruito tra il 1920 ed il 1921 “in posizione saluberrima vicino al margine lagunare” dove, per mezzo secolo, hanno abitato famiglie di lavoratori a basso reddito, finché, all’inizio degli anni ’80, il comune e l’istituto per le case popolari “nella necessità di adeguare il proprio patrimonio edilizio a Venezia al modello di vita attuale” hanno deciso di demolirlo. Nel 1983 è stato indetto un concorso internazionale per la ricostruzione, nel cui bando si raccomandava ai progettisti di ”fare evolvere la situazione urbanistica della zona… farla corrispondere alla dinamica sociale dell’area”.

Al vincitore Alvaro Siza vennero affiancati altri tre architetti fra cui Aldo Rossi, direttore della Biennale di Architettura del 1985 e del 1986. Trent’anni sono trascorsi, gli archi e colonne di Rossi sono stati completati, ma l’edificio di Siza non è finito e la parte costruita non sembra molto accogliente. All’interno degli alloggi si lamentano infiltrazioni e umidità, aggravata dal divieto di stendere biancheria all’esterno, probabilmente per non sciupare le fotografie delle riviste di architettura. Mentre il Comune e l’ATER, azienda territoriale per l’edilizia residenziale che ha sostituito l’Istituto per le case popolari, si rinfacciano le responsabilità del ritardo, l’auspicata evoluzione della zona è
puntualmente avvenuta; gli abitanti sono stati cacciati e la Giudecca è diventata terra di appetibili investimenti, che le agenzie immobiliari pubblicizzano come una sorta di Brooklyn da dove si vede Manhattan.
La mostra è un caso esemplare di come il rinnovo urbano/umano venga raccontato dal fronte dei vincitori. Ingannevole fin dal titolo, Campo di Marte 1983/2016, che fa iniziare la vicenda dalla data del concorso di architettura rimuovendo la storia precedente, l’esposizione si concentra nell’esaltazione dell’afflato partecipatorio del progettista, molte le immagini di Siza a cena con gli indigeni, e della sua “capacità di inserirsi nella lunga tradizione dell’edilizia popolare veneziana”.
Durante i sei mesi di apertura della Biennale i lavori sono stati ripresi e sul rivestimento delle impalcature giganteggia la scritta “Neighborhood, where Alvaro meets Aldo”, involontaria conferma dell’atteggiamento autoreferenziale di architetti che credono che i quartieri servano a chiacchierare fra di loro.
I curatori del padiglione hanno organizzato l’allestimento in collaborazione con l’Ater, e si dice si stiano adoperando per far raggiungere un accordo, i cui costi pubblici non sono chiari, tra le ditte e le istituzioni coinvolte per completare l’edificio, costruire la fontana e la piazza disegnate da Siza, nonché per creare nell’area un padiglione stabile per il Portogallo. “Ci voleva il Portogallo per finire un’opera incompiuta a Venezia”, è il commento compiaciuto del Corriere della Sera (22 maggio 2016), mentre la Biennale, sbarcando sul fronte della Giudecca, stabilisce un avamposto per la conquista di un altro pezzo di città .
Il Post online, 20 settembre 2016
Molto era lecito attendersi dalla Biennale di Architettura del cileno Alejandro Aravena, fresco
premio Pritzker e noto non già come ideatore di arditi grattacieli e costosissimi musei, bensì come attento rammendatore di periferie ed esperto di edilizia sociale, nonché inveterato fautore dell’idea di architettura come bene pubblico. Ed è un fatto che la mostra di quest’anno (a Venezia dal 28 maggio al 27 novembre) – che segue quella di Rem Koolhaas del 2014, più orientata sull’analisi degli elementi primari dell’architettura, dalle porte alle finestre ai muri (un analogo approccio, anche se in sedicesimo, era nella recente e godibile
Architecture as Art all’Hangar Bicocca di Milano) – segni una rottura rispetto alle tante edizioni in cui il concettualismo di cervellotiche fantasie metteva il visitatore dinanzi a opere di fatto indistinguibili dalle installazioni della
Biennale di arte contemporanea, o peggio a faraonici progetti che talora
coprivano indicibili affari. Più che porre interrogativi, come David Chipperfield nel suo
Common Ground del 2012, Aravena è tutto orientato sulle possibili soluzioni, che declina sulla falsariga di alcuni temi maggiori negli spazi dell’Arsenale e del Padiglione centrale ai Giardini.
Tra questi temi richiamo: l’impiego di materiali del luogo (il bambù in Messico e in Corea, il legno in Ecuador e Thailandia, il travertino in Cile…; per non parlare dell’architettura interamente “di riciclo” di Alexander Brodsky in Russia); il rispetto delle tradizioni costruttive locali (spiccano fra gli altri i casi di Fuyang in Cina e soprattutto le realizzazioni di Anupama Kundoo in India); il recupero e la rifunzionalizzazione di edifici abbandonati (Souto de Moura a Braga), ma anche di materiali di scarto (notevole il progetto di Hugon Kowalski per le discariche di Mumbai, ma già subito al principio il visitatore è accolto da un’ominosa stanza ingombrata dai montanti d’acciaio dismessi dalla Biennale d’Arte 2015); la centralità del progetto abitativo all’interno di una specifica comunità (dall’inurbamento dei pastori mongoli a Ulan Bator alle difficili periferie della Lisbona della crisi ridisegnate da Inês Lobo; ma interessante è anche il disegno di Alexander d’Hooghe per un mercato per gli immigrati a Bruxelles, e, in un altro contesto, le pratiche di confronto continuo con la comunità locale promosse dal Rural Studio in Alabama). Insomma, un trionfo di principi eticamente nobili, e un rigetto dell’architettura spettacolare e fine a se stessa (dall’Istituto Veneto, all’Accademia, occhieggia
par contre una
mostra dedicata alla compianta
Zaha Hadid).
Ora, non vi è dubbio che quanto si perde in spettacolarità in questa Biennale si guadagna invece nella pregnanza di molte delle soluzioni esposte, con alcune punte di assoluto interesse, come i diversi approcci al problema dei migranti (dai campi profughi del Sahara Occidentale alle soluzioni per i rifugiati in Germania proposte dallo Studio Bel di Berlino), le idee per agevolare l’accesso all’istruzione (le scuole “all’aperto” delle Ande e della foresta Amazzonica; la scuola galleggiante di Kunlé Adeyemi in Nigeria; i progetti di François Kéré in Burkina Faso o di Anna Heringer in Bangladesh; la rete di scuole di Luyanda Mpahlwa in Sudafrica), il fiorire di progetti cinesi volti a recuperare le tradizioni abitative indigene lungamente represse (per lo più a vantaggio dell’urbanizzazione forzata nei tristi palazzoni delle metropoli), o le mille sfide per il recupero del tessuto sociale e civile nelle città più problematiche del Sudamerica, dalle favelas di Asunción a quelle di Lima e Medellín. Non solo: colpisce vedere come diversi padiglioni nazionali si mantengano strettamente nel solco dei principi indicati dal curatore, a cominciare proprio da quello cinese (tutto dedicato alle pratiche abitative tradizionali, anziché – come accade di norma – ad avveniristiche proiezioni nel futuro), quello statunitense (che propone timidi tentativi di ricostruzione delle parti abbandonate di Detroit) e quello italiano (una selezione di 20 realizzazioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche in diversi luoghi della Penisola, tutte accomunate da un denominatore di aderenza all’ambiente e di uso comunitario); e in fondo anche Austria, Finlandia e Germania, con la loro viscerale e preoccupata attenzione al destino dei migranti, affrontano dinamiche urbane che hanno un risvolto socio-politico primario. Se meritano menzione, fra gli altri, anche lo studio della controversa storia di Manila nel padiglione filippino, e soprattutto la sofisticata e commovente riflessione sullo spazio abitativo dei malati di Alzheimer proposta dall’Irlanda, nulla però vale quanto il padiglione polacco, che per la prima volta dedica attenzione esclusiva ai volti e alle storie di chi materialmente costruisce gli edifici, dunque ai muratori, alle loro vite, alle loro condizioni di lavoro.
Ma proprio alla luce di questa lodevole novità di principio della Biennale di Aravena, non si può non segnalare da un lato qualche stonatura, dall’altro un’occasione perduta. Le stonature cadenzano il percorso espositivo in modo talora sorprendente, e a tratti rischiano di compromettere la credibilità del filo conduttore: cosa c’entra con il discorso qui perseguito la faraonica – e nemmeno recentissima – ristrutturazione dello spazio di Punta della Dogana ad opera di Tadao Ando per conto del magnate francese Pinault (si arriva perfino a proporre un’apologia delle colonne con cui l’archistar giapponese voleva immortalare all’esterno il proprio passaggio, e che un’avveduta mobilitazione popolare fortunatamente seppe sventare)? Era proprio necessario dedicare un’immensa sala agli esperimenti luministici di Jean Nouvel per il controverso Louvre di Abu Dhabi? E perché celebrare in questo contesto certi progetti di habitués della Biennale – le contorsioni di Herzog & de Meuron, gli instabili cubetti di Richard Rogers, le incerte pianificazioni di Kazuyo Seijima in Giappone, l’aeroporto per droni in Rwanda di Norman Foster, o il centro visitatori di un museo sudanese di David Chipperfield? In più d’un caso la spiegazione esiste: chi voglia avere una precisa visione delle dinamiche finanziarie e d’interesse che si muovono alle spalle di quanto ci viene proposto (a cominciare dal ruolo della Rolex e di Deutsche Bank, profumati sponsor delle ultime Biennali di Architettura), farà bene a leggere le analisi di Paola Somma sul sito eddyburg, che si pongono in feroce antitesi rispetto al “capitalismo compassionevole” di questo tipo di mostre, e ne mettono in dubbio alcuni assunti fondamentali (per es. l’ineluttabilità dell’inurbamento di enormi masse umane, o la credibilità dell’“imperialismo umanitario”); comunque la si pensi, si potrà per esempio prendere con maggior cautela la gragnuola di statistiche e di analisi offerte dal padiglione speciale Conflicts of an Urban Age, dedicato al tumultuoso sviluppo urbano di alcune delle più grandi metropoli del mondo, scelte e presentate secondo criteri forse non del tutto limpidi.
Infine, si può parlare di occasione perduta nella misura in cui le lunghe didascalie che accompagnano i progetti si intrattengono per lo più sempre sulle medesime questioni generali (non sono l’unico a sentire a tratti fastidio per una retorica pur teoricamente condivisibile), e raramente illustrano con chiarezza – al di là dei moventi ideologici – un fattore centrale, ovvero come le varie iniziative architettoniche e/o urbanistiche si siano concretamente sviluppate, quali soggetti pubblici e/o privati le abbiano promosse, ideate e finanziate, e quale sia o sia stata la ricaduta sulla società del luogo. È per esempio interessante contemplare un video sulla rinascita urbanistica e sociale di certi quartieri di Medellín e sulla creazione di uno spazio pubblico in loco, ma poi uno va alla Mostra del Cinema, vede Los nadie di Juan Sebastián Mesa (peraltro premiato nella Settimana Internazionale della Critica), e si domanda come stiano insieme le due cose. Tatiana Bilbao e altri lavorano sugli spazi vuoti di Città del Messico: ma qual è l’atteggiamento del potere (quello legittimo e quello de facto: si pensi alla Zona di Rodrigo Plá) dinanzi a simili iniziative? Lo stesso vale per es. per la riqualificazione di una pericolosa zona di Durban curata da Andrew Makin, o per le delicate esperienze di Al Borde in Ecuador. O ancora: in più d’un caso si mostrano i limiti dell’“edilizia sostenibile” intesa in senso ortodosso (la sua scarsa durevolezza, messa in luce dagli svizzeri Christ & Gantebein; la sua inerente fragilità, studiata da Michael Braungart), ma non ci si spinge a mettere in questione il concetto stesso e le più profonde implicazioni del suo sbandieramento.
Marginale, ma come sempre non del tutto assente, Venezia. Sull’importanza che le Biennali di Architettura hanno avuto per illustrare, legittimare e preparare l’assalto speculativo a Venezia, disponiamo ormai di una cronistoria precisa, ancora una volta a cura di Paola Somma (Mercanti in Fiera, Corte del Fóntego 2014). Quest’anno, se l’Istituto svedese propone la città lagunare come modello che va oltre la modernità (celebrando anzitutto il suo sapiente utilizzo del legno), d’altra parte i riflettori sono puntati su Marghera: “Up! Marghera on Stage” propone il Padiglione Venezia, sollecitando giovani architetti under35 a proporre soluzioni per il grande malato della Laguna, recentemente oggetto anche delle cure di Renzo Piano e del suo gruppo di giovani architetti. Un malato destinato – sotto gli auspici del primo sindaco di Venezia laureato in architettura – a risorgere come una “nuova Manhattan” sotto il peso di torri e grattacieli: in barba a tutti gli slogan caritatevoli.
.
Quest’anno, all’interno del recinto della Biennale, oltre ai padiglioni nazionali sono stati allestiti i padiglioni di due multinazionali: Rolex, sponsor dell’intera manifestazione, la cui filosofia è perfettamente riassunta nello slogan che campeggia su un manifesto pubblicitario “un Rolex non cambierà il mondo, lasciamo questo compito a chi ne indossa uno”, e Deutsche Bank, che ha finanziato l’allestimento della sezione “Conflicts of an Urban Age” e la relativa conferenza, svoltasi il 14 e il 15 luglio, entrambe curate dalla London School of Economics. Alla cerimonia di apertura dell’esposizione, il rappresentante di Rolex era sul palco accanto al presidente Paolo Baratta e al direttore Alejandro Aravena, mentre la conferenza Shaping Cities è stata inaugurata, oltre che da Baratta e da Ricky Burdett, professore alla LSE, da Paul Achleitner, presidente del consiglio di sorveglianza di Deutsche Bank.
In cambio della loro munificenza, ai due benefattori è riconosciuto un ruolo attivo e non solo una presenza simbolica. Se l’influenza di Rolex si manifesta soprattutto nella scelta di alcune archistar, gli invitati eccellenti la cui partecipazione è irrinunciabile per il “ritorno di immagine” che spetta allo sponsor, quella di Deutsche Bank è forse meno evidente, ma più pervasiva, e bene illustra il crescente potere delle istituzioni finanziarie di dettare (anche) l’agenda urbana e di cooptare università, liberi pensatori, amministratori locali al fine di renderne più facile l’attuazione.
La collaborazione tra London School of Economics e Deutsche Bank risale al 2004, quando Burdett chiese un finanziamento per organizzare una conferenza a Barcellona. Da allora il legame tra le due istituzioni si è sempre più consolidato e la banca, tramite la Alfred Herrhausen Gesellschaft, la fondazione culturale che porta il nome del suo direttore morto nel 1989, in un attentato le cui circostanze non sono mai state del tutto chiarite, ha fornito appoggio costante ai programmi di Burdett. In particolare sostiene il centro di ricerca LSE Cities, la cui “missione è studiare come le persone e le città interagiscono in un mondo che si urbanizza rapidamente” e ne finanzia le conferenze per divulgare “nuovi modi di pensare e costruire le città dove nel 2050 vivrà il 70% della popolazione mondiale”. Le conferenze, che ogni anno si tengono in una diversa città, hanno tutte il titolo Urban Age, una dizione che, evocando il sistema di periodizzazione pseudoscientifico, secondo il quale le “età” del genere umano si succedono l’una all’altra- età della pietra, del bronzo, del ferro- cerca di dare alla cosiddetta “età della città” un’aura di naturale inevitabilità.
Nel 2006 Burdett è stato nominato direttore della decima Biennale di Architettura, alla quale ha dato il titolo “Città. Architettura e Società” e vi ha esposto i risultati delle indagini di LSE Cities su sedici grandi agglomerati urbani. Ne è seguito un decennio di successi accademici e di fruttuosa collaborazione professionale con gli amministratori di molte importanti città. Ad esempio, è stato consulente del sindaco di Londra Boris Johnson e coordinatore della ristrutturazione urbana attuata in occasione delle Olimpiadi del 2012 ed è stato convocato dal sindaco Marino per organizzare Roma 2025.
Delle città prese in considerazione nel 2006, cinque compaiono anche nella mostra ospitata dalla Biennale di quest’anno: Mumbai, Città del Messico, San Paolo, Cairo e Istanbul. Fra le asiatiche, è scomparsa Tokio, sostituita da Shanghai, Guangzhou, Bangkok e Ho Chi Minh City e mancano tutte le città europee, con eccezione di Londra. In Africa, al posto di Johannesburg, ci sono ora Addis Abeba, Kinshasa e Lagos.
A parte “la velocità dell’urbanizzazione”, non sono espliciti i criteri con i quali le città, o per meglio dire le megalopoli, vengono selezionate. E’ certo, però, che in tutte esistono progetti per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali- metropolitane, tunnel, autostrade- ai quali Deutsche Bank partecipa.
Come ha detto Achleitner, che in passato ha lavorato per Goldman Sachs, Bayer, Henkel, Siemens e altri grandi gruppi finanziari, non solo la banca considera Urban Age un suo “flagship project” ma “l’urbanizzazione sostenibile” è una delle questioni cruciali verso le quali si concentra l’attenzione della fondazione Herrhausen, che rappresenta il “forum internazionale” all’interno del quale investigare e dibattere i temi più rilevanti a livello globale.
In realtà, alla conferenza della Biennale, tale auspicato dibattito non c’è stato. Studiosi di grande prestigio, da AbdouMaliq Simone a Saskia Sassen da Rahul Merhotra a Richard Sennett, hanno suggerito punti di vista problematici, altri oratori hanno perentoriamente richiesto “infrastrutture per la crescita” e ”spazio per l’espansione urbana”, altri infine hanno riduttivamente parlato dell’urbanizzazione come di un problema di design. Tra questi Burdett, che ha ripetutamente evocato il conflitto tra urbanistica “dal basso” e “dall’alto” in termini di tipi edilizi, di forma e dimensione dei lotti, di disegno di reti stradali e distributive e Joan Clos, direttore di UN Habitat, che nelle considerazioni conclusive della conferenza ha ricordato che la “politica dell’urbanizzazione spetta agli stati nazionali” e che le Nazioni Unite non possono imporla, ma solo aiutare a “pianificarla bene”. In altre parole UN Habitat può, come in effetti fa, insegnare agli urbanisti a “preparare” la terra da liberare e consegnare agli investitori, e incoraggiare le scuole di architettura ad addestrare generazioni di tecnici a “disegnare” questo esproprio su scala mondiale.
Nel suo discorso di commiato finale Ute Weiland, membro del consiglio di amministrazione della fondazione Herrhausen, con toni da perfetta padrona di casa ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dello splendido evento e ha preannunciato il prossimo che si svolgerà in Africa.
Del fronte africano, Deutsche Bank può vantare un’esperienza secolare. Ha, infatti, finanziato l’occupazione coloniale tedesca sia dell’Africa orientale, Rwanda, Burundi e Tanzania, che di quella sud occidentale, Namibia, anticipando i capitali per la costruzione di ferrovie e per le attività di estrazione mineraria. Le modalità di questi aiuti umanitari ante litteram, da tempo documentate da accurate ricerche storiche, sono state di recente anche oggetto di vertenze giudiziarie. Nel 2001, ad esempio, alcuni membri della tribu Herero hanno citato in giudizio il governo tedesco ed una serie di società, tra le quali Deutsche Bank, con l’accusa di genocidio in relazione alle attività minerarie svolte in Namibia all’inizio del novecento. L’azione è rimasta senza esito e, piuttosto che riconoscere qualsiasi responsabilità, il governo tedesco si è impegnato ad aumentare gli investimenti per la modernizzazione del paese. Uno degli argomenti usati per respingere le accuse è stato che i reati devono essere valutati in base al contesto in cui si sono verificati e che, siccome all’epoca dei fatti il termine genocidio neppure esisteva, di genocidio non si può parlare. Solo Il 14 luglio, lo stesso giorno della conferenza alla Biennale, il portavoce di Angela Merkel ha detto che il governo tedesco chiederà ufficialmente scusa alla Namibia. Si tratta ovviamente di una casuale coincidenza temporale, è comunque auspicabile che Deutsche Bank ne informi le truppe già dislocate sul fronte dell’occupazione neocoloniale.
Vorrei mettere in evidenza l’importanza del lavoro in rete tra Enti Pubblici specie riguardo a temi rispetto ai quali i comuni difficilmente dispongono di molte risorse: le poche che ci sono vanno quindi ottimizzate. In secondo luogo illustrerò brevemente le azioni messe in campo dal comune di Rivalta insieme ad altri comuni sul fronte dell’accoglienza e integrazione dei migranti.Infine vorrei sottolineare la necessità di rivedere il sistema complessivo italiano in merito all’accoglienza.
La Pace: dovere dell'amministrazione pubblica
Penso che il dovere dell’Amministrazione Pubblica sia di offrire ai propri cittadini occasioni di incontro e di approfondimento, perché una miglior conoscenza permette di vincere i timori di ciascuno. Stimolare i cittadini a un impegno concreto sul piano della solidarietà deve essere un dovere istituzionale e occuparsi istituzionalmente di pace significa che non si tratta di buone azioni dipendenti dal “buon cuore” di un Sindaco pro tempore, bensì di un piano di interventi coordinati e produttivi sia sul territorio del comune sia nelle realtà con cui si coopera. Insomma governare una città non significa occuparsi unicamente delle sue necessità immediate e materiali (luce, strade, servizi…) perché la città è un organismo vivo e complesso che deve avere relazioni altrettanto vive e complesse.
Siamo convinti che la pace non sia “solo” assenza di guerra ma che si basi su una distribuzione più equa delle risorse, che sia uno stile di vita, un modo collettivo di intendere le relazioni umane; già Capitini sostenne che le città possono e devono impegnarsi, nella certezza che ogni passo, anche il più modesto, costituisce un elemento importante per raggiungere l’obiettivo di un mondo più giusto e più bello.
Rivalta sta cercando di rendere concrete queste affermazioni in particolare sul piano dell’accoglienza dei migranti.
L’ importanza del lavoro in rete
Circa 20 anni fa Rivalta ha fondato con altri 15 comuni della provincia di Torino, il Coordinamento comuni per la pace (per brevità lo citiamo con l’acronimo Co.Co.Pa). Ora riunisce 30 comuni della provincia ed ha diverse collaborazioni con la Regione Piemonte ed è impegnato sui seguenti fronti:
- promozione cultura di pace
- proposte di percorsi di educazione alla pace
- progetti di cooperazione decentrata gestiti da reti tra comuni
- promozione della cultura della cooperazione
- valorizzazione del know how enti locali. in ambito di concertazione e di progettazione partecipata
Il cammino è ancora lungo:
- pochi enti locali hanno maturato il dovere istituzionale di cooperare, di accogliere, di integrare che nasce da una lettura attenta e lungimirante dei bisogni e delle realtà dei nostri territori
- occorre investire sulla formazione del personale politico e amministrativo
- occorre individuare con chiarezza gli obiettivi progettuali
- occorre crescere nella capacità di coprogettare con le organizzazioni non governative e le cooperative, uscendo dal ruolo riduttivo di enti finanziatori che delegano in toto progettazione e realizzazione
- è fondamentale il ruolo di indirizzo e controllo dei comuni nei confronti dei progetti di accoglienza
L’esperienza di Rivalta di Torino - Il progetto Sprar
Con altri 4 comuni, riuniti in un consorzio per i servizi socio assistenziali, Rivalta ha presentato un progetto Sprar (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), finalizzato all’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, che è stato approvato e verrà finanziato dal Ministero degli Interni.
Il progetto ha consentito di affidare, con un bando pubblico, a due cooperative la gestione delle problematiche dell’accoglienza, tra cui quella più delicata è l’individuazione di alloggi per i quali si stipuleranno regolari contratti di affitto, intestati alle cooperative, con i fondi assegnati dal Ministero degli Interni
I fondi del progetto sono poi destinati ad attività di apprendimento della lingua italiana e di inserimento nel tessuto sociale dei nostri territori, all’attivazione di borse lavoro, con l’obiettivo di accompagnare i rifugiati verso un’autonomia economica e sociale: in questo quadro sarà importantissimo l’apporto di volontari e associazioni che vogliano mettere a disposizione un po’ del loro tempo per aiutare il conseguimento di tale autonomia
Con questo progetto di accoglienza e integrazione, il nostro comune vuole continuare il percorso già avviato negli anni scorsi con i migranti dell’emergenza nord Africa che sono rimasti sul nostro territorio, con quelli accolti con un altro progetto Sprar in partenariato con il comune di Avigliana e con quelli affidati dalla Prefettura a una cooperativa con cui il comune, insieme alla Prefettura, ha firmato un protocollo di intesa per il volontariato di restituzione.
C
he cosa è il volontariato di restituzione
Nelle ultimi mesi i nostri cittadini hanno visto gruppi di africani lavorare con i nostri volontari civici per il decoro del nostro comune; altri ci aiutano nella distribuzione della posta interna al comune, altri sono entrati a far parte di un coro e del gruppo di danze popolari per condividere anche i momenti di piacere: è un modo per entrare a far parte della comunità apportando un contributo concreto e volontario in una cornice di pace e amicizia.
Criticità del sistema di accoglienza in Italia
L’Italia sta investendo risorse economiche ed umane a fronte degli arrivi e degli sbarchi utilizzando fondamentalmente:
- i centri di accoglienza (CIE: Centri d’identificazione ed espulsione [sic])
- lo smistamento tramite le Prefetture formando per lo più grandi gruppi affidati a cooperative che devono dimostrare di avere strutture e capacità di accoglienza ma che spesso, a causa degli alti numeri, si limitano al soddisfacimento dei bisogni primari e l’assistenza ai percorsi legali per la richiesta di asilo
- i progetti Spar. gestiti dal Ministero degli Interni che riguardano gruppi di minore dimensione e finalizzati all’integrazione.
Purtroppo il dialogo tra questi varie realtà è assai scarso, mentre sarebbe indispensabile avere un maggior raccordo tra la prima accoglienza di urgenza e i processi di effettiva integrazione che necessariamente possono avvenire solo operando su piccoli gruppi distribuiti nei numerosissimi comuni italiani
Il Co.Co.Pa ha tempo fa sottoscritto un appello per la chiusura dei CIE che ho fornito agli organizzatori.
Circa la connessione tra i percorsi delle Prefetture e il sistema Sprar è mia profonda convinzione che occorrerebbe dirottare verso di esso le persone inizialmente accolte con gli appalti delle prefetture, procedendo a un progressivo e continuo “assottigliamento” e ricambio dei grandi gruppi e consentendo,con le risorse dello Sprar un effettivo percorso di integrazione e conseguimento dell’autonomia grazie al raccordo tra amministrazioni e realtà associative del territorio.
Insomma occorre passare dall’assistenza all’integrazione.
RIVALTA: A NETWORK OF CITIES FOR HOSPITALITY
Thank you forthis opportunity. I apologize if I’m going to read my speech, but my English isnot so fluent.
I would like tohighlight the importance of working in networks among different PublicAdministrations, over all about themes with a low level of economicavailability.
In the secondpart of my speech I’ll describe some actions that we are carrying out inRivalta Municipality
In conclusionI’ll suggest some considerations about the Italian migrants system
Peace and Public Administrations
I think that aPublic Administration has to offer citizens some knowledge opportunities,because a better knowledge of the problem allows them to overcome suspicions.
Both motivatingcitizens to a concrete solidarity engagement and committing the Administrationresources have to be considered institutional duties and not good actions dependingon the charity and good heart of a temporary Major.
Peace on theplanet is not only and “simply” the absence of war: peace is a more equaldistribution of resources, it is a lifestyle, it is a collective way tointerpret human relationships.
What we are doing in Rivalta
Rivalta istrying to translate these statements in a concrete engagement even for migrantshospitality.
About 20 yearsago, Rivalta founded with 15 other Municipalities a network, named“Coordination of Municipalities for peace” (for the sake of brevity we’ll callit CO.CO.PA.). Now we have 30 Municipalities in the province of Turin and wehave many cooperations with the Regional Government of Piedmont.
Our main goalsare:
- To promote peace culture in schools and among our citizens
- To realize decentralized cooperation projects
- To care for staff training in these topics
- To cooperate with NGOs and with cooperatives working in these fields
- To promote the guidance and control role of an Administration in migrantshospitality and cooperation projects
Furthermore, Rivaltais included in a social Welfare Consortium whose aim is to give answers to issuesof social weakness.
With other 4Administrations of this Consortium, we are realizing a project approved by theItalian Ministry ofInternal Affairs. Its acronym is S.P.R.A.R., which wecan translate as Service for the protection of asylum seekers and refugees.
The project has made itpossible to entrust, by means of a public announcement, to two cooperatives themanagement of the reception problem, including the most delicate issue, namelythe finding of an accommodation, for which regular rent contracts are issued, paidfor by the cooperatives, with funds allocated by the Ministry of InternalAffairs.
The project funds areallocated to Italian learning programs and to integration programs into thesocial activities of the various territories, to the activation of employmentgrants, with the objective that refugees might reach economic and socialautonomy.
In this framework, thecontribution of volunteers and associations wishing to devote a bit of theirtime to help the achievement of such autonomy, will be very important.
With this project forhosting and integration, our Municipality wishes to continue the path already followedin recent years with the emergency of North African migrants who have remainedon our territory.
Also, with the people whohave arrived with another S.P.R.A.R. projectin partnership with the Municipality of Avigliana and with those entrusted bythe Prefecture to a cooperative, with which the Municipality has signed amemorandum of agreement for voluntary return. The latter consists in socialworks of public utility done by the refugees for the hosting community.
The Italian migrant systeme: not so good
Coming now to theItalian system, in response to the migration flows Italy is investing manyeconomic and human resources with utterly unsatisfying results.
We have:
- Centers of shelteringfor the first hospitality (that in Italy we call C.I.E.).
- attribution to theprefectures of migrants, mostly in large groups
- public announcements,by which the prefectures entrust the management of migrant groups to the cooperatives:the latter then have to prove that they have facilities and reception capacity,but often, because of the high numbers, they limit themselves to satisfy thevery basic needs and to provide assistance for legal procedures concerning the applicationto the right of asylum.
- Furthermore there arethe S.P.R.A.R. projects (as I have mentioned before), managed by the Ministryof Internal Affairs: they are taking care of smaller groups and of the proper integration of people.
Unfortunately, thedialogue between these various institutions is very sporadic, while it would beessential to have a tighter link between the first emergency reception and theactual integration process which can necessarily be achieved only by working insmall groups proportionally distributed throughout the many Italian Municipalities.
Because of the inadequatelife conditions and of the excessive lenght of the time spent in the CIE camps,the CO.CO.PA. has recently signed an appeal for the closure of the CIE centers.I have provided this to the organizers because it’s too long to describe it here.
As to the connectionbetween the procedures of the Prefectures and the S.P.R.A.R. system, it is mydeep conviction that we should send off to the S.P.R.A.R. the people initiallywelcomed by procurements of the Prefectures. This, in order to proceed to a gradualand ongoing "thinning" of larger groups and their gradualreplacement, as well as to kick off through the S.P.R.A.R. resources an actualpath of integration and autonomy, thanks to the link between the administrationsand the territorial associations.
So it is compulsory toshift from assistance to integration.
Thank you for yourattention.

Da un'ode a un campione del calcio a un'exursus storico dell'immigrazione/integrazione in Germania, da una mostra berlinese ricca di insegnamenti alla Biennale di architettura di Venezia, dalla vita letterario nella Germania di oggi alla minaccia della "paura": segmenti di una vicenda in atto, che condizionerà il nostro futuro. Il Post online, luglio 2016
Boateng contubernale dei celesti / come zeus adirato i suoi fulmini / tu feroce hai scagliato / con tuono e polpaccio tremante / la palla di fuoco dal piede ardente / dentro la rete dei telchini / come se avessi trafitto il loro cuore / recintato gli slovacchi avevano / le punte dei capelli ritte un tempo / smorfie di diavoli emersi / dalle estreme profondità dei boschi / ora si dimenavano come pesci ornamentali / sul prato asciutto che non aveva / più buchi nei quali potessero / acquattarsi i peggiori / dei loro incubi si avveravano / come se non si fossero da tempo / bruciati sulla pelle / se avessero visto il terrore solo / l’uno nelle braccia dell’altro / sarebbero rimasti a casa / questi tremendi esseri fiabeschi / poco prima del pianto / sono scappati via dall’uomo / nero via di nuovo nel loro occidente / nel quale il sole può sempre e solo / tramontare mentre noi / partita dopo partita nella tua luce / resistiamo jérôme tu figlio / degli dèi
Quest’ode a Jérôme Boateng, il cui tiro vincente ha aperto il 3-0 con il quale la Germania ha superato la Slovacchia negli ottavi di finale, è apparsa sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung il 28 giugno scorso: l’autore è il drammaturgo e scrittore Albert Ostermaier, unico poeta compiutamente “pindarico” della letteratura tedesca contemporanea, che ha dedicato tra l’altro una raccolta ai Mondiali del Brasile (Cambio d’ala, 2014) e una profetica “Ode a Manuel Neuer” all’abilità nel parare i calci di rigore.
La scelta di Boateng – pilastro della difesa dopo la defezione di Hummels – non è forse casuale: oltre a rappresentare una pedina insostituibile nella squadra di Loew (la débâcle nella semifinale contro la Francia è arrivata pochi minuti dopo la sua uscita per infortunio), il difensore di origine ghanese appartiene infatti alla pattuglia dei giocatori che rendono questa una delle nazionali più “MultiKulti” della storia tedesca – insieme a Khedira, Mustafi, Can, Özil, Mario Gomez, Sané, per non parlare di Gündogan, Rüdiger, Tah.
Con il suo fare posato e a tratti malinconico, ma soprattutto con la sua scelta di giocare con la Germania anziché con il Paese dei suoi genitori, il Ghana (per il quale ha optato invece il più turbolento fratello Kevin Prince, che gioca nel Milan), Boateng “figlio degli dèi” rappresenta un modello d’integrazione tramite lo sport del tutto affine a quello celebrato nella mostra che si tiene quest’estate al Deutsches Historisches Museumdi Berlino, dal titolo “Immer bunter” (“Sempre più colorati”, “Sempre più vari”): la gigantografia è lì, nell’ultima sala, quella di Mesut Özil. L’esposizione è di estremo interesse in quanto condotta su due assi, che sottolineano l’importanza del tema dell’immigrazione nel discorso pubblico del Paese: da un lato un’attenta ricostruzione storica del fenomeno a partire dal secondo Dopoguerra, dall’altro l’educazione militante agli ideali di tolleranza e multiculturalismo.
Il sottotitolo della mostra dice “La Germania come Paese d’immigrazione” (“Deutschland als Einwanderungsland”), assumendo così d’emblée un dato di fatto tutt’altro che scontato. Terminata l’epoca del massiccio assorbimento di forza-lavoro (grosso modo dal 1955 al 1973, anno in cui non furono rinnovati i trattati bilaterali che favorivano l’arrivo di lavoratori dai Paesi del Sud e dell’Est), per molto tempo la politica tedesca provò a negare che la Germania fosse o potesse diventare un Einwanderungsland: esplicite dichiarazioni in tal senso si leggono nel patto di governo CDU-FDP del 1982, ma ancora nelle parole del ministro dell’interno Manfred Kanther nel 1996, ad onta di una popolazione straniera comunque sempre in crescita (i molti permessi speciali di lavoro, i ricongiungimenti familiari, i cittadini europei non più soggetti a limitazioni come Italiani e Greci, le nascite della seconda generazione).
Né va dimenticato il picco degli arrivi di rifugiati dall’Est Europa tra il 1990 e il 1993 (dai 200mila ai 438mila profughi l’anno), un esodo paragonabile in termini numerici solo a quello dei Siriani di oggi, e tanto più rilevante in quanto composto essenzialmente di richiedenti asilo, ovvero di persone che – come recitava in quattro semplici parole l’art. 16 comma 2 della Costituzione tedesca – in quanto “perseguitati politici godono del diritto d’asilo”.
È da notare che questo articolo, già ritenuto uno dei fiori all’occhiello della Costituzione del ’49, e fondamentale per esempio per l’accoglienza di profughi vietnamiti, greci e cileni negli anni ’70,
venne modificato in senso restrittivo nel 1993 proprio sull’onda degli eventi: da allora, tecnicamente, non possono richiedere asilo coloro che entrino in Germania via terra; è proprio questo uno dei punti giuridici che si sono dovuti superare tramite una serie di legislazioni d’emergenza in occasione della crisi dell’autunno 2015, che ha portato nel Paese quasi un milione di fuggiaschi.
Il picco di arrivi attorno al ’90 fu alla radice di una recrudescenza di fenomeni xenofobi culminati nel pogrom contro il centro di raccolta degli immigrati di Rostock dell’agosto ’92 e nelle sanguinose aggressioni di Mölln e di Solingen, che tra tardo 1992 e primo 1993 causarono ben otto morti (tra cui due bambini) nelle locali comunità turche; e quella volta, sia detto per inciso, la protesta della politica e della società fu compatta, e duratura. D’altra parte, la reazione delle comunità straniere fu rapida e organizzata (“non vogliamo essere gli Ebrei di domani”): si creò la Deutsche Islam Konferenz come luogo istituzionale d’incontro fra il governo e le comunità islamiche per dibattere temi delicati e tuttora controversi come la cittadinanza, i luoghi di culto, il velo obbligatorio, le pratiche matrimoniali, l’adattamento alla morale corrente; nel 1994 entrarono in parlamento i primi deputati di origine turca (oggi Aydan Özoguz è ministra dell’integrazione); anche sul piano culturale cominciarono a proliferare gli artisti stranieri pronti a scrivere, cantare o girare in tedesco, dal regista Fatih Akin al gruppo hip hop degli Advanced Chemistry al prosatore Feridan Zaimoglu, autore peraltro di un testo autobiografico breve, scomodo e toccante per l’inaugurazione della mostra berlinese.
La Germania come Paese d’immigrazione
il senso di una mostra
Ora, il senso di questa mostra, ampiamente visitata da scolaresche forzatamente ignare del passato, ma anche da privati cittadini desiderosi di orientarsi in un momento politicamente complesso, è proprio quello di indicare da un lato come – e a quali condizioni, spesso non vantaggiose per gli stranieri – il miracolo tedesco si sia potentemente avvalso di forza lavoro non qualificata proveniente da altri Paesi, e abbia provato, almeno a partire dagli anni ’70 con i programmi d’istruzione linguistica e le prime concessioni sul voto locale, a battere tra mille difficoltà la strada dell’integrazione (uno dei simboli è la motocicletta donata dallo Stato nel 1964 al milionesimo Gastarbeiter giunto in Germania, uno spaurito carpentiere portoghese); dall’altro, come questo processo sia stato e sia tuttora costantemente avversato da una frangia della politica e della società refrattaria a ogni discorso inclusivo.
Quando il presidente della Repubblica Christian Wulff in un discorso del 2010
citò l’Islam come religione appartenente alla Germania allo stesso titolo di ebraismo e cristianesimo, fu travolto da polemiche d’ogni sorta; e il suo successore Joachim Gauck, attualmente in carica, non più tardi di domenica 26 giugno a Sebnitz, in Sassonia,
è sfuggito all’assalto di un neonazista armato, che insieme a un centinaio di altre persone lo apostrofava come “traditore del popolo” proprio in virtù delle sue posizioni sul tema.
In prospettiva storica, colpisce vedere come, 40 anni prima della famigerata notte di San Silvestro del 2015, una vignetta di Klaus Pielert rappresentasse “il futuro skyline di Colonia” come una selva di minareti che fanno corona alle guglie del Duomo; o come già nel 1986, in una striscia di Peter Leger, vi fosse la chiara denunzia di una retorica xenofoba che ripercorreva ad litteram le orme di quella anti-giudaica del 1933. D’altra parte, una seconda mostra al piano inferiore dello stesso Deutsches Historisches Museum disegna la storia della propaganda antisemita e razzista in Germania seguendo le tracce degli adesivi d’ogni tipo comparsi da fine Ottocento ad oggi nei bagni pubblici, sulle lettere private (epistole d’amore degli anni ’20 sigillate con il motto “Gli Ebrei sono la nostra rovina”!) o sui muri delle città (per esempio gli odierni stickers “Refugees welcome” e viceversa “Nein zum Heim”). Se l’analisi politica, condotta sotto questa luce, è sottile, d’altra parte la condanna nei confronti della retorica odiosa è durissima ed esplicita, e anzi i visitatori più giovani vengono invitati in un apposito laboratorio a produrre essi stessi i propri slogan e i propri adesivi per combattere l’odio contro gli uomini e ogni atteggiamento discriminatorio.
La Germania alla
Biennale di Architettura di Venezia
Sorprende – ma conferma la centralità del tema, nonché l’urgenza di parlarne a un vasto pubblico – l’assoluta consonanza di questa mostra con l’assetto del Padiglione tedesco presso la 15ma Biennale di Architettura di Venezia. In risposta all’appello del curatore cileno Alejandro Aravena (condensato nel titolo “Reporting from the Front”), il commissario Peter Cachola Schmal (peraltro di origini pakistane) ha sfondato i muri esterni di quello che è diventato “
The Open Pavilion“, trasformando una struttura chiusa in un punto di passaggio perennemente aperto da ogni lato, e dedicato a una questione chiara: “
Making Heimat” (con tutto quello che di intraducibile ha il sostantivo Heimat, solo approssimativamente reso con “patria”). Dalla collaborazione con il giornalista canadese Doug Saunders, autore del saggio
Arrival City (2011), nasce una struttura policentrica che affronta il problema delle migrazioni da diversi punti di vista. Per integrare i nuovi arrivati, si argomenta, sono indispensabili residenzialità a basso costo (è necessario che essi comprino casa, anziché restare in affitto o in alloggi di fortuna), prossimità al lavoro e alle opportunità d’impresa (un buon sistema di trasporti e di reclutamento), e infine reti di comunità che possano fornire aiuto in loco (anche se c’è sempre il rischio che queste reti viaggino al confine della legalità, com’è, a parere di alcuni, nel caso del vietnamita
Dong Xuan Center di Lichtenberg a Berlino, o del giro di manodopera attorno al porto di Amburgo).
Ma per far sì che i nuovi arrivati non siano né si sentano destinati solo ai lavori più umili (non ripercorrano cioè la sorte dei
Gastarbeiter degli anni ’60), è essenziale insistere sin dal principio sull’apprendimento della lingua, istituire scuole di alto livello nei quartieri più disagiati (si cita sempre il caso del
Campus Rütli di Neukölln a Berlino, antico istituto che nel 2006 pareva destinato alla chiusura per l’intollerabile livello di violenza e che da allora è stato invece riqualificato e rilanciato), creare biblioteche pubbliche che facciano concorrenza ai centri di indottrinamento religioso, e soprattutto – come illustrano anche molte foto della mostra berlinese – dare un gran peso alla cerimonia del conferimento della cittadinanza, rendendola de facto una forma di iniziazione civile.
La Germania, ricorda il sociologo Walter Siebel, ha creato un minor numero di quartieri-ghetto rispetto a Paesi gravati da una più lunga e più tormentata storia coloniale (il padiglione offre uno squarcio ottimista anche su Offenbach am Main, in Assia, forse uno degli agglomerati più problematici da questo punto di vista): dinanzi alle crisi dei rifugiati, il Paese ha anche escogitato soluzioni abitative interessanti, sia a livello di prefabbricati sia a livello di nuovi quartieri: da Monaco a Mannheim ad Amburgo, vengono documentate in Biennale diverse soluzioni abitative. Tuttavia, la tecnica di queste costruzioni passa in secondo piano dinanzi alla loro dimensione squisitamente politica, se è vero – come ricorda Emily Bromwell in una ricerca condotta in questi mesi presso il Max-Planck-Institut di Berlino – che tutto dipende in realtà da quanto “permanenti” o “provvisorie” vengono considerate le strutture in questione (e dunque, di riflesso, i soggiorni di chi le abita), da quanto cioè esse possano o debbano assomigliare a una casa vera. Di per sé, il “Better Shelter” promosso l’anno scorso da Ikea e UNHCR è molto simile all’unità abitativa disegnata da Paul Lester Wiener durante la II guerra mondiale: tutto sta a vedere come questi rifugi, non di rado provvisoriamente definitivi, s’inseriscono nel tessuto urbano esistente.
È interessante notare che nella Biennale di quest’anno, dove il tema dei rifugiati contagia diverse partecipazioni nazionali, l’altro Padiglione interamente dedicato all’immigrazione e alle tematiche correlate è quello greco, che dispone bensì di uno spazio assai più limitato, ma preferisce utilizzarlo non solo per presentare modellini di progetti realizzati o realizzabili da Lesbo a Patrasso alla vexatissima quaestio dell’aeroporto Ellinikòn di Atene (passato da campo di rifugiati a parco di lusso in pectore), bensì anche per ospitare conversazioni e dibattiti internazionali sul fenomeno migratorio e in specie sulle esperienze di accoglienza “dal basso” di cui la Grecia è insospettabilmente ricca (chi legge il neogreco dovrebbe seguire il fantastico reportage di Nikos Belavilas attraverso i campi profughi del Paese; tutti possono invece contribuire al coraggioso esperimento di occupazione e riconversione per i migranti dell’albergo City Plaza nel centro di Atene). Non v’è dubbio, peraltro, che l’esito di questi incontri riesca spesso assai poco “istituzionale”, nel senso che anche la recente politica del governo Tsipras sui rifugiati, specie all’indomani dell’accordo di scambio con la Turchia, viene sottoposta ad aspre e motivate critiche.
La società della paura
A Berlino, l’investimento ideale della politica sul tema dell’immigrazione è chiaramente assai elevato, almeno quanto l’atavica paura che il popolo (“
das Volk”, termine che dal 1989 ha assunto coloriture d’ogni tipo) ricada d’un tratto in dinamiche perverse già viste nei primi anni Trenta. Nel dibattito pubblico continua infatti l’onda lunga
del fortunatissimobest-seller di Thilo Sarrazin “La Germania si distrugge da sola” (“
Deutschland schafft sich selbst ab”, 2010), in cui la paura dell’invasione e della subalternità rispetto alle culture dei migranti è declinata sulle corde dell’indagine socio-demografica e del pamphlet identitario, in una prospettiva non troppo distante – ma perfino più virulenta – rispetto a quella che ha incarnato da noi Oriana Fallaci. Ma è sul piano dell’azione concreta che i segnali di allarme sono sempre meno sporadici: le manifestazioni di Pegida e NPD persistono ormai da anni senza accennare a spegnersi;
gli attacchi di vario ordine e grado contro i migranti sono decuplicati nel 2015; in varie città i cosiddetti
Reichsbürger (“cittadini del Reich”, negazionisti che odiano la democrazia e non riconoscono l’autorità dello Stato) sono arrivati a intralciare regolarmente l’attività dei tribunali tramite proteste e azioni di disturbo; soprattutto, preoccupa l’evoluzione del partito AfD (Alternative für Deutschland, già di impostazione conservatrice euroscettica), che rappresenta di fatto – stante l’abnorme persistenza della “große Koalition” fra Cristiano-democratici e Socialdemocratici – l’unica consistente offerta di opposizione politica, e ha virato ormai da un anno verso un estremismo di chiaro stampo xenofobo.
Ecco quindi che un’indagine sulla “società della paura” (una paura di agire che diventa paura del diverso, secondo il sociologo Heinz Bude) non può che terminare in uno dei maggiori teatri berlinesi, la Schaubühne, dove Falk Richter mette in scena il suo spettacolo “Fear“. Nella critica mordace della retorica nazionalista, omofoba e razzista, nella derisione degli ipocriti stereotipi della società tedesca, ma ancor più nella satira a tratti violenta di alcuni uomini politici dell’AfD (le sagome di alcuni di loro vengono letteralmente prese a pugni), Richter propone un testo che è quanto di più simile io ricordi alla commedia greca di Aristofane – solo declinata in una chiave “nera” e fondamentalmente tragica. Senza paura di “onomastì komodèin“, di “mettere in burla chiamando per nome”, si deridono i tic di Frauke Petry, le smorfie di Marine Le Pen, le pulsioni antiabortiste di Gabriele Kuby, o il passato dell’aristocratica Beatrix von Storch (nipote del ministro delle Finanze di Hitler): non è un caso che nel novembre scorso il partito di destra abbia tentato di bloccare lo spettacolo per le vie legali, senza peraltro riuscirvi. In “Fear” si mostrano le parole e le paure di quella vasta “zona grigia” dei quarantenni-cinquantenni incattiviti, i quali, partendo da una blanda e quasi cameratesca diffidenza nei confronti dello straniero, finiscono per trovare negli slogan xenofobi uno sbocco collettivo, e politico, al proprio disagio esistenziale. Dinanzi a un pubblico per lo più molto giovane, e per nulla turbato dagli eccessi verbali, gli attori – essi stessi tra i 20 e i 30 anni – rispettano il paradigma aristofaneo anche nel momento della “paràbasi”, ovvero quando l’interruzione della finzione scenica li fa ritornare ciò che sono nella realtà – Tedeschi meticci, figli di emigranti, ballerini nordamericani, biondissimi purosangue alternativi -, e li spinge a interrogarsi in un libero dialogo all’impronta sulla loro idea di società, sulle mistificazioni dei media, sul passato dei loro nonni (un po’ come Fassbinder e altri sfidavano quello dei loro padri), finendo a cantare con una chitarra e a piedi scalzi Fourth of July di Sufjan Stevens.
Né la Francia né l’Italia né l’Inghilterra (a tacere d’altri Paesi) stanno producendo uno sforzo comunicativo e ideologico paragonabile a quello che mobilita la Germania – in modi diversi, al livello istituzionale come a quello della cultura alternativa – per promuovere seriamente una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. Porre i problemi, discuterne anche con toni franchi, è un segno di civiltà; ma ovviamente non tutto è limpido: chi dimenticherà le lacrime della bimba palestinese dinanzi alle rigidità di Angela Merkel? quale politica redimerà la condanna tedesca della Grecia, una delle porte dell’Europa, a decenni di miseria? chi pagherà per l’infame accordo con la Turchia, propiziato in ogni modo proprio dalla Germania? e, per tornare ai fratellli Boateng, come non pensare che nella loro diversa riuscita abbia avuto un ruolo il fatto che l’uno ha trascorso l’infanzia con la madre nei bassifondi di Wedding e l’altro, il “contubernale dei celesti”, con il padre nel centro storico di Berlino?
Il tassista che mi porta a Schönefeld (un aeroporto piccolo e vecchio, mi spiega, niente a che vedere con quello nuovissimo che sta per aprire a Istanbul) è un sessantenne di Sanliurfa, che parla un tedesco semplice e dal forte accento turco: ha fatto per trent’anni l’operaio, poi la fabbrica ha chiuso e si è inventato questo nuovo mestiere; ora spera di sistemare il figlio, attualmente disoccupato, e di poter tornare finalmente a invecchiare nella sua Anatolia. Lui, mi dice, ama la pace, sia con la Russia sia con Israele sia – nei limiti del ragionevole – con i Curdi. È un grande ammiratore di Erdogan, e spera che faccia presto a completare
il muro che separa la sua patria dal nord della Siria, perché i Siriani sono un problema. È grato alla Germania, che ha strutturato la sua vita adulta attorno al lavoro e al rispetto. È anche, mi confessa sommessamente sapendomi Italiano, un grande fan di Mesut Özil.

eddyburg informa e riflette sull'assenza del lavoro dal palcoscenico e dalle parole della Biennale. Eppure, come il padiglione della Polonia giustamente sottolinea, si tratta di un "fronte" essenziale
Un paio d’anni fa, ad un giornalista del
Guardian che le chiedeva se fosse turbata dalle condizioni di sfruttamento e di insicurezza nei cantieri dello stadio al Wakrah in Qatar, da lei progettato in vista dei mondiali di calcio del 2022, Zaha Hadid rispose che «non era suo compito occuparsene come architetto». Se ci sono problemi, disse, «riguardano il governo e non me…
I have nothing to do with the workers». Alcuni famosi architetti presero posizione pro o contro le dichiarazioni della collega archistar; dopo di che il bollettino delle vittime- muratori indiani, nepalesi e bengalesi morti, feriti o comunque costretti a lavorare in condizioni che Human Rights Watch e Amnesty International equiparano alla schiavitù - ha continuato ad allungarsi.
A prescindere dagli orientamenti morali dei singoli architetti che, firmando un progetto ne vengono riconosciuti come legittimo autore, ma che mai hanno nessun rapporto con chi fisicamente realizza le “loro” opere, il “fronte” delle condizioni di lavoro in edilizia avrebbe potuto essere oggetto di interessanti rapporti da presentare alla Biennale. Ma tra le diciassette voci che Alejandro Aravena ha incluso nel suo elenco di «battaglie da combattere», e tra le quali figurano «qualità della vita e banalità… sostenibilità e mediocrità», non compaiono né la dignità né la sicurezza dei lavoratori. Nel complesso, il tema del lavoro è assente dalla mostra e nei pochi casi nei quali è preso in considerazione, l’attenzione è per lo più limitata alle difficoltà degli architetti alle prese con risorse finanziarie scarse e ai loro sforzi di fare “più con meno”.
Un’eccezione positiva e non abbastanza notata è il padiglione della Polonia, progettato da Dominika Janicka, Martyna Janicka e Michał Gdak, partendo dall’assunto che i cantieri costituiscano «il primo fronte dell’architettura, la manifestazione fisica di qualsiasi progetto in corso d’opera, che, nonostante il progresso tecnologico, continua ad avvalersi in gran parte del lavoro dell’uomo» e che i lavoratori edili siano la categoria meno rappresentata tra gli attori dell’architettura. «Il contributo dei lavoratori edili è assente dal discorso sull’architettura», è la loro sintetica opinione, dalla quale è auspicabile si possa partire per creare condizioni meno inique.
Il lavoro dell’uomo è il fulcro dell’intera installazione, dalla scritta che sovrasta l’ingresso del padiglione e che ci chiede provocatoriamente «conosci chi ha costruito il tuo edificio?» ai filmati, girati dagli stessi muratori, che ci restituiscono immagini, rumori, voci da undici grandi cantieri polacchi.
Senza nessuna evocazione nostalgica di epoche nelle quali l’architetto era solo il muratore/capo cantiere e ideazione e realizzazione procedevano di pari passo, e senza ricorrere ad aneddoti di tono oleografico, ad esempio Le Corbusier che teneva a battesimo i figli del suo “muratore sardo”, l’installazione si e ci interroga sulla possibilità di instaurare una relazione “giusta” tra il lavoratore, il prodotto del suo lavoro e chi ne trae profitto. Lo stesso titolo del padiglione “fair building” è un invito a riflettere sulla possibilità di applicare alle costruzioni, come ad altri prodotti, dalla cioccolata al caffè, i marchi del fair trade, altrimenti detto commercio equo e solidale.
L’installazione si compone di due parti. Nella prima, una impalcatura a grandezza naturale, si entra in cantiere assieme a chi vi lavora; nella seconda, dove eleganti divani suggeriscono l’atmosfera dello showroom di un investitore immobiliare, l’elemento più importante è lo schema grafico, che occupa un’intera parete e che sintetizza i dati di una ricerca, condotta dai curatori intervistando 50 addetti ai lavori, sul “costo umano” della costruzione e sul peso finanziario di voci come “incidenti, immigrati, straordinari non pagati”.
Si esce dal padiglione ponendosi delle domande inquietanti, il che conferma che l’obiettivo dei curatori di mettere a fuoco «le questioni etiche che ruotano attorno all’industria edile e i punti di vista di chi ne è direttamente coinvolto» è stato raggiunto.
Peccato che l’importanza del messaggio non sia stata recepita dagli organizzatori della Biennale che quest’anno indossa la maschera del capitalismo compassionevole. Del resto, la Biennale, in quanto istituzione, non è mai stata particolarmente sensibile nemmeno ai diritti di chi lavora al suo interno. In più occasioni ha disatteso accordi sottoscritti con i rappresentati dei lavoratori, provocando anche interpellanze parlamentari, rimaste senza risposta, sul suo comportamento. E non appena ha potuto, si è liberata anche del fastidio di doversi occupare delle “risorse umane”. Dal 2004 assunzione e gestione del personale sono state affidate all’agenzia Adecco Italia che, con lo slogan “better work, better life”, sostiene progetti culturali e internazionali, «offrendo ai candidati un’esperienza di lavoro in contesti unici ed emozionanti” e che, per la Biennale, ha definito dei “percorsi ad hoc dedicati alla formazione delle hostess, degli steward e di tutto il personale, così da assicurare standard elevati nella gestione dell’accoglienza e del supporto dei visitatori».

First of all I would like to pay tribute to the thousands of refugees and migrants dead in the Mediterranean sea. And thank Dafni and Maria, for inviting me and Ilaria and Edoardo and Cesare.
As you know, June 20th was the celebration day of the “Refugees”. This year the celebration was named “With the Refugees”. A petition #WithRefugees was posted on the HCR site to appeal to governments to include solidarity and shared responsibility in their actions and a law drafted jointly by the Ministry of Justice and UNHCR will be presented shortly to the Assembly of People's Representatives (ARP). http://www.unhcr.org/refugeeday/
It was an opportunity to remember that behind these figures lurks the suffering and resilience endured by refugees around the world and raise public awareness to the human side of their course. But why making the difference between Refugees and Migrants, as both are running from terrible conditions of life. Misery and war are so much alike, as wars and globalization generated misery. Two sides of the same problem which feed the revolution in march on the feet of millions of people.
***
As a Mediterranean woman from the other side of the sea, I will question why such extreme despair is bringing hundreds of thousands of youth to cross the sea not caring about death. And what could be done to avoid that, and what should be done for those who already crossed.
After listening to the discussions, and presentations made, I will say that we have here an example of one of the extreme cynicism of the European Union and the States policy regarding Migrants/Refugees issue, it is «A double-edged knife».
I will briefly, speak, about my country, Tunisia.
We have between 1 million and 1.8 million refugees, who came mainly from Lybia, with a direct and immediate impact upon arrival since before uprising, on the living conditions, especially on the growth of the rents, mainly for the single women and the youth, who cannot find, anymore, affordable appartments even to share, together with an impact on market economy, on black market, in all fields, and on medical care. This phenomenon increased after the war started in Lybia, and reached a level that became impossible to manage and reduce. Besides the fact that we are dealing with a tragedy that we have to look at and handle with care and with respect to those who suffer and who run from terror.
While hundreds of thousands of youth have crossed the sea in less than 5 years, we witness, a status of « empty from a side and fill another side ». Villages, rural areas, left behind by the youth, abandonned due to various unfavourable conditions, extreme outcome of the phenomenon of rural depopulation, disappearance of craft trades, and traditional small businesses and appearance of a new black market.
With No concrete policies to improve living conditions (housing, social care etc...). No more hope, leading to a complete failure of the uprising of 2011, held by more than half of the population. An increase of poverty level and dispair, had as a consequence to be open to any extreme. Besides, the money given to thousands of very poor families to send their boy and/or girl to kill in Syria, because they could not afford meal, or because they are disappointed, bitter, lost hope, or looking for an ideal to rise and be «someone».
In parallel, UE, WB were giving Billions of euros, dollars, where did all this money go?
Initially meant for development programs for « youth », but as with no clear procedures to control wether they were used for the development policies planned to be implemented in the regions or not, they were deviated from their path, since the beginning, enriching the « islamist government » and the hundreds of thousands of allies families.
We are here the witnesses of a Demographic revolution on the marche. For decades, youth used to leave rural areas to find a job in cities, to study, in hundreds, now they leave rural areas in thousands to Europe. They abandon old medinas, a patrimony normally to be preserved, now left behind in bad conditions on the focus of speculators.
Why do they abandon their medinas and rural villages, to go and occupy neighbourhoods and old villages abandoned by europeans? Unemployment, war and insecurity, fundamentalism and terrorism, misery and starvation, matched, give desperation, terror, no vision for the future.....only cross the sea.
This Demographic revolution should be an opportunity for a kind of urbanistic change, in a positive way. In the last century, migrants were mainly europeans, migrating within Europe and to the Americas. They have built cities, neighborhoods, but they also lived in slums.
What can we do as group of reflexion to change that? What strategy could we think of to put pressure on the countries from which these youth arrive; what could be done for those who did not cross, so that they do not cross? How can Europe help in terms of expertise to stop this flow ! And How to turn up side down this “disadvantage” as seen by so many as an advantage for Europe!
This is why all the actors at different levels should be engaged, including local authorities/municipalities, national governement, European union, organisations and inhabitants networks, and professionals (architects, urbanists, etc...).
The Biennale is an opportunity for us all, from both sides of the mediteranean sea, to seriously think together to how we could contribute and directly find practical and rapid ways to implement the right answers, taking into account both positions from both sides of the mediterranean sea.
Without regulations, all will loose their identity.
The consequence will be the growth of irregular settlements, the new slums, a mixture between popular responses to the lack of adequate public policies vis-à-vis speculators.
States and Supra-Nationals such as EU, UN etc. should be more specific in sustaining states, aiming into new social policies to enhance youth capacity building and social function of habitat.
This is why it is necessary to exchange experiences, debate, dialogue and think together how to implement public policies towards popular housing, rehabilitation, restructuring abandonned buildings for social use (as of Vivere 2000 coop. in Rome).
Social production of habitat is not evicting migrants, but recycling abandonned villages and buildings. It is necessary to have adequate social policies. With high taxation on empty buildings, states could finance social housing, especially the rehabilitation of neighborhood.
There are abandonned villages, that could be revived by migrants, giving them an objective in life.
It is time for us to take seriously our responsibilities towards the future generations from both sides, towards a new urbanistic vision, rooted in human rights, diversity, and solidarity, and not on market values, racism and individual interests.
And it is time for International events such as Habitat III and the meetings of the European Ministers of Housing, to include these proposals, themes, in their agenda, because migration is not a vanishing phenomenon, but more a demographic revolution, which could have a radical influence on the urbanistic transformation of future cities. This is why we organise alternative forums, conferences and workshops, this is why we are organizing the People's Social Forum of Resistance to Habitat III in Quito this october 2016.
To conclude, Intensified border controls, push-backs and reports of abuse won’t stop migrants and asylum-seekers from continuing to try to reach Europe ; Building walls won't resolve the problem. Why don’t we approach the subject from the other side. Here in Venice, there are tracks of turkish, armenian and other cultures. To face racism and homophobia, it is better to show the positive side of this huge demographic revolution, the presence of other cultures, as consequences. But being careful not to transform cities into Slums, that come mainly from speculations.
In both ways, if we do not find immediate solutions, Europe will become, or surrounded by walls such as in the Occupied Teritories of Palestina and shortly in Hungary, or by slums. Is it what future generations deserve to get in heritage?
Soha Ben Slama
Free active and engaged citizen sharing and participating to the main events cultural, political and gender issues at local and on international level. Politically countering the extremists agenda, via art and culture, using her gift as Painter, Ceramist Potter and engraver to reach people where politics and debate cannot.
Her journey in the defense of human rights at the international level, in particular the rights of women and in the MENA region, and the violence against women, started in 1995, in charge of the Maghreb for Mahkamet Ennissa, within the International Steering Committee in the World Public Hearing on Violence against Women at the Huairou Fourth World Conference on Violence against women. Same thing for the Dowry Court in 2009 (El Taller/Vimochana). Co-Founder and ‘previously’ active member of the Tunisian Women Coalition. Co-Founder in November 2012 of the Civil Alliance against Violences and for the Freedom. In 2013, she coordinated the first Conference on the Right to Housing during the World Zero Eviction Days. Co-founder on 2014 of the Global Platform for the Right to the City. Local organizer of last two World Assemblies of Inhabitants under the World Social Forum (Tunis, 2013 and 2015). She's the current IAI coordinator for Tunisia and on that quality she carried out the responsibility of media and culture, engaged also to support the African Network of Inhabitants (Africities VII) and other events within IAI. She's actually member of the Steering Committee of the International Tribunal on Evictions ITE and key point in ITE International Steering Committee in charge of the organization of the ITEAA with the TAAFE/ITEAA Steering Committee. East Asia Tribunal on Evictions to be held on July 1st to July 5th 2016 in Taipei.
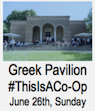
“Europe as a place to be inhabited: linking immigration and the cases of abandoned spaces” nel padiglione della Grecia alla Biennale di architettura di Venezia. In calce i link al powerpoint in inglese ai testi in lingua italiana e inglese.
1. L'ESODO
VERSO L'EUROPA
Un esodo. Ciò che si sta manifestando oggi non è la semplice migrazione di persone che desiderano spostarsi in altri paesi per ragioni personali, ma un esodo, largamente provocato da condizioni economiche, sociali, politiche e ambientali. Per le sue dimensioni e le sue cause non è un fenomeno che si spegnerà rapidamente.
Le dimensioni. Qualche numero, giusto per dare un’idea delle dimensioni del problema. Le previsioni contenute nell’ultimo rapporto dell’UNHCR (UN High Commissioner for Refugees Agency) stimano in oltre 1,19 milioni il numero delle persone da reinsediare. Il gruppo maggiore è costituito dai siriani (40%), seguito dai profughi dal Sudan, dall’Afghanistan e dalla Repubblica popolare del Congo. L’UNHCR stima inoltre che nel 2050 i profughi potrebbero essere, nel mondo intero, dell’ordine dei 200-250 milioni. Il Parlamento europeo, dal conto suo, valuta in 17,5 milioni le persone che hanno abbandonato i loro paesi (soprattutto dalle regioni dell’Africa subsahariana) dal 2014.
Le cause. Queste sono le cause principali dell’esodo, e al tempo stesso gli attori che cosa le hanno provocate. In primo luogo, la trasformazione radicale delle economie locali provocata dalle varie forme dello sfruttamento operato dal colonialismo, con il conseguente trapasso da economie locali di autosussistenza a economie legate al mercato economico globale.Le trasformazioni dell’economia si sono sempre accompagnate agli interventi della politica: un’altra causa della fuga è costituita dai regimi dittatoriali e spesso corrotti, imposti o favoriti e finanziati dagli stati o dalle imprese del Primo mondo.Ancora, le guerre scatenate o fomentate per impossessarsi delle risorse, a cominciare dalla terra e dall’acqua e quelle attuate dal Primo mondo nell’illusione di combattere il terrorismo.
Infine – ma si tratta di cause non meno importanti - la fuga dagli effetti provocati dagli eventi naturali estremi innescati dal cambiamento climatico globale (siccità, inondazioni, riscaldamento globale), nonché dai luoghi dei disastri ambientali causati da inquinamenti incontrollati o incidenti industriali, tutti frutti avvelenati dello sviluppo capitalistico.
La fuga. La fuga di moltitudini di simili proporzioni avviene in modo del tutto spontaneo, e quindi assume inizialmente la forma del caos. Ma i migranti, per poter fuggire, hanno trasformato in moneta le risorse di cui disponevano. Ciò, in assenza di altre possibilità legittime, ha provocato il formarsi di attori (soprattutto non istituzionali, generalmente organizzazioni malavitose), che sfruttano le risorse dei migranti, e spesso i loro stessi corpi, in cambio del trasporto in condizioni disumane e irte di rischi dai luoghi di origine ai luoghi della speranza.
Quelli che ci arrivano sono in precarie condizioni di salute fisica e psichica.
L’approdo. L’approdo alle terre della speranza è quasi sempre drammatico. Se il vettore è l’imbarcazione e la frontiera è la costa marina spesso si paga il prezzo del naufragio e del gran numero di morti. Se la frontiera è sulla terra e il vettore sono le gambe degli uomini, delle donne e dei bambini il prezzo è vivere nella misera, nel freddo e nelle malattie dietro recinti di filo spinato alla mercé di una vigilanza a volte disumana.
La “prima accoglienza”. Quella che dovrebbe essere la prima accoglienza è essa stessa un dramma: all’arrivo i migranti sono spesso affetti da seri problemi fisici e psicologici. Nei centri di accoglienza le condizioni di vita sono spesso disumane: l’insufficienza dei servizi per i bisogni fisici, sanitari, culturali a partire dalle difficoltà di comunicazione dovute alle lingue diverse; il completo isolamento e la mancanza di comunicazione con i familiari; infine, l’incubo della selezione e l’inammissibile discriminazione dei “profughi economici”.
La “post-accoglienza”. L’ordinaria condizione dei profughi dopo la prima accoglienza è una sorta di limbo. Essi restano in attesa del loro destino. Se saranno accettati e quindi avranno un permesso di soggiorno, oppure se saranno respinti e riceveranno un foglio e saranno messi sulla strada a infinita distanza dal luogo che, senza mezzi, dovrebbero raggiungere; una condizione ancora più drammatica di quella che aveva provocato la fuga. I ”fortunati”, ottenuto il permesso di soggiorno, sono al cospetto delle difficoltà di affrontare la vita e il proprio mantenimento : trovare un lavoro, una casa, la possibilità di costruire legami sociali, l’integrazione senza perdita di identità, etc. ma anche ristabilire contatti e riunificazione con le famiglie d’origine e infine l’assoluta mancanza di strategie e progetti che prevedano la possibilità di un ritorno programmato nei paesi di origine.
Che fare. Sebbene le cause dell’esodo non possano essere eliminate in una prospettiva temporale ravvicinata, occorre intervenire nell’immediato per rendere meno disumane le condizioni del percorso.
A questo fine non è sufficiente combattere i trafficanti di migranti. È invece indispensabile realizzare canali protetti dall’origine al termine del percorso, a opera di una organizzazione internazionale e, contemporaneamente adattare misure specifiche per i diversi momenti del percorso dei migranti. Ogni fase (dallo sbarco, all’accoglienza, all’integrazione) richiede approcci, attori e progetti diversi.
Inoltre, ogni intervento immediato deve porsi in una strategia e in una visione temporale più ampia. È necessario un impegno disinteressato, sinceramente mirato a migliorare le condizioni ambientali ed economiche dei paesi di origine. Ciò comporta il superamento degli attuali programmi di cooperazione, spesso finalizzati al mantenimento della cooperazione stessa o per ottenerne vantaggi economici e politici. Per ridurre le cause dell’esodo e per investire in modo più fruttuoso le risorse disponibili è necessario un forte impegno per la pace e la decisa condanna della produzione e del commercio di armamenti.
2. OSPITALITÀ E CITTADINANZA
I PRINCÌPI
Il modo giusto di affrontare la questione dei migranti sarebbe quello di partire dai concetti di ospitalità incondizionata e di cittadinanza universale, in relazione ai diritti universali della persona, traducendoli in vera azione solidale, anziché in nuovi strumenti di sfruttamento o discriminazione.
La promessa di ospitalità incondizionata. Dobbiamo costruire un’ospitalità libera dai legami e dalle costrizioni di sovranità statale e dalla prevalenza della nozione di appartenenza nazionale, bensì fondata sui valori di compassione, responsabilità, libertà di movimento e sul diritto di essere, di esistere ovunque, senza alcuna considerazione della sovranità dei confini territoriali.
La visione di una cittadinanza cosmopolita. Dobbiamo aspirare a una cittadinanza non più ancorata alla territorialità, sovranità e nazionalità condivisa, ma basata su forme alternative di comunità politica, che vada oltre il falso presupposto che l’interesse del singolo cittadino abbia la priorità sui doveri del resto della razza umana, poiché la nazione-stato non è l’unica né la principale comunità morale.
3. L'OSPITALITÀ COME BENE COMUNE
UNA PROPOSTA
Perché non si può rimanere indifferenti. Tre buone ragioni lo impediscono: l’etica, la sicurezza, l’interesse.
L‘etica: provoca profondo degrado morale vivere nell’opulenza al cospetto di moltitudini che vivono in così drammatiche condizioni di miseria. Le notizie che ogni giorno funestano i giornali ne sono la testimonianza quotidiana.
La sicurezza: la disperazione della miseria senza sbocco alimenta il terrorismo. Le mura della fortezza saranno inevitabilmente travolte dalla giustamente rabbiosa moltitudine degli esclusi.
L’interesse: recentemente il presidente dell’Inps, Tito Boeri ha dichiarato che le entrate nel pubblico bilancio dovute ai lavoratori emigrati ammontano a 8 miliardi di Euro, mentre solo 3 miliardi escono per le loro pensioni e gli altri benefici sociali. Politiche di accoglienza diverse dalle attuali produrrebbero notevoli vantaggi sul bilancio finanziario. Si tratta di valutazioni che nel mondo attuale hanno più peso di quelle umanitarie e morali. Si consideri ancora, a questo proposito, che oggi l’insieme dei migranti paga un miliardo di euro all’anno per tentar di entrare in Europa, e altrettanto costa all’Europa attrezzarsi per respingerli. Vero è che nel secondo caso sono le imprese europee che ne guadagnano.
Il problema non è “se” ma “come”. Il problema non è "se" dobbiamo accogliere i migranti o no. Provvedere ad assistere le persone nel bisogno o nelle difficoltà è un dovere civile. Il problema è “come” includerli nel nostro futuro e nel percorso del nostro sviluppo, senza discriminazioni né sfruttamento né pretendendo di “addomesticarli”. L’arrivo di un gran numero di migranti è una sfida per ogni paese, ma è anche un’occasione per entrambe le parti: (gli ospitanti e gli ospitati), se guardiamo al problema nel contesto sociale, economico e ambientale dei diversi paesi.
Dove troppo pieno, dove troppo vuoto. Se la storia degli ultimi secoli ha reso i territori dell’esodo troppo pieni di persone, la stessa storia ha provocato in Europa vaste condizioni di troppo vuoto, da più punti di vista. Nell’ultimo secolo i paesi poveri presentano i più alti tassi di crescita della popolazione. L’Europa al contrario sta diventando troppo vuota, sotto diversi aspetti: demografici, territoriali, sociali.
Vuoto demografico. Nel 2015 l’Unione Europea contava quasi 510 milioni di abitanti, contro circa 485 milioni nel 1995 (considerando le frontiere attuali dell’Unione). Questa progressione di 25 milioni di abitanti in vent’anni non ha niente di eccezionale (appena lo 0,2 per cento di crescita annuo, contro l’1,2 per cento della popolazione mondiale nel suo insieme nello stesso periodo). Ma il punto importante è che tale crescita è dovuta, per quasi tre quarti, all’apporto migratorio (più di 15 milioni di persone). Tra il 2000 e il 2010, l’Unione Europea ha accolto quindi un flusso migratorio (al netto degli espatri) di circa 1 milione di persone. Sulla base dei trend demografici, e ove permanessero, l’Europa avrebbe bisogno di 42 milioni di nuovi abitanti entro il 2020 e di oltre 250 milioni in più nel 2060.
Vuoto sociale e territoriale. Definiamo vuoto sociale e territoriale il fatto che esistono molte aree della società e del territorio nelle quali si manifesta una forte carenza di investimenti di risorse, e soprattutto di lavoro, dovuta a sua volta al fatto che non esistono le condizioni che rendano conveniente per il Mercato intervenirvi.
Alcune tipologie territoriali:
- terreni fertili abbandonati per la concorrenza di colture industrializzate;
- lavori di manutenzione idrogeologica e boschiva abbandonati per carenza di investimenti;
- abbandono di interi paesi e di un ricco patrimonio di infrastrutture minori dovuto alle peggiorate condizioni economiche e alla conseguente emigrazione;
- concentrazione delle risorse pubbliche e private sulle infrastrutture di trasporto basato sulle grandi distanze, sulla motorizzazione individuale e sull’alta velocità;
- abbandono di colture e di allevamenti tradizionali a causa del cambiamento degli standard di comportamento sociale degli europei;
- riqualificazione degli spazi pubblici e della manutenzione di aree di verde urbano;
- altre tipologie sociali come la cura alle persone; i mestieri scomparsi a causa della “obsolescenza programmata” dei prodotti utili per esempio tutte le categorie di riparazione di oggetti, dalle scarpe ai giocattoli, agli impianti tecnologici agli strumenti informatici;
- i lavori “scartati” dai giovani europei in quanto considerati troppo faticosi o degradanti.
Cambiare il nostro modo di immaginare e di progettare. Per molto tempo ancora il flusso sarà da Sud a Nord. Dobbiamo considerare questo come un dato normale del nostro assetto demografico e dobbiamo perciò incorporare nella nostra attività di pianificazione e programmazione territoriale il nuovo sistema di bisogni (casa, servizi collettivi, lavoro, ecc.), invece di pensare che istantaneamente il flusso si arresterà o qualcosa riuscirà a impedire alle persone di approdare.
In una parola, dobbiamo immaginare e via via trasformare le nostre città e i nostri territori non solo per le persone che vivono qui da secoli ma per i nuovi cittadini (i migranti) che hanno storie e diverse nel loro passato.
Il cuore della proposta. La proposta che da più parti viene avanzata in Italia (Luciano Gallino, Guido Viale, Piero Bevilacqua, Franco Arminio, Tonino Perna,…) si riallaccia ad esperienze compiute negli USA e in Europa per affrontare la grande crisi economica del 1929. Si decise allora (il New Deal del presidente USA Franklin Delano Roosvelt) di investire ingenti risorse pubbliche per trasformare l’assetto territoriale di vaste regioni, risolvendo problemi ambientali e territoriali, e aumentando al tempo stesso la capacità di spesa dei lavoratori, riattivando così il sistema economico. Nel nostro caso le migrazioni potrebbero essere l’occasione per investire non solo risorse pubbliche ma anche risorse fisiche collettive (terreni abbandonati ed edifici inutilizzati).
Mettere insieme quello che oggi sembra troppo pieno e quello che è troppo vuoto: anche questa è, al tempo stesso, una sfida e un’occasione. La sfida è fornire un’intelaiatura nazionale ed europea, e una coerenza territoriale sistemica, a un insieme di esperienze, di tentativi e di progetti realizzati o avviati a livello locale, spesso in collaborazione attiva con gli stessi migranti.
Riace, e non solo. L’esperienza di Riace e del suo sindaco è diventata famosa perché una rivista internazionale ad ampia tiratura, Fortune, ha inserito il sindaco Mimmo Lucano nell’elenco dei grandi leadr mondiali per il 2016. Ma molte feconde esperienze sono in atto in Italia e in Europa, da parte di molti attori, istituzionali e non, che hanno scelto la solidarietà contro gli affari.
Siamo convinti che il percorso giusto è di partire dalla molteplicità delle esperienze e dei progetti locali, di portarli a sintesi con i bisogni, i desideri e le competenze dei nuovi cittadini (i migranti) e di costruire insieme progetti più ampi e complessi.
Gli attori e il ruolo Nord-Sud del progetto. Oltre alle istituzioni dei vari livelli (comuni, regioni, stati, Europa) gli attori privilegiati sono tre:
(1) il mondo dell’associazionismo e del volontariato, istituzionale ed extraistituzionale, che già lavora in questa prospettiva;
(2) le presenze già organizzate od organizzabili di persone nei paesi di provenienza per instaurare rapporti, programmi a lunga durata, che prevedano sia l’implementazione di canali di espatrio sicuro, sia il possibile ritorno dei migranti nei loro paesi di origine quando le condizioni lo favoriscano;
(3)la scuola, dalla materna all’università: senza una cultura che rispetti la differenza, l’alterità e creda nella solidarietà non è possibile costruire una società multietnica pacifica.
I primi due attori sono particolarmente utili nella prospettiva di una presenza solo temporanea dei profughi in Europa. Quelli di loro che vorranno tornare nei loro paesi di origine potranno avvalersi delle esperienze e conoscenze (dei saperi e dei mestieri) acquisiti nella fase della loro permanenza in Europa per migliorare le condizione delle loro ritrovate patrie, così come l’Europa avrà potuto arricchirsi grazie alla conoscenze delle loro culture.
Crediti
Il testo è scritto per eddyburg da Ilaria Boniburini, Paolo Dignatici ed Edoardo Salzano, con contributi e discussioni con Maria Cristina Gibelli, Piero Bevilacqua, Paolo Cacciari, Guido Viale. È stato presentato in occasione degli incontri del 25-26 giugno 2016 sul tema “La crisi dei migranti. Industria vs Solidarietà” al padiglione della Grecia alla Biennale di architettura di Venezia, organizzato dall’associazione greca degli architetti Sadas-Pea in collaborazione con eddyburg.
Scarica qui il testo in inglese: Hospitality and Citizenship; e qui il testo in italiano: Ospitalità e cittadinanza. Qui il link al powerpoint, tradotto in formato .pdf.
Ilgiornaledellarchitettura.com, 13 giugno 2016 con postilla (p.s)
Del Padiglione Italia si è già detto, scritto e visto quasi tutto. La gran parte dei report testuali e video-fotografici hanno puntato l’attenzione su un’architettura che entra in gioco in processi più o meno spontanei di costruzione o di appropriazione e si prende cura di spazi urbani o periurbani, conferendo loro maggiore qualità estetica e funzionale, e quindi anche maggiore riconoscibilità e legittimità per le attività che vi si svolgono. In questa sorta di riscoperta della funzione sociale dell’architettura vengono richiamati soprattutto gli aspetti del riuso/riciclo, della sostenibilità energetica, del low cost, di un approccio minimale, nonché il carattere partecipato che contraddistingue molti dei percorsi progettuali selezionati. Curiosamente, molte meno attenzioni sono state poste sul motivo per cui le architetture presenti nel Padiglione dovrebbero essere guardate come beni comuni, invece che come normali, ancorché particolarmente ‘curati’, interventi di trasformazione.
La cosa risalta perché il carattere politico e non squisitamente tecnico del taking care è uno tra i messaggi centrali che questo progetto curatoriale ci lascia ed è ribadito in più occasioni. Il fatto che non sia stato colto appieno è forse dovuto al fatto che a visitare il Padiglione e a scriverne è un pubblico “di settore”, abituato ad apprezzare più la modalità di costruzione, sia anche intesa per il percorso collettivo a sostegno della realizzazione di un manufatto, che non il sistema di produzione di beni e servizi cui il manufatto stesso rinvia. E così si rileva l’efficienza, il fare tanto con meno, piuttosto che l’efficacia nel trattare una data questione e nel costituire una risposta a dei bisogni. Come se a determinare la rappresentatività di queste opere nel panorama nazionale contemporaneo fosse solo il senso etico sotteso alla scelta di forme, materiali, maestranze e partenariati, e non c’entrasse ad esempio il rapporto che esse instaurano con una collettività, i modi in cui sono percepite e vissute, e le trasformazioni che inducono a livello organizzativo, sociale e politico.
Per apprezzare appieno il valore innovativo di questa proposta si dovrebbe infatti considerare come non sia scontato che, a differenza di quanto siamo abituati a vedere in una mostra di architettura, molti di questi oggetti, e in particolare i cinque dispositivi della sezione “agire”, non siano pubblici né privati, ma nascano piuttostoda un intreccio complesso di saperi e pratiche, intuizioni, occasioni e iniziative che si combinano con risorse di vario tipo e con domande non ancora del tutto espresse. Non c’è (o è molto sfumato) un committente, né c’è una figura tradizionale di esecutore, spesso sostituita da un’aggregazione di soggetti, nata attorno al progetto stesso, cresciuta con la sua realizzazione e probabilmente capace, nelle fasi successive, di mutare le proprie attività e di affinare le proprie capacità.
Oltre che per natura giuridica e titolo di godimento, i manufatti qui proposti sono degli ibridi anche dal punto di vista delle funzioni. Prendendo il caso dei cinque dispositivi, ma lo stesso si potrebbe dire anche per la gran parte dei venti progetti selezionati, il circolo virtuoso creato tra progettisti, associazioni e contesti periferici, non produce un vero e proprio ambulatorio, una biblioteca, un ufficio-sportello, una palestra o un tradizionale laboratorio d’analisi ambientale, quanto piuttosto un mix variabile tra queste e molte altre funzioni. Quando questi dispositivi troveranno collocazione, scopriremo cosa effettivamente siano e, probabilmente, li potremo definire soltanto con nuove denominazioni, perché non risponderanno alle attuali categorie, sia per le forme esteriori sia per le forme di gestione e d’uso. Per ora, si può affermare che, da un lato, si sopperisce con essi a un’offerta pubblica di servizi sempre più vincolata dall’incomunicabilità tra livelli e tra settori amministrativi, ciascuno col proprio (risicatissimo) budget, e nel dare così qualche chance in più al trattamento di nuovi bisogni, marginalità e fasce di disagio; mentre, dall’altro lato, sembrano in grado di fornire un contributo, si spera determinante, a un cambiamento culturale centrato sulla responsabilità individuale nella realizzazione di luoghi vitali e accoglienti.
Coerentemente, anche il crowdfunding attraverso cui si finanzierà la realizzazione dei cinque dispositivi, si presenta come l’unica forma possibile per sperimentare velocemente le nuove tipologie di servizi di cui sopra; capire come si sostengono economicamente e di quali figure professionali necessitano, quali valori verranno messi in gioco, come funziona nel nostro contesto, e nel medio-lungo periodo, una proprietà multipla, condivisa, replicabile e, soprattutto, “praticata” di un bene. Si configura quindi uno spostamento netto non solo rispetto alla produzione di servizi da parte dello Stato ma anche nel ruolo del mercato, posto che a produrre questi dispositivi contribuiranno migliaia di soggetti, con finalità e interessi anche molto distanti tra loro, e tuttavia comunemente intenzionati a vedere concretizzata questa operazione, innescata, strano a dirsi, da una mostra d’architettura.
postilla
La libera stampa di regime si è dichiarata unanimemente entusiasta del padiglione italiano. Schierate a falange le truppe di Dario (Franceschini) hanno cercato di convincerci che, in Italia, architettura significa prendersi cura del bene comune. A questi commenti “indipendenti” si aggiunge, ora, l’invito da parte di uno dei consulenti che ha contribuito all’ ideazione del padiglione a considerare un «aspetto politico e non squisitamente tecnico che forse è sfuggito ai visitatori», cioè il fatto che i casi esposti alla mostra non sono «né pubblici né privati». Il che vale anche per le cinque unità mobili che dovrebbero «sopperire a un’offerta di servizi pubblici sempre più risicata per mancanza di finanziamenti». Mandare in giro un pulmino col medico dai piedi scalzi o con una biblioteca ambulante è sicuramente un mezzo per mitigare il disastro prodotto dai tagli ai servizi pubblici. E’ pur sempre un regresso, però, che coincide con il considerare inevitabile il ritorno alle condizioni di disperazione descritte nei romanzi di Steinbeck, alle quali invece che con un new deal il padiglione italiano risponde con il crowfunding. Tradotto in italiano si dice colletta e significa che i cittadini che pagano le tasse e che vedono quelle tasse dilapidate dai comitati d’affari che si sono spartiti il paese, devono ulteriormente tassarsi per garantirsi un minimo di servizi. Purtroppo è quello che accade ogni giorno e sembra l’unica possibilità rimasta ai cittadini che vogliono prendersi così cura del bene comune, con o senza gli architetti della Biennale (p.s).

Fra le varie attività di complemento alla esposizione vera e propria, la Biennale di Architettura di Venezia organizza sei incontri, a cadenza mensile, rispettivamente dedicati ai seguenti temi: infrastrutture; periferie; strutture e materiali; scarsità; ambiente; conflitti.
Il primo “sabato dell’architettura” si è svolto il 28 maggio, lo stesso giorno dell’apertura della Biennale al pubblico, e vi hanno partecipato il direttore Alejandro Aravena e il presidente Paolo Baratta.
Un’occasione importante, quindi, e dalla quale era lecito aspettarsi l’avvio di un dibattito su una serie di questioni cruciali che il tema infrastrutture inevitabilmente solleva. Ad esempio, sarebbe stato interessante conoscere cosa gli inviati della Biennale dislocati sul fronte infrastrutture ci dicono a proposito della differenza tra infrastrutture e “grandi opere” o della differenza fra concepire (pensare e realizzare) le infrastrutture come strumento per migliorare le condizioni di vita della gente oppure considerarle come una delle tante occasioni di investimento finanziario.
La presenza degli autori di due progetti molto interessanti lasciava ben sperare. Ed in effetti entrambi hanno esposto il loro lavoro con chiarezza, senza falsa modestia e senza enfasi auto celebrativa. C’era un problema sul terreno che influiva in modo negativo sull’esistenza quotidiana di migliaia di persone, hanno detto, e l’abbiamo affrontato con le armi a disposizione della nostra professione, cioè immaginando una nuova modalità di organizzazione dello spazio fisico e dandole forma concreta. In altre parole, avrebbero potuto dire, abbiamo fatto gli architetti.
Andrew Makin ha raccontato la trasformazione di Warwick Triangle, un nodo di interscambio di mezzi di trasporto a Durban, che da luogo emblematico di insicurezza e violenza, dove le autorità avrebbero voluto collocare un grande e “moderno” mall commerciale, è diventato il supporto di una miriade di attività economiche, dai venditori di cibo a quelli di tessuti, dai banchetti dove profughi da ogni parte dell’Africa lavorano come barbiere a quelli dove si pratica la medicina tradizionale.
Lavorando assieme a una NGO fondata da un ex poliziotto, che si era “stancato di arrestare la gente e aveva deciso di affrontare il problema della sicurezza da un altro punto di vista”, Makin ha progettato una serie di interventi, scale e passerelle soprattutto, per mettere in connessione i vari punti di un luogo che è attraversato ogni giorno da 460.000 pendolari e dove operano oltre 5000 venditori di strada. Grazie a questi collegamenti, da mera infrastruttura per il traffico , Warwick Triangle è diventato una infrastruttura attrezzata, una piattaforma produttiva che genera opportunità di lavoro e reddito, e quindi sicurezza, e che fa “girare” l’economia.
Anche a Medellin, l’intervento infrastrutturale pensato dagli architetti del gruppo EPM, la compagnia responsabile del servizio di rifornimento idrico, in accordo con l’amministrazione comunale, non ha comportato la costruzione di una nuova grande opera, ma una serie di interventi che hanno riconfigurato l’assetto esistente. E anche in questo caso, all’origine del progetto c’è la preoccupazione per le condizioni di vita degli abitanti e il tentativo di migliorarle fornendo una minima dotazione di spazio pubblico. La constatazione che gli unici spazi vuoti erano quelli a ridosso dei serbatoi d’acqua, recintati e per questo rimasti inedificati, ha dato origine ad un gesto progettuale di sottrazione, l’abbattimento della recinzione. Quindi il disegno paziente e intelligente degli spazi residuali ha dato avvio alla creazione di una serie di spazi pubblici attorno ai serbatoi, che sono, così, diventati il fulcro di vere e proprie oasi urbane.
Una discussione con il pubblico su questi due progetti, “piccoli” dal punto di vista delle grandi società di engineering , ma grandi in termini di capacità dei progettisti di prefigurarne l’impatto sulla vita della popolazione, impatto che oggi è evidente e documentato, avrebbe potuto essere interessante. Ma non c’è stata nessuna discussione. Dei due progetti praticamente nessuno ha parlato, né avrebbe avuto il modo di farlo dal momento che gli interventi dei progettisti di Durban e di Medellin sono stati preceduti e seguiti, per meglio dire imprigionati e soffocati , da quelli di sir Norman Foster e di Rem Koolhas.
Sir Norman Foster, algido come uno dei personaggi “cattivi” degli ultimi libri di Le Carré, ha parlato del suo progetto di aeroporto per droni in Rwanda . Senza nemmeno citare Peter Rich, alle cui costruzioni a volta in mattoni di terra si è palesemente ed ampiamente “ispirato”, si è vantato delle novità della tecnica costruttiva e del carattere umanitario di un progetto che “la comunità sente come suo”. Sir Norman, che è stato un pilota della RAF, ama molto gli aeroporti e ne ha disegnati in ogni parte del mondo, ma non disdegna neppure i progetti per valorizzare i terreni di aeroporti esistenti trasformandoli in ghetti di lusso. Suo, ad esempio, è il progetto per costruire una serie di alberghi e residenze di prestigio, una marina, un aquarium e tutto quello che prescrivono i manuali alla voce “waterfront per ricchi”, nel compendio dell’ex aeroporto Hellenikon ad Atene, che proprio in questi giorni il governo greco è stato costretto a privatizzare cedendolo, a una cordata di investitori cinesi e di Abu Dhabi. E’ un progetto che bene avrebbe figurato tra quelli selezionati di Aravena- l’area è parte del bottino della guerra che abbiamo condotto contro la Grecia ed al momento offre rifugio ad alcune migliaia di senza tetto vittime della stessa guerra- ma purtroppo gli inviati speciali della Biennalenon l’hanno avvistato.
Invece di avviare la discussione partendo dai tre casi illustrati dai progettisti, Koolhas li ha rapidamente liquidati includendoli tutti e tre nella categoria di progetti che “guardano al locale” e ci ha quindi annunciato che la “globalizzazione è finita”. Ma più che in queste dichiarazioni apodittiche, la parte interessante del suo discorso è quella dedicata alle infrastrutture come supporto all’urbanizzazione e al relativo ruolo della Biennale, che a suo giudizio lavora per l’urbanizzazione fin dal 2000. In questa parte, il suo intervento si combina perfettamente con quello successivo di Joan Clos, direttore di UN Habitat, al quale la Biennale ha affidato il compito di concludere l’incontro ma che, in realtà, ha tenuto una sorta di comizio sull’urbanizzazione sostenibile.
Che diffondere il pensiero unico sull’urbanizzazione, propugnato e propagandato dalla Banca Mondiale e dai suoi mercenari, sia una delle mission della Biennale di quest’anno è evidente dalla quantità di eventi che ruotano attorno al tema; dal progetto speciale Conflicts of an Urban Age, messo a punto da Ricky Burdett (direttore della Biennale Architettura nel 2006) e il cui padiglione è stato finanziato dalla Deutsche Bank, alla presentazione a Cà Foscari dei Laboratori di UN Habitat per diffondere i principi e le tecniche dell’urbanizzazione sostenibile.
Tutti gli eventi partono dall’assunto che non solo l’urbanizzazione è inarrestabile ma, se ben pianificata, cioè disegnata dai nostri architetti, costruita dalle nostre ditte e finanziata a tassi di usura dalle nostre banche, è positiva. Né UN Habitat né le varie agenzie che diffondono tali previsioni dicono, però, che l’urbanizzazione non è un fenomeno naturale, perché lo spostamento di grandi masse di popolazione all’interno di un paese, e da un paese all’altro, può essere contrastato, assecondato o imposto, o comunque fortemente influenzato dai governi e dai decisori economici. Non a caso “l’urbanizzazione forzata” è stata teorizzata dagli strateghi militari come arma nei confronti di popolazioni nemiche e, nel 1968, Samuel Huntington l’ha esplicitamente indicata come decisiva per debellare la resistenza dei vietnamiti. A suo parere, messo poi in pratica dai generali americani, bisognava porre i contadini di fonte a tre alternative: restare sulla propria terra (e farsi bombardare), unirsi ai ribelli ( e farsi bombardare), diventare rifugiati urbani. Oggi i governi non espongono ai loro cittadini la questione in questi termini, ma in molti casi la migrazione verso le agglomerazioni urbane è il risultato di pressioni altrettanto potenti perché enormi sono gli interessi in gioco. Anche le opzioni per i contadini sono sostanzialmente le stesse, e della loro “scelta” di diventare “rifugiati urbani” tutto si può dire tranne che sia presa senza coercizione.
Come scrivono i commentatori economici, che non dovendo esporre alla Biennale non hanno bisogno di esibire buoni sentimenti, soprattutto in Africa l’urbanizzazione è una sfida tremenda per le autorità locali, ma è un’opportunità enorme per gli affari. La rapida crescita delle città, infatti crea occasioni straordinarie. Le sfide/opportunità vanno dalla carenza di infrastrutture e di energia alla mancanza di acqua e cibo, dalla perdita di terra coltivabile ai problemi sanitari causati dall’inquinamento, dallo smaltimento di rifiuti al traffico caotico.
Tutte queste sfide/opportunità compaiono nella lista di quelle che Aravena individua come le battaglie da vincere al fronte. Si tratta di capire se le stiamo combattendo a fianco di quelli che sono bombardati o di quelli per cui l’urbanizzazione è un’ opportunità.
Detto questo, tranquillo Alejandro, venceremos!
Riferimenti
Qui il primo report di eddyburg dalla Biennale Architettura: La cattiva coscienza della Biennale targata Rolex
 «Il cileno Alejandro Aravena, curatore della XVI Biennale, immagina l’architettura come un bene pubblico e l’architetto come un prestatore di servizi». Il Sole 24 ore, 29 maggio 2016 (c.m.c.)
«Il cileno Alejandro Aravena, curatore della XVI Biennale, immagina l’architettura come un bene pubblico e l’architetto come un prestatore di servizi». Il Sole 24 ore, 29 maggio 2016 (c.m.c.)
Dal vostro inviato al fronte. Visto da Venezia il fronte dell’architettura si presenta più come una rete che come una linea retta. Una griglia involontaria di strade trafficate e di vicoli appartati, di luoghi comuni e di insolite proposizioni che aiutano a ridefinire la nostra idea dell’architettura e del progetto secondo direzioni a volte anche inattese.
Alejandro Aravena, l’architetto cileno regista e curatore di questa plateale messa in scena,è noto per l’impegno sociale esemplificato dal lavoro del suo studio nel campo delle infrastrutture, degli spazi pubblici, dei progetti di edilizia a basso costo( Elemental). L’intera Biennale da questo punto di vista è il manifesto allargato di una posizione che mette al centro l’idea di architettura come bene pubblico e una visione dell’architetto come prestatore di servizi che dà forma ai luoghi in cui viviamo.
La sua posizione non è né inedita né isolata e i suoi antecedenti storici possono essere rintracciati nella nozione di “necessario” elaborata da Tatlin nella stagione eroica della rivoluzione russa («non il meno, né il più: solo il necessario»)o in quella di Giuseppe Pagano che ,contro il formalismo delle avanguardie, rivendicava nella sobrietà i veri «benefici dell’architettura». Ma, anche se è entrata da qualche anno nell’agenda del “politicamente corretto”, quest’idea viene ancora percepita più come un obbligo sociale che come una vera condivisione intellettuale.
Credo che il merito di Aravena sia di essere riuscito a schivare in parte il pericolo di una assunzione ideologica e moralistica, aprendo a una pratica curatoriale più aperta e problematica che, accanto agli slogan dell’architettura per tutti, apre spiragli verso pratiche più interstiziali e intriganti sulle responsabilità del progetto. Come nella bella e agghiacciante installazione - The Evidence Room- che, partendo dall’ analisi forensica del campo di concentramento di Auschwitz, replica le caratteristiche degli spazi e dei luoghi di detenzione ricostruendo gli strumenti architettonici di detenzione e di tortura: frutto dell’accurata progettazione di ingegneri e di architetti al servizio del terrore.
La proposta di Aravena riguarda in fondo la necessità di ampliare la gamma delle tematiche cui ci si aspetta che l’architettura debba dare risposte, avvertendo tuttavia il limite di una sua meccanica equiparazione a strumento di servizio. Se si accoglie l’invito sintetizzato dall’immagine-manifesto - l’antropologa tedesca Maria Reiche, sorpresa da Bruce Chatwin a camminare nel deserto con una scala di alluminio per decifrare dall’alto il disegno delle tracce archeologiche disseminate disordinatamente al suolo - ci si accorge che l’insieme affastellato delle installazioni si compone infine nella complessità di linee individuali ma intrecciate tra di loro anche quando apparentemente conflittuali.
Prima tra tutte per quantità di partecipazioni, quella legata ai temi dell’emergenza; poi quella delle best practices, che riguarda sia i luoghi dell’iper sviluppo che quelli del sotto sviluppo, a partire dai rifiuti e dall’ecologia dei consumi; forse un po’ meno evidente, ma cruciale, quella infine che definisce l’architettura come una pratica di resistenza, per l’affermazione di una qualità avvertita come altrettanto “necessaria” .
Se la prima linea risulta maggioritaria in questa Biennale che ha il suo epicentro ideale nell’America Latina , le altre due forse sono , per molti motivi, più significative. L’emergenza in qualche modo è per sua natura eroica e drammatica: richiama la violenza dei conflitti etici, religiosi, sociali, la pressione delle migrazioni, l’ingiustizia insopportabile delle diseguaglianze tra nord e sud del mondo. Richiede soluzioni semplici e forti, ma legate a una condizione temporanea che difficilmente possiamo immaginare di stabilizzare in una condizione di lungo termine.
Sull’altro fronte invece , la gestione dell’ordinario non è mai eroica, richiede pazienza e negoziazione, e molto spesso non sente il bisogno del talento dell’architetto costringendolo anzi a fare più di un passo indietro: per usare la metafora del fronte, lavora in seconda linea in una guerriglia di resistenza per l’affermazione di diritti negati, di equità sempre elusa, di revoca della ghigliottina del Capitale.
Ma esiste anche un’altra linea, quelle delle piccole cose, spesso rappresentata da progetti a scala ridotta, ma sempre contrassegnata dal desiderio di trasformare l’ordinario in esemplare: l’università di Lima di Yvonne Farrell e Shelley MacNamara( Grafton architects) – un budget “sociale” per un’architettura veramente eroica per le sue prestazioni luminose, spaziali, ambientali - ; le scuole in Veneto di Cappai e Segantini che sostengono la natura collettiva e pubblica degli spazi per l’educazione; la scontrosa navigazione controcorrente di Giuseppina Cannizzo in Sicilia, con la sua quotidiana pratica di piccoli progetti trasformati in grandi architetture; l’ostinazione di Luigi Snozzi nel rivendicare il primato del collettivo nella definizione della città; le agopunture di Mazzanti negli slums sudamericani, gli interventi misurati di Barozzi-Vega in Europa, l’eroismo minimalista di Francis Kerè nel pathos del suo costante confronto tra Europa e Africa, eccetara.
Esperienze disseminate negli spazi di confine di questa Biennale, che invitano il visitatore a riflettere sulle necessari età dell’architettura nonostante tutto. È in questi interstizi che l’esposizione veneziana si rappresenta più stimolante e riflessiva, resistente alla fastidiosa ( e talvolta grottesca) estetizzazione dell’etica e alla sua neutralizzazione nell’ennesimo slogan del momento.
Un percorso fra i padiglioni della 13/ma Mostra dell'Architettura, incontrando il Venezuela attento alla collettività e la visionarietà degli Stati Uniti». Il manifesto, 28 maggio 2016, con postilla (p.s.)
Il fronte dell’architettura non riparte dal padiglione Italia, curato da Tam associati, in quanto nella definizione immaginata dal curatore della Biennale, Alejandro Aravena, l’architettura deve essere un mezzo per risolvere questioni complesse come i problemi delle periferie, dell’abitare in condizioni migliori, di progettare spazi per l’aggregazione sociale. Tutti temi che non rientrano nelle ricerche attuate dagli architetti italiani tanto meno nell’agenda politica. E questo nonostante l’architettura sia una disciplina che ha molto da dire sia sul riuso degli edifici esistenti nei centri storici, sia sul recupero sociale e architettonico dei quartieri periferici.
L’immersione totale in immagini, suoni, parole, display espositivi, subìti dai visitatori della Biennale veneziana, impone una riflessione sulla condizione dell’architettura oggi nei confronti della società. Ciò che emerge dai padiglioni nazionali, solitamente più interessanti della mostra internazionale, è invece una disomogeneità e ambiguità rispetto al tema scelto da Aravena. In molti casi, l’architettura non viene presentata come una possibilità concreta di migliorare le condizioni di vita delle persone, dalle megalopoli ai piccoli villaggi, bensì proiettando immaginari privi di ogni relazione con i temi attuali del dibattito politico internazionale ed europeo.
Nessun padiglione ha immaginato, ad esempio, come risolvere il problema dei campi di accoglienza, pianificando una strategia urbana e pensando forme di insediamento temporanee, come è accaduto a Calais con la tendopoli improvvisata dai migranti. L’Europa istituzionale e culturale dimostra un profondo disinteresse verso la capacità dell’architettura di risolvere alcune primarie esigenze come l’abitare dei migranti.
In parte, l’Austria ha cercato di raccontare, attraverso la fotografia, il processo di riuso di abitazioni esistenti da parte dei migranti, ponendosi in contrasto con le azioni governative, ma con un allestimento che non rende appieno il senso del progetto. È il padiglione del Venezuela, invece, ad imporsi come uno dei più attenti alla collettività. Risponde meglio di altri alla questione cardine: quale sia oggi il fronte dell’architettura, nonostante la complessa situazione politica che lo sta scuotendo.
Curato da Rolando Gonzalez, presenta quindici progetti che sono raccontati attraverso più temi: le politiche del territorio, l’architettura come elemento fondativo, la democrazia della conoscenza, la costruzione di un paesaggio, la governance e l’organizzazione collettiva. Nella maggior parte, si tratta di micro architetture costruite all’interno delle favelas – dai campi per le attività sportive a piccole piazze, fino agli spazi ludici per i ragazzi, tutti caratterizzati da una tecnologia povera in tubi di acciaio coloratissimi, da cui gli architetti «impegnati» italiani dovrebbero imparare.
Il padiglione degli Stati uniti, curato da Monica Ponce de Leon e Cynthia Davidson, risponde in modo visionario al fronte contemporaneo della progettualità. La scelta di indagare Detroit, la città industriale di Henry Ford e della casa discografica Motown, pone la questione del riuso delle aree industriali attraverso lo sguardo visionario e formalista dei dodici architetti invitati.
Greg Lynn, Andrew Zago, Present Future, Stan Allen, A (n) Office, Marshall Brown Projects sono solo alcuni degli architetti che hanno lavorato su quattro aree. «Il tipo di fronte dell’architettura che noi abbiamo immaginato – spiega Davidson – non è la nostalgia verso il passato di città industriale, ma il futuro. Crediamo nel potere dell’architettura per cambiare le cose. Non vogliamo costruire edifici ma un immaginario pubblico. Per ogni sito – continua Ponce de Leon – abbiamo chiesto agli architetti di lavorare con le comunità e con le organizzazioni no profit attivando un dibattito».
Indubbiamente, la scelta di un tema unico coincidente con una città industriale in profonda crisi, rafforza il legame tra il titolo del padiglione The Architecture Imagination e quello della Biennale Reporting from the front, affermando quanto sia necessario fornire ai cittadini una visione che li proietti nel futuro.
Il caso Detroit è analogo a Ivrea (incomparabili per le loro dimensioni), differente è la scelta per rinnovarsi. Se la città americana punta sulla trasformazione urbana attraverso l’architettura, Ivrea, la città di Adriano Olivetti, cerca il rinnovamento attraverso il riconoscimento Unesco come città industriale del XX secolo, non attivando nessun processo di rigenerazione urbana.
postilla
Finalmente qualcuno che non si dichiara entusiasta del padiglione italiano.
A proposito dei campi di accoglienza dei migranti bisognerebbe ricordare che la scelta dei curatori dei padiglioni nazionali è sempre occasione di conflitti e compromessi e che, nel caso particolare della Francia, la proposta dell’organizzazione PEROU di esporre i loro progetti per la Giungla di Calais è stata scartata dal governo. Ieri i rappresentati del gruppo PEROU hanno civilmente manifestato il loro dissenso di fronte al padiglione dal quale sono stati esclusi, ma i reporters embedded non se ne sono accorti.
A proposito di esclusi, va anche ricordato che le proposte degli architetti americani che da anni lavorano con i cittadini e le comunità più colpite dalla deliberata distruzione delle industrie di Detroit non sono state accolte nel padiglione americano, dove sono invece esposte una serie di soluzioni forse “immaginifiche”, ma certamente non costruite dal basso”. Come ha denunciato l’organizzazione Detroit Resists: “il padiglione è strutturalmente inadeguato ad affrontare la catastrofe di Detroit e collabora alla distruzione in corso della città”.

«Ancora una panoramica sulla Mostra dell'Architettura di Venezia Un’indagine, quasi da imprenditore, sullo stato delle città». Ma è proprio vero che gli architetti abbiano difficoltà a rispondere, in modo adeguato, alle contraddizioni dell’economia globale di mercato» ? Il manifesto, 28 maggio 2016 con postilla (p.s.)
La Mostra di Architettura di Venezia ha ospitato negli ultimi dieci anni critici come Dejan Sudic, storici, Kurt W.Foster, professori della London School of Economics, Richard Burdett e, naturalmente, architetti, Kazuyo Sejima, David Chipperfield, Rem Koolhaas, ma è la prima volta che in Laguna fa la sua comparsa un architetto-imprenditore: il cileno Alejandro Aravena.
Nulla di cui stupirsi perché l’istituzione veneziana predilige chi può garantire al meglio il successo mediatico della manifestazione e il cileno, vincitore quest’anno del Pritzker Prize, dopo sette anni nella giuria del famoso riconoscimento, è stato ritenuto il più adatto ad assolvere questo compito.
La fama non l’ha conquistata per l’Innovation Center Uc Anacleto Angelini a Santiago o il Centro Culturale di Constitución (entrambi del 2014) e neppure per i dormitori per l’Università di St. Edward a Austin, in Texas (2008), opere che sono un combinato di geometria e tettonica com’è la tendenza in molta architettura contemporanea. La notorietà gli è stata procurata dal suo progetto Elemental, una soluzione che è apparsa a molti originale perché idonea a garantire un alloggio sociale in mancanza di risorse economiche.
Il progetto consiste nell’applicazione in ciò che Aravena definisce la «logica riduttiva» (lógica reduccionista). Con lo slogan «mezza casa buona non è uguale a una casa piccola» egli propone, con la sua impresa Elemental S.A. – della quale è direttore esecutivo mentre azionisti sono con lui la società petrolifera Copec e l’Università Cattolica – la costruzione, per nucleo familiare, di soli quaranta mq. degli ottanta necessari, lasciando i restanti all’autocostruzione.
Verso l’housing
È in questo modo che in varie località del Cile sono stati realizzati migliaia di alloggi. Si presentano aggregati in stecche di tre livelli con una porzione disegnata e una da completare, che sarà costruita successivamente dai proprietari, diversa da quella dell’architetto per materiali e colori. Il risultato sono monotoni parallelepipedi che fanno rimpiangere le tipologie in linea multipiano del modernismo.
Ha scritto sul sito madrileno Arkrit (www. dpa-etsam.aq.upm.es/gi/arkrit/), Fabián Barros (La desigualdad es elemental) che l’espediente è paragonabile a «un medico che decide di dare la metà di un trattamento vitale contro una malattia; l’altra metà dipenderà dallo sforzo dei più poveri».
Per Aravena è così che l’housing riesce a trasformarsi in «investimento e non solo in una mera spesa sociale» come recita un capitolo del suo manuale (Hatje Cantz, 2012) al quale rimandiamo per comprendere, in tutti i suoi dettagli, in cosa consiste l’architettura che lo ha reso famoso: dal primo insediamento Quinta Monroy a Iquique ai masterplan per Constitución o Calama. Torniamo, però, alla mostra veneziana e all’Arsenale, il suo centro, perché proprio descrivendola attraverso i partecipanti invitati dall’architetto cileno si può comprendere meglio il significato del titolo, Reporting from the front.
Il «fronte» è quello della città, che produce disuguaglianze, del paesaggio naturale che continua essere a rischio, delle aree rurali che si impoveriscono lì dove non trovano investimenti sufficienti a svilupparle.
La più politica delle arti
Aravena usa la metafora dell’archeologa fotografata da Chatwin su una scala per guardare dall’alto le linee Nazca sul suolo per dimostrare che la soluzione ai gravi problemi che l’umanità ancora sopporta non è questione di scarsità di mezzi ma di «inventiva», non di squilibrata distribuzione della ricchezza ma di creativà.
L’altra componente che insieme all’invenzione serve a legittimare la sua architettura (ma anche quella di altri) è la «pertinenza», ossia la critica all’«abbondanza»: l’archeologa avrebbe potuto utilizzare altri mezzi, ma (non si comprende il perché) «avrebbe distrutto l’oggetto del suo studio». Tuttavia, per assecondare la tesi che l’architettura è «la più politica delle arti» (Baratta) – dalla quale si evince che chi se ne occupa sia il più politico dei professionisti – e che necessita occuparsene a dovere, ecco le nuove narrazioni proposte da Aravena.
La rassegna miscela con sapienza e astuzia progetti di architettura vernacolare (Anna Heringer in Balgladesh) con esemplari case study (la ricerca di Rahul Mehrotra a Kumbh Mela sull’insediamento «effimero» per sette milioni di abitanti), stravaganti progetti per la metropoli (Spbr Arquitetos a San Paolo con la loro megastruttura per il parco Ibirapuera) con edifici di un ingenuo formalismo (Bernaskoni a Mosca), buona pratiche rientranti nell’ordine della sostenibilità ambientale (Al Borde in Ecuador o Amateur Architecture a Fuyang) con altre invasive e incongrue (51N4E in Albania). Il risultato è uno spaccato che chiarisce in modo netto lo stato di difficoltà che l’architettura vive nel rispondere in modo adeguato e coerente alle contraddizioni dell’economia globale di mercato.
Poche le esperienze capaci di incidere nella scala planetaria della povertà o nelle contraddizioni della città capitalista. Meritevoli di riflessione ci sono quelle esposte nei diversi progetti nei padiglioni stranieri e per una volta il Padiglione Italia con il progetto Taking Care di TAMassociati che sarà nostro impegno seguire nei suoi sviluppi futuri.
Tam associati Urbanizzazione diffusa
Molte sono le presenze di giovani architetti con opere interessanti in aree povere del mondo, come il tedesco Manuel Herz con il suo insediamento temporaneo per profughi fatto di tende e fango nel Sahara Occidentale, i paraguaiani del Gabinete de Arquitectura, artefici nell’uso di tecniche e materiali low-tech, come i loro colleghi iraniani di VAVStudio o i cileni Elton Léniz con le loro aule all’aperto sulle Ande.
Si collocano accanto a loro architetti più famosi e conosciuti come Francis Kéré già impegnato in Burkina Faso con programmi di scuole e adesso con la prestigiosa sede del Parlamento, i giapponesi Sanaa (Sejima e Nishizawa) e Atelier Bow-Wow dalla raffinata ricerca minimalista sull’abitare, il ticinese Snozzi con la sua straordinara prova, seppur datata, di Monte Carasso.
Non ci è possibile soffermarci oltre sui partecipanti alla mostra.
Interessa qui solo rilevare che, insieme a processi democratici in atto in molti paesi – dove l’architettura è strumento di critica e di socializzazione e dove si stanno costruendo luoghi e spazi migliori per le persone – al tempo stesso mai come oggi sono frustrate le possibilità di cambiamento con l’aumento del disagio e della sofferenza per milioni di loro. Sappiamo che per l’architettura non ci sono modelli urbani ai quali ispirarsi, ma dovunque è possibile individuare una urbanizzazione diffusa, banale, segregante.
Tra queste contraddizioni, gli architetti dovranno ancora per lungo tempo muoversi. L’augurio è che sappiano dare risposte concrete agli esclusi e combattere l’autoritarismo urbano, già così pericolosamente presente.
postilla
Nell’articolo si parla dello «stato di difficoltà che l’architettura vive nel rispondere in modo adeguato e coerente alle contraddizioni dell’economia globale di mercato». In realtà l’architettura come professione e la maggior parte degli architetti (almeno quelli non disoccupati) sono perfettamente adatti e coerenti alle leggi del mercato e si adeguano rapidamente alle sue parole d’ordine, come dimostrano la maggior parte degli invitati di Aravena. Oggi il motto è convincere gli elettori ed i consumatori che i problemi del mondo possono essere affrontati con soluzioni tecniche e/o di design, in modo che nello stesso giorno in cui si ha notizia nuovi naufragi e morti in mare, Renzi possa inaugurare quella che il giornale locale intitola “la Biennale dell’accoglienza” (p.s.)
edizione della Biennale di Architettura di Venezia. Potente macchina al servizio degli investitori immobiliari
1.
Preceduta da una martellante campagna pubblicitaria tesa ad accreditarne la vocazione umanitaria, è finalmente aperta la quindicesima edizione della Biennale di Architettura di Venezia. Potente macchina al servizio degli investitori immobiliari e degli sviluppatori del territorio, la Biennale è molto abile nel cogliere le parole d’ordine e gli slogan del momento e trasformarli in spettacolari eventi che catturano masse di visitatori, per la gioia del ministro Franceschini che, dove vede gente in coda, vede cultura.
Già nelle ultime edizioni, i titoli evocavano nobili principi ed aspirazioni; basti ricordare “common ground” o “l’architettura incontra la gente” inventato da Kazuyo Sejima che dichiarò di volere «un luogo d’incontro fra i cittadini e l’architettura e non una vetrina di archistar», ma la scelta di quest’anno è particolarmente astuta. La metafora bellica, infatti, non solo è appropriata alla situazione del mondo, dove le guerre scatenate dal neo imperialismo sono una condizione permanente, ma suscita l’idea che gli architetti siano al fronte e combattano per “la parte giusta”, senza peraltro indicare chi è il nemico e chi sono gli alleati. Il frequente ricorso nei proclami diramati dalla Biennale ad alcune parole chiave -migrazioni, catastrofi, casa, inquinamento, diseguaglianze, traffico, rifiuti, spreco, criminalità- dovrebbe chiarire “perché si combatte”, ma in realtà nulla dice sugli “opposti schieramenti” che si fronteggiano . Inoltre, come osserva il Financial Times nell’articolo Biennale: architects’social conscience, attribuire agli architetti la capacità di risolvere i problemi del mondo “con eleganti soluzioni da riprodurre su scala industriale” distoglie l’attenzione dalle cause dei problemi.
2.
Le risposte dei vari padiglioni sono molto diverse, come diversi sono i fronti sui quali si combattono le battaglie che ogni paese ha deciso di documentare.
2.1 Alcuni seguono in modo esplicito il filone sempre più corposo dell’architettura umanitaria, che non è più delegata a volontari e ad associazioni senza scopo di lucro (Architects sans Frontières, Architecture for Humanity), ma è ormai diventata oggetto di corsi universitari e conferenze internazionali. A consacrare l’architettura umanitaria provvederà, il prossimo ottobre, una grande esposizione al MoMa di New York dal titolo “Insecurities. Tracing Displacement and Shelter” dedicata ai modi con i quali “architettura e design hanno affrontato la nozione di shelter vista attraverso le lenti delle migrazioni e l’emergenza globale dei rifugiati” e dove sarà possibile, tra l’altro, ammirare Better Shelter, il prototipo di casetta per rifugiati messo a punto e prodotto dall’IKEA e già adottato, e acquistato, dalle Nazioni Unite.
Ovviamente, nei tentativi degli architetti di “far del bene” non c’è di per sé niente di sbagliato, il che vale per qualunque persona o professione, ma il messaggio che iniziative di questo tipo diffondono, e che si può riassumere con la formula “making markets working for aid”, dovrebbe essere criticamente analizzato, così come dovrebbe essere messa in discussione la tendenza ad affrontare la cosiddetta crisi dei rifugiati come un problema di design.
Dell’accoglienza dei migranti e dei rifugiati si occupano i padiglioni della Finlandia “Housing for asylum seekers”, della Germania “Making Heimat” e dell’Austria “Places for people” (titolo che intende essere anche un omaggio all’opera di Bernard Rudofsky ), che espongono una serie di esperimenti per dare un tetto alle migliaia di persone che ne hanno disperato bisogno.
In alcuni casi si tratta di singoli edifici espressamente pensati per la “categoria” degli immigrati, ma non mancano i progettisti che, assieme alle istituzioni per le quali lavorano, hanno la consapevolezza della inevitabilità di un ripensamento complessivo delle nostre città. Non a caso la Germania, che già l’anno scorso, alla Biennale d’arte, aveva dedicato una parte del padiglione a documentare la condizione dei rifugiati in Germania, ha chiamato come consulente Doug Saunders, il giornalista canadese autore di Arrival City.
Finlandia, Germania e Austria sono tre paesi europei alfieri dell’austerità ed i cui governi hanno adottato politiche contro i migranti, ma almeno ne parlano. Stridente è il contrasto con il padiglione della Francia, dove la proposta di PEROU, un’organizzazione presieduta da Gilles Clement, di esporre il loro lavoro e il loro progetto per la “Giungla di Calais” è stata scartata a vantaggio di un progetto più “neutrale”.
2.2. Un secondo fronte è quello della casa e dei tentativi di migliorare le condizioni di vita degli abitanti agendo sul tessuto fisico delle parti di città più “svantaggiate”.
Il padiglione del Venezuela è interamente dedicato a interventi nelle favelas di Caracas e di altri grandi centri urbani e in quello del Messico sono documentate esperienze di cooperative sociali e di partecipazione.
Anche nei padiglioni degli Emirati Arabi e della Cina, che pur non fanno espliciti riferimenti alle “lotte per la casa”, è possibile leggere l’evoluzione delle tipologie abitative e la “modernizzazione” degli insediamenti come indicatori dell’ingiustizia sociale e del conflitto fra profitto e diritti dei cittadini che sono sempre alla base della cosiddetta questione della casa. “Dignità, benessere, uguaglianza” sono, ad esempio, le priorità individuate dai curatori cinesi come criteri per il loro rapporto dal “fronte ignorato”.
Un approccio auto celebrativo è, invece, quello del Portogallo, che organizza il proprio evento espositivo alla Giudecca, un tempo zona di Venezia a forte densità operaia, dove esistevano una serie di case popolari costruite durante il regime fascista. Quando, negli anni ‘80, gli amministratori locali hanno deciso di trasformare la Giudecca in una sorta di belvedere su San Marco (“è come Brooklyn da dove si vede Manhattan”, dicono le agenzie immobiliari), gli abitanti sono stati cacciati, gli edifici sono stati demoliti e al loro posto sono sorte delle costruzioni firmate dai più famosi architetti del momento, da Aldo Rossi ad Alvaro Siza. Ora, Siza è richiamato sul campo di battaglia per raccontare come un’area “di degrado” è diventata un indirizzo di prestigio. Un caso da manuale degli effetti perversi della rivitalizzazione urbana che dimostra come, anche sul fronte della casa, le truppe di occupazione ed i loro architetti non solo distruggono territori e comunità, ma riscrivono la storia.
2.3 Il conflitto per il possesso e lo sfruttamento delle risorse ambientali è il fronte indagato nel padiglione del Peru, che lega la salvezza della foresta all’educazione di massa, e del Cile con una serie di affascinanti progetti che fanno “molto con poco” in zone rurali.
Ad una esplicita denuncia dell’imperialismo ambientale è dedicata anche Extraction, l’installazione del Canada, un’opera di land art che lega politiche globali ed effetti locali. Realizzata all’esterno del padiglione nazionale, che è stato chiuso per restauri, o come si dice, perché il governo canadese non ha apprezzato l’approccio del curatore, consiste in un buco nel terreno situato nel punto mediano tra i padiglioni di Francia, Gran Bretagna e Germania, attraverso il quale il visitatore vede un filmato che documenta la rete di interessi economici che controlla e coordina le attività minerarie del Canada in ogni parte del mondo ed il loro impatto devastante.
3.
I padiglioni nazionali offrono spunti di riflessione più articolati rispetto al padiglione generale, le cui postazioni sono presidiate da una batteria di prestigiosi invitati “a prescindere” - qualunque sia il tema o il titolo, loro ci sono - fra i quali i precedenti direttori della Biennale e tutti i campioni della “scuderia” Rolex (in molti casi le due caratteristiche coincidono) che, per le tre edizioni del 2014-2016-2018, è sponsor unico della Biennale.
Da Kazujo Sejima, che ha costruito il Rolex Learning Centre a Peter Zumthor e David Chipperfield che fanno parte del gruppo dei “mentori per l’arte e l’architettura” creato dalla ditta a scopo benefico, tutti sono in scena alla Biennale.
Il fatto che Rolex, come tutti i grandi marchi del lusso, non solo faccia costruire le proprie sedi dalle archistar, ma le usi come testimonials per i propri prodotti è una ulteriore conferma di quanto dice Renier de Graaf, associato dello studio OMA: «oggi l’architettura è uno strumento del capitale» (“architecture is a tool of capital, complicit in a purpose antitetical to its social mission”, Architectural Review, aprile2015).
Il risultato è che architetti che effettivamente si propongono di migliorare le condizioni di vita delle persone che si serviranno dei loro progetti vengono affiancati ad altri che mai hanno visto un campo di battaglia. Il teatrino di palazzo Grassi e la punta della Dogana di Tadao Ando, ad esempio, è collocato tra il lavoro di Rural Studio, un gruppo che da anni lavora e costruisce con le comunità rurali dell’Alabama, e quello dell’indiano Anupama Kundoo che recupera e reinventa tecniche e materiali. Il rischio di trasmettere, così, il messaggio che qualsiasi fronte vada bene, purché sia spettacolare, è evidente.
Nei dispacci dei corrispondenti di lusso in missione per la Biennale si parla solo di vittorie (in battaglie umanitarie, ovviamente) e sono pressoché assenti notizie di vittime, dispersi, “danni collaterali o non intenzionalmente inflitti”.
Tra le poche eccezioni, il gruppo Forensic Architecture che da anni si occupa di disvelare l’uso dell’architettura come strumento di guerra.
Di guerra si occupa anche il padiglione dell’Olanda che interpreta il titolo della mostra in senso letterale. La curatrice, i cui interessi di ricerca si concentrano sullo «spazio pubblico come zona di guerra», analizza Camp Castor la base delle Nazioni Unite che l’Olanda ha costruito e gestisce a Gao in Mali mettendo in luce il significato delle sedicenti missioni di pace e l’inestricabile intreccio tra guerra e sviluppo economico. Bella l’idea di far inaugurare il padiglione da un generale e non da un architetto.
4.
Nel complesso, la Biennale dell’imperialismo umanitario, che il Financial Times definisce la «Biennale post Piketty», ignora alcuni fronti “caldi”. Ad esempio, manca una sezione dedicata a quello che fanno in Grecia gli architetti al servizio degli investitori internazionali e ci sono poche testimonianze dall’Africa.
Degli 88 invitati di Alejandro Aravena solo 4 sono africani (due dei quali sudafricani) e solo quattro paesi africani sono presenti con un loro padiglione: Egitto, Costa d’Avorio, Nigeria e Sud Africa; tutti ricchi e/o ben connessi con la comunità internazionale. Sono scomparsi i padiglioni dei piccoli paesi, come il Rwanda che, qualche anno fa avevano provato ad accedere alla Biennale. Ora il Rwanda compare solo in quanto destinatario di un progetto umanitario di sir Norman Foster: un droneport dove far atterrare gli aiuti internazionali. Manca anche l’Angola, che nel 2012 vinse con il suo padiglione un premio ufficiale della Biennale.
Debordante, invece, e pervasiva la presenza delle grandi e ricche università americane, in particolare il MIT con docenti e ricercatori protagonisti di molti padiglioni e il cui dean è membro della giuria della Biennale.
5.
Ed infine, cosa fanno i comandanti in capo insediati al quartiere generale mentre aspettano i dispacci degli inviati più o meno embedded? Business as usual, come dimostrano i tre progetti speciali sponsorizzati dalla stessa Biennale e che sono dedicati rispettivamente a:
- urbanizzazione sostenibile, un ossimoro caro alla Banca Mondiale e ai suoi accademici, secondo i quali quale sgombrare le terre coltivabili per cederle alle multinazionali e spostare tutti in città è un fenomeno, naturale, inevitabile e benefico per tutti;
- produzione di copie di opere d’arte che si trovano in siti in pericolo a causa di guerre e cambiamenti climatico, in modo da offrire alternative per un pubblico che vuole comunque visitare i siti storici (detto in altre parole fare dei falsi per catturate i turisti);
- e infine il fronte di Marghera. Che il cuore della Biennale batta per Venezia non è una novità. Ogni edizione è servita a promuovere una o più interventi che nel loro insieme hanno trasformato la città in una dependance della Biennale (vedi Mercanti in fiera, edizioni Corte del Fontego, 2014). Ora che il centro e le isole sono state conquistate, il fronte si è spostato in terraferma.
Di Marghera si occupa anche il padiglione Venezia con un progetto fortemente voluto dal sindaco Brugnaro che, col motto “Up Marghera”, intende promuovere la verticalizzazione della gronda lagunare e della terraferma per trasformare Marghera in “una nuova Manhattan e revitalizzare Venezia e l’Italia”, consentendo (niente di nuovo sul fronte occidentale!) lauti affari ai profittatori di guerra.
eddyburg contribuirà a scoprirlo, nei prossimi mesi, non solo nel padiglione italiano. La Repubblica, 26 maggio 2016
Quanti sono i fronti sui quali si misura l’architettura che contribuisce con i propri mezzi a ridurre le disuguaglianze, a mitigare sofferenze e disagi? Tanti, secondo Alejandro Aravena, il curatore cileno della quindicesima Biennale che ora apre i battenti nei Giardini e all’Arsenale. Sono tanti e abbracciano ambiti diversi e diverse scale, diversi continenti, toccano anche l’Italia, con l’architettura che resta architettura («L’architettura è occuparsi di dare forma ai luoghi in cui viviamo », si legge nella prima sala del padiglione centrale ai Giardini), ma mette al bando lo spettacolo di sé. L’esposizione dà concreta attuazione ai propositi di Aravena, che potevano limitarsi a essere tali o rischiare un indeterminato scivolamento verso altre discipline, dalla sociologia all’antropologia, con le quali invece l’architettura coopera, rimanendo, appunto, se stessa.
In Reporting from the front sfilano tanti esempi, interventi realizzati più che progettati. Come la funicolare che il colombiano Giancarlo Mazzanti ha costruito a Medellin, un tempo capitale del narcotraffico, funicolare che insieme a impianti igienici, elettricità, linee telefoniche, conduce a una biblioteca: un complesso di infrastrutture, tutt’altro che Grandi Opere, che hanno ridotto il senso di esclusione, aiutando persino con le forme ardite della biblioteca a limitare il reclutamento dei cartelli della droga. O come le iniziative a Durban in Sudafrica, dove un gigantesco e insicuro mercato è stato trasformato in un luogo di vivacità culturale.
Gli esempi si moltiplicano, spaziano dall’Iran a Parigi, dal Vietnam al Bangladesh. C’è molto Sudamerica, molti materiali poveri e di riuso, tecniche che si raffinano nell’indigenza. Il cuore della rassegna è lo sterminato disagio urbano, sono le periferie metropolitane e le periferie del mondo. Sono i conflitti. Come quelli che documenta la Forensic Architecture dell’israeliano Eyal Weizman: l’analisi del video di un bombardamento in Afghanistan che dimostra, esaminando le strutture edilizie, come la distruzione di un palazzo sia stata l’effetto dell’attacco di un drone e non dell’esplosione di ordigni lì custoditi. Ma accanto alle grandi anche le minute dimensioni – le zanzare contro il rinoceronte, le chiama Aravena: i piccoli appartamenti della siciliana Giuseppina Grasso Cannizzo, «uno sciame capace di sconfiggere le forze voraci che imperversano nella aree urbane», spiega l’architetto cileno. E non mancano alcune grandi firme, da Richard Rogers a Renzo Piano, da David Chipperfield a Eduardo Souto de Moura, convocati non per esibire luminosi grattacieli, ma anche loro per mostrare come una spiccata capacità iconica può servire scopi sociali, dalla periferia di Catania al Sudan.
La proposta di Aravena si arricchisce con il padiglione Italia, curato dalla TamAssociati di Massimo Lepore, Raul Pantaleo e Simone Sfriso. Taking care, il titolo della rassegna sostenuta dalla Direzione generale Arte e Architettura contemporanee del Mibact. Anche qui le espressioni chiave – periferie, associazionismo, beni comuni – non vagano in un cielo di stellata retorica, ma si muovono sulle gambe di realizzazioni avvenute. Anche piccole, disperse e puntuali, ma, insistono i curatori, capaci di mostrare gli effetti «di un’architettura metabolica, che assorbe risorse per farne crescere altre». A Casal di Principe la casa di un boss della camorra è stata rivestita di tubi innocenti e la rete rossa di cantiere lascia intravedere i segni di un’estetica pacchiana. L’interno poi è stato attrezzato per ospitare le opere seicentesche provenienti dagli Uffizi. A Milano, nel quartiere popolare Gratosoglio, l’ufficio tecnico dell’assessorato allo sport ha realizzato insieme a un’associazione di skaters il Gratobowl, una pista che non è solo una palestra per esibizioni spettacolari, ma uno spazio pubblico e di convivenza. E poi c’è il Teatro sociale di Gualtieri, a Reggio Emilia, abbandonato, restaurato e riaperto. C’è la restituzione ai palermitani del lungomare di Balestrate. C’è la rigenerazione di diversi isolati del centro storico di Favara (Agrigento), trasformati in gallerie d’arte, uffici co-working, residenze per artisti. Oppure il parco dei Paduli, in provincia di Lecce, dove si coltivano olive pregiatissime e si fa manutenzione del paesaggio.
La rassegna veneziana vorrebbe mettere in relazione questi mondi, ormai rintracciabili in molte regioni italiane, comprese quelle meridionali, ma ancora polverizzati e non si sa quanto portatori di esperienze replicabili. Entrano in gioco fattori imponenti – basti pensare ai quartieri pubblici, agli insediamenti abusivi del centro-sud, alle lottizzazioni private con i centri commerciali, cioè a tutte le realtà che vanno sotto il troppo uniforme termine di periferia urbana. Accanto agli interventi esemplari, dal padiglione Italia partono anche cinque progetti, cinque camion progettati da altrettanti studi e affidati a cinque associazioni (Legambiente, Emergency, Uisp, Aib e Libera) che da Ponticelli a Cerignola, dal torinese Parco Dora al Casilino di Roma, si proporranno come presidi di qualità ambientale e sanitaria, di iniziative per lo sport, la lettura e la legalità. Anche la confezione della mostra ribalta uno stereotipo, quello comunicativo, dentro il quale si arroccano molte parole dell’architettura. L’intera grafica e il catalogo (Becco Giallo) utilizzano il graphic novel, linguaggi e forme visive aderenti a un modo diverso di fare e raccontare l’architettura.