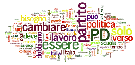 Estratto dell’intervento dell’autore al "Festival del diritto" a Piacenza; quest’anno il tema su cui studiosi di varie discipline si stanno confrontando è quello della dignità. La
Estratto dell’intervento dell’autore al "Festival del diritto" a Piacenza; quest’anno il tema su cui studiosi di varie discipline si stanno confrontando è quello della dignità. La Repubblica
, 24 settembre 2016 (c.m.c.)
C’e' una piccola frase, apparentemente alquanto banale, in La sera del dì di festa di Giacomo Leopardi che dice «tutto al mondo passa e quasi orma non lascia». Desidero richiamare l’attenzione su quel “quasi”. Certo, la vita e le nostre opere sono effimere, ma non del tutto. C’è un residuo, il “quasi”, che resta, che si accumula e che forma ciò che chiamiamo umanità, un termine che può tradursi in cultura: il deposito delle esperienze che vengono da lontano e preparano il futuro, un deposito al quale tutti noi, in misura più o meno grande, partecipiamo. O, meglio: dobbiamo poter partecipare. Altrimenti, siamo fuori della umanità.
Per questo, troviamo qui il primo, il primordiale diritto, che condiziona tutti gli altri. La violazione di questo diritto equivale all’annientamento del valore della persona, alla sua riduzione a zero, a insignificanza.
Eppure, viviamo in un mondo nel quale non è nemmeno possibile stabilire con precisione quanti sono gli esseri umani che non conoscono questo elementare diritto che possiamo chiamare “diritto al segno” o, leopardianamente, “diritto all’orma”.
Si misurano a milioni, cioè a numeri approssimativi, senza che — ovviamente — a questi numeri possano associarsi nomi. Milioni di anonimi, che giungono a noi come fantasmi, mentre le loro sono esistenze concrete, anche se durano spesso lo spazio d’un mattino o di pochi mattini, consumandosi in fretta in condizioni disumane, in luoghi dove la lotta per la mera sopravvivenza
materiale sopravanza qualunque possibilità di relazioni, dove i neonati vengono al mondo sotto la maledizione di leggi statistiche che li condannano alla sparizione entro pochi giorni o settimane di vita.
Ciò che ci interpella inderogabilmente è che non possiamo dire, come forse si sarebbe potuto un tempo, nel mondo diviso per aree, storie, politiche separate e indipendenti le une dalle altre: sono fatti loro, loro è la responsabilità, il nostro mondo non è il loro, ognuno pensi per sé alle proprie tragedie. Non possiamo dirlo, perché il mondo, come ci ripetiamo tutti i momenti, è diventato uno solo, grande, globale. Noi, in un tale mondo, osiamo parlare kantianamente, senza arrossire, di “dignità” come universale diritto al rispetto. Il “diritto all’orma” detto sopra è legato a tutti gli altri diritti come loro premessa e condizione: è davvero quello che è stato definito da Hannah Arendt, con una formula che ha avuto successo (Rodotà), il “diritto di avere diritti”.
C’è un diritto che potremmo dire essere un altro modo d’indicare il diritto di avere diritti, ed è il diritto al nome: un diritto al quale i trattati di diritto costituzionale, se non l’ignorano, dedicano poche righe. La nostra Costituzione, all’art. 22, tra i diritti umani fondamentali stabilisce che nessuno può essere privato del suo nome perché i Costituenti sapevano il valore di quel che dicevano. “Nominando” si specifica, si riconosce, si creano le premesse per creare un rapporto.
Questo non accade, oggi, alle centinaia di migliaia e, in prospettiva, dei milioni di migranti che sono, per noi, milioni non solo di senza nome, ma anche di senza terra. «Quel che è senza precedenti — scriveva Arendt con riguardo alla tragedia del suo popolo negli anni ’30 e ’40 del Novecento — non è la perdita della patria, ma l’impossibilità di trovarne una nuova». Tale impossibilità, allora, era determinata dalle politiche razziali e colpiva comunità umane determinate. Oggi, deriva dalla condizione generale del mondo saturo globalizzato.
Questa situazione estrema è la sorte delle persone private dei diritti umani. I diritti umani sono una realtà per chi sta sopra, e il contrario per chi sta sotto. Lo stesso, per la dignità. Per chi sta sopra, le rivendicazioni di chi sta sotto e chiede di emergere all’onor del mondo sono attentati allo standard di vita “dignitoso” di chi sta sopra. Quando si chiede lo sgombero dei migranti che intasano le stazioni, dormono nei parchi pubblici e puzzano, non si dice forse che danno uno spettacolo non dignitoso? Ma, dignità secondo chi? Non secondo i migranti, che della dignità non sanno che farsene, ma secondo noi che da lontano li guardiamo.
Ci sono parole, dunque, che non valgono nello stesso modo per i divites e gli inanes. Si dovrebbe procedere da questa constatazione per un onesto discorso realistico e riconoscere che le parole che hanno valore politico non sono neutre. Servono, non significano; sono strumenti e il loro significato cambia a seconda del punto di vista di chi le usa; a seconda, cioè, che siano pronunciate da chi sta (o si mette) in basso o da chi sta (o si mette) in alto nella piramide sociale. Occorre, perciò, diffidare delle parole e dei concetti politici astratti. Assunti come assoluti e universali, producono coscienze false e ingenue, se non anche insincere e corrotte.
Potremmo esemplificare questa legge del discorso politico parlando di democrazia, governo, “governabilità”, libertà, uguaglianza, integrazione, ecc. e di diritti e dignità. Si prenda “democrazia”: per coloro che stanno sopra e hanno vinto una competizione elettorale, significa autorizzazione a fare quello che vogliono; per coloro che stanno sotto e sono stati vinti, significa pretesa di rispetto e di riconoscimento: fare e non fare; prepotenza e resistenza. Oppure “politica”: forza sopraffattrice dal punto di vista dei forti, come quando la si usa in espressioni come “politica di espansione”, “politica coloniale”, “politica razziale”, “politica demografica”; oppure, esperienza di convivenza, coinvolgimento e inclusione sociale. Oppure ancora: la (ricerca della) “felicità”.
Oggi, sono i potenti che rivendicano la propria felicità come diritto, la praticano e la esibiscono come stile di vita, quasi sempre osceno e offensivo. Ma non sentiremo un disoccupato, un lavoratore schiacciato dai debiti, un genitore abbandonato a se stesso con un figlio disabile, un migrante senza dimora, un individuo oppresso dai debiti e strangolato dagli strozzini, uno sfrattato che non ha pietra su cui posare il ca- po, una madre che vede il suo bambino senza nome morire di fame: non li sentiremmo rivendicare un loro diritto alla “felicità”. Sarebbe grottesco. Sentiremo questo eterogeneo popolo degli esclusi e dei sofferenti chiedere non felicità ma giustizia.
Ma, anche la parola giustizia non sfugge alla legge dell’ambiguità. Giustizia rispetto a che cosa? Ai bisogni minimi vitali, come chiederebbero i senza nome e i senza terra; oppure ai meriti, come sostengono i vincenti nella partita della vita? La giustizia degli uni è ingiustizia per gli altri. Si comprende, allora, una verità tanto banale quanto ignorata, nei discorsi politici e dei politici: se si trascura il punto di vista dal quale si guardano i problemi di cui ci siamo occupati e si parla genericamente di libertà, diritti, dignità, uguaglianza, giustizia, ecc., si pronunciano parole vuote che producono false coscienze, finiscono per abbellire le pretese dei più forti e vanificano il significato che avrebbero sulla bocca dei più deboli.
Onde, la conclusione potrebbe essere questa: queste belle parole non si prestano a diventare stendardi che mobilitano le coscienze in un moto e in una lotta comuni contro i mali del mondo, per la semplice ragione che ciò che è male per gli uni è bene per gli altri. La vera questione è la divisione tra potenti e impotenti. Tanto più le distanze diminuissero, tanto più l’ambiguità delle parole che usiamo diminuirebbe. Ma, è chiaro, qui il discorso deve finire, perché si deve uscire all’aperto, dove non bastano le parole ma occorrono le azioni.


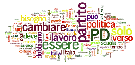 Estratto dell’intervento dell’autore al "Festival del diritto" a Piacenza; quest’anno il tema su cui studiosi di varie discipline si stanno confrontando è quello della dignità. La Repubblica, 24 settembre 2016 (c.m.c.)
Estratto dell’intervento dell’autore al "Festival del diritto" a Piacenza; quest’anno il tema su cui studiosi di varie discipline si stanno confrontando è quello della dignità. La Repubblica, 24 settembre 2016 (c.m.c.)