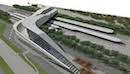Ieri la notizia agghiaccioante del senzatetto bruciato vivo nel suo giaciglio a Palermo, oggi la buona notizia di un'iniziativa promettente a Torino. Noi speriamo che diventi nazionale. la Repubblica online, ed. Torino, 12 marzo 2017
«Chi l’ha detto che i senzatetto non debbano avere diritti?». A porsi la domanda è proprio un senzatetto, una persona che, causa il corso non lineare della vita, ha come casa da un anno e mezzo un dormitorio. «Non siamo in pochi — racconta Marco Mascia, 50 anni — e le condizioni sono diverse: c’è chi sta sotto i portici sopra un cartone giorno e notte, chi entra ed esce dai dormitori, chi cerca riparo nei vagoni parcheggiati delle Ferrovie o nell’atrio delle stazioni. Perché non unire le forze e fare una nostra associazione? », sottolinea Mascia. L’idea prende corpo a Torino dove sta nascendo un’associazione per la tutela e l’autodeterminazione dei senza dimora gestita dai senza dimora.
Un gruppo di senzatetto, che si sta ampliando, grazie al supporto tecnico della Fio.Psd, la Federazione Italiana degli Organismi per le persone senza dimora. La prima iniziativa dell’associazione spontanea che si sta costituendo è la distribuzione di un questionario fra i clochard torinesi per sapere, secondo loro, quali sono i diritti che vanno rivendicati. Base di partenza per arrivare a una carta dei diritti dei senza tetto. «Il questionario è un punto di partenza — racconta il gruppo che sta lavorando al progetto — per scrivere la carta vorremmo aprire un confronto con gli educatori, le cooperative, le associazioni, le istituzioni pubbliche, private e religiose. Ci siamo dati sei mesi di tempo per fare l’associazione e scrivere la carta».
Il questionario, anonimo, servirà per avere una fotografia del fenomeno e capire quali sono i diritti più sentiti dai senzatetto. Ad esempio il diritto alle cure, a scaldarsi, al riparo, alla parola, al reddito minimo, al voto senza una residenza, alla casa subito, al diritto alla scelta del percorso di reinserimento sociale. «E poi c’è uno spazio bianco per lasciare a ciascuno la possibilità di scrivere il diritto che più lo rappresenta», sottolinea Mascia.
L’Istat indica per l’area metropolitana circa 1.800 homeless, ma il numero potrebbe essere anche più alto. A livello nazionale si stima che i senza dimora siano lo 0,2 per cento della popolazione. L’ambizione è che il progetto dell’associazione e della carta dei diritti da Torino si possa esportare a livello nazionale, ma i senzatetto vogliono evitare che qualcuno metta su di loro un cappello. A iniziare dalla politica. «Nel direttivo dell’associazione ci saranno solo senza dimora. E quando si perde lo status si lascerà anche l’associazione», dice Mascia.
Solo chi vive la condizione di barbone, come qualcuno continua a chiamare con disprezzo chi non ha un tetto, può sapere quali sono le necessità. Capire quali diritti rivendicano le persone — secondo i promotori del «sindacato« dei senzatetto — è utile per chi decide poi le politiche di sostegno e aiuto cosa fare. Ci sono senza dimora che rifiutano i percorsi di reinserimento, oppure preferiscono il freddo della notte al letto in un dormitorio. «Forse perché in un dormitorio dovrebbe rispettare alcuni paletti — raccontano — Meglio piccole strutture sparse, che grandi poli». Nei piani dell’Associazione italiana persone senza dimora, questo per ora il nome provvisorio, c’è l’idea di proporre progetti. Il primo riguarda incontri nelle scuole per riuscire a sensibilizzare i ragazzi sui problemi dei senza dimora. Altro progetto è la costituzione di attività commerciali che possano creare posti di lavoro per permettere ai clochard di riprendersi una parte della propria dignità.
 Altro che "chirurgo".Per la prima volta il presidente di una Regione (ma è un leghista) considera l'istituzione come se fosse un'azienda privata, le accolla il rischio d'impresa" e fa pagare il bilancio negativo ai cittadini, dimenticando che non sono azionisti. la Nuova Venezia, 9 marzo 2017 (p.s.)
Altro che "chirurgo".Per la prima volta il presidente di una Regione (ma è un leghista) considera l'istituzione come se fosse un'azienda privata, le accolla il rischio d'impresa" e fa pagare il bilancio negativo ai cittadini, dimenticando che non sono azionisti. la Nuova Venezia, 9 marzo 2017 (p.s.)
Venezia. Si sente come un chirurgo in sala operatoria che deve salvare un paziente in fin di vita e che per questo deve fare ogni manovra possibile, se necessario anche l’amputazione di una gamba. Il governatore Luca Zaia per far vivere la Pedemontana ha messo le mani nelle tasche dei cittadini proponendo il ritorno, a partire dal 2019, dell’addizionale regionale Irpef per i redditi sopra i 28 mila euro.
Questa è la prima addizionale dell’era Zaia, i veneti la capiranno?
«Non è un addizionale coram populo: su 2 milioni 668 mila 997 contribuenti va a pesare solo sulla parte alta e altissima, circa 120 mila persone. La fascia intermedia paga 3 euro al mese; le fasce deboli e quindi pensionati, casalinghe e lavoratori non sono toccati. E il Veneto è ancora fra le prime tre regioni d’Italia quanto a minor pressione fiscale. Ricordo che non ho applicato i ticket della sanità».
Ma così vengono traditi i principi leghisti del federalismo fiscale.
«Nessun tradimento. Il federalismo fiscale, insieme all’autonomia, resta una priorità. Io sono l’antitasse e certo non mi diverto a metterle. Ma un amministratore corretto e perbene, davanti a un problema, deve intervenire. L’approccio è quello del chirurgo che entra in sala operatoria dove c’è un paziente in fin di vita: ha l’obbligo di fare tutto il possibile per salvargli la vita. Lo stesso vale per me con la Pedemontana. C’è invece una minoranza che gode a dire ai familiari che il paziente sta morendo e che è meglio non mettergli le mani addosso».
Certo è che ai veneti viene chiesto un sacrificio.
«Un sacrificio che ci permetterà di completare un cantiere da oltre 2 miliardi. Pensiamo alle conseguenze se l’opera si bloccasse: alle aziende che chiuderebbero, ai lavoratori che resterebbero a casa, agli espropriati che non prenderebbero i soldi, ai costi degli ammortizzatori sociali che dovremmo attivare. Ripeto, si tratta di un sacrificio: io stesso e il consiglio regionale pagheremo mille euro l’anno. Io ho presentato una soluzione innovativa che verrà ripresa a livello nazionale per tutti i project che hanno lo stesso problema: dopodiché il consiglio è sovrano e potrà decidere se procedere o meno».
Ha annunciato che l’addizionale avrà carattere temporaneo. Quanto temporaneo?
«Questa è una tassa di scopo che riguarda la Pedemontana e per una piccola parte i tagli di quest’anno che non riusciamo a riassorbire. Per me si esaurisce col 2019, poi sarà il consiglio a decidere. E, preciso, di tratta di una manovra che può avere aliquote modificate fino a dicembre 2017. Al governo ho chiesto 200 milioni di contributo su questa operazione: se li versasse, il fabbisogno si ridurrebbe e le aliquote cambierebbero».
Potrebbero essere applicate aliquote diverse in rapporto alla prossimità geografica all’opera?
«No perché la Pedemontana è di tutti. Come il Passante».
Ma c’erano alternative all’addizionale?
«No. Il progetto è del 2002, la gara del 2006, l’aggiudicazione del 2009. In virtù di una legge dell’epoca, chi metteva in gara doveva garantire che il traffico ci fosse: il rischio di impresa, insomma, ce l’aveva la Regione. A un certo punto l’impresa non è riuscita a trovare sul mercato i finanziamenti e Cassa Depositi e Prestiti ha detto che lo studio del traffico, con 33 mila veicoli al giorno, non stava in piedi e che era antecrisi. Sono stati rifatti gli studi del traffico, ricalibrati su 27 mila veicoli. A questo punto abbiamo cambiato ragionamento: si è passati da un modello in cui il concessionario guadagna in base ai pedaggi a in base ai flussi del traffico garantiti dalle Regioni, a un modello nuovo in cui il concessionario ha un canone annuale e la Regione incassa i pedaggi. Un modello nuovo che potrebbe essere esportato. Questa è la soluzione proposta, l’alternativa era fermare i lavori e riparlarne tra 10-15 anni, con tutti i contenziosi relativi».
Non bastava intervenire sui pedaggi?
«No, tanto che per arrivare ai 27 mila veicoli abbiamo dovuto anche togliere l’esenzione. Ma c’è un vantaggio: che il pedaggio viene abbassato per tutti, il 23% in meno».
Con gli eventuali guadagni legati ai pedaggi restituirete l’addizionale?
«La restituzione va in servizi. C’è una cosa da ricordare: in realtà questa strada sarebbe già stata completata da tempo».
In che senso? Cos’è successo?
«Nel ’98 c’era già il progetto, si chiamava Autostrada Pedemontana Veneta, c’era il ministero delle Infrastrutture con Nerio Nesi che lo seguiva. Erano previsti diversi svincoli e solo tre barriere; c’era una carreggiata con due corsie per ogni senso di marcia più l’emergenza ed era larga 25 metri. Il mondo ambientalista fece un assalto alla Conferenza dei servizi che si tenne a Castelfranco e protestò vivacemente perché non voleva l’autostrada. Il risultato? La Pedemontana com’è oggi, con i caselli a pagamento, una carreggiata di 24,5 metri e un limite di velocità a 110 anziché a 130. Abbiamo perso i caselli liberi, buttato via un progetto e c’è un’opera che deve essere ancora realizzata».
Parliamo di costi, lievitati.
«Si è detto che si è passati da 800 milioni a 2,2 miliardi: un’eresia. La verità è che è stato fatto il progetto esecutivo, ci sono 300 milioni di espropri e poi tutte le opere dei 35 Comuni che hanno dato il consenso negoziando le opere complementari. Nel piano economico si può leggere quanto costa l’infrastruttura e quanto costano tutte le opere. A pesare è poi il fatto che per circa il 50% del tracciato è in trincea, ci sono 32 gallerie. In ogni caso tutti costi sono documentati, se qualcuno ha notizie che noi non sappiamo, vada in Procura e non infanghi con insinuazioni».
Realisticamente che tempi ci sono?
«Se il consiglio dà corso ai provvedimenti portati, si firma l’accordo che ci permette tra l’altro di pagare gli espropriati entro 60 giorni. Loro hanno al massimo 8 mesi per fare il closing finanziario e trovare 1,1 miliardi. Nel 2018 apriamo il primo pezzo, nel 2021 l’opera è finita».
Lo stato di avanzamento?
«Circa il 30-40%, ma abbiamo fatto le opere più complicate: gallerie e scavi».
Ma presidente oggi lei la Pedemontana la rifarebbe?
«È una struttura chiesta dal territorio ed era nel programma di tutti i partiti. Grazie ad essa si ridurranno di 2/3 i tempi di percorrenza. Pensiamo alle aziende, certo, ma anche ai pendolari e alla sicurezza stradale: la Schiavonesca Marosticana è la seconda strada più pericolosa d’Italia».
 «Denuncia di 40 tra economisti, docenti esperti della materia per chiedere una profonda revisione dei metodi con cui in Italia si pianificano gli investimenti pubblici». Il Fatto Quotidiano, 5 marzo 2017 (c.m.c.)
«Denuncia di 40 tra economisti, docenti esperti della materia per chiedere una profonda revisione dei metodi con cui in Italia si pianificano gli investimenti pubblici». Il Fatto Quotidiano, 5 marzo 2017 (c.m.c.)
È in corso un grande rilancio politico delle “Grandi Opere”. I denari pubblici in gioco sono moltissimi, paria circa 70 miliardi. Una cifra enorme se si pensa agli stretti vincoli di bilancio e tutti concentrati su un numero limitato di grandi interventi, a cui si sommano le risorse dei Contratti di Programma con Fsi e Anas.
Il costo complessivo dei soli interventi ferroviari ammonta a quasi 26 miliardi di euro (Allegato al Def 2016), equivalente a oltre un terzo di quello complessivo di tutte le opere “strategiche”. Esistono in ambito internazionale consolidate regole di valutazione economico-finanziaria, ma in Italia sono state finora ignorate. Per nessuna delle opere sopra citate c’è stata una valida analisi, pubblicamente disponibile al momento della decisione, che ne dimostrasse l’utilità sociale. Solo per alcune (il Brennero ad esempio), sono stati pubblicati documenti, peraltro oggetto di critiche metodologiche, solo dopo che la decisione era stata presa. Lo stesso vale per grandi progetti stradali, come la Pedemontana veneta, quella lombarda, e la Livorno-Civitavecchia.
L’entità dei costi previsti impone che le grandi opere passino al vaglio di pubbliche ed approfondite analisi costi-benefici da parte di valutatori “terzi” rispetto ai committenti, per evitare scelte economicamente non giustificabili, dettate da considerazioni elettorali di breve respiro (nella migliore delle ipotesi). Purtroppo esempi di progetti infelici non mancano, dagli 800 milioni già inutilmente spesi per la stazione dell’Alta velocità di Firenze che non si farà ai quasi 8 miliardi spesi per l’Av Torino-Milano, scarsamente utilizzata rispetto alla capacità, e con costi stimati tripli rispetto ad analoghe linee francesi.
Analisi indipendenti evidenziano come due progetti – la nuova linea Torino-Lione e la linea Alta capacità/Alta velocità Napoli-Bari – mostrino flussi di traffico, attuali e prospettici, così modesti da poter escludere che sia opportuno realizzarli nella forma prevista. Perla Milano-Padova le ricadute positive saranno quelle dell’aumento di capacità complessiva che si potrebbe però ottenere con interventi assai meno onerosi e impattanti, mentre trascurabile appare il beneficio della velocizzazione del traffico diretto tra Milano e Venezia.
Per quanto riguarda il Terzo Valico Milano-Genova un’analisi costi-benefici, ancorché sommaria ha dato anch’essa risultati negativi. Per tutte queste opere le previsioni di traffico sembrano essere irrealistiche, come è evidente sia dal confronto storico dei flussi reali sia dalla stima, implicitamente assunta nelle analisi, di un forte aumento della domanda a seguito della disponibilità dell’opera. Queste assumono poi tariffe d’uso invariate rispetto a quelle attuali, quindi implicitamente che l’intero costo di investimento sia a carico dell’erario.
Se è vero che la decisione finale sulle opere pubbliche deve rimanere politica, essa non può prescindere dai risultati di analisi rigorose, trasparenti e comparative, né ignorare studi e valutazioni effettuate da esperti indipendenti e deve anche aprirsi a un confronto con tutte le parti interessate.
La corruzione è deprecabile, ma un danno più grave può essere inflitto alla collettività dal dedicare enormi risorse all’esecuzione di strade, linee ferroviarie o ponti non giustificati dai benefici del traffico, destinato a una crescita comunque modesta per ragioni economiche e demografiche. Forse per la percezione della necessità di un cambiamento, è stata recentemente creata nel ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una struttura tecnica che dovrà valutare gli investimenti pubblici secondo regole precise e rendendo trasparenti e meno discrezionali le scelte politiche.
L’iniziativa del ministro Graziano Delrio è lodevole e necessaria, e deve ricevere il massimo supporto da parte di chi ha a cuore la cultura della valutazione e della trasparenza nelle scelte. Ma non si può fare a meno di notare che emergono forti ombre sul ruolo reale di questa struttura, se guardiamo alle contemporanee dichiarazioni della politica che certo non favoriscono valutazioni neutrali.
Da un lato si susseguono infatti dichiarazioni politiche in favore di “Grandi Opere” mai seriamente valutate (opera “strategica” o che “crea 100.000 posti di lavoro”, ecc.), dall’altro lato molte scelte vengono dichiarate “irreversibili” a causa dell’esistenza di forti penali in caso di mancata realizzazione. Ma queste penali furono spesso stabilite su contratti affidati senza gara, con patti evidentemente lesivi dell’interesse pubblico.
Prescindendo dalla consistenza giuridica di queste penali (il governo Prodi cancellò quei contratti, quello Berlusconi poi li ri-convalidò), è pur possibile valutare in modo rigoroso quali opere converrebbe alla collettività portare comunque a termine e quali sarebbero invece da cancellare o ridimensionare pur in presenza di penali (anche in funzione del loro stato di avanzamento: alcune sono appena iniziate).
C’è dunque il rischio che la costituzione di un organismo apposito, così innovativo nei principi, copra il perpetuarsi di scelte non validate, sotto le fortissime pressioni da parte delle lobby interessate ai lavori, ma indifferenti all’utilità dell’opera. Auspichiamo che il ministro mostri nei fatti la proclamata volontà di cambiamento.

L'incredibile vicenda del parere di una commissione per la valutazione d'impatto ambientale che è positivo nonostante ci siano 142 (centoquarantadue) cose che non vanno nel progetto presentato. Fuori i nomi! La Città invisibile, 27 febbraio 2017 (c.m.c.)
L’aeroporto di Firenze e l’insostenibile leggerezza del Master Plan
In attesa che il prossimo 10 marzo, con la presentazione del progetto per il nuovo stadio di Firenze, il Sindaco Nardella annunci finalmente dove e come saranno localizzate e distribuite le funzioni di cui si parla oramai da tempo immemorabile (mercafir, stadio, aeroporto), ho pensato di leggere (attentamente) le 216 pagine del parere della Commissione nazionale di VIA sull’aeroporto di Firenze e mi permetto di giudicarle un mero esercizio di equilibrismo terminologico e dialettico.
Partendo dalla doverosa ricostruzione degli aspetti amministrativi del procedimento, il documento riporta l’elenco delle osservazioni (analizzate e contro dedotte in sede istruttoria) e, prendendo atto dei pareri del Mibac e della Regione Toscana e del pronunciamento del TAR (attraverso la sentenza 1310/2016 su questioni di merito poste da ricorrenti), si dilunga in una approfondita descrizione dei contenuti dei tre quadri di riferimento (programmatico, progettuale e ambientale) in cui è suddiviso lo studio di impatto ambientale presentato dal proponente.
L’istruttoria si conclude con l’espressione del parere positivo della Commissione condizionato dall’ottemperanza di 62 prescrizioni, a loro volta contenenti circa 80 sub-prescrizioni, per un totale quindi di circa 142 indicazioni obbligatorie ai fini della realizzazione dell’intera opera.
Rispetto all’abnorme numero di “condizioni” a cui è sottoposto il progetto dell’aeroporto di Firenze, prima di commentarne i contenuti, vorrei ricordare quanto già dichiarato in occasione di una precedente riflessione relativa allo stesso argomento, e cioè che, in tema di valutazioni ambientali, vi è un rapporto inversamente proporzionale tra la qualità del progetto e il volume del quadro prescrittivo elaborato dall’autorità competente per la valutazione: a forti carenze del progetto e dello studio di impatto tende a corrispondere un alto numero di prescrizioni, finalizzate a sopperire a quanto non è stato approfondito nella proposta.
Se, di per se, non bastasse a generare preoccupazione il dato numerico (partendo dalla constatazione che 142 prescrizioni sono, a tutti gli effetti, una “bocciatura mascherata” dell’iniziativa), la conferma dell’irrealizzabilità dell’aeroporto (almeno allo stato attuale delle conoscenze) emerge chiaramente dal “peso” di alcune prescrizioni.
Il particolare mi soffermo sui temi più rilevanti, citandone i contenuti e commentandone le conseguenze.
Rischio di incidente aereo
Con la prescrizione n. 3 la Commissione ha imposto la redazione di «uno studio riferito agli scenari probabilistici sul rischio di incidenti aerei considerato anche l’uso esclusivamente monodirezionale della pista … Lo studio dovrà essere redatto da soggetto terzo pubblico con esperienza per la previsione del rischio degli incidenti aerei mediante modelli di calcolo. Lo studio dovrà descrivere e quantificare i possibili rischi per la salute umana e per l’ambiente…. con la stima dei danni materiali attesi … Lo studio dovrà anche individuare le misure … per eliminare o ridurre il danno, misure inclusive della delocalizzazione delle preesistenze qualora emerga un rischio per la perdita di vite umane …».
Dunque, il proponente, prima che il Ministro delle infrastrutture approvi definitivamente l’opera, dovrà rivolgersi ad un organismo pubblico al quale sarà dato l’onere di descrivere il rischio di incidente aereo, perché tale imprescindibile analisi non ha fatto parte della documentazione presentata, pur trattandosi di un tema quale la perdita di vite umane, la cui rilevanza credo sia inoppugnabile.
Stante tutto ciò, mi chiedo quale credibilità possa avere un parere espresso in assenza di elementi di tale importanza, in grado di condizionare, qualora correttamente evidenziati, la stessa realizzabilità del progetto.
Stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti nell’intorno aeroportuale
Con la prescrizione n. 4, la Commissione, così come per la prescrizione n. 3, certifica un’altra sostanziale carenza progettuale, riferita alla necessità di evidenziare «… la probabilità di accadimento di un impatto aereo sugli stabilimenti circostanti l’aeroporto, in particolare su quelli classificati dalla Direttiva Seveso come a rischio di incidente rilevante. Questa stima sarà finalizzata a valutare tutti i possibili effetti domino o di amplificazione e a definire idonee procedure di sicurezza …».
Valgono per questo argomento le stesse considerazioni fatte al punto precedente, ricordando – quindi – che attualmente nulla si sa del rapporto tra le modalità di sorvolo del territorio e le attività insediate.
Terre e rocce da scavo
L’Argomento, per Firenze, è delicato, visti i precedenti relativi alla TAV (tra l’altro ancora non risolti a 5 anni dalle indagini della magistratura).
La prescrizione n.8 sub c), conclude dichiarando «La presentazione del Piano di utilizzo [delle terre e rocce da scavo] al MATTM (art. 5 DM 161/2012) è condizione necessaria alla preventiva autorizzazione alla realizzazione di qualsiasi opera prevista …».
Tale condizione è totalmente in contrasto con i contenuti dello stesso art. 5 del DM 161/2012 citato, che impone invece (opportunamente) la presentazione del Piano di utilizzo «… prima dell’espressione del parere di valutazione ambientale», e non prima dell’autorizzazione alla realizzazione.
La questione – tra l’altro – era già stata trattata nel parere VIA della Regione Toscana, ove si dichiarava l’illegittimità del procedimento, proprio con riferimento alla mancanza tra i documenti del richiamato Piano di utilizzo.
E’ quindi del tutto incomprensibile come la Commissione, in totale difformità dalla legge, abbia potuto rimandare ad una fase procedimentale successiva alla VIA la presentazione di un elaborato la cui importanza è legata anche ai quantitativi in gioco (oltre 3 milioni di mc di terre, o altro che dovranno essere rimosse e/o trattate).
Valgono- purtroppo – anche per questo argomento le stesse considerazioni in merito alla attendibilità di un giudizio di compatibilità ambientale, che più che a uno strumento di tutela da eventuali impatti sembra assomigliare ad una cambiale da scontare.
4) Fosso reale: attraversamento autostrada A11
Con la prescrizione n. 29 si impone al proponente, in sede di progettazione esecutiva, di “sviluppare la soluzione di attraversamento della autostrada A11 …. risolvendo la problematica tecnica evidenziata nel parere del Genio Civile di Bacino Arno …”.
Nella sostanza la Commissione è costretta a constatare che il progetto, relativamente alle opportune modifiche al Fosso reale per consentirne il passaggio sotto il rilevato autostradale in assoluta sicurezza, non individua soluzioni accettabili, ma ciò non ha impedito alla Commissione stessa di esprimersi favorevolmente anche con riferimento agli aspetti idraulici, seppure attribuendo ad elaborazioni da presentare nella successiva fase autorizzativa l’onere di trovare soluzioni alla problematica.
Alla luce di tali gravi carenze progettuali (alle quali si devono aggiungere molte altre che non cito), le imbarazzanti conclusioni del parere sono totalmente contrarie ai principi che regolano le procedure di valutazione, e inducono a delegittimare – di fatto – il ruolo stesso della Commissione (e la finalità per cui è stata istituita), minandone la credibilità e producendo il solo effetto di allontanare ancor di più i cittadini dalle istituzioni.
Per essere più chiaro e diretto potrei dire che la fiducia riposta – oggi – nel lavoro della Commissione è la stessa che ognuno di noi avrebbe nei confronti di un meccanico che giudica le prestazioni di una automobile senza conoscerne le caratteristiche, o di uno chef che commenta una pietanza senza averla assaggiata.
Sarebbe l’ora che tutto questo finisse, che ognuno tornasse a fare il proprio mestiere (in scienza e coscienza): che chi è chiamato a valutare lo facesse in autonomia e chi deve decidere evitasse di cercare sempre compiacenti coperture.
I virtuosi comportamenti che dovrebbero caratterizzare le azioni quotidiane di tutti coloro che operano per il bene della società furono rappresentati già sette secoli fa da Ambrogio Lorenzetti nell’allegoria del “Buon governo”, ma, a quanto pare, perché tutto ciò entrasse nel sentire comune, non è bastato fissarlo su un muro.
P.S. Dei 48 membri della Commissione VIA, 35 hanno sottoscritto il parere e 10 sono risultati assenti. Tre sono i membri che hanno espresso un parere contrario: chapeau!
Il drammatico resoconto di un missionario che dalle bidonville dell’Africa nera è piombato nella “periferia interna” di Napoli, Italia. Scritto il 22 febbraio 2017
Solo ora, dopo tanti anni di presenza nel rione Sanità, unadelle periferie interne di questa città, riesco a capire quanto complessa siala situazione e quanto difficile sia essere missionario in luoghi come questi. Vista dalle periferie, Napoli salta subito all’occhio comeuna metropoli spaccata in due, la “Napoli bene” come la borghesia di Chiaia,Vomero, Posillipo e la “Napoli malamente” che va dalle periferie esterne diScampia, Ponticelli, Barra alle periferie interne (il centro storico degradatodi Forcella, Quartieri Spagnoli, Rione Sanità). C’è un muro invisibile chesepara queste due Napoli, due città che non vogliono incontrarsi. Da una parteuna ricchezza ostentata e dall’altra una bomba sociale che fa paura.
Un muro invisibile
Nelle periferie di Napoli sta crescendo una generazione diragazzi ai quali è negato il futuro. La cosiddetta “Napoli bene” trova piùcomodo ignorare questo divario. «Il dramma dei ragazzi stritolati dalla camorranon si risolve nei salotti-ammonisce il PM Woodcock che indaga sulle baby-gangdel centro città - È un fenomeno criminale imponente che ci riguarda tutti, acominciare da quella borghesia che dovrebbe decidersi una volta per tutte auscire dal suo isolamento» E questo non sta avvenendo, mentre si fa sempre piùaspra la guerra fra bande di ragazzini per il controllo delle piazze dispaccio. Ormai la vecchia camorra è finita, i vecchi boss sono quasi tutti incarcere, sostituiti dai baby-boss. «L’aver assicurato alla giustizia i grandicapi - osserva lo stesso procuratore nazionale anti-mafia, Franco Roberti - hacreato un vuoto di potere che ora, giovani e giovanissimi, senza alcun frenocercano di occupare»
E questi giovanissimi sono il frutto maturo di trent’anni diconsumismo, veicolato da una squallida TV, che hanno spazzato via i valoridelle famiglie del sottoproletariato napoletano. Oggi tanti giovani di questefamiglie hanno solo un sogno: la vita bella che possono ottenere solo con tantisoldi. E dato che siamo alSud, la regione più in difficoltà della UE secondo il rapporto Svimez, dove ladisoccupazione giovanile raggiunge il 60%, la via più breve per fare tantisoldi è la droga: Napoli infatti è diventata la più grande piazza di spaccio didroga in Europa. Nasce così la nuova camorra, quella delle baby-gang. «Questigiovani non hanno mai conosciuto valori, sport, affetti giovanili - scriveSamuele Ciambriello- .
Si sentono superiori ai vecchi boss. Vogliono tutto esubito. Qui e ora. Se, hanno deciso di uccidere, lo fanno. Sparano nel mucchio,uccidono vittime innocenti» Questi giovani, con le loro “stese” terrorizzano ilterritorio e proclamano a tutti che loro sono in controllo. Questi ragazzi nonimitano più neanche la fiction televisiva di Gomorra, ma imitano l’Isis. «Unfilo sottile ed esistenziale lega i giovani che scorrono in armi nel centrostorico di Napoli per uccidere e farsi uccidere e i militanti della Jihad - cosìafferma il giudice Nicola Quatrano nella condanna contro la Paranza dei Bambinidi Forcella - Entrambi sono ossessionatidalla morte, forse la amano, probabilmente la cercano, quasi fosse l'unica chanceper dare senso alla propria vita e vivere in eterno»
In questi due ultimi anni è stato proprio il Rione Sanità l’epicentrodi questa guerra che ha visto nel 2015 l’uccisione di un ragazzino innocente di17 anni, Genny Cesarano (6 settembre), seguita da quella del boss PierinoEsposito (14 novembre). E come risposta la strage il 22 aprile 2016 di viaFontanelle dove hanno perso la vita Giuseppe Vastarella (fratello del boss) eSalvatore Vigna. A stretto giro di posta, arriva il 7 maggio la strage diMarano in cui perdono la vita Giuseppe Esposito e il figlio Filippo, padre efratello di Emanuele, il killer delle Fontanelle. Ma la faida continua. L'8giugno due killer entrano nel circolo ricreativo del Lotto 0 a Ponticelli per uccidereRaffaele Cepparulo che, per salvarsi, usa come scudo umano un altro ragazzinoinnocente, Ciro Colonna di 19 anni. Ambedue vengono falciati. Cepparulo, un giovanedi 25 anni, era stato cacciato con altri tre dal Rione Sanità e abitava pressola fidanzata a Ponticelli (periferia di Napoli est). Basta leggere i tatuaggisul corpo di Cepparulo per capire chi sono questi ragazzi. Cepparulo portavatatuato in grande il nome del suo giovane boss, Genidoni (ora in carcere). Sulpettorale sinistro c'è la scritta LOVE, ma per ogni lettera viene usato comefondo un’arma: per la L una pistola, per la O una bomba, per la V un rasoio eper le E un mitra. Sulla spalla campeggia l’acronimo inglese: ACAB (tutti ipoliziotti sono bastardi). Sono questi i simboli, meglio i versetti satanici diuna generazione che ha scelto l’inferno.
“Un Popolo in cammino” ha reagito all’uccisione di un altroinnocente Ciro Colonna, sfilando con un migliaio di persone per le strade di Ponticelli.Marciando ho potuto osservare bene il Lotto 0: una piccola Scampia! Che vergognaquesti ghetti di Napoli. E come azione positiva abbiamo, insieme ai cittadini,ripulito un campo abbandonato, dove ora i ragazzini del Lotto 0 giocano apallone. Piccoli segni che nascono dal basso.
Ma il gioco al massacro è continuato con l’uccisione, il 20giugno a Melito (nord di Napoli) di Alessandro Laperuta e del marocchino MohamedNouvo. L’eterno scontro tra il centro storico di Napoli (Rione Sanità) e ilnord di Napoli (Melito, Secondigliano, Scampia). Il 3 agosto altra strage in VicoNocelle, nel quartiere Materdei, limitrofo al Rione Sanità, mentre era in corsoun vertice per creare un solo cartello della droga. A questo vertice eranopresenti gli uomini di Salvatore Esposito (storico boss del Cavone, vicino aPiazza Dante), ma anche quelli dei Sequino del Rione Sanità (dei quali CiroMarfé era portavoce al tavolo delle trattative). I killer hanno bloccato iltraffico di Vico Nocelle per poi sparare e uccidere a colpo sicuro il boss SalvatoreEsposito e Ciro Marfé, mandando all’aria un affare di varie centinaia dimilioni di euro. Chiara la strategia: creare tante piazze di spaccio, collegatedagli stessi prezzi, stesse tariffe, stessi canali di approvvigionamento,stessi fornitori.
Cronache di unosterminio
Il 6 settembre, primo anniversario dell’uccisione di Genny,abbiamo voluto reagire a questo stillicidio con un evento. Il nostro parroco, don Antonio Loffredo, sempre molto attivo sul territorio, ha pensato, insiemea un bravo artista napoletano, che aveva conosciuto Genny, di preparare una raffigurazionedi quel giovane mentre gioca a pallone, seduto su due assi con la scrittaSan(t)ità. Il tutto è collocato sotto l’albero di ulivo che era stato piantatoin memoria del ragazzo. Dopo la messa, siamo usciti in piazza Sanità, dove igenitori di Genny hanno tolto il lenzuolo che copriva il memoriale del lorofiglio. Un momento importante per il popolo del Rione Sanità .
Purtroppo il 30 settembre arriva la risposta alla strage diVico Nocelle con l'uccisione di Vittorio Vastarella, altro fratello del boss.Un'esecuzione plateale fatta alle 12.30 con tanta gente per strada, a pochipassi da Piazza Sanità, presidiata dall’Esercito Italiano! L’esecuzione sembrasia stata ordinata dai Sequino per colpire il clan Vastarella forte dei legamicon Secondigliano, dove è in atto una feroce lotta tra i clan emergenti.Infatti nello stesso giorno, quattro killer entrano in azione in Vico Cotugno aMiano (nord di Napoli), tra i bambini che giocano a pallone, freddandoSalvatore Corradi, 37 anni e Domenico Sabatino, 40 anni, quest’ultimo, figliodi Ettoruccio, ex-boss del Rione Sanità, ora in carcere. Un duplice omicidioche si inquadra nella lotta esplosa all’interno di ciò che rimane del clan LoRusso che controllava il nord di Napoli e aveva tentato di mettere le mani sulrione Sanità tramite il boss Pierino Esposito.
Ma la faida tra i Sequino e Vastarella alla Sanità continua.Il 7 settembre i killer entrano in una affollata cornetteria ai Colli Aminei euccidono Antonio Bottone di 28 anni e feriscono il suo amico Daniele Pandolfidi 21 anni che riesce a salvarsi nascondendosi nel laboratorio. Siamo in guerraper la droga, per il racket, una guerra pagata anche dagli immigrati, i qualiperò dimostrano più coraggio nel reagire rispetto ai cittadini. E quanto èavvenuto il 4 gennaio di quest’anno nell’affollatomercato della Maddalena, che si trova a ridosso della centralissima PiazzaGaribaldi. Quel giorno un commando di quattro uomini, armati di bastoni epistole, urlando:«Diamo una lezione a questi bastardi di neri», si scaglianocontro un senagalese, reo di essersi rifiutato di pagare il pizzo di venti europer Natale al clan Mazzarella di Forcella. A quel punto però si mobilitanodecine di africani in difesa del connazionale aggredito ed è allora che uno deicamorristi estrae la pistola e inizia a sparare all’impazzata, colpendo allegambe tre senegalesi e una bambina di 10 anni che era lì con i suoi genitoriper comperare i regali per la Befana. Si è sfiorata un’altra tragedia e un’altravittima innocente. Pochi giorni dopo “Un Popolo in cammino” ha invitato tuttia ritrovarsi vicino al mercato della Maddalena in solidarietà con i migrantisenegalesi per il coraggio dimostrato.
Una camorra questa sempre più spregiudicata, capace diusare anche i bambini e minorenni per la preparazione e lo spaccio della droga.Ce lo rivela l’arresto il 17 gennaio di 42 persone del clan Elia che controllail Pallonetto a S.Lucia. Tra queste c’era una ragazzina di otto anni, cheaiutava a preparare le dosi di cocaina e un ragazzino di 13, Giovanni, chegestiva da solo la piazza di spaccio. Un fatto questo che ha lasciato tuttiscioccati a Napoli. Ha ragione il prof. Isaia Sales quando afferma che «lacamorra è diventata così potente da quando l’area napoletana è statatrasformata nella più grande piazza di spaccio di cocaina e di tutte le droghein Europa, soprattutto da quando la cocaina è passata da droga per pochi ad affaredi massa»
Un grande affare che porta ogni anno in media ottantamilioni di euro nelle tasche dei boss. E questo spiega anche la spaventosadisponibilità di armi in questa città. I carabinieri nel giro di un anno (2014-15)hanno sequestrato circa 1.265 fra armi da fuoco e armi bianche, 23milamunizioni e quasi diecimila chilogrammi di esplosivo. Napoli sta diventandosempre più una città sudamericana,
Da Korogocho (Nairobi,Kenya) al rione Sanità (Napoli, Italia)
E questa la drammatica realtà che dobbiamo affrontare, sevogliamo realmente fare missione in questa megalopoli. Dopo dodici anni spesinella violenta baraccopoli di Korogocho (Nairobi) in Kenya, mi ritrovo inmissione qui a Napoli nel rione Sanità, insieme al francescano Arcadio Sicherche è vissuto anche lui per dieci anni in baraccopoli ad Accra (Ghana) e allapediatra Felicetta Parisi, laica consacrata, da anni impegnata sul territorio.Non è una missione facile la nostra e deve essere tutta inventata! Ma noiriteniamo fondamentale prima di tutto esserci dentro queste realtà, viverlegiorno per giorno, sentirle sulla propria pelle.
Ecco perché è importante essere qui su questo campanile della Chiesa condividendo le angosce di questopopolo. Il dramma di un ragazzino innocente come Genny ucciso nel cuore dellanotte, proprio qui sotto casa. L’orrore dell’uccisione in piazza, quasi sottoi nostri occhi, in pieno giorno, delboss Pierino Esposito, il cui corpo ho ricoperto con un lenzuolo. Lo sconcerto,quando giorni fa, qui davanti alla porta di casa è stato gambizzato, amezzanotte, un giovanotto. Son balzato dal letto e sono sceso in piazza peraccogliere la disperazione dei vicini. E ancora, a pochi metri da casa, il 21 gennaio, i killersparano a un giovane, in sella a uno scooter, che pur ferito, accelera e riescea scappare. E l'11 febbraio, verso sera,con negozi aperti e tanta gente per strada, un altro agguato con ferimento di padre e figlio, gestori di un garage, aqualche centinaio di metri da casa. E così che anche noi sperimentiamo sullanostra pelle la paura e lo sconcerto della gente che vive in questo quartiere.
Ma per noi missionariè altrettanto importante il comeci siamo in queste periferie! Infatti abbiamo scelto uno stile di vita semplicee sobrio che ci permette di mettere al centro le persone con un’attenzioneparticolare agli ammalati, agli anziani soli, ai malati mentali, ai senza fissadimora, ai migranti e ai rom. (Tante le lotte che stiamo facendo per questeultime tre categorie, gli scarti della nostra società). Incontrando le personedel quartiere ci rendiamo conto di quanto grande sia anche la sofferenzaeconomica. Questo ci ha spinto ad iniziare il microcredito (non è la cosa piùfacile alla Sanità!). Sosteniamo con forza anche il lavoro dei GiocatoriAnonimi per le vittime del gioco e dell’usura, cancro del rione Sanità (e nonsolo alla Sanità!).
Ma il nostro ruolo di missionari qui è anche quello di creare comunità, fare rete,far nascere dal basso un movimentopopolare capace di chiedere i propri diritti fondamentali come cisuggerisce Papa Francesco. Purtroppo questo non è facile perché le periferiedel Meridione sono attraversate da un esasperato individualismo, in parteretaggio storico del Sud, in parte frutto del consumismo. Per questo, comemissionari abbiamo puntato sulle Piccole Comunità cristiane che si ritrovanonelle case a leggere il Vangelo e a contestualizzarlo nell'oggi. Piccole realtàche riscaldano il cuore, creando autentiche relazioni umane e comunitarie. Equesto stesso motivo che ci ha spinto ad iniziare anche la Rete del RioneSanità per creare comunione fra le varie realtà che operano sul territorio. Inquesti anni la Rete è riuscita ad evidenziare i gravi problemi sociali presso l'amministrazionecomunale sia con le lettere LiberiAmo laSanità che attraverso i tavoli istituzionali. Un bel frutto della Rete è laRete Educativa che riunisce tutte le scuole, i dopo-scuola, i centri educativi delquartiere. All’inizio di questo anno scolastico è stata organizzata unagiornata unitaria in piazza, come unitaria sarà la sfilata del Carnevale (24febbraio), che quest’anno ha cometema:” Il diritto allo studio”.
E due anni fa, dopo l'uccisione del giovane Genny Cesarano, abbiamodato inizio a un movimento che tenta di mettere insieme le realtà socialiimpegnate delle periferie di Napoli con le parrocchie presenti nelle stesse. L’abbiamochiamato “Un Popolo in cammino”.Non è un cammino facile, sia per la frammentazione dei comitati, sia per ladifficoltà che si ha a legare fede e vita. E un lento e difficile processo questo,ma lo ritengo fondamentale.
Un appello inascoltato
“Un Popolo in cammino” si appella prima di tutto al Governo perché intervengacon un Piano Marshall per le scuole, la sicurezza e il lavoro per i giovaninelle periferie di Napoli. Lo abbiamo chiesto di nuovo con forza il 16 dicembrescorso con un’altra marcia per le vie centrali di Napoli. Noi chiediamo per iquartieri in difficoltà scuole aperte fino a sera tarda, con insegnanti sceltiallo scopo di avvicinare questi ragazzi. Scuole che devono includere anche scuoleserali e maestri di strada. Qui ci vogliono grossi investimenti dello Stato. Inpiù chiediamo sicurezza sulle nostre strade e piazze, munite di telecamere, presidi fissi di polizia e vigili urbani. Maanche un impegno serio contro la bomba sociale che colpisce le periferie diNapoli, altrimenti non ci potrà essere sicurezza. Infine chiediamo lavoroinedito per i giovani: il 60% sono disoccupati. Lavori inediti comecooperative per la raccolta dell’umido nei vicoli o lavoro negli orti urbani…
Dopo più di un anno di pressione sul governo Renzi e oraGentiloni, dobbiamo riconoscere che abbiamo ottenuto quasi nulla. Non solo, marischiamo di perdere quel poco che abbiamo! Qui alla Sanità, nonostante lelotte e i blocchi stradali compiuti, è stato chiuso anche l’ospedale S. Gennarodei Poveri. E ora rischiamo anche la chiusura dell’unico Istituto Superiore,il Caracciolo. Ma tutto questo impegno è difficile sostenerlo senza una fortespiritualità, quella indicataci da Papa Francesco, quella di una chiesa poverae dei poveri. Ecco quello che ci ha spinto e ci spinge a promuovere il “Pattodelle Catacombe”. Questo è un Patto firmato il 16 novembre 1965 da unacinquantina di Padri Conciliari, alla fine del Vaticano II, nelle catacombe diDomitilla a Roma, con il quale i vescovi si impegnarono per una Chiesa povera edei poveri. E dato che a Napoli abbiamo le splendide catacombe di San Gennaro,abbiamo voluto riproporlo ma adattandolo alloggi. E così nel 50° anniversariodi quel Patto, il 16 novembre 2015, un folto gruppo di fedeli, preti,religiosi/e si sono ritrovati inpreghiera nelle catacombe di S.Gennaro dei Poveri, qui al Rione Sanità, perfirmare il rinnovato Patto delle Catacombe, che ci impegna a “fare l'opzione deipoveri, degli esclusi, degli scarti della società, a riconoscere in loro la carnedi Cristo, Sacramento vivo della sua Presenza e prestare ad essi la nostra vocenelle loro cause”. Ma abbiamo anche promesso di «sostenere in manieranon violenta, nella nostra azionepastorale, i movimenti popolari che si impegnano a favore dei dirittifondamentali dell'essere umano»,
Ora che abbiamo ottenuto la benedizione e l’incoraggiamentodel nostro vescovo, il cardinale C. Sepe, ci siamo dati appuntamento (fedeli,preti, religiosi/e) il 24 marzo prossimo presso le catacombe di S. Gennaro perrinnovare quel Patto. E la giornata del martirio dell’arcivescovo di S.Salvador, Oscar Romero e dei missionari martiri, straordinarie figure che sisono giocate la vita a favore degli impoveriti in nome del Dio della vita. «Crediamoin Gesù che è venuto a portare vita in pienezza-aveva affermato Oscar Romero -Crediamo in un Dio vivente che dà vita agli uomini e vuole che gli uomini vivanodavvero. Si presenta quindi alla Chiesa, come a ogni uomo, l’opzionefondamentale per la sua fede: essere in favore della vita e della morte.Vediamo con grande chiarezza che in questo la neutralità è impossibile. Oserviamo la vita dei salvadoregni o siamo complici della loro morte. E qui sidà la mediazione storica dell’aspetto fondamentale nella fede: o crediamo in un Dio di vita o serviamo gliidoli di morte».
E questa anche la nostra opzione fondamentale, noi cheviviamo e operiamo nelle periferie di Napoli.
Napoli, 22 febbraio 2017
 Ecco dove spinge la logica del Mercato secondo la confessione di quelli che realmente governno i processi di trasformazione della città. il Sole24ore, 23 febbraio 2017, con postilla
Ecco dove spinge la logica del Mercato secondo la confessione di quelli che realmente governno i processi di trasformazione della città. il Sole24ore, 23 febbraio 2017, con postilla
La domanda residenziale che negli ultimi semestri si è riaffacciata al mercato deve fare i conti con una serie di variabili determinanti per il real estate e con alcune anomalie caratteristiche del mattone italiano. È in estrema sintesi il riassunto del report pubblicato da Rur, Rete Urbana delle Rappresentanze, e Yard, società che si occupa di consulenza nel real estate, per fotografare trend e tendenze del nostro mercato immobiliare.
Fatto 100 il numero base nel 2006 oggi la domanda abitativa è a quota 81,4, ma le compravendite si fermano al 59. Oggi sono 950mila i potenziali acquirenti, rispetto ai 907mila del 2012.
Secondo Yard non pochi sono i rischi interni e internazionali con il quale lo stesso mercato immobiliare deve fare i conti. Tra quelli interni Yard nomina la produttività, ma anche le calamità naturali oltre all’alto debito, tra quelli internazionali le elezioni in Europa, le migrazioni ma anche la riduzione degli investimenti cross-border.
Ma l’analisi del settore è più complessa. «Il ciclo immobiliare, e soprattutto quello delle costruzioni, ha subìto, a partire dalla metà dello scorso decennio, un ridimensionamento di proporzioni che non hanno avuto eguali in passato - recita il report -. Un settore fortemente esposto alla componente residenziale: circa l’80% del fatturato immobiliare deriva dalla componente del “mercato di consumo residenziale” in gran parte per uso proprio, mentre negli altri grandi mercati europei si attesta attorno al 60%, pur avendo dimensioni assolute comparabili».
In Italia, e gli operatori locali e internazionali da tempo lo segnalano, manca la componente essenziale dell’immobiliare per le attività produttive e di servizio urbano che costituiscono il vero motore dello sviluppo territoriale.
«Il fatturato di quello che Eurostat classifica come real estate activities nel 2015 vale, infatti, 130 miliardi di euro in Germania, 83,5 miliardi nel Regno Unito, 80,8 in Francia e 36,2 in l'Italia. Inoltre, nel nostro Paese dal 2006 il turnover si è ridotto del 27%, mentre in Germania è cresciuto del 21%» recita ancora lo studio.
Bisogna reinventare il real estate. Come nel segmento “commercial” (non residenziale) si sta passando sempre più a investimenti value added - edifici da riqualificare per ricavarne valore - così bisogna rigenerare pezzi di città attraverso la demolizione di quartieri degradati, obsoleti o invivibili (pensiamo ad alcuni quartieri di case popolari). Questo il pensiero del team di Yard e di Giuseppe Roma, segretario generale di Rur.
La riqualificazione permette da un lato di non consumare nuovo suolo e dall’altro di innescare un processo di sviluppo che può incidere sulla ripresa dell’economia.
Da segnalare anche lo stop dello sviluppo nel residenziale, che in un momento di crisi ha evitato però di mettere sul mercato abitazioni che non avrebbero incontrato domanda. Nel 2006 a fronte di cento abitazioni vendute si registravano permessi per 30 nuove costruzioni, nel 2016 ogni cento transazioni vengono autorizzate sette nuove abitazioni.
Il Rei (Real Estate Italia) Index (somma le opinioni di miglioramento e la metà di quelle che indicano stabilità) riferito al 2017 per quanto riguarda i volumi scambiati, nel solo comparto residenziale supera la soglia del 50% che rappresenta una prevalenza di opinioni positive per il futuro. Per quanto riguarda i prezzi, gli opinionisti interpellati dalla Rur, segnalano per il 2017 ancora una fase di contenimento nel settore abitativo, con una sostanziale stabilità, tranne che per l’usato di bassa qualità che dovrà subire ancora qualche rastrematura.
Il mercato abitativo sembra soggetto a una forma di “astinenza” da parte dei proprietari di immobili medio–alti, non offerti in vista di una possibile inversione di tendenza. Quindi, i prezzi medi sono in discesa per una diversa composizione qualitativa dei beni scambiati, rispetto al passato.
postilla
Abbiamo capito la logica del Mercato. Case vuote ne abbiamo costruite troppe. Ma gli investimenti, e il lavoro, non possono essere impiegati per restaurare i territori degradati, perché il danaro pubblico serve per gli armamenti, alla faccia della Costituzione. Allora "rigeneriamo" fisicamente e socialmente la città: aumentiamo le cubature nei vecchi quartieri, sovraccarichiamo i servizi già insufficienti, mandiamo fuori i poveri, e dentro i benestanti.
Archistar, grandi opere, assenza di governo, mancanza di dosi anche minime di programmazione e coordinamento: ecco come si gettano al vento le risorse e si caricano di debito pubblico i vivi e i futuri. Corriere della sera, 22 febbraio 2017
Lunga e sinuosa come un gigantesco serpente. È appoggiata sull’erba e non sul mare, che qui neanche si vede. Ma nel corpo centrale di quasi 400 metri ha la copertura a gradini che ricorda villa Malaparte a Capri. Bella. Anzi bellissima. E moderna. Con i computer a controllarne la luce. Un architetto la indicherebbe come ardito esempio di rapporto tra invaso e involucro. E ne decanterebbe il fascino tirando in ballo il decostruttivismo russo e il razionalismo classico. Ma il punto è: servirà a qualcosa?
La nuova stazione dell’Alta velocità di Afragola, progettata da Zaha Hadid e inserita dalla Cnn tra le perle dell’architettura contemporanea, già più volte visitata da governatori e ministri, sarà inaugurata ufficialmente tra un paio di mesi nella campagna a Nord di Napoli: in grande ritardo rispetto all’avvio dei lavori, iniziati nel 2003 e poi bloccati per oltre un decennio, ma ora addirittura in anticipo rispetto all’ultimo cronoprogramma. Quarantamila metri quadrati distribuiti su quattro livelli, 5 mila metri di vetrate, vuoti da vertigine e spazi in abbondanza per uffici e servizi: insomma, roba da squilli di tromba, l’ideale per ridare un po’ di tono a questa immensa periferia impoverita. E invece, c’è già chi nutre dubbi sulla sua utilità, perché è diventata il simbolo di ciò che il Paese potrebbe essere e invece non è.
Michele Oricchio, procuratore generale della Corte dei Conti, ne ha parlato nella sua relazione di apertura dell’anno giudiziario. Un paio i passaggi. Il primo, generale, quando ha fatto riferimento a «un investimento eccessivo» e alla «troppa superficialità nella spesa pubblica in Campania». Il secondo, quando è entrato nel merito. «La chiamano pomposamente — ha detto — “Porta del Sud”. Ma mi chiedo se sarà davvero dimensionata al reale numero di viaggiatori che prenderanno ad Afragola un treno per la Calabria o per Bari». Ironica la conclusione: difficile pensare a un traffico di viaggiatori «da Victoria Station».

Costata finora sessanta milioni, ma ne occorreranno molti altri per completarla e «connetterla» al territorio, la stazione di Afragola fu originariamente pensata per accorciare le distanze dell’Alta velocità. I Frecciarossa da e per il Sud non sarebbero stati più obbligati a entrare e uscire da Napoli, ma avrebbero potuto fermarsi ad Afragola e poi proseguire in linea retta. Sennonché è successo esattamente quello che non doveva succedere. Non solo l’Alta velocità si è fermata a Napoli, come si sa. Ma dal 2003, a cantieri aperti, nulla è stato fatto per garantire contemporaneamente il collegamento locale tra la nuova mega stazione galattica e quella ormai storica di Napoli-centrale. Niente metropolitana, che si ferma a 20 chilometri di distanza. Niente Circumvesuviana, che chissà come tira avanti essendo da anni classificata come la peggiore ferrovia italiana. Solo progetti più o meno vaghi e finanziamenti tutti ancora da confermare. E addirittura — almeno finora — non è previsto neanche un servizio alternativo su gomma. Tanto che il sindaco di Afragola, Domenico Tuccilo, ancora si sbraccia nel tentativo di richiamare l’attenzione di qualcuno: governo, Regione, Comune metropolitano. Qualcuno purchessia. Chiede navette, parcheggi, attrezzature per la vivibilità e lo sviluppo. Tutto tranne i soliti supermercati.
«La nuova stazione — dice — non può rimanere lì come un’astronave abbandonata nei campi». Tuttavia per ora la conseguenza è paradossale. Afragola sarà attraversata solo da qualche Intercity o Frecciargento, ma non sostituirà Napoli-centrale. A maggior ragione per l’Alta velocità. I Frecciarossa si fermeranno nella stazione di Zaha Hadid solo quando sarà completata la tratta Nord-Sud, o quella, già avviata, Napoli-Bari. Se ne riparlerà, in ogni caso, non prima del 2022. Intoppi permettendo. E sempre che si trovi un taxi per raggiungerla.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<div id="div_bg_btnData" class="CHitNPReader_toolbar_btn_bg" >Data</div> <div id="div_bg_btnContenuti" class="div_bg_btnData" ></div> <div id="div_bg_btnData" class="CHitNPReader_toolbar_btn_bg" >Contenuti</div> <div id="div_bg_btnContenuti" class="div_bg_btnContenuti" ></div>

Un progetto obsoleto ma una Grande Opera produttrice di giganteschi investimenti pubblici e generatrice di ingenti arricchimenti privati, ostacolata da un’intelligente e tenace opposizione popolare
Le “grandi opere” inutili e/o dannose non sono una prerogativa italiana, come sanno coloro che a livello europeo si occupano di questa problematica di vaste dimensioni. Dappertutto questi grandi progetti che implicano un oneroso investimento pubblico provocano ingenti danni non solo ambientali ma anche sociali ed economici alle comunità.
Il progetto
Secondo un progetto che risale al lontano 1994, la principale stazione ferroviaria di Stoccarda, situata in centro-città, con 17 binari e una frequenza di 50 treni all`ora, sta per essere sotterrata. Il grande cantiere, aperto nel febbraio 2010, è ormai esteso a tutta la città e devasta da anni ampi spazi cittadini : si scavano tunnel per circa 60 km per far passare solo 8 binari sui quali dovrebbero transitare 32 treni all`ora.
L’argomento ufficiale del necessario potenziamento del nodo ferroviario è dunque obsoleto, come si può evincere anche dalla nuova stazione centrale di Vienna, attiva dal 2015 e simile nelle sue dimensioni, con un traffico inferiore del 30% rispetto a quanto previsto anche per la nuova stazione di Stoccarda. Quali sarebbero allora i benefici di questa grande opera, i cui costi sono balzati dagli iniziali 2 miliardi di euro a 4,5 nel 2011, a 6,5 nel 2013 e nel 2016 a oltre 10 miliardi di euro? Si presume inoltre che con la nuova linea ferroviaria prevista sulla tratta Wendlingen - Ulm i costi lieviteranno a ben 14,6 miliardi di euro complessive. (Queste cifre sono infine da paragonare con la somma erogata alle Ferrovie tedesche per l’intera rete nazionale: 1,2 mrd.di euro.)
Oltre ai lauti profitti per le ditte di costruzione, ci si aspetta così anche per città e regione un lucrativo sviluppo urbano ed economico, last but not least sulle superfici liberate dagli attuali binari (circa 100 ettari). Ma anche qui i calcoli sono alquanto vaghi e la Corte dei conti ha ammonito contro aumenti e ritardi a seguito di una pianificazione solo approssimativa.
Richiesto dalle Ferrovie S.p.A. come “controllo” dello stato dei lavori (la cui fine si è posticipato ormai al 2021/22), il più recente rapporto (2016) della multinazionale KPMG, che fornisce servizi professionali alle grandi imprese nel mondo, si basa solo su informazioni interne e conferma più o meno le aspettative del committente pur rivelando tra le righe molte lacune su una serie di gravi mancanze tecniche. Oltre al fatto che non è di dominio pubblico.
La resistenza
L`intero progetto è stato osteggiato attivamente dal 2009 fino al 2011 da decine di migliaia di cittadini, sostenuti all`inizio dalle organizzazioni di tutela ambientale del Bund e dal partito dei Verdi. Nel 2011, i Verdi sono entrati in coalizione con la Spd (dal 2016 la coalizione è con la Cdu) al governo del Land Baden-Württemberg oltre a quello della città di Stoccarda, e da allora essi hanno virato su una posizione consenziente: “costruttiva, ma critica”.
Anche sull’onda dell`esito “favorevole” al finanziamento regionale, espresso in un referendum regionale nel novembre 2011, che - pur senza raggiungere il quorum necessario - ha fatto crollare parte della resistenza attiva. Ciò nonostante permane un’opposizione di base molto decisa al progetto “Stuttgart 21” che ha elaborato un progetto alternativo per una “svolta” (Umkehr 21/K21) mantenendo alta l`attenzione in città, nella speranza che “Stuttgart 21” non venga portato a termine nel modo previsto alla luce delle tante questioni ancora aperte. Dal 17 luglio 2010 il nucleo duro di resistenti (circa 300 persone, in maggioranza donne) tiene aperto 24 ore su 24, giorno e notte, davanti alla stazione centrale la “Mahnwache”, un posto di monito, di protesta permanente dove chiunque può trovare materiali e informazioni sullo stato delle cose.
Ogni lunedì (ininterrottamente dal 26 ottobre 2010!) questo gruppo di irriducibili organizza un raduno serale con qualche oratore nella centrale Schlossplatz che poi raggiunge in corteo la stazione centrale (alla 357a manifestazione dello scorso 6 febbraio hanno partecipato anche testimoni contro le grandi opere a Firenze e Venezia).
Con il gruppo di lavoro nominato “Stuttgart 21 è ovunque” si è potuto constatare che in ogni paese, e nello spazio pubblico sempre più privatizzato, le grandi opere non corrispondono alle esigenze concrete dei cittadini o del territorio ma piuttosto alle aspettative di alto profitto dei capitali, aspettative difficilmente raggiungibili altrove nella fase dell`odierno capitalismo. Lottare contro questi mostri (per lo più di cemento) significa quindi anche lottare per un futuro sostenibile per tutti.

«Il dibattito di questi giorni dimostra che non esiste una progettazione dei trasporti in città, si improvvisa cercando di rimediare maldestramente ai guai creati».territorialmente, 2 febbraio 2017 (c.m.c.)
Quando il saggio indica la luna qualcuno vuol farci vedere solo il dito. Pare proprio quello che sta succedendo attorno al Passante TAV: le persone sono attonite all’idea di spendere 1,5 miliardi per una mega stazione senza treni, ma si cerca di cambiare argomento e deviare l’attenzione dell’opinione pubblica dicendo che si metteranno tanti bus in quella voragine ai Macelli.
Così ha fatto l’assessore ai Trasporti del Comune di Firenze Stefano Giorgetti nelle sue recenti dichiarazioni dove ha tranquillizzato che la futura “Foster” non sarà un deserto, ma ci saranno ben 20.000 viaggiatori al giorno che scenderanno e saliranno da tutti i bus diretti in città.
Questa prospettiva, che dovrebbe consolare i cittadini perplessi nel vedere tanti soldi buttati, al Comitato No Tunnel TAV rinforza invece le domande che non hanno ancora trovato risposta: se il buco ai Macelli sarà una stazione di bus che si fanno a fare due tunnel ferroviari? Se i viaggiatori ferroviari saranno così pochi che si spendono a fare 1,5 miliardi di euro?
Il Comitato indica da anni che questo progetto TAV è profondamente inutile e pericoloso, mentre qualcuno vuol distrarre l’attenzione parlando di autobus Il Comitato si pone anche un’altra serie di domande: ma è stato fatto uno studio che giustifichi lo spostamento di tutti i bus che arrivano a Firenze in una zona come quella dei Macelli? Questa decisione non sarà una trovata, poco credibile, per giustificare un errore marchiano come quello di aver iniziato a realizzare una ferrovia sotto la città? Ancora le dichiarazioni di Giorgetti, “È proprio la presenza dei pullman che ci consentirà di realizzare la nuova stazione”, sono lì a darci la risposta: è lo spostamento dei bus a far sembrare plausibile questa operazione!
Lasciano basiti le dichiarazioni del presidente della Commissione Ambiente Fabrizio Ricci che continua a dire che senza i tunnel le FS potrebbero “bypassare Firenze con il tracciato dell’alta velocità”. Ma vogliamo scherzare? Ma di cosa si sta parlando? Dal nodo fiorentino passano circa 200 treni AV ogni giorno, non ci sono percorsi alternativi; i treni o passano da Firenze o non passano! Il Comitato si chiede se non sarebbe opportuno un ripassino di geografia da parte dei nostri politici.
Il dibattito di questi giorni dimostra che non esiste una progettazione dei trasporti in città, si improvvisa cercando di rimediare maldestramente ai guai creati.Il re pare proprio nudo; c’è da chiedersi solo quand’è che i Fiorentini cominceranno a riderne sul serio.
Comitato No Tunnel TAV
 A tutto questo c’è solo una spiegazione razionale: che si debba scavare e rimuovere milioni di metri cubi di terra perché ci sono accordi inconfessati e inconfessabili da cui non si può tornare indietro. perUnaltracittà, 2 febbraio 2017 (c.m.c.)
A tutto questo c’è solo una spiegazione razionale: che si debba scavare e rimuovere milioni di metri cubi di terra perché ci sono accordi inconfessati e inconfessabili da cui non si può tornare indietro. perUnaltracittà, 2 febbraio 2017 (c.m.c.)
Il Comitato No Tunnel TAV di Firenze ha letto con incredulità le dichiarazioni dell’Assessore ai Trasporti del Comune di Firenze Stefano Giorgetti relative al futuro del Passante AV. Che il progetto rivisto fosse caratterizzato da gravi lacune è stato subito chiaro, ma adesso che alcuni particolari stanno emergendo la cosa si sta facendo addirittura ridicola.
Giorgetti ha riconosciuto che nella futura “mini-Foster” andrebbero solo i treni AV che attualmente fermano a Campo di Marte, servendo cioè circa 3.000 viaggiatori al giorno, il 10% dei viaggiatori dell’alta velocità a Firenze. Tutti gli altri, circa 160.000 al giorno, continuerebbero a servirsi di Santa Maria Novella.
C’è da non credere alle proprie orecchie! Si costruiscono due tunnel sotto la città e una stazione di 700.000 metri cubi di volume e 60.000 di superfici utili per un numero di viaggiatori come a Pontassieve! Si mettono a rischio monumenti e migliaia di appartamenti per realizzare una stazione con molto meno traffico di Rifredi o Campo Marte!
E in quei pericolosissimi tunnel sono previsti solo poche decine di treni al giorno! Quasi tutti i treni AV andranno a Santa Maria Novella; ma allora di cosa si parla quando si dice che si «libereranno i binari di superficie»? Questo deserto che hanno ideato ai Macelli a cosa potrebbe mai servire? Ecco la trovata: ad una stazione dei bus! Anzi, un hub, sembra una cosa più seria. Si cerca di riempire il vuoto di idee con una trovata da cabaret. Si giustifica la costruzione di 7 km tunnel ferroviari e tre piani sotto terra per una fermata di autobus? Ma vogliamo scherzare?
Per un traffico da stazione di campagna si sono stanziati e si vogliono spendere 1,5 miliardi di euro?
Il Comitato sa che ormai le faide interne al PD toscano portano agli assurdi che vediamo, ma si chiede cosa faccia il governo davanti a questi numeri, cosa ci sia stato a fare il Ministro Del Rio alla riunione del 25 scorso dove si è deciso di continuare con questi lavori TAV; come possa continuare a tacere il Ministro del Tesoro Padoan davanti a tanto vergognoso sperpero in una controllata dal suo ministero; a che politiche di risanamento stia pensando il Presidente del Consiglio Gentiloni se tollera follie come questa.
Il quadro che l’assessore Giorgetti ha aiutato a chiarire è senza senso, non ha alcuna logica. A tutto questo c’è solo una spiegazione razionale: che si debba scavare e rimuovere milioni di metri cubi di terra perché ci sono accordi inconfessati e inconfessabili da cui non si può tornare indietro.
Di questi veti e accordi segreti è prigioniera Firenze.
*Comitato No Tunnel TAV Firenze
«Una storia minore, che però dice molto di come le cose spesso funzionano in Italia». Il Fatto Quotidiano online, 31 gennaio 2017
La sentenza sancisce “l’esistenza di criticità acustiche” che impediscono la costruzione di Bellaria. La vicenda è stata anche oggetto di un’inchiesta giudiziaria archiviata nel novembre del 2014. Nel decreto di archiviazione si racconta dei 29 milioni di euro nascosti al Fisco da parte di Immobiliare Santilo, la società che aveva venduto i terreni diventati edificabili: tutto però è stato prescritto o sanato dallo scudo fiscale
È una storia che da anni tiene banco a Peschiera Borromeo, un piccolo comune alle porte di Milano. Una storia minore, che però dice molto di come le cose spesso funzionano in Italia. Ora è arrivata una sentenza del Consiglio di Stato, che da un lato impedisce la realizzazione delle nuove residenze, dell’asilo e del parco che erano stati previsti in zona Bellaria in barba a ogni criterio di sicurezza, visto che lì di fianco sorge uno stabilimento della Mapei a rischio di incidente rilevante. Dall’altro lato, la sentenza dice chi in questi anni ha fatto l’interesse pubblico, e chi invece non ha rispettato le leggi per farsi gli affari suoi.
Tutto inizia nel 2007, quando il sindaco del Pd Francesco Tabacchi e il suo assessore all’Urbanistica Silvio Chiapella, entrambi vicini all’allora presidente della provincia Filippo Penati, danno il via a un’incredibile speculazione immobiliare, approvando in zona Bellaria un piano integrato d’intervento per edificare su quello che era un terreno agricolo nuove case, un asilo e un parco, questi ultimi due come opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Peccato che l’area abbia più di un problema: la strada di fianco è piuttosto trafficata e i limiti di inquinamento acustico non vengono rispettati, mentre nello stabilimento della Mapei, quello dell’ex presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, c’è un deposito di sostanze a rischio di esplosione, con possibili conseguenze in un raggio di 200 metri.
L’amministrazione di centrodestra che segue quella di centrosinistra se ne accorge e nel 2012 annulla parte del piano, bloccando la costruzione dell’asilo, del parco e delle residenze che non sono ancora state tirate su. Il sindaco Antonio Falletta e il presidente del consiglio comunale Luciano Buonocore presentano anche un esposto in procura. L’inchiesta giudiziaria viene archiviata nel novembre del 2014, ma solo per sopraggiunta prescrizione. Nel decreto di archiviazione sono elencati i nomi dei consiglieri comunali che hanno fatto approvare il piano Bellaria, considerato illegittimo, e racconta dei 29 milioni di euro nascosti al Fisco da parte di Immobiliare Santilo, la società che aveva venduto i terreni diventati edificabili a First Atlantic Real Estate (oggi Idea Fimit) e a tre cooperative locali, realizzando plusvalenze per oltre 42 milioni di euro. In ogni caso tutto finito in prescrizione o sanato grazie allo scudo fiscale.
In comune, dove nel frattempo è tornato al governo il Pd con Luca Zambon, il decreto di archiviazione viene protocollato solo mesi dopo, in modo che nessuno possa leggere cosa c’è scritto sopra. La vicenda Bellaria continua però a tenere banco e a fine 2015 la giunta Zambon finisce per cadere. Qualche mese fa il Fatto quotidiano.it dà conto in un articolo del decreto di archiviazione infrattato e quando lo scorso giugno, in campagna elettorale, alcuni cittadini distribuiscono l’articolo a mo’ di volantino, il Pd locale minaccia pure querele.
Alle elezioni Zambon viene sconfitto da Caterina Molinari, alla guida di due liste civiche. La nuova amministrazione, per quanto riguarda Bellaria, conferma la linea dell’amministrazione di centrodestra. E cambia, rispetto alla giunta Zambon, la linea difensiva del comune nel ricorso che Immobiliare Santilo e Idea Fimit hanno presentato al Consiglio di stato per fare ripristinare su Bellaria il piano originario che già il Tar aveva giudicato illegittimo.
Nei giorni scorsi la sentenza è arrivata, a sancire “l’esistenza di criticità acustiche” che impediscono l’attuazione dei progetti delle opere pubbliche da destinare a parco e asilo. E soprattutto i rischi di incendi ed esplosioni “presenti anche al momento dell’approvazione e dell’adozione del piano integrato di intervento”. Ora ci sarà da realizzare delle opere di mitigazione dei rischi e dell’inquinamento acustico a favore di chi ha comprato un alloggio anni fa, negli edifici costruiti prima che le magagne saltassero fuori. E, secondo la sindaca Molinari, non ci si dovrà fermare a questa sentenza: «Riteniamo che i responsabili della vicenda debbano rispondere direttamente delle scelte e delle conseguenze che ne sono derivate, a tutela della legalità e del benessere dei cittadini».

«Comunicato stampa:Il Comitato No Tunnel TAV constata come si siano avverate le peggiori previsioni per la città: lo sciagurato progetto di Passante Alta Velocità di Firenze è stato confermato per intero nella riunione tentasi ieri a Roma tra Ministero dei Trasporti e enti locali». territorialmente online, 26 gennaio 2017 (c.m.c.)
Per il momento ha vinto la lobby del cemento e della politica clientelare che la sostiene, senza curarsi delle incongruenze e delle illogicità insite in ciò che è stato deciso; ma ormai la politica italiana ci ha abituato ad assumere gli ossimori come realtà.La Regione parla di «centralità del sottoattraversamento e della stazione di Santa Maria Novella» senza rendersi conto che le due cose sono incompatibili: o è centrale l’una o l’altro. Dietro questa confusione semantica si cela soprattutto l’imbarazzo di imporre alla città un progetto sbagliato, cercando affannosamente una logica dove non c’è che approssimazione.
Questa confusione la si vede chiaramente nell’idea che si propone per la Foster 2.0: si parla di “mini Stazione”, ma non si capisce cosa ci possa essere di “Mini” in una struttura a tre piani di 450×50 metri, dove – se l’aritmetica non è una opinione – si avranno tre livelli da oltre 20.000 metri quadri ciascuno. Lo scavo è di quelle dimensioni e non si può certamente ridurre. Si sta preparando un enorme deserto sotterraneo nel cuore della città.
L’idea di uno hub per treni AV e autobus è un coniglio fatto uscire dal cappello, un gioco di prestigio per nascondere l’assenza di idee, un goffo tentativo per mettere qualcosa nel deserto che si vuol costruire.
Nessuno si rende conto che, se si crea un interscambio forte tra bus e AV, si taglia totalmente fuori il trasporto ferroviario, soprattutto quello regionale, che resterà così totalmente scollegato dai trasporti a lungo percorso? I bus, che sono una componente fondamentale del trasporto locale, resterebbero lontanissimi dalla stazione di Santa Maria Novella dove continuerebbero ad attestarsi i treni locali. Ma ci si rende conto dell’incongruenza, della rottura di carico che si provoca?
Adesso i bus turistici entrano in città dall’uscita autostradale di Firenze Sud e, col raccordo che porta a Varlungo, poi in piazza Piave; soluzione assolutamente carente, ma l’idea di far attraversare tutta la zona ovest di Firenze per arrivare ai Macelli è ancora più pazza!
Ma esiste un piano dei trasporti che giustifiche questa trovata, che appare invece una boutade inventata sul momento per giustificare un progetto che non sta in piedi?
Il comitato ricorda come sarebbe molto più semplice, economico ed efficace concentrare servizi distribuendoli attorno alla stazione di Santa Maria Novella, soprattutto utilizzando gli spazi ricavabili dal terrapieno ferroviario e dalle zone dismesse al Romito; ma l’imperativo è scavare, muovere terra: esattamente ciò che gradiscono le mafie in tutti i cantieri d’Italia.
Nell’incontro romano si sono totalmente ignorati i rischi enormi di uno scavo in area metropolitana; questi non sono per niente spariti, si sono solo volutamente dimenticati; ma ce ne ricorderemo presto. Purtroppo.
 «L’affermarsi di concetti quali “pianificar facendo” delegittimava fino al sospetto di ideologismo il tecnico legato ai valori del territorio. Oggi le evidenti difficoltà del campo richiedono un “passaggio di fase”». La città invisibile, 25 gennaio 2017 (c.m.c.)
«L’affermarsi di concetti quali “pianificar facendo” delegittimava fino al sospetto di ideologismo il tecnico legato ai valori del territorio. Oggi le evidenti difficoltà del campo richiedono un “passaggio di fase”». La città invisibile, 25 gennaio 2017 (c.m.c.)
1.1 La recente ripresa di interesse sul campo elaborativo “particolare” costituito dalla penetrazione e dai condizionamenti della criminalità organizzata su politiche e pratiche urbanistiche e territoriali si può collegare certo agli studi diversificati che stanno osservando le crescenti distorsioni dei processi di governance della cosa pubblica (Gallino, 2012; Bevilacqua, Agostini, 2016; Barbieri, Giavazzi, 2014).
Tra gli effetti spaziali, possono annoverarsi i frequenti episodi di corruzione che stanno caratterizzando la gestione di progetti e programmi territoriali, specie nel nostro paese. Non solo per quanto riguarda i continui scandali che investono e stravolgono il comparto delle grandi opere, ma più in generale per le contraddittorie problematicità che segnano molte attività di trasformazione dell’uso dello spazio.
Tutto ciò può significare un sostanziale fallimento di azioni e strategie tipiche della fase precedente di “urbanistica concertata”, contrassegnata spesso dalla presenza di piani tanto “straordinari e complessi” quanto sovente “singolari ed anomali”. Ciò che può evidenziarsi non solo dagli effetti ambientali, in termini di consumo di suolo, distruzione di paesaggio, inquinamenti crescenti, perdita di funzioni territoriali essenziali, e da quelli economico-finanziari, per spreco di risorse e indebitamenti fino al default dei soggetti gestori; ma anche dalla presenza pressoché costante, di fenomeni di corruttela.
Altre discipline, dalla sociologia agli studi giuridici e politici, hanno evidenziato come elemento distintivo (Barbieri, Giavazzi, cit.; Sciarrone, 2009; Mattei, 2013) assai frequente nella distorsione della governance la presenza di criminalità organizzata, mafia ‘ndrangheta o camorra a seconda delle diverse realtà regionali italiane. Si tende sovente a “esasperare le semplificazioni” delle procedure di gestione, fino all’illegittimità e appunto all’illegalità, segnate da rilevanti processi di corruzione, ma spesso concertati con quegli interessi “speculativi speciali” rappresentati dalle soggettività citate.
1.2 La problematicità delle vicende urbanistiche della fase ha contribuito a rilanciare oggi le concezioni più legate alle dimensioni “etiche e valoriali” dell’urbanistica (Magnaghi, 2010; Berdini, 2011; Salzano, 2003), che sembravano di recente riposte sullo sfondo dalle capacità pragmatiche della governance. L’affermarsi di concetti quali “pianificar facendo” o “piano come trading zone” delegittimava fino al sospetto di ideologismo il tecnico legato ai valori del territorio. Oggi le evidenti difficoltà del campo richiedono un “passaggio di fase” o come si diceva un tempo un “cambio di paradigma”: nuovi approcci, contenuti, linguaggi. Con la difficoltà ulteriore dell’accentuarsi di un certo ritardo istituzionale, che ne esaspera gli aspetti critici; specie nel cogliere limiti e contraddizioni di approcci e prospezioni affermatesi nel passato recente, e quindi nella capacità di individuare i momenti per una svolta (Magnaghi, cit.; Bevilacqua, 2011).
Peraltro non sono solo l’analisi di campo e le dialettiche disciplinari a favorire l’elaborazione sulla “deterritorializzazione di stampo mafioso”; anche vicende che hanno contrassegnato le pratiche professionali dell’urbanistica spingono in tale direzione. I problemi di tecnici operanti nelle zone storicamente “ad alta densità criminale”, come quelli di coloro che esercitano nelle aree – anche settentrionali – di penetrazione più recente, sono passati dalla cronaca giudiziaria alla pubblicistica specifica (De Leo, 2015). Qualche tempo fa il caso di Marina Marino, professionista di consolidata expertise nella “bonifica” e nell’amministrazione di enti territoriali a forte rischio di presenza criminale – o addirittura di comuni sciolti per mafia –, ha scosso tra gli altri, una parte della comunità disciplinare (Cornago, 2014) e favorito ulteriore allargamento ed approfondimento del lavoro su tale terreno.
1.3 Oggi questo filone elaborativo presenta intenso fermento: ricerche tipiche di sede si coordinano fino a formare Osservatori di livello nazionale. La pubblicistica disciplinare dedica crescente spazio al tema. I dottorati – oltre che le tesi di laurea – che continuano ad essere sensori delle traiettorie innovative della ricerca, dedicano attenzione ad esso. Peraltro, seppure con molta discontinuità e spesso senza la necessaria tensione, la questione dei condizionamenti della criminalità organizzata rispetto alle pratiche è presente nell’elaborazione urbanistica da più di una trentina d’anni.
Certo, fino al recente passato, essa non ha rappresentato un tema “individuato e dichiarato”, quanto piuttosto la ricaduta, pure rilevante, di istanze analitico-programmatiche tese alla lettura ed all’azione su problematiche specifiche; che caratterizzavano nelle diverse fasi parti del territorio nazionale: abusivismo, consumo di suolo, infrastrutture, gestione dei rifiuti; o percorsi di indagine su comparti e categorie sostantivi per l’assetto, come le grandi opere, le ricostruzioni post disastri sismici o idrogeologici, i grandi progetti turistici, i centri commerciali, le attrezzature speciali (Sberna, Vannucci, 2014).
1.4 Nell’articolo si tenta un prospetto di geografia della “deterritorializzazione di stampo mafioso”, incrociando tre traiettorie evolutive, cronologica, spaziale e tematica. La storicizzazione di quest’ultima permette forse di rischiarare anche le altre.
Le prime tracce di presenza criminale si registrano oltre trent’anni fa nell’ambito di ricerche che osservano “l’edilizia spontanea” che degenera in abusivismo, un fenomeno dapprima tipicamente meridionale, ma presto colto come rilevante, oltre che nelle tre regioni ad alta densità criminale, in altre parti del paese, per esempio Roma (Fera, Ginatempo, 1985; Costantino, 2001).
Nel corso degli anni ottanta, il crescente interesse per l’impatto ambientale di grandi attrezzature ed infrastrutture, di trasporto, energetiche, di gestione dei rifiuti, permette di scoprire il ruolo costante e crescente fino alla dominanza, della criminalità organizzata (Arlacchi, 1983; Piselli, Arrighi, 1985; Sciarrone, 2009), che si era già vista all’opera nella costruzione post-sismica del Belice, ed emerge, più nettamente nel caso dell’Irpinia. Le Colombiadi, i Mondiali del ’90, le grandi opere di fine Prima Repubblica, favoriscono gli incroci tra “Tangentopoli e Mafiopoli” (Arlacchi, cit.; Bocca, 1992).
Talora queste costituiscono occasioni di nuove colonizzazioni criminali di territori che prima non avevano mai conosciuto tali fenomeni, o quasi (Giorgio Bocca, cit., oltre ad Arlacchi, ricorda come il rapimento di Paul Getty negli anni ’70 servì ad assicurare alla ‘ndrangheta di Gioia Tauro le risorse utili a pagare a Fiat Iveco i camion con cui si sarebbero eseguiti i primi movimenti di terra per il costruendo porto industriale. In seguito a quell’affare la famiglia dei Mazzaferro, collegata alle cosche della piana di Gioia Tauro, subappaltava i lavori dell’ampliamento del villaggio-Juventus a Villar Perosa, “aprendo” così le attività in Piemonte).
Ma l’affermarsi dell’emergenza rifiuti, insieme alla sostanziale dominanza del settore dell’escavazione, sul finire del secolo, illumina la capacità mafiosa di controllo su intere filiere, fino all’intero ciclo, dall’accaparramento dei terreni, alle fasi di raccolta e movimentazione, alla posa in discarica e alla sua gestione, o all’incenerimento. La retorica di Gomorra (Sales, 2014).
Ma altri grandi eventi e attrezzature permettono, qualche tempo dopo, la “diffusione nazionale” di mafia ‘ndrangheta e camorra: in primis l’alta velocità, ma anche l’aumento dei grandi centri commerciali e dei distretti turistico- commerciali. Ambiti che permettono tra l’altro alla criminalità di controllare anche l’intero ciclo del cemento in contesti centro-settentrionali, come già avveniva in molte aree del sud. Le opere della Legge Obiettivo negli anni più recenti sono state contrassegnate da scandali a forte intensità di corruzione e criminalità (Barbieri, Giavazzi, cit.; Imposimato, 1999).
La crisi economico-finanziaria, con i limiti alla spesa pubblica, ha clamorosamente ampliato le possibilità di manovra della criminalità: spesso soggetto prioritario, se non unico, a disporre della liquidità necessaria a sostituire la precedente capacità di spesa pubblica. Il crescente ricorso al project financing, per esempio, è stato un altro mezzo di grande penetrazione della criminalità nell’economia dei territori, specie settentrionali. Siamo all’attualità, con la criminalità diffusa su tutto il territorio nazionale (Galullo, 2015).
Riferimenti bibliografici
Arlacchi P., 1983, La mafia imprenditrice. L’etica mafiosa e lo spirito del capitalismo, Il Mulino, Bologna
Barbieri G., Giavazzi F., 2014, Corruzione a norma di legge, Rizzoli, Milano
Bazzi A., 2010, Urbanistica quotidiana a Villabate, in “Urbanistica informazioni” n. 232
Becchi A., 2000, Criminalità organizzata. Paradigmi e scenari delle organizzazioni mafiose in Italia, Donzelli, Roma
Berdini P., 2011, Le mani sulla città, Alegre, Roma
Bevilacqua P., 2011, Il grande saccheggio. L’età del capitalismo distruttivo, Laterza, BariRoma
Bevilacqua P., Agostini I., 2016, Viaggio in Italia. Le città nel trentennio neoliberista, manifestolibri, Roma
Bocca G., 1992, Inferno. Profondo Sud, male oscuro, Mondadori, Milano
Cornago D., 2014, L’anticittà mafiosa e gli urbanisti, in “Urbanistica informazioni”, n. 258
Costantino D., 2001, “Problemi sociali dei contesti paesaggistici siciliani”, in Atti del workshop di Presentazione del quadro conoscitivo del Piano Territoriale Paesaggistico di Ambito 1 della Regione Siciliana, Trapani, Bozza Stampa
De Leo D., 2010, Contrasto alla criminalità e pratiche urbane, in “Urbanistica informazioni”, n. 232.
De Leo D., 2015, Mafie & Urbanistica, Angeli, Milano
Gallino L., 2012, Finanzcapitalismo, Einaudi,Torino
Galullo R., 2015, Finanza criminale. Soldi, investimenti e mercati delle mafie e della criminalità in Italia e all’estero, Il Sole 24 ORE, Milano
Imposimato F., 1999, Corruzione ad Alta Velocità, Koiné, Bologna
Magnaghi A., 2010, Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Milano
Mattei U., 2010, Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali, Mondadori, Milano
Piselli F., Arrighi G., 1985, “Parentela,clientela e comunità”, in Bevilacqua P., Placanica A., Storia d’Italia. La Calabria, Einaudi,Torino
Sales I., 2014, La mafia come metodo e modello, in “Limes”, n. 11
Salzano E., 2003, Fondamenti di urbanistica, Laterza, Roma-Bari
Sberna S., Vannucci A., 2014, Le mani sulla città. Corruzione e infiltrazioni criminali nel governo del territorio, in Fregolent L., Savino M. (a cura di), 2014, Città e politiche in tempo di crisi, Franco Angeli, Milano
Sciarrone R., 2009, Mafie vecchie mafie nuove, Donzelli, Roma
riferimenti
Sull'argomento si veda, su eddyburg, il lavoro di Serena Righini, L’hinterland milanese tra sregolazione e criminalità
 «Chiediamo alle forze politiche che in Parlamento svolgono un’azione di opposizione di mettere in stato d’accusa il Governo della Repubblica, per l’aperta e continuata violazione di un principio costituzionale e per la responsabilità piena e consapevole nel privare i cittadini italiani delle risorse necessarie per la loro sicurezza
«Chiediamo alle forze politiche che in Parlamento svolgono un’azione di opposizione di mettere in stato d’accusa il Governo della Repubblica, per l’aperta e continuata violazione di un principio costituzionale e per la responsabilità piena e consapevole nel privare i cittadini italiani delle risorse necessarie per la loro sicurezza». il manifesto,
26 gennaio 2017 (c.m.c.)
Essi denunciano una realtà mille volte nota e denunciata: la fragilità del nostro territorio, che necessità di cure particolari, investimenti, risanamento di equilibri sconvolti. A questa realtà antica, che illustra la sordità inscalfibile delle nostre classi dirigenti, si aggiunge ora l’impotenza delle amministrazioni locali, privi di risorse, che portano a situazioni indegne di un paese civile. Un paese che sino a poco tempo fa si vantava di essere la quarta o la quinta potenza industriale del pianeta.
Dov’è finita tanta boria?
In questi ultimi giorni abbiamo assistito a spettacoli grotteschi. Centinaia di scuole chiuse per mancanza di riscaldamento, allarmi degli studenti e dei genitori sulla sicurezza degli edifici dove debbono formarsi le nuove generazioni. Le scuole dei nostri ragazzi sono spesso insicure, con servizi scadenti, prive di mezzi. Ebbene, tale squallida situazione, frutto di una politica europea che ci trascina verso il declino non è più tollerabile. Ma non è più tollerabile anche alla luce di quante risorse vengono impiegate dai nostri governi in spese militari.
Il nostro paese cade in ginocchio per qualche alluvione o per nevicate fuori dall’ordinario e noi sperperiamo in spese belliche e in interventi militari, nei vari teatri di guerra, oltre 29 miliardi di € l’anno (2015), circa 80 milioni di € al giorno. Mentre siamo impegnati ad acquistare gli aerei F35 al costo di 14 miliardi complessivi. Si tratta di velivoli da combattimento, strumenti di aggressione e di morte che denunciano da soli la violazione dell’articolo 11 della Costituzione: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».
Ebbene, di fronte ai problemi elementari in cui si dibatte il nostro paese – la cui soluzione potrebbe generare centinaia di migliaia di posti di lavoro – riteniamo moralmente intollerabile lo sperpero di tante risorse a fini di guerra.
Chiediamo alle forze politiche che in Parlamento svolgono un’azione di opposizione di mettere in stato d’accusa il Governo della Repubblica, per l’aperta e continuata violazione di un principio costituzionale e per la responsabilità piena e consapevole nel privare i cittadini italiani delle risorse necessarie per la loro sicurezza.
Piero Bevilacqua, Tonino Perna (Università di Messina), Paolo Berdini, Tiziana Draghi (Università di Bari)Rossella del Prete (Università del Sannio) Piero Caprari, Roberto Budini Gattai, Ilaria Agostini( Università di Bologna), Cristina Lavinio, Paolo Favilli, Francesco Trane, Maria Pia Guermandi (Emergenza cultura), Alberto Magnaghi, Enzo Scandurra, Daniele Vannitiello, Ginevra Virginia Lombardi (Università di Firenze), Piero di Siena, Rossano Pazzaglia, (Università del Molise),Francesco Pardi, Laura Marchetti, Giuseppe Saponaro, Giancarlo Consonni, Andrea Ranieri, Annamaria Rufino (Università della Campania), Graziella Tonon, Velio Abati, Romeo Salvatore Bufalo (Università della Calabria), Amalia Collisani, Salvatore Cingari (Università di Perugia), Marcello Buiatti, Carlo Cellamare, Michele Carducci, Giovanni Attili, Luigi Vavalà, Lia Fubini, Alfonso Gambardella, Ignazio Masulli, Paola Bonora, Alessandro Bianchi, Ugo Olivieri (Università di Napoli, Federico II), Edoardo Salzano, Vezio de Lucia, Giorgio Nebbia, Stefano Sylos Labini, Franco Toscani, Lucia Strappini, Giorgio Inglese (Università di Roma.La Sapienza) Alberto Ziparo, Patrizia Ferri, Pier Luigi Cervellati, Anna Nassisi, Vittorio Boarini.
 «Paesaggi berlinesi. Intervista con il sociologo tedesco Andrej Holm sul diritto all’abitare». il manifesto, 21 gennaio 2017 (c.m.c.)
«Paesaggi berlinesi. Intervista con il sociologo tedesco Andrej Holm sul diritto all’abitare». il manifesto, 21 gennaio 2017 (c.m.c.)
Si potrebbe parlare di «nuovo maccartismo», questa volta al servizio della speculazione immobiliare. Dopo le dimissioni dall’incarico di Segretario di stato per la casa nel Senato della capitale tedesca, il sociologo Andrej Holm ha appena presentato ricorso contro la decisione della Humboldt Universität di cancellare il suo contratto di ricercatore (ne ha dato notizia Jacopo Rosatelli su queste pagine). Abbiamo conversato con Holm che ha accettato di raccontarci la sua storia.
«Sono nato nel 1970 nella Germania Est e cresciuto in una famiglia di solida tradizione comunista – ha spiegato -. Da ragazzo nella Ddr il mio atteggiamento verso il socialismo era molto idealista. E perciò mi sono arruolato per la leva in un reparto della StaSi. Con la svolta del 1989 ho cambiato molte convinzioni rispetto al sistema socialista e sono diventato parte del movimento libertario e autonomo qui a Berlino. Poi ho iniziato a impegnarmi con il movimento degli inquilini nei quartieri orientali. Il dibattito sulla gentrification inizia ufficialmente tra il 2008 e il 2009, ma a Berlino Est abbiamo avuto lotte contro la gentrificazione molto prima che il concetto diventasse «di moda» in ambito accademico. Ho iniziato a studiare sociologia urbana alla Humboldt Universität, trovando una diretta corrispondenza tra questi concetti scientifici e la mia esperienza di lotta. Così ho sempre lavorato sull’interrelazione tra ricerca accademica, movimenti e politica cittadina».
Poi ci sono state le elezioni di settembre a Berlino ed è cominciata la discussione sul programma della coalizione di governo rosso-rosso-verde. Che ruolo hanno avuto i movimenti?
Per la prima volta si discuteva nel merito dei contenuti, in dettaglio, e con grande trasparenza oggi chiunque può leggere quali sono gli impegni assunti dal nuovo governo della città. In materia di politiche abitative ma non solo, siamo di fronte a un programma marcatamente anti-liberista. Si dice che il «decennio dell’austerity» è finito e si apre invece una fase di rinnovati investimenti pubblici, per la creazione di infrastrutture sociali. Sulla base di questo ho accettato la proposta della Linke di entrare nella squadra di governo in prima persona. Sono state direttamente assunte nel programma molte delle rivendicazioni elaborate dal movimento. E le lotte per il diritto alla casa avevano fatto di questo tema uno degli aspetti decisivi della sconfitta Cdu.
Poche ore dopo la sua nomina è scoppiato il caso-Holm. Come possiamo interpretarlo?
Ci sono certo intrecci tra la campagna contro di me, la cultura profondamente anti-comunista di settori dell’establishment tedesco e gli interessi materiali del capitale speculativo. È certo un dibattito dalle molte sfaccettature, come del resto è la mia biografia politica e personale insieme. Ho deciso di dimettermi per evitare che si arrivasse alla rottura nella coalizione rosso-rosso-verde e che le nuove politiche sociali, antiliberiste e anti-austerity contenute nei suoi impegni programmatici, venissero messe in discussione.
Ha scritto nella sua lettera di dimissioni «il mio ritiro non significa affatto la rinuncia a una politica alternativa per la casa». Che cosa intendeva?
La possibilità di un’interazione positiva tra il nuovo governo di Berlino e i movimenti è tutta aperta. Abbiamo imparato una volta di più che invertire le tendenze dominanti nel campo della politica residenziale è questione di rapporti di forza sociali. E noi dobbiamo interrogarci su come sia possibile costruire un contro-potere più forte di prima. Se vogliamo una nuova politica della casa, dobbiamo lottare: un buon social housing non sarà mai un «regalo» del governo, bisogna conquistarlo. Ed è chiaro che molte iniziative degli inquilini escono rafforzate da questa esperienza.
Può riassumere quali sono i principali problemi per quanto riguarda il diritto alla casa a Berlino e, viceversa, quali siano i punti di forza del programma che ha contribuito a scrivere?
È una materia complessa. Mettiamola così: soddisfare il diritto all’abitare è troppo costoso per chi ha un basso reddito, ma questo è il risultato dell’intreccio tra condizioni economiche generali, meccanismi finanziari e politiche pubbliche. Bisogna perciò avere un approccio sistemico. E il punto è ancora quello posto 150 anni fa da Friedrich Engels, cioè la logica capitalista che ritiene la casa una merce, da valorizzare il più possibile. Perciò vogliamo ricombinare un ampio ventaglio di strumenti: dal superamento della logica privatistica di gestione dello stesso patrimonio pubblico, a nuove regole per il «social housing», dalla protezione effettiva dei diritti degli inquilini alla fine di dismissioni e privatizzazioni; serve anzi un massiccio piano di nuove acquisizioni comunali. Infine, abbiamo affermato un diverso modo di prendere le decisioni politiche: non più consultazioni con le lobby immobiliari, ma un ampio e partecipato dibattito, che analizzi l’impatto sociale di ogni scelta istituzionale.
Quali sono le similitudini e le differenze tra la situazione della casa a Berlino e nelle altre città europee?
Ci sono molte cose in comune, perché tutti, anche se in misura e con modalità diverse, abbiamo subito gli effetti delle politiche neoliberiste negli ultimi vent’anni. E dall’altra parte, ogni città ha la sua specifica storia, sia nello sviluppo urbano che nella crescita dei movimenti. Berlino, per effetto della sua storia di città divisa, continua ad avere una certa «mixité» sociale anche nei quartieri più centrali. Nel cuore della metropoli continuano a vivere persone a basso reddito, famiglie che beneficiano del sistema di welfare. Questa è la grande differenza con Parigi, Londra o Barcellona, dove la trasformazione neoliberista del centro è un processo compiuto. E la nostra sfida è mostrare che è possibile una diversa qualità sociale della vita urbana nel suo insieme. Che è una componente essenziale del discorso sull’eguaglianza sociale nelle nostre città, che può nascere ed essere portato avanti dai movimenti.
Pensa possa esserci lo spazio per costruire alleanze tra città per affermare una diversa politica della casa in Europa?
Dobbiamo portare avanti questo lavoro su entrambi i versanti. Da alcuni anni c’è un buon livello di relazioni tra movimenti per la casa: le nostre iniziative anti-sfratto qui a Berlino hanno adottato molte delle forme sperimentate dalla Pah, ad esempio, traducendole nelle nostre condizioni. Imparare dalle altre città e organizzarsi su scala transnazionale è fondamentale. Poi c’è un secondo livello, quello dell’elaborazione dei dispositivi necessari ad attuare una nuova politica dell’abitare: abbiamo differenti legislazioni nazionali, in Olanda o in Italia, ma ci sono delle idee che possiamo adattare e applicare.
Perciò dobbiamo fare rete, sia tra ricercatori critici, sia tra attivisti, sia tra governi di sinistra e alternativi. E combinare questi differenti livelli, non solo tra istituzioni. Ada Colau sa bene, come del resto la coalizione rosso-rosso-verde di Berlino, di aver bisogno di una forte spinta dal basso, di una permanente pressione sociale. E questo è parte della nostra capacità di mutuo apprendimento a livello internazionale.
 «Dal bene pubblico al bene comune condiviso: è questo l’obiettivo del nuovo Regolamento comunale per la gestione civica condivisa di beni comuni, che è approdato sui banchi del Consiglio comunale per l’approvazione». controradio online, 20 gennaio 2017 (c.m.c.)
«Dal bene pubblico al bene comune condiviso: è questo l’obiettivo del nuovo Regolamento comunale per la gestione civica condivisa di beni comuni, che è approdato sui banchi del Consiglio comunale per l’approvazione». controradio online, 20 gennaio 2017 (c.m.c.)
In pratica, grazie a questa nuova procedura, associazioni, comitati, gruppi informali di cittadini o anche singoli potranno presentare il proprio progetto di gestione di un bene pubblico come un giardino o un edificio senza finalità commerciali o di lucro. La modifica, illustrata dall’assessore alla Partecipazione Simone Mangani, è stata proposta dal Consiglio Comunale con una mozione congiunta approvata nel gennaio dell’anno scorso che dava indirizzo alla Giunta in questo senso, sulla scorta di quanto già sperimentato con successo in altri enti locali a partire dal Comune di Bologna, dotatosi di questo strumento dal 2014, e in osservanza dell’art. 118 della Costituzione sul principio di sussidiarietà tra istituzioni e cittadini.
I 35 articoli che compongono il Regolamento sono frutto del lungo lavoro compiuto dall’assessorato con le Commissioni consiliari 1 (Affari istituzionali) e 5 (Servizi sociali, sanità, partecipazione) e con i rappresentanti di comitati, associazioni e consulte del mondo civico pratese.
Lo stesso assessorato ha avviato un processo partecipativo ad iniziativa pubblica, come previsto dal Regolamento della Partecipazione del Comune, volto alla condivisione della costruzione e della scrittura del Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni : «Si tratta di un patto tra cittadini ed istituzioni per la cura, la gestione condivisa sulla base di un progetto e la rigenerazione dei luoghi e della qualità della vita della città – spiega l’assessore alla Partecipazione Mangani – Il nuovo strumento di cui ci dotiamo, ampliando la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni, e formando dei cittadini attivi e responsabili, è in accordo con il programma di mandato e con lo stesso programma elettorale di questa Amministrazione». –
La collaborazione tra Comune e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, in particolare la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa occasionale, la gestione condivisa costante e continuativa e la rigenerazione temporanea o permanente. Può riguardare spazi pubblici o anche spazi privati ad uso pubblico, beni materiali, immateriali o digitali ed edifici. Può prevedere l’attività di progettazione, organizzazione, animazione, assistenza, produzione culturale, realizzazione di eventi, comunicazione, manutenzione, restauro e riqualificazione dei beni mobili ed immobili in stato di parziale o totale disuso o deperimento.
L‘elenco dei beni comuni urbani che potranno essere oggetto di gestione condivisa sarà pubblicato sul sito web del Comune di Prato (www.comune.prato.it) e la stessa Rete Civica del Comune avrà il compito di raccogliere le proposte e i progetti di collaborazione avanzati dai cittadini, che dovranno essere valutati dagli uffici e ricevere l’assenso del Comune. Gli esempi da cui partire ci sono già: il giardino della Passerella, quello intorno all’assessorato ai Servizi sociali di via Roma e l’immobile della Gualchiera di Coiano.
Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene, il Comune ne promuoverà il coordinamento e l’integrazione. Se questo non fosse possibile, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.
Applicare la costituzione anziché storpiarla. Per esempio, quando la proprietà privata non assicura più alcuna funzione sociale, i comuni possono intervenire. Succede a Napoli, Ciampino e San Giorgio di Pesaro. salviamoilpaesaggio.it, 18 gennaio 2017 (m.b.)
C’era chi voleva modificare 47 articoli (su un totale di 139), vale a dire un terzo della Costituzione in vigore, ma i cittadini italiani non lo hanno permesso. E c’è, invece, chi vorrebbe che almeno un articolo della vigente Costituzione (l’articolo 42) venisse applicato in maniera corretta, secondo le interpretazioni suggerite da Paolo Maddalena, Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale. E negli ultimi mesi questo invito inizia ad assumere i contorni di una prassi corrente, che è utile conoscere e sostenere.
Sono almeno tre i casi concreti su cui possiamo poggiare le nostre tesi e sospingere una «new age» che potrebbe sconvolgere – in positivo – l’abitudine di dichiarare la priorità della tutela del Bene Comune sotto il profilo della pura teoria, salvo relegarla a un ruolo inattivo. Gli stimoli che giungono, ora – da Napoli, da Ciampino e da San Giorgio di Pesaro – sono segnali importanti di una «marea» che si sta alzando e che possiamo contribuire a trasformare in un’onda lunga.
Napoli
Nel 2014 la giunta del Comune di Napoli aveva varato due delibere, dedicate al riutilizzo a fini sociali dei beni abbandonati, individuando i beni del patrimonio immobiliare «inutilizzati o parzialmente utilizzati», ma «percepiti dalla comunità come “beni comuni“ e suscettibili di fruizione collettiva», attraverso una specifica mappatura analitica.
Siamo nel cuore del problema: il tema tocca infatti il “nervo” del rapporto tra proprietà collettiva e proprietà privata, indicando un principio già felicemente applicato in alcuni paesi scandinavi.
Nel maggio 2016 una nuova delibera fa un passo avanti: Villa Medusa e l’ex Lido Pola a Bagnoli, l’ex Opg (ex Monastero S. Eframo nuovo) e il Giardino Liberato (ex Convento delle Teresiane) a Materdei, l’ex Conservatorio di Santa Fede (Liberata) e lo Scugnizzo Liberato (ex carcere Filangieri, ex Convento delle Cappuccinelle) nel centro storico, insieme alla ex Schipa di via Salvator Rosa, vengono riconosciuti come «spazi che per loro stessa vocazione (collocazione territoriale, storia, caratteristiche fisiche) sono divenuti di uso civico e collettivo, per il loro valore di beni comuni» e quindi restituiti alla vita quotidiana e alla città intera per tutelarli, scongiurare che possano essere alienati e consentire che vengano amministrati in forma diretta da collettività/comunità di riferimento, senza lucro privatistico e al fine esclusivo di indirizzarli al soddisfacimento dei diritti dei cittadini.
Esemplare l’esempio dell’ex Asilo Filangieri – edificio storico patrimonio Unesco nel cuore di Napoli e anche demanio comunale, abbandonato dopo il terremoto del 1980 – che dal 2 marzo 2012 si è trasformato in uno spazio aperto dove si va consolidando una pratica di gestione condivisa e partecipata di uno spazio pubblico dedicato alla cultura, in analogia con gli usi civici: una diversa fruizione di un bene pubblico, non più basata sull’assegnazione a un determinato soggetto privato, ma aperto a tutti quei soggetti che lavorano nel campo dell’arte, della cultura e dello spettacolo e, in maniera partecipata e trasparente, attraverso un’assemblea pubblica, condividono i progetti e coabitano gli spazi. Grazie al provvedimento della giunta comunale, attraverso il regolamento per la gestione dei beni comuni pubblici, l’Asilo da luogo occupato è ora luogo di cultura aperto a tutti, di sperimentazione comunitaria e un’importante esperienza pilota, riconosciuta dalla delibera comunale per «l’alto valore sociale e economico generato dalla partecipazione diretta dei cittadini alla rifunzionalizzazione degli immobili».
Ciampino
A Ciampino (Comune di oltre 38 mila residenti), invece, un folto gruppo di associazioni, comitati e semplici cittadini – su proposta di “Ciampino Bene Comune”, una delle oltre mille organizzazioni aderenti al Forum nazionale Salviamo il Paesaggio – si è fatto portavoce di un’iniziativa per la tutela dell’area della «Tenuta del Muro dei Francesi», in stato di abbandono e soggetta a continui crolli.
Nell’ottobre 2016 è stato notificato al Sindaco l’invito perentorio a iscrivere formalmente l’area al patrimonio comunale, in quanto bene abbandonato, ricordando al Primo cittadino il suo dovere di intimare ai proprietari la richiesta di indicare la propria disponibilità a riattivare, entro 150 giorni, la funzione sociale dei beni abbandonati ed in parte crollati; in caso di mancata risposta o di rifiuto, il Sindaco potrà quindi procedere all’iscrizione di quei beni al patrimonio comunale.
L’intimazione fa riferimento al comma 2 dell’articolo 42 della Costituzione secondo il quale “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”, e alla funzione sociale non assicurata dai proprietari che, «contravvenendo al loro dovere, li hanno abbandonati facendo venir meno la “tutela giuridica” dei loro preesistenti diritti proprietari sicchè questi beni medesimi non hanno più un titolare e, ai sensi dell’articolo 827 del codice civile, in combinato disposto con il citato articolo 42 della Costituzione, sono tornati nella “proprietà collettiva del Popolo di Ciampino». Al momento non si registrano reazioni da parte del Sindaco, ma i cittadini sono all’erta e pronti a ricorrere al TAR del Lazio in caso di sua inottemperanza.
San Giorgio di Pesaro
A San Giorgio di Pesaro (piccolo Comune di poco meno di 1.400 abitanti), nel febbraio 2016 il consiglio comunale ha approvato una delibera per fronteggiare il preoccupante fenomeno degli edifici abbandonati nel territorio, cioè quegli immobili che si trovano in grave stato di degrado urbano, di incuria volta a determinare pericolo per la sicurezza, la salubrità e l’incolumità pubblica e che non siano mantenuti e utilizzati da più di 10 anni.
Si tratta di un regolamento mirato all’acquisizione al patrimonio comunale, alla riqualificazione e al riuso, anche attraverso la cessione a terzi, di beni in stato di abbandono e, anche in questo caso, si rapporta alle norme del codice civile sulla proprietà «subordinate alle norme di ordine pubblico economico immediatamente percettive degli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione che sanciscono la prevalenza dell’utilità sociale e della “funzione sociale della proprietà” sull’interesse privato».
Con l’espressione “beni comuni” la delibera considera «quei beni a consumo non rivale, ad uso non esclusivo ma esauribile, che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo dei cittadini che possono formare oggetto di fruizione collettiva».
Poche settimane fa il sindaco di San Giorgio di Pesaro, Antonio Sebastianelli, ha emesso tre ordinanze: se non otterranno risposta, dopo 120 giorni scatterà l’acquisizione per fini pubblici e il Comune «provvederà d’ufficio ad eseguire gli interventi necessari con spese a carico dei proprietari o aventi diritto. In caso di mancanza delle risorse finanziarie necessarie a coprire i costi di intervento coattivo, attestato dal responsabile del settore contabile, il Comune avrà la facoltà di imprimere all’immobile una destinazione d’uso pubblica ai fini della conseguente acquisizione al patrimonio dell’Ente».
Tre casi indubbiamente differenti ma con una matrice profondamente solida e unificante, che danno la misura di una possibilità applicabile ovunque: nelle grandi città metropolitane, in Comuni di media dimensione, in ognuno dei circa 6 mila municipi del nostro Paese al di sotto dei 5 mila abitanti (che rappresentano il 72 % dei Comuni italiani). Senza dimenticarci una proposta di legge presentata dalle Onorevoli Chiara Di Benedetto e Claudia Mannino del Movimento 5 Stelle: “Disciplina della funzione sociale della proprietà, in attuazione dell’articolo 42 della Costituzione” (n° 2805, presentata l’8 gennaio 2015). Possiamo ora attendere gli sviluppi che, nelle prossime settimane, si registreranno a Napoli, Ciampino e San Giorgio di Pesaro. Oppure possiamo immaginare un diverso futuro per tutti quegli immobili – pubblici e privati – che popolano la città o il Comune in cui siamo residenti e dare il via a una nuova azione (proprio a casa nostra …), che funga da effetto moltiplicatore e trasformi in un potente strumento civico un fondamentale articolo della Costituzione, mai, purtroppo , correttamente applicato.
Su eddyburg, rinviamo a un approfondimento del caso di Napoli, sempre tratto da salviamoilpaesaggio.it, con molti documenti e riferimenti in allegato.
Molte cose buone, ma moltissime cattive nella gestione privatizzata e discrezionale del patrimonio pubblico a Roma. Si comprende perché se qualcuno vuole metterci un po' do chiarezza (vedi giunta Marino) viene cacciato. il manifesto, 15 gennaio 2017
«La mappa interattiva dei beni immobiliari di Roma. Il 14% dei beni indisponibili concessi è inutilizzato. Il 59% è in una posizione irregolare. La mappa interattiva del patrimonio immobiliare di Roma. Dati raccolti da Stefano Simoncini, elaborazioni ReTer. Grafici elaborati da Giovanni Renzi e Davide Rossidoria»
Considerato nel suo insieme, il Patrimonio di Roma Capitale è una città nella città molto grande, dell’estensione di un medio comune italiano, come Bologna per intendersi. 14.090 ettari di superficie per 50.499 beni immobili unitari, tra terreni, parchi, giardini, monumenti, palazzi, ville, casali, appartamenti, scuole, centri sportivi, mercati, locali commerciali, capannoni, officine, box, cantine.
La maggior parte di questi beni, l’84 per cento circa (42.455 beni unitari), fa parte dell’edilizia residenziale pubblica, sono cioè case popolari alla Corviale, con un sistema di gestione afflitto da problemi enormi, dovuti perlopiù a carenza di manutenzione e assenza di controlli. Quando si parla di «Affittopoli» ci si riferisce soprattutto al “patrimonio disponibile”, alloggi e locali commerciali destinati alla messa a reddito (rispettivamente 1,92% e 1,19% del totale), e al “patrimonio indisponibile” assegnato in concessione a fini sociali e istituzionali (1,61%).
Due componenti che complessivamente rappresentano il 4,7 per cento dell’intero patrimonio (circa 1700 beni unitari). Una città perciò più piccola, ma non per questo trascurabile, in quanto il conteggio per beni unitari (che vanno da singole cantine a interi palazzi) è fuorviante, e dei 989 beni del patrimonio indisponibile in concessione, ben 180 sono interi fabbricati o porzioni di fabbricato, e spesso anche di grande pregio.
Tra le realtà associative e culturali che animano il Patrimonio non mancano situazioni di abuso o di attività per lo più economiche, ma prevalentemente esse costituiscono un diffuso e radicato capitale sociale, e sono spesso delle vere eccellenze “storiche” nel contesto capitolino. Parliamo di realtà come l’Accademia Filarmonica Romana, istituzione concertistica tra le più antiche e illustri d’Italia, o come il Grande cocomero, centro riabilitativo per i ragazzi di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I nato oltre 20 anni fa da un’idea del celebre neuropsichiatra Marco Lombardo Radice, o ancora il Celio Azzurro, nota scuola d’infanzia dedicata all’inclusione multiculturale, o l’associazione A Roma Insieme, fondata 24 anni fa da Leda Colombini, storica figura del Pci romano, che si occupa dei bambini che vivono nel carcere di Rebibbia con le madri e del reinserimento di queste ultime. E poi ancora la storica Casa dei Diritti sociali di via Giolitti, Viva la Vita onlus che da molti anni si occupa di malati di Sla, il centro Ararat all’ex Mattatoio di Testaccio, associazione della comunità curda, insieme a centri sociali come il Rialto Sant’Ambrogio, l’atelier Esc a San Lorenzo, Auro e Marco a Spinaceto, il Csa La Torre su via Nomentana, la Palestra popolare di San Lorenzo, l’ex casale Falchetti a Centocelle, il Laboratorio Sociale Autogestito 100celle, lo spazio sociale 100celleaperte, il Csoa Corto Circuito a Cinecittà.
Come si vede dalla mappa che qui pubblichiamo con i dati di gestione, in buona parte inediti, (interattiva online sul sito de il manifesto, elaborazioni ReTer) il Patrimonio immobiliare del Comune è disseminato un po’ su tutto il territorio della città metropolitana. Si possono distinguere (layer «concessioni minacciate») le concessioni a rischio per l’azione della Corte dei Conti, che sta inducendo l’amministrazione a convertire in determine di sgombero tutte le istruttorie per danno erariale (230 a oggi).
Il patrimonio si divide in indisponibile in concessione (con dati inediti su tutte le concessioni, compresi beneficiari, canoni e morosità al 30/11/2013); patrimonio disponibile a uso residenziale; centri sportivi in concessione. Da notare la prevalente irregolarità delle posizioni, attestata dai 510 contratti «non presenti agli atti» su 861 (59%), trattandosi probabilmente di procedure non perfezionate. Come particolarmente significativa è pure la composizione dei beneficiari con due nuclei forti: il non profit, tra associazioni, enti pubblici ed enti ecclesiastici (39%), e la voce «altro» (41%), che comprende locali per attività commerciali e produttive, ma anche alloggi ad uso residenziale (destinazioni ammesse nel patrimonio indisponibile per motivi tecnici).
La mappa evidenzia anche un elevato tasso di inutilizzo e abbandono (14%) e la vasta distribuzione su tutto il territorio cittadino, che ne fa nel loro insieme un’infrastruttura fondamentale per politiche territoriali di promozione di cooperazione sociale, cultura diffusa e sviluppo locale.
 «Le città non sono luoghi esclusivi per speculazioni dei fondi immobiliari. Le città sono invece i luoghi della socialità e per garantirla si tratta di difendere e ripristinare – ovviamente senza sprechi o favoritismi – la rete delle associazioni che ci difendono da una deriva sociale che può travolgere le stesse radici del vivere urbano».
«Le città non sono luoghi esclusivi per speculazioni dei fondi immobiliari. Le città sono invece i luoghi della socialità e per garantirla si tratta di difendere e ripristinare – ovviamente senza sprechi o favoritismi – la rete delle associazioni che ci difendono da una deriva sociale che può travolgere le stesse radici del vivere urbano». il manifesto
, 15 gennaio 2017 (c.m.c.)
Nel 1903 un grande ministro, Luigi Luzzatti, portò in apporvazione del Parlamento la legge che apriva la nobile stagione delle case popolari. Luzzatti era un esponente della destra storica, era un economista ed aveva fondato banche. Sapeva dunque di economia.
Eppure nelle relazioni al Parlamento parla con durezza contro la speculazione fondiaria che impedisce alle persone senza ricchezza di vivere dignitosamente. In quel periodo, anche grazie alla spinta sociale dei municipi guidati dai primi sindaci socialisti, esisteva la convinzione che le città vanno guidate sostenendo la parte debole della società.
Sarà necessario un imponente lavoro di riflessione sulle cause della tragica involuzione culturale che negli ultimi trenta anni ha fatto diventare le città esclusivi fattori economici rinunciando a qualsiasi ruolo di guida pubblica. La vicenda che trova spazio nelle pagine del manifesto trae origine da atti approvati da amministrazioni di centrosinistra.
L’azione devastante condotta dalla Corte dei Conti parte infatti da una deliberazione approvata dalla giunta Marino e confermata dal prefetto Tronca e rischia di cancellare una serie di istituzioni culturali come l’Accademia filarmonica romana o come tante associazioni che costituiscono il tessuto connettivo che tiene in vita le relazioni sociali nella città. Comitati di cittadini, associazioni che non svolgono attività lucrative vengono chiamate a pagare affitti calcolati sui valori di mercato.
Torniamo dunque al nodo culturale. Negli anni Ottanta si afferma il pensiero unico urbano secondo il quale non possa esistere nessuna attività che sfugge dall’azione predatoria di un’economia senza regole. Questo pensiero unico si è affermato con una rapidità sorprendente e ha prodotto il disastro che abbiamo sotto gli occhi. Per questo, germi nuovi nati al fuori delle vecchie culture politiche, hanno iniziato ad affermarsi in questi anni difficili.
È infatti grazie a questa cultura di difesa dei beni comuni che abbiamo vinto il referendum sull’acqua pubblica. È per questa nuova cultura che a Napoli grazie all’azione di Lucarelli e Maddalena si è affermata una importante concezione dei beni comuni. È per questa nuova cultura che tante città stanno ragionando sugli antidoti per rimediare al disastro. Dentro questa prospettiva culturalmente differente va anche richiamata l’importante azione condotta dall’allora prefetto Gabrielli che riuscì a mettere a disposizione del comune di Roma una importante somma da destinare ai gravi disagi abitativi.
Questa nuova cultura ha consentito l’affermazione di Virginia Raggi a sindaco di Roma e proprio dalla capitale arriverà il segnale culturale che l’intero Paese aspetta. Le città non sono luoghi esclusivi per speculazioni dei fondi immobiliari. Le città sono invece i luoghi della socialità e per garantirla si tratta di difendere e ripristinare – ovviamente senza sprechi o favoritismi – la rete delle associazioni che ci difendono da una deriva sociale che può travolgere le stesse radici del vivere urbano.
 «Penelopi in cerca di tela, progetti e iniziative per renderle artefici di un tessuto sociale solidale e multiculturale, basato non sulla “tolleranza” ma sulla condivisione e sulla solidarietà». ArcipelagoMilano, 10 gennaio 2017 (c.m.c.)
«Penelopi in cerca di tela, progetti e iniziative per renderle artefici di un tessuto sociale solidale e multiculturale, basato non sulla “tolleranza” ma sulla condivisione e sulla solidarietà». ArcipelagoMilano, 10 gennaio 2017 (c.m.c.)
A Milano arrivano sempre più stranieri, tra cui molte donne, spesso condannate all’invisibilità, relegate tra le mura domestiche proprie o dei datori di lavoro per svolgere lavori tipicamente “femminili”. La scarsa conoscenza della lingua italiana e la poca informazione sui propri diritti, la frequente condizione d’irregolarità, il basso livello di scolarizzazione o il mancato riconoscimento del loro titolo di studio, sono le cause che impediscono alle donne di partecipare pienamente alla vita sociale della comunità ospite. E il persistere anche nel nostro Paese di pregiudizi sociali e culturali, impedisce spesso il loro coinvolgimento in rapporti di amicizia e solidarietà, nonché la loro partecipazione alle attività del territorio, con una ricaduta positiva su tutta la comunità, in virtù del ruolo di ponte tra famiglia e società che la donna inevitabilmente (seppur inconsapevolmente) svolge.
Questi aspetti della vita femminile, di frequente trascurati, sono ciò su cui si concentrano diverse associazioni di promozione sociale e culturale di Milano, che si rivolgono proprio alle donne, italiane e straniere, per renderle artefici di un tessuto sociale solidale e multiculturale, basato non sulla “tolleranza” ma sulla condivisione e sulla solidarietà.
Tra le Associazioni impegnate a offrire occasioni d’espressione, incontro e condivisione alle donne c’è Makramè , Onlus la cui storia si lega al territorio dell’attuale Municipio 2, tra via Padova, viale Monza e Piazzale Loreto (dove vi è un’altissima concentrazione di residenti stranieri) e al desiderio di rispondere all’esigenza inespressa di spazi “protetti”, inclusivi e capaci di abbattere ogni tipo di discriminazione o asimmetria sociale, linguistica o culturale.
Antonella Piccolo (Presidente dell’Associazione) e Wanda Di Pierro (vicepresidente) hanno pensato di incoraggiare l’incontro e la solidarietà femminile attraverso la creatività e l’arte, presentando al Bando del 2009 del Comune di Milano (in collaborazione con l’Associazione Al Quafila) il “progetto Macramè”, il cui titolo fa metaforicamente riferimento alla tecnica di tessitura manuale basata su soli tre nodi, a partire dai quali si realizzano manufatti stupendi.
Questo primo progetto è stato poi assorbito nell’ambito di Associazione Makramè, già esistente dal 2005 ma di cui la nuova Onlus ha raccolto l’eredità, dotandosi di una precisa identità femminile e multiculturale e assumendo il proposito di tessere legami con null’altro che volontà, solidarietà, creatività e coinvolgimento delle donne.
Dal 2012 al giugno 2016, grazie ai bandi indetti dal Comune di Milano per il sostegno di progetti di utilità sociale, Makramè ha ottenuto la concessione alcuni spazi nella Cascina Turro, ex sede restaurata del Governo provvisorio lombardo del 1948 (sotto l’amministrazione del Consiglio di Zona 2), e grazie a finanziamenti pubblici e privati (tra cui quelli di Fondazione Cariplo), ha potuto portare avanti due importanti attività pensate per incentivare una solidarietà basata non sul “bisogno” ma “desiderio” (di uscire di casa, di stare insieme, di realizzare qualcosa di bello e sentirsi parte di un gruppo in cui non contano età, religione, lingua, status sociale o etnia di appartenenza).
La prima attività è Voci di donne (esistente dal 2009), un coro femminile multiculturale che, ormai da sette anni, si esibisce con canti popolari di tutto il mondo, diretto da Camilla Barbarito (cantante e ricercatrice di musiche etniche e canzoni folkloristiche) e che, inizialmente sostenuto dall’Associazione, ormai si autofinanzia (pur continuando a usufruire di uno spazio concesso gratuitamente dall’ICS Casa del Sole situato nel Parco Trotter per le prove).
La seconda è il Laboratorio di sartoria creativa del martedì mattina: non un vero e proprio “corso” come ne esistono tanti a Milano, ma uno spazio libero di incontro, in cui trascorrere il tempo con altre donne, e i figli, e apprendere delle tecniche attraverso l’aiuto reciproco e la guida della giovane docente Erika (che realizza costumi anche per il Teatro alla Scala). Avviato nel 2012, il progetto si basa sulla realizzazione artigianale di accessori (che non richiedono lunghi tempi di realizzazione e si sottraggono all’individualismo del capo di vestiario, favorendo invece il lavoro di squadra), alcuni dei quali sono stati esposti in occasione delle festa “Popolandomi” dello scorso settembre.
L’obiettivo dell’autofinanziamento attraverso la vendita dei prodotti realizzati dalle partecipanti è ancora lontano; per sopravvivere il laboratorio avrebbe ancora bisogno di un sostegno esterno (pubblico o privato). La vicepresidente Wanda spiega che «basterebbero 10 o 15 mila euro all’anno», non solo per l’acquisto dei materiali e la retribuzione dell’insegnante, ma soprattutto per permettere ad un numero maggiore di donne di incontrare questa esperienza e di «far proseguire il percorso, alle donne che lo desiderano, verso una forma di microimprenditorialità».
Il nuovo Municipio 2 insediatasi lo scorso giugno non le ha rinnovato la concessione degli spazi né le ha assicurato alcun sostegno economico rilevante. Costretto a chiedere ospitalità presso la Cooperativa Tempo per l’infanzia (in via Bechi 9), il laboratorio di sartoria è ora portato avanti solo da un piccolo gruppo di donne, con l’obiettivo di realizzare eventi di autofinanziamento che permettano al laboratorio di riaprirsi. La nuova scommessa è quella di costruire uno spazio creativo in cui donne richiedenti asilo possano trovare un luogo in cui sentirsi accolte e incontrare le “sarte” di Makramè.
Ma al momento l’Associazione non riesce a garantire l’attivazione formale di quella rete solidale che ne faceva non solo un “luogo protetto” di accoglienza, ma anche un punto di riferimento per l’integrazione sociale delle donne, migranti, anziane, neoarrivate, che avessero bisogno di essere guidate anche nelle questioni pratiche come la regolarizzazione del permesso di soggiorno, l’inserimento dei figli nel sistema scolastico, la ricerca di lavoro o di corsi di formazione professionalizzanti, l’individuazione di luoghi sociali sul territorio.
I bandi pubblici favoriscono i progetti “innovativi”, ma in questo modo non garantiscono la continuità dei progetti, né favoriscono l’acquisizione di competenze o la stabilità dei rapporti umani tra i partecipanti: «È un peccato che il Municipio 2 non ci riconosca la stessa rilevanza sociale attribuitoci dall’Amministrazione precedente, perché il nostro operato ha ricadute positive sul territorio, crea socialità, favorisce i rapporti e l’integrazione multiculturale».
Le associazioni di promozione sociale non sono “corsifici” il cui scopo è quello di rinnovare ogni anno l’offerta con proposte accattivanti; il loro obiettivo è quello di trasformarsi in punti di partenza per processi lunghi e difficili di condivisione delle responsabilità, acquisizione di fiducia reciproca, costruzione di equilibri che annullino le asimmetrie etniche, generazionali, sociali, culturali.
Le istituzioni restano talvolta troppo lontane dalla realtà dell’emarginazione silenziosa di molti cittadini (e cittadine) e dalle difficoltà di coloro, operatori e volontari, impegnati a favorire l’integrazione: per acquisire reale consapevolezza della situazione dovrebbero abbandonare statistiche e teorie sociologiche e scendere per le strade, visitare i centri di accoglienza, vedere i luoghi in cui la multiculturalità e l’uguaglianza non si studiano ma si “fanno”. Allora la distribuzione dei sostegni economici potrebbe essere ripensata in maniera più adeguata alle reali esigenze dei cittadini e cittadine e in modo da garantire una maggiore continuità ai progetti che cercano di fornire ad esse una risposta.
I fatti dimostrano che le “grandi opere” solo occasionalmente producono utilità sociale. Ampio resoconto di un interessante convegno della Fondazione Basso e della Fondazione Culturale Responsabilità Etica. Un ricco inventario di misfatti a. Sbilanciamoci.info, 10 gennaio 2017
Davvero un appuntamento ricco di contenuti quello promosso di recente dalla Fondazione Basso e dalla Fondazione Culturale Banca Etica sul tema delle grandi opere, per ragionare non solo sugli aspetti ambientali, ma soprattutto sulla partecipazione dei cittadini, la vitalità dei territori, le regole del gioco deformate dalla Legge Obiettivo e dalle misure di semplificazione. Regole che non aiutano a scegliere le opere utile alla rigenerazione delle città, alla tutela del paesaggio ed alla cura contro il dissesto idrogeologico, come ha sottolineato Nicoletta Dentico della Fondazione Basso, concludendo i lavori e proponendo che questo dialogo e questa rete prosegua e diventi sempre più serrata ed innovativa. Una rete di associazioni e comitati capace anche di progetto e di alternative concrete, come dimostrano le tante esperienze di impegno e partecipazione nei territori.
Un evento a cui ha collaborato Giulio Marcon, Deputato e Segretario della Commissione Bilancio, animatore della campagna Sbilanciamoci, che ha ricordato come sia Pierluigi Vigna nel 2001 ed oggi Raffaele Cantone hanno definito le regole della Legge obiettivo potenzialmente “criminogene” e di come la Legge di Bilancio 2017 sia ancora nel solco delle grandi opere invece che sulla manutenzione del territorio e di servizi ai cittadini/e.
Il nuovo codice appalti approvato ad aprile 2016 prevede il superamento della Legge Obiettivo ma il regime transitorio rischia di essere lungo ed incerto, per questo occorre vigilanza in Parlamento ed azioni sul territorio per raggiungere l’obiettivo. A questo si è aggiunto di recente un regolamento Madia di semplificazione che ripropone la logica della lista e l’accentramento delle decisioni a Palazzo Ghigi.
Ma in realtà è un clima generale e la visione intorno alle grandi opere che deve cambiare. Il binomio grande opera/grande evento è spesso evocato come una irrinunciabile opportunità per le comunità, un sogno di sviluppo capace di generare nuove energie, nuove potenzialità di convivenza. I fatti dimostrano che, in realtà, questo binomio solo occasionalmente produce utilità sociale, mentre si accompagna sovente a prassi autoritarie e poco rispettose delle comunità coinvolte, a forzature gestionali e amministrative, talora non disgiunte da profili di opacità se non di illegittimità e illiceità.
Molte indagini, anche penali, hanno evidenziato che i sistemi costruiti sui meccanismi della deroga, del commissariamento, delle privatizzazione, dell’eterna emergenza per mettere subito in cantiere opere faraoniche che violentano il territorio e arricchiscono i grandi operatori economici, producono un meccanismo perverso di rapporti tra politica, enti istituzionali e imprese. Questo agevola l’inserimento di operatori spregiudicati e refrattari all’osservanza della legalità e dei controlli. La prospettiva della grande opera, presentata come realizzazione di un sogno collettivo, porta in dote una ben più prosaica realtà: una privatizzazione di programmazione e di decisioni apparentemente pubbliche, con spazio a concessionari, general contractors, progettisti-consulenti, i quali finiscono per dettare condizioni agli enti pubblici, stabilire in concreto tempi (e inevitabili contrattempi) dei lavori, autocertificare i costi. Un meccanismo dagli effetti deleteri per le comunità locali, talora coinvolte in esercizi formali di consultazione, più spesso strette nella morsa delle mitigazioni e con grave lesione per gli spazi della democrazia partecipata.
Al convegno si è ragionato su di un paradigma diverso, che serva davvero al nostro Paese, che coinvolga le Comunità locali come un processo educativo collegiale e come tutela dei diritti delle persone che vivono in un luogo, con una visione di tutela globale e capace di futuro. Estremamente interessante è stato l’Intervento di Franco Ippolito, Presidente del Tribunale Permanente dei Popoli (organismo promosso dalla Fondazione Basso) che ha seguito da vicino il caso delle grandi opere e della TAV in Valsusa, arrivando ad una sentenza di condanna l’8 novembre 2015. La forza di questo Tribunale indipendente deriva dalla capacità di denuncia e dalla forza della pubblica opinione, con un processo che segue tutte le regole e norme dei processi ordinari.
Prima d’ora il Tribunale Permanente per i diritti dei popoli si era occupato di grandi violazioni dei diritti fondamentali dei nativi in diversi paesi del mondo, ma quando ha ricevuto la denuncia del Controsservatorio Valsusa ha deciso di aprire una sessione su questo riscontrando violazioni anche in un paese democratico come l’Italia. La sentenza di condanna è motivata dal fatto che non è stato predisposto uno studio serio di impatto ambientale, non si è garantita una reale partecipazione alle popolazioni locali negando l’accesso a documenti, con dibattimenti fittizi e giustificativi, con la militarizzazione del dissenso nella valle, trasformandolo un problema di ordine pubblico. (Per saperne di più www.controsservatoriovalsusa.org)
Le raccomandazioni del Tribunale al Governo Italiano chiedono di aprire un confronto reale esteso a tutte le opzioni ed alternative, compresa l’opzione zero e nel frattempo sospendere i lavori del cantiere della Maddalena e l’occupazione militare della zona.
Roberto Cuda, giornalista economico ha analizzato con rigore il mito delproject financing, sempre invocato per realizzare l’opera senza contributo pubblico e quindi capace di una grande persuasione verso la politica e le sue regole, come è accaduto nel caso dell’autostrada Brebemi. Su questo caso clamoroso ha scritto anche un bel libro (Anatomia di una grande opera, la vera storia della Brebemi. Edizioni Ambiente 2015). La Brebemi era uno dei pochi casi su cui è stata effettuata una gara per la scelta del concessionario, che si doveva pagare completamente con le tariffe per l’investimento da 1,6 miliardi di euro. Ma non è andata cosi: ha ottenuto 300 milioni di contributo pubblico, una proroga di sei anni della durata della concessione, ed un valore di subentro che pagherà lo Stato alla scadenza della concessione pari a 1,250 miliardi. In pratica l’hanno pagata interamente tutti i cittadini e non gli utenti come era stato promesso. In questo caso si dimostra che l’opera serve solo a chi la costruisce, aumenta i debiti dello Stato e non serve a risolvere i problemi di mobilità. Altri tre casi “negativi” di grandi opere sono stati poi presentati al convegno. Il primo è la storia infinita del Ponte sullo Stretto con Stefano Lenzi del WWF Italia, che ha descritto l’iter trentennale di progetti bocciati e risorti, le intricate vicende giudiziarie ed i ribassi d’asta, i contratti sottoscritti senza un progetto definitivo approvato e la minaccia sempre agitata delle penali, in realtà di molto inferiori, in caso non si realizzi l’opera. Con l’auspicio che la promessa di realizzare il Ponte dell’exPresidente del Consiglio Renzi sia tramontata con le sue dimissioni.
Il secondo caso è l’autostrada della Maremma esposto da Edoardo Zanchini, vicepresidente Legambiente, un progetto nato negli anni 70, che si insiste nel voler realizzare ancora oggi, con la bocciatura di diversi tracciati, mentre l’alternativa è semplice: adeguare e mettere in sicurezza la Strada Statale Aurelia in quei 30/40 km ancora pericolosi. Proprio in queste settimane è in corso una nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sul tracciato autostradale Grosseto Capalbio e le associazioni sono di nuovo sul piede di guerra contro un progetto che sottrae una infrastruttura di uso quotidiano e gratuito come la SS Aurelia trasformandola in autostrada a pedaggio.
Il terzo è stato presentato da Cesare Vacchelli che a nome dei Comitati No Tibre e No Mantova Cremona è intervenuto su due progetti autostradali che incombono nel quadrante Parma, Verona, Mantova e Cremona. Ha descritto la storia ventennale di impegno dei comitati locali che con rigore hanno dimostrato l’inutilità dell’opera, il suo impatto ambientale, la crescita dell’inquinamento e del traffico, i legami perversi del progetto con la concessione autostradale privata del gruppo Gavio, i ricorsi in sede europea ed i ripensamenti in corso. Adesso si insiste nel voler realizzare 13 km di opera con un primo lotto del tutto inutile, ma evidentemente necessario per tenere in piedi la proroga della concessione a suo tempo autorizzata. In alternativa servirebbe il potenziamento del Tibre ferroviario. Ed ha rappresentato con il suo intervento una storia esemplare di impegno, rigore, competenza e resilienza di una comunità locale.
Anche il mondo della politica è intervenuto nel dibattito. Loredana de Petris, senatrice di Sinistra Italiana ha sottolineato il suo impegno contro le grande opere e la difficoltà anche a sinistra di cambiare strategia e strada. Il Ministro Delrio sta facendo un tentativo reale di superamento della legge obiettivo, ma gli interessi, i progetti in corsa, il peso delle concessionarie e dei costruttori, si fanno sentire rallentando le scelte nella giusta direzione. Se poi a questo si aggiunge che Luca Lotti i è diventato di recente con il nuovo Governo Gentiloni, sottosegretario con delega al Cipe e quindi sulle grandi opere, c’è ragione di preoccuparsi davvero.
Monica Frassoni copresidente del gruppo verde europeo ha raccontato tutte le iniziative di impegno contro le grandi opere che anche in sede europea con le reti TeN-T hanno preso piede come filosofia, tra cui la TAV Torino-Lione, l’Autostrada della Maremma, la Valdastico. E di come le regole europee e le direttive impongano Valutazioni Ambientali Strategiche, niente proroga delle concessioni autostradali, informazione e partecipazione dei cittadini: criteri spesso disattesi in Italia ma che diventano sempre oggetto di trattativa tra Bruxelles ed il Governo Italiano per trovare compromessi e deroghe in nome della realpolitik e della necessità di far ripartire gli investimenti e l’economia. Anche in Europa serve mobilitazione ed azioni per far pesare i punti di vista differenti e le alternative concrete e realizzabili.
Infine un appassionato intervento di Tomaso Montanari, storico dell’arte, animatore della battaglia contro lo Sblocca Italia, ha messo in relazione il successo del no al referendum con la battaglia contro le grandi opere, perché democrazia e territori possano davvero contare nelle scelte e che riguardano le regole del gioco del nostro paese. Non solo ambiente quindi, ma una idea di futuro dove coinvolgere l’immaginario, offrire una visione, usare linguaggi nuovi è essenziale per cambiare le cose ed avere ascolto tra i cittadini. Insomma fare cultura nel Belpaese per fermare la barbarie. Ad aprile 2017 il Ministro Delrio dovrà presentare il primo Documento di Programmazione Pluriennale dove indicare le opere prioritarie da realizzare ed entro fine 2017 l’aggiornamento del Piano generale dei Trasporti e della Logistica con la strategia per la mobilità e di trasporti. Si tratta di due documenti che faranno comprendere davvero se il superamento della Legge Obiettivo e della logica delle grandi opere da promessa sia trasformata in realtà o se invece interessi di parte e regime transitorio esteso avranno la meglio. Serve molta vigilanza, coordinamento, azioni comuni, competenze, partecipazione – anche in sede UE – per capire se stiamo andando davvero verso opere “utili, snelle e condivise”.
 «Le rovine di Ouara, l’antica capitale del regno di Ouaddai in Ciad, ci ricordano che la deforestazione indotta dai consumi urbani di legna da ardere ha a che fare con la desertificazione, cioè il principale problema dell’economia dei paesi del Sahel ». millenniourbano, 8 gennaio 2017 (c.m.c.)
«Le rovine di Ouara, l’antica capitale del regno di Ouaddai in Ciad, ci ricordano che la deforestazione indotta dai consumi urbani di legna da ardere ha a che fare con la desertificazione, cioè il principale problema dell’economia dei paesi del Sahel ». millenniourbano, 8 gennaio 2017 (c.m.c.)
Come altri paesi dell’Africa sub-sahariana, il consumo di cemento in Burkina Faso è in piena esplosione e si prevede che aumenti in media del 12% all’anno: nel 2015 esso era pari a 105 milioni di tonnellate e si stima che nel successivo decennio raggiunga i 134 milioni. D’altra parte il tasso di urbanizzazione della popolazione del Burkina Faso sta triplicando dal 1985 e nel 2025 è previsto che raggiunga il 35-40% .
Tali prospettive non hanno lasciato indifferenti i produttori ed ha attirato giganti della produzione di cemento come la società francese Lafarge, la tedesca Heidelberg Cement e il gruppo nigeriano Dangote Cement. Il fondatori di quest’ultima società, Aliko Dangote, è l’uomo più ricco d’Africa ed ha costruito un impero nella produzione di cemento in soli dieci anni e nel 2020, Dangote Cement spera di produrre 100 milioni di tonnellate all’anno.
Paese del Sahel senza sbocco sul mare, il Burkina Faso ha un tasso di urbanizzazione della popolazione di quasi un quarto di quella totale, per circa due terzi residente nelle due maggiori città: Ouagadougou e Bobo Dioulasso. Il fenomeno dell’urbanizzazione del Burkina Faso si basa su una rete di città precoloniali e su centri urbani nati della colonizzazione, ma sono le due maggiori città i poli di attrazione delle migrazioni interne dalle zone rurali verso i centri urbani.
Insieme alle persone verso le città si dirige anche una crescente quantità di legna da ardere. Sono tipiche del paesaggio saheliano le cataste di legna poste nelle vicinanze delle strade ed i camion carichi di legname che trasportano i loro carichi verso le città. La legna raccolta o tagliata nelle zone rurali viene principalmente consumata in città. Il fenomeno, per quanto in crescita così come il tasso di urbanizzazione non è tuttavia nuovo. Le rovine di Ouara, l’antica capitale del regno di Ouaddai in Ciad, ci ricordano che la deforestazione indotta dai consumi urbani di legna da ardere ha a che fare con la desertificazione, cioè il principale problema dell’economia dei paesi del Sahel.
Il processo di urbanizzazione implica una marcata crescita della superficie urbanizzata: tra il 1980 e il 2000 la superficie di Ouagadougou è triplicata, mentre nel trentennio 1976-2006 la popolazione delle città è quasi decuplicata.
Nel caso della capitale essa è passata dei 60.000 abitanti del 1960, anno del passaggio da colonia francese a paese indipendente con la dominazione di Alto Volta, ai quasi 2 milioni odierni. Con l’urbanizzazione, e i cambiamenti economici e sociali connessi, la tradizionale legna da ardere viene soppiantata dal carbone di legna, diventato il combustibile maggiormente utilizzato in quanto meglio trasportabile.
Nelle campagne del Burkina Faso sono per lo più le donne che raccolgono la legna, la portano dei villaggi o sul ciglio della strada o ai mercati locali, per poi essere trasportata con i camion verso le città. Nelle zone rurali, dove le donne cucinano un pasto al giorno, il consumo pro capite di legna da ardere è più contenuto che in città anche grazie alla disponibilità di fonti energetiche alternative (scarti vegetali da agricoltura).
Il fatto che l’urbanizzazione sia una delle maggiori cause del maggior consumo di legna da ardere si spiega anche con il fatto che la popolazione urbana cresce ad un tasso annuo del 4,28% rispetto al 1,14% della popolazione rurale e al 2,13% di quella totale. E se la crescita urbana è fatta prevalentemente di insediamenti informali ai quali mancano le infrastrutture minime proprie dell’ambiente urbano, come una adeguata rete stradale e di approvvigionamento idrico ed energetico, il massiccio prelievo di legna dalle zone rurali a quelle urbane diventa inevitabile per il soddisfacimento dei bisogni deli abitanti degli slum.
L’altra faccia della medaglia di questo fenomeno sono le ricorrenti inondazioni provocate dalle piogge torrenziali a carattere stagionale che colpiscono pesantemente soprattutto gli slum di Ouagadougou lasciando dietro di sé migliaia di senza casa. I poveri delle aree rurali che cercano nelle città condizioni di vita migliori sono da una lato la causa e dall’altro coloro che pagano le conseguenze dell’incontrollato processo di crescita urbana.
Oltre tre quarti della popolazione urbana del Burkina Faso vive negli slum e nel 2015 la Banca Mondiale ha finanziato per ottanta milioni di dollari la realizzazione della rete idrica e fognaria nelle periferie di Ouagadougou. Le iniziative di sviluppo urbano della capitale hanno visto nel 2003 la distruzione di villaggi urbani, posti su 85 ettari di superficie tra il centro di Ouagadougou e il suo aeroporto, per avviare la costruzione di un centro commerciale e amministrativo. Qui vivevano circa 50.000 abitanti che nel corso degli anni sono riusciti a costruire reti economiche informali ma efficienti che hanno permesso a questa popolazione di sopravvivere alle dure condizioni di vita degli slum.
Il progetto ZACA (Zones d’Activités Commerciales et Administratives) aveva anche l’obiettivo di risolvere i problemi legati alla proprietà fondiaria delle aree sulle quali sorgono gli insediamenti informali, di riabilitare il tessuto urbano e di fornire gli ex abitanti della zona con migliori condizioni di vita altrove. Dopo circa un decennio di stallo, recentemente il governo locale ha cominciato a rilasciare i permessi per costruire alcuni settori dell’area di progetto, anche se non molto è cambiato riguardo alle conseguenze sociali e fisiche dello spostamento delle 50.000 persone che abitavano l’area.
Dal 2008, il governo ha messo a punto un programma pluriennale di edilizia sociale grazie al quale nel luglio 2013 sono state consegnate 1 500 case. Il nuovo governo, sorto dopo la fine del regime dittatoriale di Campaoré, sta accelerando lo sviluppo del nuovo polo urbano di Bassinko, un villaggio situato a circa 15 chilometri da Ouagadougou, dove diverse aziende private stanno costruendo 14 000 case. Il progetto di edilizia abitativa Bassinko è il secondo più grande dopo il progetto ZACA.
Con i due terzi della popolazione urbana che vive in case realizzate con mattoni di terra cruda, non c’è quindi da meravigliarsi se i progetti di riqualificazione urbana e di costruzione di nuove unità abitative sostenuti dalle agenzie governative ha come effetto un’impennata della domanda di cemento.
«La questione non sono le “opere” ma la democrazia. La riforma di Renzi era (anche) un esproprio dei poteri di autogestione dei territori». Il Fatto Quotidiano, 29 dicembre 2016 (p.d.)
«Pubblichiamo una parte dell’intervento di Tomaso Montanari, vicepresidente di Libertà e Giustizia, al convegno “Grandi Opere, grandi ombre” organizzato in Senato»
Il 20 dicembre, cioè due settimane dopo il trionfo del No al referendum costituzionale, la Camera ha votato definitivamente la ratifica all’accordo tra i governi italiano e francese per l’avvio dei lavori del Treno ad Alta velocità tra Torino e Lione. Un voto che ha assai più a che fare col passato che col futuro: non solo perché il progetto risale al 1990 (quell’anno, per dire, Sanremo fu presentato da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, e fu vinto dai Pooh), ma perché dimostra in modo plateale la drammatica incapacità della classe dirigente italiana di leggere la direzione in cui si muove il Paese.
Uno dei cuori della riforma costituzionale firmata da Matteo Renzi, infatti, riguardava proprio le Grandi Opere: le si definivano strategiche per l’interesse del Paese, e si stabiliva che esse fossero decise dal governo di Roma, tagliando completamente fuori le Regioni. Il sindaco d’Italia giurava che avrebbe preso quelle cruciali decisioni nell’interesse delle comunità condannate al silenzio, ma quelle comunità non gli hanno creduto.
Uno dei motivi di questa radicale sfiducia è legato proprio all’esperienza nera della Val di Susa. Qui, nella notte di Ognissanti del 2005, mille agenti caricarono un gruppo di manifestanti guidati da numerosi sindaci: “Quindici fasce tricolori. Pubblici ufficiali contro pubblici ufficiali, la forza armata dello Stato mandata a sbaragliare quelli che in teoria erano suoi rappresentanti”.
Quella notte “i No Tav avevano dalla loro tre forze: quella della ragione, quella della disperazione, quella della gravità perché gli agenti erano in numero soverchiante ma spingevano in salita”. Sono brani estratti da uno straordinario libro recente di Wu Ming 1 (Un viaggio che non promettiamo breve. Venticinque anni di lotte No Tav, Einaudi, 2016), che consegna la vicenda della Val di Susa all’epopea nazionale. E permette anche al pubblico più vasto di conoscerla nei minimi, documentatissimi, dettagli: e l’immagine che ne esce non ha a che fare con le Grandi Opere, ma con la questione della democrazia.
La memoria dei sindaci caricati dalla polizia impediva di credere all’immagine sorridente del sindaco d’Italia che sa qual è il bene delle più remote comunità. E invece rafforzava la convinzione che – per dirla con le parole di Papa Francesco – in ogni decisione “devono avere un posto privilegiato gli abitanti del luogo, i quali si interrogano su ciò che vogliono per sé e per i propri figli, e possono tenere in considerazione le finalità che trascendono l’interesse economico immediato”.
L’inderogabilità dell’autodeterminazione delle comunità nel governo del proprio territorio: ecco il vero frutto politico di 25 anni di lotta in Val di Susa. Tra le ragioni del No al referendum c’è anche questa: gli italiani non sono disposti a cedere sovranità su questo punto. Non per caso, alla campagna del No ha attivamente partecipato Nicoletta Dosio, una mitissima cittadina della Val di Susa che la Procura di Torino avrebbe voluto prima agli arresti domiciliari e ora fuori dalla Valle.
D’altro canto, solo chi ignora la nostra storia può stupirsene: il rapporto viscerale tra comunità e ambiente è uno dei tratti più profondi della nostra identità, come dimostra il fatto che la parola “nazione” figuri tra i principi fondamentali della Costituzione (art. 9) solo in rapporto appunto al “paesaggio”, vale a dire al territorio.
Per questo è davvero lunare ascoltare il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino dichiarare, dopo il voto della settimana scorsa, che “la morale è che bisogna sentire le comunità coinvolte. La svolta è arrivata infatti con la nascita dell’Osservatorio nel 2005”. Non ci potrebbe essere un capovolgimento più clamoroso della verità: quel grottesco Osservatorio avrebbe avuto, almeno in teoria, il compito di decidere se fare il Tav o no, ma era presieduto da quello stesso Mario Virano che, come commissario del progetto, aveva invece il compito di realizzarlo senza se e senza ma.
D’altra parte, proprio la verità è la più frequente vittima della battaglia intorno al Tav: si pensi al processo intentato a Erri De Luca (poi assolto) o all’inaudita condanna di una studentessa (Roberta Chiroli), accusata di aver manifestato, nella propria tesi di laurea, un’adesione alle azioni dei no Tav. Capovolgere la verità, ignorare la realtà: la maggioranza di questo Parlamento illegittimo corre spensierata sulla strada che l’ha già portata a sbattere contro il muro del 4 dicembre. I moventi che la guidano sono più forti dello stesso istinto di sopravvivenza, perché hanno a che fare con i grumi di interesse che dettano l’agenda del Paese.
Nel 1974 un leader per nulla ambientalista come Enrico Berlinguer comprendeva che era urgente mettere fine “al sistematico sacrificio degli interessi pubblici più sacrosanti (la salute, la difesa del paesaggio e del patrimonio artistico, l’ordinato sviluppo urbanistico, l’onesto rispetto della legge e dell’equità) agli interessi privati: di parte, di corrente, di gruppi e uomini nella lotta per il potere”. Una lezione del tutto inascoltata, se oggi Enrico Rossi – che si candida a guidare il Pd ‘da sinistra’ – è ben deciso a sventrare la Maremma per un'autostrada che servirà solo a chi la farà, e frontalmente avversata dalle comunità locali.
Ma una cosa il 4 dicembre l’ha insegnata: qualunque rinnovamento della politica si voglia attuare, non può che passare attraverso il rafforzamento del rapporto tra comunità e governo del territorio. Fuori da questo nesso elementare non c’è futuro per la democrazia in Italia.
 «La nozione di beni comuni, riscoperta negli anni 1980, conosce una popolarità crescente fra i militanti di sinistra. Dall’acqua pubblica ai software liberi, la gestione collettiva invalida il mito della privatizzazione come garanzia di efficienza».il manifesto Le Monde diplomatique n. 12, anno XXIII, dicembre 2016 (c.m.c.)
«La nozione di beni comuni, riscoperta negli anni 1980, conosce una popolarità crescente fra i militanti di sinistra. Dall’acqua pubblica ai software liberi, la gestione collettiva invalida il mito della privatizzazione come garanzia di efficienza».il manifesto Le Monde diplomatique n. 12, anno XXIII, dicembre 2016 (c.m.c.)
L’ 11 gennaio 2016, il segretario nazionale del Partito comunista francese Pierre Laurent faceva i suoi auguri per il nuovo anno e offriva un’immagine della «società che vogliamo»: «Un nuovo approccio allo sviluppo in cui sociale ed ecologia si uniscano a profitto dell’essere umano e del pianeta, per una società del benessere e del bene comune». «Bene comune»? Sull’altro fronte dello scacchiere politico, il fondatore del Movimento per la Francia, Philippe de Villiers, fa riferimento allo stesso concetto, ma per giustificare il proprio progetto di ridimensionamento dello Stato: «Lo Stato non esiste più come fornitore di bene comune. Non ha alcun diritto su di noi» (1).
Nel maggio 2016, alcuni mesi dopo l’annuncio del Ritorno dei beni comuni da parte dell’«economista sgomento» francese Benjamin Coriat (2), il liberale Jean Tirole pubblicava Économie du bien commun (3). Nella rubrica del suosito «Nostre idee», l’Associazione per la tassazione delle transazioni finanzia- rie e l’aiuto ai cittadini (Attac) sostiene l’importanza di «promuovere le alternative e recuperare i beni comuni».
Invece, l’Institut de l’entreprise, afferma, attraverso il suo segretario generale, che «le iniziative private si preoccupano del bene comune (4)». È raro incontrare concetti tanto malleabili. Molteplici le declinazioni in ambito politico o universitario: «bene comune», «beni comuni», «common», «commmons»... Da un lato, l’espressione «bene comune» – più o meno sinonimo di «interesse generale» – si è imposto come elemento del linguaggio imprescindibile per i dirigenti di ogni ambiente sociale. Dall’altro, la nozione di beni comuni porta un rinnovamento intellettuale e militante a un movimento sociale caratterizzato, a volte, da un letargo concettuale. È difficile orientarsi... ma non impossibile. Aprile 1985, Annapolis (Stati uniti). In occasione di una conferenza finanziata dalla National Research Foundation, accademici provenienti da tutto il mondo hanno presentato le proprie ricerche sui «commons».
Il termine evoca generalmente una storia antica: quella della trasformazione, all’alba dell’era industriale, delle terre lasciate a pascolo e gestite collettivamente in proprietà private delimitate da recinzioni. Il movimento delle enclosures è considerato come il momento fondante dello sviluppo del capitalismo. È il simbolo dell’emergere della proprietà come diritto individuale: una «rivoluzione dei ricchi contro i poveri», scrive Karl Polanyi (5). I ricercatori riuniti ad Annapolis riprendono il filo di questa storia, sottolineando l’esistenza di molti luoghi nel mondo in cui le terre, le aree di pesca o le foreste continuano a essere gestite come dei commons: risorse condivise all’interno di comunità che organizzano collettivamente il loro sfruttamento.
Secondo i ricercatori, questi sistemi di commons si dimostrano spesso efficaci e limitano lo sfruttamento indiscriminato delle risorse (6). Si assiste a un rovesciamento totale delle tesi elaborate da Garrett Hardin nel suo celebre articolo sulla «tragedia dei beni comuni (7)». È un attacco all’intera ortodossia liberale, per cui la proprietà privata esclusiva è sempre il miglior sistema di assegnazione delle risorse rare. Nel 1990, l’economista Elinor Ostrom ha fatto una sintesi dei principali passi avanti resi possibili dalle ricerche esposte ad Annapolis. Ha insistito soprattutto sulle condizioni isti- tuzionali che permettono di perpetuare i sistemi dei commons, sostenendo che un common non possa esistere sul lungo periodo in assenza di regole sul suo sfruttamento.
Inoltre, sottolinea come queste regole possano essere prodotte e applicate dalle comunità interessate, senza dover ricorrere alla sovrastante potenza dello Stato. Tra i molti esempi che cita, c’è il caso di un’area di pesca in Turchia, dove «a occuparsi del processo di controllo e di applicazione delle regole (...) sono gli stessi pescatori (8)». Nel 2009, queste ricerche le valgono il premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel comunemente chiamato «premio Nobel per l’economia».
In Italia, la riscoperta dei beni co- muni si estende al campo della politica quando, nel 2008, una commissione, creata dal governo di Romano Prodi e presieduta dal giurista Stefano Rodotà, riferisce le proprie conclusioni. Propone una definizione di beni comuni come «quelle cose da cui dipendono l’esercizio dei diritti fondamentali e il libero sviluppo della persona». «Persone giuridiche pubbliche o private», poco importa lo status dei titolari di questi beni i loro «proprietari » (9). In compenso, la commissione insiste sul fatto che le risorse debbano essere gestite conformemente alla loro funzione, per permettere l’esercizio di un diritto.
Definire l’acqua un «bene comune» significa anche che la sua distribuzione, qualunque sia l’attore che la organizza, deve garantire l’accesso a tutti a un’ac-ua sana e in quantità sufficiente.
Sulla base dei lavori della commissione Rodotà, molti movimenti sociali e politici transalpini si sono impadroniti della nozione di bene comune per denunciare il settore privato e lo Stato neoliberale, entrambi incapaci di soddisfare i bisogni collettivi fondamentali (10). Forti di questo principio, nel giugno 2011, 25 milioni di italiani (sui 27 milioni di votanti) si sono pronunciati per via referendaria contro la privatizzazione dei servizi pubblici locali di fornitura di acqua potabile.
Il movimento per il software libero Ma la riscoperta dei beni comuni non si limita alle risorse naturali. Nel 1983, Richard Stallman, giovane informatico del Massachusetts Institute of Technology (Mit), ha lanciato un appello a contribuire al gruppo di discussioneUsenet, proponendo lo sviluppo di un sistema di condivisione liberamente distribuito. Così, fa la sua comparsa il movimento per il software libero, in reazione all’emergere di una fiorente industria del software, che trasforma i programmi informatici in beni commerciali sottoposti al diritto d’autore (copyright) e protetti da restrittive condizioni d’uso (11).
Qui, il codice informatico non è più conside- rato come proprietà esclusiva di un at- tore privato, ma costituisce una risorsa liberamente accessibile che ognuno può contribuire a migliorare. Questi principi di apertura e condivisione sono stati ripresi da diversi commons digitali e applicati alla produzione di enciclopedie (Wikipedia), di database (Open Food Facts) o a creazioni arti- stiche collettive regolate da licenze di Arte libera o di Creative Commons.
Malgrado le loro differenze, tutte le componenti del movimento per i beni comuni mettono in discussione la proprietà privata esclusiva. Il movimento italiano per i beni comuni contesta la privatizzazione dei servizi pubblici; l’interesse per i commons detti «fisici» risponde al selvaggio accaparramento delle terre. In merito invece allo sviluppo dei commons digitali, si oppone alla privatizzazione dell’informazione e della conoscenza: quest’ultima ha assunto un’entità tale che alcuni giuristi parlano di un «secondo movimento di enclosures (12)».
I commons assestano duri colpi a una delle istituzioni centrali del neolibera- lismo, rifiutando il dogma secondo cui il rafforzamento della proprietà privata garantisce una maggiore efficienza economica. I lavori di Ostrom invalidano questo postulato, che viene contraddetto anche nella pratica dallo sviluppo di numerose risorse condivise. Trattandosi di risorse fisiche, i commons poggiano spesso su forme di proprietà collettiva e, come nel caso francese, su strutture cooperative o associazioni fondiarie agricole (Groupements fon- ciers agricoles, Gfa). Quanto ai commons digitali, invece, sono protetti da licenze specifiche, che sovvertono le forme classiche di proprietà intellettuale per favorire la circolazione e l’arricchimento delle creazioni collettive:
General Public License (Gpl), Open Database License (Odbl)... I militanti dei commons, oltre a met- tere in discussione la proprietà privata, criticano anche l’uso deviato della pro- prietà pubblica in un contesto di liberalizzazione generalizzata. Quando lo Stato ha carta bianca per svendere le risorse di cui dispone per risanare le sue finanze, la proprietà pubblica offre le stesse garanzie della proprietà privata? Non si riduce forse a un semplice trasferimento della proprietà nelle mani di un attore che non necessariamente agisce nell’interesse di tutti (13)? Così, si capisce meglio la definizione proposta dalla commissione Rodotà. Insistendo sulla funzione sociale dei beni comuni, i giuristi italiani hanno voluto sostituire alla classica logica dello Stato sociale la proprietà pubblica come custode dell’interesse collettivo la garanzia incondizionata di alcuni diritti.
Questo cambiamento di prospettiva va di pari passo con una lotta contro la burocratizzazione dei servizi pubblici, vista come principale causa della loro incapacità di difendere l’interesse collettivo. La critica delle debo- lezze della proprietà pubblica è al tempo stesso un’esigenza di partecipazione civica, di cui l’esperienza napoletana di Acqua bene comune (Abc) offre un interessante esempio. Nell’enfasi del referendum del 2011, in effetti, la gestione dell’acqua di questa città è stata rimunicipalizzata e affidata a «un’azienda speciale» di diritto pubblico chiamata Abc. Il suo statuto è stato pensato per permettere una gestione democraticae partecipativa, grazie alla presenza di due cittadini nel consiglio di amministrazione e alla creazione di un comitato di sorveglianza a cui partecipano dei rappresentanti dei consumatori e delle associazioni.
In Italia, la risonanza politica del concetto di beni comuni mette in evidenza l’ambiguità del rapporto dei di- fensori dei commons con lo Stato. Il movimento dei commons, nato da una persuasiva critica alla proprietà privata e alle rinunce dello Stato neoliberale, ogni tanto si lascia andare al veemente elogio delle capacità di auto-organizzazione della «società civile». Il rischio è quello di diventare gli «utili idioti» del neoliberalismo, criticando la sacralizzazione della proprietà privata solo per far arretrare lo Stato sociale. Tuttavia, molti ricercatori e militanti sono con- sapevoli del pericolo. Come ricorda Benjamin Coriat, «i beni comuni hanno bisogno dello Stato per svilupparsi, perché deve creare le risorse (a cominciare dalle risorse giuridiche) di cui i commoners [i produttori di beni comuni] hanno bisogno per esistere (14)».
Proibire la vendita di computer abbinati a determinati software l’acquisto di un Pc corrisponde, in pratica, all’acquisto di un computer e di Windows in- centiverebbe per esempio lo sviluppo di software liberi.Si tratta quindi di riaffermare il ruolo dello Stato, riflettendo contemporaneamente sull’evoluzione dei suoi interventi. Questo implica l’elaborazione di un quadro giuridico in grado di favori- re i beni comuni e le strutture come le cooperative capaci di farsene carico, anche in ambito commerciale.
Questo presuppone inoltre l’accettazione che la proprietà pubblica non si limiti a un patrimonio di cui lo Stato può fare un uso discrezionale, ma comprenda l’insieme dei beni e dei servizi destinati all’uso pubblico, che di conseguenza devono essere gestiti nell’interesse di tutti. Bisogna inoltre ricordare che lo Stato sociale ha la vocazione di fornire agli individui gli strumenti temporali e finanziari per sviluppare attività indipendentemente dalla proprietà privata e della ricerca del profitto. I beni comuni invitano quindi a rivedere l’articolazione tra la sfera commerciale, i compiti dello Stato e quel che può essere lasciato all’autoorganizzazione dei collettivi liberamente costituiti. Una bella sfida per la filoso fia politica e, forse, anche una speranza per la sinistra.
(1) «Parlez-vous le Philippe de Villiers?», Bfmtv. com, 7 ottobre 2016.
(2) Benjamin Coriat (a cura di), Le Retour des communs. La crise de l’idéologie propriétaire, Parigi, Les Liens qui libèrent, 2015.
(3) Jean Tirole, Économie du bien commun, Pa- rigi, Presses universitaires de France, 2016.
(4) Frédéric Monlouis-Félicité, «Pour une élite économique engagée», Parigi, L’Opinion, 16
aprile 2015.
(5) Karl Polanyi, La grande trasformazione: le origini economiche e politiche della nostra epoca, Einaudi, 2010.
(6) Cfr. National Research Council, Procee- dings of the Conference on Common Property Resource Management, Washington, DC, Na- tional Academy Press, 1986.
(7) Garrett Hardin, «The Tragedy of the Com- mons», Washington, DC, Science, vol. 162, n° 3859, 13 dicembre 1968.
(8) Elinor Ostrom, Governare i beni collettivi, Marsilio, 2006.
(9) Commissione Rodotà, conclusioni cita- te da Ugo Mattei, «La lutte pour les “biens communs” en Italie. Bilan et perspectives», Raison publique, 29 aprile 2014, www.raison- publique.fr
(10) Si legga Ugo Mattei, «Rendere inalienabili i beni comuni», Le Monde diplomatique/il ma- nifesto, dicembre 2011.
(11) Si legga «Lo strano destino del software libero», Le Monde diplomatique/il manifesto, luglio 2014.
(12) Cfr. James Boyle, «The second enclosure movement and the construction of the public do- main», Durham (Stati uniti), Law and Contem- porary Problems, vol. 66, n° 1-2, inverno 2003.
(13) Cfr. Pierre Crétois e Thomas Boccon-Gibod (a cura di), État social, propriété publique, biens communs, Lormont, Le Bord de l’eau, 2015.
(14) «Ne lisons pas les communs avec les clés du passé. Entretien avec Benjamin Coriat», Contretemps, 15 gennaio 2016, www.contretemps.eu
(Traduzione di Alice Campetti)
 «Chiediamo alle forze politiche che in Parlamento svolgono un’azione di opposizione di mettere in stato d’accusa il Governo della Repubblica, per l’aperta e continuata violazione di un principio costituzionale e per la responsabilità piena e consapevole nel privare i cittadini italiani delle risorse necessarie per la loro sicurezza». il manifesto, 26 gennaio 2017 (c.m.c.)
«Chiediamo alle forze politiche che in Parlamento svolgono un’azione di opposizione di mettere in stato d’accusa il Governo della Repubblica, per l’aperta e continuata violazione di un principio costituzionale e per la responsabilità piena e consapevole nel privare i cittadini italiani delle risorse necessarie per la loro sicurezza». il manifesto, 26 gennaio 2017 (c.m.c.)