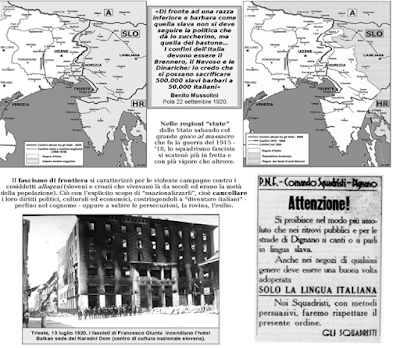il manifesto,
Ha ragione Piero Bevilacqua a sottolineare la «distrazione» nell’attuale campagna elettorale rispetto a un tema strategico come quello dell’istruzione. Esiste però un testo che affronta la decostituzionalizzazione intenzionale cui la scuola è soggetta da 20 anni.
Si tratta della Lip (legge di iniziativa popolare) Per la scuola della Costituzione. L’8 settembre è stata depositata in Cassazione e da qualche giorno è iniziata la raccolta delle firme per proporne la discussione parlamentare. 37 articoli, che abrogano gran parte della normativa degli ultimi 15 anni, dalla riforma Moratti, alla Gelmini, alla «Buona Scuola», tentando di riportare la scuola al modello dettato dagli artt. 3, 9, 33 e 34 della Carta.
Non solo abrogare, dunque, ma anche ri-costruire e ri-portare la scuola all’altissimo rango di organo costituzionale, quale fu pensata – non a caso – nell’Italia che risorgeva sui principi dell’antifascismo. La Lip non si propone di intervenire su tutti gli aspetti della normativa scolastica, ma di disegnare un’idea di scuola. Vi si parla di gratuità e di inclusione, perché la scuola è lo strumento che la Repubblica ha in mano per «rimuovere gli ostacoli»; di laicità (sono vietate le cerimonie di culto negli edifici scolastici; l’IRC è in orario extracurricolare; viene abolito l’inserimento delle scuole paritarie private dal sistema nazionale di istruzione); si prevede un rapporto alunni-docente che scongiuri per sempre le classi pollaio; l’unico insegnamento obbligatorio esplicitamente previsto (la legge non si occupa di programmi e discipline) è quello di Costituzione e cittadinanza; diritto allo studio e all’apprendimento; sapere disinteressato ed emancipante; si rende obbligatorio il terzo anno di scuola dell’infanzia, in previsione della generalizzazione; si abrogano i test Invalsi e il voto numerico alla primaria e alle medie; si ripristinano tempo pieno e prolungato; si riconducono alla loro centralità gli organi collegiali, riaffidandogli prerogative che sono espressione della democrazia scolastica; il biennio è unitario, posticipando così la scelta della scuola superiore – troppo spesso compiuta su base socio-economica – di due anni e garantendo i saperi imprescindibili per tutti più a lungo; l’obbligo al termine della scuola superiore, in modo che la scuola riprenda ad essere ascensore sociale e garanzia di pari opportunità per tutti, nessuno escluso; un presidente del collegio sovrano, eletto dai docenti, affiancherà il dirigente scolastico, con funzioni amministrative; l’autonomia scolastica viene riportata nel suo alveo costituzionale, quello del principio della libertà dell’insegnamento, strumento dell’interesse generale.
L’alternanza scuola lavoro diventa un «percorso di cultura del lavoro», obbligatoria per tutti gli indirizzi di scuola superiore, organizzati dalle scuole, che «possono prevedere, sia l’intervento in aula di esperti/e, oltre a quello degli insegnanti curriculari, sia l’inserimento del/la singolo/a allievo/a in realtà di lavoro e di ricerca nel rispetto degli artt. 2, 35 e 36 della Costituzione». Si effettuano al fine di «garantire agli studenti e alle studentesse attività coerenti con il loro percorso di istruzione, utili per acquisire gli strumenti critici necessari a comprendere non solo gli aspetti operativi della realtà lavorativa analizzata, ma anche il quadro dei diritti e delle responsabilità e il rapporto fra i processi produttivi ed economici e le implicazioni sociali e ambientali».
Grande attenzione, nel testo, al linguaggio di genere e alla purificazione da anglicismi e tecnicismi di matrice anglofona ed economicista. Si prevede di spendere il 6% del Pil nazionale, come da media dei paesi europei: anche per questo la raccolta si affianca a quelle – promosse dal Coordinamento Democrazia Costituzionale – per ripristinare il testo originario dell’art. 81 della Costituzione, eliminando l’equilibrio di bilancio; e per una legge elettorale proporzionale – per sanare tre ferite che gli ultimi parlamenti hanno inflitto alla democrazia nel Paese.
Ribaltare il paradigma corrente, privatistico e classista, disinfestare lo spazio culturale dal dominio del mercato, ricostruire l’equilibrio di diritti e poteri, restituire il sistema scolastico alla funzione di promozione del pensiero critico e della cittadinanza consapevole: questo e tanto altro nel testo che troverete in www.lipscuola.it.
Qui il testo originale dell'articolo

la Repubblica, blog Articolo 9, 14 febbraio 2018. Se la politica fosse quella che il ministro renziano Dario Franceschini ritiene che sia - e di fatto pratica - bisognerebbe vergognarsi di farla. Ma cè un'altra Politica, bella e utile a tutti
Per la seconda volta in poco tempo (la prima qualche giorno fa a Otto e mezzo, la seconda oggi a L’Aria che tira), il ministro uscente per i Beni Culturali Dario Franceschini risponde alle mie obiezioni in materia di governo del patrimonio culturale dicendo che non parlo da storico dell’arte, ma da politico. Ebbene, vorrei rispondergli una volta per tutte: e vorrei farlo perché quella sua affermazione (che è, di fatto, una piccola furbizia mediatica) è capace di rivelare molto circa la concezione della politica che è propria non solo di Franceschini, ma di una larga parte del nostro ceto politico.
C’è innanzitutto un ammiccamento all’antipolitica, un inchino al populismo. Franceschini dice ai cittadini: "badate che Montanari non parla come tecnico autorevole, o come cittadino indignato, ma come politico. E dunque non dice la verità, ma fa propaganda". L’opposizione popolo-politica è il cardine stesso di ogni populismo. Così come la presunzione che il politico sia mendace per natura, e, più in generale, il disprezzo per la politica.
A me non verrebbe mai in mente di dire: "guardate che Franceschini è un politico". Perché ho un’enorme considerazione per la vera politica, e semmai penso proprio il contrario: e cioè che il nostro ministro abbia un’idea assai modesta della politica. Troppo modesta.
Se Franceschini invece ricorre a questo "argomento" è proprio – questo è il paradosso –a causa della sua consumata abilità di professionista della politica come la intende lui. Di politico abilissimo a galleggiare in ogni stagione: un vero e proprio"autoreggente"della politica, come lo definisce Alessandro Gilioli in questo immortale ritratto pubblicato sull’Espresso. Una carriera inaffondabile: Franceschini è in politica dal 1980, quando era già consigliere comunale. Grazie a questa carriera Franceschini ha imparato ad annusare l’aria: e ora sa bene che lui (purissimo politicante da una vita) deve cavalcare l’antipolitica e mescolare le carte. Fino ad arrivare a suggerire che la politica è una cosa sporca, intessuta di menzogne: e che dunque chi parla da ‘politico’ non merita una risposta nel merito.
Ma perché Franceschini mi definisce politico?
Forse perché, con molti altri colleghi storici dell’arte, archeologi, archivisti, bibliotecari abbiamo organizzato un cartello di associazioni che si chiama Emergenza Cultura, e che cerca di difendere le ragioni dell’articolo della Costituzione che dà il nome a questo blog.
O forse ancora perché sono il presidente di Libertà e Giustizia, una associazione di cultura politica, che non dà indicazioni di voto e che è guidata da un consiglio di presidenza composto da persone che nessuno definirebbe "politici" (Sandra Bonsanti, Salvatore Settis, Gustavo Zagrebelsky, Lorenza Carlassare, Nadia Urbinati, Roberta de Monticelli, Paul Ginsborg, Valentin Pazè, Elisabetta Rubini).
O infine perché ho cercato (senza peraltro riuscirci) di costruire una sinistra nuova e radicale, nel cosiddetto percorso del Brancaccio. Un percorso in cui ho annunciato fin dall’inizio che non mi sarei candidato ad alcunché e che concepivo quell’impegno come una forma di cittadinanza attiva. Quello stesso modo di fare politica senza essere un politico per cui oggi ho presentato la proposta di reddito minimo di dignità della Rete dei Numeri Pari di Libera: e non so se Franceschini chiamerebbe "politico" anche don Ciotti, che sedeva al mio stesso tavolo.
Insomma, se un cittadino prova a dedicare una parte della sua vita a invertire la rotta di questa sciagurata società; se prova a intendere la politica non come una cosa che serve a cambiare la sua stessa vita, ma quella di tutti; se prova a correggere i danni fatti dai professionisti della politica, come Franceschini: ecco che questi ultimi si difendono nel più incredibile dei modi: "sei un politico, e dunque non ti rispondiamo".
E così siamo oggi davanti al paradosso di un Franceschini che (vivendo di politica da quando io avevo nove anni, ed essendo oggi candidato al Parlamento) dice che io (che faccio un altro lavoro, e non sono candidato al Parlamento) lo attacco "da politico".
No, signor ministro: io la attacco da cittadino, da storico dell’arte, da intellettuale.E visto che da anni le pago, con le mie tasse, il suo lauto stipendio mi aspetto che risponda ai miei argomenti con altri argomenti. E non con quelli che vorrebbero essere insulti.

Internazionale online, 12 febbraio 2018. Cronaca di una grande dimostrazione contro il rigurgito razzista e fascista, che ha visto a Macerata uno dei suoi momenti più truci nel tentato assassinio di innocenti di colore
“Black lives matter”, le vite dei neri valgono. La vita diJennifer, quella di Wilson, quella di Gideon e quella di tutti gli altri. AMacerata una ragazza nera, che se ne sta in disparte dietro allo striscione deimetalmeccanici, ha scritto su un cartoncino bianco questa frase in inglese.Ricalca lo slogan del movimento antirazzista statunitense, nato nel 2013 perdenunciare le violenze sistematiche della polizia contro i neri. Come tanti, èvenuta a ribadire un principio fondamentale: lo stato moderno nasce dal ripudiodella violenza arbitraria di un essere umano su un essere umano. Vale anche perla repubblica italiana.
A Macerata il 10 febbraio qualcuno è venuto semplicemente adare “un abbraccio collettivo a Wilson Kofi, Omar Fadera, Jennifer Odion,Gideon Azeke, Mahamadou Toure, Festus Omagbon” (come è scritto su unostriscione), cioè a dimostrare solidarietà ai feriti della
sparatoriaavvenuta il 3 febbraio nella cittadina marchigiana, quando LucaTraini, un estremista di destra di 28 anni, ha impugnato una pistola e si èmesso a girare per la città in auto, sparando a caso contro i neri che haincontrato per strada.
Molti cittadini sono scesi in piazza per criticare ladecisione delle autorità di non far visita ai feriti in ospedale, altri hannocontestato la scelta di alcuni partiti e organizzazioni di non partecipare auna manifestazione unitaria contro il razzismo, una settimana dopo lasparatoria. Altri ancora sono arrivati a Macerata per ribadire chel’antifascismo è ancora un valore fondamentale.
Tante ragioni
 |
| fotografia di Michele Lapini |
Il movimento spontaneo che si è materializzato a Macerata il10 febbraio ha portato in piazza diverse rivendicazioni e almeno ventimilapersone: gruppi di attivisti, centri sociali, sindacati come la Fiom, i Cobas el’Usb, alcune sezioni dell’Anpi e dell’Arci, i collettivi antifascisti e quellifemministi, la rete nazionale Non una di meno, alcune organizzazioni comeLibera ed Emergency, parlamentari e partiti come i Radicali italiani di PiùEuropa, Potere al popolo e Liberi e uguali, molti operatori sociali impegnatinel sistema dell’accoglienza come il Gus e infine organizzazioni di migranticome il Movimento di rifugiati e migranti dell’ex Canapificio di Caserta.
“La politica non sopporta vuoti e se le istituzionidemocratiche si ritirano, lasciano il campo ad altre forze violente che sonopronte a riempire questi vuoti, come stanno facendo in questo momento i partitixenofobi e fascisti”, afferma Simona Baldanzi, scrittrice toscana arrivata aMacerata dopo tre ore e mezzo di viaggio in macchina da Barberino del Mugello.Con tre amici dell’Anpi ha portato la bandiera ricamata a mano della BrigataGaribaldi, il gruppo partigiano d’ispirazione comunista che combatté contro inazifascisti durante la resistenza. Per Baldanzi l’antifascismo non è un valoresuperato, ma significa “resistere ai soprusi, combattere le ingiustizie”.
Almeno sessanta sezioni locali dell’Anpi, come quella RenatoBiagetti di Roma,
hanno volutopartecipare alla manifestazione nonostante la decisionecontraria della segreteria nazionale, che aveva deciso di non scendere inpiazza accettando la proposta del sindaco di Macerata Romano Carantini diannullare tutte la manifestazioni. Anche Stefano Bucchioni, delegato deimetalmeccanici della Fiom di Monza, ritiene che non partecipare sia stato unerrore: “Questa timidezza delle istituzioni deve far preoccupare, perché è giàsuccesso all’inizio del novecento e il risultato è stato il ventenniofascista”.
Per Bucchioni l’intolleranza contro gli immigrati èalimentata dalla crisi economica, “causata dalla mancanza di strategieindustriali nel nostro paese e da scelte sbagliate che hanno dato troppo poterealle multinazionali”. Così i capri espiatori diventano gli immigrati, “che sonovenuti in Italia per lavorare, come noi in passato siamo andati in altripaesi”. Un’altra voce critica con i vertici della propria organizzazione èquella di Eliana Como, rappresentante di minoranza della direzione nazionaledel più grande sindacato italiano, la Cgil, che ha definito la scelta dirinunciare a manifestare “sbagliata e in qualche modo irresponsabile”, perché èimportante “opporsi ai segnali di riorganizzazione del neofascismo”.
“Una delle cose che mi scandalizza di più”, continua Como,“è che si sia voluto giustificare il gesto di Traini come una vendetta per ilfemminicidio di Pamela Mastropietro”. Per la sindacalista, si tratta dellastrumentalizzazione del corpo di una donna. Anche le
femministe delmovimento Non una di meno sono d’accordo e chiedono di nonusare la morte di Pamela Mastropietro per giustificare la violenza di LucaTraini. Per l’omicidio della ragazza
sono indagatitre nigeriani e Traini ha riferito di aver deciso di compiereuna strage dopo aver avuto notizia del ritrovamento del corpo smembrato diMastropietro.
Stefania Dimento, di un collettivo femminista maceratese,spiega che “ancora una volta il corpo di una ragazza è usato per giustificarela violenza razziale, contro altri corpi che sono considerati inferiori perchéneri”. Per Dimento la violenza razzista, il sessismo e il fascismo hanno unamatrice comune. La donna, che vive a Macerata, spiega che la città è ancorasotto shock sia per l’omicidio di Mastropietro sia per la tentata stragecompiuta da Traini. Per questo, conclude, voler annullare le manifestazioni ” èil tentativo di far finta di niente, di riportare tutto alla normalità. Maquesto non è possibile. Si deve parlare di quello che è successo”.
L’impressione però è che i maceratesi vogliano rapidamenteuscire dal clamore delle cronache nazionali in cui sono finiti nelle ultime duesettimane. Anche per questo hanno vissuto con ostilità il corteo pacifico chesabato ha attraversato la città. “Fino a due settimane fa i cittadini diMacerata discutevano animatamente delle conseguenze della pedonalizzazione delcentro storico, poi l’omicidio feroce di Pamela Mastropietro e la sparatoriadel 3 febbraio hanno gettato la città nella paura”, spiega una giornalistalocale.
Una città blindata
Quando intorno all’una del pomeriggio attivisti e cittadinida tutta Italia cominciano ad arrivare davanti ai giardini Diaz di Macerata, lacittà è blindata. I poliziotti e i carabinieri in tenuta antisommossa chiudonoil centro storico e i negozi sono sprangati. Alcuni commercianti hanno montatodelle protezioni di legno e ferro sulle vetrine. Il sindaco in una nota suFacebook aveva annunciato che tutte le scuole di ogni ordine e grado sarebberorimaste chiuse e il trasporto pubblico interrotto dalle 13.30. Anche ilcarnevale è stato rimandato al fine settimana successivo. I giornali locali hannotitoli allarmistici.
La decisione di alcune organizzazioni e partiti di nonpartecipare al corteo per il timore di nuove violenze appesantisce il clima chesi respira in città. “Hanno disdetto una manifestazione che non hannoconvocato”, sintetizza Valentina Giuliodori dell’Ambasciata dei diritti delleMarche. Il cielo è carico di nuvole grigie e un freddo umido avvolge i bastioniausteri della città, che lentamente si colorano di striscioni e bandiere.
“La manifestazione antirazzista e antifascista di Macerata èstata convocata già sabato sera (3 febbraio) dal centro sociale Sisma diMacerata, dal Collettivo Antifa e da molti gruppi e movimenti attivi sulterritorio, ma alcuni giochi politici nell’arco della settimana hanno tentatodi sabotarla e di dargli un altro significato”, spiega Giuliodori, primadell’inizio del corteo.
Il raid razzista nelle Marche – avvenuto a un mese dalle elezionipolitiche del 4 marzo – ha stravolto la campagna elettorale italiana e hariportato la questione dell’immigrazione al centro del dibattito, fino a quelmomento dominato da temi come le tasse, le pensioni e il reddito di base.L’opposizione – in particolare la Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – haaccusato il Partito democratico di aver favorito un’immigrazione incontrollata.
All’indomani dell’attentato, il leader di Forza ItaliaSilvio Berlusconi ha annunciato di voler rimpatriare 600mila immigratiirregolari, mentre il leader della Lega Matteo Salvini ha detto che“un’immigrazione fuori controllo, voluta e finanziata in questi anni, portaallo scontro sociale”. Le posizioni della destra hanno finito per creare unatteggiamento giustificatorio intorno alla violenza razzista di Traini.
Dal canto loro, i rappresentanti del Partito democratico,che si giocano un’importante partita elettorale nelle Marche (il ministrodell’interno Marco Minniti è candidato al collegio uninominale di Pesaro),hanno chiesto di abbassare i toni della polemica politica e di nonstrumentalizzare l’accaduto, ma non hanno riconosciuto la matrice ideologicadell’attentato e hanno deciso di non scendere in piazza, per non contrapporsi aun’opinione pubblica sempre più spaventata, secondo i sondaggi, dalla presenzadegli immigrati nel paese. Il ministro dell’interno, parlando a Pesaro duranteun comizio elettorale, pochi giorni prima della manifestazione, avevarivendicato la politica migratoria restrittiva adottata nell’ultimo annoe
l’avevagiustificata dicendo che “aveva visto Traini all’orizzonte”.
E aveva aggiunto: “Ringrazio Anpi, Cgil, Arci e Libera, chehanno accolto la richiesta del sindaco di Macerata di sospendere lemanifestazioni in questo momento così delicato per la città, che ora ha bisognodi pace e di tranquillità. Al tempo stesso mi auguro che anche altreorganizzazioni che hanno annunciato manifestazioni accolgano l’invito delsindaco di Macerata. Se questo non avverrà, ci penserà il ministro dell’internoa evitare tali manifestazioni”.
La paura
Minniti, insieme al leader della Lega Matteo Salvini, è stato uno dei bersaglidegli slogan della manifestazione di sabato. Il ministro è accusato dagliattivisti di aver favorito lo spostamento del corpo sociale a destra conmisure, come i decreti sull’immigrazione e quelli sulla sicurezza urbana, chehanno criminalizzato i migranti. A Minniti è contestata, da alcuni settori della sinistra,anche la chiusura della rotta del Mediterraneo centrale attraverso un accordocon il governo di Tripoli, che ha avuto come conseguenza la detenzione deimigranti nelle carceri libiche per periodi più lunghi, e infine la
campagna dicriminalizzazione delle organizzazioni non governative, che nelcorso dell’estate 2017 ha avvelenato ancora di più il dibattitosull’immigrazione.
Minniti ha giustificato spesso le sue scelte con il timore“per la tenuta democratica del paese” e la necessità di “arginare i populismi”.Ma tra i manifestanti di Macerata molti sospettano che la politica migratoriadel governo, concentrata sull’obiettivo della riduzione degli sbarchi, abbiamostrato le sue contraddizioni più evidenti proprio dopo l’attentato del 3febbraio.
Articolo ripreso da "internazionale online" qui raggiungibile.

Comune-info.net
«Possiamo affrontare il tema del lavoro in modo diverso? Possiamo dire chiaramente che non si difende qualsiasi lavoro? Che non possiamo proteggere la produzione di armi o la produzione di morte come avviene ad esempio a Taranto? È giunto il momento di smettere di produrre “ciò che produce profitto” per dedicarci a ciò che “serve collettivamente per vivere,” spiega Marvi Maggio. “Il tempo liberato dal lavoro è il criterio per capire quanto si stia andando nella direzione della trasformazione sociale…”. I soldi? “Ci sono e vanno dirottati dalle guerre e dagli sgravi alle imprese…Analisi e strategia, un nuovo stato sociale»
Neoliberismo: ruolo dello stato e
della pubblica amministrazione
e privatizzazione
Noi come lavoratori del pubblico impiego siamo colpiti in modo estremo dal neoliberismo, inteso come politica di rivalsa delle classi dirigenti, tesa a riprendere il potere perduto negli anni del dopoguerra e soprattutto negli anni Settanta. David Harvey, geografo marxista, definisce il neoliberismo come politica di restaurazione del potere di classe (quello della classe dirigente, del capitalismo). Una politica che si somma al funzionamento del capitale come motore del sistema economico, con il suo sfruttamento di esseri umani e della natura, con il suo produrre beni e servizi solo per chi può pagare, il suo dissipare risorse e la sua capacità di disumanizzazione. Tratta le cose da persone e le persone da cose. Il neoliberismo è iniziato a fine anni Settanta e continua ancora oggi.
Il neoliberismo è contro le norme ambientali e le norme che difendono i lavoratori, è contro ogni regola che controlli e restringa lo spazio dell’impresa e dell’investimento. È, quindi, contro le norme urbanistiche e paesaggistiche quando dettano regole che riducono la possibilità di estrarre profitto e rendita (intesa come profitto da monopolio).
Tuttavia il neoliberismo e il capitalismo utilizzano lo stato e la pubblica amministrazione come garante dell’ordine sociale che gli è necessario: primo fra tutti del diritto di proprietà. La utilizzano anche perché costruisca con finanziamento pubblico il capitale fisso di cui le imprese (o più in generale il capitalismo) hanno bisogno per funzionare: infrastrutture di trasporto e di connessione in rete in primis. Ne consegue che chi nelle pubbliche amministrazioni contribuisce alla progettazione delle infrastrutture, se queste funzionano dal punto di vista della produzione e realizzazione, contribuisce anche alla produzione di plusvalore. Dico, se funzionano dal punto di vista della produzione e realizzazione, perché alcune infrastrutture potrebbero in effetti essere semplicemente l’effetto di un fenomeno corruttivo: un finanziamento all’impresa costruttrice da parte dello stato anche se si tratta di una infrastruttura non necessaria alla produzione e realizzazione di plusvalore (né al trasporto delle persone). Il neoliberismo da subito si muove contro le leggi che lo ostacolano, abolendo fra l’altro lo stato sociale, per poi sostituirle con le sue leggi.
Il neoliberismo nasce con la Thatcher e Reagan proprio a fine anni Settanta e fa parte di una politica internazionale volta a distruggere tutto quello che avevamo costruito: i movimenti degli anni Settanta nelle scuole, università e posti di lavoro avevano spostato in modo rilevante i rapporti di forza a livello internazionale a favore delle classi subalterne. Il neoliberismo vuole eliminare le leggi e le regole che riducono il potere delle classi dominanti ma ne vuole altre che sostengono il suo potere.
Lo stato non è un corpo unico e univoco: al suo interno ci sono o ci sono stati elementi di welfare, di politiche di riequilibrio territoriale, di promozione di qualità territoriale, e contemporaneamente elementi di controllo, repressione di possibilità, tutte tese a conservare il potere delle classi dirigenti. Gli stessi servizi offerti dallo stato che oggi ci troviamo a proteggere dalla privatizzazione sono gli stessi che sono stati giustamente criticati per la scarsa qualità, l’ideologia e il pregiudizio familistico-democristiano che spesso contenevano, per la scarsa capacità di mettersi in rapporto con i fruitori, per la riduzione e semplificazione della complessità dei destinatari in categorie prestabilite e non verificate. Case solo per famiglie nucleari, scuole che tramandano ideologie del potere e non spirito critico, solo per fare degli esempi.
Ma con il neoliberismo appare sempre più forte il sostegno pubblico alle politiche di sviluppo economico capitaliste, in contrasto netto con qualsiasi ipotesi di qualità ambientale, sociale, territoriale. I piani strutturali e i piani operativi in diverse regioni (gli ex Piani Regolatori Generali) troppo spesso hanno come principale obiettivo politico da realizzare lo sviluppo economico capitalista, che ipotizzano possa essere compatibile con le qualità ambientali e sociali, fatto che però non si realizza mai.
Chi lavora nella pubblica amministrazione assiste a processi di privatizzazione dei servizi, ma anche delle attività di governo: per esempio in Regione Toscana si ampliano i settori che si occupano di appalti di servizi e di progettazione, in cui il compito diventa dettare le regole in base alle quali il servizio verrà offerto o il progetto verrà redatto da soggetti privati, imprese o cooperative.
Accanto a queste attività di esternalizzazione ci sono attività di finanziamento alle imprese, quelle vincenti come recita un adagio neoliberale: sostenere le imprese vincenti e abbandonare quelle perdenti, secondo l’idea (mai risultata vera) che le imprese vincenti traino lo sviluppo delle altre. Ma lo sviluppo che viene sostenuto è lo sviluppo capitalista: uno sviluppo in cui si produce quello che crea più profitto e non quello che è più utile e necessario. E si produce anche quando comporta la distruzione della natura non umana e l’alienazione dei lavoratori e della collettività. Si privatizzano anche le attività di governo quando, per fare un esempio, la pubblica amministrazione assume in toto nei propri piani urbanistici e territoriali quelli redatti da imprese private, immobiliari (tutto iniziò con le aree FIAT) o di settore (cave per esempio).
Con la scusa di promuovere lo sviluppo (capitalista) la Regione Toscana, ad esempio, distribuisce miliardi di finanziamenti europei alle imprese, che sono anche esonerate dalle tasse per il loro presunto ruolo di creare occupazione. Ma di quale occupazione stiamo parlando? Una produzione che risponde ai bisogni sociali e offre valore d’uso a tutti, oppure offre quel valore d’uso solo a chi lo può pagare? Bisogni fondamentali come quello della casa e quello della salute non trovano risposta, anzi ciò che prima, grazie alle lotte del passato (e non al compromesso capitale lavoro), era patrimonio di tutti, viene negato. Tutto quello che abbiamo avuto e abbiamo come diritto lo ha sempre conquistato chi ha lottato davvero per migliorare la situazione e non chi ha fatto compromessi. Ci sono riforme che sono un passo nella direzione di una trasformazione radicale e riforme che sono una scambio al ribasso (e questo descrive il compromesso). La descrizione dello stato sociale come compromesso elide la realtà: è stato conquistato con dure lotte inscritte in una ipotesi di trasformazione complessiva e non come contentino per stare zitti e piegare la testa.
Lavoro per tutti, ma utile per tutti
Oggi c’è un enorme bisogno di lavoro concreto che produce valore d’uso (non alienato).
La società in cui viviamo ha bisogno di una grande quantità di lavoro. Sto parlando di società, non del lavoro alienato di cui ha bisogno il capitalismo, ma del lavoro utile di cui abbiamo bisogno noi tutti.
Abbiamo bisogno di lavoro per far funzionare i servizi da offrire in modo universale: scuola, dagli asili nido, all’università, all’istruzione permanente; sanità a tutti i livelli, consultori; cura degli anziani di qualità e umana; cura del territorio, per garantire qualità idrogeomorfologica ed ecosistemica, per garantire qualità urbana, case per tutti, spazio pubblico, luoghi di incontro; cultura: biblioteche, archivi, teatri, luoghi per prove e per concerti, solo per fare degli esempi. C’è bisogno di numerosi nuovi servizi oltre che di far funzionare quelli che ancora esistono. In Italia un vero stato sociale, come è esistito nel Regno Unito del dopoguerra o nei Paesi Bassi, non è mai esistito.
C’è bisogno di un vero stato sociale ma diverso da quello del passato, diverso per contenuti, modalità organizzative, organizzazione del lavoro e per diritti dei lavoratori (che devono essere molti di più, assoluti e incondizionati). Reagan affermava: basta togliere i finanziamenti ai servizi pubblici e la gente si arrabbierà così tanto del fatto che non funzionino che accetterà di eliminarli e sostituirli con il privato.
Si tratta di dirottare i finanziamenti dalle imprese (e dalla guerra) ai servizi e alla produzione che serva per rispondere ai bisogni della popolazione a basso reddito. Contemporaneamente questa strategia offrirebbe una soluzione ai disoccupati. Si unirebbe la risposta a bisogni sociali di servizi e beni, alla risposta a chi ha bisogno di un reddito.
Ma il lavoro non dovrebbe solo essere utile (produttore di valore d’uso) ma anche non alienato (e questo attiene ai diritti del lavoro). Appare evidente che il lavoro nelle pubbliche amministrazioni oggi sia alienato: non controlliamo nulla di quello che facciamo, molto è lavoro meccanico e burocratico, malgrado i nostri sforzi di dargli senso. La qualità del lavoro che offriamo alla collettività dipende solo in minima parte dal nostro impegno, per il resto dipende da scelte politiche spesso tese a ridurre l’offerta pubblica e la sua qualità per garantire nuovi ambiti di investimento economico per le imprese.
Un lavoro non alienato
La rivendicazione di nuove massicce assunzioni nel settore pubblico per risolvere la domanda sociale (per dare corpo allo stato sociale) e per garantire lavoro ai disoccupati, deve coniugarsi con la rivendicazione di un lavoro non alienato. Non alienato perché i lavoratori conoscono le ragioni, contribuiscono a individuare le soluzioni, a garantire la qualità del lavoro che offrono. E contribuiscono a definire i limiti: pensioni di vecchiaia a 60 e orario. Ci vuole una vera democrazia organizzativa e per far questo il diritto del lavoro deve essere trasformato in meglio.
Siamo in tanti a criticare molti dei servizi pubblici esistenti, come fruitori e come lavoratori. Come lavoratori vediamo un’organizzazione gerarchica, i cui vertici sono scelti con lo spoil system e non sono mai all’altezza del ruolo. Disciplina e valutazioni spinte al massimo, ma non per migliorare le attività, bensì per renderle militari, tese all’obbedienza ai capi (e ai politici al comando) e non alla soluzione dei problemi e alla risposta di domande sociali che sono plurime e non possono essere presunte come faceva lo stato sociale democristiano.
Sono necessari democrazia organizzativa nel lavoro e partecipazione dei fruitori per la conoscenza dei bisogni a cui rispondere e per la definizione del servizio o del bene da offrire.
Non si tratta certo di difendere l’esistente né tanto meno di tornare al passato.
Perché mentre vanno chiesti servizi che rispondano ai bisogni sociali è necessario che siano organizzati direttamente dai lavoratori e dai fruitori, in un contesto di vera democrazia partecipativa (o autogestionaria). Non servizi solo rivolti agli indigenti (come stanno cercando di fare per le case popolari in un ottica neoliberale in base alla quale lo stato può offrire servizi e beni fuori mercato solo agli indigenti, tutti gli altri devono passare attraverso il mercato), ma servizi di alta qualità rivolti a tutti in modo universale.
Questa è una proposta per rispondere con un lavoro non alienato alla domanda di lavoro.
I sintomi sono chiari, ma la vera questione sono le soluzioni. Io credo che la questione cruciale sia lo scenario in cui poniamo le nostre lotte.
Se è quello che propongo, non si difende qualsiasi lavoro, perché non difendo la produzione di armi o la produzione di morte come avviene a Taranto. Non si baratta l’occupazione con la vita e poi una volta morti che conta il reddito? E qui parlo quindi di cosa produco: non deve essere prodotto ciò che produce profitto ma ciò che ci serve collettivamente per vivere, e la produzione non deve distruggere il nostro patrimonio collettivo, il territorio e l’ambiente, la natura (per quanto già seconda natura trasformata dall’interazione con le società nel corso del tempo, conserva sempre una componente di naturalità).
Veniamo poi al lavoratore, all’alienazione dal lavoro, alla perdita di umanità (il lavoratore è alienato dalla sua stessa essenza, poiché il suo non è un lavoro costruttivo, libero e universale, bensì forzato, ripetitivo e unilaterale (Marx paragona l’operaio al Sisifo della mitologia greca). L’organizzazione del lavoro deve essere nelle mani dei lavoratori. Il tempo liberato dal lavoro è il criterio per capire quanto si stia andando nella direzione della trasformazione sociale, come giustamente pensava Marx.
Il punto cruciale è promuovere e costruire una società umana e non alienata, in cui i bisogni delle persone trovino risposta.
Per iniziare ad andare in questa direzione è necessario una massiccia e imponente assunzione di nuovi lavoratori che offrano i servizi in tutti i settori che ho citato (istruzione a tutti i livelli, sanità, cultura, cura anziani, cura dei bambini, cura del territorio) attraverso una organizzazione del lavoro finalizzata al destinatario del servizio, non gerarchica e fondata sulla cooperazione. Un lavoro pubblico che usi soldi pubblici per attività davvero utili e non per rincorrere lo sviluppo capitalista.
Questa ri-pubblicizzazione dei servizi e nascita di nuovi (per esempio per la cura degli anziani) serve ad andare nella direzione opposta della privatizzazione (che è finalizzata ad aprire nuovi settori al mercato capitalista) cioè a rendere di nuovo bene comune il benessere di tutti ottenuto attraverso servizi pubblici. Servizi che non siano organizzati come istituzione totale ma come servizio che riconosce la piena umanità del fruitore. Di conseguenza anche l’organizzazione del lavoro deve trasformarsi rispetto a quella esistente: invece delle gerarche e della competizione (la corsa dei ratti promossa dal governo) cooperazione e umanità.
La tattica del governo è quella di stanziare pochi soldi per il pubblico impiego in modo che la stabilizzazione dei tempi determinati sia in alternativa con gli aumenti stipendiali dei tempi indeterminati, in modo che solo una minoranza possa avere la produttività mentre i disoccupati, che premono fuori, faranno intendere che gli occupati siano dei privilegiati. Il discorso va ribaltato. I soldi ci sono e vanno dirottati dalle guerre, dagli sgravi alle imprese, dalle infrastrutture non funzionali che ai profitti delle imprese di costruzione, e dai politici e sottosegretari, al lavoro utile e necessario, in modo da sottrarre settori alle imprese, e al capitalismo e alla sua logica segregante, alienante, escludente e disumana, per renderli un nuovo bene pubblico.
 il manifesto, 15 febbraio 2018 Mentre la lista di "estrema" sinistra Potere al popolo(dove sono le "sinistre" non estreme?) sta superando la soglia per entrare in Parlamento, ecco un finalmente un documento politico che affronta i problemi che gli altri trascurano
il manifesto, 15 febbraio 2018 Mentre la lista di "estrema" sinistra Potere al popolo(dove sono le "sinistre" non estreme?) sta superando la soglia per entrare in Parlamento, ecco un finalmente un documento politico che affronta i problemi che gli altri trascurano
Un gruppo di urbanisti, architetti, agronomi, ecologi, ambientalisti, attivisti ha lanciato un appello perché nella campagna elettorale e nel voto del 4 marzo assuma rilievo politico la città, il territorio e l’ambiente. I promotori dell’appello, Ilaria Boniburini, Paolo Cacciari, Eddy Salzano, Sergio Brenna, Guido Viale, Enzo Scandurra, affermano che non c’è più tempo per trasgiversare.
«I cambiamenti climatici, inquinamenti, perdita della biodiversità e della fertilità dei suoli, rarefazione delle risorse naturali, devastazione del paesaggio, emarginazione dei soggetti più fragili, la lotta di tutti contro tutti ci dicono che il nostro habitat è prossimo al collasso».
La politica dei partiti ha ignorato la dimensione fisica, territoriale e ambientale delle scelte politiche. La pianificazione pubblica è stata delegittimata per lasciare campo libero alle singole iniziative immobiliari, alle «grandi opere», all’urbanizzazione selvaggia, alle forze economiche di mercato, alle rendite immobiliari e finanziarie. Nel nostro paese non vi è mai stata una visione strategica per un uso ecosostenibile e condiviso del territorio.
Non è solo una crisi «nel» sistema, né una crisi solo italiana. E’ una crisi «del» sistema capitalistico e dell’attuale modello di sviluppo, che brucia risorse naturali vicine all’esaurimento e restituisce scarti tossici non metabolizzabili, che espelle gli abitanti meno abbienti e più fragili dal loro habitat e produce diseguaglianze sempre più accentuate.
Il sistema va profondamente cambiato, a partire dalle sollecitazioni dei comitati, movimenti e associazioni che agiscono in difesa della salute e della qualità dei territori, dell’agricoltura contadina, del diritto alla città, e del patrimonio naturale e storico.
Un’idea convincente di ciò che occorre fare è espressa nel programma elettorale di Potere al popolo:
* rivendicare un radicale cambiamento negli investimenti pubblici. Le risorse finanziarie destinate alle missioni militari, alle «grandi opere» (come il Mose, la Tav in Val di Susa, la Pedemontana) e ad altri progetti ambientalmente dannosi (come la Tap, le trivellazioni petrolifere, l’eolico selvaggio), in quanto dispendiosi, devastanti, spesso del tutto inutili che impoverisco territori e indebitano i cittadini, dovrebbero essere destinati al benessere di tutti gli abitanti;
* un massiccio programma di manutenzione e cura del patrimonio naturale, infrastrutturale ed edilizio, a partire della messa in sicurezza idrogeologica e sismica;
*centralità della salute ambientale nelle scelte di sviluppo economico, culturale e sociale: dalla tutela della qualità dell’aria e dell’acqua alla sovranità e qualità alimentare; dall’eliminazione dell’energia da combustibili fossili e altre fonti ambientalmente dannose, alla bonifica dei siti inquinati, dal potenziamento di una mobilità sostenibile e il trasporto pubblico allo stop del consumo di suolo; dalla ripubliccizazione della acqua, a una gestione dei rifiuti basata sulla loro riduzione, riuso e riciclo;
* priorità della vivibilità delle città sugli interessi della rendita: da un piano di riqualificazione delle periferie a un potenziamento dei servizi pubblici, da un piano straordinario di alloggi sociali a una nuova legge per il controllo degli affitti; da una pianificazione democratica dei territori e un reale decentramento delle decisioni al prevalere delle virtù sociali della cooperazione, solidarietà, mutualismo e valorizzazione delle differenze.
Il testo integrale dell’appello e l’elenco dei firmatari è pubblicato su eddyburg.it
PRIMI FIRMATARI:
Maurizio Acerbo, Paolo Baldeschi, Piero Bevilacqua, Giancarlo Consonni, Lidia Decandia, Enzo Di Salvatore, Maria Pia Guermandi, Susanna Böhm Kuby, Giorgio Nebbia, Cristina Quintavalla, Maria Rosa Vittadini, Alberto Ziparo

globalproject, L'Huffington post, il manifesto,
Huffington post
«TEMPO DI RISCATTO E INSUBORDINAZIONE»
OLTRE 30.000 aA MACERATA CONTRO OGNI
FASCISMO, SESSISMO E RAZZISMO
Migliaia di persone - giunte da tante città d’Italia e da ogni angolo delle Marche – hanno raggiunto i giardini Diaz a Macerata per la grande manifestazione contro ogni fascismo, sessismo e razzismo, convocata dai movimenti dopo la tentata strage fascista della scorsa settimana. Sono tantissimi anche gli abitanti di Macerata, ribaltando quella ricostruzione fatta ad hoc dai media mainstream, di una «città chiusa, blindata e ostile».
L’unico a voler blindare, e addirittura impedire, la piazza di Macerata di oggi è stato il ministro dell’Interno Marco Minniti. Ma, nonostante il tentativo d’intimidazione e la minaccia politica, d, oggi Macerata è attraversata da una moltitudine di persone che hanno scelto di esprimere la propria indignazione, la propria indipendenza, ripristinando dal basso l’agibilità democratica.
«Ci sono momenti in cui la storia si comprime, dove tutto sembra accadere in un lasso di tempo troppo breve perfino per rendersene conto. L’ultima settimana maceratese ci ha forse insegnato che della storia occorre esserne parte, senza tirarsene indietro, declinando la tanto sbandierata responsabilità in altri termini». Questo dicono i compagni e le compagne del centro sociale Sisma, che per primi hanno respirato l’angoscia di questi giorni, ma anche il senso di un riscatto collettivo, che da subito si è messo in moto.
Mentre ancora dovevano arrivare decine di pullmann, i giardini Diaz già erano stracolmi di gente. «Siamo tantissimi e tantissime e stiamo aspettando ancora che arrivino numerosi. Siamo qui per dire che noi siamo la vita, loro sono la morte, loro l'odio noi la gioia. Loro sono quelli che respingono, noi quelli che accolgono». dicono dal camion d'apertura prima della partenza del corteo.
La manifestazione di oggi è una grande vittoria almeno per due ragioni: innanzitutto perché contro tutto e conto tutti si è riusciti a strapparla a chi cavalca il clima di paura anziché dare la possibilità a chi vuole combatterlo di scendere in strada. La seconda ragione è che è stata una vittoria collettiva, costruita insieme alle tante e ai tanti insubordinati che hanno continuato ad inviare appelli e adesioni nonostante le minacce velate del ministero, ai tanti che si sono rifiutati di cedere ai diktat di chi dall’alto voleva imporre “la rinuncia” e anche grazie ai tanti maceratesi che hanno riscattato la storia della città partecipando alla costruzione di questa giornata.
Paolo dei centri sociali delle Marche interviene alla partenza del corteo: «tantissime persone stanno invadendo le strade nonostante i tentativi istituzionali di fermare questa manifestazione, nonostante i tatticismi elettorali delle grandi organizzazioni della “sinistra”, subordinate al Pd. Quello che è accaduto, una sparatoria fascista su donne e uomini migranti e tutto quello che ne è conseguito, ci ha portato a indire questo corteo. Lo abbiamo fatto per dire che siamo tutti antirazzisti, perché siamo convinti che solo il legame sociale fra gli ultimi, fra chi subisce questo sistema economico, può rappresentare la forza per cambiare al mondo. Perché solo i movimenti sociali reali possono cambiare la realtà». E ancora: «Caro Minniti se il tentativo era imporci il silenzio, ci sembra che tu abbia fallito. L’insubordinazione che abbiamo visto in questi giorni è qualcosa di inedito e di estremamente potente».
«Siamo migliaia, siano insubordinati, siamo semplici cittadini. Grazie a tutti, era necessario dare una risposta forte. Stiamo dimostrando insieme che Macerata è una città degna della tradizione antifascista che porta» dice Simone del centro sociale Sisma, dando il benvenuto alle tantissime persone giunte a Macerata. Mentre il corteo giunge in fondo a via Pantaleoni, avendo percorso già diverse centinaia di metri, molte persone ancora devono partire dai giardini Diaz. Dal palco viene annunciata la presenza di oltre 20.000 manifestanti; anche se i numeri sono destinati ad aumentare, visto che diversi autobus ancora devono arrivare a Macerata.
Determinazione e insubordinazione sono concetti che emergono anche in altri interventi dal camion, che si susseguono in continuazione. «La determinazione delle tante e dei tanti che sono oggi a Macerata ha smascherato i tentativi di normalizzare il fascismo. Grazie a tutte e tutti quelli che sono qui», dice Pierpaolo dell’Ambasciata dei diritti delle Marche.
Intervengono anche diversi iscritti ai circoli Anpi, che nei giorni scorsi hanno disobbedito al tentativo della loro organizzazione di sabotare la manifestazione di oggi. «Ringrazio i compagni delle Marche per non aver ceduto alle minacce di Minniti. Io sono iscritto all'Anpi e sono qua per mio padre, che era partigiano, e per respingere il fascismo. Un fascismo al servizio di chi vuole tutelare i privilegi e chi vuole che gli sfruttati si combattano tra di loro» sono le parole di un iscritto del Veneto.
Nel frattempo giungono notizie di manifestazioni di solidarietà a quella di Macerata che in questo momento si stanno svolgendo in diverse città d'Italia e d'Europa. A Cosenza, proprio in questi minuti, antifascisti e antifasciste stanno contestando la presenza del leader di Forza Nuova Roberto Fiore. Nel corso del corteo tantissime persone si affacciano dalle finestre e dai balconi per salutare i manifestanti. Con la manifestazione giunta quasi a metà percorso, la coda si è appena messa in marcia: sono presenti oltre 30.000 persone, un numero impressionante per una città "di provincia".
Continuano gli interventi. Mamadou, del movimenti migranti e rifugiati di Caserta, ricorda i 7 migranti uccisi a Castel Volturno nel 2008, vittime della criminalità organizzata e del razzismo. In piazza ci sono centri sociali provenienti da tutta Italia. Marco Baravalle, dei centri sociali del Nord-Est, ricorda Pamela «che è stata uccisa due volte e la seconda è quando hanno strumentalizzato la sua morte. Anche questo è decidere sul corpo delle donne».
Da Napoli Eleonora del centro sociale Insurgencia: «Quello che è successo oggi è la cosa più bella e potente che poteva succedere. Vogliono farci credere che il fascismo ha conquistato la società. Oggi abbiamo dimostrato che quando i fascisti scendono in strada sono quattro gatti, quando lo facciamo noi siamo migliaia. Oggi il Ministro Minniti dovrebbe dare le dimissioni! Grazie Macerata per aver rimesso le cose apposto e per averci ricordato che l'unica lotta che ha senso è dal basso verso l'alto». Luca dei centri sociali di Roma: «Dobbiamo ribaltare il paradigma di un paese che prova ad alimentare la guerra tra poveri. A Roma nelle prossime settimane sono previste diverse iniziative antifasciste e antirazziste. Ci difenderemo dalla barbarie con ogni mezzo necessario».
«Oggi Macerata dà una grande risposta moltitudinaria contro i fascisti e contro chi istituzionalmente fa il loro gioco. E oggi è successo l'impensabile, perchè la base di Anpi, Arci e Cgil oggi ha realmente disobbedito ai loro vertici, scendendo in piazza con noi» dice Alessandro dello spazio sociale Arvultura di Senigallia. Interviene anche Vittoria di Veneto Accoglie: «la scorsa settimana siamo andati in migliaia a Chioggia e oggi siamo a Macerata perché su diritti e accoglienza si gioca una battaglia decisiva per l'umanità. A chi ci vuole divisi rispondiamo oggi uniti. Nessuno spazio ai razzisti, ai fascisti, a Minniti, a Salvini!»
In piazza anche le realtà di lotta per il diritto all’abitare. Per Paolo dei Blocchi Sociali Metropolitani di Roma: «non possiamo lasciare il disagio sociale nelle mani dei fascisti e dei leghisti. Italiani e migranti sono un unico fronte sociale e l'insubordinazione di chi è oggi in piazza è comune». Tutti gli interventi rimarcano la questione del sessismo e la necessità di riaprire ancora di più spazi di lotta femminista nella nostra società. Un’attivista di Non una di Meno prende la parola: «oggi le femministe di tutta Italia hanno raccolto l'invito di Macerata. Le attiviste che hanno aderito al corteo sono state minacciate e oggetto di stalking. Vogliamo spazi che siano abitabili per tutte e tutti e non solo per l'uomo bianco e ricco. Antirazzismo e antisessismo sono nel nostro DNA».mL’antirazzismo si intreccia con le pratiche solidali e di mutualismo. Per questa ragione anche le Brigate di Solidarietà Attiva hanno aderito al corteo di oggi.
Il corteo ritorna ai giardini Diaz. Una manifestazione immensa, che potrà realmente sovvertire l'involuzione reazionaria che stiamo vivendo, in Italia e non solo. Nell'intervento finale Nicola, dei centri sociali delle Marche, ringrazia le donne e gli uomini liberi e antifascisti che, con questa piazza, mettono una pietra tombale su chi diceva che l'antifascismo era minoritario. «Noi ci siamo! Ringraziamo chi ha resistito al ministro Minniti, al Partito Democratico, ai fascismi! Ringraziamo chi è venuto qua a metterci corpo e faccia. Ringraziamo tutti quelli che sono qua. Speriamo che oggi da Macerata possa nascere qualcosa di nuovo. Oggi non abbiamo voluto un palco, perché non è una fine, ma un inizio. Dobbiamo ripartire dai territori, dalle periferie, dal lavoro e dalle scuole. Questo paese è ancora antifascista e da oggi cominciamo a riprendercelo con ogni mezzo necessario».
Qui l'articolo di globalproject completo di immagini e filmati
«PERCHÈ IL PD E LE ISTITUZIONI NON SONO QUI?»
intervista di Gabriella Cerami a Gino Strada
Gino Strada guida la delegazione di Emergency al corteo contro il razzismo e il fascismo a Macerata
Gino Strada guida la delegazione di Emergency. Sono stati tra i primi ad arrivare ai Giardini Diaz di Macerata dove c'è il concentramento del corteo contro il razzismo e il fascismo a una settimana esatta dagli spari di
Luca Traini contro gli immigrati.
Il presidente di Emergency si chiede però come mai non ci siano in piazza anche le Istituzioni e il Pd. «Intervenire sarebbe doveroso. È il compito delle istituzioni. Invece ho sentito le istituzioni e il sindaco Pd che in questi giorni hanno invitato a non manifestare. Credo che ci sia un affievolimento dell'antifascismo e bisognerebbe chiederlo a loro perché non sono qui a Macerata. Quell'atto di terrorismo è successo qui. Quando hanno fatto saltare in aria molti ragazzi nei bar d'Europa, non hanno fatto le manifestazioni a Tunisi, le hanno fatte a Parigi o a Barcellona. Perché oggi non sono qui a Macerata? Hanno paura di qualche potenziale terrorista? Vanno isolati perché quando li si isola anche politicamente non si manifestano».
CONTRORDINE MINNITI
IL CORTEO DI MACERATA NON SARà VIETATO
di Mario Di Vito
Oggi in piazza. La prefettura revoca il divieto alla manifestazione: non sussistono ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Il sindaco chiude le scuole e ferma il carnevale dei bambini di domani. La diocesi lo segue: oggi le chiese non apriranno
È il giorno dell’antifascismo a Macerata. A una settimana esatta dalla sparatoria di Luca Traini, la città si appresta a ospitare il corteo organizzato dal centro sociale Sisma, al quale hanno aderito decine e decine di associazioni da tutta Italia, con quaranta pullman in arrivo da Trento a Palermo.
Il raduno è previsto alle 14.30 ai giardini Diaz e il percorso si snoderà intorno alle mura della città per poi tornare al punto di partenza. Secondo gli organizzatori - che assicurano si tratterà di un corteo «assolutamente pacifico» - arriveranno almeno cinquemila persone. Il sindaco Romano Carancini, dopo aver invocato uno stop a tutte le iniziative, con un’ultima dichiarazione ha quasi corretto il tiro: «Condivido pienamente i valori della manifestazione antifascista. I miei dubbi erano solo sull’opportunità del momento, visto il clima che si respira in città». Il primo cittadino ha anche deciso di chiudere le scuole per oggi e di annullare il carnevale dei bambini di domani. La diocesi lo ha seguito pronta chiudendo le chiese in centro città, stop a messe e catechismo, e invitando i cittadini a rimanere chiusi in casa e pregare.
Il segretario del Pd Matteo Renzi chiede di «non consegnare il paese agli estremisti», continuando a mettere fascisti e antifascisti sullo stesso piatto della bilancia. La risposta arriva dal leader di Leu Pietro Grasso: «La piazza si può gestire in modo ordinato e sicuro, negandola si creano più tensioni. Cavalcare la paura non fa bene al paese». Sulla tentata strage di Luca Traini ieri è intervenuto anche il premier Paolo Gentiloni: «Il dibattito politico è libero, la giustificazione del fascismo è fuori dalla Costituzione italiana», ha detto durante l’apertura della campagna elettorale della federazione Pd di Ascoli Piceno. «Non scambiamo la situazione migratoria che stiamo affrontando con quella della sicurezza», ha proseguito, contraddicendo la linea Minniti, «Chi soffia sul fuoco trova spazio. Ma noi lavoriamo dalla parte opposta».
La questura di Macerata, a ben guardare, non ha mai vietato il corteo di oggi, e nei giorni scorsi sul centro sociale Sisma si è scatenata una incredibile tempesta di fake news istituzionali quando dopo il famigerato appello del sindaco, le segreterie nazionali di Cgil, Anpi, Arci e Libera avevano deliberatamente parlato di annullamento della manifestazione. Infine il comunicato un po’ surreale della prefettura, arrivato nella tarda serata di mercoledì, nel quale si diceva che ogni corteo sarebbe stato vietato. Tesi poi ribadita dal ministro Minniti con una dichiarazione: il risultato è stato una gran confusione sui social network, con tante persone a chiedersi se alla fine si sarebbe fatto qualcosa o no a Macerata. Poi ieri pomeriggio la prefettura ha sciolto ogni riserva, nel prendere atto «dell’impegno degli organizzatori a garantire il carattere pacifico della manifestazione» ha decretato che «non esistono ragioni di ordine e sicurezza pubblica per un provvedimento di divieto»: è il via libera definitivo.
Già tre giorni fa il leader di Casapound Simone Di Stefano si è fatto la sua passeggiata elettorale in centro con tanto di cronisti al seguito, mentre giovedì sera è stata la volta di Roberto Fiore, accompagnato da una trentina di militanti di Forza Nuova. La nottata è stata piuttosto tesa: arrivati nella centralissima piazza della Libertà, i manifestanti di ultradestra sono entrati in contatto con gli agenti di polizia in assetto antisommossa. Risultato: sei contusi lievi e quattro fermati, mentre poco distante un pugno di antifascisti protestava gridando «assassini» e «terroristi» all’indirizzo di Fiore e dei suoi. La tensione si è sciolta nel giro di una mezz’ora.
Il clima non è dei migliori in città, e non soltanto perché per oggi è prevista una leggera pioggerella, in aggiunta alle consuete temperature rigide. Come in uno stanco gioco delle parti, diversi militanti locali del Pd continuano ad evocare lo spettro di una piazza violenta, chiedendo un non meglio precisato «rispetto» per una Macerata sconvolta dai fatti delle ultime due settimane. Rispettare la città, però, significa anche dire no al fascismo. E rispetto, d’altra parte, meritano anche Wilson Kofi, Omar Fadera, Jennifer Otiotio, Gideon Azeke, Mahamadou Toure e Festus Ogmabon. I sei ragazzi rimasti feriti dalla follia fascista di Luca Traini.

il manifesto e la Repubblica.
CHI ÈSCESO IN PIAZZA
CI HA SALVATO LA FACCIA E LA COSTITUZIONE
di Marco Revelli
Macerata ritorna umana. Nonostante il coprifuoco di un sindaco dal pensiero corto, che ne ha reso spettrale il centro storico. Nonostante il catechismo sospeso e le chiese chiuse da un vescovo poco cristiano. Nonostante gli allarmi, i divieti, le incertezze della vigilia. Nonostante tutto. Un’umanitá variopinta, consapevole e determinata, l’ha avvolta in una fiumana calda di vita, ritornando nei luoghi che una settimana prima erano stati teatro del primo vero atto di terrorismo in Italia in questo tormentato decennio. Un terrorismo odioso, di matrice razzista e fascista, a riesumare gli aspetti più oscuri e vergognosi della nostra storia nazionale.
Era un atto dovuto. La condizione per tutti noi di poter andare ancora con la testa alta. Senza la vergogna di una resa incondizionata all’inumano che avanza, e rischia di farsi, a poco a poco, spirito del tempo, senso comune, ordine delle cose. Un merito enorme per questo gesto di riparazione, va a chi, fin da subito, ha capito e ha deciso che essere a Macerata, ed esserci in tanti, era una necessità assoluta, di quelle che non ammettono repliche né remore. A chi, senza aspettare permessi o comandi, nonostante gli ondeggiamenti, le retromarce, le ambiguità dei cosiddetti «responsabili» delle «grandi organizzazioni», si è messo in cammino. Ha chiamato a raccolta. Ha fatto da sé, come si fa appunto nelle emergenze.
Il Merito va ai ragazzi del Sisma, che non ci hanno pensato un minuto per mobilitarsi, alla Fiom che per prima ha capito cosa fosse giusto fare, ai 190 circoli dell’Arci, alle tante sezioni dell’Anpi, a cominciare da quella di Macerata, agli iscritti della Cgil, che hanno considerato fin da subito una follia i tentennamenti dei rispettivi vertici.
Alle organizzazioni politiche che pur impegnate in una campagna elettorale dura hanno anteposto la testimonianza civile alla ricerca di voti. Alle donne agli uomini ai ragazzi che d’istinto hanno pensato «se non ora quando?». Sono loro che hanno «salvato l’onore» di quello che con termine sempre più frusto continua a chiamarsi «mondo democratico» italiano impedendo che fosse definitivamente inghiottito dalla notte della memoria. Sono loro, ancora, che hanno difeso la Costituzione, riaffermandone i valori, mentre lo Stato stava altrove, e contro.
Tutto è andato bene, dunque, e le minacce «istituzionali» della vigilia sono alla fine rientrate come era giusto che fosse. Il che non toglie nulla alle responsabilità, gravi, di quei vertici (della Cgil, dell’Arci, dell’Anpi…) solo parzialmente emendate dai successivi riaggiustamenti. Gravi perché testimoniano di un deficit prima ancora che politico, culturale. Di una debolezza «morale» avrebbe detto Piero Gobetti, che si esprime in una incomprensione del proprio tempo e in un’abdicazione ai propri compiti.
Non aver colto che nel giorno di terrore a Macerata si era consumata un’accelerazione inedita nel degrado civile del Paese, col rischio estremo che quell’ostentazione fisica e simbolica di una violenza che del fascismo riesumava la radice razzista, si insediasse nello spazio pubblico e nell’immaginario collettivo, fino ad esserne accolta e assimilata; aver derubricato tutto ciò a questione ordinaria di buon senso, o di buone maniere istituzionali accogliendo le richieste di un sindaco incapace d’intendere ma non di volere, accettando i diktat di un ministro di polizia in versione skinhead, facendosi carico delle preoccupazioni elettorali di un Pd che ha smarrito il senno insieme alla propria storia e rischiando così di umiliare e disperdere le forze di chi aveva capito…
Tutto questo testimonia di una preoccupante inadeguatezza proprio nel momento in cui servirebbe, forte, un’azione pedagogica ampia, convinta e convincente. Un’opera di ri-alfabetizzazione che educasse a «ritornare umani» pur nel pieno di un processo di sfarinamento e di declassamento sociale che della disumanità ha ferocemente il volto e che disumanità riproduce su scala allargata. Quell’ opera che un tempo fu svolta dai partiti politici e dal movimento operaio, i cui tardi epigoni ci danzano ora davanti, irriconoscibili e grotteschi.
Negli inviti renziani a moderare i toni e a sopire, mentre fuori dal suo cerchio magico infuria la tempesta perfetta, o nelle esibizioni neocoloniali del suo ministro Minniti, quello che avrebbe voluto svuotare le vie di Macerata delle donne e degli uomini della solidarietà allo stesso modo in cui quest’estate aveva svuotato il mare delle navi della solidarietà, quasi con la stessa formula linguistica («o rinunciate voi o ci pensiamo noi»).
Il successo della mobilitazione di ieri ci dice che di qui, nonostante tutto, si può ripartire. Che c’è, un «popolo» che non s’è arreso, che sa ancora vedere i pericoli che ha di fronte e non «abbassa i toni», anzi alza la testa. Ed è grazie a questo popolo che si è messo in strada, se del nostro Paese non resterà solo quell’immagine, terribile e grottesca, di un fascista con la pistola in mano avvolto nel tricolore.
il manifesto
«IRRIDUCIBILI DELLA DEMOCRAZIA»
UNA SINISTRA UNITA SENZA I PARTITI
di Luca Pakarov
«Presenti i centri sociali da tutta Italia. Bus cancellati, allarmi assurdi dei quotidiani locali, negozi sbarrati. Ma è stata una festa di popolo»
La risposta di Macerata, ma di quasi tutta l’Italia antifascista e antirazzista, c’è stata. I km dell’anello che circonda le mura medievali della città hanno manifestato quasi 20mila persone. Qualcosa che non si era mai visto e che ha rotto l’isolamento di una piccola provincia.
In una mattina gelida e senza sole, già dalle 11 è cominciato l’assembramento ai giardini Diaz, con i ragazzi dei centri sociali che organizzavano il servizio d’ordine e distribuivano volantini. Visto lo spazio ristretto della piazza davanti al parco, man mano che arrivavano i pullman da ogni parte d’Italia la testa del corteoavanzava, fino a fermarsi in viale Trieste. Da lì, allle 15 è partito, in un clima finalmente disteso e gioioso. Un paio d’ore di di musica e colori, benefica decompressione, in cui tutti quelli che hanno deciso di partecipare sono riusciti a liberarsi delle tensioni accumulate nella settimana.
Tutto il contrario di come era stato prospettato dai quotidiani locali, ancora ieri in prima pagina con titoli allarmistici, come «Barricati» o «Strade deserte e clima da coprifuoco» e le foto dei pochi che, al pari dell’arrivo di un ciclone, avevano bollato con tavole di legno l’ingresso delle loro attività. Quelli aperti sono stati sì presi d’assalto, ma dai clienti. Le forze dell’ordine con una presenza massiva ma defilata e mai invasiva, hanno serrato gli accessi al centro storico evitando ogni tipo di contatto.
Le scuole erano state chiuse, i mezzi pubblici fermati e le arterie principali interdette al traffico, un’ordinanza vietava la somministrazione di bevande in bottiglie di vetro. Una serie di misure che a un abitante non avvezzo alle grandi manifestazioni aveva fatto pronosticare il peggio, così già da ieri sera le strade erano vuote e i parcheggi liberi. Chi individualmente o con le basi di gruppi di appartenenza come Libera, Anpi, Cgil e Arci che hanno deciso a un certo punto di partecipare, hanno spinto il motore di questa giornata rappresentato dai centri sociali, arrivati con quasi 50 pullman. Una risposta, la loro, immediata e unanime, a cui poi si sono unite tutte le sigle, a partire dalla Fiom.
Egidio del centro sociale Insurgencia di Napoli è chiarissimo: «Questa è una chiamata per gli irriducibili della democrazia. Quello che è accaduto dopo l’attentato terroristico di Macerata è imbarazzante, le forze politiche e le organizzazioni di categoria non si sono dimostrate all’altezza rispetto al fenomeno del fascismo e del razzismo dilagante in questo paese».
Una festa di civiltà e rispetto, dove c’è stata una scelta precisa, quella di non avere un palco finale né di annunciare chi, dai microfoni della testa del corteo, ha parlato in nome dell’antifascismo. Nessun nome, come per un po’ sono state le vittime di Traini. Da quei microfoni si sono levate tante voci di resistenza che hanno preso di mira soprattutto il ministro Marco Minniti e il sindaco. Si è trattata di una piazza multirazziale, composita e eterogenea nel rivendicare le colpe di chi la voleva far tacere.
Ai più è sembrato uno spartiacque fra la sinistra partitica e quella che cerca di lavorare sul territorio, Jacopo del centro sociale Rivolta di Marghera ci dice: «Da noi il razzismo è il pane quotidiano. La cosa assurda è che chi governa la nostra regione ha additato prima al sud e poi ai migranti le colpe della crisi economica. Nei nostri territori la sinistra partitica ha dimostrato la sua inadeguatezza nel rispondere ai problemi dei cittadini, i centri sociali sono rimasti presenti nel territorio e siamo vicini ai cittadini nella questione della casa o studentesche».
Un concatenarsi di storie, come quella di Mamadou Sy del Movimento dei Migranti e dei Rifugiati di Caserta e presidente dell’Associazione dei Senegalesi, da 16 anni in Italia che ci racconta le similitudini con i 6 migranti uccisi a Castel Volturno nel 2008: «Dopo 10 anni è la stessa situazione, con la difficoltà di far capire chi siamo, le nostre storie o che lavoro facciamo».
Un segnale però sembra partito, e proprio da dove non te lo aspetti, Macerata.
Abbiamo distrutto la dicotomia fascismo/antifascismo violento. Il messaggio oscuro di Minniti è stato letteralmente disintegrato. Nando, del centro sociale Pedro di Padova sintetizza così: «Non c’entrano la grandezza della città ma i ruoli che i centri sociali hanno assunto nelle varie fasi storiche. Oggi siamo riusciti a distruggere quella dicotomia fascismo/antifascismo violento, sorta a causa delle imposizioni di Minniti. Un messaggio oscuro che è stato letteralmente disintegrato».
Si sono visti fra gli altri Adriano Sofri, Cecile Kyenge, Sergio Staino, Gino Strada di Emergency o Pippo Civati (Leu), ma la metafora più calzante sullo stile di fare politica forse è stata la presenza della novantenne partigiana Lidia Menapace (candidata con Potere al popolo: «Fino a quando ho voce e forza preferisco stare in mezzo alle persone che capiscono il mondo in cui stiamo»), arrivata da Bolzano, e l’assenza del primo cittadino Romano Carancini, che da casa sua a pochi metri ha dichiarato di esserci col cuore.
PPIAZZE ANTIRAZZISTE IL PD RESTA AI MARGINI
E DISORIENTA LA BASE
di Alessandra Longo
«Dopo il raid contro gli immigrati. Centri sociali e associazioni di solidarietà trainano le manifestazioni In 20mila a Macerata con slogan anti Minniti. A Milano anche Fiano»
Macerata. È il giorno della piazza che divide e disorienta la sinistra in tutta Italia. Macerata è l’epicentro della lacerazione. Una città blindata che non partecipa fisicamente alla manifestazione contro il fascismo e il razzismo. Le finestre sono chiuse, i negozi hanno le porte protette dal compensato come per gli uragani in America. Ventimila, trentamila persone sfilano dai giardini Diaz, là dove lo spaccio si consuma vicino alle giostre per i bambini. Un fiume di militanti, centri sociali, anarchici, la Fiom, ma non la Cgil, Libera, Emergency con Gino Strada, i Cobas, Potere al Popolo con Lidia Menapace che tiene lo striscione a 94 anni, i comunisti con Marco Ferrando, i leninisti di Che fare (scatenati contro «la stampa di regime»), i deputati di Leu Civati, Fratoianni e Zoggia, segmenti di Arci, partigiani locali e l’Anpi di Roma, contraria all’assenza decisa dall’Anpi nazionale, i neri, regolari e non, l’ex ministra Kyenge, gli studenti, i vecchi di Lotta Continua che riabbracciano Adriano Sofri e a qualcuno vengono le lacrime.
Ma il Pd non c’è. Il Pd è il grande assente. Non solo a Macerata ma anche a Milano dove altri ventimila, soprattutto giovani, occupano la piazza ed Emanuele Fiano, promotore Pd della legge sul divieto di propaganda fascista, si materializza quasi timidamente. C’è anche Pierfrancesco Majorino. Li conti sulle dita di una mano. È Laura Boldrini a tenere banco: « Non c’è posto per l’apartheid in Italia. Mi fa piacere ci siano Fiano e Majorino, ma il Pd ha sbagliato a non esserci » . E poi una frecciata ad Emma Bonino: « Come fa a stare col Pd che non ha voluto lo Ius soli?». A Palermo il sindaco Orlando sfila sotto le bandiere di Cobas, Arci e Anpi.
Su temi come l’antifascismo, potevano essere assieme. Ecco, a Macerata, Sergio Staino: « Doveva esserci una grande manifestazione repubblicana ma il Pd, che è l’asse di riferimento, ci ha spiazzati tutti ». Nei più vecchi militanti c’è sofferenza per la scelta del vertice di lasciare vuoto il campo. Alvaro, 74 anni, iscritto all’Anpi di Cerreto Desi, si guarda intorno: «Non c’è il Pd, non ci sono i compagni dell’Anpi nazionale. Provo un sentimento, strano, confuso » . Forse lo stesso sentimento che porta all’abbraccio tra Vasco Errani, passato a Leu, e Gianni Cuperlo. Loro sono a Bologna, altro sit in in questa giornata difficile. Cuperlo è amaro: «Dividere le piazze sull’antifascismo è l’errore più grave che possiamo fare». Però ormai è andata così. E i giovani che sfilano sotto le Mura Urbiche di Macerata sfogano la loro rabbia contro Marco Minniti. Gli danno del “nazista”, della “ testa d’uovo”. Portano cartelli del tipo Minniti=Cossiga, Minniti fascisti garantiti. Molto più rari gli slogan a pennarello contro la Lega. Uno dice : “Salvini fascista”. Se la prendono più volentieri con il sindaco Pd di Macerata Romano Carancini che aveva chiesto, per la sua comunità choccata, una pausa di silenzio e riflessione. E quasi ignorano Pamela uccisa, Pamela fatta a pezzi e chiusa in due valigie. Lei è il non detto, lo sfondo macabro da cui è partito tutto.
Macerata città non c’è, si blinda, i fiori alle finestre, la pace perduta. Non è un corteo dove ci sono le famiglie, è un corteo “politico”, che parla all’Italia e non alla città. Sofri la spiega così: «Hanno spaventato la gente con l’allarme su possibili disordini. Avrei voluto telefonare a Renzi e dirgli: “Vieni in incognito ma vieni”» . Fratoianni, la giacca d’ordinanza con su scritto “parlamentare antifascista”, mette sale sulla ferita: «Questa è una sconfitta per il Pd, la sua scelta di non esserci è stata incomprensibile» . Da un comizio a Porto Torres, il capogruppo dei senatori dem Luigi Zanda cerca una connessione con i manifestanti: «Il fascioleghismo di Salvini ha prodotto gli spari razzisti di Macerata e non possiamo sottovalutarlo».
Certo, con il Pd sarebbe stata una manifestazione diversa, forse senza slogan isolati ma indegni come quello scandito da un centro sociale del Nord Est: “Ma che belle sono le foibe da Trieste in giu”. O come l’orrendo coro già usato dopo il delitto Mattei e risentito ieri: “I covi dei fascisti si chiudono con il fuoco; con i fascisti dentro sennò è troppo poco”.
Le parole pesano, dice Susanna Camusso, con Matteo Orfini alla manifestazione di Roma per le foibe, a Tor Bella Monaca: «L’attentato terrorista va chiamato con il suo nome». La giornata è difficile: a Piacenza gli antagonisti vanno all’assalto di CasaPound, cinque carabinieri feriti; a Torino sassi contro la polizia. Ma a Macerata, presidiata come per un G8, fila tutto liscio. Ulderico Orazi, consigliere comunale del Pd a Macerata, e titolare del bar di fronte al monumento ai caduti dove si è consegnato il pistolero filoleghista Luca Traini, guarda scorrere il fiume in piena dei manifestanti e si sente contento di aver sparigliato: «Sono qui con orgoglio piddino». Renziano, fa finta di non sentire quello che dice un “compagno” con l’altoparlante: «Caro Renzi, stai delirando tu e il tuo partito. Altro che silenzio. Noi siamo qui a manifestare!il» . A sera, Elena, una giovane mamma di Terni, dà il biberon ad Edera, 4 mesi. Non ha avuto paura di portarla qui, così piccola? « Mi fa paura altro, la direzione che sta prendendo questo Paese».
 Parliamo di foibe e di popolazioni ma, a differenza di Sergio Mattarella, presidente della nostra Repubblica, ne parliamo in un'ottica libera da ogni traccia di ipertrofia nazionalistica
Parliamo di foibe e di popolazioni ma, a differenza di Sergio Mattarella, presidente della nostra Repubblica, ne parliamo in un'ottica libera da ogni traccia di ipertrofia nazionalistica
Fu negli anni del secondo governo Berlusconi che il Parlamento italiano approvò la legge 30 marzo 2004, n.92,
«Istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti
degli infoibati». Le foibe, l’esodo giuliano-dalmata: due espressioni su cui giova riflettere, ancora una volta.
Il 9 febbraio scorso il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, intervenendo solennemente sul ricordo tragico delle foibe, ha parlato anche lui (l’aveva già fatto anni fa il suo predecessore Giorgio Napolitano) degli eventi accaduti a oriente delle frontiere dell’Italia negli anni 1943-1945. Mattarella ha detto: «Capitolo tragico, violenza ingiustificabile. Alla durissima occupazione nazi-fascista di queste terre, nelle quali un tempo convivevano popoli, culture, religioni diverse, seguì la violenza del comunismo titino, che scatenò su italiani inermi la rappresaglia, per un tempo molto lungo: dal 1943 al 1945»
E ha proseguito: «Le stragi, le violenze, le sofferenze patite dagli esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati non possono essere dimenticate, sminuite o rimosse. Esse fanno parte, a pieno titolo, della storia nazionale e ne rappresentano un capitolo incancellabile, che ci ammonisce sui gravissimi rischi del nazionalismo estremo, dell'odio etnico, della violenza ideologica eretta a sistema».
Le Foibe
Domandiamoci intanto che cosa sono le “foibe”, una parola che ha assunto un significato truce, una parola adoperata come un manganello chiodato per colpire slavi e comunisti.
Le foibe sono, geomorfologicamente, voragini di varia ampiezza e profondità caratteristiche dei territori carsici, come in parte dell’Italia nordorientale e della Slovenia. Sono state usate, nell’Europa contadina e silvo-pastorale, come qualunqua altro fosso o dirupo nascosto nella boscaglia e nella campagna: un luogo nel quale nascondere i rifiuti domestici o del lavoro, le carogne degli animali, e occasionalmente i cadaveri dei briganti sorpresi e vinti e dei nemici ammazzati in duelli o un agguati. È evidente che sono state largamente utilizzate nei momenti delle più cruente guerre civili.
Le foibe sono divenute negli ultimi decenni il simbolo di un tragico capitolo della nostra storia. Un capitolo che non si comprende (e anzi se ne rovescia il senso) se lo si guarda e valuta con l’occhio di una sola delle vittime. Chi vuole comprendere che cosa furono davvero le foibe, come e da chi vi gettarono persone vive o cadaveri, legga la documentatissima e rigorosa narrazione della storica Claiudia Cernigoi, una volta disponibile su eddyburg, ora raggiungibile in un volume cartaceo oppure online: Clara Cernigoi, Operazione foibe a Trieste.
Le popolazioni
Il presidente della Repubblica italiana, quando oggi ricorda «la grande sofferenza delle popolazioni istriane, fiumane, dalmate e giuliane» dovrebbe ricordare anche le ancor più grandi sofferenze patite, prima del 1943, dalle popolazioni della Slovenia, della Croazia, del Montenegro e inflitte con indicibile crudeltà da chi portava quella stessa bandiera tricolore che oggi distingue la nostra Repubblica.
Dovrebbe ricordare le stragi di popolazioni inerme, di interi paesi e villaggi rei di ospitare popolazioni slave. La bandiera tricolore la impugnavano gli sgherri italiani agli ordini del generale Mario Roatta, il quale, posto a capo delle truppe italiane dal governo italiano emanò, l’ordine: «non “dente per dente”, ma “testa per dente”»: per ogni colpo sparato da un partigiano slavo contro un italiano, ammazzate lo slavo, anche se l’italiano appartiene all’esercito invasore che sta trucidando la sua famiglia, saccheggiando il suo patrimonio, bruciando le sua case e i suoi villaggi.
Dovrebbe sapere, e ricordare, che tra il 1941 e il 1943 nella provincia di Trieste furono bruciati per rappresaglia contro i partigiani sloveni e italiani i paesi di Mavhinje-Malchina, Čerovlje-Ceroglie, Vižovlje-Visogliano, Medjevaš-Medeazza, Mačkovlje-Caresana, Gročana-Grozzana. Dovrebbe sapere che in quegli anni decine di partigiani sloveni (la Slovenia era stata inghiottita dall’Italia fascista come provincia di Lubiana) furono impiccati o fucilati o avviati nelle camere a gas.
L’occupazione manu militari dei territori e dei popoli slavi era stata accompagnata da una massiccia e penetrante campagna propagandistica. Si vedano in proposito i materiali esposti nella mostra “Testa per dente”. La prima cosa che balza agli occhi, è una frase di Benito Mussolini pronunciata a Pola nel 1922: «Di fronte a una razza inferiore e barbara come quella slava non si deve seguire la politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone. I confini dell’Italia devono essere il Brennero, il Nevoso e le Dinariche: io credo che si possono sacrificare 500.000 slavi barbari per 50.000 italiani»
Un annuncio, quello di Mussolini, cui più tardi seguirono i fatti. L’Italia savoiarda e fascista si è impegnata, a partire dagli anni Venti del secolo scorso (quindi ben prima della Germania di Hitler) in una penetrante operazione di cancellazione di ogni elemento della cultura e dell’identità slovena, croata, montenegrina (in una parola, slava). A partire dalla toponomastica, dalla lingua insegnata e parlata negli asili e nelle scuole (50 scuole slovene erano state chiuse), dai nomi e cognomi degli impiegati pubblici e privati (un volume di 350 pagine conteneva l’elenco di 3mila cognomi da cambiare Un migliaio di circoli culturali, assistenziali, sportivi e ricreativi sloveni e croati furono chiusi, e i patrimoni assegnati a destinatari italiani.
Il primo episodio vistoso riguardò ovviamente la cultura: nel luglio 1920 fu bruciato dai fascisti il Centro sloveno di cultura di Trieste
Mistificazione continua.
I rapporti tra l'Italia e le popolazioni slave sono stati spesso occasioni di mistificazioni. Attribuire agli sloveni o ai croati delitti o stragi o altre forme di annullamento delle persone o delle cose fu prassi consolidata. Qualche volta fu clamorosamente smentita nel momento stesso in cui avveniva. La disavventura capitò una volta a Bruno Vespa.
Nel corso di un dibattito a più voci nella trasmissione "Porta a porta" Vespa mostrò un'immagine fotografica che rappresentava la fucilazione alla schiena di un gruppo di persone, presentandola come un'esecuzione, compiuta dai comunisti jugoslavi, di un gruppo di partigiani italiani. Uno storico presente all'incontro ebbe buon gioco nel dimostrare che si trattava, all'opposto, di civili sloveni fucilati da ben riconoscibili (in altre foto) militari italiani. Come spiegò più tardi il giornalista Michele Smargiassi sul sito "Fotocrazia, nel quale si riportano anche i nomi delle vittime, tutte slovene.
Per concludere, tutto quello che abbiamo sommariamente ricordato lo abbiano tratto dalla lettura del libro di Claudia Cernigai, dell'archivio di
eddyburg o dal sito web
10 febbraio. Consigliamo caldamente la lettura di quest'ultimo per chi non vuol essere accusato come (per adoperare le parole di Sergio Mattarella), di «nazionalismo estremo, dell'odio etnico, della violenza ideologica eretta a sistema», vizi dai quali lui stesso non ci sembra essere del tutto esente.
piccolo campionario delle nefandezze dell'Italia in Slovenia e Croazia

il manifesto,
Male ha fatto il sindaco di Macerata Carancini a chiedere la sospensione di tutte le manifestazioni, come se fossero uguali. Non lo sono affatto. Quelle che presidiano i valori democratici, che protestano contro un vile attacco fascista alla convivenza civile, hanno un valore positivo. Un valore che manca in quelle di segno opposto, che inneggiano alla violenza come strumento risolutore del disagio e del conflitto sociale. Le prime sono a difesa della Costituzione, le seconde la attaccano. E non si può applicare alla Costituzione il concetto che certe questioni si sottraggono alla politica, e non sono - come a qualcuno piace dire - né di destra né di sinistra.
La Costituzione non è mai indifferente. Al contrario è in servizio permanente effettivo - come direbbe il ministro Minniti - per le libertà, i diritti, l’eguaglianza, la tolleranza, la solidarietà, la pace. E a tutto questo un sindaco, tenuto per l’art. 54 a osservare la Costituzione e le leggi e ad esercitare la sua funzione con “disciplina ed onore”, è obbligato a essere sensibile, che gli piaccia o no. Diversamente, si dimetta.
Per questo, c’è chi non condivide la decisione di Anpi, Cgil, Arci e Libera di accettare la richiesta del sindaco. Sono organizzazioni vicine al cuore di molti di noi, e non dubitiamo che la decisione sia stata sofferta. Ma è legittimo il dubbio che proprio l’eccezionalità delle circostanze, e la gravità dell’accaduto, avrebbero consigliato la scelta opposta. Essere un presidio essenziale della democrazia nel nostro paese - come indubbiamente quelle organizzazioni sono - impone un particolare carico di responsabilità. Una bocciofila o un club del golf avrebbero bene il diritto di non vedere, non sentire, non parlare, per non turbare la serenità dei soci. Non è così per loro.
Veniamo al ministro Minniti.
Capiamo bene che vuole costruire l’immagine di uomo forte del centrosinistra, capace di iniziative efficaci sul terreno incandescente della sicurezza. Che abbia o meno disegni futuri sulla poltrona più alta di Palazzo Chigi non interessa. Intanto, capiamo la valenza elettorale per un centrosinistra che insegue con affanno i voti perduti. Capiamo, ancora, che il tema sicurezza è comunque centrale e che anche la sinistra deve darsene carico, se non vuole ridursi in una nicchia irrilevante per il futuro del paese. Ma questo non giustifica ricostruzioni di fantasia e stravolgimento di fatti.
Minniti ci informa di aver fermato gli sbarchi proprio per la previsione che un caso Traini potesse verificarsi. Ma è banale la constatazione che averli “fermati” non ha prevenuto o impedito il caso Traini. E se poi l’aveva previsto, perché non ha adeguatamente aumentato la vigilanza su chi era lecito sospettare avrebbe potuto causare problemi? Non aveva forse avvertito crescere nel paese un clima pericoloso, non aveva percepito i rigurgiti fascisti?
Ci dice che l’accordo con le autorità libiche è un patrimonio del paese. Sappia che rifiutiamo un patrimonio intriso di sangue, torture e morte nei lager libici. Ci dica piuttosto qual è la sua soluzione, se la politica delle espulsioni non funziona. Essendo del tutto ovvio che non si fermano le migrazioni di masse di disperati in fuga dalla guerra, dalla fame, dalla morte schierando manipoli di soldati sulle rotte dei mercanti di carne umana.
Infine, il ministro apprezza la cancellazione della manifestazione, e annuncia che interverrà contro chi non dovesse seguire il buon esempio. A chi si rivolge davvero? Intanto, la sua vasta esperienza politica certo gli dice che proprio le sue parole possono aumentare la tensione. Dovrebbe poi sapere che le riunioni non si vietano preventivamente, e a prescindere. La formulazione dell’art. 17 della Costituzione non è affatto casuale, e gli consigliamo una rilettura. Cosa intende fare? Mandare cingolati e forze antisommossa nelle piazze d’Italia, a tutela della pubblica tranquillità?
Una pacifica dimostrazione di massa non è solo l’esercizio di diritti costituzionalmente protetti, fondamentali in un sistema democratico. È anche il migliore antidoto contro il veleno sparso da chi cinicamente sfrutta le paure profonde di una parte del paese per guadagnare un pugno di voti. Anche questa è una violenza contro la Costituzione. E ci aspettiamo che un ministro della Repubblica sia in trincea per fermarla.
la Stampa
«Dai social solidarietà al naziskin accusato di strage»
Lo hanno applaudito al passaggio per i corridoi del carcere, Luca Traini. I detenuti italiani, ovviamente, non tutti. E lui s’è impettito. Orgoglioso di quello che ha fatto. Altro che «gesto folle di un fascista che ha infangato il tricolore», come sosteneva ieri il ministro Andrea Orlando, in visita ai feriti di Macerata. No, Traini per tanti è ormai un eroe.
Sembra davvero aver scoperchiato i sentimenti più segreti di una parte d’Italia, questo naziskin dall’aria truce. In tanti solidarizzano. Non soltanto sui social, ma anche nelle strade. E il suo avvocato Giancarlo Giulianielli è il primo a esserne sbalordito. Due giorni fa l’ha chiamato un normale cittadino da una cittadina della civile Toscana, e ha chiesto come fare a collaborare alle spese della sua difesa. Anche diversi gruppi dell’estrema destra dichiarano di essere pronti a pagarne le spese legali. Giulianielli, correttamente, ha informato il suo assistito di queste iniziative. Gli ha chiesto: che vuoi fare? E Traini, che si è detto onorato di riscuotere tanto consenso, ha risposto: «Che diano tutto alle famiglie bisognose. Ma che siano famiglie italiane».
Si sentono i suoi dieci anni di militanza nei gruppi più estremi, quelli che già da tempo fanno raccolte di cibo a favore dei poveri, alla maniera dei neonazisti greci di Alba Dorata. Al sostituto procuratore Stefania Ciccioli, Traini ha raccontato la sua vita di adolescente emarginato e triste, con una difficile storia familiare, che a 17 anni trovò finalmente un gruppo dove sentirsi spalleggiato. La sua prima manifestazione, un raduno di Forza Nuova ad Ascoli. Ma poi di queste iniziative ce ne sono state tante. L’innamoramento per la Lega e per Matteo Salvini è storia recente.
Brutti sporchi e cattivi, in genere i naziskin si vantano di essere diversi dalla brava gente borghese. Traini non fa eccezione. Sulle nocche delle mani si era fatto tatuare la parola inglese «Outcast». Significa: emarginato. Così come farsi tatuare sulla tempia la runa celtica: a un certo punto ha intrapreso un percorso di non ritorno. E se ora in tanti a Macerata s’interrogano su come sia stato possibile, Luca Traini evidentemente aveva varcato la sua linea d’ombra. Non per caso, se fino a un anno fa in palestra lo chiamavano «Big John» e lui ci stava a questo ruolo abbastanza inoffensivo, e con gli amici il massimo dell’esagerazione era mangiare 10 hamburger al fast food, ora aveva preso a farsi chiamare «Lupo». Un percorso verso il precipizio che in palestra era stato ben percepito. La storia era davvero diventata un’altra. E ora? «Siccome si sente orgogliosamente un emarginato tra gli emarginati - racconta il suo legale - dice che il carcere non gli sta stretto. Anzi, lo sente come se fosse casa sua». Un successo.

l'Avvenire,
Ma in ospedale, a visitare e portare solidarietà ai feriti di Macerata, a tre giorni dagli spari del filonazista Luca Traini non c’è andato nessuno. Nessun rappresentante del governo, solo un paio di deputati. Unici, e gliene va riconosciuto il merito, l’esponente di Leu Beatrice Brignone e (non ricandidato) il cattolico e demo-solidale Mario Marazziti. Come mai, viene da domandarsi? È usanza normale da parte delle autorità andare a stringere la mano ai feriti innocenti, dopo un episodio di violenza. Stavolta no.
Forse perché di questi tempi farsi riprendere mentre si stringe la mano a un migrante, a un nero di pelle, sia pure in ospedale, non giova. In questi tempi di elezioni, in un’Italia esacerbata da propagande odiose. Si sa, poi su media e social la foto gira, la vedono in milioni. E al 4 marzo, manca meno di un mese.
Segni inquietanti da Macerata. La solidarietà allo sparatore espressa da alcuni cittadini all’avvocato di Traini, che ne è rimasto stupefatto. Solidarietà, a dire il vero, con una sola remora: «Ecchè, se va a spara’ così? Poteva piglia’ qualcuno», è il commento di un salumiere del centro della città, riferito dalle cronache del "Corriere". «Poteva piglia’ qualcuno, qualcuno di noi; per fortuna ha colpito solo quei là».
Quei là, ecco. Di cui quasi nessuno di noi sa il nome, perché i media per lo più non ci si sono molto soffermati. Quei sei ragazzi: Wilson Koff, 20 anni, ghanese; Omar Fadera, 23 anni, dal Gambia; Jennifer Otiotio, 25 anni, Gideon Azeke, 25 anni, e Festus Omagbon, 32 anni, tutti nigeriani; Mahamadou Toure, 28 anni, dal Mali.
All’età in cui i nostri figli sono ancora in casa, hanno già traversato il deserto, i campi profughi, il Mediterraneo. Alcuni di loro hanno regolari documenti. Altri no, come uno dei nigeriani, che appena medicate le ferite al pronto soccorso se la è filata alla svelta, temendo altri guai. Perché anche tra le lenzuola candide e le attenzioni dei medici non si sentiva al sicuro. Lo sanno, le giovani ombre che lavorano in nero e dormono negli scantinati, che non sono "come noi". Che ci sono gli uomini, e poi ci sono loro, gli invisibili. «Non si spara così, poteva colpire qualcuno...». Invece quel neonazista ha colpito soltanto dei migranti, cioè nessuno.
Hannah Arendt nei tempi della persecuzione antiebraica parlava di "non uomini"; di masse di persone cui venivano tolti i diritti civili, il passaporto, le proprietà, e che venivano respinti da Paesi fino a allora democratici. Finché, ovunque cacciati, diventavano appunto, nei lager, «non uomini». Displaced people, sfollati, senza terra: ieri su "Avvenire" la filosofa Laura Boella osservava come oggi si usi la stessa espressione per profughi e migranti.
C’è da riflettere, su questo processo di "anonimizzazione" che coinvolge anche italiani per niente razzisti. È quello sguardo che non si posa nemmeno un istante, per strada o in metrò, sul nero che ci affianca; quasi avendolo meccanicamente già infilato in una categoria, "vù’ cumprà", "clandestino". Insomma, altri da noi. Tacitamente, senza pensarlo apertamente,«non uomini».
Non possiamo certo accogliere, e nemmeno dare l’elemosina, a tutti i poveri che incrociamo.
Emagari non siamo noi che possiamo dar loro un lavoro non in nero. Guardarli in faccia, quello sì però possiamo, fare un cenno di saluto, chiedere magari a quello che è sempre al solito angolo come si chiama, e da dove viene. È poco, è quasi niente: ma è almeno un cominciare a riconoscere, nella massa indistinta che spaventa tanti, dei volti, degli esseri umani. Come noi.
Intanto, da Macerata arriva la notizia che il gip dubita dell’accusa di omicidio per il nigeriano arrestato per la morte di Pamela Mastropietro, tanto che non ha convalidato il fermo per questo reato, ma "solo" per vilipendio e occultamento di cadavere. Si sospetta che la povera ragazza potrebbe essere morta di overdose (e per una dose comprata coi soldi ottenuti vendendo il proprio corpo a un italianissimo "cliente").
Anche se poi Innocent Oseghale, forse con un complice, ne avrebbe fatto a pezzi e occultato il corpo. Oseghale potrebbe non essere un assassino, come ha invece rapidamente giudicato il vendicatore nero di gesti e di parole, con trascorsi in Casa Pound e Lega. Che ha preso un tricolore e una pistola, e dall’auto ha cominciato a sparare. Mirando solo ai neri di pelle, solo a quei là, nel mucchio. Un mucchio in cui indistinguibili erano i nomi, le facce, le storie.
A terra, sanguinanti, solo «non uomini». Che non è bene andare a trovare in ospedale. Poi ti fotografano mentre gli stringi la mano. E non conviene, meglio di no – al 4 marzo, manca meno di un mese.

Huffpost 3 febbraio 2018. Dalla violenza delle parole degli energumeni a quella stragista dei fatti criminali il passo non è tanto lungo. Ma porta all'abisso. A Macerata è avvenuto.
Era solo questione di tempo e il tempo è arrivato. Un crimine all'americana, dell'America di oggi, un raid razzista fatto sparando in giro per le strade della città, una tentata strage nutrita di odio razziale e di rabbia, una generica vendetta diretta non a questo o a quel colpevole ma a una razza, a un colore, a tutto ciò che non siamo noi. Stavolta però non d'America si è trattato ma della provincia italiana, la provincia tranquilla, una volta luogo di certezze e solidità contrapposte alle nevrosi e violenze della città. Provincia oggi raggiunta e travolta, anch'essa, dall'onda lunga dell'ansia italiana. Inatteso ed estremo risveglio del Paese tutto davanti a quelle molteplici firme identitarie: saluto fascista, bandiera tricolore sulle spalle, e quel "Viva l'Italia". L'Italia, sì, è stata chiamata in causa tutta – e davvero siamo arrivati a questo, siamo diventati questo?
A Macerata un limite è stato attraversato, una barriera è stata rotta. Dagli slogan violenti è stata generata vera violenza. Una affermazione banale, eppure sempre negata, dalla leggerezza e dalla irresponsabilità di un dibattito politico che detesta e disprezza come buonismo gli inviti al rispetto, che boccia come evirato ogni tentativo di ragionare invece che inveire, una cultura tornata in voga perché usa le parole come sostituto delle pallottole – per ferire l'anima, per sminuire la dignità altrui, e per soddisfare ego sminuiti gonfiandoli di finta superiorità.
E se pensate che sto pensando a Salvini e alla estrema destra, ebbene sì: è proprio a loro che sto pensando. Penso a tutte le colonne di stampa che grondano parolacce, volgarità, battute e tanti, tanti incitamenti a reagire, colpire. Fino a divenire l'inno – e abbiamo visto anche questo – alla reazione individuale contro il mondo, armi in mano e resistenza al "nemico" nel cuore. Diritto alla difesa, viene chiamato, anche se dovrebbe più spesso definirsi diritto all'offesa.
Macerata è oggi al centro di una orribile storia: una ragazza diciottenne, scappata da una comunità di recupero dalla droga, uccisa e fatta a pezzi in due valigie da un nigeriano spacciatore di droga. La polizia pare sicura della colpevolezza. La storia dolorosa, la morte efferata che è stata inflitta a Pamela Mastropietro merita ogni indagine, ogni severità, ogni condanna.
Una storia così crudele invoca anche ogni domanda di sicurezza e deve indicare anche la responsabilità dello Stato nel non saper gestire, o anche solo capire, le conseguenze di una politica dell'immigrazione mai davvero pensata e organizzata. La politica tutta ha l'obbligo di pensare alla sicurezza del paese. E certamente è colpevole di inadeguatezza. Ma la risposta a tutto questo, ai tanti errori non possono portare certo all'odio, allo scontro, alla giustizia individuale, alla strage pianificata.
E quando vi si arriva, siamo molto vicini, come si diceva, a entrare in un territorio tutto nuovo, da cui sarà molto difficile tornare.
Peccato che Salvini, così ambizioso, così dinamico, così voglioso di fare qualcosa per il Paese non abbia colto che anche per lui, soprattutto per lui, oggi era arrivato il momento di non attraversare il limite, di porre un argine alla follia attraverso una netta presa di distanza. Di dire parole di cautela e avviare un dialogo e una riflessione con il suo popolo. Non l'ha fatto. E non è stato un errore, il suo. È evidentemente una convinzione: perché questa è l'Italia che Salvini vuole, evidentemente.
Per la politica italiana questo è stato un giorno in cui la verità sui rischi che corre il Paese ha fatto irruzione nei riti sempre finti della campagna elettorale. Le conseguenze di questo scossone si possono avvertire fin da ora: l'episodio crea scompiglio nella coalizione della destra, obbliga la sinistra a ripensare un po' alle proprie divisioni interne, e mette sotto pressione il Movimento 5 Stelle che come sempre preferisce rimanere nel vago, come già è successo, quando avvengono storie scomode. Sempre che la verità la si voglia ascoltare.

il manifesto, 4 febbraio 2018.
Di colpo, il buio. A Macerata, ieri, siamo caduti in uno dei punti più oscuri della nostra storia recente. Di quelli in cui sembrano materializzarsi i peggiori incubi, da «scene di caccia in Bassa Baviera». Il folle tiro al bersaglio su base etnica, i corpi che cadono uno dopo l’altro, la corsa dell’auto alla ricerca di nuove vittime di colore, la città paralizzata, rinchiusa in casa, tutto questo ci dice che un nuovo gradino dell’orrore è stato sceso.
Non è il primo caso di violenza sanguinosa di tipo razzista: il 13 dicembre del 2011, in Piazza Dalmazia a Firenze, due giovani senegalesi, Samb Modou e Diop Mor, caddero sotto i colpi della 357 Magnum di Gianluca Casseri, un fascista di Casa Pound che poco dopo, braccato dalla polizia, si suicidò. Ed è di appena un anno e mezzo fa l’omicidio di Emmanuel Chidi Namdi, nigeriano, massacrato a botte da un energumeno di estrema destra mentre cercava di difendere la fidanzata a Fermo, non molto lontano da Macerata.
Ma questo di Macerata sta ancora un passo oltre. Per la modalità e il movente del fatto: l’intento di vendicare l’atroce morte di Pamela Mastripietro, secondo le cadenze tipiche del linciaggio nell’America dell’apartheid, colpendo indiscriminatamente i presunti compatrioti del presunto assassinio (e dimenticando, fra l’altro, che la rapidissima cattura di questo si deve alla preziosa testimonianza non di un italiano ma di un africano).
Per le caratteristiche del protagonista, ancora un fascista, candidato senza fortuna nella Lega, ma prima già vicino a Forza nuova e Casa Pound come Casseri, che però a differenza di quello non si è suicidato ma ha inscenato una teatrale rappresentazione, salendo sulla base del monumento ai caduti avvolto nel tricolore, quasi a lanciare un proclama alla nazione. Prontamente accolto, d’altra parte, da un impressionante seguito sui social, ed è questo il terzo fattore che colloca Macerata «oltre»: energumeni della tastiera che invocano «Luca Traini Santo Subito», invitano a fare altrettanto e proclamano che «questo non è che l’inizio» scaricando su «chi apre le porte all’invasione» degli africani la colpa sia dell’uccisione di Pamela che della reazione del «giustiziere» di Corridonia. Un argomento quest’ultimo, sostanzialmente in linea con le prime esternazioni di Matteo Salvini, che nel segno di una feroce campagna d’odio sta conducendo il proprio giro elettorale.
Non possiamo più ignorarlo. Macerata non è un fatto isolato. Né semplicemente opera di un disadattato. Macerata si inserisce in un quadro spaventosamente degradato. Ci parla di un vero sfondamento antropologico del nostro Paese. Viene dopo le oscene esternazioni della sindaca di Gazzada sul giorno della memoria nella terra del leghismo. Dopo la pubblicazione in rete di un aberrante fotomontaggio in cui la testa mozzata della Presidente della Camera Boldrini appare sotto la scritta «Sgozzata da un nigeriano inferocito, questa è la fine che deve fare così per apprezzare le usanze dei suoi amici», e dopo il rogo del manichino che la rappresentava, da parte dei «giovani padani» di Busto Arsizio. Dopo un lungo rosario di dichiarazioni, atti, ordinanze di sindaci leghisti, sfregi da parte di squadristi fascisti di cui si va perdendo il conto.
Macerata ci dice che l’azione dei tanti «imprenditori dell’odio» in felpa o in camicia bianca, sta tracimando oltre il terreno delle propaganda, e generando vere e proprio azioni terroristiche. Perché quello che si è visto a Macerata è in senso proprio un episodio di terrorismo, non diverso da quelli organizzati dall’Isis o dai suoi cani sciolti a Barcellona, Londra o Bruxelles, con le persone inermi fatte bersaglio e le città chiuse nel terrore. Come tale va trattato l’attentatore di Macerata. E come tale il mondo democratico dovrebbe trattare l’evento, organizzando subito una risposta di massa, lì dove il fatto è avvenuto, mobilitando chi ancora crede che quella deriva possa essere arrestata. E che la notte della memoria non è del tutto caduta su di noi. Se non ora, quando?

la Stampa, 2 febbraio 2018.Nessuno dei popoli nell'ambito dei quali sono avvenuti delitti contro l'umanità, e che non abbia reagito, può proclamare "noi siamo brava gente"
«Il Senato approva la legge che punisce chi si riferisce a “campi di concentramento polacchi”. Israele reagisce e valuta il richiamo dell’ambasciatore: "Così si rischia di negare l’Olocausto"»
Come non fosse successo nulla, sordi alle proteste delle vittime dell’Olocausto, dell’opposizione interna, di Israele, dell’Ue e degli Stati Uniti, pochi minuti prima delle due di mercoledì notte, la Camera alta polacca ha approvato con 57 voti favorevoli, 23 contrari e due astenuti la controversa legge sui campi di sterminio che prevede pene fino a tre anni di carcere per chiunque si riferisca ai lager nazisti come campi «polacchi». Ma il punto che più fa scatenare le reazioni è un altro: diventerà illegale accusare la nazione polacca di collaborazionismo con il regime hitleriano.
Ora gli occhi sono tutti puntati sul presidente Duda che dovrà decidere se approvare la legge, bloccarla o imporre modifiche. Il governo polacco non accenna a passi indietro e i legami tra il presidente e il leader del partito al potere, il PiS di Kaczynski, sono molto stretti. Così che Duda potrebbe assecondare i desideri del partito ultraconservatore. «Noi polacchi, siamo stati vittime, come lo erano gli ebrei», ha detto l’ex premier Beata Szydlo. «È un dovere difendere il buon nome della Polonia». Ma il «buon nome della Polonia» e la sua reputazione internazionale è precipitata dopo le condanne incrociate degli Stati Uniti, che vedono la legge come una «minaccia alla libertà di parola» e ne chiedono il veto, di Israele che accusa Varsavia di negazionismo e anche del ex premier Donald Tusk e attuale presidente del Consiglio europeo: l’espressione campi polacchi riferita ai lager nazisti «è una spregevole diffamazione» ma la legge approvata dal Senato ha avuto l’effetto boomerang di «promuovere questa vile calunnia in tutto il mondo, efficacemente come nessuno ha mai fatto prima». Il primo vicepresidente della Commissione Europea Timmermas riporta il dibattito al punto cruciale: «Tutti i Paesi europei occupati da Hitler hanno avuto, oltre ai molti eroi, anche collaborazionisti».
I colloqui diplomatici delle ultime 72 ore hanno portato a un nulla di fatto, e l’ira di Israele contro la legge non si placa: «Non lasceremo che la decisione del Senato polacco passi senza reazioni. L’antisemitismo polacco ha alimentato l’Olocausto» ha detto il ministro Yoav Gallant. Mentre il premier Benjamin Netanyahu, potrebbe richiamare l’ambasciatore israeliano in Polonia per consultazioni, come chiesto da più parti.
In Israele il dibattito era scoppiato già nel fine settimana, dopo il primo via libera alla Camera polacca: «La nostra posizione è che il testo deve essere cambiato», aveva affermato Netanyahu, chiarendo che «non abbiamo tolleranza per la distorsione della verità e la riscrittura della storia o la negazione dell’Olocausto». Fonti diplomatiche di Varsavia sono al lavoro per tentare di contenere i danni, ma non nascondono la sorpresa: «La legge è stata studiata ed emendata con l’aiuto di autorità ed esperti israeliani. E nella maniera più assoluta non protegge i criminali, e non limita le discussioni pubbliche su i casi di pogrom contro gli ebrei, verificati in tutta l’Europa occupata, inclusa la Polonia. A questi crimini hanno partecipato anche i polacchi».

Ytali
Il sistema democratico di tipo statunitense, che si era affermato nell’Europa uscita dalla Seconda guerra mondiale, è pervaso almeno dalla fine del mondo bipolare da una crisi strisciante che si manifesta in maniera diversificata nelle attuali nazioni europee. Che questa crisi appaia ora evidente anche nella Repubblica federale tedesca – nelle elezioni del 24 settembre scorso – può sorprendere solo chi finora ha visto nella Germania riunificata una roccaforte inespugnabile, un emblema di stabilità istituzionale e politica.
Eppure all’interno della Germania gli scricchiolii del sistema si sentono da molti anni, e fu proprio la politica della “grande coalizione” tra democristiani e socialdemocratici ad averli attutiti in nome della “governabilità”, ritenuta garanzia sufficiente per la “stabilità”. Eppure – osserva Marco Bascetta (il manifesto, 23/1/2018 ) – dopo il recente risicato consenso della base del SPD per concordare con il CDU/CSU un nuovo programma di governo, vi sono politiche di stabilità che a lungo andare favoriscono la peggiore delle destabilizzazioni, quella che conduce alle soluzioni autoritarie, se non al centro, almeno alla periferia.
Compito facile e difficile insieme: facile in quanto la futura politica deve comunque continuare a garantire alla Germania le condizioni produttive per mantenere il suo ruolo dominante in Europa e il rispettivo surplus economico – questo è il tacito consenso tra tutte le forze politiche. Difficile, perché all’interno di questo consenso ci si differenzia per questioni di ridistribuzione del consistente surplus della bilancia commerciale tra le varie frange della società.
Di fronte a una realtà economica in cui le quarantacinque famiglie più ricche posseggono quanto la metà dei tedeschi meno abbienti, si discute di fatto sulle percentuali dei contributi al sistema sanitario, sull’alleggerimento di questa o quella tassa, sulla misura del “tetto” da imporre al numero dei migranti da accogliere ecc. Ma non si ridiscutono le premesse di sistema nel loro complesso, che hanno prodotto e continuano a produrre anche quasi un milione di senzatetto e circa otto milioni di working poor, di lavoratori precari che non arrivano alla fine del mese senza gli aiuti del welfare pubblico. E non c’è dibattito sulla politica estera, né sull’intervento di truppe tedesche nel resto del mondo e ancor meno su una revisione del ruolo della Germania in Europa, perché si nega e si occulta la vera natura economica della conflittualità anche intereuropea.
Il neoliberalismo, diventato teoria e prassi dominante dopo la fine del mondo bipolare, ha negato la pluralità degli interessi, l’esistenza di conflitti di classe e non riconosce più una controparte sociale. Il che ha prodotto quella rigidità autoritaria che collega – pure in decenni e contesti politici diversi – Angela Merkel a Margaret Thatcher: “Non c'è alternativa”.
Negando l`esistenza di contraddizioni economiche antagoniste la politica degenera in una lotta all’interno del blocco di potere dominante. E mentre nel contesto europeo dopo Maastricht le attuali democrazie nazionali stanno perdendo parte delle funzioni che avevano in passato, la Germania è tornata a essere “Stato-nazione” proprio in quel momento storico che doveva ridimensionare il peso delle nazioni. Il contrasto tra Merkel e Trump si spiega anche così: Germany first vs America first.
La propaganda mainstream insiste in queste settimane sulla necessità di costituire al più presto un governo tedesco “capace di agire”, lo chiederebbero non solo i cittadini tedeschi, ma anche i partner europei, per non dire il mondo intero, che guarderebbe con ansia a Berlino! E si favorisce apertamente la riedizione di una Grande Coalizione, per poter continuare più o meno come prima (nonostante il fatto che gli elettori abbiano sottratto milioni di voti, circa il quattordici percento del consenso a questa opzione).
Ma l’ipotesi di un governo di minoranza è fuori dall’orizzonte dell’establishment politico, il cui atteggiamento richiama in mente la logica della propaganda elettorale democristiana degli anni Sessanta: Keine Experimente. Infatti “calma e ordine” costituiscono la consolidata massima della politica tedesca, almeno dal 1806 (Ruhe ist die erste Bürgerpflicht! – Mantenere la calma è il primo dovere dei cittadini! – fu l’ordine impartito ai sudditi berlinesi dopo la disfatta prussiana presso Jena a opera di Napoleone).
Anche la Repubblica Federale postbellica si votò alla restaurazione – ora dell’ordine capitalistico col modello consumistico statunitense, concepito come non conflittuale e armonico e reagì quindi male alle prime scosse a quell’idillio.
Dopo aver messo a tacere le estese proteste popolari contro il riarmo nei primi anni Cinquanta – solo pochi anni dopo l`ultima sconfitta – e messo fuori legge il partito comunista (KPD) nel 1956 (misura solo recentemente riconosciuta ufficialmente come incostituzionale) furono gli scioperi nella zona della Ruhr nei primi anni Sessanta e le svariate proteste sociali, accentuate dalla prima grande recessione postbellica del 1966 a turbare il sonno del’establishment e della maggioranza dei tedeschi.
Il tutto culminò poi nel cosiddetto Sessantotto che non solo attaccò le premesse dell’ordine costituito, almeno a parole, ma tentò per la prima volta dopo la guerra di sviluppare delle alternative politiche, sociali ed economiche al di fuori del sistema normativo tradizionale. Questa deviazione dal consenso maggioritario incontrò durissime reazioni da parte del’establishment politico e mediatico (cfr. il varo della legislazione d’emergenza, Notstandsgesetze, in barba allo stesso Grundgesetz), reazioni sproporzionate rispetto al “pericolo” costituito dagli studenti ribelli, subito stigmatizzati come estremisti, radicali e potenziali terroristi, ben prima della deriva degli attacchi della Rote Armee Fraktion negli anni Settanta, culminati nell’“autunno tedesco” (1977).
Toccò al primo governo social-liberale (SPD/FDP), in carica dal 1969, quando Willy Brandt aveva proposto ai tedeschi di “osare più democrazia” (Mehr Demokratie wagen), a promulgare nel 1972 quel Radikalenerlaß, diventato noto in tutte le lingue europee come Berufsverbot, con il quale si escludevano per anni e per motivi insindacabili i cosiddetti “elementi anticostituzionali” dai pubblici uffici (ovvero gli ex-sessantottini, allora ritenuti “nemici della costituzione” – Verfassungsfeinde). Centinaia di migliaia di giovani tedeschi vennero sottoposti a procedure inquisitorie, che ebbero a lungo anche un indubbio effetto intimidatorio sul resto della società.
I nemici della libertà e della democrazia sono dunque di nuovo pesantemente all`attacco, nella Rft [constatò Lucio Lombardo Radice nelle sue corrispondenze di viaggio dalla Germania del 1977 ( Germania che amiamo, Editori Riuniti, 1978) e non da] sostenitori di Hitler, e perciò (tali nemici) sono più pericolosi dei neonazisti antistorici. Si richiamano a una tradizione di conservatorismo e di “repressione legale” che è vecchia quanto lo Stato tedesco unificato dalla Prussia militarista un secolo fa, e più: è la tradizione di Bismarck e ancora di più di Hindenburg.
La SPD era ormai divenuta “immanente al sistema” con la decisiva svolta programmatica di Bad Godesberg (1959), abdicando definitivamente alla lotta di classe e al marxismo. Max Horkheimer aveva definito quel riformismo della SPD come pura “strategia per arrivare al potere”. Eppure, occorre constatare, che l’opposizione non arriva mai “al potere”, ma solo al “governo”, per periodi relativamente brevi e sostanzialmente a più riprese per togliere le castagne dal fuoco.
Accreditata dunque come possibile Juniorpartner alla direzione degli affari della vecchia Bundesrepublik, la SPD di Willy Brandt, dal 1969 al governo in coalizione con la FDP, poté finalmente avviare quella Ostpolitik che mise fine alla miopia politica della negazione dell’esistenza della Repubblica democratica tedesca e avviò una politica di distensione verso l’Europa sovietica. Ebbe inizio quel Wandel durch Annäherung (svolta attraverso l`avvicinamento), di cui la CDU era stata incapace, ma che contribuì infine alla dissoluzione del blocco sovietico – e del cui successo si vantò la SPD poi dopo il 1989.
Ma presto, nel 1974, Brandt fu fatto cadere e dovette cedere la cancelleria all’uomo forte della SPD, Helmut Schmidt, promulgatore di uno Stato forte, che preparò indirettamente quella geistige Wende (svolta dei valori) reclamata ormai da Helmut Kohl, già alla guida della CDU, con cui nel 1982 ebbero inizio altri sedici anni di governo democristiano.
La lunga “era Kohl” (1982-1998) lasciò la SPD nuovamente in seconda fila anche nel processo della riunificazione nazionale. Essa poté tornare al governo solo alla svolta del secolo, dopo che Kohl aveva privatizzato l’intera industria della Rdt, creando non pochi problemi sociali. Toccò quindi a una finora inedita coalizione tra SPD e Verdi a guida di Gerhard Schröder cancelliere, reimpostare l’economia tedesca, ora unificata, con le pesanti riforme base dell’Agenda 2010, finalizzate alla razionalizzazione del welfare (riforme Hartz) e al dumping salariale che poi fece esplodere la produzione e l’export tedesco non solo in Europa, ma nel mondo intero.
Nel 2002 i Verdi facevano posto alla FDP ed è da allora che la SPD viene punita dal suo elettorato tradizionale. Entra nella prima Grande Coalizione con Angela Merkel, CDU, nel 2005, ma perde sempre più credibilità e il quattordici per cento del suo elettorato durante gli ultimi dodici anni (dal 34 per cento nel 2005 al venti per cento dei voti nel 2017). E non pochi valutano la sua recente svolta verso una nuova GroKo per “responsabilità nazionale” – ennesima resa di fronte alla chiamata della patria – come un suicidio politico.
Eppure questa deriva non è nuova nella storia tedesca, anzi, si ha sempre più spesso l`impressione del déjà-vu. Già cento anni fa, durante la prima esperienza repubblicana dopo la prima guerra mondiale, allorché la SPD aveva votato i crediti di guerra per sfuggire allo stigma dei vaterlandslose Gesellen (gente senza patria) , inflittole dall’establishment del Reich guglielmino a causa dell’internazionalismo proletario degli inizi, la SPD perse consenso politico presso le masse a causa della sua politica troppo accondiscendente nei confronti dei poteri forti che sopravvissero anche a Weimar.
Di fronte alla crisi della SPD diventata irreversibile verso la fine della Repubblica di Weimar, Kurt Tucholsky aveva formulato nel 1927 il seguente “compito di matematica”:Il partito socialdemocratico ha in otto anni zero successi. Quando si accorge che la sua tattica è sbagliata?
E si potrebbe aggiungere oggi: perché nei novant’anni successivi non ha mai messo in dubbio la propria strategia politica, pur essendosi questa rivelata quasi sempre perdente nei grandi appuntamenti storici?
Nelle condizioni attuali e con i politici attualmente in campo è prevedibile che una prossima GroKo, se si realizzerà, sarà politicamente più debole, ma continuerà a perseguire gli interessi di Germany first, anche per “frenare la destra nel parlamento e nelle piazze”, come ripetono i media, una destra (AfD) che viene alimentata proprio da quella politica. Un circolo vizioso.
La strategia di fondo rimarrà quella della costruzione di un “Kerneuropa”, concetto di origini lontane, ripreso da Wolfgang Schäuble e non messo in questione dalla SPD, persino Jürgen Habermas si è schierato in questo senso. Quella “Europa a due velocità” rafforzerà il legame con la Francia, nel comune interesse di creare forze militari europee. Le nazioni “periferiche” rispetto al nucleo forte, a sud e a est, manterranno il loro status di supporto semicoloniale. Restano indispensabili, anche per ragioni geopolitiche, l’Italia come porta-aerei della NATO e gli stati del gruppo Visegrad, come supporto-base per gli interessi USA/NATO, al fine di limitare sia l’autonomia della Russia sia quella europea.

il manifesto,
Un appello al mondo della cultura. Contro le politiche neoliberiste portate avanti dai governi di centrodestra e centrosinistra in questi anni; contro la barbarie che oggi ha mille volti: il lavoro che sfrutta e umilia, la povertà e l’ineguaglianza, i migranti lasciati annegare in mare, i disastri ambientali, i nuovi fascismi, la violenza sulle donne, la crescente repressione, i diritti negati»
Siamo lavoratori della cultura, dell’informazione e della conoscenza. Siamo scrittori, docenti, autori, musicisti, giornalisti, registi, ricercatori, attori, artisti, scenografi, direttori della fotografia, produttori; abbiamo tutti storie personali diverse e diversi percorsi interni alla sinistra. Ma tutti ci siamo ritrovati concordi nello scegliere, oggi, di votare i candidati della lista di «Potere al popolo».
Noi firmatari di questo appello votiamo «Potere al popolo» perché ci siamo battuti e continueremo a batterci contro le politiche neoliberiste portate avanti dai governi di centrodestra e centrosinistra in questi anni; contro «la barbarie che oggi ha mille volti: il lavoro che sfrutta e umilia, la povertà e l’ineguaglianza, i migranti lasciati annegare in mare, i disastri ambientali, i nuovi fascismi, la violenza sulle donne, la crescente repressione, i diritti negati».
Viviamo il tempo buio di una crisi economica, sociale, ambientale e culturale che apre la strada ad una vera e propria crisi di civiltà il cui emblema è la guerra tra i poveri, il razzismo, la xenofobia.
Noi firmatari di questo appello votiamo «Potere al popolo» perché ci battiamo per la costruzione di una sinistra basata sulla connessione tra diversi soggetti del conflitto e culture critiche, che coinvolga persone, associazioni, partiti, reti e organizzazioni della sinistra sociale, culturale e politica, antiliberista e anticapitalista; una sinistra che in tutti questi anni si è battuta contro le ingiustizie e lo sfruttamento, la demolizione della democrazia, dei diritti sociali e civili, contro la mercificazione della cultura, dei diritti, della vita, per la piena applicazione della Costituzione; una sinistra che non si è mai arresa; una sinistra che non ha rinunciato ad elaborare un pensiero forte, che non ha rinunciato alla sfida per l’egemonia e alla costruzione di un nuovo senso comune alternativo al pensiero unico neoliberista. Pensiero unico che l’intera gamma della comunicazione ha costruito in anni e anni di lavoro determinando una ormai generalizzata sfiducia e «insofferenza» nei confronti della politica e delle istituzioni, che produce rifiuto senza la forza di proposte di cambiamento.
Noi firmatari di questo appello votiamo «Potere al popolo» perché ci riconosciamo nell’alternativa di società che propone: una società fondata sulla dignità e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, sull’eliminazione di ogni discriminazione, sull’affermazione dei diritti delle donne, sul principio di eguaglianza sostanziale, sulla riconquista dei diritti sociali e civili, sulla salvaguardia del patrimonio ambientale, culturale ed artistico, sul ripudio della guerra.
Noi firmatari di questo appello votiamo «Potere al popolo» perché vogliamo cambiare lo stato delle cose esistenti.
Citto Maselli, Moni Ovadia, Francesca Fornario, Paolo Pietrangeli, Fabio Alberti, Carmine Amoroso, Gianluigi Antonelli, Enzo Apicella, Piero Arcangeli, Giorgio Arlorio, Marco Asunis, Manuela Ausilio, Saverio Aversa, Stefano G. Azzarà, Simona Baldanzi, Tiziana Barillà, Mauro Berardi, Cesare Bermani, Luca Bigazzi, Paola Boffo, Susanna Bhome-Kuby, Cinzia Bomoll, Marina Boscaino, Sergio Brenna, Mario Brunetti, Benedetta Buccellato, Paolo Cacciari, Enrico Calamai, Francesco Calandra, Francesco Caruso, Riccardo Cardellicchio, Carlo Cerciello, Salvatore Cingari, Lorenzo Cini, Paolo Ciofi, Elena Coccia, Gastone Cottino, Wasim Dahmash, Franco D’Aniello, Massimo Dapporto, Fabio de Nardis, Marco Dentici, Pippo di Marca, Enzo di Salvatore, Angelo d’Orsi, Valerio Evangelisti, Amedeo Fago, Paolo Favilli,, Luigi Fazzi, Beppe Gaudino, Alfonso Giancotti, Michele Giorgio, Giovanni Greco, Alexander Hobel, Maria Jatosti, Francesca Lacaita, Maria Lenti, Maria Grazia Liguori, Guido Liguori, Antonio Loru, Fabiomassimo Lozzi, Romano Luperini, Silvia Luzzi, Maicol&Mirco, Lucio Manisco, Danilo Maramotti, Fabio Marcelli, Gino Marchitelli, Eugenio Melandri, Lidia Menapace, Magda Mercatali, Maria Grazia Meriggi, Massimo Modonesi, Francesco Moneti, Giorgio Montanini, Giovanna Montella, Lia Francesca Morandini, Raul Mordenti, Roberto Musacchio, Federico Odling, Federico Oliveri,Federico Pacifici, Marco Pantosti, Vera Pegna, Riccardo Petrella, Pina Rosa Piras, Sabika Shah Povia, Alberto Prunetti, Stefania Ragusa, Christian Raimo, Elisabetta Randaccio, Gianfranco Rebucini, Gianluca Riggi, Annamaria Rivera, Annalisa Romani, Maria Letizia Ruello, Mimma Russo, Nino Russo, Giovanni Russo Spena, Arianna Sacerdoti, Carla Salinari, Cesare Salvi, Edoardo Salzano, Antonio Sanna, Angela Scarparo, Marino Severini, Alessandro Simoncini, Ernesto Screpanti, Paolo Sollier, Massimo Spiga, Stefano Taglietti, Angelo Tantaro, Enrico Terrinoni, Mario Tiberi, Stefania Tuzi, Renzo Ulivieri, Pierfrancesco Uva, Fulvio Vassallo Paleologo, Vauro, Guido Viale, Imma Villa, Lello Voce, Annalisa Volpone, Pasquale Voza, Giulia Zoppi.
Per adesioni: maselli.citto@fastwebnet.it

Comune-Info, 28 gennaio 2018.
“Arrendetevi siamo pazzi”. In questi cinque anni di occupazione la scritta all’ingresso dell’Asilo Filangieri di Napoli non è stata un bizzarro slogan ma il grimaldello con cui ripensare la gestione di uno spazio comune, tessere percorsi inediti tra teoria e prassi (a cavallo tra filosofia, mondo dell’arte e scienze umane), costruire legami con esperienze di altre città e perfino promuovere un’incursione nel diritto. Dopo un percorso complicato c’è stato il pieno riconoscimento dell’itinerario giuridico partito dal basso. Secondo Giuseppe Micciarelli, ricercatore presso l’Università di Salerno, l’idea vincente è stata immaginare una forma di gestione per cui un bene pubblico viene amministrato direttamente dai cittadini, non con un’assegnazione, «ma attraverso una dichiarazione d’uso collettivo ispirata agli usi civici, un antico istituto tutt’ora vigente che rappresenta uno degli echi di quell’altro modo di possedere quasi dimenticato dall’ordinamento»
Beni comuni e spazi urbani
Com’è possibile che da un’occupazione di uno spazio pubblico nasca un nuovo istituto giuridico? Com’è possibile che il collettivo che ha intrapreso l’azione si sciolga per costruire un sistema assembleare regolamentato, aperto a tutti i lavoratori del settore culturale e agli abitanti del territorio? E ancora, com’è possibile che questo strumento si sia diffuso tra altre esperienze di occupazioni, in diverse parti di Italia, e che queste stesse realtà abbiano deciso di scrivere pubblicamente delle dichiarazioni di autonormazione civica per mostrare e garantire l’accessibilità a questi spazi? La risposta a queste domande spiega l’anomalia che la città di Napoli sta percorrendo sui beni comuni. L’uso civico e collettivo urbano, nato a partire dalla sperimentazione pratica e teorica dell’Asilo Filangieri, ha sfidato l’ordinamento giuridico per dare la possibilità a tante realtà caratterizzate da una gestione collettiva e comunitaria di essere coerentemente riconosciute anche dal mondo del diritto. Molti elementi di questo percorso sono diventati, in questi anni, oggetto di studi e hanno portato la città di Napoli alla vittoria del prestigioso premio Urbact 2017. Proverò qui a descriverne alcuni passaggi essenziali.
Dal punto di vista teorico, anche questa battaglia nasce sulla sponda dei beni comuni. Eppure, essi sono diventati qualcosa di diverso da ciò che la Commissione Rodotà aveva ipotizzato nel 2007-2008. Quei lavori furono fondamentali perché avvicinarono le battaglie più disparate arricchendole, in senso evocativo, di una dirompente matrice comune. Si è venuta così a creare una polisemia feconda, che ha visto la proliferazione di nuovi beni pretesi come comuni. È questa la peculiarità, forse la forza e insieme la debolezza, della via italiana ai beni comuni che, diversamente dagli studi di ascendenza economica sui commons nel mondo anglosassone (Ostrom, 1990), si interroga ancora sul loro perimetro e sulla eventuale necessità di individuarne uno in forme consuete (Mattei, 2011; Marella, 2012). In parte si tratta di una debolezza perché, come Stefano Rodotà ammoniva se tutto è bene comune allora niente è un bene comune. Ma è anche un elemento di forza, perché l’incertezza ha dato la straordinaria opportunità a tanti conflitti sociali di riconoscersi reciprocamente in un significante capace di riempire di senso comune lotte solo geograficamente distanti (Negri-Hardt, 2010; Dardot-Laval, 2015). Ma c’è di più. Questa fase costituente ha dato la possibilità ai protagonisti di quelle lotte di prendere in prima persona parola sul loro significato, scavando nuovi percorsi intellettuali a cavallo tra filosofia, diritto, economia, mondo dell’arte e scienze umane. Un percorso raro dove studio e conflitto continuano ad andare di pari passo, alimentandosi reciprocamente.
Com’è noto la prima ondata di studi e lotte sui beni comuni è culminata con la vittoria referendaria del 2011. Dopo quel successo è nata una seconda generazione di conflitti, che si sono “appoggiati” al lessico dei beni comuni. Mi riferisco in particolare al movimento dei lavoratori dell’arte, dello spettacolo e della cultura che hanno dato vita a forme di riappropriazione diretta di teatri e spazi culturali abbandonati o sottoutilizzati. Il teatro Valle a Roma, l’Asilo Filangieri a Napoli, l’ex colorificio a Pisa e Macao a Milano sono stati non a caso la sede di una seconda Commissione itinerante – la costituente dei beni comuni – presieduta dallo stesso Rodotà con la partecipazione di alcuni degli studiosi che facevano parte di quella istituzionale del 2007, insieme a tanti giovani ricercatori e attivisti impegnati in prima persona in quelle esperienze. Tali pratiche sperimentali hanno prodotto uno scarto rispetto al profilo teorico originario, quando il bene di riferimento era limitato alla sola risorsa idrica. Infatti, rivendicare spazi urbani come beni comuni ha messo per certi versi in crisi la stessa loro tassonomia, che tanto difficilmente era stata abbozzata (Mattei-Reviglio-Rodotà, 2007).
Terminata anche questa esperienza è cresciuta una seconda generazione di pratiche e studi che hanno rimesso al centro del dibattito il tema che la prima Commissione non solo aveva ritenuto superabile, ma che anzi aveva definito un ostacolo alla protezione dei beni comuni, vale a dire il tema dei regimi di governo dei beni. Attualmente, al contrario, la rivendicazione di forme di gestione, o controllo, partecipate o dirette, di beni da parte di comunità organizzate di cittadini è diventato il cuore della questione sia politica sia teorica. In questo senso uno dei punti su cui si è poggiata l’esperienza napoletana è stata la nozione di beni comuni emergenti (Micciarelli 2014, 2017), cioè quei beni che, esprimendo utilità funzionali all’arricchimento del catalogo dei diritti fondamentali, si caratterizzano per una forma di gestione diretta e non esclusiva da parte delle comunità di riferimento individuabili, al fine di garantire, attraverso modelli di regolamentazione specifici, l’uso e il godimento collettivo del bene, indirizzandolo al soddisfacimento di tali diritti, nonché al libero sviluppo della persona e la salvaguardia per le generazioni future[1]. Un modo per materializzare, anche nel mondo del diritto, il principio secondo cui «non esistono beni comuni senza le pratiche e le consuetudini che consentono alla comunità di gestire le risorse per il bene collettivo (…) caratterizzati da partecipazione diffusa, responsabilità individuale e capacità autogestionali» (Bollier, 2015).
L’anomalia napoletana
Sono tanti gli spazi abbandonati che disegnano le nostre città: orfanotrofi, scuole, caserme dismesse, ospedali psichiatrici, conventi, stazioni. La brama di riempirli di nuove attività svela l’interesse trasversale per la rigenerazione urbana, che non a caso è uno dei temi più attraversati non solo dalla letteratura, ma anche da progetti europei, bandi regionali, corsi di laurea e premi. Ed è anche terreno di conquista dei soggetti economici più attrezzati. Si pensi ai grandi protagonisti della rigenerazione degli ultimi anni: i poli commerciali e le grandi multinazionali che, grazie a una forza di investimento e persuasione economica maggiore di tanti finanziamenti pubblici, hanno trasformato pezzi di città in “non luoghi”, secondo il fortunato paradigma descritto da Marc Augè, in cui gli individui si incrociano senza mai entrare in relazione, se non attraverso quelle mediate dal consumismo. Multi utilities dell’intrattenimento a gettone svolgono ora anche una funzione, in senso lato, “sociale”: arricchite oltre che di merci anche da arcipelaghi di bar, ristoranti, cinema, pub e asili nido sempre aperti e dal prezzo quasi conveniente, dove intere famiglie si rovesciano nel loro tempo libero.
Ribaltando l’espressione di Augè, possiamo riconoscere che a diverse latitudini ci sono degli “ex-luoghi”, sulla loro riscoperta e funzionalizzazione si gioca il futuro della città. Qui la creatività gioca un ruolo fondamentale; non a caso il campo artistico è quello che viene più di tutti chiamato in causa per favorire processi di rigenerazione di questi ex-luoghi. Purtroppo però, come mostra il caso di quartieri del genere di Kreuzberg a Berlino, Covent Garden a Londra, Isola a Milano, spesso l’azione di artisti e designer diventa il preludio alla gentrificazione di intere aree popolari.
Questo destino non è ineluttabile. Una delle ricchezze di quel movimento di artisti/attivisti che si è costituito intorno al lessico dei beni comuni è il tentativo di produrre una forma di rigenerazione consapevole e conflittuale dello spazio urbano, provando a mettere al centro tanto le vertenze dei lavoratori, la necessità di riforma dei finanziamenti e della governance del settore culturale, quanto i bisogni del tessuto sociale, degli abitanti di quartieri che normalmente vengono esclusi dalla fruizione dei prodotti artistici estranei al circuito mainstream. Un percorso quindi altamente politicizzato, legato da principio al tessuto connettivo di movimenti che sui territori lottavano per il diritto alla casa, a un ambiente salubre e contro le forme di razzismo e neofascismo che tipicamente infestano le zone socialmente più povere delle città.
In Italia, questo movimento così peculiare - che si immaginava come quinto Stato (Ciccarelli-Allegri, 2011) e trovava linfa nell’eco delle lotte degli intermittenti in Francia (Lazzarato, 2004) - aveva cominciato, subito dopo la vittoria referendaria, a organizzare una scia di occupazioni, sviluppando un’ondata di rivendicazioni non impiantante tanto su una base vertenziale di categoria, bensì sulla pretesa gestione diretta degli spazi culturali da parte degli stessi lavoratori, organizzati attraverso la messa in comune dei mezzi di produzione. Dopo il cinema Palazzo e il teatro Valle a Roma, Macao a Milano, a Napoli la manifestazione di questo movimento occupò il 2 marzo del 2012 l’Asilo Filangieri. Un’azione simbolica, nell’idea originaria di soli tre giorni, considerato che l’immenso edificio, un ex convento di circa 5.000 mq2 nel centro storico della città, era stato da poco ristrutturato e assegnato al Forum Universale delle Culture: organismo aspramente criticato in quanto parte di un modello di finanziamento che non avrebbe accolto le esigenze del territorio, data una permeabilità già presente nei confronti del circuito di clientele e favoritismi che attanaglia buona parte del settore dello spettacolo.
Le assemblee partecipate da centinaia di persone spinsero però gli occupanti a osare e il processo, dapprima limitato al solo terzo piano del palazzo, cominciò a estendersi in altre zone, protraendo per un paio di anni una coabitazione con altre stanze usate dagli uffici amministrativi del Forum, il quale poi si rivelò, come preconizzato, un fallimento (Cagnazzi, 2017). Parallelamente al crescente numero di attività, anche all’Asilo ci si interrogò sulla sperimentazione giuridica, che caratterizzava il movimento. Diversamente dal teatro Valle, che a Roma stava sperimentando un’innovativa idea di fondazione con l’aiuto di molti giuristi impegnati nella prima commissione Rodotà (Caleo, 2016), a Napoli si tentò di trovare una forma che potesse rispecchiare meglio il cuore teorico della pratica assembleare che si stava sperimentando, cioè quello di costruire una comunità aperta, orizzontale, porosa e non strettamente identitaria. Un modello che pretendeva di rinunciare alla direzione artistica e al contingentamento dei tempi e degli spazi finalizzati alla produttività piuttosto che alla libera ricerca. Una forma che creasse una interdipendenza - professionale e relazionale - tra soggetti diversi, disobbedendo così all’educazione alla concorrenza tra competitors imposta da bandi, festival e mercato.
Limitandomi al punto di vista giuridico, si trattava di evadere l’illusoria conquista di una concessione, che avrebbe magari dato la rassicurante immagine di un ambito di autonomia e indipendenza, ma che staccata da un tentativo di impatto più generale sul circuito arte/rigenerazione urbana avrebbe rischiato, anche nel caso di successo, di essere schiacciata dal peso degli oneri che qualunque soggetto giuridico concessionario di un bene pubblico si deve assumere. Avrebbe inoltre rischiato di favorire la costruzione di un privilegio proprietario a vantaggio di chi era riuscito a conquistare, sebbene con la lotta e alla luce del sole, un titolo di uso esclusivo. Un discorso che piccole associazioni, realtà informali e cittadinanza attiva conoscono purtroppo molto bene. D’altronde, il minimo comun denominatore per cui si stanno diffondendo nel paese tanti regolamenti sui beni comuni urbani, pur nella loro diversità, è appunto che il patrimonio abbandonato rappresenta per un ente locale un serio problema: ogni mancata manutenzione apre la porta a rischi sia in termini di responsabilità civile sia per danno erariale, nel caso si riscontrasse la violazione degli obblighi di messa a reddito degli immobili.
Si trattava perciò di provare a cambiare il sistema, e con esso immaginare una diversa erogazione dei fondi pubblici, che sfuggisse sia ai parametri del successo decretati solo dalle leggi del mercato sia alla subalternità clientelare con gli apparati amministrativi di turno. L’idea vincente fu quella di immaginare una forma di gestione per cui un bene pubblico fosse amministrato direttamente dai cittadini, non con un’assegnazione, ma attraverso una dichiarazione d’uso collettivo ispirata agli usi civici, un antico istituto tutt’ora vigente che rappresenta uno degli echi di quell’altro modo di possedere quasi dimenticato dall’ordinamento post unitario (Grossi, 1977).
La scelta di dotarsi di un regolamento, per quanto scritto a partire dalle proprie pratiche, fu ovviamente il fulcro di una rivoluzione identitaria. L’esito di questo complesso confronto può essere riassunto con delle parole molto efficaci che ricordano come l’immanenza e lo spontaneismo non possano chiudere «i conti con un passaggio istituzionale ineludibile: il riconoscimento giuridico di una destinazione propria a tali beni, procedimento tecnico che in taluni momenti della storia interviene con quella forza decisoria che le lotte politiche e le nuove acquisizioni conoscitive sono in grado di suscitare e le costruzioni formali provvedono poi a tutelare. Contrariamente a un certo marxismo dal sapore tralatizio, la “forma” giuridica non spegne, ingannandola, la prassi sociale, ma ne rappresenta un’articolazione di pari livello e sovente più attrezzata» (Napoli, 2013).
La scrittura della dichiarazione è diventata invece una straordinaria opportunità di auto-riflessività politica, in cui le pratiche vengono messe alla prova della teoria e viceversa. Una strategia anche concreta, perché la pur importante rivendicazione del diritto di uso civico, ove non regolamentato, rappresenterebbe altrimenti uno spazio indeterminato, in cui è facile prevedere l’espansione dei poteri ora dei soggetti privati più attrezzati ora della stessa Amministrazione, al primo cambio d’umore politico. Una strategia ambiziosa quella della riscoperta degli usi collettivi perché, com’è stato chiaramente messo in evidenza, può ambire a una possibile ricostruzione della nozione di proprietà pubblica, che in un clima di esasperata esaltazione della proprietà individuale è stato progressivamente rimosso dalla riflessione giuridica e politica dei diritti collettivi (Capone, 2016). Una sperimentazione originale, che si può riassumere nello slogan “arrendetevi siamo pazzi” che gli attivisti dell’Asilo affissero all’ingresso del bene, rivendicando una strategia politico-teorica che allora appariva eretica più che eterodossa, anche per il resto del movimento nazionale.
Nel frattempo la nuova amministrazione de Magistris aveva cominciato un suo percorso che, dopo la nascita dell’azienda speciale di diritto pubblico Abc (Acqua bene comune), per la gestione della risorsa idrica, modificava lo statuto del Comune di Napoli, riconoscendo “i beni comuni in quanto funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico” e garantendone “il pieno godimento nell’ambito delle competenze Comunali”. Veniva inoltre istituito, caso unico in Italia, un assessorato ai beni comuni, presieduto da uno degli studiosi più radicali che avevano partecipato ai lavori della prima commissione Rodotà. A questo punto venne lanciato un dialogo che aveva il sapore della sfida, alle volte con toni aspri, nei confronti dell’Amministrazione: capire fino a che punto il riconoscimento da parte loro dei beni comuni potesse spingersi oltre la dimensione evocativa, per sostenere progettualità conflittuali che si muovevano in un orizzonte poco compatibile con declinazioni docili della sussidiarietà orizzontale, in cui a cittadini resi carpentieri e muratori viene concesso di prendersi cura di giardini e strade periferiche, in forme del tutto a-conflittuali.
Riconoscere l’uso civico era non facile e non era scontato, poiché si andava a definire un tipo di uso collettivo che non trovava piena collocazione giuridica tra gli strumenti tipicamente usati dagli enti locali. Di solito, infatti, la scorciatoia adottata nel caso di simili rivendicazioni è l’affidamento diretto o la sottoscrizione di patti di collaborazione tra Comune e un’associazione. Questi, però, in alcuni casi si risolvono in fictio iuris, cioè nella creazione di associazioni ad hoc, forme di affido a custodi o garanti che, però, non sono né gli animatori né i veri fruitori degli spazi; modalità che cioè non rispecchiano un uso collettivo non limitato a soci o cerchi di affinità ristretti. E invece in molti casi la scelta di non costituirsi in una singola associazione, il privilegiare la costituzione di gruppi informali o reti di realtà in continuo divenire, la garanzia del ricambio costante di utilizzatori, rappresentano una forma di uso la cui specificità è un patrimonio che l’ordinamento deve valorizzare, trovando strategie adeguate.
L’alternativa dell’uso civico urbano è stata dunque al centro dei lavori del tavolo di autogoverno dell’Asilo, e portò all’approvazione di una prima delibera già il 24 maggio 2012. Con questa gli attivisti impegnavano il Comune a «garantire una forma democratica di gestione del bene comune monumentale denominato ex asilo Filangieri in coerenza con una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 43al fine di agevolare una prassi costituente dell’“uso civico” del bene comune, da parte della comunità di riferimento dei lavoratori dell’immateriale». L’impianto però, nella parte del deliberato, tradiva il complesso sistema assembleare e di tavoli di lavoro, assegnando loro un ruolo semplicemente consultivo, mentre i poteri decisionali formalmente restavano in capo agli assessori di volta in volta competenti nel quadro partecipativo del cosiddetto. “laboratorio Napoli”[2]. Una soluzione provvisoria, che però ha avuto il pregio di dare respiro alla sperimentazione. Ci sono voluti oltre tre anni di tavoli di lavoro, scontri, riunioni interminabili con il nuovo assessore ai beni comuni Carmine Piscopo, studi fatti a tavolino anche con funzionari e dirigenti per provare a contaminare il quadro amministrativo vigente che riconoscesse l’uso civico come una nuova forma di amministrazione diretta del patrimonio pubblico (Micciarelli, 2017).
Un lavoro che è stato rafforzato anche da numerose realtà di movimento e associative, che stavano svolgendo altri esperimenti di autogestione nel panorama cittadino, il cui impatto sociale era enorme. Coinvolti poco a poco nel progetto di estensione dell’uso civico urbano si giunse alla importante tappa dell’approvazione in Consiglio Comunale di alcuni emendamenti, scritti dagli attivisti, per migliorare la regolamentazione quadro sulla gestione dei “cd. beni percepiti come comuni di proprietà pubblica” (delibera n. 7/2015). Così si introduceva un esplicito riferimento ai «regolamenti di uso civico o altra forma di autorganizzazione civica» da riconoscere in apposite convenzioni collettive e affiancando questo modello a quello delle concessioni e affidamenti.
Il pieno riconoscimento c’è stato però con una successiva delibera, la n. 893 del 29 gennaio 2015: la dichiarazione di uso civico e collettivo urbano, che a quel punto era stata completata dagli “abitanti” dell’Asilo, è stata assunta «quale complesso di regole di accesso, di programmazione delle attività e di funzionamento, e innovativo modello di governo di spazi pubblici». La dichiarazione, esplicitamente richiamata anche nella parte dispositiva, così diventava non lo statuto di un’associazione assegnataria, ma il regolamento pubblico di utilizzo dello spazio. Veniva acquisito anche il calendario, che indicava come il concetto di sostenibilità andasse di pari passo con quello di “redditività civica”, cioè i vantaggi economici per tutto il territorio generati dalla capacità autonoma degli abitanti di coordinarsi per accogliere un numero impressionante di richieste da parte di altri concittadini (ex Asilo Filangieri, 2016).
Così gli irrisori oneri di spesa per garantire l’accessibilità (come le utenze e la guardiania) potevano essere assunti dal Comune, mentre tutte le attività e la dotazione degli spazi gravavano sulla comunità generata dagli organi di autogoverno previsti dalla dichiarazione. Queste delibere hanno rappresentato la base per un’ulteriore estensione del modello. Un nuovo atto amministrativo, delibera n. 446 del 2016, ha riconosciuto «quali beni comuni emergenti e percepiti dalla cittadinanza quali ambienti di sviluppo civico e come tali strategici» altri sette ex-luoghi della città, occupati negli ultimi anni: ex Carcere minorile Filangieri (ora Scugnizzo Liberato); Ex Scuola Schipa; Villa Medusa; ex Lido Pola; ex Opg (ora Opg Je so’ pazzo); ex convento delle Teresiane (ora Giardino Liberato di Materdei); ex convento di Santa Maria della Fede (ora Santa Fede Liberata).
Nello specifico, aderendo alla “seconda via” aperta con gli emendamenti alla delibera n.7 sopra citata, è stata attivata “una procedura di ricognizione degli spazi di rilevanza civica ascrivibili nel novero di beni comuni” che si è tradotta nell’acquisizione da parte degli uffici competenti di sette dossier, contenenti le attività generate fino ad allora e le forme di gestione sviluppate dagli occupanti. Una spinta dal basso che oggi ha portato il comune di Napoli a riconoscere un percorso che, allo stato attuale, coinvolge un patrimonio immobiliare di circa 40 mila mq2 ed è rivendicato da una rete di altre esperienze da Torino a Palermo, da Firenze a Reggio Emilia. Una strategia che crea nuove istituzioni, sia come una piattaforma polemica di quelle esistenti, sia come banco di prova per la realizzazione concreta di comunità capaci di organizzarsi in una eterogeneità, che non significhi neutralità, nei confronti dei modelli di produzione esistenti.
NOTE
[1] Una differenziazione questa che segue quella che l’art. 822 c.c. opera per il demanio: i beni comuni necessari e quelli in senso eventuale o emergenti si distinguono per le forme di governance. Al primo caso appartengono beni necessariamente in comuni, come l’acqua, la cui governance dovrebbe essere connessa a forme tradizionali di democrazia partecipativa; i beni comuni emergenti sono invece da forme di gestione diretta da parte delle comunità di riferimento, e emergono si possono generare queste forme di partecipazione.
[2] Un modello di democrazia partecipativa su cui aveva alacremente lavorato l’allora assessore Alberto Lucarelli.
Pagina tratta da Comune-Info. L'articolo completo di immagini, riferimenti e bibliografia è qui raggiungibile

il Fatto quotidiano
Lavorare per 10, 12 ore, a volte addirittura 14. In un solo giorno. Con pause per il bagno conquistate con fatica, quasi fosse una concessione, mentre quintali di carne scorrono veloci sul nastro: i ritmi impongono a ciascun operaio di pulire decine, anche centinaia di pezzi. Sono questi i racconti che fanno da sfondo alla protesta degli ormai ex-operai in appalto della Castelfrigo, azienda di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, dove si sezionano parti di maiali, in particolare pancette e gole. Qui i lavoratori lasciati a casa nell’autunno del 2017 dalle coop Work Service e Ilia D.A (a cui la Castelfrigo aveva dato in appalto i servizi di logistica) hanno superato il 90esimo giorno di sciopero. E da oltre un mese stanno vivendo, giorno e notte, davanti allo stabilimento, nelle tende montate dalla Flai-Cgil, dandosi il cambio per il presidio notturno e combattendo il freddo umido che punge la pianura, allungando le mani su una sorta di bidone stufa, utile anche per scaldare il cibo.
Sono tutti stranieri, arrivano in gran parte dall’Albania, dal Ghana, dalla Costa d’Avorio e dalla Cina. “Perché accettiamo queste condizioni? Il più grande problema di uno straniero è rinnovare il permesso di soggiorno e per farlo abbiamo bisogno di un contratto. È un ricatto”. E così spesso firmano di tutto, diventano soci o addirittura presidenti delle cooperative. Lulja Harum, 30enne albanese, ad esempio, è stato per molto tempo presidente di una cooperativa a sua insaputa. Lo ha scoperto solo quando la Guardia di Finanza ha bussato a casa sua e gli ha detto che avrebbe dovuto saldare un debito di 1milione e 700mila euro. “Mi avevano detto di firmare e stare tranquillo, che in questo modo avrei avuto il lavoro – racconta a fatica davanti alla telecamera – ma non io non sapevo né leggere, né scrivere”.
Il meccanismo lo spiega Umberto Franciosi, segretario della Flai Cgil Emilia Romagna che insieme ad altri suoi colleghi si dà il cambio regolarmente per garantire una presenza costante al sit-in. “Ogni 2 o 3 anni, queste false cooperative si sciolgono perché capeggiate da prestanome nullatenenti, lasciando grossi debiti di Iva non versata, di Irap non pagata e di mancati contributi”.
Perché accettiamo queste condizioni? Il più grande problema di uno straniero è rinnovare il permesso di soggiorno e per farlo abbiamo bisogno di un contratto. È un ricatto
Ogni mattina, all’alba, chi protesta fuori dall’azienda vede gli ex colleghi varcare i cancelli dello stabilimento per andare al lavoro. Tra loro ci sono anche i 52 che non hanno scioperato, riassunti per 6 mesi tramite una società interinale, grazie a un accordo sottoscritto dalla Fai-Cisl e sotto accusa dalla Cgil: “Per la prima volta in Italia l’esercizio del diritto di sciopero è diventato elemento formale di discriminazione dei lavoratori in un accordo sindacale”.
Ma se la Cisl difende le modalità con cui ha portato avanti al vertenza, in un audio registrato di nascosto nel 2016 durante un’assemblea con i lavoratori si sente il proprietario della Castelfrigo, Roberto Ciriesi, dire chiaramente agli operai delle coop di “scegliere il sindacato giusto”. Ma non solo: nello stesso video Ciriesi se la prende con chi ha iniziato a protestare (i primi scioperi sono dell’inizio del 2016 e hanno portato all’applicazione del Contratto nazionale dell’industria Alimentare), reo a suo parere di aver attirato i controlli dell’ispettorato del lavoro e della Finanza. Il Fatto.it ha contattato la Castelfrigo per avere un commento, ma l’azienda “in questo momento ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione”.
Per la prima volta in Italia l’esercizio del diritto di sciopero è diventato elemento formale di discriminazione dei lavoratori in un accordo sindacale
Le storie si replicano, quasi sempre con lo stesso copione, se ci si sposta nelle altre aziende delle carni del modenese. Un settore che vale 3 miliardi di euro, con 170 imprese, molte delle quali si avvalgono di cooperative per tagliare i costi: secondo la Cgil dei 5mila occupati del distretto agroalimentare, circa 1500vivono condizioni di lavoro simili a quelli della Castelfrigo. Numero che cresce se si considera tutta Italia, e raggiunge i 17mila lavoratori. “Le responsabilità – spiega Franciosi – sono delle imprese che per abbattere i costi di produzione utilizzano queste forme di lavoro, ma anche della politica. Sono state cambiate ad hoc alcune leggi, a partire dalla legge Biagi che ha completamente tolto il reato penale per l’intermediazione illecita di manodopera. Per arrivare fino al Jobs act, con la depenalizzazione della somministrazione irregolare di manodopera. Una vera manna dal cielo per queste imprese”

il manifesto,
«
Raccolte oltre 40mila firme. Viola Carofalo: "Siamo gli unici che non rischiano di sciogliersi prima delle elezioni"»
Superato l’ultimo ostacolo in un collegio della circoscrizione Sicilia 1, è adesso ufficiale che alle elezioni del 4 marzo ci sarà anche la lista di sinistra Potere al Popolo! Liste e firme vengono consegnate stamattina alle 11.30 nelle corti d’appello, l’annuncio diffuso ieri ai militanti in giro per l’Italia è già di festa: «Portate i moduli, lo spumante, i dolci, le bandiere, le trombette, fate venire le persone da tutta la regione, trasformiamo un atto burocratico in una grande presa di parola collettiva». Servivano poco più di 25 mila firme, ne hanno raccolte in pochi giorni più di 40mila.
Nata a Napoli in un’assemblea del centro sociale Je so’ pazzo la notte successiva al definitivo fallimento delle assemblee del Brancaccio, la proposta di una lista che tenesse assieme movimenti e partiti della sinistra radicale è cresciuta attraverso 150 assemblee territoriali e l’adesione di Rifondazione comunista, Partito comunista italiano, Sinistra anticapitalista e rete Eurostop. Il nome riprende lo slogan con il quale il centro sociale napoletano conclude da tempo si suoi comunicati – richiamo al motto all power to the people del Black panther party – il simbolo è tutto nuovo. «Ce ne avevano proposto uno incredibile che aveva dentro tutto: la bandiera italiana, la parola sinistra, un pugno, una stella e la falce e martello. Uno dentro l’altro, sembrava disegnato da Escher», raccontano i militanti napoletani. Che hanno fatto di testa loro.
L’invito alle assemblee è stato invece quello di scegliere i candidati nelle liste senza votazioni, ma con la discussione. Qualche volta ci si è persino riusciti. «Mentre tutte le forze politiche dal Pd a Liberi e Uguali litigano sulle candidature per spartirsi tra ceti politici le poltrone in palio – dice Viola Carofalo, portavoce che per la legge elettorale è il capo politico della lista, ma che non sarà neanche candidata – mentre i cinque stelle dimostrano ancora una volta la mancanza di democrazia delle parlamentarie, noi, che abbiamo iniziato dal basso e senza mezzi, siamo riusciti in pochissimi giorni a raccogliere le firme e a elaborare le candidature che vengono soprattutto dalle vertenze e dalle lotte del territorio».
Negli elenchi, maggioranza di donne capolista nel proporzionale alla camera, 35 (il 56%) contro 28 uomini (44%). Tra le candidate la partigiana e pacifista Lidia Menapace a Trento, a Verona Patrizia Buffa, impegnata nelle lotte contro le mafie, Stefania Iaccarino nel Lazio, protagonista della vertenza contro Almaviva, Nicoletta Dosio, storica attivista No Tav, capolista nel plurinominale in Piemonte 2. Altri candidati di movimento sono Giovanni Ceraolo che viene dalle lotte per la casa a Livorno e Gianpiero Laurenzano, impiegato di banca impegnato nel Clash city workers, Giuseppe Aragno, professore di storia che correrà a Napoli nel collegio del Vomero dove Renzi ha schierato Paolo Siani. I segretari di Rifondazione Maurizio Acerbo e del Pci Mauro Alboresi sono capolista rispettivamente a Roma e in Emilia Romagna 3. Giorgio Cremaschi in Campania 1.
«Abbiamo scelto i nostri candidati alla luce del sole – dice ancora Viola Carofalo – per condividere con tutti le scelte e le ragioni del programma. Siamo l’unica lista che non rischia di sciogliersi prima ancora di iniziare la campagna elettorale». La soglia di sbarramento del 3% sembra lontanissima, anche se il fatto di essere ostinatamente esclusi da ogni sondaggio autorizza almeno a sognare. «Se andrà male avremo fatto comunque un passo in avanti, messo in contatto realtà di movimento che non si conoscevano, imparato a fare cose che prima non sapevamo fare. E non finisce qui».

il manifesto, 27 settembre 2018. non si può proprio dire che l'Italia fascista (e nemmeno quella prefascista) abbiano dovuto attendere Hitler e il nazismo per dimostrare queste virtù Le avventure in Abissinia, Somalia e Libia lo testimoniano, oltre le leggi antisemite del 1938.
Quest’anno il Giorno della Memoria coincide con la ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi contro gli ebrei dell’Italia fascista. Promulgazione ad opera di quel sovrano Vittorio Emanuele III al quale, se non altro per questa ragione, devono essere precluse le porte del Pantheon.
Come giustamente ricorda una importante pubblicazione edita l’anno scorso in Germania per gli ottanta anni dalle leggi di Norimberga, fu una iniziativa tutta italiana senza che vi fosse alcuna pressione da parte del Reich nazista, come si ostina a ripetere qualche tardo estimatore di Benito Mussolini.
Tutto quello che si può dire in proposito è che nell’Europa invasa dall’antisemitismo, l’Italia fascista non volle essere seconda a nessuno, ossessionata come era, fra l’altro, dallo spettro della contaminazione razziale. Frutto avvelenato dell’appena conquistato impero coloniale e della forzata coabitazione con i nuovi sudditi africani.
Come tutti i neofiti, anche il razzismo fascista ebbe il suo volto truce. La «Difesa della razza», l’organo ufficiale del regime che ebbe come segretario di redazione Giorgio Almirante, ne forniva la prova in ogni numero contraffacendo le fattezze fisiche degli ebrei o rendendo orripilanti quelle delle popolazioni nere.
Il tentativo di fare accreditare l’esistenza di una razza italiana pura nei secoli aveva il contrappasso di dare una immagine inguardabile delle popolazioni considerate razzialmente impure. L’arroganza della propaganda non impedì che essa facesse breccia in una parte almeno della società italiana e ancora oggi non è detto che essa si sia liberata dall’infezione inoculata dal fascismo, come stanno a dimostrare piccoli, ma numerosi episodi che si manifestano, e non solo negli stadi.
Non bisogna fra l’altro dimenticare che non solo tra il 1938 e l’8 settembre del 1943 l’odio razziale ebbe libero corso, ma che dopo l’armistizio e l’occupazione tedesca la caccia agli ebrei divenne uno dei principali motivi dell’esistenza della Repubblica Sociale neofascista.
In nome della purezza della razza il regime costrinse a fuggire o mise in campo di concentramento ebrei che in altre parti d’Europa si erano illusi di trovare un rifugio non precario entro i confini italiani; ma costrinse all’emigrazione scienziati e intellettuali italiani, privando il Paese di una componente culturale che, nella più parte dei casi, non avrebbe fatto ritorno in Italia neppure dopo la liberazione anche a causa degli ostacoli non solo burocratici alla reintegrazione di quanti erano stati costretti a espatriare e che per tornare a esercitare il proprio ruolo in patria non avrebbero potuto contare su nessun automatismo.
Le leggi contro gli ebrei costituirono un’ulteriore penetrazione del regime nel privato dei cittadini: il divieto dei matrimoni con cittadini ebrei; l’espulsione degli ebrei come studenti ed insegnanti dalle scuole e dalle università; l’espulsione degli ebrei dalla pubblica amministrazione.
Di fatto, ma anche di diritto, si venne a creare una doppia cittadinanza con cittadini di serie A e cittadini di serie B, preludio dell’ostracismo generalizzato sancito dalla Repubblica Sociale che proclamò semplicemente gli ebrei cittadini di stati nemici, quasi a dare la motivazione non solo ideologica per la parteicpazione italiana alla Shoah.
Ancora oggi è difficile dare una valutazione sicura delle reazioni della popolazione italiana alle leggi razziali. Le azioni di salvataggio compiute dopo l’8 settembre non devono ingannare a proposito dei comportamenti che si manifestarono prima dell’armistizio.
Gli stessi ebrei non si resero esattamente conto della portata delle leggi razziali. Il fanatismo della stampa, in particolare nella congiuntura bellica in cui gli ebrei vennero imputati di tutti i disastri del Paese, andava probabilmente oltre il tenore dello spirito pubblico che oscillava tra indifferenza e cauto plauso, aldilà del solito stuolo dei profittatori.
Le autorità periferiche non ebbero affatto i comportamenti blandi che qualche interprete vuole tuttora addebitare loro. Il conformismo imperante coinvolse la più parte della popolazione. Il comportamento timido, più che cauto, della Chiesa cattolica non incoraggiò in alcun modo atteggiamenti critici che rompessero la sostanziale omogeneità dell’assuefazione al regime.
A ottanta anni di distanza la riflessione su questi trascorsi è ancora aperta e si intreccia con alcuni dei nodi essenziali della storiografia sul fascismo (per esempio la questione del consenso).
È una storia che deve indurci ad approfondire un esame di coscienza collettivo alle radici della nostra democrazia e a dare una risposta a fatti che sembrano insegnarci come la lezione della storia non sia servita a nulla se è potuto accadere che il presidente del tribunale fascista della razza diventasse anche presidente della Corte Costituzionale della Repubblica.

“Non siamo populisti, ci definiamo popolari: andiamo al sodo delle questioni che ci sembrano centrali per le persone e cioè lavoro, diritti, ambiente e no alle discriminazioni“. Non ha dubbi Viola Carofalo nel definire in un’intervista all’agenzia Dire il movimento Potere al Popolo, di cui è "capo politic2o.
“La scelta dei nostri candidati non sul web ma in assemblea” Spesso si parla alla pancia delle persone – aggiunge -: si fa gioco sul razzismo, sui più bassi istinti. Noi vogliamo parlare alla testa e al cuore delle persone e dire che può esistere un’Italia solidale, più equa, più giusta dove non si venga sfruttati sul lavoro, dove non si discrimini per il colore della pelle, dove non si alimenti l’odio per chi sta peggio di te. Ma dove si cerchi una solidarietà tra persone che vivono condizioni analoghe”. Quindi diversi dai partiti considerati oggi populisti, il Movimento Cinque Stelle, e la Lega Nord.
Sul tema della cittadinanza agli stranieri, avversato dalla destra leghista, Carofalo spiega la posizione di Potere al Popolo. “Le persone che nascono italiane sono italiane, a tutti gli effetti. Nessun uomo deve essere considerato clandestino, tantomeno chi nasce in questo Paese”. Nessuna spinta verso i ‘no euro’, “il tema del referendum non si pone, piuttosto – commenta Carofalo – c’è la questione dei trattati. Se ci chiedessero di poterci esprimere sui trattati saremo favorevoli, intanto perché sarebbe un esercizio di quello che chiamiamo potere o sovranità popolare”.
Il metodo di selezione dei loro candidati è uguale in tutto il Paese: non il web, modus operandi del Movimento 5 Stelle, né le segreterie di partito, come avviene nelle formazioni politiche tradizionali. “Potere al Popolo ha scelto i suoi candidati in Italia nelle assemblee territoriali; ogni territorio sarà rappresentato da chi ne è stato il principale portavoce di lotte e battaglie”, spiega Viola Carofalo.
“I nostri candidati sono principalmente provenienti da realtà di base, da comitati dal basso, da sindacalisti. Uno tra tutti, Giorgio Cremaschi– dice la candidata premier – un nostro candidato e un sindacalista molto attivo e radicale”. La lista di Potere al Popolo sarà nazionale“saremo in tutte le grandi città, da Nord a Sud, e siamo in dirittura d’arrivo quasi dappertutto per la raccolta delle firme utili a presentare la lista. Gli altri avranno nomi eccellenti, grandi appoggi e sponsor. Noi abbiamo la forza di attivisti e militanti che sono stati con noi, ai banchetti, a raccogliere firme”.
“La Sinistra radicale siamo noi”. La necessità da cui partiamo è quella di ricostruire una sinistra radicale: ci sembra che in Italia non ci sia, che si siano persi ragionamenti su questi cruciali come il lavoro, la solidarietà sociale, la difesa dell’ambiente, la lotta alle discriminazioni“.
Si presentano come la vera sinistra radicale, in corsa alle elezioni del 4 marzo, gli esponenti di Potere al Popolo, movimento rappresentato da Viola Carofalo, ricercatrice precaria e candidato premier della formazione. Lavoro e diritti sono i punti centrali del programma di Potere al Popolo, riassunti da Carofalo nel corso di un’intervista all’agenzia Dire.
“Il lavoro deve essere stabile e non precario“, precisa la ricercatrice, secondo cui vanno abolite tutte le riforme approvate dai governi degli ultimi 20 anni “dal Jobs Act alla riforma Fornero, dal pacchetto Treu alle riforme che hanno peggiorato le condizioni dei lavoratori e degli sfruttati di questo Paese”. Al Sud “tutte le contraddizioni che viviamo nel Paese, dalla sanità, al lavoro, alla scuola, si vivono doppiamente. Partiamo dai territori – riflette Carofalo – che da troppo tempo sono stati abbandonati”. E quello che chiede Potere al Popolo è un governo che sia finalmente attento “ai diritti sociali”. “Dalla Buona Scuola ai tagli inflitti alla sanità: bisogna fare marcia indietro – spiega il candidato premier – e andare avanti verso un nuovo Stato sociale in cui tutti abbiano la possibilità di essere curati, di avere accesso a una istruzione adeguata, a una vita degna. Che è quello che non ci è stato dato negli ultimi anni”.
“De Luca se ne frega delle persone”
“De Luca è inqualificabile, non solo per il livello politico ma anche umano. E per noi le biografie delle persone contano: lui è l’incarnazione dell’arroganza della politica, del fregarsene dei bisogni di chi dovrebbe rappresentare”. Questo il giudizio di Carofalo sul governo della Regione Campania, guidata da Vincenzo De Luca.
Un’insufficienza per il governatore Pd; un voto positivo, invece, all’amministrazione retta da Luigi de Magistris nella città di Napoli. “L’amministrazione ha fatto molto su cultura e riscatto della città, poco per le periferie. Ma ci sembra che il voto sia positivo: benché nessuno di noi faccia parte di demA e nonostante ribadiamo di non essere interni a quel percorso – sottolinea la ricercatrice – ci sono delle persone candidate con noi a Napoli espressione di demA”.
E attenzione proprio alle dichiarazioni rilasciate da Luigi de Magistris alla Dire (“Potere al Popolo è l’unica lista che dice qualcosa di maggiormente radicato con il popolo”, ndr): “Se ci apprezza – commenta Carofalo -, visto che è la prima volta che ci candidiamo, in qualsiasi forma e a qualsiasi livello, non è tanto per quello che diciamo quanto per quello che facciamo. Sicuramente ha visto cosa facciamo a Napoli ed è questo modello che vogliamo portare a livello nazionale, mettendo insieme tante forze e realtà dal basso”.
Articolo ripreso dall'agenzia DIRE. qui raggiungibile
Qui potete aprire Il video di Viola Carofalo

Comune-info.net. gennaio 2018.
LA SCONFITTA: CONDANNATI A VINCERE?
Sentieri interrotti e strade nuove
nelle esperienze sociali, spirituali ed esistenziali
di Paolo Cacciari
Dopocapodannoa Sezano
3-4-5 gennaio 2018
PRIMA PARTE
DANILO DOLCI E NUTO REVELLI
Il compito che mi è stato assegnato è di guardare al tema dei “vinti” in chiave sociale. In questa ottica i “vinti” sono i dominati, i deprivati, gli inferiorizzati, gli emarginati, gli esclusi, gli “scarti” (per usare un’espressione di papa Bergoglio), le vittime, insomma, dei sistemi economici-sociali- istituzionali che penalizzano, umiliano fino a mortificare le persone infliggendo loro varie sofferenze.
Penso che in Italia nessuno meglio di Danilo Dolci e Nuto Revelli sia riuscito a dare la parola agli “sconfitti” della società. Il mio, quindi, vuole essere solo un invito a riprendere in mano i loro lavori, troppo presto dimenticati. Di Dolci ricordo Racconti siciliani (che è una selezione di interviste/racconti raccolti tra il 1952 e il 1960) e di Revelli, i due volumi de Il mondo dei vinti (testimonianze contadine raccolte nel Cuneese nel dopoguerra).
La prima cosa che ci insegnano i nostri due maestri dell’indagine sociale è che per capire e raccontare la condizione di chi patisce esclusione e impoverimento è necessario entrare con loro in un rapporto di fiducia capace di superare reticenze, vergogne, paure. Creare un “campo di empatia” (Eugenio Borgna, psichiatra) capace di aprire il cuore delle persone non è facile. Comporta una fatica enorme.
Scriverà Dolci a proposito delle sue conversazioni con gli abitanti di Trappeto o con i detenuti dell’Ucciardone: “Tutto questo non era semplice, costava ansie e sudori: ogni volta erano dei parti” (Giuseppe Barone, Gli “industriali” e i banditi di Danilo Dolci, in: D.Dolci, Racconti siciliani, Sellerio, 2008, p. 409). Per riuscire ad accendere una comunicazione sincera tra le persone bisogna immedesimarsi nella condizione dell’interlocutore con attenzione, delicatezza, rispetto. Saranno questi i fondamenti della maieutica pedagogia di Dolci.
Ha scritto Dolci: “Il primo strumento che ciascuna persona ha a disposizione da valorizzare, è sé stessa” (Esperienze e Riflessioni, p.107). Oggi diremo empowerment, capacitazione, restituzione di autostima. Dare davvero la parola agli ultimi, agli emarginati, agli oppressi non significa farsi interpreti e raccontare “noi” le “loro” storie, ma è un modo per intraprendere “un percorso di liberazione” assieme (Carlo Levi nell’introduzione alla edizione dei Racconti siciliani editi da Sellerio).
L’indagine sociologica, quindi, non è neutra, asettica, ma è “co-ricerca”, “inchiestazione”. Un modo per compiere la scelta di stare dalla parte delle vittime, dei “vinti” fino a giungere a condividerne la sorte. Per intraprendere un percorso di liberazione, quindi, non basta portare solidarietà, essere caritatevoli, assistenziali. É necessario risalire nella consapevolezza alle cause generali che creano le particolari condizioni di sofferenza.
In altre parole, il percorso di liberazione passa attraverso un processo di presa di coscienza e di protagonismo sociale e politico, individuale e collettivo. Mi viene in mente il discorso che papa Bergoglio ha pronunciato il 4 febbraio del 2017 in occasione di una udienza in Vaticano con i rappresentanti dell’Economia di comunione, quando disse: “Imitare il buon Sammaritano non è sufficiente”. Occorre: “combattere le strutture del peccato che producono briganti e vittime”. “Bisogna allora puntare a cambiare le regole del gioco del sistema economico-sociale”. E’ necessario: “cambiare le strutture per prevenire la creazione delle vittime e degli scarti” (quotidiano
l’Avvenire di domenica 5 febbraio 2017).
Sono le strutture e le logiche di potere/dominio/coercizione che creano subordinazione, sfruttamento fino alla perdita di autonomia e alla disumanizzazione dei “perdenti”.
Danilo Dolci
Le scelte di vita di Dolci sono esemplari. Nato a Sesana, vicino a Trieste, renitente al servizio militare nel ’43, riesce a fuggire all’arresto da parte delle SS e a riparare negli Abruzzi. Finita la guerra, studia a Milano architettura e lavora come insegnate a Sesto San Giovanni. Le sue grandi passioni sono la musica e la poesia. Pubblica presto e diventerà un affermato poeta vincendo anche un premio Viareggio. Incontra padre Turoldo e la sua filosofia: “Godi del nulla che hai, del poco che basta giorno per giorno: e pure quel poco se necessario dividilo”. Nel 1950 lavora con don Zeno Santini alla Comunità Nomadelfa per orfani della guerra a Fossoli (Carpi) riutilizzando una parte dell’ex campo di concentramento. Ma ben presto anche questa struttura gli appare troppo protetta e va nella profonda Sicilia occidentale, a Trappeto, frazione di Partinico sul Golfo di Castellamare, che conosceva già perché suo padre vi era stato come capo stazione.
Cosa trova Dolci a Trappeto? Ce ne dà un’idea Carlo Levi ne Le parole sono pietre : “Scendemmo con lui nel Vallone, per le strade miserabili e putride, rivedemmo, ancora una volta, come in tanti altri villaggi e paesi del Sud, la grigia faccia della miseria; uomini senza lavoro, ‘disfiziati’, senza volontà e desideri, le madri senza latte, i bambini denutriti e ridotti a scheletri (...) Un uomo ancora giovane, dal viso smunto, infreddolito dalla tubercolosi, cercava, avvolto in uno scialle di lana, di scaldarsi al sole (...) Entrammo in un’altra casa dove vedemmo un uomo chiuso in una gabbia. La piccola stanza dove viveva tutta la famiglia era stata divisa con delle sbarre di ferro come quelle degli animali feroci, e nella gabbia camminava avanti e indietro un giovane dal viso bestiale, dai neri occhi terribili”. Era un infermo di mente.
Per molti mesi vive in una tenda ospite da amici del padre e poi costruisce un edificio con l’aiuto di amici e fonderà il Borgo di Dio. Inizia la sua attività di sociologo irregolare, di educatore informale, di animatore culturale, di attivista sociale. Animato da una profonda forza spirituale e da un metodo analitico rigoroso svolge un’infinità di azioni che nel suo Diario per gli amici descrive così:
“a) Assistenza alla popolazione più bisognosa (compresa l’assistenza sanitaria: medicine, ecc.).
b) Continuazione delle pratiche per la prima irrigazione, che darà lavoro a mille uomini. Finché non arriva l’acqua nelle campagne, qui c’è fame.
c) Opera di documentazione ed informazione perché si sappia che specie di vita c’è in questa zona, ed in particolare si sappia come nasce qui il banditismo e come ci si vuole porre rimedio.
d) Università popolare e concerti (...) Inizia da oggi la biblioteca popolare.
e) Motopescherecci fuorilegge: non possiamo non essere con tutti i pescatori di qui (...)
f) Quanto ai bambini. A nessun poliziotto, a nessun Prefetto ubbidiremo quando i suoi ordini saranno contro la legge di Dio. Rosetta, di otto anni [morta di stenti NdR] era stata costretta a dormire nel letto del padre tisico (...) In questi casi estremi (...) nessuno ci potrà vietare di accogliere e di amare i figli di tisici, o di carcerati, o di gente alla rovina, quando altri non provvedono ad essi.” (B
anditi a Partinico, Laterza, 1955, p. 221).
Nel 1953 sposa Vincenzina, vedova di un sindacalista con cinque figli. Con Dolci ne avranno alti cinque.
Grazie alle inchieste e agli articoli di denuncia, Trappeto diventa un punto di riferimento per i maggiori intellettuali progressisti italiani e stranieri: Aldo Capitini, Norberto Bobbio, Vittorini, Calvino, Rodari. E poi: Erich Fromm, Bertrand Russell, Aldous Huxley, Lewis Munford, Paulo Freire, Johan Galtung... intrattengono rapporti con Dolci. Nasce il Centro studi ed iniziative per la piena occupazione, sulla ispirazione di Centri di Orientamento Sociale che Capitini aveva tentato di lanciare in Italia. Con i braccianti e i pescatori si organizzano digiuni, marce, scioperi alla rovescia.
Le parole d’ordine sono semplici: Pace e sviluppo, Acqua, Lavoro. Dolci e i suoi collaboratori arrivati da varie parti d’Italia e dall’estero subiranno vari processi ed anche incarcerazioni. Nel 1956, a seguito di uno sciopero alla rovescia con cui un gruppo di disoccupati intende ripristinare la strada comunale Trazzera Vecchia viene arrestato e carcerato per due mesi all’Ucciardone a Palermo come “individuo con spiccata capacità a delinquere”. Al processo sarà difeso da Pietro Calamandrei che svolgerà una celebre arringa, poi pubblicata in un libro Processo all’articolo 4.
Dolci sarà definito “il Gandhi siciliano”, uno “pseudo-apostolo”, ma riceverà critiche anche “da sinistra” per il suo eccessivo individualismo e il rifiuto a stare nelle logiche partitiche. Scriverà nel suo Diario per gli amici: “Alcuni (...) giudicano opportuna la nostra attività di informazione, ma deleteria la cura intima per il nostro prossimo più ferito in quanto ritarda con palliativi il rinnovamento della struttura. Rivoluzione: d’accordo. Non si può rimandare a domani il disoccupato che cerca lavoro perché ha i figli alla fame. Rivoluzione subito. Ma il modo della rivoluzione è essenziale. Se seminiamo piselli non nascono pesci. Se seminiamo morte ed inesattezze non nasce vita “ (p.219). E qui sono evidenti le sue radicate convinzioni nonviolente, gandhiane e tolstojane.
Le cronache delle sue iniziative e le sue conferenze lo fanno conoscere in tutto il mondo. Nel 1957 gli sarà conferito il Premio Lenin per il rafforzamento della pace tra i popoli (il Nobel dell’Unione sovietica). Accetterà quale riconoscimento della “validità delle vie rivoluzionarie nonviolente, accanto alle altre forme di azione e di lotta nell’affrontare la complessa realtà; la continua necessità di un’azione scientifica ed aperta, maieutica direi, dal basso”.
Ma cresceranno anche le ostilità. Il celebre cardinale di Palermo Ernesto Ruffini dirà di Dolci: “In questi ultimi tempi si direbbe che è stata organizzata una congiura per disonorare la Sicilia e tre sono i fattori che maggiormente vi hanno contribuito: la mafia, il Gattopardo, Danilo Dolci. Una propaganda spietata, mediante la stampa, la radio, la televisione ha finito per far credere in Italia e all’estero che di mafia è infettata largamente l’isola” (Tratto dalla
Biografia di Danilo Dolci a Cura del Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci. Sito Ufficiale di Danilo Dolci www.danilodolci.it).
Negli anni ’60 Dolci riesce a raccogliere testimonianze e a formulare circostanziate accuse sul “sistema clientelare mafioso” che avvolge le istituzioni politiche della Sicilia e ottiene audizione presso la Commissione parlamentare antimafia dove depositerà dossier con i nomi “eccellenti” dell’allora ministro al commercio internazionale Bernardo Mattarella e del sottosegretario Calogero Volpe. Denunciato per diffamazione, Dolci verrà condannato – una delle sue tante sconfitte - ma la pena sarà condonata.
Sono centinaia le storie che Dolci riesce a farsi raccontare e costituiscono pezzi di letteratura. Ma ciò che interessa più a noi in questo contesto é scoprire che anche nelle persone più segnate dalla sofferenza, sventurate, sciagurate, “bandite” dalla società... emerge una umanità indomita. Sconfitte sì, ma mai vinte, potremmo dire. Perdenti nella impari lotta per la sopravvivenza in condizioni di estrema povertà, ma mai del tutto disumanizzate.
Solo per avere una piccola idea della bellezza di queste storie, riporto alcuni brevi stralci.
Rosario è un “verdurario”, un raccoglitore di ogni cosa: lumache, rane, anguille, granchi, carbonella, carbone lungo i binari, piombo nei poligoni di tiro.
“Ci sono cinque o sei tipi di verdura: verdura selvaggia, coltivata da nessuno, nasce per conto suo. Tu vai camminando e quel che trovi prendi, giustamente; la mattina ti alzi, circa le quattro, le tre, le cinque: dipende dalla stagione e da dove devi andare. Ti alzi e vai in campagna, fai dieci o dodici chilometri e incominci in mezzo in mezzo a cercare la verdura. (...) Si può fare quattro o cinque chilometri, o di più, in mezzo in mezzo, per riempire un sacco (...) quando il sacco è pieno zeppo ce ne andiamo al paese. A casa la moglie fa trovare una bagnera d’acqua, che ci vuole acqua assai per pulirla bene, altrimenti il rivenditore non la prende (...) Se piove prima di partire, noialtri non ci andiamo, andiamo a lumache (...) Ci sono tre specie di lumache: attuppatedde, babbaluce e crastuna. (...) Per esempio io cammino, e le lumache non ce n’è, ma io vedo la bava che luccica a per terra, io seguisco o la vo a trovare sottoterra, o la trovo aggrappata, ma la devo trovare. (...) Le rane, per venderle, ci tagliamo con la forbice la testa e i quattro piedi, e le scocciamo dalla pelle. Ci leviamo il budello e il fiele. Dopo ci spezziamo le gambe, per gonfiargli le gambe: così la rana sta più pulita, con le cosce grosse. Quando tu vedi le rane con le cosce grosse allora dici: - Me ne dà un chilo -. E anche con le gambe rotte, pelate, senza testa, senza piedi, senza fiele, ancora si muovono. E dopo due ore nell’acqua andiamo a venderle duecento lire al chilo (...) Se tu tagli la testa alla rana e la metti sul tavolo e ci guardi gli occhi, sembrano sempre vivi: come quando guardi un quadro, sembra che guardino sempre te. Quando tu ci hai tagliato tutte le teste, sembra un macello: se tu mettessi tutte le teste schierate una per una... Le prime volte mi facevano un’impressione terribile, poi...L’altranno ne ho ammazzate centocinquanta chili. (...) Questa è l’arte mia, per guadagnare il pane; che io a tutti i mestieri mi butto. Da otto anni fino alla seconda elementare, ho vissuto arrangiandomi così alla meglio. Ringraziando Dio fin oggi non ho avuto niente da spartire con la polizia. E il pane che porto alla mia famiglia è un pane sudato e pulito”. (
Racconti siciliani, pp 32-44).
Nonna Nedda racconta della violenza familiare.
“Quando ci danno legnate, ci mettiamo in un angolo e quelle che cadono cadono. C’è un Dio solo, e il marito è uno solo pure: - Uno è Dio, e uno è il marito,- si dice. Le carezze sono nostre, e le legnate sono nostre pure. Non si può uscire senza ordine suo: ci si deve passare la preferenza, l’ordine. Lui è padrone. (...) Giusto è che il marito picchia la moglie. Quando ha ragione, magari. Non è giusto? Magari linguaire, risponderci? Il marito non pretende, e picchia. (...) Quando una non ci ha che fare, si mette con una vicina e parla, accoppiata magari a quattro o cinque (...) Ci piace a parlare, per svariare il cervello. Quando affaccia il sole, ci affacciamo al sole. – Bih, - dicono, - il sole è affacciato, ha voglia a sparlare -. E io ci rispondo: -E allora il sole non ha affacciare mai? – Il sole è bello, quando si affaccia il sole, col sole si respira meglio. Una che si siede al sole piglia i pensieri di tutti i cristiani. Affacciare il sole vuol dire che la gente si siede in strada in conversazione.” (Racconti siciliani pp 91-93)
Leonardo è un pastorello di pecore e capre.
Da piccolo giocavo strad-strada, che facevo? Mi affitti a tredici anni: mio padre era pastore, e prima avevo fatto il pastore con lui. Le bestie quando uno ce l’ha sottocchio tutto l’anno poi le conosce. (...) Non sono tutte uguali a mungere: c’è quella più selvaggia, quella più mansa; c’è quella che ha le minne giuste, c’è quella che ce le ha più spostate: quella più dura e quella più molle a mungere. Da me si facevano afferrare, dagli altri non si facevano avvicinare.
Non le so contare, ma lo so da lontano se ce ne manca una. Guardo e guardo, fino che me ne accorgo. Le conosco una per una, quella è figlia di quella, quella e figlia di quella. Quante sono, le conosco tutte. Ci sono stato con cento pecore, con duecento. Le contava il padrone quando era ora. (...) Nomi non ne hanno. Quando ci getto una gridata, loro si voltano”. (Racconti siciliani pp 106- 107)
Xx è un truffatore incallito, baro, chiromante professionista, fabbricante di talismani, militare in Africa, frequentatore di bordelli, sifilitico... e fermiamoci qui.
Dolci lo incontra in carcere ormai avanti negli anni e si fa raccontare lungamente la sua vita sicuramente ripugnante. Alla fine Xx ha parole di sorprendente profondità.
“Io penso che se tutti gli esseri umani avrebbero la minima sensazione e comprensione di profondirsi che noi sulla terra fossimo provvisoriamente, i giorni i mesi e gli anni li dovremmo adorare, perché vedendoli trascorrere si trascorre la nostra vita, ragione per cui ci dovessimo tutti adorare, aiutarci uno con l’altro, come fisicamente, e come di tranquillizzarci l’animo gli uni con gli altri (...) il mondo è più in mano di queste persone egoiste, vendicative, che non si curano del bisogno del suo simile (...) L’uomo è così ignorante che trova più poesia nelle cose private, proibite, che nelle aperte. Come quando si è in galera, che se il carceriere lascia la porta aperta, non c’è la voglia di uscire nel corridoio; ma essendo chiusa, si patisce. E’ sempre per tutti così”. (Racconti siciliani pp 104-109).
Una amico di Palcido Rizzotto, sindacalista assassinato dalla mafia.
“Placido si era accorto che tutto, in questo stagno, andava in putrefazione. Qui è come acqua ferma: quando nasce la palude, le cose marciscono, germogliano gli in setti e nasce l’epidemia. Lui diceva: - Non credo che dovremo restare sempre bestie, qua; arriverà il tempo in cui la gente apre gli occhi -. (...) Non posso dare un giudizio: lui è morto e se è morto ha sbagliato, mi viene da dire, da un lato affettivo. Se giudico però da un altro lato, l’ideale di Placido era ammirevole, perché lui operava con tutto il cuore nell’interesse di tutta l’umanità” (Racconti siciliani p.264)
Angela, ha conosciuto suo marito a 15 anni
“Uscivo solo una volta la settimana per la messa, e dopo mi ritiravo subito. Non avevo frequenza con amiche ma avevo simpatia per i bambini e per le mamme. Le ragazze che conoscevo io erano quasi tutte come me.(...) Ci siamo sposati e per un po’ ha lavorato ancora al cantiere [navale]. Una sera di queste mi ha detto: “Sai, devo imbarcarmi”. Gli ho detto: “Perché?”, ero in stato interessante, piangevo, non volevo che mio marito si distaccava, non volevo rimanere sola. Al cantiere prendeva poco, mio marito pensava che venendo i figli ci voleva una casa, bisognava pensare avanti (...) Ognuno non dovrebbe perdersi facilmente: vorrei che gli uomini siano affrattellati, che abbiano salute, lavoro, ma anche che ciascuno abbia il suo silenzio, sentirsi vivere, il corpo che lo desidera, e che tutti siano affratellati, associati sì, ma che mio marito possa stare più in casa”.
Nuto Revelli
La vita, l’impegno e i luoghi di Nuto Revelli sono molto diversi. Nato nel 1919 è della “generazione del Littorio”. Diplomato geometra, ufficiale degli alpini e volontario allo scoppio della seconda guerra. Partecipa alla campagna di Russia – che chiamerà: “lunga marcia della follia”. Sopravvive alla disperata ritirata dal Don. Dopo l’8 Settembre del ’43 si unisce ai partigiani e diventa comandante della brigata Carlo Rosselli di Giustizia e Libertà operante nel cuneese, nelle Langhe. Il suo interesse per la vita delle persone delle classi subalterne e la sua passione per il “dialogo con la gente” incominciano già in caserma tra i commilitoni. Finita la guerra e spentasi “la fiammata della Resistenza”, incomincia a raccogliere una quantità enorme di testimonianze e interviste tra le famiglie dei contadini. Nasceranno i due volumi: Il mondo dei vinti (Einaudi, 1977) e L’anello forte (Einaudi 1985).
In questi lavori l’obiettivo di Revelli é salvare la memoria della civiltà contadina in rapido disfacimento. Revelli pensa che la perdita della memoria storica di una comunità sia grave, perché priva le persone di una parte importante della loro identità e dissolve i legami di solidarietà. Senza alcuna concessione alla nostalgia di un mondo passato fatto di miseria, migrazioni e due guerre mondiali, ma nemmeno senza avallare la tesi dell’ineluttabilità di una “corsa del progresso” sulle ali di una ricostruzione industriale forzata, distruttrice di territorio, che ha comportato lo spopolamento delle aree interne delle montagne e delle colline, che ha lasciato i coltivatori diretti della pianura “padroni della propria miseria”, proprietari di piccoli “fazzoletti di terra”, anche se arati da “trattori enormi”, grazie agli incentivi alla Fiat e alle cambiali garantite dalla Coldiretti. Mentre i poveri di Partinico descritti da Dolci erano i dimenticati dalla Storia, quelli delle Langhe sono “gli emarginati dalla società del benessere”, i contadini “sopravvissuti al grande genocidio”, residui di una “società che muore” (Prefazione a:
Il mondo dei vinti).
Quella di Marietta Ponzo è una delle testimonianze raccolte da Revelli in un borgo di montagna: “Siamo più in pochi su al Colletto, uno qui e uno là, dove un tempo vivevano cento persone (...) Oggi siamo padroni di un pezzo di terra che non vale niente. Il nostro domani? Scendere in pianura, scendere in città a morire in quelle scatole che sembrano prigioni, oppure finire la nostra vita in ricovero” (Il mondo dei vinti, primo volume, p. LXXIV).
Pietro Balsamo è uno dei tanti che racconta le storie dell’emigrazione. “In Francia ne andavano tantissimi, a piedi. Non era un problema andare in Francia, era come andare in campagna qui nei dintorni di Margarita. Passavano il confine di notte, senza documenti, andavano a Nizza o a Mentone a fare i lavori di campagna. Poi, con la guerra del ’15, l’emigrazione è finita”.
Un altro, Balsamo Giovanni, così commenta la fine della Grande Guerra: “Eh, l’abbiamo vinta quella guerra, ma l’abbiamo perduta. La statistica dice che sono più i tubercolotici tornati dalla guerra del ’15-18 che i morti di quella guerra”. Come dirà Nuto Revelli: “La guerra dei poveri non finisce mai”.
Ferdinando Manera, classe 1892, racconta: “C’era chi si stufava della guerra e disertava. Tutti eravamo stufi, come rimbambiti. Gli ufficiali avevano le balle piene anche loro. Conosco un capitano che si è sparato, che si è ferito ad una mano per farla finita... C’era il soldato che si sparava una schioppettata in una gamba pur di andare lontano dal fronte (...) Qui nella Langa saranno stati cinquanta i disertori, e avevano ancora tutti dei soldi. Aiutavano la gente nei lavori di campagna, aiutavano le donne che avevano i mariti al fronte, le tenevano allegre... La gente dava da mangiare ai disertori, anche perché aveva paura”.
Molte sono le storie intrise di violenza. Revelli scrive che “il culto della violenza” imperversa anche tra le classi povere e i deboli sembrano un peso.
Letizia, classe 1901, racconta: “ Allora mia madre mi ha venduta tre anni, mi ha venduta per poche pagnotte di pane a gente che lavorava in Liguria: mia madre ha detto a quella gente che mi tenessero, che lei non aveva da mantenermi. Sun sta cunvinta e vanta che steisa cunvinta che l’avìa vendüme. I nuovi padroni avevano l’osteria, il commestibile, il mulino, i trasporti con i carri. Io accompagnavo un vecchio servitore e che era padre di sette bambini, camminavo giorno e notte, i tre cavalli erano alti come questo soffitto, io non arrivavo all’altezza della pancia dei cavalli, il servitore andava al tiro e io in mezzo alla cavezza. Andavamo fino a Garresio e anche più lontano, una vita grama e da mangiare poco o niente. Poi una brutta notte il servitore è rimasto ucciso da un’automobile, e Tuina [la padrona] a dare la colpa a me, mi ha picchiata come sempre”. (Il mondo dei vinti, secondo volume, p. 195).
Pino Luchese, classe 1885, racconta la sua storia: “A dieci dodici anni si andava già via da vaché [servitori di campagna], le famiglie erano tutte numerose (...) La mia famiglia aveva un po’ di bosco, di castagneto, e un po’ di prato, più o meno avevano tutti così, qui era tutta piccola proprietà (...) Si faceva come si poteva, patate, meliga, castagne, ci adattavamo alla miseria (...) La vita oggi è cambiata da così a così. Sì, è cambiata in meglio. Ma non per tutti. Per parte mia no, non c’è più il dovuto rispetto per il vecchio. Oggi c’è il benessere, troppa abbondanza, alla radio parlano di milioni e miliardi come niente. Che vada sempre bene come oggi, io auguro ogni bene ai giovani perché ho anche della famiglia, i nipoti. Ma il benessere bisogna anche saperlo curare, non sprecarlo”.
SECONDA PARTE
IL LINGUAGGIO E LA LOGICA DELLA POLITICA
Il linguaggio della politica è infarcito di metafore guerresche: “scendere in campo”, stare in “prima linea”, appartenere ad un “fronte”, “posizionarsi”, “militare” in uno o nell’altro “schieramento”, “conquistare” voti, seggi, parlamenti, consigli di amministrazione, banche ... e tanti altri bottini di guerra! Von Clausewitz diceva che la guerra è il prolungamento della politica, ma forse è più giusto pensare che sia la politica la prosecuzione della guerra.
La politica è tanto più forte, nella attuale comune concezione, quanto è più capace di prevalere e di imporre le proprie visioni e le conseguenti scelte sull’intero corpo sociale. Insomma, l’ideale politico è quello del dominio, attraverso la conquista degli apparati amministrativi e tecnici. Prevale un’idea del governo come comando, più che come garante e guida. Chi vince si adopera per “prendere tutto”, per superare le stesse divisioni e le autonomie dei diversi poteri costituzionali. Quando sentiamo ripetere in continuazione: “Il giorno dopo le elezioni dobbiamo sapere chi ha vinto e chi ha perso”, in realtà si vuole dire: “Chi vince non farà prigionieri”.
Non c’è più un luogo in cui le diverse parti politiche possano “parlamentare”, dialogare, mediare nel tentativo di trovare le soluzioni migliori per tutti. I tempi del confronto sono percepiti come una perdita di tempo. Le assemblee elettive sono ridotte a palazzetti dello sport popolate da variopinte tifoserie. In nome della tempestività e dell’efficienza sta avvenendo un processo di accentramento dei poteri in mano agli “esecutivi”. Peggio, al “capo”. Ciò è evidentissimo nei Comuni, dove il sindaco è diventato una figura monocratica: i consiglieri comunali non contano più nulla e gli assessori sono consulenti privati del principe.
Insomma, la politica appare sempre più aggressiva nel linguaggio e autoritaria nei comportamenti. É evidente che si tratta di un colossale, paradossale abbaglio: all’indebolimento dei sistemi democratici nazionali – dovuto a enormi mutazioni macroeconomiche, tecnologiche, geopolitiche – il ceto politico si illude di rispondere menomandone il funzionamento, riducendo la loro rappresentatività e quindi la loro autorevolezza. Siamo entrati un una spirale pericolosissima, il cui punto di caduta è già evidente nel riemergere di tendenze neonazionaliste feroci, razziste, xenofobe: “American First”, “Prima gli italiani”, “Primi i veneti” e via balcanizzando e aizzando le popolazioni le une contro le altre.
Il problema della deriva dispotica della politica, della riduzione del tasso di democrazia della politica (per richiamare un libro fondamentale di Marco Revelli, La politica perduta, Einaudi 2002) è più grave di quel che si pensa, perché molto probabilmente non dipende dalle scelte occasionali dei leader, dei loro partiti e degli elettori, ma più al fondo deriva da antiche concezioni filosofiche e da consolidati postulati antropologici. La bipolarizzazione della politica tra vinti e vincitori, maggioranza e opposizione, governanti e governati, dirigenti e diretti, elite e masse non sarebbe
altro che un riflesso del modo di pensare dualistico della cultura occidentale che scompone e riduce la complessità della realtà umana su due assi cartesiani: bene/ male, giusto/sbagliato, vero/falso, pubblico/privato, individuo/comunità, struttura/sovrastruttura, oggettivo/soggettivo, fatti/valori, razionale/emotivo, teoria/prassi, tattica/strategia, forza/debolezza, uomo/donna... e, in generale, amico/nemico.
Un modo di pensare dicotomico e antinomico che conduce alla disastrosa separazione e opposizione tra “noi” e “loro”, impedendo agli individui di riconoscersi in comunità concorrenti (nel senso di complementari, interconnesse, interdipendenti) e non ostili, non esclusive, ma plurime, non mono-identitarie. L’“uomo planetario” di cui parlava Ernesto Balducci ha una coscienza di sé come appartenente a tutte le specie viventi e alla famiglia umana, prima ancora che al proprio clan e alla propria famiglia.
Ci portiamo addosso un’idea antropologica individualista dell’essere umano come se fosse un “atomo di egoismo” che per legge di natura è portato a ricercare il proprio tornaconto personale. Siamo ancora dentro l’ideal-tipo umano del sistema delle relazioni sociali capitalistiche, liberistiche. Siamo ancora completamente immersi nella visione di Thomas Hobbes dell’ homo homini lupus, del bellum omnium contra omnes.
Insomma, la politica continua ad essere una pratica che mutua le sue regole dalla guerra e ne richiama la logica di violenza. In guerra, come nella politica, vince il più forte e chi vince ha la ragione dalla sua parte. Carl Schmitt ci ricorda cinicamente la differenza tra l’autorità e la verità: auctoritas, non veritas facit legem. Così come, ben prima di lui, Machiavelli ci ha spiegato l’esistenza di un doppia etica: quella del Principe, per cui vale solo il risultato delle sue azioni, e quella dell’individuo singolo che è invece sempre vincolato a rispettare i precetti di vita cristiani; compresa l’ubbidienza al Principe, suo Cesare – ovviamente!
Oggi, la riproposizione in politica di un linguaggio e di comportamenti sempre più aggressivi e dispotici potrebbero sembrare persino ridicoli a fronte della manifesta incapacità dei governi nell’affrontare i sempre più gravi problemi che l’umanità ha di fronte (pensiamo ai cambiamenti climatici, alle migrazioni bibliche, alla corsa agli armamenti, all’inurbamento nelle megalopoli del terzo mondo, alle disparità sociali, agli sprechi di risorse, all’uso manipolatorio delle tecnologie, alla finanza fuori controllo...). Piccoli aspiranti dittatori giocano con un mappamondo a forma di palloncino prossimo a scoppiare.
Mi si obietterà che è generalmente accettato che il metodo migliore per stabilire chi abbia il diritto di governare sia quello elettorale. Ma anche le consultazioni elettorali, svestite dalla retorica, sembrano una pantomima di una battaglia campale. Si comincia con un lungo lavorio di preparazione (alleanze, coalizioni ecc.) per rifornire le salmerie (finanziamenti e sottoscrizioni, acquisizioni di mezzi di comunicazione ecc.), per stabilire le regole dello scontro (leggi elettorali), per selezionare i guerrieri più prestanti ed infine, all’ora x, viene dato fuoco alle polveri.
Destinatari di questi giochi pirotecnici sono i cittadini-elettori che devono assistere allo spettacolo e sono invitati ad esprimere le loro simpatie tramite un voto. Si compie così la “trasformazione della popolazione in elettorato” – per usare una espressione di Pierre Rimbert (
Dietro le quinte del mercato elettorale su "Le Monde Diplomnatique" del maggio 2017). Il “principio di maggioranza” stabilisce chi è il più forte, legittima i vincitori e condanna le minoranze all’angolo. Chi vince è legittimato ad interpretare e applicare giustizia, ordine ed economia. Così è stabilito dalle regole della democrazia. Il Demos (popolo) esercita la sua sovranità attraverso una rappresentanza che è quindi legittimata ad esercitare il Kratòs (potere). Ma da tempo si capisce che qualche cosa non funziona. Vi è una crisi di credibilità nel sistema democratico che allontana gli elettori e che rende il “gioco parlamentare” alquanto inefficace. Le regole del gioco sono truccate, i partiti sono catturati dai loro finanziatori, i margini reali di scelta delle politiche sociali ed economiche sono stabiliti da poteri esterni alle assemblee elettive, le diversità tra le formazioni politiche che si contendono la conquista degli apparati di governo sono in realtà più di facciata che di sostanza. E potremmo continuare a lungo elencando gli elementi della crisi della politica.
Ma è giusto segnalare l’esistenza di un altro modo di intendere la politica come una azione permanente per abbassare il baricentro delle decisioni, disseminare il potere, creare orizzontalità nelle reti civiche solidali. Guido Viale ci invita a distinguere tra com-petizione e con-correnza. Concorrere vuol dire correre insieme, alla pari e tra uguali, dove gli uni e gli altri contribuiscono al raggiungimento di uno scopo comune, di un bene da condividere. “Correre ha nella sua radice il verbo greco reo, scorro. Panta rei, tutto scorre, diceva Eraclito (...) Concorrere significa portare il proprio contributo a un processo comune”. Mentre: “Competizione viene dal verbo latino peto: chiedere per avere, cercare di ottenere” (G.Viale, Slessico familiare. Parole usurate, prospettive aperte, edizioni interno 4, 2017). Un vecchio sindacalista,
Vittorio Foa, diceva: “La politica non è solo comando, è anche resistenza al comando (...) la politica non è, come in genere si pensa, solo governo della gente, politica è aiutare la gente a governarsi da sé” (V. Foa, Prefazione a
La Gerusalemme rimandata, Rosenberg & Sellier, 1985). La vicinanza con il pensiero di Danilo Dolci è evidente: si tratta di concepire l’idea stessa di potere un altro modo. Dolci scriveva che bisognava “Correggersi dalla losca confusione fra potere e dominio, occorre distinguere. Il potere nonviolento può strutturarsi senza diventare dominio”, se riesce ad agire mutualmente. Mentre la mentalità del dominatore fa parte fa parte di una “perversione di origine psicopatologica”. (D.Dolci, C
omunicare, legge della vita, La Nuova Italia, 1997).
Sezano, gennaio 2018
Paolo Cacciari, La sconfitta. Condannati a vincere? è scaricabile qui
 il manifesto, 24 gennaio 2018. Ovviamente PaP firma l'appello, ma ricorda che molti dei proponenti (d'Alema, Bersani, e moltissimi altri membri del Pd e dello stessa listaGrasso hanno votato contro la costituzione.
il manifesto, 24 gennaio 2018. Ovviamente PaP firma l'appello, ma ricorda che molti dei proponenti (d'Alema, Bersani, e moltissimi altri membri del Pd e dello stessa listaGrasso hanno votato contro la costituzione.
Abbiamo letto l’appello rivolto alle liste elettorali da parte di Felice Besostri e altri costituzionalisti a sottoscrivere un patto che contrasti «ogni ulteriore proposta di riforma che miri a modificare la forma democratica e parlamentare del nostro modello repubblicano» e ogni ulteriore tentativo di «costituzionalizzare principi neoliberisti o limitare la sovranità popolare, i diritti fondamentali delle persone».
Per Potere al Popolo si tratta di un impegno scontato: la nostra è la lista del No sociale al referendum del 4 dicembre, per questo non possiamo non aderire al Patto che pone le condizioni minime per qualunque lista che abbia a cuore la difesa dei diritti. Condizioni minime ma non sufficienti, a nostro avviso, ad assicurare attualmente quei diritti ai lavoratori, alle donne, agli studenti, ai pensionati, ai richiedenti asilo, ai senza casa, ai malati, ai precari, ai disoccupati, agli abitanti delle periferie.
L’appello infatti chiede di non violare la Costituzione «ulteriormente», visto che le violazioni negli ultimi anni sono state ripetute, persino da parte di chi oggi aderisce al Patto. Molti tra i candidati più in vista di LeU – firmatari dell’appello – come Bersani e D’Alema hanno deliberatamente modificato la Costituzione che oggi si impegnano a difendere.
Lo hanno fatto insieme a Berlusconi riscrivendo l’articolo 81 e inserendo l’obbligo del pareggio di bilancio imposto dalle oligarchie europee, votando la riforma Fornero, il Jobs Act e le altre leggi che hanno reso la Costituzione lettera morta.
Il pareggio di bilancio ha obbligato gli enti locali a tagliare drasticamente la spesa destinata ai servizi sociali fondamentali: sanità, edilizia popolare, trasporto pubblico, istruzione, solo per citarne alcuni. Oggi cinque milioni di italiani sono in povertà assoluta, dieci in povertà relativa, undici rinunciano alle cure mediche. Comprendiamo che chi in passato ha tradito il ripudio della guerra, bombardando gli inermi e votando a favore delle finanziarie che ogni anno hanno aumentato le spese militari, non possa oggi promettere la pace né sottrarsi ai vincoli della Nato, che chiede ai paesi aderenti di destinare il due per cento del Pil alle spese militari.
Potere al Popolo invece si batterà per garantire a tutte e tutti l’effettiva applicazione dei principi fondamentali della Costituzione, a cancellare l’obbligo del pareggio di bilancio, a contrastare le misure di austerity imposte dai trattati europei. Ci impegniamo a cancellare le leggi che hanno alzato muri tra le persone e limitato i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, degli omosessuali, dei richiedenti asilo. Aderiamo, con l’auspicio che la Costituzione, patrimonio di tutti i cittadini e non di una o più liste elettorali, possa in futuro essere modificata non per negare i diritti ma per estenderli alla maggioranza della popolazione.
Potere al popolo si opporrà a ogni tentativo di fare della prossima una «legislatura costituente»: un parlamento eletto col Rosatellum non ha la legittimità di toccare la Costituzione. Siamo l’unica lista che si pronuncia per l’approvazione di una legge elettorale proporzionale finalmente costituzionale. Soprattutto, continueremo a difendere la Costituzione non tanto firmando appelli ma sostenendo e prendendo parte alle lotte di coloro che si battono nelle piazze e nei luoghi di lavoro per tutelare e conquistare i diritti costituzionali finora negati.
Per vedere e sentire: Viola Carofalo è il “capo politico” di Potere al Popolo