

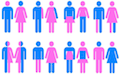 «Una manifestazione così massiccia come si è vista ieri a Roma contro «l’ideologia
«Una manifestazione così massiccia come si è vista ieri a Roma contro «l’ideologia
gender», ha fatto esplodere un sentimento covato da una parte consistente del mondo cattolico, ma senza input dall’alto, senza la mobilitazione partita dai pulpiti». Ne siamo proprio sicuri? Corriere della Sera, 21 giugno 2015 (m.p.r.)
Parte del mondo cattolico ha manifestato la sua disperazione culturale per un modo di vedere le cose, il demonizzato «gender», che sradica l’umanità da se stessa. È stata fornita un’immagine implicitamente polemica verso l’atteggiamento «accomodante» del Papa.
 «Con questa enciclica il gioco di far finta di non capire non sarà più possibile. Bisognerà stare o dalla parte di Francesco o contro di lui, perché sta chiedendo una scelta. E questo vale non solo per i politici, per gli opinionisti, per i giornali, vale anche per i vescovi, per i cardinali. E vale anche per i semplici fedeli».
«Con questa enciclica il gioco di far finta di non capire non sarà più possibile. Bisognerà stare o dalla parte di Francesco o contro di lui, perché sta chiedendo una scelta. E questo vale non solo per i politici, per gli opinionisti, per i giornali, vale anche per i vescovi, per i cardinali. E vale anche per i semplici fedeli».
Il manifesto, 19 giugno 2015 (m.p.r.)
C’è un debito estero dei Paesi poveri che non viene condonato, e anzi si è trasformato in uno strumento di controllo mediante cui i Paesi ricchi continuano a depredare e a tenere sotto scacco i Paesi impoveriti, dice il papa (e la Grecia è lì a testimoniare per lui). Ma il “debito ecologico” che il Nord ricco e dissipatore ha contratto nel tempo e soprattutto negli ultimi due secoli nei confronti del Sud che è stato spogliato, nei confronti dei poveri cui è negata perfino l’acqua per bere e nei confronti dell’intero pianeta avviato sempre più rapidamente al disastro ecologico, all’inabissamento delle città costiere, alla devastazione delle biodiversità, non viene pagato, dice il papa (e non c’è Troika o Eurozona o Banca Mondiale che muova un dito per esigerlo).
La denuncia del papa («il mio appello», dice Francesco) non è generica e rituale, come quella di una certa ecologia “superficiale ed apparente” che si limita a drammatizzare alcuni segni visibili di inquinamento e di degrado e magari si lancia nei nuovi affari dell’economia “verde”, ma è estremamente circostanziata e precisa: essa arriva a lamentare che la desertificazione delle terre del Sud causata dal vecchio colonialismo e dalle nuove multinazionali, provocando migrazioni di animali e vegetali necessari al nutrimento, costringe all’esodo anche le popolazioni ivi residenti; e questi migranti, in quanto vittime non di persecuzioni e guerre ma di una miseria aggravata dal degrado ambientale, non sono riconosciuti e accolti come rifugiati, ma sbattuti sugli scogli di Ventimiglia o al di là di muri che il mondo anche da poco approdato al privilegio si affretta ad alzare, come sta facendo l’Ungheria. L’«appello» del papa giunge poi fino ad accusare che lo sfruttamento delle risorse dei Paesi colonizzati o abusati è stato tale che dalle loro miniere d’oro e di rame sono state prelevate le ricchezze e in cambio si è lasciato loro l’inquinamento da mercurio e da diossido di zolfo serviti per l’estrazione.
Questa enciclica rappresenta un salto di qualità nella riflessione sull’ambiente, si potrebbe dire che apre una seconda fase nella elaborazione del discorso ecologico, così come accadde nel costituzionalismo quando dalla prima generazione dei diritti, quelli relativi alle libertà civili e politiche, si passò alla considerazione dei diritti di seconda e terza generazione, sociali, economici, ambientali, e cambiò il concetto stesso di democrazia.
Ora il discorso della giustizia sociale e della condizione dei poveri, a cui nei Paesi del Sud «l’accesso alla proprietà dei beni e delle risorse per soddisfare le proprie necessità vitali è vietato da un sistema di rapporti commerciali e di proprietà strutturalmente perversi», viene introdotto organicamente da papa Francesco nella questione ecologica, sicché essa non riguarda più semplicemente l’ambiente fisico, il suolo, l’aria, l’acqua, le foreste, le altre specie viventi, ma assume la vita e il destino di tutti gli esseri umani sulla terra, diventa un’«ecologia integrale», a cui è dedicato l’intero capitolo quarto dell’enciclica: «Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale», dice il papa; e la prima cosa da sapere, come dicono i vescovi boliviani ma anche molte altre Chiese, è che i primi a essere colpiti da «quello che sta succedendo alla nostra casa comune» sono i poveri. E il salto di qualità è anche nel rigore dell’analisi, nella cura con cui vengono ricercate tutte le connessioni tra i diversi fenomeni ed ecosistemi, e anche nell’onestà con cui si dice che non tutto possiamo sapere, che la scienza deve fare ancora un grande cammino, e che non si può presumere di prevedere gli sviluppi futuri, sicché il principio di precauzione diventa un obbligo di saggezza e di rispetto per l’umanità di domani, contro l’ideologia della ricerca immediata del profitto e dell’egoismo realizzato.
Si può capire allora come con questa enciclica che comincia con un cantico di san Francesco e finisce con una preghiera in forma di poesia, l’idillio del mondo ricco con papa Francesco sia finito. «Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra», dice il papa nella sua preghiera. «Non occuparti di politica, perché l’ambiente è politica», gli dicono i ricchi. E mentre da un lato quello che negli Stati Uniti non si fa chiamare Bush per riprendersi in famiglia il governo dell’America dice che non si farà dettare la sua agenda dal papa, dall’altro quello che da noi pubblica sulle sue felpe messaggi di razzismo e di guerra dice che non c’è proprio di che essere perdonati per le porte chiuse in faccia ai profughi e tutti i «clandestini» vorrebbe metterli a Santa Marta.
«Questo papa piace troppo» diceva la destra più zelante, allarmata al vedere masse intere di persone in tutto il mondo affascinate da un pensiero diverso dal pensiero unico. Però si faceva finta di niente, sperando che la gente non capisse. Il papa diceva che l’attuale sistema non ha volto e fini veramente umani, e stavano zitti. Diceva che questa economia uccide, e stavano zitti. Diceva che l’attuale società, in cui il denaro governa (Marx diceva «il capitale») è fondata sull’esclusione e lo scarto di milioni di persone, e stavano zitti. Diceva ai politici che erano corrotti, e stavano zitti. Diceva ai disoccupati di lottare per il lavoro e ai poveri di lottare contro l’ingiustizia, e facevano il Jobs Act.
Ma con questa enciclica il gioco di far finta di non capire non sarà più possibile. Bisognerà stare o dalla parte di Francesco o contro di lui, perché non sta facendo una predica, sta chiedendo una scelta. E questo vale non solo per i politici, per gli opinionisti, per i giornali, vale anche per i vescovi, per i cardinali. E vale anche per i semplici fedeli perché, scrive Francesco «dobbiamo riconoscere che alcuni cristiani impegnati e dediti alla preghiera, con il pretesto del realismo e della pragmaticità, spesso si fanno beffe delle preoccupazioni per l’ambiente».
Quello che infatti da Francesco è posto davanti al mondo è il problema vero: «il grido della terra» è anche il «grido dei poveri», ma nel monito che si leva dai poveri perché la loro vita non vada perduta, c’è un monito che riguarda tutti, perché senza un rimedio, senza un cambiamento, senza un’assunzione di responsabilità universale la vita di tutti sarà perduta.
Ed è per questo che l’enciclica di papa Francesco è rivolta a «ogni persona che abita questo pianeta»: non ai cattolici, e nemmeno agli «uomini di buona volontà», come faceva la «Pacem in terris» di Giovanni XXIII, in cui si poteva sospettare ancora un residuo di esclusione, nei confronti di qualcuno che eventualmente fosse di volontà non buona. Qui papa Francesco abbraccia veramente tutti (come ne sono figura essenzialissima per il cristiano le braccia di Cristo aperte sulla croce) e si pone non come capo di una Chiesa, e nemmeno come profeta dei credenti, ma come padre della intera umanità. Perché il messaggio è il seguente: non questa o quella Potenza o Istituzione, non questo o quello Stato, non quel partito o movimento, ma solo l’unità umana, solo la intera famiglia umana giuridicamente costituita e agente come soggetto politico può prendere in mano la terra e assicurarne la vita per l’attuale e le prossime generazioni.
 «Con la morte della discussione politica è morta per asfissia anche la mente collettiva, come soggetto critico». L'accettazione dello slogan della politica come cosa sporca e l'indifferenza nei coinfronti del genocidio dei profughi dalla misera e dalla guerra sono due facce della stessa medaglia.
«Con la morte della discussione politica è morta per asfissia anche la mente collettiva, come soggetto critico». L'accettazione dello slogan della politica come cosa sporca e l'indifferenza nei coinfronti del genocidio dei profughi dalla misera e dalla guerra sono due facce della stessa medaglia.
Il manifesto, 14 giugno 2015
Qualche giorno fa sul Corriere della sera è apparso un articolo che si interrogava sulle radici della corruzione dilagante in Italia. Giovanni Belardelli invitava a considerare le finalità perseguite da uomini politici «spinti in via esclusiva da miserabili aspirazioni di arricchimento personale» e puntava il dito sulla scadente qualità di una classe dirigente «priva di ogni aspirazione od obiettivo di natura politica, come non era invece nella Prima Repubblica». L’ascesa di una razza padrona del tutto indifferente alle sorti della cosa pubblica era indicata tra le cause principali del verminaio scoperchiato ogni giorno dalle cronache politico-giudiziarie.
In questo argomento c’è indubbiamente del vero, ma è probabile che esso vada sviluppato sino a coinvolgere gli stessi corpi sociali. Forse il tramonto della politica aiuta a comprendere un fenomeno tra i più allarmanti: che il paese convive pacificamente con quella cloaca a cielo aperto che in molti territori (a cominciare dalla capitale) e in tanti gangli dello Stato centrale ha di fatto sostituito le istituzioni della politica e dell’amministrazione pubblica. Certo non tutti appaiono cinicamente indifferenti. Ma anche la reazione antipolitica converge nella passività, tradendo un radicale disincanto. La politica appare ai più una «cosa sporca» con la quale il paese è costretto a convivere. Se pensiamo al trauma che fu, venti e rotti anni fa, la scoperta di Tangentopoli, non c’è paragone. Non solo la piaga della corruzione è oggi ben più vasta e infetta. Non c’è neppure l’ombra dell’indignazione che allora scosse l’opinione pubblica.
Il fatto è che se non c’è più la politica – il confronto tra culture, modelli di società, progetti, concezioni diverse dei valori e dei fini della convivenza civile – subentra il naturalismo. Ci si identifica immediatamente con l’esistente senza nemmeno immaginare la possibilità di un’alternativa. Magari si mugugna e si protesta, ciascuno nel suo piccolo. Ma intanto, forse inconsapevolmente, ci si rassegna, perché così va il mondo. Il tramonto della politica è la morte della critica, o nel silenzio del risentimento o nelle grida della deprecazione fine a se stessa.
Tutto ciò aiuta a spiegare anche un’altra vicenda sconvolgente all’ordine del giorno: la risposta vergognosa, inaudita delle leadership europee (a cominciare dai principali paesi dell’Unione) alla drammatica emergenza umanitaria costituita dall’arrivo in massa dei profughi dall’Africa. Che i Cameron, i Merkel, gli Hollande e i Rajoy, per non parlare dei commissari europei e degli altri capi di Stato e di governo, non siano dei giganti, non c’è dubbio. Ma bisogna riconoscere che essi non millantano affermando che, ove decidessero di coinvolgere i propri paesi in questa tragedia, rischierebbero di perdere buona parte del consenso di cui ancora godono, e farebbero per di più il gioco degli imprenditori politici del razzismo, del nazionalismo e della xenofobia.
Piaccia o meno, si tratta di un timore fondato e ciò dà la misura della gravità del problema con il quale si tratta di fare i conti. La fuga in massa dalla guerra, dal terrore, dalla miseria e dalla fame non si arresterà. L’Europa rimarrà a lungo per decine di milioni di persone una meta irrinunciabile. Il diritto di chi chiede asilo non è negoziabile, ma l’ipotesi di un’immigrazione illimitata non è realistica e il rischio di una reazione di stampo razzista e fascistoide in gran parte dei paesi europei appare concreto. Si può discutere fin che si vuole sulle responsabilità di questo stato di cose. Chiamare in causa chi nell’ultimo quarto di secolo ha contribuito a scatenare una guerra dopo l’altra tra Corno d’Africa e Asia centrale, passando per l’Iraq, i Balcani, la Libia e la Siria. Denunciare l’insipienza delle élite politiche europee che hanno sempre sottovalutato il problema, illudendosi di governarlo con misure di tamponamento. Resta che oggi nessuno sa come risolverlo senza violare i diritti dei migranti e al tempo stesso evitando in Europa terremoti sociali e politici che potrebbero resuscitare gli spettri più inquietanti del nostro passato.
L’Europa si è illusa di essersi liberata dal fardello della propria storia dopo la Seconda guerra mondiale. In realtà le ceneri dalle quali è rinata non contenevano soltanto la coscienza democratica e l’universalismo, l’illuminismo e la cultura dei diritti individuali e sociali, ma anche il colonialismo, il razzismo e la xenofobia, il nazionalismo e il comunitarismo. Nella tensione tra queste componenti dell’identità europea la rivoluzione neoliberale ha influito in modo decisivo. Non governati, gli spiriti animali hanno imposto un fine indiscutibile nell’impiego delle enormi risorse materiali e umane disponibili nel Vecchio continente. Hanno decretato il ridursi della politica ad amministrazione, asservendola alla sovranità del capitale privato. Come mostra da ultimo la guerra della troika contro la Grecia, hanno criminalizzato e messo al bando il confronto critico sui valori, i criteri di giudizio e i modelli sociali. Ma l’avvento della postdemocrazia tecnocratica ha comportato un prezzo elevatissimo in termini di consapevolezza e di responsabilità – di qualità etica – delle popolazioni.
Con la morte della discussione politica è morta per asfissia anche la mente collettiva, come soggetto critico. Le società europee ristagnano ormai da decenni in una morta gora e nei corpi sociali, terrorizzati dalla crisi e consegnati alla ripetizione di un eterno presente, dilagano le ansie e il rancore, e ferve una ricerca mal orientata di sicurezza. Ci si rinchiude ciascuno nel proprio micromondo privato. Il fuori inquieta, l’importante è non esserne sfiorati. A chi comanda – non importa se incapace o corrotto – non si chiede che di essere lasciati in pace. Ma così non solo la corruzione straripa, non solo l’umana pietà dilegua. Rischia di tornare anche la rimossa fascinazione di un’Europa fatta di caste e gerarchie e di comunità chiuse agli stranieri e ai diversi.

Il manifesto, 12 giugno 2015, con postilla
Da settimane si agita lo spettro delle persone sbarcate in Italia per cercare rifugio nel nostro o negli altri paesi europei. In realtà, il loro numero dall’inizio dell’anno al 7 giugno è di 52.671. Quindi, poco più dei 47.708 registrati nello stesso periodo dell’anno scorso. Sulla base di questo trend è calcolabile un numero di 190.000 a fine anno (200.000 secondo altri). Come si giustificano, allora, le posizioni estreme e i toni, talora quasi paranoici, raggiunti nel dibattito su questo fenomeno in Italia e in Europa? Davvero si vuol far credere che l’arrivo di alcune centinaia di migliaia di persone costituisca una minaccia per gli equilibri economici e sociali di un gruppo di paesi tra i più ricchi del mondo?
In realtà, stiamo assistendo a una grossolana mistificazione.
Intanto, sembra smarrito ogni senso delle proporzioni e si parla come se s’ignorassero dati di fatto significativi. I paesi membri dell’Ue, alla fine del 2013, contavano un numero di immigrati di prima generazione (cioè nati all’estero), regolarmente registrati ed attivi nelle rispettive economie assommanti a più di 50 milioni, di cui circa 34 milioni nati in un paese non europeo. Questi immigrati, come gli altri che li hanno preceduti, concorrono direttamente alla produzione e alla ricchezza di quei paesi. E non si vede proprio come nuovi flussi che si aggiungono a quelli registratisi negli anni precedenti non possono essere assorbiti con vantaggi demografici, economici e socio-culturali, solo che si adottino politiche appropriate e positive d’inclusione sociale.
In secondo luogo, invece di contrastare sentimenti xenofobi, che pure allignano in parti della popolazione, li si strumentalizza e incoraggia pur di guadagnare consensi elettorali nel modo più spregiudicato. L’esempio più vicino di tale irresponsabile comportamento viene dalle dichiarazioni dei governatori di alcune delle regioni più ricche del paese. Il loro lepenismo sembra ignorare che proprio la vantata ricchezza di quelle regioni è dovuta anche al massiccio sfruttamento del lavoro degli immigrati. Sfruttamento tanto più facile e pesante con i clandestini. E questo ci porta dritto alla seconda mistificazione cui stiamo assistendo in Italia e in Europa.
Indicare gli immigrati come una minaccia serve a motivare misure di contrasto e leggi restrittive che in realtà servono a sfruttare al massimo il loro lavoro, inducendoli a lavorare in nero, in impieghi pesanti e mal pagati, in affitto, a chiamata e simili. Infatti, sono proprio le soglie di sbarramento all’integrazione, poste sempre più in basso, e il mancato o difficoltoso riconoscimento dei diritti ai lavoratori immigrati che permettono ai gruppi dirigenti economici e ai loro alleati politici di sfruttare anche l’immigrazione per spingere verso la concorrenza al ribasso delle condizioni di lavoro. In tal modo, si rendono più agevoli le politiche di restrizione dei diritti dei lavoratori e di smantellamento dello Stato sociale.
In terzo luogo, agitare lo spettro del pericolo immigrazione occulta altre responsabilità. Il fatto, cioè, che i maggiori paesi europei, Gran Bretagna e Francia in testa, ma seguiti anche da Germania e Italia si sono fatti promotori, accanto agli Stati Uniti e insieme ad altri, di pesanti interventi politico-militari in Africa e in Medio Oriente. L’elenco è lungo. Si può cominciare dall’interminabile guerra in Afghanistan. Si può proseguire con il supporto dato alla ribellione contro il regime siriano, rinfocolando conflitti civili e religiosi che ora sfuggono ad ogni controllo. Ancor più diretto è stato l’intervento in Libia, col risultato di una situazione, se possibile, ancor più confusa e ingovernabile. Si è soffiato sul fuoco di vecchi conflitti tra le popolazioni in Africa Centro-orientale perseguendo obiettivi tutt’altro che chiari. E lo stesso può dirsi per gli interventi in Mali e altri paesi.
Nel 2013, il numero di profughi che hanno cercato di fuggire da zone di guerra, conflitti civili, persecuzioni e violazioni dei diritti umani è stato di 51,2 milioni. Anche a considerare circa un quinto di essi, vale a dire gli 11,7 milioni di persone che, in quell’anno, si trovavano sotto il diretto mandato dell’Alto commissariato per i rifugiati delle nazioni unite e per i quali disponiamo di dati certi, vediamo che più della metà era costituito da persone che fuggivano dalla guerra in Afghanistan (2,5 milioni), dall’improvvisa deflagrazione del conflitto in Siria (2,4 milioni), dalla recrudescenza degli scontri da tempo in atto in Somalia (1,1 milione). Ad essi seguivano i profughi provenienti dal Sudan, dalla Repubblica democratica del Congo, dal Myanmar, dall’Iraq, dalla Colombia, dal Vietnam, dall’Eritrea. Per un totale di altri 3 milioni, sempre nel solo 2013. Altri richiedenti asilo cercavano di scampare dai «nuovi» conflitti in Mali e nella Repubblica Centrafricana.
La grande maggioranza di queste e altri milioni di persone fuggite da situazioni di pericolo e sofferenza, sempre nel 2013, non hanno cercato e trovato accoglienza nei paesi più ricchi d’Europa o negli Usa, bensì nei paesi più vicini. Paesi con un Pil pro capite basso e variante tra i 300 e i 1.500 dollari l’anno. Infatti, fin dallo scoppio della guerra del 2001, il 95% degli afgani ha trovato rifugio in Pakistan. Il Kenya ha accolto la maggioranza dei somali. Il Ciad molti sudanesi. Mentre altri somali e sudanesi hanno trovato rifugio in Etiopia, insieme a profughi eritrei. I siriani si sono riversati in massima parte in Libano, Giordania e Turchia. Di fronte all’entità di questi flussi, il numero delle persone che, sempre nel 2013, hanno cercato protezione internazionale in 8 dei paesi più ricchi dell’Ue, con Pil pro capite dai 33.000 ai 55.000 dollari, assommava a 360mila (pari all’83% dei rifugiati in tutta l’Ue).
Questi dati di fatto dimostrano l’assoluta mancanza di fondamento e la totale strumentalità che caratterizza la discussione in atto tra i paesi membri e le stesse istituzioni dell’Ue. Si discute di pattugliamenti navali, bombardamenti di barconi, per concludere con quello che viene definito un «salto di qualità» nel dibattito e che consisterebbe nella proposta di accogliere nei 28 paesi membri dell’Ue un totale di 40.000 rifugiati in due anni. Mentre, nel 2013, Pakistan, Iran, Libano, Giordania, Turchia, Kenya, Ciad, Etiopia, da soli, ne hanno accolti 5.439.700. Il che significa che un gruppo di paesi, il cui Pil è 1/5 di quello dei paesi dell’Ue, ha accolto in un anno un numero di immigrati e rifugiati che è 136 volte più grande del numero di quelli che sono disposti ad accogliere i paesi della grande Europa in due anni! Ma perfino questa misera proposta viene ora messa in discussione, dato anche l’atteggiamento negativo di paesi come la Gran Bretagna e la Francia, che pure si autodefiniscono grandi e civili. Lo spettacolo di tanta pochezza politica e morale induce a chiedersi se i nostri governanti e i dirigenti di Bruxelles si rendono conto che stanno assestando un altro colpo alla credibilità dell’Unione europea.
postilla
Tanto più indignano le reazioni - di troppi eletti e troppi elettori - in quanto la penisola chiamata Italia è abitata da popoli che hanno conosciuto tutti analoghe storie di fuga dalla miseria o dalla guerra. Quanti di noi italiani sono stati profughi nella prima guerra mondiale dopo la disfatta di Caporetto, o durante la Seconda per i bombardamenti e l'avanzata nel Sud, o cacciate dai campi e fuggiti nel Belgio o in Argentina, o cacciati dal loro Polesine dall'esondazione del Po... Sono ben pochi che hanno compreso come quella che viviamo sia l'esodo inarrestabile di un un'area che comprende più ancora che un intero continente, e che moltissime responsabilità delle catastrofi attuali hanno la loro origine (e la loro prosecuzione) nelle politiche di sfruttamento rapace delle risorse altrui compiuto dal Primo mondo. Quanto solitario, e quando alto, appare al confronto quel mite argentino che ammaestra il Vaticano.
 «In altre parole la politicizzazione del sociale è un processo necessario e inevitabile se si vuole contrapporre un nuovo potere costituente ad un potere costituito nelle attuali condizioni di degenerazione delle istituzioni e delle forme del potere politico».
«In altre parole la politicizzazione del sociale è un processo necessario e inevitabile se si vuole contrapporre un nuovo potere costituente ad un potere costituito nelle attuali condizioni di degenerazione delle istituzioni e delle forme del potere politico».
Il manifesto, 11 giugno 2015
Diciamo pure che era cominciata un po’ in sordina. Il documento preparatorio non era di quelli che hanno la forza di farti sobbalzare sulla sedia. Forse era un tattica di voluta prudenza. Poi, soprattutto nel passaggio tra la prima e la seconda giornata, l’ Assemblea ha preso quota e acquistato senso. Certamente ha influito la ricca discussione che si è tenuta nei vari gruppi tematici nel pomeriggio di sabato, ben sintetizzati dai report della mattina seguente. Alcuni dei quali possono essere considerati come un approfondimento specifico di una proposta di alternativa le cui fila si vanno tessendo in varie sedi e modalità.
Avendo partecipato come osservatore a uno di questi gruppi e sulla base dei report, balza agli occhi che le tematiche sono le stesse che vengono affrontate in altri incontri che si definiscono o vengono considerati direttamente politici. In altre parole quella distinzione fra il politico e il sociale, un po’ ingessata nelle prolusioni iniziali, si è molto assottigliata nel proseguo della discussione, mano a mano che si entrava nel merito di analisi e di proposte.
Non c’è da stupirsi. I temi per la costruzione di una opposizione e di una alternativa politica e sociale non possono in realtà che essere gli stessi, derivando entrambi dalle palesi contraddizioni del mondo contemporaneo. La distinzione – che non va risolta nell’autonomia del politico o per converso nell’assolutizzazione del primato del sociale – sta nella diversità dei piani con cui gli stessi temi e obiettivi vengono affrontati e portati avanti. La lotta al job act - per fare solo un esempio - va fatta, per essere efficace, sul terreno culturale, quanto su quello sociale; a partire dai luoghi di lavoro e dai territori; deve coinvolgere la dimensione sindacale e quella giudiziale; avrebbe dovuto – e qui il punto dolente - trovare più energica ed efficace opposizione a livello parlamentare; potrà raggiungere una piena dimensione di massa se si giungerà – come da più parti si sta riflettendo – ad un referendum abrogativo.
Non c’è solo bisogno di una ovvia moltiplicazione delle forze e dei punti di attacco utili per ottenere un risultato, ma soprattutto è in atto una ridefinizione del sistema di potere capitalistico nelle società mature che si è definitivamente separato dalla democrazia - pur nei limiti con cui l’abbiamo conosciuta e praticata -; che nega alla radice la dualità fra capitale e lavoro, quindi il conflitto; che vuole costruire un suo spazio , a-democratico ed extragiudiziale, oltre che no unions, per regolare, se possibile individualmente, il rapporto con il lavoratore. Il quale non è solo colui che lo è effettivamente, ma chi aspira ad esserlo, o lo è in modo intermittente o chi sta per perdere quella condizione.
In altre parole la politicizzazione del sociale è un processo necessario e inevitabile se si vuole contrapporre un nuovo potere costituente ad un potere costituito nelle attuali condizioni di degenerazione delle istituzioni e delle forme del potere politico, di cui ha anche parlato Stefano Rodotà nel suo intervento all’Assemblea andando ben al di là della tradizionale denuncia della corruzione e dell’italico stato duale.
Anche cambiando l’oggetto dell’intervento, che so io la “buona scuola”, l’Italicum oppure la privatizzazione dei beni comuni, il ragionamento di fondo non cambia, tanto per i soggetti sociali che per quelli politici.
Solo che se i primi non stanno benissimo – altrimenti non si parlerebbe di nuova coalizione sociale e perfino di rifondazione del sindacato – i secondi mancano del tutto. Per questo Renzi - pur avendo perso milioni di voti tra un’elezione e l’altra; pur affidandosi ad una maggioranza che si è fatta ancora più esile al Senato; pur apparendo meno “pigliatutto” (definizione che preferisco a quella di partito della nazione, visto che qui siamo di fronte ad una articolazione delle elites europee) di quanto lo era poche settimane fa - non ha per ora moltissimo da temere. Se non della propria arroganza.
Nei prossimi mesi può aprirsi una interessante e strategica campagna referendaria, dalla legge elettorale alle contro-riforme della Costituzione; dai decreti attuativi del job act allo scempio della legge sulla scuola. Dipenderà in primo luogo dai soggetti sociali promuovere concretamente questo percorso. Ma cosa succederà se non ci sarà in campo - quindi ben prima della tornata elettorale politica, al netto di elezioni anticipate - una forza politica dotata di credibilità e di una qualche consistenza che sappia a sinistra essere protagonista di queste battaglie? A parte il fatto che la legge elettorale chiama direttamente in causa la rappresentanza politica, anche nell’ipotesi di una vittoria ci potremmo trovare nella situazione nella quale già siamo, dove avendo pur vinto il referendum sull’acqua, non si riesce ad applicarne tutte le necessarie conseguenze sul piano operativo.
So bene che c’è bisogno di nuovi protagonisti e che dunque quelli che con luci e soprattutto ombre hanno popolato fin qui lo spazio enorme che si è aperto alla sinistra del Pd farebbero bene a scegliere per sé compiti da seconda e terza fila, peraltro non meno entusiasmanti. Ma potrebbero dare il là - e sarebbe un bel passaggio di testimone - all’avvio concreto di un processo di riunificazione delle disperse membra della sinistra d’alternativa, quale parte iniziale di un progetto ben più ambizioso di ricostruzione della sinistra in Italia. Farlo con una dichiarazione congiunta che contemporaneamente proponga una grande assemblea di tutte e di tutti entro l’estate, sarebbe la migliore risposta positiva, da parte di chi opera prevalentemente nel desertificato terreno politico, all’Assemblea della coalizione sociale.
 «Ha senso che un Paese dove la Costituzione garantisce ai cittadini l’uguaglianza di diritti abbia venti servizi sanitari diversi? Non è il momento di guardarsi allo specchio, e discuterne?».
«Ha senso che un Paese dove la Costituzione garantisce ai cittadini l’uguaglianza di diritti abbia venti servizi sanitari diversi? Non è il momento di guardarsi allo specchio, e discuterne?».
Corriere della sera, 8 Giugno, 2015 (m.p.r.)
L a crisi delle Regioni è profonda, e per certi versi irreversibile. A certificarlo è il verdetto consegnatoci dalle ultime elezioni: il vuoto assoluto di programmi, il degrado della classe politica, la percezione degli Enti regionali come di istituzioni ipertrofiche, fonti di sprechi e inefficienze, hanno spinto molti elettori a disertare l’appuntamento con le urne. Di fronte a questa situazione, il silenzio dei partiti è assordante. E la riforma del titolo V della Costituzione rischia di essere insufficiente. Serve ben altro, se vogliamo che le Regioni smettano di essere in larga misura centri di potere fini a se stessi e diventino strumenti al servizio dei cittadini. Occorre il coraggio di mettere in discussione i meccanismi elettorali, il ruolo e le competenze, le funzioni istituzionali, i poteri reali. E occorre porsi domande scomode: hanno senso 20 sistemi sanitari diversi, sedi faraoniche, una quantità enorme di dipendenti? Hanno senso gli statuti speciali? E hanno senso Regioni con un numero di abitanti paragonabili al quartiere di una grande città?
L a crisi delle Regioni è profonda e per certi versi irreversibile. Il verdetto che ci hanno consegnato le ultime elezioni regionali, con il loro strascico di polemiche, veleni e sospetti, è senza appello. La campagna elettorale ha offerto spettacoli indecenti: e non parliamo soltanto della vicenda dei cosiddetti «impresentabili», ma anche di certi spregiudicati traslochi da uno schieramento politico all’altro. Abbiamo assistito a fatti come quelli di un governatore di sinistra che si è candidato con la destra pur di rimanere in partita, o di ex neofascisti accolti a braccia aperte dalla sinistra. Di tutto si è parlato tranne che di contenuti e programmi. Per un semplice motivo: non c’erano.
«Il reddito di cittadinanza? È la cosa meno di sinistra che esista», «significa negare il principio che l’Italia non è paese dei furbi ma chi lavora duro ce la può fare». Addirittura: «È incostituzionale». Renzi boccia il sostegno al reddito, nonostante qualcosa del genere esista in 24 paesi europei e anzi l’europarlamento da anni inviti i paesi a trovare forme di reddito «in grado di sottrarre ogni bambino, adulto e anziano alla povertà e garantire loro il diritto a una vita dignitosa» (risoluzione del 20 ottobre 2010). Renzi, che parla da Genova dov’è ospite del palco della festa di Repubblica intervistato dal direttore Ezio Mauro, forse ce l’ha con il Movimento 5 stelle, fan della proposta. Ma con tiro fa strike: proprio ieri in 200 città — Genova compresa — l’associazione Libera di don Luigi Ciotti raccoglieva le firme per l’istituzione di «un reddito minimo o di cittadinanza» nell’ambito della (fortunata) campagna «Miseria Ladra». Cui ha aderito, oltre a tutti i parlamentari del M5S e di Sel, anche la sinistra del suo partito, almeno quella parte di Area Riformista rappresentata da Roberto Speranza che il 22 maggio ha firmato la petizione di Libera e auspicato «un progetto di legge condiviso da tutti». In parlamento una maggioranza ci sarebbe. Ma da ieri sappiamo che il parere del governo, fin qui sfumato e possibilista, è contrario. E per questioni alla sua maniera ideologiche («non è di sinistra»), neanche per più digeribili obiezioni di cassa.
Messo a posto il Movimento 5 stelle, con il quale in questi giorni il Pd incrocia i ferri (sulle liste degli «impresentabili» e sul caso Bindi, sulla giunta Marino e sull’inchiesta Mafia Capitale e infine sul ’caso Orfini’, attaccato a testa bassa dallo stesso Grillo), Renzi si applica alla sua minoranza interna. Anche qui con parole ruvide. Siamo nel capoluogo della regione che il Pd ha perso rovinosamente. Settantatremila voti in meno rispetto alle regionali del 2010, 140mila in meno rispetto alle europee dell’anno scorso e del 41,7 per cento (ora crollato al 27,8). Renzi ammette che si tratta di «un campanello d’allarme», poi recita la consumata storia di quelli che se perdono non hanno «diritto di spaccare tutto». Ma archiviata la polemica con Pastorino&Cofferati è alla minoranza ancora nel Pd che invia un avviso di garanzia: «Basta spaccature tutto. Se fai così, è finita la storia del Pd». Domani sera alla direzione del partito ci sarà la resa dei conti: «Le molte mail che ricevo dicono ’vai alla direzione non solo con la mimetica ma con i reparti speciali’», assicura. Lui promette «un dibattito vero» ma chiederà «lealtà nei comportamenti perché servono delle regole di condotta», «altrimenti stai in un partito anarchico» (copyright Matteo Orfini).
Dal Pd renziano da giorni si moltiplicano i boatos di «nuove regole». Ma è difficile che la discussione interna prenda la curva disciplinare, quella imboccata senza complessi dai 5 stelle. Non ora che al senato i numeri della maggioranza sono incerti e che una ventina di democratici sono pronti a dare battaglia sul ddl scuola. Al loro indirizzo infatti Renzi saggiamente invia un messaggio di pace: «Siamo pronti a ragionare e cercheremo di coinvolgere più persone».
Il fronte sinistro del Pd si prepara al confronto in ordine rigorosamente sparso. Un presepe di posizioni diverse, da quelle in uscita dal Pd a quelle in entrata nella maggioranza renziana. Dall’account ufficiale di Area riformista su twitter parte un «#Scuola #Senato #Partito facciamo fatica ad andare avanti così. Ci stiamo preparando alla sfida congressuale». Replica Matteo Mauri, area ’dialogante’: «Chi continua a concentrarsi su una battaglia tutta interna al Pd, pensando ora al congresso del 2017 fa un danno al Pd, al paese e anche alla sinistra del Pd». E Davide Zoggia, altro bersaniano: «Proporremo un patto sul merito dei provvedimenti, così da arrivare al 2018, dando all’Italia le risposte di cui ha bisogno». Per Gianni Cuperlo le minoranze non vogliono «una resa dei conti», ma «è bene discutere di cosa intendiamo per partito della nazione», visto che le urne non hanno premiato il partito che si allontana dalla sinistra «per sfondare nell’altro campo».
E qui il discorso di fa interessante perché si tratta della stessa argomentazione svolta, all’indomani del voto, dal ministro della giustizia Andrea Orlando. Che è nella maggioranza renziana, ma su posizioni ’turche’. E che ha dichiarato «il partito della nazione» un’idea superata, anzi «ambigua, a pericolosa». E che sulla sconfitta ligure si è cavato un sasso dalla scarpa rivelando di aver cercato «di dare qualche indicazione, molto felpata», ma di essersi sentito rispondere «fatti i fatti tuoi».

Da anni ormai conviviamo con una crisi difficile da afferrare, che nel suo svolgimento ha assunto in continuazione forme nuove. Emersa negli Usa sul finire del 2007 con i mutuisubprime, esplosa successivamente come crisi bancaria e finanziaria, è venuto poi il turno degli Stati nazionali e dell’intera Europa. In un contesto dominato dalla recessione e dalla stagnazione, che alimentano disoccupazione, lavori sottopagati e precarietà, e dunque una condizione di malessere umano e di rischio ambientale crescenti.
Nonostante gli sforzi per occultarne e mistificarne la natura più profonda, se andiamo alla sostanza dobbiamo oggettivamente prendere atto che siamo in presenza di una crisi strutturale del modo di produzione capitalistico, le cui espressioni si manifestano in varia forma. Ormai, sebbene anche le interpretazioni della crisi siano le più diverse, è sempre più difficile negare che viviamo in una società spaccata in due, non solo in Italia e in Europa. Nella quale la stragrande maggioranza delle donne e degli uomini è costretta a vendere in condizioni di subalternità e di permanente incertezza le proprie abilità fisiche e intellettuali in cambio dei mezzi per vivere a una classe dominante di proprietari universali, peraltro sempre più ristretta e parassitaria, che le usa allo scopo di ricavarne il massimo profitto.
Se non si prende atto di questo elementare dato di realtà, non per caso ideologicamente mascherato con destrezza, è difficile compiere qualche significativo passo avanti sul terreno politico. Come insegnava quel tale di Treviri, la lotta di classe è sempre lotta politica. Soprattutto in questa fase storica, giacché il capitale, prima ancora di una cosa o di un semplice algoritmo, di un accumulo di merci e di mezzi finanziari, è una relazione tra esseri umani, un rapporto sociale storicamente determinato. Non statico e sempre uguale a se stesso, bensì in incessante movimento per effetto del rivoluzionamento continuo degli strumenti della produzione e delle conquiste delle scienza e della tecnica, ma segnato da una contraddizione insuperabile, oggi diventata dirompente.
Aldo Tortorella direbbe che il capitale è vittima delle sue stesse macchinazioni. Per accrescere i profitti deve contenere i salari. Ma i bassi salari comprimono il potere d’acquisto impedendo la realizzazione dei profitti. E poiché la capacità di consumo dei produttori diretti è strutturalmente legata alla capacità di generare un plusvalore che è alla base del profitto, se questo plusvalore non viene generato, o non si realizza perché le merci restano invendute, la produzione si ferma e il lavoratore viene licenziato. Cioè, cancellato come produttore e come consumatore. Il suo destino è quello di andare ad accrescere l’esercito dei disoccupati e degli esclusi, con la conseguenza di rendere ancora più acuta la contraddizione tra capitale e lavoro.
Le crisi ricorrenti, come ben sappiamo, sono state finora il mezzo che ha consentito di riportare in temporaneo equilibrio il sistema attraverso la massiccia distruzione di capitali e di forze produttive umane e naturali, fino all’esplosione di guerre catastrofiche per l’accaparramento delle risorse del pianeta. In teoria, dalla crisi di un sistema il cui fine è l’estrazione del massimo profitto privato dagli esseri umani e dalla natura, su cui si conforma l’intero assetto della società e delle istituzioni, e quindi della politica, si esce in due modi. O attraverso un’ulteriore stretta del dominio del capitale sul lavoro e sull’intera comunità, con la conseguenza di acutizzare tutte le contraddizioni e con esiti imprevedibili. O attraverso l’avvio di un processo di superamento del sistema diventato insostenibile, ponendo dei limiti al dominio del capitale e aprendo la strada a una gestione comunitaria della produzione di ricchezza.
Un’altra soluzione non è data. Non dimentichiamo che dalla Grande Depressione del 1929-33, si è usciti temporaneamente in Europa con il nazismo e la seconda guerra mondiale. Oggi, mentre alle porte dell’Europa premono masse di diseredati e si moltiplicano le guerre guerreggiate, il ricatto cui viene sottoposta la Grecia è il paradigma di una regressione senza precedenti imposta dai poteri capitalistici dominanti: prima la remunerazione del capitale finanziario, poi la vita delle persone. La finanziarizzazione universale, tipica di questa fase di globalizzazione, non ha attenuato il processo di subordinazione del lavoro. Al contrario, lo ha generalizzato e modernizzato nelle modalità di sfruttamento, con l’intento di contrastare la tendenza alla caduta del saggio di profitto e alla perdita di efficienza del sistema.
La spinta a fare denaro con il denaro bypassando la produzione ha generato, come osservava Hilferding, uno «schema mistico» del capitale, rivestendolo di sacralità e impenetrabilità. Nei fatti, garantendo alti rendimenti, ha moltiplicato i valori finanziari rispetto all’economia reale, diffuso la speculazione e la corruzione, accresciuto a dismisura le disuguaglianze. Grazie all’indebitamento di massa inventato dalle economie anglosassoni, si è ottenuto per un certo tempo il miracolo di tenere alti i consumi in regime di bassi salari. Ma il debito come fattore propulsivo dell’economia, in sostituzione della valorizzazione del lavoro, è il segnale vistoso del decadimento di un sistema.
D’altra parte, la rivoluzione scientifica e tecnologica, con l’uso dell’informatica e della microelettronica, non ha posto fine al lavoro, ma rivoluzionando il modo di lavorare e di vivere richiederebbe la formazione di una classe lavoratrice di livello superiore per cultura generale e conoscenze specifiche, e quindi un’attenzione particolare all’istruzione e alla ricerca. Mentre il superamento della tradizionale nozione del tempo e dello spazio consentirebbe di accorciare globalmente i tempi di lavoro allungando i tempi di vita, e di pianificare un’occupazione dignitosa per tutte e per tutti.
Ma alla socializzazione crescente dei processi produttivi, di comunicazione e di ricerca, cui concorre una molteplicità di soggetti diversi, non corrisponde la socializzazione della proprietà e la comune gestione degli strumenti indispensabili per il governo di tali processi. Il risultato è la formazione di un enorme esercito di manodopera di riserva nel mondo, disponibile per qualsiasi tipo di lavoro precario. Di qui la concorrenza e la guerra tra poveri. Il rapporto di proprietà capitalistico è diventato una gabbia che imprigiona il libero sviluppo di tutti e di ciascuno. La contraddizione tra sviluppo delle forze produttive e rapporti di proprietà, tra il lavoro e il capitale, è arrivata a un punto limite che è necessario riconoscere e mettere a nudo. Se non si vuole che al conflitto di classe si sostituisca una guerriglia permanente e senza sbocchi tra i subalterni.
Nella controrivoluzione liberista di Ronald Reagan e di Margaret Thatcher si si è incarnato al massimo livello il dominio totalitario del capitale sul lavoro. Una vera e propria dittatura, non solo in ambito economico-sociale, ma anche nel linguaggio e nella comunicazione, fino al formarsi di un diffuso senso comune. In una fase di massima espansione della lotta di classe del capitale contro il lavoro è stata teorizzata la fine della lotta di classe, addirittura la fine delle classi. Lo slogan di lady Thatcher detta TINA (There Is No Alternative), secondo cui la società non esiste, esistono solo individui, ha fatto molta strada ed è assurto al rango di principio universalmente riconosciuto anche a sinistra con conseguenze politiche devastanti.
E’ evidente infatti che se si sostiene, come sostenne a suo tempo Giorgio Ruffolo scambiando lucciole per lanterne, che ormai «abbiamo una società di individui» e con ciò la sinistra ha raggiunto il suo scopo, vale a dire «la società senza classi», non ha alcun senso la presenza di una forza politica delle classi subalterne, essendo state le classi sociali cancellate. Peraltro, non da una rivoluzione socialista ma dalla forza egemonica del pensiero unico liberista. Nel deserto popolato da individui egoisti privi di legami sociali anche la visione del capitale come rapporto sociale viene azzerata, e si erge dominante l’homo oeconomicus, l’individuo che dispone dei mezzi necessari per mettere al lavoro a suo piacimento altri individui, ridotti al rango di capitale umano, spossessati anche della loro storia, oltre che della loro comunità sindacale e politica.
L’impianto egemonico neoliberista, nella sostanza acquisito e perfezionato dalla socialdemocrazia di Blair e di Schröder, ha espulso dall’agenda e dalla pratica politica europea e italiana un clamoroso dato di realtà: il conflitto capitale-lavoro, che pure segna il destino di milioni di donne e di uomini. Da una parte, i sindacati sono additati come un ostacolo da abbattere sulla via della piena libertà del capitale. Dall’altra, è stata semplicemente cancellata l’autonoma e libera presenza politica delle lavoratrici e dei lavoratori del XXI secolo. La politica come protesi dell’economia, cioè del capitale, è stato il punto di approdo. E con ciò è stato definitivamente archiviato il vecchio compromesso socialdemocratico tra capitale e lavoro. In un sistema politico-rappresentativo monoclasse, in cui i diritti diventano una variabile dipendente dal rendimento dei capitali, la democrazia traligna inevitabilmente in autoritarismo e oligarchia.
Su questa linea, corresponsabile dell’innesco e del dilagare della crisi ma presentata come una novità strabiliante, si è attestato Matteo Renzi. Ormai, dopo le più recenti vicende, il suo obiettivo dovrebbe risultare chiaro anche ai ciechi. Né più né meno, è la definitiva soppressione del fondamento politico della Repubblica democratica. Ma il corrispettivo potenziamento del capitalismo italiano cui mira Renzi attraverso radicali misure di internazionalizzazione e di privatizzazione che lo liberino da storiche inefficienze e incrostazioni, e insieme da ogni residua responsabilità sociale secondo il modello anglosassone, non ci farà uscire stabilmente dalla crisi perché non ne mette in discussione i fattori strutturali.
Un conto è il miglioramento dei parametri europei, definiti stupidi da Romano Prodi, o di quelli imposti dai colossi multinazionali del rating, che li fissano per assicurarsi laute rendite di posizione. Altro conto è affrontare i nodi della piena occupazione; di una remunerazione del lavoro che garantisca a tutte e tutti una vita dignitosa e degna di essere vissuta; di un nuovo welfare universale; della salvaguardia dell’ambiente e della pace; del trasferimento all’intera comunità dei benefici che la rivoluzione scientifica e tecnologica mette a disposizione. Di che parliamo, se non di un altro modello di società? Di un avanzamento di civiltà oltre i limiti imposti dal dominio del capitale? Un nuovo socialismo? Sì, se la parola non fosse stata deturpata e stravolta dai molti che se ne sono abusivamente appropriati.
Muovere nella direzione opposta a quella indicata da Renzi e dai governanti europei vuol dire costruire un’alternativa politica al dominio del capitale. È questa la questione di fondo che non si può eludere. E che innanzitutto richiede, per essere affrontata con qualche probabilità di successo, una visione del lavoro che abbandoni senza rimpianti lo schema novecentesco. In altre parole, c’è bisogno di una visione non limitata alla classe operaia tradizionalmente intesa come unico soggetto trainante dell’antagonismo al capitale, bensì allargata ai nuovi soggetti indotti dalla rivoluzione elettronica e digitale in tutti i campi delle attività lavorative. Perciò aperta al lavoro cognitivo e creativo, seppure erogato in forma individuale e a distanza. E nel contempo in grado di coinvolgere tutti coloro, giovani e donne innanzitutto, ma anche le teste grigie, che da qualunque forma di lavoro vengono esclusi.
In secondo luogo, occorre prendere atto una volta per sempre che l’esperienza del movimento operaio novecentesco, in tutte le sue forme, è davvero definitivamente conclusa. E non è ripetibile. Sia nella forma del cosiddetto socialismo realizzato nella Russia sovietica, sia nella forma socialdemocratica nell’Occidente europeo, che ha sposato i dogmi della controrivoluzione liberista. Come aveva intuito Enrico Berlinguer, esaurite le due fasi novecentesche del movimento operaio, adesso «si tratta di aprirne un’altra e di aprirla, prima di tutto, nell’Occidente capitalistico», e dunque di «porre le basi del superamento di un sistema che è entrato in una crisi strutturale e di fondo».
Una sinistra nuova ha senso, e avrà un avvenire, se assume questa prospettiva, peraltro delineata con sufficiente chiarezza dalla Costituzione della Repubblica democratica fondata sul lavoro. Un progetto di portata europea per il quale vale la pena di impegnarsi e di lottare, attraverso l’espansione massima di una democrazia progressiva e partecipata. Uscire da questo capitalismo non è una «bubbola», come pensa Scalfari. E neanche un insostenibile fardello da mettere sulle spalle dei nipoti. È invece un problema drammaticamente aperto, riproposto dagli effetti devastanti della crisi.
 Dopodomani non è la festa della nazione, ma quella della Repubblica. Oggi, nei tempi bui nei quali gli egoismi nazionalistici, il degrado della democrazia e il tradimento dei principi della Costituzione sembrano prevalere, non dimentichiamo il significato delle elezioni che condussero a quel risultato. E torniamo a votare.
Dopodomani non è la festa della nazione, ma quella della Repubblica. Oggi, nei tempi bui nei quali gli egoismi nazionalistici, il degrado della democrazia e il tradimento dei principi della Costituzione sembrano prevalere, non dimentichiamo il significato delle elezioni che condussero a quel risultato. E torniamo a votare.
La Repubblica, 31 maggio 2015
In quella prima domenica di giugno del 1946, gli italiani e le italiane decisero con un solenne plebiscito di voler essere una Repubblica democratica. Il loro fu un atto di fondazione che diede vita a un nuovo ordine politico. I cittadini e le cittadine furono per la prima volta nella storia della nazione italiana chiamati a decidere sull’ordinamento politico e la loro identità pubblica, a farsi volontà sovrana. La nazione italiana ha avuto tre ordinamenti dal tempo della sua unificazione nel 1861: quello monarchico costituzionale, quello fascista, e quello repubblicano. Il 2 giugno non si festeggiano tutti e tre questi ordinamenti, e in questo senso non è il giorno della nazione; se ne festeggia uno solo, l’ultimo. Se si fa perno sull’aggettivo “nazionale” si rischia di perdere il senso storico e politico di ciò che si festeggia: la nazione repubblicana e solo quella.
Soprattutto, si mette in secondo piano il significato politico del plebiscito del 2 giugno 1946 e si normalizza quell’evento eccezionale traducendolo con un termine onnicomprensivo e diversamente interpretabile. La nazione comprende infatti tutta la storia politica, sociale, culturale e civile del Paese, non soltanto quella parte che ha preso avvio nel 1946. Certo, come ci insegnano gli storici, lo Stato italiano nelle sue strutture burocratiche e anche nel suo personale amministrativo ha registrato una sostanziale continuità dal fascismo alla Repubblica. Non così la sovranità politica, che con quel plebiscito cambiò radicalmente, passando da una casa monarchica a milioni di cittadini che compongono il popolo, come recita la nostra Costituzione, esito diretto di quel plebiscito.
Un esempio può aiutare a comprendere meglio perché la Festa della Repubblica non é semplicemente una festa della Nazione: prima del 1946, le italiane erano sia parte della nazione che suddite dello Stato italiano, ma non erano soggetti politici liberi. Come loro anche molti uomini; ma nel caso delle donne l’esclusione politica era totale, e l’appartenenza alla stessa nazione non valse a correggerla.
 «Libia, le rivelazioni di Wikileaks sui piani di attacco dell'Europa. Una missione militare a tutti gli effetti e non un'operazione di polizia per salvare migranti, come invece raccontano i ministri Alfano e Gentiloni».
«Libia, le rivelazioni di Wikileaks sui piani di attacco dell'Europa. Una missione militare a tutti gli effetti e non un'operazione di polizia per salvare migranti, come invece raccontano i ministri Alfano e Gentiloni».
Il manifesto, 27 maggio 2015
Se ci fosse stato bisogno di una conferma che di guerra si tratta per il documento strategico di 19 pagine presentato da Mogherini all’Onu nemmeno due settimane fa su «Libia, migranti e scafisti», ecco la rivelazione di Wikileaks — anticipata dall’Espresso — che rende noti due protocolli riservati della Ue sull’operazione. È una missione militare in Libia a tutti gli effetti e non un’operazione di polizia per salvare migranti, come invece raccontano i ministri Alfano e Gentiloni. La Ue con la sua flotta navale unita — finalmente l’Unione — commenta Wikileaks «schiererà la forza militare contro infrastrutture civili in Libia per fermare il flusso di migranti. Dati i passati attacchi in Libia da parte di varie paesi europei della Nato e date le provate riserve di petrolio della Libia, il piano può portare ad altro impegno militare in Libia».
Proprio mentre la Commissione Ue rivede al ribasso il «piano Juncker» per le quote dei migranti che quasi tutti i paesi europei rifiutano; e mentre al Cairo falliscono gli ennesimi incontri tribali per avere in Libia un accordo di governo — utile solo ad approvare la nostra impresa bellica. La nuova guerra durerà un anno e comunque tutto il tempo necessario a «fermare il flusso migratorio». All’infinito dunque, visto che la disperazione di chi fugge da guerre (spesso nostre) e miseria (spesso provocata da noi) è inarrestabile.
Per questo «l’uso della forza deve essere ammesso, specialmente durante le attività come l’imbarco, e quando si opera sulla terra o in prossimità di coste non sicure o nell’interazione con imbarcazioni non adatte alla navigazione». Quindi ci sono le operazioni a terra, come scriveva The Guardian. E per «la presenza di forze ostili, come estremisti o terroristi come lo Stato Islamico», la missione «richiederà regole di ingaggio robuste e riconosciute per l’uso della forza».
Ma la vera novità è l’invito esplicito dei ministri della difesa Ue: «Per l’operazione militare sarà fondamentale il controllo delle informazioni che circolano sui media». Perché il Comitato Militare dell’Ue «conosce il rischio che ne può derivare alla reputazione dell’Unione Europea… qualsiasi trasgressione percepita dall’opinione pubblica in seguito alla cattiva comprensione dei compiti e degli obiettivi, o il potenziale impatto negativo nel caso in cui la perdita di vite umane fosse attribuita, correttamente o scorrettamente, all’azione o all’inazione della missione europea. Quindi il Consiglio Militare dell’Unione Europea considera essenziale fin dall’inizio una strategia mediatica per enfatizzare gli scopi dell’operazione e per facilitare la gestione delle aspettative. Operazioni di informazione militare dovrebbero essere parte integrante di questa missione europea».
Avete capito bene: ci saranno tante vittime innocenti, vale a dire i migranti, destinati alle fosse del Mediterraneo e sottoposti sempre più ad arresti e violenze in Libia. E serviranno informazioni «mirate» dai vertici militari e un giornalismo velinaro e/o embedded con «robuste regole d’ingaggio».
 , nell'ultimo mezzo secolo, hanno condotto alla frantumazione della sinistra e al trionfo del renzismo. Una novità nelle posizioni dell'autrice: il riconoscimento delle ragioni dell'ambientalismo. S
, nell'ultimo mezzo secolo, hanno condotto alla frantumazione della sinistra e al trionfo del renzismo. Una novità nelle posizioni dell'autrice: il riconoscimento delle ragioni dell'ambientalismo. S
bilanciamoci.info, newsletter n. 420, 26 maggio 2015
Le pagine che seguono spiegano, nella prima parte, il Jobs act del governo di Matteo Renzi e nella seconda presentano un’alternativa a esso: non per caso si chiamano “Workers act” perché esprimono il punto di vista dei lavoratori. È necessario spiegarlo perche l’insieme di testi presentato dal governo, non per essere discusso ma affidato con una serie di deleghe all’esecutivo, va chiarito a coloro che vi saranno obbligati senza aver potuto contribuire alla sua elaborazione. Dietro le formule nebulose si rivela, non detta, la volontà di rendere la prestazione della manodopera più flessibile in entrata e in uscita, cioè meno garantita per i dipendenti sia nell’assunzione, sia nel licenziamento, che torna a essere possibile a piacimento del padronato con un semplice rimborso, abolendo sia nel licenziamento, che torna a essere possibile a piacimento del padronato con un semplice rimborso, abolendo quel che restava dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970, dopo il già grave ridimensionamento operato dalla riforma Fornero del 2012.
Contro questa pessima riforma della "buona scuola", perché è nella «struttura pubblica del sistema scolastico a tutti i livelli che risiede la difesa della democrazia italiana dai pericoli che la assediano». La Repubblica, 19 maggio 2015 (m.p.g.)
La scuola è una grande questione nazionale. La più grande. Qui si intrecciano e qui si incontrano i drammi della disoccupazione giovanile e dell’integrazione di milioni di immigrati, qui si giocano le sorti presenti e future della cultura italiana come sapere e coscienza diffusa di cittadinanza. Che la questione della riforma della scuola venga vissuta come un conflitto tra governo e sindacati o tra governo e una specie di Fort Alamo della sinistra irriducibile, cioè come uno dei tanti conflitti sociali di un paese smarrito e impoverito, è qualcosa di intollerabile; è anche il segno della sconfitta che ci aspetta tutti alla prova di un passaggio decisivo.
La domanda che bisogna farci è: come siamo arrivati a questo punto? Per rispondere bisogna partire da lontano. L’on. Alfredo D’Attore in un’intervista al manifesto di sabato 16 maggio, ha accusato Renzi di avere imbroccato una strada che «amplifica le disuguaglianze e scardina un sistema nazionale di formazione su base universalistica». In realtà la cosa è più antica. Si aprì all’epoca lontana in cui il partito progenitore di quello di D’Attorre approvò la riforma dell’Università del suo ministro Berlinguer.
Fu allora che passò il paradigma economicista e classista della divisione tra serie A e serie B a tutti i livelli: tra le università condannate a un’autonomia che deresponsabilizzava lo Stato e cancellava la distinzione tra pubbliche e private, tra le lauree, divise fra triennali e quinquennali ma soprattutto tra quelle del sud e quelle del nord, tra insegnamento e ricerca — privata quest’ultima di investimenti necessari, declassata quella ad affabulazione oratoria da scuola media mentre passava in uso il linguaggio dei «crediti », grottesco scimmiottamento del valore supremo, il danaro, la banca. Intanto saliva il danaro richiesto per le tasse mentre si impoverivano biblioteche e laboratori. Intanto il mondo della docenza accademica si incanagliva nei suoi antichi difetti e il rapporto tra insegnamento e ricerca veniva sottomesso al potere dei rettori e a quello di consigli di amministrazione aperti al mondo della finanza e dell’impresa. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, anche se non lo si vuole vedere. Somme immense sono state investite nel funzionamento di una agenzia di valutazione scelta dall’arbitrio politico che ha inventato sistemi spesso grotteschi e sempre costosi di “valutazione”.
Di fatto nelle università come nelle scuole tutte si è bloccato il ricambio con danni immensi per il paese. E si è perduta l’idea della funzione comune di tutto l’insieme della scuola pubblica. Si capisce così perché dall’università non si levi oggi quel coro di voci in difesa della scuola che sarebbe giusto e necessario. Eppure è nella struttura pubblica del sistema scolastico a tutti i livelli che risiede la difesa della democrazia italiana dai pericoli che la assediano.
Chi si straccia le vesti davanti alla fine del bicameralismo dovrebbe farlo assai più davanti al percorso liquidatorio della scuola pubblica: un percorso da tempo avviato da una classe politica spesso penosamente incolta, selezionata con le liste bloccate, incapace di rispettare l’unica categoria insieme alla magistratura che eserciti la sua professione dopo avere studiato a lungo e dopo essersi sottoposta a pubblici concorsi. Senza una scuola dello Stato italiano che garantisca a tutti i cittadini la stessa qualità di offerta educativa, senza docenti selezionati in università statali di pari dignità e livello, senza concorsi pubblici, è difficile sperare che rinasca quell’unica condizione fondamentale perché l’incontro tra professore e allievo torni a essere quello giusto: la passione del docente per quello che fa. È solo lei che potrà lasciare una traccia positiva nella vita del giovane. Lo attesta il dialogo tra il maestro Fiorenzo Alfieri e suo nipote Leonardo nel libro Strade parallele. Ma per questo occorre che il docente sia ben preparato e abbia tutto il riconoscimento sociale cui ha diritto. E che raggiunga il suo luogo di lavoro senza dipendere dalla chiamata di un preside.
Non si dimentichi che la scuola ha creato la lingua degli italiani e con la lingua la letteratura ben prima che se ne occupassero il cinema e la televisione. È nella scuola che i diritti astrattamente descritti nella Costituzione diventano esercizio quotidiano, materia primaria di confronto e di palestra civile nel rapporto tra culture, religioni, questioni di colore e di sesso. Così è sempre stato. Si pensi alla figura della maestra suicida di Porciano, ai tempi della legge Coppino, quell’Italia Donati che portava nel nome le speranze del paese appena unificato. Alla creazione di questa scuola si sono dedicati i maggiori ingegni dell’Italia risorgimentale.
Se gli italiani non sono più il “volgo disperso” descritto da Manzoni, se la Recanati di Leopardi non è più un “borgo selvaggio” ma ha uno splendido Liceo dove anche gli ultimi nipoti dello zappatore e della “donzelletta” possono studiare, è per merito di un percorso faticoso ma fondamentale di costruzione di una buona scuola. O vogliamo tornare alle biblioteche e ai soldi di famiglia, ai precettori privati e ai colleges per i più fortunati lasciando gli altri a incanaglirsi nelle scuole e nelle università di serie B?
Gli intellettuali ne dovrebbero sapere qualcosa... Si sono chiesti se la Buona Scuola lo ha a cuore? Hanno speso qualche ora del loro tempo per capire quali sono le vere priorità di questa riforma e quale lo scopo di quel linguaggio da marketing così caro al premier? Si sono chiesti quale posto occupi nel DdL l’alfabetizzazione di base degli studenti? Quale spazio ci sarà nella nuova scuola disegnata dal trio Renzi-Farone-Giannini per costruire alfabeti forti: linguistico-matematico innanzitutto, proprio gli alfabeti dove i nostri ragazzi sono quasi sempre messi malissimo? Mi chiedo davvero come mai siano così mancate le analisi serie di questo testo renziano, come mai nessuno abbia tentato un confronto tematico e di stile fra la Buona Scuola del trio di governo e la LIP (Legge di iniziativa popolare) promossa dall’interno del mondo della scuola e caduta nel più totale oblio. Ma dove è finita la semiotica in questo paese?
I conti delle riforme della scuola arrivano dopo decenni, quando maturano le generazioni. Molti di noi non ci saranno più, ma porteremo tuttavia la responsabilità di questa devastazione ignorante.
< i>L'autrice è insegnante di scuola secondaria< /i>
 Gli italiani che credono davvero nella democrazia, e che al tempo stesso riescono a informarsi di ciò che il Palazzo Renzi gli sta preparando devono essere davvero pochi, se così pochi ne scendono in piazza .
Gli italiani che credono davvero nella democrazia, e che al tempo stesso riescono a informarsi di ciò che il Palazzo Renzi gli sta preparando devono essere davvero pochi, se così pochi ne scendono in piazza .
Il manifesto, 17 maggio 2015
Tra poco — probabilmente tra un annetto — questo programma comincerà a realizzarsi organicamente. Ma non dobbiamo aspettare nemmeno pochi mesi per assaporarne i primi frutti avvelenati. Quanto sta accadendo con la «riforma» della scuola è un’anticipazione molto istruttiva di ciò che ci attende. Un indizio e una prova tecnica, somministrata per testare il paese e per assuefarlo al nuovo che avanza.
Raramente, forse mai prima d’ora, si era assistito alla scena di un ramo del parlamento italiano che vota in tranquillità a favore di un provvedimento di indiscutibile rilevanza (che modifica in profondità strutture e modo di operare di un settore vitale della società, e le condizioni materiali di lavoro e di vita di milioni di cittadini) mentre l’intero comparto investito da quel provvedimento esprime la propria assoluta contrarietà. Lo sciopero del 5 maggio e la manifestazione contro le prove Invalsi possono essere giudicati come si vuole, ma su una cosa non sarebbe serio eccepire. Entrambi attestano l’unanime avversione del complesso mondo della scuola — insegnanti, studenti, personale tecnico e amministrativo — a un modello che non per caso ruota intorno a due cardini della costituzione neoliberale: la sedicente meritocrazia (foglia di fico propagandistica a copertura del ritorno a logiche censitarie, autoritarie e oligarchiche) e la privatizzazione della sfera pubblica.
C’è tutto sommato di che stupirsi per la prontezza e precisione della diagnosi che insegnanti e studenti hanno fatto della «buona scuola» renziana. Evidentemente l’ideologia mercatista non ha ancora totalmente invaso l’anima del paese. O forse la realtà della scuola italiana è talmente evidente nelle sue contraddizioni e miserie da non permettere quelle operazioni di cosmesi — di camouflage, direbbe qualcuno — che funzionano altrove. Studenti, operatori della scuola e tanti genitori sanno troppo bene che cosa in realtà si nasconde dietro la vergognosa retorica dell’«eccellenza» e dell’«autonomia», della «selezione» e della logica premiale del «merito». E dietro il ricatto della stabilizzazione della metà dei precari in cambio dell’accettazione dell’intera «riforma».
In un paese che figura stabilmente all’ultimo posto della classifica Ocse per la percentuale di Pil investita nella formazione dei giovani le chiacchiere restano a zero. A chiarire come stanno le cose provvedono gli edifici fatiscenti e i tanti soldi come sempre regalati alle private. Le collette per comprare la carta igienica e il toner delle stampanti. E i bassi salari degli insegnanti di ogni ordine e grado, responsabili anche del poco rispetto che taluni genitori mostrano nei riguardi di chi si impegna per istruire i loro venerati rampolli.
Sta di fatto che contro la «riforma» renziana la scuola ha messo in campo una protesta pressoché universale, benché anni di divisioni tra le organizzazioni sindacali e un’eccessiva timidezza nelle iniziative di lotta rischino di vanificare le mobilitazioni. Non solo la scuola si è fermata in occasione delle agitazioni, ma è in fermento da settimane e manifesta senza reticenze un consapevole e argomentato dissenso. Peccato che tutto questo al parlamento non interessi né poco né punto. Quel che si mostra allo sguardo degli osservatori è uno sconcertante parallelismo, quasi che «paese legale» e «paese reale» non fossero distinti ma dialetticamente connessi, bensì proprio dislocati su pianeti diversi. Per cui quanto accade nell’uno - le agitazioni, le preoccupazioni, il disagio, la protesta - non turba l’impermeabile autoreferenzialità dell’altro, ormai (di già) assorbito nella recezione e promozione della volontà del reuccio che si balocca alla lavagna col suo approssimativo idioma burocratico.
Certo, non è la prima volta che si assiste a un fenomeno del genere. Qualcosa di simile è già accaduto col Jobs act, varato mentre le fabbriche erano in subbuglio per la cancellazione dell’articolo 18. Ma si sa che le questioni di lavoro e in particolare di lavoro operaio dividono il paese (e gli stessi sindacati) e offrono ai governi ampi varchi per operare forzature. Il caso della scuola è diverso per la sua connotazione essenzialmente interclassista e per questa ragione prefigura plasticamente il quadro al quale dovremo abituarci nel prossimo futuro. Protesti pure il paese, scendano pure in piazza i cittadini, si mobiliti quel che resta dell’opinione pubblica. La cittadella della politica non si degna nemmeno di verificare la pertinenza delle doglianze, tanto basta a se stessa e può fare da sé, in una miserabile riedizione dell’autocrazia di antico regime. Può darsi che questa non sia che un’illusione e che un programma incentrato sull’autonomia del politico si riveli, oltre che indecente, impraticabile in virtù della reattività del corpo sociale. Ma di certo risulta evidente a quale poverissima cosa si saranno ridotti, in tale scenario, parlamentari e partiti. Mentre la politica avrà negato se stessa con l’essersi anche formalmente ridotta a mera funzione di dominio di una casta sulla cittadinanza costretta a obbedire.

C’è però da chiedersi se è Barbara Spinelli a non volersi più considerare parte de L’Altra Europa o è L’Altra Europa – o i suoi “organi centrali” – a non considerarla più, e da tempo, parte del proprio “progetto”. Vi sembra un modo normale di tenere i rapporti tra colleghi di uno stesso gruppo parlamentare definire in una riunione pubblica “un carnevale” le scelte di Barbara Spinelli, come ha fatto Curzio Maltese, e senza che il COT abbia sentito il bisogno di eccepire alcunché (e ricevendone in premio l’assunzione negli organi direttivi di Sel)? Ma non si tratta purtroppo di una novità,
Barbara Spinelli è stata, fin dall’inizio di questa vicenda, per il suo nome, per il suo lavoro di giornalista, per i suoi interessi, testimone e garante non solo dell’orizzonte europeo del progetto, che è la prima delle grandi novità che fanno la differenza dell’Altra Europa rispetto a tutte le altre formazioni politiche; ma anche del suo carattere unitario ma apartitico, che è ciò che ha permesso a quel progetto di arrivare là dove tutte le precedenti “iniziative unitarie” non erano più da tempo riuscite ad arrivare. La lista Arcobaleno, quella Ingroia o la Federazione della sinistra avevano già abbondantemente dimostrato come anche gli elettori di sinistra avessero ormai voltato le spalle a qualsiasi lista con una caratterizzazione partitica.
Il fatto che Barbara si fosse “rimangiato” l’impegno a non accettare un eventuale seggio nell’Europarlamento, così come era stata indotta a “rimangiarsi” la decisione di non candidarsi, come tutti gli altri garanti (ma allora senza alcuna protesta) avrebbe potuto e dovuto essere accolto come un altro grande passo avanti lungo la strada intrapresa. Nessuno infatti osava negarlo; tanto che persino il segretario e il coordinatore dei due principali partiti che avevano sostenuto la lista erano stati concordi nel riconoscerlo. E l’autentica rappresentante, nel nome e nei fatti, della lista l’Altra Europa avrebbe potuto entrare nell’aula del Parlamento Europeo intitolata a suo padre come prova vivente di quel nuovo inizio. Invece ci è dovuta entrare accompagnata sì, dall’entusiasmo di tanti di noi, ma anche inseguita dagli insulti e dai lazzi di molti di coloro che avrebbero dovuta sostenerla (non poi così tanti; ma sufficienti a fare caciara, anche con il rincalzo di tanti nemici giurati della lista). Che cosa era mai successo? Era successo che Barbara aveva “portato via” il posto non a un altro candidato de L’Altra Europa (cosa che nelle liste elettorali è ordinaria amministrazione); ma all’”Europarlamentare di SEL”, rompendo quell’equilibrio così diligentemente illustrato dai cultori dell’alta politica (uno a Rifondazione, uno alla “società civile” e uno a Sel) che avrebbe dovuto riportare la lista a quella condizione di mera aggregazione di organizzazioni diverse a cui si era cercato in tutti i modi di sottrarla; peraltro non sempre riuscendoci, come evidenziato in molte situazioni da una conduzione separata della campagna elettorale.
Quella guerra contro Barbara, scatenata dall’interno e dall’esterno dell’organizzazione, è stata in realtà una guerra contro il progetto dell’Altra Europa; che da allora è rimasta paralizzata, nell’attesa di arrivare a un qualche compromesso con le sue presunte “componenti”. Che da allora, poco per volta, sono diventate tre: Rifondazione, Sel, ma anche l’Altra Europa: al tempo stesso (presunto) contenitore sia delle altre due componenti che di se stessa… Oggi si rinfaccia a chi non ha un partito il lavoro che i membri dei partiti hanno fatto per raccogliere le firme e fare campagna elettorale (i volantini, i manifesti, i comizi, i viaggi, i soldi, il tempo…). Ma non hanno fatto le stesse cose anche quelle e quelli senza partito? E non eravamo, o non avremmo dovuto essere, tutti della stessa partita? Invece oggi si invoca invece quell’impegno come se dovesse legittimare la compartecipazione alla gestione de L’Altra Europa non di chi vi milita, il che sarebbe normale, ma degli apparati dei relativi partiti. E perché mai? Perché questa è la strada che è stata imboccata da L’Altra Europa.
In realtà, una scelta o una decisione ufficiale non c’è mai stata; c’è stata una pratica che si è andata trascinando per mesi e mesi nell’inconcludenza: niente gruppi di lavoro (quindi niente elaborazione); niente apertura dell’associazione (perché Sel non voleva; ma chi l’ha deciso?); niente appoggio alle liste regionali Altra Emilia Romagna e Altra Calabria (il silenzio, in una situazione del genere, si chiama boicottaggio, che significa non “vendere” e non “comperare” un prodotto. Ma Sel si presentava con il PD, e non bisognava “dividersi”); niente rapporto con i movimenti (tutti) e, in particolare con No-triv e No-expo per non disturbare governanti e amministratori di Sel; niente autofinanziamento e quindi niente comunicazione per mesi e mesi (10); niente regole di funzionamento fino a che non sono state messe a punto quelle che, scimmiottando un congresso, hanno garantito al gruppo permanente al comando la propria perpetuazione; niente, ovviamente, dibattito su quelle regole, da prendere o lasciare. Ma abbiamo appoggiato la Grecia, Syriza e il governo Tsipras! Ci mancherebbe solo che non si fosse fatto… Ma una scelta del genere non basta a tenere in piedi un’organizzazione che si pretende politica. (di associazioni Italia-qualcosa ne abbiamo tante; tutte o quasi meritorie, anche se certo meno importanti). Ma quanto maggiore è stato il riferimento, sacrosanto, alla Grecia, di altrettanto si è affievolita la capacità di misurarsi con i maggiori processi sociali in corso nel nostro paese. Il punto di approdo di questa parabola è stato l’appoggio alla lista Pastorino. Certo è una lista che potrebbe anche avere un certo successo: non per proprio merito, ma per l’incancrenimento del PD. Dubito però, per come si è costituita, che possa pescare gran che tra tutti coloro che non votano più perché sono disgustati dalla politica, e non solo dal PD così com’è ora.
Ma quel punto di approdo era nella logica delle cose. Dal documento Siamo a un bivio, che è stata la bandiera del finto congresso di aprile dell’Altra Europa, si era esplicitamente voluto escludere una clausola – ed è stato il motivo per cui ho rifiutato di sottoscriverlo - che prevedeva di darsi “una struttura provvisoria, democraticamente eletta, che abbia il suo fulcro nei comitati e nelle associazioni dell’Altra Europa che si sono andati costituendo o si costituiranno nei territori”. La si è esclusa con l’esplicita affermazione che quei comitati “non contano nulla”, e che occorreva guardare al di là: alle decine di migliaia di firmatari dell’appello iniziale (quelli che così facendo abbiamo in gran parte perso) e al milione e passa di nostri elettori (idem): apparentemente un rapporto demiurgico tra il “centro” e una platea tutta da costituire; in realtà, la predisposizione di una sommatoria di “componenti” da non mettere in discussione.
 Un tema finalmente all'ordine del giorno. Mentre il premier mostra di credere giusto un mondo in cui qualche persona non abbia un reddito, il dibattito oscilla tra lotta alla povertà e nuova concezione del lavoro.
Un tema finalmente all'ordine del giorno. Mentre il premier mostra di credere giusto un mondo in cui qualche persona non abbia un reddito, il dibattito oscilla tra lotta alla povertà e nuova concezione del lavoro.
La Repubblica, 15 maggio 2015
«IL reddito di cittadinanza nel senso che tutti i cittadini da Agnelli in giù hanno un reddito è una follia. L’idea di una misura contro la povertà è una cosa su cui stiamo lavorando e siamo disponibili a parlare con i 5Stelle e con gli altri, ovviamente compatibilmente con i vincoli di bilancio». Così ha dichiarato Renzi nella conversazione con Repubblica . Ma ciò che propongono i Cinquestelle è esattamente questo, una misura contro la povertà. Sbagliano a chiamarla reddito di cittadinanza, perché questo termine evoca altre proposte che circolano a livello internazionale e sono sostenute da studiosi di tutto rispetto, come Atkinson e Van Parijs, e da un network internazionale, che auspicano, appunto, un reddito di base per tutti. Ma la proposta dei Cinquestelle si riferisce a chi si trova in povertà, come quelle della Alleanza contro la povertà con il Reis (Reddito di inclusione sociale), della commissione Guerra con il Sia (Sostegno di inclusione attiva), di una proposta di legge di iniziativa popolare avanzata dal Bin (Basic Income Network) Italia, e prima ancora del lontano reddito minimo di inserimento sperimentato alla fine degli anni Novanta.
Non mancano, infatti, le proposte e neppure le sperimentazioni, anche se Maroni, che oggi a sorpresa annuncia di voler sperimentare il “reddito di cittadinanza” in Lombardia sembra aver dimenticato di aver affossato il reddito minimo di inserimento appena diventato ministro del welfare, chiudendo la sperimentazione e dichiarandola fallita, senza spiegazioni né discussioni.
Al di là dei nomi, ciò di cui si parla, e che esiste già nella stragrande maggioranza dei Paesi dell’Unione Europea, in molti Paesi Ocse e in diversi Paesi dell’America Latina, è una misura universalistica, non categoriale (cioè non limitata a una o un’altra categoria di poveri) di sostegno al reddito per chi si trova in povertà, solitamente accompagnata dalla richiesta di disponibilità ad accettare richieste di lavoro per chi ne ha la capacità, o a partecipare a corsi di formazione per chi ne ha necessità, di fare in modo che i figli (per chi ne ha) frequentino regolarmente la scuola e abbiano le cure mediche necessarie e così via. Il termine “di cittadinanza” (anche se io non lo userei proprio perché si presta ad equivoci) si riferisce al diritto di ricevere sostegno se si è in condizione di bisogno (così come si ha diritto di ricevere una istruzione di base, o cure mediche quando si è malati), a prescindere dalla appartenenza ad una o un’altra categoria.
Si può discutere dell’importo base di questa misura, di come debbano essere definiti i diritti e i doveri di chi la riceve e dei doveri di chi deve fare funzionare le attività integrative e di accompagnamento (dalla scuola ai servizi per l’impiego), su come e con quale periodicità si devono effettuare i controlli. E si deve, ovviamente, ragionare su come finanziarla (senza tuttavia metterla sempre in coda rispetto ad altre priorità non adeguatamente discusse). Ma, ripeto, si tratta di misure che già esistono in altri Paesi (incluso il Portogallo, molto più povero dell’Italia) da diversi decenni. Sono state sperimentate anche in Italia e alcuni comuni hanno da tempo qualche cosa di simile. La provincia di Trento ha messo a regime il proprio reddito minimo da oltre due anni. Sono esperienze da cui si può imparare senza iniziare ennesime sperimentazioni che servono solo per rimandare la questione creando ulteriori disparità tra chi è coinvolto nella sperimentazione e chi no: una disparità che può essere accettabile una volta, ma che non può essere sistematicamente ripetuta, senza che si vada mai a regime.
Nei dibattiti di questi giorni, incluso “Ballarò” e “Di martedì” scorsi, si sono sentiti pareri, commenti, fondati su una intollerabile ignoranza da parte anche di illustri commentatori e commentatrici. Peraltro, nessuno sembra abbia pensato di sentire, oltre ai Cinquestelle, chi di queste cose si occupa da anni e ha fatto proposte argomentate (ad esempio l’Alleanza contro la povertà). Il dibattito sembra limitato a politici (inclusi quelli del Pd) e giornalisti apparentemente scelti tra chi ne sa meno ed ha meno memoria storica. Con il risultato di aumentare la confusione, delegittimando in partenza ogni proposta, lasciando aperto il campo ad ennesime sperimentazioni più o meno idiosincrasiche, o all’invenzione di qualche ennesima misura categoriale con cui vengono disperse risorse già scarse.
 La parola alla saggezza. Se queste tre omissioni non saranno corrette vivremo «un tempo di dura lotta perché la nostra scuola continui a essere, secondo costituzione, la scuola della nostra repubblica».
La parola alla saggezza. Se queste tre omissioni non saranno corrette vivremo «un tempo di dura lotta perché la nostra scuola continui a essere, secondo costituzione, la scuola della nostra repubblica».
L’internazionale, 11 maggio 2015
Il disegno di legge Giannini e altri, “Riforma del sistema nazionale di istruzione”, e i documenti governativi che lo hanno preceduto e lo accompagnano sono stati colpiti da molte critiche puntuali, tante da rendere difficile il compito di riassumerle. Lo hanno fatto su Internazionale due recenti messe a punto di Christian Raimo il 5 maggio e Mauro Piras il 7 maggio e mi rimetto a queste.
Tutti i critici, direi, si sono concentrati nel contrastare, smentire, sforzarsi di correggere singoli punti del disegno di legge fino a chiederne con ragione il ritiro, senza fermarsi a segnalare quel che nei testi non c’è. Però, come imparano gli studenti di prima annualità di buoni corsi di linguistica generale o filosofia del linguaggio o semiotica e comunicazione, un testo ci parla di un argomento non solo con quel che ci dice in esplicito, ma anche con quel che ne tace.
Sta nel potere delle nostre parole rendere significativi anche i silenzi. A me pare che nei testi di ispirazione renziana ci siano tre silenzi da segnalare, tre peccati di omissione. Sono silenzi che colorano malamente tutto ciò che si dice. Se non verranno corretti, devono metterci in allarme fin d’ora per le future politiche scolastiche governative e, ciò che più conta, per le sorti della nostra scuola.
1. La buona scuola che c'è
Ma anche questa differenziazione manca nella prospettiva renziana. La scuola, come fanno i giornalisti meno informati, è considerata come un blocco unitario, indifferenziato. Non se ne capiscono così i meriti e, anche, alcuni limiti.
All’inizio del cammino nell’età della repubblica la scuola e con lei l’intera società italiana si sono trovate schiacciate dall’eredità dello stato monarchico e fascista. Quasi due terzi degli ultraquattordicenni, il 60 per cento, erano privi di licenza elementare, un terzo dei quali analfabeti confessi (per l’Istat si era ed è analfabeti se tali ci si dichiara). Nelle classi giovani in età scolastica, per ragazzine e ragazzini, il titolo di licenza elementare (non il diploma, non la laurea) era riservato a un’élite, un terzo. Pochi, nel ceto intellettuale e politico, si rendevano ben conto di ciò: Umberto Zanotti Bianco, Guido Calogero, Anna Lorenzetto, Giuseppe Di Vittorio, Piero Calamandrei.
Soltanto dopo quasi dieci anni, alla pattuglia sparuta si aggiunse un giovane parroco rompiscatole del suburbio fiorentino, rimasto più noto per merito, dobbiamo dirlo, del Sant’Uffizio o simili. Il giovanotto aveva capito che era impossibile portare le parole del Vangelo a chi era immerso nell’analfabetismo e, in più, gli appariva già sedotto dalle prime ondate del consumismo, di cui nessuno, Pier Paolo Pasolini a parte, si rendeva conto. Cominciò a trafficare con le statistiche per capire quale era l’estensione del fenomeno. E scrisse un libro, Esperienze pastorali, che dispiacque alla sua chiesa, che isolò l’autore e lo relegò in una sperduta parrocchia di montagna, a Barbiana, sopra Vicchio, nel Mugello, nella convinzione che lontano dalla città avrebbe fatto meno danni. “Ecco il giudicio uman come spesso erra”, direbbe Ludovico Ariosto. Il ritardatario aggregato alla pattuglia, il rompiscatole mandato al confino si chiamava Lorenzo Milani.
Dinanzi alla realtà di dominante mancata scolarità la reazione fu lenta. Anche gli odiatori del populismo devono ammetterlo. La reazione cominciò dagli strati popolari, dalle campagne più povere del latifondo. Le famiglie capirono, sentirono, che dovevano mandare figlie e figli a scuola, sola alternativa al dispatrio.
Le statistiche ancora raccontano con i loro numeri, per chi si dà la briga di andarle a consultare, questa storia. Ragazze e ragazzi tra tardi anni quaranta e metà cinquanta affollarono le elementari e cominciarono a conquistare in grande maggioranza la licenza elementare prima preclusa invece alla grande maggioranza dei genitori, a non parlare dei nonni.
Mentre il parlamento discuteva del creare o no una scuola postelementare che onorasse il precetto costituzionale degli “almeno otto anni” di scuola “obbligatoria e gratuita” (articolo 34, comma 2), ragazze e ragazzi la scuola postelementare cominciarono a farsela da sé affollando i diversi canali che lo stato offriva e cercando di rimanerci. Varata nel 1962 la scuola media inferiore unificata, gli otto anni di scuola cominciarono a diventare realtà per percentuali crescenti, ma ancora lontane dal 100 per cento.
Il fatto è che una gran parte degli insegnanti resisteva e continuò a resistere. Erano convinti che il loro compito fosse censire, fermare e mandar fuori dai piedi i somari, gli svogliati, i testoni. Non erano stati attrezzati a capire che il loro compito era esattamente il contrario: fare in modo che i somari imparassero a non ragliare, gli svogliati ad avere voglia di studiare, i testoni a usare la testa per capire e orientarsi nella società. Facile a dirsi, non a farsi. Nel corso degli anni, gli e le insegnanti non solo delle elementari, ma anche delle medie inferiori hanno imparato a farlo. Le scuole elementari hanno raggiunto un doppio risultato: portano al loro termine il 100 per cento dei loro alunni e questi, nei confronti internazionali, si collocano tra quelli con i più alti livelli di competenza.
Interessante: il massimo di inclusività va a braccetto con la qualità più elevata dei risultati. Così è nel resto del mondo, così è stato ed è per la nostra scuola elementare. Comunque, in complesso, l’intera scuola di base è riuscita a portare alla licenza media dell’obbligo quasi il 100 per cento dei figli di famiglie in maggioranza analfabete o semianalfabete ancora quarant’anni fa e oggi in maggioranza dealfabetizzate. E perfino quello che è l’anello debole, la scuola media superiore, porta al diploma l’80 per cento di ragazzi e ragazze. E in questa scuola le nostre straordinarie ragazze nei test comparativi internazionali raggiungono punteggi superiori alla media delle loro compagne europee.
Questa è la scuola cui, senza conoscerla, voi volete mettere mano. Il vostro silenzio su ciò che la scuola ha saputo e sa fare fa temere che il vostro metter mano sia un manomettere. Questa scuola è la sola istituzione che ha aiutato la società italiana a evadere dalla prigione dell’analfabetismo primario, totale, e a conquistare almeno l’alfabetizzazione strumentale per il 95 per cento e quella pienamente funzionale (vedremo poi) per il 30 per cento. Mai erano stati raggiunti livelli così alti in tre mezzi secoli di storia patria.
“Se per strada incontro un mio collega lo saluto. Ma se incontro un insegnante mi fermo, mi cavo di capo il cappello e mi inchino”: così amava dire Guido Calogero nei lontani anni cinquanta e ne hanno conservato memoria quelli che lo hanno conosciuto e hanno condiviso con lui il confino come Carlo Azeglio Ciampi. E sapeva benissimo quante cose non funzionavano nella nostra scuola, come ha ricordato giorni fa Claudio Giunta.
Ma, interrompendo a tratti i suoi preziosi lavori specialistici di filosofo e di storico del pensiero antico e andando in giro per le scuole a conoscerne e capirne i problemi, aveva imparato quanto è duro, quanto è degno di riconoscenza e stima il lavoro di chi insegna. Voi cappelli non ne portate più, ma fermarvi e inchinarvi potreste e dovreste.
2. La Costituzione
Diffidenti o preveggenti i costituenti stabilirono una serie di vincoli.
1.La scuola deve essere “aperta a tutti” (articolo 34 comma primo: la frase è di sei parole, brevissima, e starebbe bene sull’ingresso di tutte le scuole): Gianni e Deborah non ci piacciono, ma non possiamo cacciarli via.
2.La scuola deve essere anzitutto e comunque luogo di un’istruzione “obbligatoria e gratuita” “impartita per almeno otto anni” (articolo 34 comma secondo).
3.Di conseguenza nemmeno la repubblica può cantare sempre libera degg’io: severa, la Costituzione le dice che deve istituire “scuole statali per tutti gli ordini e gradi” (articolo 33, comma secondo).
In altre parole istruirsi è sì un diritto soggettivo di cittadini e cittadine, ma “rendere effettivo questo diritto” non è una faccenda privata, è un dovere della e per la repubblica, che, vincendo i pianti dei ministri del tesoro, deve trovare i mezzi per consentirne l’esercizio (articolo 34, comma quarto).
Non bisogna essere esimi costituzionalisti per capire perché tanta attenzione per la scuola. La Costituzione è scritta con grande chiarezza (per questo ha perfino vinto un premio Strega). Proprio perché “aperta a tutti” e perché “obbligatoria per almeno otto anni” la scuola è l’unico luogo istituzionale in cui per forza devono ritrovarsi, almeno nei loro anni giovani, “tutti i cittadini (…)
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (articolo 3, comma primo). È qui, nella scuola, che la repubblica può adempiere al suo “compito” (questa parola fu pensata, scelta e confermata con cura dai costituenti): “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli (…) che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione (…) all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” (articolo 3, comma secondo).
La scuola della repubblica è il luogo privilegiato per vincere le limitazioni della libertà e dell’eguaglianza, rimescolare le carte della stratificazione sociale, trasformare le diversità in ricchezza culturale comune, favorire lo sviluppo delle persone, costruire le premesse per l’effettiva partecipazione attiva alla vita del paese. Voi che mandate i figli all’American talent school non sapete che cosa gli fate perdere (o lo sapete ma non v’importa niente): la progressiva costruzione di una società di persone libere.
La scuola dunque, come vide Piero Calamandrei e tornarono poi a spiegare i ragazzi di Barbiana, non è un pezzo qualunque dello stato, ma è un “organo costituzionale”. È entro questi limiti che la repubblica “detta le norme generali sull’istruzione” (articolo 33, comma secondo). Buone norme per la scuola devono richiamarsi sempre alla sua natura di delicato, essenziale organo costituzionale. La “Buona scuola” ne tace. È il secondo, preoccupante silenzio. È un’omissione voluta? Oppure è una sciatteria, una dimenticanza non voluta “con l’aggravante della buona fede”, come diceva don Milani?
3. Il neoanafletismo
Oggi, dopo tre indagini osservative internazionali (fondate su osservazioni, non su autovalutazioni) sappiamo che in tutti i paesi ricchi e consumistici una parte consistente di popolazione, dopo avere raggiunto in età scolastica livelli anche eccellenti di competenza nella comprensione della lettura, nella scrittura, nel calcolo, nel ragionamento scientifico, in età adulta tende a dealfabetizzarsi. Quasi due anni fa Internazionale ha pubblicato l’essenziale di questi dati. In paesi con scuole eccellenti, come Giappone, Finlandia, Olanda la percentuale di persone adulte al di sotto dei livelli minimi necessari a capire un testo e a usare basilari concetti matematici e scientifici tocca quasi il 40 per cento. Tocca il 50 per cento in Corea del Sud, altro paese di buona scuola, buona davvero, supera la metà nel Regno Unito e Germania, arriva a toccare e superare il 60 per cento in Francia e Stati Uniti, raggiunge infine il 70 per cento in Spagna e Italia.
Fattore determinante non è evidentemente da sola la qualità della scuola, ma sono gli stili di vita che allontanano chi è uscito da scuola dalla voglia di tenersi informato, di ragionare, di partecipare in modo attivo alla vita sociale. E così le competenze acquisite a scuola si indeboliscono, si avvizziscono, perfino muoiono, Per l’Italia va osservato che, se si tengono presenti anche i dati sulla capacità di problem solving (uso delle conoscenze per risolvere problemi non routinari nelle singole discipline), la percentuale delle persone sotto i livelli minimi di competenza sale all’80 per cento.
Questa massa cospicua di neoanalfabeti interessa due volte la scuola ordinaria. Interessa una prima volta perché in qualche misura la scuola, specie quella media superiore, è complice della dealfabetizzazione adulta, nel senso che non riesce a fare abbastanza per garantire che i livelli buoni cui porta ragazze e ragazzi si fissino e durino nel tempo dell’età adulta e anziana. Cosa relativamente di poco peso di fronte al danno che la scuola riceve da questa massa.
Sappiamo bene da studi di ogni sorta e paese che il livello culturale delle famiglie incide in modo determinante sull’andamento degli apprendimenti scolastici dei ragazzi. Otto su dieci dei ragazzi e delle ragazze che la scuola si trova di fronte vengono da famiglie in cui non entrano libri e giornali e non si praticano collegamenti a banda larga con internet e Google.
Da decenni, in altri paesi, si sono sviluppati antidoti specifici: un’ampia offerta di corsi per l’istruzione degli adulti. In Italia siamo astralmente lontani da ciò. Una commissione nominata nel 2013 dai ministri Carrozza e Giovannini (istruzione e lavoro nel governo Letta) produsse nel febbraio 2014 un rapporto analitico su quel che scuole e imprese potevano e dovevano fare per contenere e ridurre la massa dei dealfabetizzati. Gli estensori dei testi renziani devono averlo considerato materiale da rottamare e fare stare sereno.
Male assai: proposte serie sulla scuola non possono mettere da parte quello che la scuola può e deve fare per l’istruzione degli adulti. Oltre tutto i renziani amano molto gli anglismi e l’espressione tecnica in uso per la cosa è life long learning, imparare per tutta la vita. Ma loro non l’hanno usata, e non per purismo: la sconoscono come si dice in Sicilia. Secondo norme già vigenti e secondo le analisi della commissione di cui s’è accennato sono le scuole il luogo deputato a far da centro a un sistema di life long learning e anche di continuum training, formazione continua. Esse possono e devono diventare “fabbriche della cultura”. Su tutto ciò silenzio tombale di Renzi e di quelli che omericamente si possono dire “quelli a lui d’intorno”.
Matteo Renzi pareva partito con buone intenzioni. La prima era ottima: aveva fatto capire che di scuola , del complesso della scuola, si sarebbe occupato in prima persona, quale capo del governo. Sembrava che avesse capito che così in effetti richiede la intricata complessità economica, amministrativa, culturale e politica della realtà scolastica di un grande paese sviluppato. Così, di conseguenza, nei maggiori paesi del mondo le grandi svolte delle politiche scolastiche ed educative sono gestite direttamente dai capi di governo o di stato.
Così invece non è stato nella tradizione italiana, dove, a parte casi isolati come quello di Giovanni Giolitti e lampi di interesse di Romano Prodi ai tempi del Prodi uno, si è creduto che le politiche scolastiche potessero esser lasciate ai ministri dell’istruzione. Questi però non hanno competenze e poteri rispetto a troppe facce del problema, a cominciare dai riassetti del bilancio dello stato necessari se davvero si vuole intervenire sul complesso della realtà educativa. Sono riassetti che comportano decisioni che può e deve prendere solo chi guida l’intera compagine governativa, non un singolo ministro, a meno che non abbia una delega in bianco come (ma solo per due anni) fece Mussolini con Giovanni Gentile.
Una seconda buona intenzione manifestata all’inizio è stata insistere sulla natura solo parziale degli interventi che annunziava: non chiamatela riforma, ebbe a dire il presidente, sono solo singoli provvedimenti più immediatamente necessari, la riforma la faremo, ma verrà dopo. Invece e però da un certo punto in poi la buona intenzione è svanita e in comunicazioni governative, nei mezzi di informazione e infine nel testo consegnato al parlamento si è parlato di riforma, parola pesante che, a usarla correttamente, implica l’esistenza di un ripensamento adeguato e di una revisione radicale e complessiva di uno stato di cose.
Le buone intenzioni del capo del governo, svaporando, hanno infine portato il 27 marzo al disegno di legge presentato al parlamento dai tre ministri di settore, Giannini, Madia e Padoan. Le omissioni di cui si è detto qui sono pesanti. Se non saranno corrette prefigurano un tempo di dura lotta perché la nostra scuola continui a essere, secondo costituzione, la scuola della nostra repubblica.
 Nella lettera con cui l'europarlamentare comunica il suo distacco dalla lista italiana "L'altra Europa con Tsipras" , e nel dibattito che ne è nato si fa riferimento a una lettera nella quale, a metà aprile scorso sono state comunicate le ragioni del dissenso. Crediamo sia utile pubblicarla oggi per i frequentatori di
Nella lettera con cui l'europarlamentare comunica il suo distacco dalla lista italiana "L'altra Europa con Tsipras" , e nel dibattito che ne è nato si fa riferimento a una lettera nella quale, a metà aprile scorso sono state comunicate le ragioni del dissenso. Crediamo sia utile pubblicarla oggi per i frequentatori di
eddyburg. In calce le prime firme
Abbiamo condiviso e continuiamo a condividere l’appello iniziale L’Europa a un bivio, che alcuni di noi hanno contribuito a redigere e che altri hanno sostenuto con la propria candidatura e con la propria militanza, ma – nonostante molte mediazioni – non possiamo condividere il percorso che l’attuale gruppo dirigente dell’Altra Europa sta perseguendo.
Durante l’ultima assemblea nazionale di Bologna, il 18 e 19 gennaio, non è stato definito alcun programma, dato che quell’assemblea era stata messa nell’impossibilità di esprimere un voto.
Non votare e non contarsi significa sempre eludere la sostanza: cioè i temi politici fondamentali su cui non c’è eventualmente accordo.
Era stato però designato un “Comitato operativo transitorio” formato dalle stesse persone che avevano dato corpo in precedenza ai molti e spesso stravaganti acronimi (Con, Cot) che indicavano organismi non eletti, incaricati di condurre all’assemblea successiva. Di assemblea in assemblea, con sempre meno militanti e sempre più invisibili al mondo, siamo giunti a compiere quel presunto “percorso unitario” – mai votato e mai deciso, reso possibile dall’immobilismo e dalla subalternità ai piccoli ceti partitici della sinistra – che ha portato a delegittimare il lavoro di aggregazione fatto con continuità e abnegazione dai comitati regionali nati in vista delle elezioni.
Fino a giungere al caso esemplare dell’Altra Liguria, di cui la dirigenza di Altra Europa ha ignorato o misconosciuto le scelte – analogamente a quanto accaduto per L’altra Sardegna, L’altra Calabria e L’altra Emilia Romagna - insieme a quelle delle tante forze con cui questa struttura locale era riuscita a costruire un primo embrione di coalizione sociale. Un disconoscimento volto ad appoggiare la candidatura Pastorino che, per le passate prese di posizione, contrasta con gran parte dei principi ispiratori e dei punti programmatici della nostra comunità. In particolare, contrasta con uno dei cardini dell’appello istitutivo de L’Altra Europa: quello di non candidare personaggi che ricoprissero o avessero ricoperto cariche elettive o ruoli dirigenti in altri partiti nella passata e nella presente legislazione, onde salvaguardare il carattere sostanzialmente apartitico della lista.
Il superamento delle piccole identità partitiche era la caratteristica che aveva maggiormente distinto il nostro progetto, permettendoci di raggiungere il risicato quattro per cento che ci aveva fatto esistere come forza politica: un principio che per l’Altra Europa dovrebbe avere valore statutario.
Le cose sono andate diversamente. La dirigenza che gestisce oggi quel che resta dell’Altra Europa ha voluto perseguire ciò che già aveva enunciato nel documento Siamo a un bivio: l’unità, in vista di una fantomatica e sempre di nuovo rinviata unificazione, tra i piccoli partiti della cosiddetta sinistra radicale, e dell’ancor più fantomatica unificazione con una frangia della sinistra Pd di cui non si conoscono le reali prospettive.
Il nucleo di una ventina di persone che, pur non essendo mai state elette, si sono insediate al comando dell’Altra Europa, si è di fatto ritagliato, all’interno dei circa quarantamila sottoscrittori dell’appello iniziale, un proprio “corpo sociale” costituito da poco più di settemila adesioni (dopo averne preannunciate decine di migliaia e aver detto che il vero referente erano il milione e centomila elettori), ormai formato in gran parte da militanti di partiti (soprattutto Rifondazione comunista) che tutt’ora hanno forti legami con le proprie case di appartenenza.
Il cosiddetto Comitato di Transizione ha trasformato la prossima assemblea nazionale del 18-19 aprile in un congresso per delegati – un ossimoro, e in buona parte un tradimento delle intese inziali – che eleggerà un organismo su lista unica bloccata, un comitato centrale inamovibile, solo formalmente legittimato “democraticamente”. Si sono tenute assemblee territoriali con la pretesa di voto su mozioni (una della quali, per altro, ritirata dagli stessi estensori) e con “controllori” centrali a verificare il rispetto dei criteri imposti. In questo modo, migliaia di militanti sono stati esclusi dal corpo sociale dell’Altra Europa. Dei sei promotori iniziali (poi garanti) del progetto, ne è rimasto solo uno. Tutti gli intellettuali, gli artisti, gli studiosi, gli esponenti di rilievo dei tanti movimenti che si erano raccolti intorno al progetto – un gran numero di persone, tra cui decine dei nostri candidati e candidate – ci hanno lasciato strada facendo.
Il risultato è che la linea politica dell’Altra Europa si piega ormai di volta in volta alle esigenze tattiche imposte dalla sua subalternità agli interessi dei partiti con cui vorrebbe unificarsi: basti pensare al voltafaccia sulla nostra costituzione in associazione, che Sel non gradiva e che per questo non si è più fatta, o al voltafaccia sulla partecipazione alle elezioni regionali, prima scartata perché “le Regioni non contano nulla”, poi sostenuta per offrire uno spazio a Sel, dove questo partito non riesce ad accordarsi con il Pd; o, ancora, al voltafaccia nei confronti del tema “coalizione sociale”, prima marginalizzato e addirittura irriso, e poi, dopo le prese di posizione di Landini e Rodotà, riannesso in modo posticcio al percorso della “Casa comune della sinistra e dei democratici”. Per non dire dei contorsionismi necessari a stare con i movimenti No Tav, No Triv, No Expo e al tempo stesso mantenersene fuori, così da non costituire una minaccia per chi, pur abbracciando astrattamente una posizione, ne pratica un’altra, spesso diametralmente opposta, quando siede in giunte comunali e regionali. Lo stesso vale per la vicenda di Tempa Rossa e per i movimenti che lottano contro le Grandi Opere, l’erosione del suolo in Liguria, il No Muos in Sicilia, le Grandi Navi e il No Mose in Veneto.
Tutto questo ha disgregato ciò che era unito: molti di coloro che hanno sostenuto la nascita dell’Altra Europa si sentono ormai come esuli in patria, alcuni si sono allontanati, altri hanno ritrovato entusiasmo riavviando un processo partecipativo. Tutti però sono convinti che il percorso seguito attualmente non abbia futuro, essendo una stanca e ancor più contorta riedizione di progetti di aggregazione tra forze politiche prive di una propria ragion d’essere, per quanto ben decise a salvaguardare la propria sopravvivenza, la propria identità e, il più delle volte, i propri apparati (o zavorra, come li definisce Stefano Rodotà).
Stanno tuttavia prendendo forma e moltiplicandosi molti punti da cui partire per far rivivere quello spirito unitario – fondato su partecipazione orizzontale e attenzione ai processi sociali, anziché sugli schieramenti partitici – che aveva animato l’adesione al nostro progetto iniziale. Li ritroviamo nelle reti fra movimenti, nella trasversalità delle mobilitazioni per i migranti, nella perseveranza di tanti militanti e comitati, nella fierezza con cui L’Altro Veneto e molte “Altre” Regioni hanno deciso di affrontare le elezioni regionali con slogan come “basta cemento, basta tangenti”, chiedendo che la politica ritrovi un rapporto con l’etica del bene comune e sappia mettere al primo posto la solidarietà, l’accoglienza, le persone. La politica vera dell’Altra Europa, per noi, si fa lì.
15aprile 2015. Primi firmatari: Antonella Leto, Daniela Padoan, Roberta Radich, Barbara Spinelli, Guido Viale
 Barbara Spinelli presenta un'interrogazione a Bruxelles. Per chiedere alla Commissione europea d'indagare sul rispetto dei diritti dei profughi in Italia. Partendo da un video in cui i bambini dichiarano di aver subito percosse nella struttura di prima assistenza di Ragusa. Mentre la questura smentisce: Sono calunnie».
Barbara Spinelli presenta un'interrogazione a Bruxelles. Per chiedere alla Commissione europea d'indagare sul rispetto dei diritti dei profughi in Italia. Partendo da un video in cui i bambini dichiarano di aver subito percosse nella struttura di prima assistenza di Ragusa. Mentre la questura smentisce: Sono calunnie».
L'Espresso online, 12 maggio 2015
Uno sbarco a Pozzallo Dalla recinzione escono solo le grida. Voci di bambini, che urlano in arabo. Frasi che gli interpreti volontari traducono come un appello disperato: «Vogliamo uscire!». Gli viene chiesto: siete stati picchiati? La risposta è presentata in modo raccapricciante: «Si, con la corrente elettrica». Sono le cronache del centro ragusano di Pozzallo, dove vengono raccolti i profughi che hanno attraversato il Mediterraneo, riferite dai volontari siciliani in un video pubblicato il 24 aprile da MeridioNews .
La polizia ha smentito con decisione questa ricostruzione, presentando una querela. Ma la questione di Pozzallo adesso arriva a Bruxelles con un'interrogazione di Barbara Spinelli , che chiede di fare chiarezza: «Cittadini stranieri, anche minori, hanno dichiarato di aver subito percosse con manganelli elettrici, e un adulto ha mostrato segni di una bruciatura». L'eurodeputata invoca un'indagine perché in quel centro si sarebbe verificato «un uso illegittimo della forza». E domanda se «ciò che continua a registrarsi non violi la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione».
Dietro la denuncia c'è una questione decisiva, che rischia di esplodere con il nuovo esodo di disperati dalle coste dell'Africa. I profughi non vogliono essere registrati in Italia, perché questo li obbliga a restare nel nostro paese fino al completamento dell'istruttoria. Che da noi – come ha evidenziato un'inchiesta de “l'Espresso” - spesso richiede più di un anno. Durante Mare nostrum migranti e rifugiati venivano lasciati andare senza imporre la registrazione, in modo che potessero presentare la domanda di asilo in altri paesi. Più ospitali o più efficienti: solo nel 2014 in centomila hanno attraversato la frontiera senza lasciare traccia negli schedari della polizia. Adesso, in base alle ultime intese tra governi, questo non viene più tollerato.
Migranti, in centomila sono scomparsi
La grande fuga dopo lo sbarco. Mentre bruciamo miliardi per l’accoglienza. Senza riuscire ad aiutarli, né a controllarli. Cosi in 104.750 sono sfuggiti ai controlli. Scappano anche davanti ai militari. Che non intervengono: in esclusiva le immagini di Bari
Secondo l'Ansa, nel giorno in cui è stato reso noto il video, il 24 aprile 2015, sarebbe scattata una protesta dei rifugiati nella struttura di Pozzallo. I profughi, in prevalenza siriani e palestinesi, avevano rifiutato il pasto e la colazione, perché volevano essere trasferiti al più presto dalla Sicilia. Quel giorno la struttura ospitava 113 migranti. L'indomani il direttore, Angelo Zaccaria, ha assicurato che tutti avevano consumato il pranzo di mezzogiorno.
Ma la videodenuncia è arrivata fino a Bruxelles. Scrive Barbara Spinelli (che ha appena lasciato la lista Tsipras) : «Il 25 aprile 2015, nel centro di Pozzallo, risultavano trattenuti da sette giorni 113 cittadini siriani e palestinesi. Con particolare riferimento a Pozzallo, fonti diverse e concordanti documentano l’uso illegittimo della forza per costringere i migranti, anche minori, all’identificazione attraverso il prelievo delle impronte digitali in violazione delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo».
La Polizia ha smentito questa versione: «Sono state seguite con la consueta professionalità le rituali procedure relative all'accoglienza e alla successiva identificazione dei migranti», ha scritto la Questura di Ragusa in una nota diffusa lo stesso giorno del video: «Coloro che hanno mostrato resistenze, sono stati puntualmente denunciati per il rifiuto di sottoporsi alle procedure di foto-segnalamento», e conclude dichiarando di aver depositato alla procura della Repubblica una denuncia per diffamazione.
Ma le tensioni per il segnalamento dei profughi sono destinate ad aumentare con i nuovi sbarchi. Siriani, eritrei, palestinesi, spesso anche afghani, iracheni e nigeriani in fuga dai conflitti e dalle persecuzioni religiose chiedono di potere raggiungere altri paesi europei, dove vivono i loro familiari e ci sono maggiori possibilità di inserimento. La legge europea, applicata ora con rigore dalle nostre forze dell'ordine, non lo permette.
E almeno al Brennero adesso le polizie tedesche e austriache bloccano tutti i profughi. Solo l'approvazione delle nuove misure sulla distribuzione dei rifugiati in tutte le nazioni dell'Unione potrebbe offrire una soluzione diversa. Ma le trattative sono lontane da un accordo. Adesso però i governi europei si devono domandare quali siano i limiti per costringere all'identificazione e se sia tollerabile che venga imposta con la forza.
 Una recensione di due testi di Stefano Massini ( "Sette minuti" e "Lehman Trilogy") sul dramma del lavoro nel capitalismo.
Una recensione di due testi di Stefano Massini ( "Sette minuti" e "Lehman Trilogy") sul dramma del lavoro nel capitalismo.
L'Indice dei libri, aprile 2015
Con “7 minuti” Stefano Massini è riuscito a portare in teatro un fatto normale facendoci meravigliare. Undici operaie tessili di un consiglio di fabbrica intorno a un contratto da rinnovare. L’ azienda va bene, è stata venduta, la nuova proprietà in cambio di una garanzia dell’ occupazione e dello stipendio propone alle maestranze di rinunciare a 7 minuti “dell’ intervallo pattuito in sede di contratto premiando lo sforzo della proprietà di venirvi incontro in questo delicato passaggio storico”. La prima reazione delle donne è un grande sollievo. Perfino un sentimento di gratitudine. Questa garanzia, la tranquillità di un lavoro e di uno stipendio, valgono il sacrificio di 7 minuti al giorno. Altre fabbriche chiudono, ma qui si continua a lavorare. L’ offerta va accettata subito. Solo Blanche, trent’ anni al telaio, ha una strana „sensazione alla bocca dello stomaco“. Vuole discutere, vuole vedere chiaro. “Perché ho sempre la sensazione che noi dobbiamo ringraziare? Non è uno scambio alla pari?”.
Massini ci porta fino alle soglie del mistero economico. Andare oltre è il compito del lettore o dello spettatore che legge/vede cose che forse già sa, ma delle quali difficilmente si rende conto: Il lavoratore salariato appartiene non al singolo capitalista, ma al capitale, perché le sue condizioni di vita dipendono dai movimenti e dalle esigenze del capitale che la nostra società considera essere oggettive. La dipendenza può assumere forme attenuate da diritti conquistati, può diventare sopportabile e perfino confortevole. Ma periodicamente la legge del profitto si affaccia con la sua maschera ferrea e richiede, come gli dei degli aztechi, i suoi sacrifici umani. Infatti, il capitalismo può essere considerato ormai una delle grandi religioni. E’ il dio denaro che dà senso alle nostre azioni, regola la nostra vita, i nostri sentimenti e i nostri sogni. Nella sua “” Massini racconta attraverso le vicende di una dinastia di banchieri e finanzieri, che sono i sacerdoti di questa religione, i suoi fasti e la sua gloria fin dalla sua incarnazione nel mito americano. La forza che dà fiato al suo canto epico scaturisce da una catastrofe: Il 15 settembre 2008 crolla la Lehman Brothers provocando il fallimento più grande nella storia delle bancarotte mondiali. La banca era considerata too big to fail. Eppure questa volta il sistema bancario e lo stesso governo americano hanno voluto statuire un esempio facendo squillare le trombe del giudizio universale. Un epoca è finita. Ma che cosa significa questa affermazione e che tipo di Requiem stiamo cantando?
La Lehman Trilogy ci illumina sui passaggi cruciali da un capitalismo arcaico della “roba” a quello trascendentale della finanza. I Lehman, ebrei poveri immigrati dalla Germania, vendono attrezzi agricoli, passano alla compra-vendita di cotone, si trasferiscono dopo la guerra civile dall’ Alabama a New York dove figurano tra i fondatori della Borsa di Cotone, lontani da attrezzi, campi e carri. Capiscono il bisogno di nuovi mezzi di trasporto, investono in ferrovie e petrolio, in aerei e armi di guerra, si sposano bene, rimangono attaccati alla religione dei padri e conducono una vita da capitalisti “protestanti”, direbbe Max Weber. Sono tra gli artefici dell’ industrializzazione di un continente, creatori, come scriveva Marx, di “meraviglie ben diverse dalle piramidi egizie, dagli acquedotti romani e dalle cattedrali gotiche”.
 «Il motivo per cui ho preso le distanze da “L’Altra Europa” è che è stata la lista ad abbandonare il progetto originario, che era quello di creare un insieme di forze della sinistra molto costruito dal basso, basato sull’associazionismo, sulla società civile».
«Il motivo per cui ho preso le distanze da “L’Altra Europa” è che è stata la lista ad abbandonare il progetto originario, che era quello di creare un insieme di forze della sinistra molto costruito dal basso, basato sull’associazionismo, sulla società civile».
La Repubblica, 13 maggio 2015 con postilla
Barbara Spinelli, la sua decisione di lasciare la lista in cui era stata eletta all’europarlamento, “L’Altra Europa con Tsipras”, ha scatenato le polemiche. Il coordinatore di Sel, Fratoianni, la accusa di essere incoerente, rimproverandole di aver voluto tenere il seggio proprio per garantire la tenuta di quel progetto di cui oggi dichiara il fallimento. E sui social network c’è addirittura chi la accusa di tradimento. Come risponde?
«Io non trovo che ci siano né incoerenza né tradimento. Il motivo per cui, da tempo ormai, ho preso le distanze da “L’Altra Europa” è che secondo me è stata la lista ad abbandonare il progetto originario, che era quello di creare un insieme di forze della sinistra molto costruito dal basso, basato sull’associazionismo, sulla società civile. E soprattutto non dominato dai vecchi partiti della sinistra radicale. In questo anno e mezzo, piano piano ho avuto invece l’impressione di un predominio dei piccoli partiti che avevano promesso di sciogliersi ma non si sciolgono mai».
Quando ho letto la lettera di presa di distanza dalla lista ho scritto a Barbara Spinelli: «sono molto addolorato ma ti comprendo». Sono convinto che in un nuovo soggetto politico all'altezza dei problemi di oggi, che voglia promuovere una mobilitazione di massa, deve rivolgersi alle persone e non alle organizzazioni. Sono altrettanto convinto che la tecnica della lottizzazione delle posizioni di responsabilità sulla base delle appartenenze di gruppo non sia accettabile da parte di quanti hanno espresso la loro diffidenza verso la vecchia politica con l'astensionismo. Sono altrettanto convinto che oggi il pericolo maggiore sia rappresentato da Matteo Renzi, e che combattere dall'interno della sua macchina di guerra sia del tutto perdente. Infine, sono convinto che la priorità della lotta al renzismo non consenta alleanze con chi di Renzi è alleato. Per quanto riguarda la permanenza di Spinelli nel parlamento europeo ho votato con entusiasmo per lei non perchè la consideravo un buon capopartito, ma un ottimo parlamentare europeo e un magnifico rappresentante, in quella sede, di una nuova sinistra. Come ha dimostrato di saper essere. (e.s.)

Sembra che il reddito di cittadinanza, sinora teorizzato da isolate avanguardie, abbia fatto finalmente il suo ingresso nel cuore del Palazzo. Non ci sono solo i parlamentari di Sel e del movimento 5 Stelle, ma anche uomini del PD, il partito al governo, a premere per una sua realizzazione, che potrebbe trovare una strada praticabile nelle aule del Senato. E bisogna riconoscere che ancora una volta è stato Grillo e il suo movimento a imprimere una accelerazione di interesse politico sul tema.
Non sono così ingenuo da non sapere che la scarsa determinazione nel perseguire tale obiettivo non è solo dovuta a inerzia politico-organizzativa. A sinistra e soprattutto all'interno del sindacato, covano riserve tenaci nei confronti di questa misura assistenziale. Si teme la creazione di sacche di parassitismo, soprattutto fra la gioventù. E' la vecchia etica del lavoro, così radicata nel mondo comunista. L'etica del lavoro, introiettata da secoli di ideologia capitalistica, è stata certo trasformata col tempo dalle lotte del movimento operaio in fierezza di classe, un nuovo ethos civile che ha fatto delle classe operaia l'avanguardia sociale del Novecento.
Questo restringimento dell'età lavorativa in Italia ha almeno due gravi esiti. I giovani (almeno la maggioranza più fortunata) cercano protezione nel guscio della famiglia, rattrappendo aspirazioni e prospettive. Coloro che non ce l'hanno o non si accontentano, si rivolgono al welfare criminale. Spacciare droga non è un lavoro tranquillo, né eticamente apprezzabile, ma toglie tanti giovani dalla disperazione. E' dunque auspicabile che sia lo Stato a fornir loro un reddito, guastando l'etica capitalistica del lavoro, o preferiamo - come sempre più per tutto il resto, la scuola, la sanità, i trasporti - affidarci al mercato? Un mercato criminale, naturalmente, fra i più efficienti della Penisola. Ma naturalmente la questione giovanile riguarda, più gravemente, l'avvenire del nostro Paese. Stiamo perdendo le migliori intelligenze della presente generazione, che scappano nei grandi centri d'Europa e degli USA mentre il presidente del Consiglio e il suo governo ingannano gli italiani con le fumisterie della cosiddetta “buona scuola”.
Ma la condizione degli anziani che perdono il lavoro e non hanno ancora la pensione è tragica. Queste figure, esistenti da tempo in Italia, che la riforma Fornero ha fatto ingigantire, facendone le vittime sacrificali di una riforma ispirata dal panico e da una cultura produttivistica, non hanno nessuna famiglia a cui appoggiarsi. Quella famiglia in genere debbono reggerla loro, coi loro magri redditi. E spesso non pochi di loro si trovano in situazioni che nessuno potrebbe immaginare all'interno di una società opulenta come la nostra. Non solo devono provvedere spesso a mogli e figli disoccupati, ma talora hanno a carico anche qualche genitore anziano, tenuto in vita da una delle tante sontuose pensioni che allietano gli ultimi anni dei nostri vecchi.
Ci auguriamo che ne tengano conto i nostri parlamentari. Il reddito minimo toglierebbe dalla disperazione tante persone che hanno decenni di fatiche alle spalle e un futuro di incertezza. Aumenterebbe la domanda interna, di cui l'economia italiana ha un evidente bisogno. Costituirebbe la strada per ridurre le disuguaglianze sociali, offrirebbe a tanti nostri giovani un punto di partenza per intraprendere, studiare, continuare ricerche avviate. I giovani non si assopirebbero per un modesto reddito, vivendo da parassiti: si tranquillizzino sindacalisti e vetero comunisti. Questo lo credono coloro che dei giovani hanno solo sentito parlare.
Una versione ridotta dell'articolo è stato pubblicato su il manifesto
 Dieci consigli utili per chi vuole contribuire a «costruire le fondamenta di idee e pratiche che diano voce e volto all’universo degli invisibili, ai milioni di persone che sono fuori dalle élite economiche».
Dieci consigli utili per chi vuole contribuire a «costruire le fondamenta di idee e pratiche che diano voce e volto all’universo degli invisibili, ai milioni di persone che sono fuori dalle élite economiche».
Esse, comunità di passioni, 7 maggio 2015
Congratulazioni a Pippo Civati che è uscito dal Pd. Il segno che con un po’ di coraggio e coerenza ce la si può fare. Lo sappiamo: il Pd è non solo l’erede del Pci. È stato anche progetto di un grande partito che stesse dalla parte dei più deboli. Per questo è così difficile, per tante persone in ottima fede, accettare l’idea che quel progetto non è andato oltre le intenzioni dichiarate. Non ci è andato prima di Renzi, ancor meno dopo. Ma questa è ormai storia. Ora, se possiamo, suggeriamo (non richiesti) una decina di cose da fare e da non fare, perché adesso bisogna partire sul serio.
1. Per carità vi preghiamo: non incollate i cocci di tante piccole storie sconfitte. L'unità è una parola bellissima, ma non può essere pensata come la somma di ministrutture finite. Deve essere, piuttosto, l’unità tra persone in carne e ossa, tra pezzi di società. Vi ricordate i contadini e gli operai di un tempo, che erano la parte bassa della piramide sociale? Ecco, sono diventati gli invisibili di oggi: precari, disoccupati, partite iva, insegnanti, “neet", ricercatori, ex ceto medio impoverito e tante altre cose. È lì la maggioranza. Diamole voce, diamole senso.
3. Il cambio di passo che serve non è solo nelle facce, ma è in primo luogo nelle teste, cioè nel modo di essere e quindi di presentarsi, con trasparenza e verità. Non è scritto da nessuna parte che l’alternativa alle liturgie delle vecchie forme della politica (quelle che non parlano più a nessuno semplicemente perché parlano una lingua incomprensibile alla stragrande maggioranza della gente comune) sia il partito del monarca assoluto. Si può essere innovativi senza rottamare la democrazia.
4. Barra dritta, a ogni modo, sull’innovazione e sul cambiamento a favore dei deboli, non contro di loro. Quella di Renzi è un’innovazione contro i deboli e a favore dell’élite. Noi non vinciamo se contrapponiamo a essa la conservazione, la caricatura di Cipputi in tuta blu, le vecchie parole d’ordine. Guardiamo avanti, non indietro.
5. Che poi, la sinistra si fa, non si dice. E sinistra – parola usurata e deturpata da troppo tempo, compresi tanti anni di politiche di destra fatte a nome della sinistra – vuol dire occuparsi dei problemi delle persone, della parte bassa e mediobassa della piramide sociale. Che non ha più nemmeno la forma di una piramide, ma di un’enorme base di non élite con sopra una piccola punta di élite. La dialettica tra sinistra e destra è diventata un'inutile e spesso ingannevole dialettica "geografica": quello che conta invece è la contrapposizione reale tra la grande maggioranza che non ha e la piccola maggioranza che ha. E comanda.
6. Per questi motivi fare vuol dire, vi preghiamo, non solo convegni ma lavoro vero nel sociale: il mutuo soccorso, la disobbedienza civile, le proposte di legge di iniziativa popolare, i referendum, le strade, i quartieri, i luoghi del lavoro e del non lavoro, insomma le pratiche. Questo forse è anche il senso della “coalizione sociale” di cui tanto si parla e di sicuro lo è delle varie coalizioni sociali che, con altri nomi, in tutta Italia e in tutta Europa, spesso in silenzio, sono pronte a muoversi.
7. Insieme a questo, serve un programma vero. Un programma di governo per il Paese e per l’Europa, non un elenco di slogan. Per scriverlo bisogna cacciare i fantasmi del minoritarismo che ammorbano la cultura politica di gran parte della sinistra esistita fin qui. Si esiste e si propone un’alternativa al governo delle élite perché si ritiene di poter essere la soluzione ai problemi, non la grancassa della frustrazione collettiva.
8. Basta discutere dalla mattina alla sera di alleanze e di elezioni. Ci siamo divisi per anni e continuiamo a dividerci tra quelli che vogliono allearsi e quelli che non vogliono allearsi, litigando per pessime questioni di liste e di candidature. Ecco, ripartiamo da capo. Prima costruiamo una nostra identità, costruiamo il chi siamo e il cosa vogliamo. Saranno altri, semmai, a bussare alla nostra porta. Alla porta della maggioranza.
9. La buona politica è quella che moltiplica, per contagio, il protagonismo e l’attivismo. Non quella che impone la passività e l’obbedienza ai propri militanti e simpatizzanti. Più potere reale decentrato e maggiore efficacia nella comunicazione, anche attraverso leadership (che servono) non burocratiche ma dinamiche, capaci di suscitare passioni ed entusiasmi ragionevoli e critici.
10. Rivoluzione copernicana, infine, anche nello stile, che è parte ed espressione dell’essere. Si può essere radicali senza essere violenti, si può essere popolari senza essere volgari, si può essere convinti e convincenti senza perdere la gentilezza. In un mondo di pescecani, proviamo a dire – anche nei nostri comportamenti, nelle nostre pratiche – come vorremmo fosse la società nella quale ci piacerebbe abitare. Del resto, si sa, ciascuno deve essere la rivoluzione che vuole vedere nel mondo.
Questo il nostro piccolo contributo, per ora. Speriamo che altri ne arrivino, per costruire le fondamenta di idee e pratiche che diano voce e volto all’universo degli invisibili, ai milioni di persone che sono fuori dalle élite economiche. Noi proviamo a cominciare da qui e sappiamo di non essere soli. Qualcosa si è già mosso, negli scorsi mesi, in queste direzioni. E anche da incontri che qualche base hanno gettato, come quello chiamato Human Factor, nel novembre scorso; ma non solo, naturalmente: tanti altri fermenti sono nati dal basso, nelle associazioni diffuse, nella realtà fisica e in quella digitale, lontano dai riflettori mediatici, in quella galassia di persone che non si vede ma c’è e si impegna. Se da tutte queste persone, idee e pratiche ora nasce o no qualcosa di buono e di utile, dipende da tutti voi, da tutti noi.
 Il modello di rapporto tra potere e società al quale si ispira l'Innovatore è vecchio di qualche secolo. Eccolo puntualmente descritto in un articolo tratto da
Il modello di rapporto tra potere e società al quale si ispira l'Innovatore è vecchio di qualche secolo. Eccolo puntualmente descritto in un articolo tratto da
La tecnica della scuola, il quotidiano della scuola online, 8 maggio 2015
Il Re che decide di annunciare riforme che impattano sull'impegno lavorativo dei docenti, i vassalli che cercano di far apparire il cambiamento delle regole come unica soluzione per uscire dalla situazione di stallo organizzativo in cui si trova la scuola, i valvassori di rango inferiore che dicono: "Io sto con il Re" e infine i valvassini che dicono: "Io sto con il valvassore".
Questo potere vorrebbe far sfumare le proteste della servitù della gleba, ovvero di quella docenza che non conta, ma deve solo ubbidire e possibilmente non fiatare, perché indebolire l'immagine del Re non fa bene a quell'Europa sempre prodiga nel chiedere sacrifici e austerità.
Ma nel Medioevo non esistevano i sindacati capaci di fare immediata opposizione costruttiva, come ad esempio la Gilda di Rino Di Meglio, e soprattutto non esisteva il web, luogo di vera condivisione di idee per una servitù della gleba 2.0, che con un solo clic può mettere in discussione qualsiasi struttura piramidale.