

 Un'analisi attenta al modo in cui, sotto la retorica dell'Universalismo, vengono camuffati i nazionalismi, razzismi, e le altre perversioni del pensiero e violazioni dei diritti, nel mondo di oggi (e soprattutto nell'Europa).
Un'analisi attenta al modo in cui, sotto la retorica dell'Universalismo, vengono camuffati i nazionalismi, razzismi, e le altre perversioni del pensiero e violazioni dei diritti, nel mondo di oggi (e soprattutto nell'Europa).
Il Fatto Quotidiano online, 5 maggio 2016 (c.m.c.)
Gli Stati-nazione e la loro ideologia di governo, il nazionalismo, compaiono grosso modo contemporaneamente al credo del valore universale dell’Umanità.
Si potrebbe dire che se c’è una prova dell’essenza ipocrita dell’universalismo, questa è la prova perfetta. Probabilmente nel corso della storia non ci sono mai state così tante persone assassinate dal nazionalismo, dal razzismo e dalle altre ideologie come nel XX secolo sotto il sole universale dell’Umanesimo. Si potrebbe replicare che se il genocidio è diventato per noi il male assoluto è proprio grazie alla validità dei valori universali. Dopo tutto la letteratura inizia con il genocidio. Troia fu distrutta, tutti gli uomini vennero uccisi e le donne prese come schiave, ma per molte generazioni questa è stata solo una bella storia da leggere. Cartagine fu arata e cosparsa di sale; vero o meno che fosse, sta di fatto che i Romani se ne vantavano.
Cosa è cambiato? Ci sono delle alternative. Molti giudizi negativi sulle altre razze, religioni non vengono più dati per scontati, ma respinti come pregiudizi. Mentre gli antichi conquistatori erano fieri di definirsi conquistatori, oggi preferiscono chiamarsi liberatori. E’ ipocrita? Per lo più sì. La creazione di molte istituzioni internazionali, in primo luogo le Nazioni Uniti, incorpora (almeno apparentemente) il concetto di universalità. Non siamo estranei e ancor meno nemici, siamo nazioni diverse di un pianeta comune. E’ ipocrita? Per lo più sì.
E’ ipocrita in primo luogo perché l’universalismo nulla significa per molte culture, con la sola eccezione della scienza e della tecnologia. Sebbene quasi tutti gli Stati del mondo abbiano firmato la Dichiarazione universale delle Nazioni Unite, tale firma ha o può avere conseguenze pratiche solamente nelle democrazie liberali. Se ricordo la contraddizione o solo la tensione tra valori universali e la posizione antropologica fondamentale, ho in mente soltanto le democrazie liberali. Non solo gli Stati totalitari, ma anche le autocrazie ricorrono ai pregiudizi contro l’Altro come arma per garantirsi l’appoggio popolare.
Al tempo stesso il rapporto con l’”Altro” diventa selettivo. I pregiudizi nazionali, razziali, religiosi, sessuali rimangono vivi, anche se a volta nascosti, se confermano la posizione antropologica fondamentale, la convinzione che “noi” siamo il centro dell’universo, la sensazione di sicurezza. Per molti altri aspetti, tuttavia, la curiosità e l’interesse per l’Altro hanno guadagnato terreno. La Cina, l’Africa nera, lo yoga, il buddismo, la religione Krishna vanno di moda. I ristoranti offrono cucine di ogni parte del mondo. Nelle sale da concerto, nelle gallerie, alla televisione non c’è quasi più un “noi” e un “loro”.
La scena cambia completamente quando l’”estraneo” si stabilisce permanentemente tra “noi”.
La tensione tra posizione naturale e universalità non ha il medesimo significato in tutte le democrazie liberali. A questo punto c’è una sostanziale differenza tra Stati-nazione e altri Stati moderni, una differenza tra Europa e il cosiddetto “nuovo mondo”.
Parlo dell’attuale Europa, di Stati nei quali la “nazione” è diventata una identità onnicomprensiva nella quale tutti i bambini imparano a scuola o dai genitori quanto la loro nazione sia superiore. In queste nazioni i bambini vengono allattati al seno con le leggende del passato nazionale, con le storie sulla grandezza della loro nazione e su come fu tradita. Si fondono insieme identità etnica, politica, culturale, tradizionale e talvolta persino religiosa. Per definizione si esclude la doppia identità. Nel nuovo mondo si può essere “irlandesi americani”, “afro-americani”, “cino-americani” “Italo-americani” ecc., in Europa no. I francesi sono solo francesi, i tedeschi solo tedeschi, gli ungheresi solo ungheresi. In uno Stato-nazione l’”estraneo” non si sarebbe potuto integrare senza essere assimilato. L’assimilazione comporta la totale identificazione con la nazione ospite, l’abbandono della cultura, della religione, del modo di vestire, delle leggende, del passato tradizionale dei migranti. Chi non riesce ad assimilarsi rimane un paria. Al contrario del “nuovo mondo”, l’emancipazione politica, vale a dire l’aspetto principale dell’integrazione, significa poco o nulla in uno Stato-nazione.
Il carattere escludente degli Stati-nazione è chiarito nel migliore dei modi possibili dalla storia degli ebrei europei nel XIX e XX secolo e dalla storia di due guerre mondiali. Il moderno antisemitismo (al contrario dell’originario anti-ebraismo) è stato il prodotto degli Stati-nazione. La trasformazione del nazionalismo in razzismo non è stato un mero caso in quanto il nazionalismo etnico contiene in sé un elemento di razzismo. Ho detto in precedenza che la prima guerra mondiale è stata una guerra europea, la vittoria degli Stati-nazione contro l’internazionalismo e il cosmopolitismo. Allo stesso modo in cui l’intreccio tra etnia e razza è stato la motivazione (almeno da parte tedesca) della seconda guerra mondiale.
Dopo la devastazione della seconda guerra mondiale, alcuni Stati europei tirarono le conseguenze in ordine al lato oscuro degli Stati-nazione e crearono l’Unione Europea. Non bisogna sottovalutare il significato di questo grande progetto. Gli Stati membri dell’Unione Europea si sono impegnati a non iniziare mai più una guerra gli uni contro gli altri. Non di meno a tutt’oggi nessun sentimento identitario europeo ha conquistato la stessa forza o lo stesso significato delle identità nazionali degli Stati membri. Se chiedessi ad un qualunque bambino di un qualunque Paese dell’Unione Europea: “cosa significa per te essere europeo?”, dubito che sarebbero in molti a rispondere o a capire il senso della domanda. Il problema non va individuato nei conflitti di interesse, ma nei conflitti in ordine al significato di appartenenza, al problema dell’identità e della legittimazione generali, se non universali.
E tuttavia gli europei non sono più “estranei” per gli altri europei. Un francese non è estraneo per un tedesco, uno slovacco o un ungherese. L’ideologia nazionalista, i miti e le leggende nazionali mobilitano ancora popolazioni frustrate e, quanto più frustrate sono tanto più efficaci sono i vecchi miti. Oggi, tuttavia, il vero estraneo non è più l’altro europeo, ma il migrante. I migranti sono gli estranei che arrivano tra noi da chissà dove, hanno costumi e religioni diversi, hanno tradizioni, leggende, punti di vista diversi su ciò che e vero e ciò che è falso. Sono terroristi, occupano la nostra terra e la distruggono. Il pericolo intrinseco nello Stato-nazione si ripresenta. L’estraneo deve assimilarsi o scomparire completamente.
Da un lato l’Europa ha un tasso di natalità insufficiente e ha bisogno dei migranti. Nell’arco di circa 60 anni gli europei hanno ucciso cento milioni di europei. Mancano non soli i figli, i genitori, i nonni, i bisnonni. I peccati dei padri e dei nonni vanno espiati.
Dall’altro lato, gli europei sono pronti sono disposti ad accettare i migranti solo se sono disposti ad assimilarsi. Assimilarsi non all’Europa (che non ha una memoria tradizionale e culturale comune né una medesima lingua), ma a questo o a quello Stato-nazione.
I rifugiati provenienti da zone di guerra dell’Asia o dell’Africa, oggi si rifanno alla dichiarazione universale: “voi europei avete inventato che tutti gli uomini nascono ugualmente liberi, quindi noi siamo come voi. Di conseguenza dovete trattarci come esseri umani con pari diritti e lasciarci vivere con voi nel vostro pacifico, abbondante e piccolo continente”. Gli europei rispondono: “è vero, tutti gli uomini nascono ugualmente liberi e noi siamo tutti uguali, ma la maggior parte degli uomini debbono rimanere dove si trovano. Noi abbiamo lavorato per le nostre ricchezze che sono comunque a rischio in quanto dobbiamo sfamare la nostra popolazione povera. Abbiamo dei diritti sulla nostra terra e siamo noi a decidere che può vivere qui. Chi possiede una casa, detta le regole. Anche i parenti prossimi che vengono a trovarci e sono nostri ospiti a Natale debbono rispettare le nostre regole”. L’estraneo chiede: “avete bisogno di regole per potere salvare da morte certa chi si trova in una casa in fiamme? Se non è così, perché non consentite ai rifugiati di entrare in casa vostra senza alcuna condizione?”. Gli europei rispondono: “accogliamo i rifugiati senza condizioni e li ospitiamo nei campi profughi fin quando non potranno tornare da dove sono venuti senza correre pericoli. Ma debbono comunque rispettare delle regole. Le stesse regole della casa? O altre regole? Che regole sono le regole della casa?”.
Un americano risponderebbe: “le regole della casa sono le regole dello Stato. Tutti debbono osservare le leggi dello Stato sia che riguardino il comportamento verso gli altri sia che riguardino il comportamento da tenere tra voi o nei confronti di vostra moglie o dei vostri figli”. “Questo può essere accettabile”, risponderebbe l’estraneo “ma alcune regole della nostra religione non ci consentono di onorare sempre le leggi dello Stato”. “Mi spiace”, risponderebbe l’americano. “In tal caso non potete sistemarvi in casa mia”. Ma io non sono americano, io sono europeo, cittadino di uno Stato-nazione…nei nostri Stati-nazione ci sono molte più regole della casa rispetto al nuovo mondo. Dovete imparare la lingua dello Stato, la tradizione della nazione, osservarne i costumi, adottarne il comportamento pubblico e privato e considerarvi membri di quella particolare nazionale”. “E se non lo faccio?” “Sarai un emarginato, non troverai un lavoro decente, i tuoi figli non avranno la possibilità di salire la scala sociale”. “Ci chiedete troppo”, protesta l’estraneo. “Sì, lo so, ma dovete capire che abbiamo le nostra tradizione. A lungo ci siamo considerati caucasici rispetto alle persone di colore e questo genere di razzismo sfortunatamente è importante per molti nostri compatrioti. Ci siamo considerati il continente cristiano e non è facile abbandonare questa tradizione. Ci siamo considerati progressisti, non solo nel campo dell’hi tech, ma anche in quanto democratici liberali in molti aspetti della vita di tutti i giorni”. “Siete gente molto strana”, sottolinea l’estraneo.
Riferimenti
la lectio magistralis della filosofa Agnes Heller si terrà il 6 maggio al Bergamo Festival “Fare la pace” (5-15 maggio).
« Il manifesto, 6 maggio 2016 (c.m.c.)
La recente pubblicazione di alcuni documenti sui negoziati in corso sul Ttip effettuata da Greenpeace ha riportato sui media il trattato di libero commercio tra Usa ed Europa. Tranne in alcuni momenti – in Italia solo quando sembra poter diventare una discussione che riporta al cortile di casa – tutto quanto sta accadendo intorno al Ttip non trova granché spazio nella discussione pubblica e politica.
L’argomento, in effetti, non è dei più semplici perché la volontà dei negoziatori (in primo luogo gli statunitensi) è quella di regolare il commercio del mondo occidentale all’interno di standard che da quel momento in poi saranno da considerarsi universali. O almeno in grado di regolare i rapporti tra quasi tutti gli Stati tranne, dicono i maligni, Cina e Russia, escluse, guarda il caso, da tutto questo movimento internazionale desideroso di «liberalizzazioni». Ci sono molti aspetti, inoltre, da cui discendono dei «no» talmente forti al trattato da aver coinvolto centinaia di associazioni e organizzazioni in mobilitazioni che trovano sfogo nelle piazze di molti paesi.
In Italia sabato 7 maggio ci sarà una manifestazione nazionale e per capire tutte le ragioni dei «no» e i motivi delle campagna di «Stop Ttip» sabato, in occasione delle proteste, sul manifesto ci sarà un inserto ad hoc di otto pagine. Nel frattempo è bene segnalare la letteratura che esiste circa le argomentazioni contro «i metodi» con i quali il trattato si sta portando avanti, oltre che contro il trattato stesso (se mai arriverà a compimento). In Ttip – L’accordo di libero scambio transatlantico, quando lo conosci lo eviti (Derive e Approdi, 13 euro), Paolo Ferrero, Elena Mazzoni e Monica Di Sisto, affrontano tutto quanto riguarda le ricadute economiche, sociali e politiche del Ttip. Partendo proprio dalla domanda di partenza: qual è l’obiettivo dichiarato del Ttip?
Gli autori del volume spiegano che il fine è «abbattere le differenze di normative tra le parti, differenze che sono considerate barriere non tariffarie al commercio e agli investimenti: l’idea chiave è che, riducendo queste differenze di regolamentazione, il commercio e gli investimenti aumenteranno con conseguente crescita economica». La prima constatazione è la convenienza di un percorso simile: a chi porterà dei vantaggi? «Un percorso simile potrebbe sfociare in un’enorme ingerenza sulla capacità degli Stati di legiferare nell’interesse dei cittadini, perché il Trattato crea delle costrizioni internazionali che, in modo evidente, vanno a influire sull’autonomia normativa delle parti».
Su questo la posizione dell’Europa – che in realtà qualche dubbio lo ha – non ha alcun tentennamento, come dimostrato dalla Commissaria al Commercio Ue, Cecilia Malmstrom quando ha specificato che «i due contraenti si impegnano, con l’accordo in fase di negoziazione, a eliminare le normative che impediscono al mercato transatlantico di essere armonioso».
Al di là dell’ironia dell’utilizzo della parola «armonia» (usata da Pechino per indicare la necessità di una società sottoposta al volere del Partito comunista), le parole di Malmostrom indicano una chiara volontà dell’Ue di appoggiare i piani tanto degli Usa quanto delle multinazionali, in favore dell’abbassamento di standard di qualità che finiscono poi per ripercuotersi in molti settori delle nostre vite future. In ballo non c’è tanto e solo la sovranità di uno stato, quanto le conquiste fatte nel corso del tempo in tema di diritti ambientali, del lavoro, dell’alimentazione. E soprattutto c’è la volontà di negoziare – come dimostrato dai leaks resi pubblici da Greenpeace – senza che la società civile sappia di cosa si sta discutendo, salvo poi assistere alla farsa dell’eventuale ratifica dei parlamenti nazionali completamente esclusi del resto dalle trattative. Gli autori del volume, in ogni caso, vanno oltre.
Mettiamo, sembrano dire, che tutto questo insieme di elementi generali (compreso quello che riguarda la risoluzione delle controversie tra Stati e aziende) non sia sufficiente per un «no» energico al progetto di Ttip, vediamo allora cosa succede nell’ambito numerico, economico, puramente di guadagno. Se il Ttip, ad esempio, portasse all’azzeramento «delle tariffe doganali e dei contingenti tariffari, le esportazioni agroalimentari degli Usa verso l’Ue aumenterebbero di 5,5 miliardi di dollari rispetto all’anno di riferimento (2011), mentre i livelli di esportazioni europee verso gli Stati uniti crescerebbero di 0,8 miliardi».
Questo accade perché l’Ue «attualmente impone barriere tariffarie più alte sulle importazioni di quanto non facciano gli Usa», ma se «oltre ai dazi, si rimuovono dal commercio transatlantico alcune specifiche misure non tariffarie, la situazione è destinata a cambiare di molto».
Ovvero, carne, colture, frutta e verdura: sono questi «gli ambiti più interessati da misure non tariffarie restrittive, e rimuoverle si tradurrebbe in un aumento delle esportazioni degli Usa verso l’Europa di ulteriori 4,1 miliardi». La crescita di esportazioni complessive degli Usa diventerebbero quindi di quasi 10 miliardi di dollari. Per l’Europa la rimozione delle misure non tariffarie si tradurrebbe in un guadagno di 1,2 miliardi. E al di là di questo: chi quantificherà i danni per la salute?

Il Fatto Quotidiano, 5 maggio 2016 (p.d.)
I politici non hanno smesso di rubare, hanno solo smesso di vergognarsi”. L’ha detto Piercamillo Davigo in un’intervista al Corriere della Sera, ripetendo una frase che è stata un grande classico in tanti suoi interventi pubblici negli ultimi anni. Si sono indignati i politici, ma non i cittadini. E comunque la cronaca sembra dargli ragione.
In una settimana abbiamo dovuto raccontare ai lettori de ll’arresto del sindaco di Lodi Simone Uggetti (Pd) per turbativa d’asta; dell’arresto di Antonio Bonafede, consigliere comunale del Pd a Siracusa, mentre stava per imbarcarsi su traghetto con 20 chili di droga; dell’indagine per concorso esterno in associazione mafiosa a carico del consigliere regionale e presidente del Pd in Campania, Stefano Graziano; dell’incredibile vicenda del Consiglio regionale della Sardegna, dove in cella si sono incontrati il vicepresidente del Consiglio regionale Antonello Peru (Forza Italia), arrestato per una vicenda di presunti appalti truccati, e Giovanni Satta (centristi) che quando è stato fermato pertraffico internazionale di stupefacenti ancora non era consigliere regionale. Lo è diventato – da detenuto – dopo che a seguito di vari ricorsi, l’ufficio elettorale della Regione gli aveva assegnato il seggio.
La questione morale incombe, è un’emergenza ormai cronica. Abbiamo chiesto a Gustavo Zagrebelsky com’è possibile che quelle affermazioni di Enrico Berlinguer (“I partiti sono soprattutto macchine di potere e di clientela. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune”), 35 anni dopo suonino così attuali.
Dalla politica ci dicono che la responsabilità penale è personale, che bisogna essere garantisti: i corrotti sono casi isolati, cioè singole mele marce. Cosa ne pensa?
». Il manifesto, 5 maggio 2016 (c.m.c.)
Il 20 aprile in Italia i metalmeccanici hanno scioperato per il contratto nazionale. Il 25 aprile, inaugurando la fiera di Hannover ,la cancelliera Merkel e il presidente Obama hanno dato il loro sostegno politico al programma “Industry 4.0”. Sono due momenti del grande processo di trasformazione del modo di produrre, al cui centro non sono solo le tecnologie, ma il ruolo dei lavoratori , se autonomo o subalterno a questo cambiamento.
Superato l’arcigno ammonimento di Taylor “non siete pagati per pensare”, ora nella fase della grande innovazione del Toyota Production System, il TPS, ai lavoratori si dice “la qualità dipende da voi”, perché siete il sistema nevoso di un “ un processo di miglioramento continuo “ dei metodi di lavoro e dei prodotti.
L’obiettivo è un sindacato collaborativo o marginale, senza potere contrattuale sulle concrete condizioni di lavoro lasciate al governo dell’impresa, che interviene attraverso i team leader, lavoratori con competenze specialistiche e trasversali che su mandato dell’azienda coordinano un piccolo gruppo di compagni . E‘ una estesa rete di consenso alle politiche ed ai valori aziendali, rispetto alla quale i rappresentanti sindacali sono in grande svantaggio , anche numerico: in media sono uno contro dieci.
“Industry 4.0” deve essere un ulteriore avanzamento in questa direzione: più internet, più robotica, più stampanti 3D; pianificazione della produzione via rete integrandovi il cliente come partner e governando così la turbolenza dei mercati; logistiche adattabili perché continuerà a crescere la rete della fornitura . Il mercato richiede personalizzazione, flessibilità, velocità. Per questo non basta la tecnologia. Servono figure professionali poliedriche e competenti che sappiano gestire la complessità e risolvere problemi, . I teorici di “ Industry 4.0 “puntano sull’ operaio “aumentato”, più versatile di in robot, nervo della lean production.
Avrà, comunque, sempre il difetto di fare domande sulla sua condizione. Finora il TPS è sembrato avere le risposte, puntando sulle culture aziendali e sulla partecipazione in via gerarchica per i lavoratori al centro del processo produttivo e disperdendo tutti gli altri nel vasto mare del precariato, dagli immigrati che fanno funzionare la logistica ai nuovi lavoratori autonomi iper-laureati dei moderni servizi alle imprese.
Non è detto che sia sempre così e che non sia possibile una ripresa di iniziativa sindacale, di cui i contratti nazionali sono aspetto importante. Occorre, però, aprire una discussione intorno al ruolo dei lavoratori nei processi di innovazione tecnologica e di cambiamento sociale. E’ positivo che nel documento di CGIL-CISL-Uil per un moderno sistema di relazioni industriali si accetti la sfida sulla questione della partecipazione toglendola dal chiuso recinto dell’aziendalismo e della dipendenza gerarchica e riproponendola come “ valore fondamentale per la crescita democratica, politica e sociale dell’ intera collettività nazionale” come è giusta la scelta della contrattazione “inclusiva” come strumento per unire quanto il TPS tiene diviso.
«». Il Fatto Quotidiano online,
La riforma della Costituzione, che sarà a breve sottoposta al vaglio di un referendum, è soltanto l’ultima (per ora) convulsione di una politica tutta italiana, che riforma l’esistente per l’incapacità di gestirlo, o di gestirlo nel modo voluto. E’ il prodotto della stessa violenta immaturità politica per la quale non esiste in questo paese un partito che abbia il coraggio di definirsi conservatore. Possibile che non ci sia nulla da conservare della storia politica del paese? Nessuna conquista del passato che valga la pena di mantenere? Come insegna il Gattopardo cambiare continuamente tutto è un modo di conservare, ma non di conservare il meglio o il buono: di conservare il potere, a costo della distruzione del sistema.
Ovviamente perché la strategia della riforma continua, funzionale alla conservazione del potere anziché all’interesse del cittadino – elettore, funzioni è necessario che la politica sia in grado di convincere il cittadino che dopo tutto riformare, se non addirittura rivoluzionare, il sistema sia nel suo interesse. La riforma della Costituzione è la madre di tutte le riforme: cambia i meccanismi decisionali e i rapporti di potere al più alto livello politico e consente quindi potenzialmente qualunque ulteriore riforma dell’ordinamento dello Stato e dei suoi servizi.
E’ quindi importante analizzare il meccanismo attraverso il quale l’elettore viene imbrogliato e convinto la politica faccia l’interesse dei cittadini anziché il proprio.Uno strumento molto importante dell’imbroglio è la denigrazione dell’esistente: almeno dai tempi di Berlusconi, se non da prima ancora, è in corso l’esperimento politico di creare consenso elettorale attraverso la (presunta) denuncia dei difetti del sistema, anziché attraverso la pubblicizzazione dei suoi meriti.
Denigrare è sempre più facile che lodare: basta infatti riferirsi ad una idealità della cui realizzabilità pratica non c’è traccia. Con l’aiuto di giornalisti compiacenti, sarà sempre possibile trovare un giudice che indossa calzini azzurri, a dimostrazione e vituperio dei difetti della giustizia; o un caso di malasanità, a dimostrazione che un Servizio Sanitario Nazionale valutato dall’Oms il secondo migliore del mondo, sia un disastro e una vergogna. Sarà sempre possibile additare al pubblico disprezzo un sistema della ricerca che è ottavo nelle graduatorie internazionali o una università pubblica che si classifica duecentesima nel mondo? Ciò che deve essere nascosto (e basta non riferirlo) è che la duecentesima università del mondo, rispetto al numero delle università valutate, si classifica al 97mo percentile: su 99 università scelte a caso, la duecentesima del mondo è peggiore di tre e migliore delle rimanenti novantasei; allo stesso modo, basta non riferire che il Servizio Sanitario Nazionale nel quale un paziente è morto in corso di intervento chirurgico salva ogni giorno la vita di mezzo milione di pazienti diabetici.
Una volta che il cittadino è stato convinto da una propaganda martellante che i servizi pubblici che paga con le sue tasse ed ai quali ha accesso sono pessimi, e che quindi qualunque riforma sia preferibile allo status quo, la strada del consenso è aperta e qualunque saltimbanco può costruirsi una carriera politica sulla semplice promessa di “cambiare” qualcosa. Berlusconi ha promesso cambiamenti per vent’anni, Renzi segue l’esempio, Beppe Grillo pure.
Ovviamente domani saremo insoddisfatti delle riforme di Renzi, come pure di quelle di Beppe Grillo (o chi per lui): perché riformare il secondo miglior Servizio Sanitario Nazionale del mondo, o l’ottavo sistema della ricerca, comporta il grosso rischio di renderli peggiori anziché migliori: date le condizioni di partenza c’è molto più margine per il peggioramento che per il miglioramento, tanto più se lo scopo della riforma non è il miglioramento del sistema ma il controllo del potere.Un consiglio Opporsi alle ipotesi di riforma (Costituzionale o altre) se proposte da gruppi di potere che mancano di riconoscere i pregi del sistema che intendono riformare: perché quei pregi li distruggeranno, senza dare garanzia del miglioramento promesso.
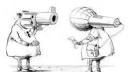
Il manifesto, 4 maggio 2016 (p.d.)
E vanno male quelli che in questo periodo sono sotto i riflettori del Vecchio Continente: la Turchia del presidente-sultano Erdogan che tiene dietro le sbarre oltre 30 reporter (per lo più kurdi) e l’Egitto del golpista al-Sisi che mette a tacere le voci critiche con la consolidata pratica delle sparizioni forzate. Non a caso i redattori del quotidiano turco Cumhuriyet Dundar e Gul e il giornalista egiziano Shawkan (per la cui scarcerazione si è mossa anche la famiglia Regeni) sono tra i 9 reporter che ieri Amnesty International ha preso a modello delle abusi contro la stampa.
In generale, registra Rsf, la situazione peggiora ovunque: «Tutti gli indicatori della classifica mostrano un deterioramento – spiega il segretario generale Deloire – Molte autorità temono che il dibattito pubblico sia troppo aperto». Nel caso italiano, le ragioni dell’arretramento le spiega lo stesso Rsf: il caso Vatileaks e le conseguenze giudiziarie subite dai giornalisti Nuzzi ed Fittipaldi che hanno reso note informazioni nascoste dietro il portone di San Pietro.
Si potrebbe scorrere tutto l’indice, arrovellarsi per capire perché El Salvador e Burkina Faso occupano posizioni sicuramente più prestigiose (38° e 42° posto). Si potrebbe studiare il meccanismo dietro l’indice di Reporter Senza Frontiere, giudicato poco veritiero perché per l’80% fondato su percezioni soggettive più che su dati assoluti.
C’è del vero dietro il giudizio tranchant di alcuni media che nei giorni scorsi hanno pubblicato il rapporto. Si parte da un questionario compilato da associazioni e giornalisti chiamati a dare un punteggio da 1 a 10 su legislatura, autocensura, pluralismo, indipendenza, trasparenza e infrastrutture. I voti vengono poi calcolati sulla base di una particolare formula matematica. Poi si utilizzano dati assoluti: numero di giornalisti arrestati, minacciati, licenziati, uccisi. Valori che pesano meno dei giudizi personali, spesso prodotto del contesto nazionale.
In Italia, però, si potrebbe anche fare autocritica. E dirci che se siamo tra i paesi occidentali meno liberi in campo mediatico forse un motivo c’è. Da noi del resto la condizione di lavoro di migliaia di giornalisti è senza contratto, freelance che spesso freelance non sono perché lavorano nelle redazioni, siedono a fianco dei colleghi contrattualizzati, fanno lo stesso mestiere, a volte seguono un intero settore.
Sono tanti: secondo i dati 2014 dell’Lsdi, oltre il 62% dei giornalisti attivi sono autonomi, 31mila contro 18mila subordinati. Il restante 38%, da dipendente, può guadagnare 5 volte più di un freelance. Sono tanti e di tanti tipi: dai giovani disposti ad accettare retribuzioni basse o collaborazioni gratuite a chi ha esperienza di decenni ma si ritrova disoccupato per la chiusura del proprio giornale. Secondo la Federstampa, la gran parte dei precari (il 75%) non supera il traguardo dei 10mila euro l’anno. Di questi il 62% è sotto la soglia dei 5mila.
Forse scendiamo nella classifica perché è difficile parlare di informazione libera e indipendente quando chi lavora nelle redazioni – che siano quotidiani, tv, radio o agenzie web – è sottopagato e spogliato dei propri diritti. Quindi ricattabile. A uscirne malconcio è un intero sistema che si fonda su giornalisti che mettono insieme uno stipendio – o no – a seconda degli articoli pubblicati ogni mese. Ed è ovvio che di tempo per inchieste, per il mito del giornalismo investigativo, per chiedere diritti ne resta poco.
LaRepubblica, 4 maggio 2016 (c.m.c.)
Il Ttip è nudo! Qualcuno è riuscito a pubblicare quasi tutte le carte di un trattato importante tra due continenti che pochi tecnocrati, con appoggi governativi, cercavano di nascondere nelle segrete stanze. Finalmente sappiamo di che stiamo parlando e la realtà è ben peggiore delle peggiori previsioni. Le turbolente vicende relative ai negoziati sul Ttip confermano alcuni segnali poco consolanti, ma ci danno anche qualche speranza.
Le brutte notizie, a dire il vero, già le conoscevamo:
1) I cittadini, a volte, devono difendersi dalle istituzioni: questo non era nell’idea di democrazia. Non era nei patti che una Commissione Europea di “nominati” si svincolasse dichiaratamente dalla volontà dei cittadini che eleggono il Parlamento Europeo, arrivando ad accettare modalità di negoziazione che ostacolano l’accesso dei parlamentari ai documenti. Così ci hanno pensato i cittadini, e nella fattispecie Greenpeace, a pubblicare il testo di quel trattato segreto. Non è così che dovrebbe funzionare.
2) L’arroganza del mercato e dei suoi alfieri si concentra su velocità e facilità degli scambi trascurando l’oggetto: armi, pane o informazioni, è uguale, purché sia tutto rapido e uniforme. Questo è di una stupidità straordinaria, è la vecchia metafora del treno che va sempre più veloce senza che i passeggeri possano sapere dove vanno e chi sta guidando, né chi li ha messi su quel treno. Con il Ttip questa logica ha raggiunto il suo massimo splendore: “armonizziamo” gli standard, ci dicono, così gli scambi aumenteranno, di ritmo e di numero.
“Abbassiamo le barriere non tariffarie” così facilitiamo il commercio tra Europa e Stati Uniti. Ma il commercio di cosa? Con quali benefici pratici per le comunità? Fa lo stesso: l’importante è che le merci corrano per il pianeta senza intralci che si chiamano “normative”. Che fastidio dover pianificare gli affari evitando di calpestare i diritti, di ammalare le persone e di inquinare l’universo.
3) L’intralcio principale è, in fin dei conti, il sistema democratico. Che prevede che i rappresentanti eletti dalle popolazioni coinvolte dicano la loro in situazioni come queste. Ma se si fa così non si va avanti, avranno pensato i tecnici ai quali è stato affidato (da chi?) il compito di scrivere il trattato. Invece la democrazia si costruisce poco alla volta, si riconsolida ad ogni passaggio. La democrazia europea tra mille difficoltà, ha costruito le normative che ora paiono d’intralcio alle multinazionali. Perché, come ci diceva il buon Pericle cinque secoli fa «il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: e per questo viene chiamato democrazia». Le multinazionali sono poche. I cittadini sono molti.E veniamo alle buone notizie.
1) Non è vero che gli interessi degli statunitensi sono diversi da quelli degli europei. Di più: non è vero che gli imprenditori, e in particolare quelli agricoli, degli Usa sono tutti di grande scala e dediti alle monoproduzione, mentre quelli europei sono tutti piccoli e multifunzionali. La differenza semmai sta nell’interesse alle esportazioni intercontinentali. Ma attenzione: quando si parla di cibo e di vino di qualità, si fanno affari oltreoceano anche restando piccoli; l’importante è mantenere alta la qualità. La quale è tutelata dalle normative- intralcio.
2) Lo stesso senso di condivisione pervade i consumatori, da entrambe le parti dell’oceano. Sembra proprio che, grazie a questo tentativo di patto scellerato, finalmente le popolazioni si riscoprono parte della medesima comunità di destino, parte di un sistema planetario che deve innanzitutto difendere la qualità della propria vita.
3) Infine la migliore di tutte: nonostante gli spudorati tentativi di tenere il dibattito il più lontano possibile non dico dalle piazze, ma addirittura dai Parlamenti legittimamente in carica, le parrocchie, le librerie, le università, le associazioni si son fatte sentire e stanno cambiando di fatto gli equilibri: per quanto ancora verranno ignorate?
La democrazia negata si può restaurare proprio a colpi di democrazia: ovvero di informazione e di spazi di confronto. Come quello che si aprirà a Roma il 7 maggio. Spero che sia una manifestazione che si realizzerà in una grande partecipazione dei cittadini italiani perché siamo tutti cittadini del mondo e gli “uomini di buona volontà”, quelli che lavorano per il bene comune, sono dappertutto, e parlano la stessa lingua.

greenMe.it, rilanciato da Comune-info, 03 maggio 2016 (p.d.)
Ecco allora che questo maestro che ha davvero a cuore i bambini ha deciso di raggiungere in bici le località più povere dell’Afghanistan per portare dei libri da leggere ai bambini. Durante la settimana il maestro lavora in una scuola mentre nel weekend raggiunge i bambini che non possono frequentarla per dare loro in prestito dei libri.
All’incontro successivo i bambini possono restituire i libri già letti e prenderne in prestito degli altri, In questo modo la cultura entra in circolazione gratuitamente tra i più poveri. L’impegno del maestro è ormai ben noto in Afghanistan e la sua iniziativa è molto apprezzata soprattutto da chi non avrebbe mai la possibilità di acquistare un libro.
Esistono diversi modi per mostrare solidarietà ai bambini e alle persone in difficoltà. Grazie alla sua iniziativa il maestro ha distribuito centinaia di libri per rendere felici i bambini e per fare in modo che potessero accedere alla lettura.
Non tutti purtroppo nel mondo hanno questa opportunità e dobbiamo ritenerci davvero fortunati nell’avere sempre a disposizione dei libri da prendere in prestito nelle biblioteche o da acquistare nelle librerie.
Il maestro ha scelto la bicicletta e i libri come un vero e proprio simbolo per dimostrare che possiamo sostituire la violenza con la cultura. La produzione di libri in Afghanistan è molto limitata dunque quelli distribuiti dal maestro di solito sono importati dall’Iran. Si tratta soprattutto di versioni semplificate delle opere di Victor Hugo, Jack London, Saint-Exupery e di poesie e racconti di scrittori iraniani.
Ogni volta che il maestro porta dei libri ai bambini cerca di parlare con loro e di proporre un argomento che può essere utile per la loro istruzione. Quando arriva nei villaggi trova sempre un gruppo di bambini pronto ad ascoltare una lettura o una piccola lezione.
Siamo davvero colpiti dall’impegno del maestro che gratuitamente porta cultura, libri e un raggio di speranza ai bambini che si trovano in difficoltà. Servirebbero più persone così anche in altre zone del mondo.
Guardate il video per approfondire la sua storia.

Comune-info, 3 maggio 2016 (p.d.)
Il Ttip è conosciuto come “il più grande trattato della storia”, perché se verrà approvato, legherà gli Usa e l’Unione europea coinvolgendo circa 820 milioni di persone e abbracciando un’area che produce circa il 45 per cento del Pil mondiale. E costituirebbe la più grande area mondiale di libero scambio. Le trattative per creare il Ttip sono partite in tutta segretezza nel luglio 2013 a Washington e sono condotte da pochi esperti della Commissione europea e del ministero del Commercio Usa: è un negoziato stipulato senza la partecipazione dei cittadini. È un vero e proprio golpe da parte dei poteri economico-finanziari che governano il mondo.
Infatti il Trattato indebolisce il “principio di precauzione” vigente in Europa , in relazione ai nuovi prodotti, elimina le sanzioni in caso di abusi relativi ai diritti sociali e ambientali e mira a una progressiva privatizzazione di tutti i servizi pubblici (il Ttip, infatti spiana la strada per l’altro trattato in arrivo, il Tisa – Accordo sul commercio dei servizi -, che vuole privatizzare tutti i servizi pubblici). Ancora più grave è il fatto che il Ttip introduca le corti arbitrali private per le dispute investitori-stati (il cosidetto Isds): un meccanismo che – seppure nelle correzioni addotte come compromesso al ribasso del gruppo socialista nel Parlamento Europeo – subordina tuttora i diritti umani alla prevalenza delle imprese e del mercato (Francesco Martone)”.
Il Ttip avrà inoltre pesanti ricadute sul mondo del lavoro aggirando le norme dei diritti dei lavoratori, svuotandone le normative per la loro protezione, ma anche ridimensionando il diritto di contrattazione collettiva. Il Trattato mina poi alla base il “principio di precauzione” aumentando i rischi per la salute alimentare. "Il Ttip – dice Susan George – è un assalto alla democrazia, alla classe lavoratrice, all’ambiente. L’unica risposta possibile dinanzi a questo attacco è alzarsi dal tavolo, chiudere le porte e lasciare la sedia vuota".
Infatti ci sono mobilitazioni contro il Ttip in tutta Europa e negli Usa: il 24 aprile ben novantamila persone sono scese in piazza ad Hanover. Sono molti i sindaci e i governatori di regioni che in Europa, come anche in Italia, hanno aderito alla campagna: "Fuori Ttip dalla mia città".
 «Le Costituzioni vanno pensate “per sempre”: come quella americana, che dal 1789 ha avuto solo 27 emendamenti, Ma l’equivoco del plebiscito oscura la sostanza dei problemi, spinge a trattare il tema come una competizione sportiva e non come una discussione sul merito, da valere nei tempi lunghi». LaRepubblica, 3 maggio 2016 (c.m.c.)
«Le Costituzioni vanno pensate “per sempre”: come quella americana, che dal 1789 ha avuto solo 27 emendamenti, Ma l’equivoco del plebiscito oscura la sostanza dei problemi, spinge a trattare il tema come una competizione sportiva e non come una discussione sul merito, da valere nei tempi lunghi». LaRepubblica, 3 maggio 2016 (c.m.c.)
Non si riforma per comodo di chi governa, né si respinge se l’attuale governo non ci piace. Le Costituzioni vanno pensate “per sempre”: come quella americana, che dal 1789 ha avuto solo 27 emendamenti, dei quali dieci tutti insieme, e dal 1992 nessuno. Ma l’equivoco del plebiscito oscura la sostanza dei problemi, spinge a trattare il tema come una competizione sportiva e non come una discussione sul merito, da valere nei tempi lunghi. Dimenticando che dalla tenuta della Costituzione dipende la vita della democrazia, anzi della Repubblica.
Certo, non è facile discutere nel merito una riforma che modifica in un sol colpo 47 articoli della Carta; mentre dal 1948 ad oggi si erano cambiati 43 articoli, a uno a uno, seguendo l’aureo principio secondo cui le revisioni della Costituzione devono essere «puntuali e circoscritte, con una specifica legge costituzionale per ogni singolo emendamento» (Pizzorusso).
Nonostante questa valanga di modifiche, è assolutamente necessario entrare nel merito. Con un intervento tanto invasivo, è statisticamente improbabile che vada tutto bene o tutto male. Proverò a indicare due punti che ritengo accettabili e due che mi paiono da respingere. Va bene aggiungere la “trasparenza” tra i requisiti dei pubblici uffici (art. 97). La parola non era nel linguaggio politico del 1948, lo è adesso. Forse non è proprio la Costituzione il luogo per dirlo, ma in fondo perché no? Altro punto su cui si può esser d’accordo, la restrizione del potere del governo di emanare decreti legge (art. 77).
Ma punti ancor più importanti suscitano gravi preoccupazioni. Ne indico solo due. L’art. 67 della Costituzione vigente dice: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato» (ossia senza obbligo di ubbidienza verso il partito, ma con piena responsabilità personale). Questo principio è stato già svilito dall’indecorosa migrazione di parlamentari da un partito all’altro (a fine gennaio 2016 si contavano 325 metamorfosi dei voltagabbana di questa legislatura). Ma nella proposta di riforma costituzionale il testo vigente, breve e chiaro, viene smembrato e disfatto. Il nuovo articolo 67 direbbe infatti: «I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato ».
Scompaiono le parole «rappresenta la Nazione», trapiantate (depotenziandole) nell’art. 55, da cui risulta che «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione». Avremo dunque un Senato i cui membri non rappresentano piú la Nazione, perché «il mandato dei membri del Senato è connesso alla carica ricoperta a livello regionale o locale» (cosí la relazione esplicativa). Ma siccome gli ex Presidenti della Repubblica saranno senatori a vita, avremo l’assoluta meraviglia di Presidenti come Ciampi e Napolitano che non rappresenteranno più la Nazione, bensì le istanze locali.
Ma come verrà eletto, secondo la riforma, il Presidente della Repubblica? Lo faranno deputati e senatori, come ora (art. 83). Ma con una differenza importante. Oggi il Presidente è eletto con una maggioranza di due terzi dell’assemblea nei primi tre scrutini (così nel caso di Ciampi, 1999), con la maggioranza assoluta dal quarto in poi (così Napolitano, 2006). In futuro, se la riforma sarà approvata nel referendum, non sarà più così. Nei primi tre scrutini resta valida la maggioranza di due terzi dell’assemblea, dal quarto in poi si passa ai tre quinti dell’assemblea; ma la vera novità della riforma scatta a partire dal settimo scrutinio: da questo momento in poi basterà la maggioranza assoluta non più dell’assemblea, bensì dei votanti.
In altri termini, se al settimo scrutinio dovessero votare solo 20 fra deputati e senatori, a eleggere il Presidente basteranno 11 voti. Gli assenti dall’aula avranno sempre torto. Si aprirebbe così la gara a colpi di mano, delegittimazioni, conflitti procedurali. Un Presidente eletto cosí, certo, non «rappresenta la Nazione» nemmeno quando è in carica, figurarsi da senatore a vita. Chi ha votato questo articolo in aula doveva essere davvero assai distratto.
Nel merito bisogna entrare (non lo farò ora) anche sul neo-bicameralismo che nasce dal nuovo Senato non elettivo. E’ difficile, è vero, render conto dell’intrico di competenze fra le due Camere quale risulta dall’ammucchiata verbale della riforma (l’art. 70, nove parole nella Costituzione vigente, ne conta 434 nel nuovo). Ma è importante parlarne nel merito: perché criticare il “bicameralismo perfetto” della Costituzione vigente non vuol dire necessariamente sottoscrivere un testo che «non funzionerà mai e complicherà in modo incredibile i lavori del Parlamento» (Ugo De Siervo).
Davanti a enormità come quelle degli artt. 67 e 83 (e non sono le sole), c’è da chiedersi perché mai l’elettore debba essere obbligato a votare in blocco con un SI’ a tutto (comprese le modifiche che detesta) o con un NO a tutto (comprese quelle su cui è d’accordo). E’ stato uno svarione istituzionale cucinare in un unico testo una riforma tanto estensiva; ma è ancora possibile rimediare in parte segmentando i quesiti referendari in più punti, come propone il documento firmato da 56 costituzionalisti, fra cui 11 presidenti emeriti della Corte Costituzionale. Sarebbe più rispettoso della Costituzione, degli elettori, della democrazia. Ma il governo avrà il coraggio di farlo?

 «XII edizione del festival Vicino/Lontano, in programma a Udine dal 5 all’8 maggio moltissime saranno le voci che si confronteranno nei “dialoghi sul mondo che cambia”». LaRepubblica, 3 maggio 2016 (c.m.c.)
«XII edizione del festival Vicino/Lontano, in programma a Udine dal 5 all’8 maggio moltissime saranno le voci che si confronteranno nei “dialoghi sul mondo che cambia”». LaRepubblica, 3 maggio 2016 (c.m.c.)
La vulnerabilità come cifra del nostro tempo. È il tema sotteso agli oltre cento appuntamenti della XII edizione del festival Vicino/Lontano, in programma a Udine dal 5 all’8 maggio. Cuore della rassegna, la consegna del Premio Terzani a Martín Caparrós, che il 7 maggio dialogherà con Loredana Lipperini. Ma moltissime saranno le voci che si confronteranno nei “dialoghi sul mondo che cambia”, a partire dalla lectio magistralis “L’Età dell’incertezza” del direttore di LiMes, Lucio Caracciolo.
Sul rapporto tra mondo islamico e Occidente interverrà il sociologo franco-iraniano Farhad Khosrokhavar, mentre a far luce sul complesso fenomeno migratorio in atto sarà il dibattito che vedrà fra i protagonisti Loris De Filippi, presidente di Medici Senza Frontiere Italia, e il giornalista Domenico Quirico, che a Udine presenterà in anteprima Esodo. Storia del nuovo Millennio. Di immigrazione, tra indifferenza e disinformazione, si parlerà anche con Stefano Allievi, Giampiero Dalla Zuanna e Pierluigi Di Piazza, mentre Roberta Carlini e Alessandro Leogrande analizzeranno l’approccio dei media.
Il potere e le sue menzogne saranno il tema del confronto inaugurale del festival, di cui discuteranno Gianni Rufini, direttore generale di Amnesty International Italia e i giornalisti Andrea Purgatori e Valerio Pellizzari. E in questa prospettiva si colloca anche la lectio sulla tortura proposta dalla filosofa Donatella Di Cesare.
Sul male oscuro della democrazia si confronteranno, invece, l’8 maggio, l’ex direttore di Repubblica, Ezio Mauro, lo storico Guido Crainz e il linguista Raffaele Simone, insieme all’antropologo Nicola Gasbarro. Nel percorso dedicato alla legalità si inscrive anche il format educativo che il 6 maggio vedrà la partecipazione di Domenico Quirico e di Federica Angeli.
Dalla vulnerabilità del sistema alle fragilità del singolo: del reddito di cittadinanza come utopia possibile parlerà Philippe Van Parijs. Di fragilità del sistema economico- finanziario discuteranno gli economisti Giangiacomo Nardozzi e Antonio Massarutto, mentre Riccardo Staglianò e Fabio Chiusi spiegheranno come web e robot stiano impoverendo la classe media.
Il tema della “cura” troverà spazio nell’incontro con Beatrice Bonato, Duccio Demetrio e Vittorio Lingiardi. Mentre il filosofo Pier Aldo Rovatti terrà una lectio sul mettersi in gioco, tema rilanciato da Marcello Fois e Alberto Garlini nel dialogo su soggettività e scrittura creativa. In gioco oggi è anche il ruolo della famiglia e dei genitori, di cui parlerà lo psicanalista Massimo Ammaniti. Non mancherà la riflessione sulla violenza, da quella verbale che corre in Rete - esplorata da Giovanni Ziccardi e Fabio Chiusi - a quella mostrata dall’Isis, di cui dialogheranno Bruno Ballardini e Nicola Strizzolo.
Ma si parlerà anche di violenza esercitata sulle donne, con Chiara Volpato, Filippo Focardi e Igiaba Scego. Moltissimi saranno inoltre gli spettacoli, le mostre e i concerti: il programma completo del festival è disponibile sul sito www. vicinolontano. it
Il manifesto, 1 maggio 2016 (c.m.c.)
Chiara Saraceno, sociologa e autrice del libro Il lavoro non basta (Feltrinelli) ha raccontato di essere stata pagata con un voucher per una lezione. «Credevo di essere un’eccezione, ma ho scoperto di non essere l’unica tra chi fa ricerca – afferma – Non ho certo il profilo di chi lavora con i voucher. Quando è successo ero già in pensione. Il voucher non è solo una forma leggera di lavoro nero, ma è anche una forma di elusione fiscale non voluta dal lavoratore. Legalmente il denaro guadagnato con i voucher è esente da tasse e quindi è conveniente. Il dramma è che questo strumento è diventato la nuova frontiera del lavoro, non solo a tempo, ma precarissimo.
Non era stato pensato così all’epoca della riforma Biagi. Allora c’era la positiva intenzione di fare emergere il lavoro nero e assegnare un minimo di contributi ai lavoratori molto occasionali. Il caso classico è la studentessa che fa la baby sitter o chi fa il commesso fa il commesso nei negozi per poche ore. Oggi invece è diventato una forma per passare al nero al grigio. Al datore di lavoro può convenire pagare un po’ in voucher, un po’ in nero. Se in un cantiere c’è un incidente, può sempre dire che quel giorno l’incidentato lavorava con il voucher. Pensato per essere usato per picchi produttivi, questo buono viene usato per pagare normalmente”.
La tracciabilità dei voucher proposta dal governo contrasterà questo fenomeno?
Non credo. Con la tracciabilità si dovrà dichiarare in anticipo per chi e per quante ore è stato usato. Ma questo non esclude che poi ci sia il nero: che si dichiari cioè di avere pagato con voucher per duemila euro per un tot di numero di ore. Il lavoratore potrà essere costretto a lavorarne altrettanto in nero. È importante che si facciano più controlli. Il sindacato dovrebbe essere molto più attento. I voucheristi sono molto ricattabili. Se denunciano, nessuno li riassume.
Il voucher inaugura una nuova epoca del precariato?
La diffusione abnorme di questa forma di pagamento tutto sommato marginale è dovuta alla capacità dei datori di lavoro di sfruttare ogni possibilità dei contratti per fregare i lavoratori. Non vale per tutti naturalmente. Accadde lo stesso con i cocopro. Il progetto in questione è diventato il fine, e non la causa, per fare questi contratti. Risultato: esistono persone che hanno lavorato con un cocopro per anni. Soprattutto per lo Stato italiano. Oppure nei consultori dove si può avere lo psicologo solo se ci si inventa un progetto. Questo progetto serve a giustificare un lavoro di routine.
È passato del tempo dalla riforma dei contratti a termine, un aspetto non molto citato del Jobs Act. Qual è il bilancio?
È assolutamente contraddittorio rispetto al contratto a tutele crescenti. Un lavoratore può essere contrattualizzato a termine e rinnovato fino a cinque volte. Resterà sempre precario con il terrore che non sia rinnovato. Se è fortunato può avere un contratto a tutele crescenti dove continuerà a essere precario. Questo diventa un periodo di prova allungato smisuratamente fino a otto anni. Il lavoro diventa una corsa ad ostacoli, senza contare che è molto più facile licenziare oggi.
La maggioranza dell’occupazione prodotta è data dal rinnovo dei contratti e riguarda gli over 50. Come si spiega questo andamento?
Da anni tutti gli interventi sul lavoro insistono sul lato dell’offerta per rendere i lavoratori più flessibili e meno costosi. In italia abbiamo il problema opposto: quello della domanda di lavoro e imprese non competitive che non sono in grado di stare sul mercato internazionale e non investono su quello nazionale. I governi potranno tagliare il costo della forza-lavoro perché un’impresa assuma. Ma se non c’è una vera ripresa e le imprese non diventano più efficienti, questo non avverrà.
La politica del governo Renzi va in questa direzione?
Assolutamente no, Sostengono che dipende dal mercato e che la politica non c’entra nulla. Hanno erogato miliardi di incentivi alle imprese a fondo perduto, senza chiedere una contropartita in nuova occupazione.
Che cos’è il lavoro povero oggi?
Ci sono due tipi di lavoro povero. I voucheristi e chi prende un salario molto al di sotto del salario minimo sono lavoratori poveri su base individuale. Poi ci sono i lavoratori poveri su base familiare. L’Italia è uno dei paesi in cui questo fenomeno è più diffuso. La quota di famiglia monoreddito è molto elevata, non c’è sostegno all’occupazione femminile, in particolare per le donne con meno istruzione e carichi familiari pesanti, non esistono servizi né trasferimenti adeguati e universali per il costo dei figli. Dal sistema sono esclusi anche gli autonomi poveri e i disoccupati di lungo periodo. E pensare che i fondi del bonus sugli 80 euro potevano servire per una seria riforma. Solo con quelli del bonus bebé si poteva sottrarre dalla povertà un’ampia quota di famiglie.
Il presidente dell’Inps Tito Boeri sostiene che chi è nato negli anni Ottanta lavorerà fino a 75 anni e avrà una pensione minima. Che mondo ci aspetta?
Ho simpatia per Boeri e concordo con le sue paure. Mi preoccupa di più un’altra parte del suo discorso: il poco reddito che hanno i giovani oggi. È vero che non matureranno i contributi per la pensione, ma non hanno un reddito sufficiente per fare la loro vita oggi, per farsi una famiglia se vogliono. Se li mettessimo nelle condizioni di una vita decente, creando un orizzonte temporale per pensarsi e fare progetti, forse la situazione migliorerà. “. Se invece li costringiamo a inseguire spezzoni di lavoro e terrorizzandoli dicendo che non avranno una pensione, mi sembra che sprecheranno le loro energie. Mi preoccupa questo perché anch’io ho figli che hanno già questa carriera frammentata alle spalle. Oltre ai giovani ci sono anche i 40enni.
È sempre convinta che la soluzione sia il reddito minimo?
Sto diventando più radicale. Il lavoro buono per tutti non è dietro l’angolo, forse bisognerà cominciare a pensare a una garanzia di reddito di base universale che si può dare sotto forma di imposta negativa, una misura che in Italia non esiste ancora, si rende conto? Il reddito potrebbe essere uno degli strumenti per non essere ricattati e inventarsi cose che noi anziani non abbiamo ancora pensato. Per quanto riguarda le pensioni è chiaro che prima o poi si dovrà pensare a una pensione di base. È dalla riforma Dini del 1995 che si sa come sarebbe andata a finire la flessibilità. E’ stata fatta una riforma fordista mentre il mercato del lavoro cambiava in tutt’altro senso. Già allora si sapeva che una quota di persone non avrebbero mai maturato la storia contributiva per avere una pensione decente.
Perché non è stato fatto nulla da allora per rimediare?
La preoccupazione era di mettere in sicurezza il sistema senza pensare a cosa sarebbe successo dopo. Adesso è evidente, molto evidente. Non è proprio possibile pensare che un muratore, un camionista, una maestra lavorino fino a 75 anni. Sono fantasie. Le diseguaglianze iniziano ad affermarsi nelle speranze di vita: tanto più si lavorerà peggio, prima si morirà. Un tempo lavorare fino a 75 anni era considerato un privilegio. Nella mia generazione questo valeva per i professori universitari, i giudici, i vescovi o i medici. Non era un obbligo, anzi gli altri che andavano in pensione a 60 anni avrebbero voluto lavorare di più. È vero che la vita si è allungata, ma il corpo non è più la cosa che era prima. La resistenza fisica, e la lucidità si appannano. Dagli anni Settanta in poi, il rischio povertà tra gli anziani è andato diminuendo. Hanno iniziato a lavorare di più, ad avere storie contributive continuative, sono stati tutelati meglio dal sistema previdenziale che si è rafforzato in tutto il mondo. Oggi ci stiamo nuovamente avviando verso una condizione dove una quota di anziani sarà di nuovo a rischio povertà, mentre sta aumentando la povertà dei minori e delle famiglie con minori. Questo problema non lo si può risolvere restando più a lungo al lavoro. Con le carriere interrotte e i salari bassi nessuno riuscirà a farsi una pensione decente. E non riuscirà ad avere i fondi per una pensione integrativa. Ai voucheristi come si fa a dire di farsi una pensione integrativa, se non sono sicuri di avere un lavoro domani? Dovranno risparmiare per l’oggi e non avranno risorse da investire per il domani
 « ». Il manifesto,
« ». Il manifesto,
Il flop del Jobs Act del governo Renzi non è il semplice effetto di un obiettivo mancato. Il continuo maneggio di dati e cifre poi contraddette dai fatti, non serve a nascondere un fallimento inaspettato. Esso è funzionale a politiche di riduzione dei diritti del lavoro che, invece, si vogliono spacciare per provvedimenti innovativi e capaci di creare nuovo lavoro.
Il «contratto a tutele crescenti», perno del Jobs Act, si basa su una stridente contraddizione. Da un lato, lo Stato eroga contributi alle imprese perché stipulino contratti a tempo indeterminato, modificando quelli a termine già esistenti o per i neoassunti. Dall’altro, si ammette la libertà di licenziare i lavoratori in qualsiasi momento e con qualunque motivazione. Il che rappresenta il massimo della precarietà. Infatti, si sta verificando che i nuovi contratti crescono in misura strettamente dipendente dai contributi versati agli imprenditori, mentre continuano a crescere i lavori precari.
A cominciare da quelli part time (presenti anche nei nuovi contratti) fino al dilagare delle forme di massima precarietà come quella del ticket-lavoro, che nel primo bimestre di quest’anno è aumentata del 45% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (per un totale di 19,6 milioni di voucher). In realtà si tratta di una sostanziale subordinazione delle politiche del lavoro ai dettami del neoliberismo imperante. Ed ha ragione Renzi a dirsi erede di Blair o a sottolineare la connessione tra i suoi provvedimenti e quelli propugnati dalla commissione Hartz nella Germania di Schröder. Sono stati, infatti, proprio loro e gli altri becchini di quel che restava della socialdemocrazia europea a piegare le politiche del lavoro alle esigenze del neoliberismo imperante.
La svolta conservatrice è stata battezzata con l’ingannevole definizione di «politiche attive del lavoro». Tale definizione ricorre nelle controriforme del lavoro introdotte nei maggiori paesi europei dalla fine degli anni ’90 ad oggi.
La prima, varata da Blair nel 1998, si proponeva di ridurre i diritti dei lavoratori e le prestazioni di welfare ad essi connesse. Secondo lui, i cittadini dovevano uscire dalla «dipendenza e pigrizia» determinate dai provvedimenti di assistenza sociale e diventare responsabili del proprio destino ricercando attivamente un lavoro.
La motivazione era la stessa sostenuta dalla Thatcher e da Reagan. In realtà, i provvedimenti previsti avevano lo scopo di spingere i cittadini ad accettare un lavoro qualsiasi, anche pesante e malpagato. In questo modo si tagliavano drasticamente le spese sociali e si favoriva la competizione al ribasso nel mercato del lavoro. Lo stesso principio è stato adottato dalla commissione Hartz istituita in Germania nel 2002. Anche il governo del socialista Jospin in Francia, che, pure, è stato più avveduto nella revisione del sistema di welfare, si è conformato al paradigma delle «politiche attive del lavoro» promulgando, nel 2002, provvedimenti affatto simili a quelli adottati in Gran Bretagna e Germania.
In Italia, misure analoghe hanno trovato facile sponda nel liberismo populista dei governi Berlusconi. Né sono state efficacemente osteggiate dalle coalizioni di centro sinistra, peraltro caratterizzate da paralizzanti tensioni interne. Il sempre più accentuato spostamento dei rapporti di forza tra capitale e lavoro a vantaggio del primo, dovuto alle strategie economiche e politiche neoliberiste, ha trovato rispondenza in altri due obiettivi complementari al precedente e perseguiti con pari tenacia.
Il primo riguarda la sempre maggiore libertà di licenziamento accordata agli imprenditori e praticabile per semplice convenienza economica. In Gran Bretagna il terreno già arato in questo senso dai governi Thatcher e Major ha reso più agevole a Blair superare i vincoli normativi. In Germania, dove essi erano più rigidi, sono stati aggirati nella pratica e con la tolleranza del governo. In Francia e in Italia la resistenza sindacale è stata più tenace su questo punto, anche se gli imprenditori si sono valsi della più ampia e crescente flessibilità nelle norme e tipologie contrattuali, con la conseguente proliferazione delle forme di lavoro precario.
L’altro obiettivo riguarda l’incoraggiamento dato alla contrattazione aziendale rispetto a quella nazionale. Perseguito per prima da Margaret Thatcher, esso è stato riaffermato, in completa continuità, dal New Labour di Blair. Anche in questo caso l’intento è quello di indebolire la capacità contrattuale di lavoratori e sindacati. Peraltro, il perseguimento di tali obiettivi non è disgiungibile dalla parallela opera di decostruzione dello Stato sociale. Infatti, i provvedimenti citati sono stati regolarmente accompagnati, in tutti i paesi cui ci siamo riferiti, da drastici ridimensionamenti delle pensioni, da tempo sganciate dal reddito raggiunto in età lavorativa.
Parallelamente, sono stati fatti tagli sempre più impietosi ai sistemi sanitari. In questo e altri settori sono stati adottati criteri di gestione quasi-market, ovvero ancorati a budget prefissati. Le varie forme di assistenza sono state limitate ai «realmente bisognosi» sulla base di ristretti accertamenti dei mezzi. Mentre l’intero sistema è stato contrassegnato da privatizzazioni crescenti e da assicurazioni private, specie in ambito pensionistico e sanitario. Tutto ciò non ha fatto altro che ridurre il salario reale e con esso i margini di una sia pur minima redistribuzione della ricchezza. Sull’altro versante, invece, è stata costante la riduzione della tassazione sulle imprese e i redditi, con chiaro vantaggio dei più alti.
In questo quadro di generale contrazione delle politiche sociali, il perseguimento dei tre obiettivi principali che hanno caratterizzato la legislazione sul lavoro ha avuto effetti sociali sempre più pesanti. Ed essi hanno caratterizzato in modo, se possibile, ancor più determinato i provvedimenti successivi alla crisi del 2008. Oggi, le misure di Cameron, il Jobs Act di Renzi, come la Loi Travail proposta dal governo francese rappresentano una sorta di completamento di un lungo percorso che ha contribuito non poco all’aumento delle diseguaglianze sociali. Tuttavia, il nuovo indirizzo dato al Labour Party da Jeremy Corbyn e la forte resistenza che sta incontrando la legge proposta dal governo francese mostrano che cambiamenti di rotta sono possibili, oltre che necessari.
«». LaRepubblica, 1 maggio 2016 (c.m.c.)
La campagna elettorale per il referendum costituzionale, già cominciata da tempo, ha avuto una forte e prevedibile accelerazione dopo i risultati del referendum sulle trivelle. E dalle polemiche e dai conflitti di questi giorni già vengono indicazioni che consentono di avanzare ipotesi sui caratteri che assumerà la campagna elettorale e sugli effetti che via via si produrranno nel sistema politico-istituzionale.
Si deve partire da una constatazione. I referendum sono un gioco a somma zero, un sì contro un no, un vincitore e un vinto, e quindi il conflitto è nella loro stessa natura. Fatta questa ovvia constatazione, si tratta poi di stabilire per ciascun referendum come si strutturi concretamente il conflitto, con quali caratteristiche e intorno a che cosa. E, facendo questo, si scopre che i referendum possono incidere sul funzionamento del sistema politico al di là della conferma o dell’abrogazione di una legge. Più d’una volta, negli anni passati, si è ritenuto che un voto referendario potesse avere un effetto destabilizzante del sistema politico al punto tale che, pur di evitarlo, in alcuni casi si è preferito sciogliere le Camere.
Considerando le ultime vicende, i critici dell’utilità del voto sulle trivelle hanno insistito sul fatto che ben cinque dei sei quesiti predisposti dalle regioni avevano trovato una risposta positiva da parte del governo, sì che non valeva più la pena di andare a votare su un caso residuale. Valutazioni a parte su questo giudizio, questa vicenda mostra come una semplice richiesta referendaria possa modificare l’agenda politica, stabilire priorità. Inoltre, la mobilitazione sociale necessaria già al momento della raccolta delle firme può dare origine ad un vero e proprio movimento, a forme di intervento alle quali i cittadini ricorrono quando appaiono chiusi gli altri canali di partecipazione politica.
Questo sfaccettarsi delle funzioni del referendum diviene ancor più evidente se si considera l’imminente referendum costituzionale. All’abituale polarizzazione referendaria, infatti, si è questa volta aggiunta una chiara personalizzazione del voto perché, con l’annunciata decisione di dimettersi in caso di bocciatura della riforma, il presidente del Consiglio ha ormai trasformato l’occasione referendaria in un vero e proprio voto di fiducia.
Si può dire, ed è stato detto, che un governo, se attribuisce una particolare importanza ad alcuni suoi provvedimenti, ben può ritenere che la loro cancellazione impedisca la prosecuzione della sua azione, annunciando preventivamente ai cittadini questa sua intenzione. Ma questo referendum non riguarda l’indirizzo politico di maggioranza bensì, come è giusto dire, una massiccia riscrittura delle regole del gioco, con una modifica della forma di governo e del contesto democratico definito dalla Costituzione. Lo ha messo in evidenza efficacemente Romano Prodi, ricordando che «le riforme costituzionali debbono durare molto e non possono essere mirate solo all’interesse di chi possiede la maggioranza del momento».
Il riferimento ai soli interessi della maggioranza è, alla lettera, quello che si trova nelle pagine di Hans Kelsen dedicate alla virtù fondativa del «compromesso », dove si sottolinea che esso «fa parte della natura stessa della democrazia » e consiste, in primo luogo, nel risolvere «un conflitto mediante una norma che non è totalmente conforme agli interessi di una parte, né totalmente contraria agli interessi dell’altra». Chi ha memoria della nostra storia costituzionale, cosa ben diversa dai troppi richiami sgangherati ai lavori dell’Assemblea costituente fatti in questo periodo, ricorda che di un “compromesso costituzionale” si è molto parlato, anche con toni critici, ma in definitiva riconoscendo la saggezza politica dei costituenti che, attraverso un confronto serrato, erano giunti a sintesi assai elevate, garantendo l’alta qualità della Costituzione.
Si dice che bisogna discutere nel merito la riforma sottoposta al voto. Ma non vi è merito più importante e ineludibile della valutazione della logica che la ha guidata e di quale risultato, in termini di democrazia, sia stato raggiunto. È bene ricordare, allora, che nel corso dell’iter parlamentare, e in particolare in occasione delle audizioni di molti studiosi, proprio sul punto centrale della nuova disciplina del Senato vi erano state proposte assai circostanziate di modelli che avrebbero evitato non solo il pasticcio attuale, ma avrebbero consentito una soluzione davvero innovativa, con effetti di seria semplificazione e mantenimento di equilibri costituzionali che, soprattutto se si tiene conto dell’intreccio con la nuova legge elettorale, vengono invece pregiudicati. Il buon “compromesso democratico” è lontano, e di questo si dovrà discutere.
Ma il riferimento alla democrazia torna, in maniera ancor più impegnativa, quando si constata che siamo di fronte al passaggio da una democrazia rappresentativa ad una democrazia d’investitura, dunque ad un mutamento della forma di governo. Ancora una ineludibile questione di merito, se appena si considera che la sentenza della Corte costituzionale che ha cancellato il “Porcellum” è sostanzialmente fondata sulla constatazione che non veniva garantita proprio la rappresentanza dei cittadini. E questo non è tema che riguarda il passato, perché la Corte costituzionale dovrà occuparsi della legittimità dell’Italicum, contestata con argomenti che sottolineano come anche questa nuova legge elettorale sia viziata da un deficit di rappresentanza (e contro l’Italicum si stanno anche raccogliendo le firme per un referendum abrogativo).
Vero è che ad ottobre non si voterà sulla legge elettorale. Ma è evidente che la discussione investirà anche questo aspetto della strategia istituzionale del governo, come peraltro sta già avvenendo, perché la stessa riforma costituzionale evoca il tema del potere dei cittadini con le nuove norme sui referendum e sulla iniziativa legislativa popolare, in sé deboli e comunque inadeguate per costituire un contrappeso ad un accentramento del potere che mette la maggioranza nella condizione di poter vanificare le iniziative popolari (altra cosa è la democrazia partecipativa considerata anche nella dimensione digitale).
Giustificato con l’argomento della semplificazione delle procedure di decisione (realizzata invece in forme confuse e contraddittorie), il moto ascendente del potere, la sua concentrazione in poche mani pongono chiaramente una questione di democrazia, già evidente in alcune inquietanti prassi dell’attuale governo, o per meglio dire del presidente del Consiglio. Il giudizio degli elettori riguarderà inevitabilmente tutti questi aspetti della questione, che oggi si presenta con i tratti di una democrazia messa sotto tutela.
Diventa fondamentale, allora, il contesto nel quale si svolgerà la campagna elettorale. Uno storico come Emilio Gentile ha appena pubblicato un libro dal titolo “Il capo e la folla”, che riprende un tema trattato nel 1895 da Gustave Le Bon, analizzando “la psicologia delle folle”. La ricostruzione dei rapporti tra il leader e le masse, la personalizzazione del potere ci portano ai giorni nostri, che conoscono il pieno dispiegarsi di quella che Abramo Lincoln chiamò la “democrazia recitativa”. Varrà la pena di tornare su questo tema. Ma, considerando la campagna elettorale, bisognerà garantire subito che la “recita” non sia riservata ad un numero ristretto di personaggi. Questo chiama in causa particolarmente la televisione pubblica, ma implica una responsabilità dell’intero sistema informativo. Una questione di democrazia, che si aggiunge alle altre appena ricordate.

Articoli di Riccardo Chiari e Francesco Ditaranto
Il manifesto, 30aprile 2016
A PISA IL MANGANELLO DAY
di Riccardo Chiari
“Che strana questa brillante modernità renziana. Si parla tanto di internet e innovazione, poi si continua ad usare il vecchio manganello”. Il commento di Tommaso Fattori fotografa bene quanto accaduto per ore nel lungo viale che costeggia il Cnr, con le ripetute, violente cariche della celere ai danni di un corteo di protesta organizzato nell’Internet day. A Pisa era arrivata la ministra Giannini, ospite del Centro nazionale ricerche per una iniziativa in ricordo del primo collegamento internet partito qui trent’anni fa. Mentre Matteo Renzi, che pure era annunciato, era rimasto a Roma. In sua assenza, l’ospite d’onore della giornata è stato, appunto, il manganello.
Il corteo, autorizzato, era partito pochi minuti dopo le 10 da piazza XX Settembre. In testa gli studenti medi e universitari, e fra il migliaio abbondante di manifestanti il comitato locale “Vittime del salvabanche”, altri comitati cittadini come quello del popolare Quartiere Cep, delegati e simpatizzanti dei sindacati di base Usb e Cobas, e attivisti delle variegate realtà della sinistra pisana. “Vogliamo arrivare al Cnr – raccontavano i manifestanti – è un pezzo della nostra città e della nostra storia. Ci devono ascoltare”.In realtà tutta l’area intorno al Cnr era stata considerata come “zona rossa”, e naturalmente l’accesso al Centro era stato vietato a chiunque avesse, anche solo lontanamente, l’idea di contestare il governo. Intanto lungo il tragitto i manifestanti scandivano slogan ed esponevano striscioni, fra questi spiccava: “Non accettiamo che Renzi festeggi il paese dove 6 milioni di persone vivono nella povertà”.
Una volta arrivato alla rotonda fra via Luzzato e via Volpi, con alle spalle i giardini pubblici, il corteo è stato bloccato dalla celere in assetto antisommossa. “Andate ad arrestate il Pd campano – hanno reagito i manifestanti – non i lavoratori”. E dopo alcuni lanci di uova e ortaggi è bastato che un uomo si staccasse dal corteo, per spingere lo scudo di plexiglass di un agente, per far partire le prime cariche. Molto violente.
Grazie a internet, le immagini girate dagli smartphone dei manifestanti e dalle telecamere dei videoreporter sono andate in tempo reale in rete. Comprese quelle girate da un giovane videocronista del gruppo Espresso-Repubblica, manganellato al volto mentre stava riprendendo. “Sono state almeno tre cariche a freddo – riepilogava Sebastian Parenti del comitato Quartiere Cep a Rai News 24 – anche a gente anziana. Hanno colpito indistintamente tutti, mentre stavo alzando un ragazzo da terra mi sono venuti addosso in cinque e mi hanno trascinato via”.
Un altro manifestante segnalava l’assenza del presidente del consiglio: “Ha paura. Avrebbe dovuto essere qui in un evento che celebrava la rete, quando la rete è proprio il nemico giurato di Renzi, che scappa. Il ‘Ciaone’ degli esponenti del Pd lo rispediamo al mittente. Ciaone Renzi, che ormai non si presenta a interventi pubblici”. Nel mentre, con il corteo rimasto fermo nei giardini sempre fronteggiato da alcune decine di agenti, venivano curati alcuni ragazzi feriti alla testa dalle manganellate.
Nonostante il tentativo di accreditare ai manifestanti la responsabilità delle cariche, l’Associazione stampa toscana e il Gruppo cronisti toscani hanno denunciato: “Siamo consapevoli dei rischi, anche fisici, che si corrono seguendo gli avvenimenti di cronaca. Ma ci rivolgiamo anche alle forze dell’ordine, chiedendo quantomeno attenzione e tutela per chi si trova sul posto a svolgere la propria attività professionale”. Tira le somme Fattori, consigliere regionale di Toscana a Sinistra: “Dice Renzi che si tratta di scontri ‘incomprensibili’ e in effetti sono incomprensibili. Il fatto è che Renzi deve chiederne conto ai responsabili del disordine pubblico, dato che una ragione per manganellare i manifestanti proprio non c’era”.
NO AL CORTE DI LOTTA STUDENTESCA A MATERA
La notizia ha cominciato a circolare sui social network nei giorni scorsi, scatenando un’aspra polemica nella città lucana. In poche ore, è stata lanciata una petizione online per ottenere che la manifestazione fosse vietata. Per i cittadini che, a vario titolo, sotto l’insegna Matera Antifascista e non solo, stanno chiedendo di bloccare l’iniziativa, si tratta di un’intollerabile provocazione di matrice neo-fascista. Matera non è soltanto la capitale europea della cultura 2019, dunque una grandissima vetrina mediatica, ma rappresenta la prima testimonianza nel Mezzogiorno di sollevazione contro gli occupanti nazisti. Quella insurrezione, avvenuta il 21 settembre del ’43, valse alla città il conferimento della Medaglia d’Argento al Valore Militare. E come ogni anno, lo scorso 25 aprile, le autorità locali hanno ribadito quale fondamentale importanza abbia la Resistenza nella cultura democratica della città.
Eppure, nelle ore seguenti alla celebrazione ufficiale della Liberazione, si è consumato un corto circuito politico. La minoranza di centrosinistra ha presentato, in Consiglio Comunale, un ordine del giorno che stigmatizzava l’ipotesi di un corteo dell’estrema destra, e chiedeva al sindaco De Ruggieri di adoperarsi con le autorità competenti per scongiurare lo svolgimento di una manifestazione incompatibile con i valori della Festa dei Lavoratori. L’ordine del giorno, però, non è stato votato perché mancava il numero legale. Ma nella maggioranza (particolarmente composita per sensibilità e percorsi politici) c’è chi non ci sta.
I consiglieri che si richiamano a una tradizione di sinistra e sindacale, hanno ribadito nuovamente, nelle ultime ore, la necessità di dare priorità al valore del 1° maggio, quando in questione ci sono principi universalmente riconosciuti e costitutivi della democrazia repubblicana. Facile leggere, tra le righe, un invito, innanzitutto al sindaco, ad assumersi le sue responsabilità.
Dal primo cittadino, tuttavia, è giunta una risposta che appare vaga ai più, nella quale si conciliano i riferimenti all’importanza delle lotte dei lavoratori con quelli al diritto a manifestare come elemento imprescindibile della nostra Costituzione. Questo richiamo al diritto di esprimere le proprie opinioni, riferiscono quanti hanno partecipato giovedì a un sit-in sotto la Prefettura, ricevuti poi in delegazione proprio dal Prefetto, sarebbe all’origine della decisione di permettere lo svolgimento della sfilata, che si terrà abbastanza lontano dal centro città.
Antifascisti e sindacati celebreranno, invece, la Festa dei Lavoratori con un concerto in una piazza del centro storico. In un clima teso, questa mattina si dovrebbe tenere una seduta del Consiglio Comunale, che in molti sperano possa produrre, finalmente, una presa di posizione ufficiale alla vigilia della sfilata dell’estrema destra.
Riferimenti
Mario Scelba è stato Ministro dell'interno negli anni della più dura repressione delle lotte operaie e contadine. Una sintesi dell'attivita reazionaria ed anticostituzionali di Scelba è offerta da Wikipedia
LaRepubblica, 29 aprile 2016 (c.m.c.)
La prima leggendaria schedina della Sisal è datata 5 maggio 1946: nel 2016 ne ricorre il settantesimo anniversario. Nell’idea di un concorso a pronostici, l’Italia in macerie cercava di scommettere sul suo futuro, e al tempo stesso raccoglieva fondi per rimettersi in piedi. Agli albori della sua storia, la schedina conteneva sul retro un riquadro sul quale scrivere i propri dati, e fra essi compariva immancabile la dicitura “professione”. Sappiamo così che il signor Pietro Aleotti da Treviso, vincitore di 64 milioni nella primavera del 1947, era artigiano del legno (pare costruisse bare).
E così, fra i più famosi vincitori, Giovanni Mannu era un minatore sardo, Giovanni Cappello un ferroviere, mentre il fortunato che nel 1977 superò l’asticella favolosa del miliardo era un semplice impiegato. Ma come investivano i soldi della vincita questi invidiatissimi italiani? Credo che la risposta possa darci da riflettere. Fino almeno a tutti gli anni Settanta, la domanda «che cosa farebbe se vincesse un miliardo? » vedeva concordare gli intervistati su poche risposte eguali: la maggioranza «si metterebbe in proprio», «cambierebbe lavoro», oppure «aprirebbe un’attività».
Significa che per alcune decine di anni la gran parte degli italiani ha escluso di volersi astenere da un’attività lavorativa, anche nel remoto caso di trovarsi all’improvviso milionaria. Il mestiere – scritto sul retro della schedina stessa, come un sigillo da cui non prescindere – era insomma un crisma comunque inscalfibile, un momento essenziale per l’essere sociale di un cittadino, tanto più in un’Italia costituzionalmente fondata sul lavoro, dove la quasi maggioranza, nel segreto del voto, metteva la sua ics su una falce e su un martello.
Oggi i nostri Gratta e vinci, eredi morali e sostanziali del Totocalcio, portano perfino nei titoli un sapore radicalmente diverso come “Turista per sempre”, “Caraibi”, “Pazzi per lo shopping”. Davanti a quell’antica religione del lavoro, sembra quasi una bestemmia. E se rivolgiamo ai nostri contemporanei la stessa domanda di quel vecchio sondaggio, è incredibile come sia spazzato via ogni riferimento al mondo del lavoro: la prima aspirazione di una megavincita oggi è proprio il licenziarsi, prologo al successivo «vivere di rendita », «viaggiare», «comprare immobili », e via dicendo.
Quella che un tempo sarebbe stata ragione di scomunica (ecclesiastica, certo, ma anche sociale), oggi è un’ambizione collettiva. Percepita come sinonimo ora di «sforzo inutile», ora di «ingiustizia sociale», ora di «mal digerita sottomissione», ora di «confronto impari con la tecnica», la parola «lavoro» porta su di sé tutti i graffi di un’epoca confusa. Idolatrato dai nostri nonni e castamente amato dai nostri padri, oggi il lavoro ha finito da tempo di essere un luogo di aspettative o di conferme, caricandosi di tutte le possibili inquietudini di una suprema incognita.
Lontana anni luce l’oasi di un mestiere sicuro, e svanito l’approdo assolato del posto fisso, l’occupazione è diventata essa stessa un miraggio, indipendentemente dal suo essere organica a un progetto di vita. E se la percentuale di adolescenti che indicano un “mestiere dei sogni” va rapidamente crollando, ancora più illuminante è la quantità di loro che aspirano a carriere da calciatori o da veline, entrambi concepiti come emblema di arricchimento facile e di immediata riconoscibilità pubblica.
E siamo giunti con questo al paradosso che in una Repubblica costituzionalmente «fondata sul lavoro », assistiamo a una contrapposizione fra il lavoro stesso e i diritti del lavoratore, in molti casi considerati ormai accessori: si preferisce semmai lavorare senza sicurezza e senza prevenzione pur di non restare a casa. La regressione civile che questo ingenera è quanto mai evidente, cosicché il lavoro non solo non redime più l’uomo, ma di fatto lo getta in una spietata plaza de toros, in cui si festeggia chi sopravvive.
L’ultimo caso che io ricordi è quello di una cava vicino Palermo, dove un dipendente appena licenziato ha ucciso il proprietario e il capocantiere, spiegando il gesto con un laconico «Mi hanno tolto il lavoro», frase che suonerebbe paradossale se non ci chiedessimo subito «Quale lavoro gli hanno tolto?». E la risposta, evidentemente, è che non si tratta di difendere un lavoro, ma uno stipendio. La novità è che in tempi di crisi si è disposti a uccidere per non perderlo. Ecco allora che il risultato è clamoroso: il lavoro, pietra miliare di ogni società organizzata, diviene per noi il motore scatenante di una riemersa paura ancestrale, il terrore di essere sopraffatti dai nostri simili. Leggendo i media è infatti evidente come oggi il lavoro crei spesso divisioni frontali: giovani contro anziani, autoctoni contro immigrati, precari contro stabilizzati.
La ricerca di un lavoro è divenuta competizione per la sopravvivenza, con le implicazioni drammatiche che ciò comporta. Ed è inquietante – ma paradigmatica – la situazione dell’Ilva di Taranto, difesa a oltranza da folle di lavoratori, all’insegna del motto «Uccide, certo, ma ci dà da vivere». Figlia di un momento storico rimasto senza bussola, la parola “lavoro” rimbalza sulle nostre bocche come farebbe lo sporadico frammento di un ricordo dentro una generale amnesia. Sentiamo che aveva un senso, che rappresentava molto di più di ciò che noi oggi le attribuiamo. Forse percepiamo perfino un vago sentore di origini preziose, e intuiamo un brillare lontano. Ma è solo l’eco di un discorso andato. Forse un giorno, richiudendo l’ombrello dopo la lunga pioggia, ne riannoderemo fra le pozzanghere il senso.
 ». LaRepubblica, 29 aprile 2016 (c.m.c.)
». LaRepubblica, 29 aprile 2016 (c.m.c.)
La svolta arriva nella notte. Quando Silvio Berlusconi, sbarcato a Roma per cercare di sedare l’ennesima rivolta interna a Forza Italia, convoca Guido Bertolaso a palazzo Grazioli per comunicargli il suo fine corsa. Troppe le gaffe, disastrosi i sondaggi: tutti concordi nel condannare gli azzurri a morte certa, nella capitale e non solo. Continuare a insistere sull’ex capo della Protezione civile sarebbe stato un suicidio. Mr emergenze prova a resistere, in fondo gli era già accaduto di incontrare “Silvio” per valutare il ritiro, ma quando capisce che è tutto inutile, pone un’unica condizione: che almeno si viri su Alfio Marchini, mai sulla “traditrice” Meloni. Esattamente ciò che l’ex Cavaliere voleva.
E così di buon mattino Berlusconi si predispone al suo ultimo colpo di scena. Prima convoca l’imprenditore del cuore, il simbolo della sua lista; con lui sigla l’intesa; insieme chiamano Storace per chiedergli di essere della partita; quindi, a cose fatte, riunisce i maggiorenti azzurri. Facendo diramare una nota in cui si spiega che «per vincere occorre una proposta unitaria delle forze moderate e liberali, con un forte spirito civico», per cui «con il dottor Bertolaso abbiamo deciso di fare nostra la candidatura dell’ingegner Alfio Marchini», che tra l’altro «non è una scelta nuova. Era la nostra prima opzione, caduta per i veti posti da un alleato della coalizione».
Parole chiare, che rendono l’onore delle armi all’uomo rimasto stritolato nella guerra fratricida in atto nel centrodestra (malinconico il twitt diffuso in serata, con foto di lui in Africa: «Resto in panchina ma a disposizione della mia città»); ricompattano una Fi sull’orlo della scissione; rilanciano il sogno di un grande centro che metta all’angolo l’ala lepenista di Meloni e Salvini. E infatti, come per incanto, la polifonia azzurra diventa coro. Intonato da Paolo Romani, capo della fronda del Nord: «Berlusconi si conferma leader e guida dell’intero centrodestra». Finanche Gianfranco Fini si complimenta per «aver reso possibile a Roma un‘alternativa alla sinistra che non sia né populista né demagogica».
Chi non la prende bene è Giorgia Meloni: «Fi sceglie di convergere sul candidato di Alfano, Casini e di quell’ex centrodestra che ama governare con Renzi. Vogliono aiutare il Pd ad arrivare al ballottaggio nella città in cui il premier è più in difficoltà. È il pattone del Nazareno ». A risponderle ci pensa Storace, pure lui in procinto di sostenere Marchini: «Ora ritirati e riuniamo la coalizione come a Milano. Altrimenti sei tu che aiuti Renzi». A godere è il candidato dem Roberto Giachetti: «Io non temo nessuno, sono consapevole della mia forza».
«». LaRepubblica, 29 aprile 2016 (c.m.c.)
In principio fu una manciata di volantini gettati sul volto dei poliziotti, in via Frascati a Prato. Gli autori di quel gesto provocatorio, due giovani operai tessili, avevano un’unica finalità: essere denunciati per aver infranto una legge del codice penale fascista, l’articolo 113 che vietata il volantinaggio senza autorizzazione. Era il dicembre del 1955. Il pretore di Prato, un siciliano trentacinquenne molto combattivo, non aspettava altro che trovarsi davanti i due imputati, Enzo Catani e Sergio Masi, per chiedere il pronunciamento della neonata Corte Costituzionale: poteva ancora valere, in un regime democratico, quella vecchia legge varata dal fascismo? Avvocati dei due operai, Giuliano Vassalli, Vezio Crisafulli e Massimo Severo Giannini, ossia il meglio della cultura giuridica del dopoguerra. Il nome del procuratore? Antonino Caponnetto.
Molti anni dopo, in occasione del sessantesimo anniversario della Corte Costituzionale - l’organo di garanzia che giudica la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti di Stato e Regioni lo storico Maurizio Fioravanti rivela un capitolo poco noto: la prima seduta pubblica della Consulta, il 23 aprile del 1956, riguardò un episodio sapientemente organizzato da un gruppo di giuristi per dare avvio allo smantellamento della legislazione fascista. Perché allora era in gioco non soltanto la costituzionalità di quell’articolo 113, che certo limitava la libertà di opinione. Ma era in gioco una questione molto più importante, ossia la facoltà della Consulta di giudicare le leggi varate del regime di Mussolini.
E fu quella prima storica sentenza — su richiesta di Caponnetto — a dare inizio alla demolizione dell’impalcatura giuridica del fascismo.La Consulta e la vita degli italiani. Basterebbe il principio della storia per illuminare il rapporto profondo tra la Corte e i diritti dei cittadini nei campi più diversi dell’esistenza, nelle relazioni sentimentali come nella fecondazione assistita, nel sostegno ai disabili e negli assegni di invalidità riconosciuti anche agli immigrati, nelle abitudini quotidiane che riguardano l’autovelox o la casa. Le sentenze di questi ultimi quattro decenni hanno anticipato o assecondato i movimenti della società italiana, talvolta svolgendo un ruolo di supplenza rispetto al legislatore. Però questo fondamentale ruolo pubblico viene largamente ignorato.
Da queste premesse è partito Giuliano Amato per promuovere un incontro con Mario Calabresi, Luciano Fontana e Alessandro Barbano — direttori di Repubblica, Corriere della Sera e Mattino — insieme alla presidente della Rai Monica Maggioni. Come fare per comunicare di più e meglio con l’opinione pubblica? Dai direttori dei quotidiani è arrivato un suggerimento: per far crescere la percezione della Corte sono necessarie chiarezza, trasparenza e tempestività. «Potrebbe essere utile l’analogia con la Corte suprema americana », ha suggerito Mario Calabresi. «Pur nella diversità del ruolo, i pronunciamenti delle due corti investono direttamente la vita dei cittadini. Negli Stati Uniti le decisioni vengono precedute da un dibattito tra giuristi e studiosi che crea una grande aspettativa. E il calendario degli appuntamenti decisivi viene pubblicizzato con cura.
Da noi si fa più fatica a stare dietro alle sentenze: spesso arrivano tardi rispetto ai tempi di chiusura del giornale. E l’eccesso di tecnicalità non aiuta: la corte dovrebbe avere la pazienza di spiegare in tre punti chiari la sostanza dei propri pronunciamenti». Luciano Fontana insiste sulla trasparenza dei meccanismi di decisione: «Sarebbe importante conoscere le varie posizioni e anche le ragioni dei dissenzienti».
L’altro grande tema che attraversa la discussione è il rapporto tra Corte Costituzionale e politica, avendo spesso la Consulta esercitato “un ruolo di correzione “ rispetto al legislatore carente. L’elenco delle sentenze anticipatrici è sterminato, molte riguardano i diritti delle donne e degli omosessuali. Alcune vengono ricordate dalla Maggioni, dal riconoscimento della «natura discriminatoria della punizione del solo adulterio femminile» (1968) alla «illegittimità della sanzione penale prevista per il medico che procura aborto a una donna consenziente» (1975).
Risalgono agli anni Ottanta le sentenze sui diritti dei conviventi, di fatto equiparati a quelli dei coniugi. Ed è stata sempre la Corte nel 2010 a riconoscere alle unioni gay «il diritto di vivere una condizione di coppia, con connessi diritti e doveri» (ma non il matrimonio). E infine la legge 40 sulla fecondazione assistita: la Consulta ne ha eliminato le misure più restrittive, aprendo all’eterologa e sopprimendo il limite di tre embrioni. «È questo un caso in cui non c’è stata discussione», ha commentato Amato. «O, come avrebbe detto Crisafulli, la decisione era “a rime obbligate”». Nessun dubbio, in sostanza: come quella prima storica sentenza di sessant’anni fa.
 Esistono muri che non sono fatti di mattoni o filo spinato. «Berlino anticipa Londra: lavoratori dell’Ue discriminati».
Esistono muri che non sono fatti di mattoni o filo spinato. «Berlino anticipa Londra: lavoratori dell’Ue discriminati».
Il Fatto Quotidiano, 29 aprile 2016 (p.d.)
La porta aperta dalla trattativa tra Gran Bretagna e Unione Europea è stata imboccata per prima dalla Germania: i lavoratori comunitari, infatti, saranno discriminati rispetto ai colleghi tedeschi nell’accesso ai sussidi sociali. La ministro del Lavoro Andrea Nahles - che, per quanto vale, è socialdemocratica, il lato sinistro della Grande Coalizione - ha annunciato ieri che in tempi brevi porterà in Consiglio dei ministri una proposta sul tema: “Lo avevamo annunciato a dicembre”, ha spiegato, per colmare “le lacune interpretative” sull’accesso agli aiuti dello Stato nati dalla sentenza di una Corte sociale federale. I giudici, infatti, avevano stabilito che i cittadini dell’Unione che cercano lavoro in Germania possono accedere ai sussidi (ma non a quello di disoccupazione) dopo sei mesi di permanenza nel Paese: la sentenza aveva preoccupato assai le istituzioni locali, Comuni in testa, che temevano per la tenuta dei loro bilanci. Niente paura: interviene il governo, che fa pure un passo più in là.
In futuro, secondo il progetto del ministro Nahles, i cittadini comunitari saranno esclusi dalle prestazioni garantite dal cosiddetto pacchetto “Harz-IV”- le riforme del lavoro approvate dai governi Schroeder e Merkel - che include peraltro il sussidio di disoccupazione. Niente aiuti sociali poi (supporto per l’affitto, l’asilo dei figli e quant’altro) se non hanno un lavoro in Germania e non hanno maturato il diritto all’assicurazione sociale, che si acquisisce dopo 5 anni di lavoro senza aiuti dallo Stato. La cosa non è senza effetti in particolare nel sistema tedesco: il pacchetto di “aiuti” contenuto nel pacchetto Hartz, infatti, serve a controbilanciare gli effetti di una riforma del lavoro particolarmente penalizzante per i lavoratori.
Si rivolge, in particolare, ai cosiddetti mini-jobber, persone che pur lavorando - e costando quasi nulla in tasse alle imprese - non possono mettere in tasca 900 euro al mese: l’impresa può così abbassare il costo del lavoro, ma il dipendente rischia di fare la fame, soprattutto perché questo genere di mini-lavori sono spesso discontinui. E qui arrivano i sussidi: non solo quello di disoccupazione (equivalente alla nostra Naspi e che vale 391 euro al mese), a anche il sostegno alle spese di affitto, per i figli o i famliari a carico, eccetera fino a colmare la distanza col reddito considerato minimo (un po’meno di 1.500 euro). Può sembrare un’ottima cosa, ma questo sistema è in sostanza un enorme aiuto di Stato alle imprese (per abbassare il costo del lavoro) mascherato da welfare.
I benefici concessi ai lavoratori comunitari nel progetto Nahles, alla fine, sono condizionati a durata e resistenza nel mercato del lavoro tedesco e a una sorta di primo soccorso: un sostegno all’arrivo, che non potrà superare le quattro settimane, per coprire vitto e alloggio. Porte a perte per chi se ne vuole andare: un prestito per quelli che vogliono tornare nei Paesi d’origine.
La platea interessata non è affatto piccola. Secondo l’Agenzia federale del lavoro, riportava ieri l’A ns a, sono 440.000 i cittadini dell’Unione europea che ricevono al momento in Germania prestazioni sociali dallo Stato (su un totale di sei milioni di percettori): in numeri assoluti, il gruppo più esteso è costituito dai polacchi (92.000) seguiti da italiani (71.000), bulgari (70.000), rumeni (57.000) e greci (46.000). In termini percentuali, rispetto alle presenze in Germania, ai primi posti ci sono bulgari e rumeni.
L’idea del governo tedesco è di bloccare quei migranti interni all’Unione europea che si muovono - ha sostenuto la ministro tedesca - solo per beneficiare del welfare tedesco: questa pratica va fermata, disse, per salvare il sistema. Se il progetto è questo, però, si va parecchio più in là del tentativo di fermare “l’emigrazione del sussidio”e si introduce una discriminazione piena tra lavoratori tedeschi e lavoratori di altri stati Ue: il significato dell’Unione europea come viene raccontata - fratellanza, solidarietà, etc - corrisponde sempre meno al suo effettivo dispiegarsi nella vita dei suoi cittadini.
 ». Il manifesto, 28aprile 2016 (c.m.c.)
». Il manifesto, 28aprile 2016 (c.m.c.)
Ci risiamo, per l’ennesima volta. La Grecia stretta in un angolo, con le richieste dei falchi – ad iniziare dall’Fmi e da Schauble – che non si accontentano e chiedono continuamente tagli, in un eterno presente che pare impossibile lasciarsi alle spalle. Nel ben noto gioco di ruoli, questa volta la parte del cattivo la sta giocando il Fondo monetario internazionale, che richiede l’approvazione, da parte del parlamento greco, di misure preventive per un ammontare di 3,6 miliardi di euro. Dovrebbero entrare in vigore nel caso i tagli accettati sinora da Atene si dovessero dimostrare troppo «buoni», non abbastanza efficaci.
E ovviamente si sono subito posti due problemi, uno di natura formale ed uno assolutamente pratico. Da una parte, la legislazione ellenica non prevede che il parlamento possa legiferare su misure «eventualmente applicabili in futuro», ma solo su questioni di natura certa. Anche perché, rispetto alle clausole di salvaguardia italiane c’è una sostanziale differenza: nel caso del governo Tsipras, non gli si permette di includere le misure «di garanzia» all’interno di una finanziaria, ma si chiede una legge ad hoc.
In più, dal punto di vista dei cittadini, tartassati da cinque anni di austerità senza limiti, queste nuove misure richieste dal Fondo monetario – se dovessero venire applicate – porterebbero a nuovi tagli di stipendi e pensioni per una percentuale intorno all’8% del loro ammontare totale, e all’ulteriore innalzamento delle aliquote Iva. Obbligando a chiudere, per esempio, anche le case editrici che finora erano riuscite, tra mille sacrifici, a resistere alla crisi. Il governo di Syriza propone un meccanismo che controbilanci automaticamente eventuali minori introiti per le casse dello Stato, ma chiede di salvaguardare le classi sociali più deboli e di non dover presentare in parlamento, ovviamente, la legge richiesta dai creditori.
Il premier Alexis Tsipras, constatato che le trattative con i creditori si sono arenate, ha chiesto la convocazione di un vertice europeo straordinario per discutere della situazione e riuscire a trovare una via d’uscita politica. La decisione definitiva al riguardo dovrebbe essere presa oggi, ma la posizione del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, non sembra delle più incoraggianti: i suoi collaboratori hanno lasciato trapelare che la soluzione deve essere trovata solo ed esclusivamente all’interno dell’Eurogruppo. Quello in programma per oggi, ovviamente, è stato annullato e l’ulteriore perdita di tempo può andare solo a discapito della Grecia.
Il presidente del gruppo dei socialisti e democratici all’Europarlamento, Gianni Pittella, si è schierato apertamente a favore di Atene, chiedendo di non strangolare la Grecia, e di non chiederle di adottare misure supplementari. Lo stesso Juncker, secondo la stampa greca, parlando al collegio dei Commissari, sembra aver definito irragionevoli e anticostituzionali le misure ex ante, richieste alla Grecia.
Pare essere una prima presa di posizione contro l’asse del rigore assoluto, quella costruita da Berlino e dall’Fmi con sede a Washington. Ma è chiaro che a questo punto sono più che necessari degli interventi chiari, di sostegno energico e visibile, sia da Parigi che da Roma, se si vuole sperare ancora che qualcosa possa cambiare. Altrimenti, entro fine maggio Atene potrebbe avere nuovamente problemi di liquidità e il pagamento di pensioni e stipendi sarebbe ancora una volta a rischio, come avvenne nel giugno del 2015.
Non bisogna essere particolarmente malevoli per ricordare che proprio poche settimane fa, WikiLeaks aveva diffuso il contenuto di una lunga teleconferenza tra Poul Thomsen, a capo del dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, la rigidissima Delia Velculescu – che lo rappresenta ai colloqui con il governo greco – e un’altra responsabile dell’Fmi. Nel colloquio in questione si faceva chiaramente riferimento alla possibilità di portare nuovamente il paese al collasso economico, viste anche le resistenze del governo di Syriza ad accettare i diktat neoliberistici.
Tutto ciò, in un paese che continua ad ospitare più di 50.000 migranti e profughi arrivati negli ultimi mesi, sopportando un peso pratico ed economico enorme. E che malgrado le difficoltà non ha chiuso le proprie frontiere, come ha fatto, invece, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e sta minacciando di fare, ora, anche l’Austria. Atene spera che si esca dall’impasse, per arrivare alla conclusione della trattativa e passare, così, alla delicatissima fase che dovrà riguardare l’alleggerimento del debito pubblico greco. Più i giorni e le settimane passano a vuoto, e più l’economia greca non riuscirà a riprendersi, con il solito circolo vizioso: consumi al minimo, alta disoccupazione, minori entrate per lo Stato e richiesta di ulteriori tagli dai creditori.
I falchi del rigore sembrano non aver imparato assolutamente nulla in tutti questi anni. E forse non hanno neanche capito la cosa più importante: che in Grecia, per loro, non ci sono comode alternative politiche. Un eventuale governo conservatore, o anche di larghe intese, non riuscirebbe mai a portare avanti i nuovi piani lacrime e sangue voluti da Fmi e ultraliberisti.
 «Gli attacchi ai giudici sono elementi costitutivi di una riscrittura della democrazia che vuole accentrare i poteri nell’esecutivo».
«Gli attacchi ai giudici sono elementi costitutivi di una riscrittura della democrazia che vuole accentrare i poteri nell’esecutivo».
Il Fatto Quotidiano, 27 aprile 2016 (p.d.)
Non c’è nulla di stupefacente nell’attacco che ancora una volta viene lanciato, dal governo e da un gran numero di politici, alla magistratura italiana e in particolare alle parole di Piercamillo Davigo. Né il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati dovrebbe preoccuparsene oltre misura: il suo compito è di rappresentare il potere giudiziario, quindi di dare a tale rappresentanza una voce, che per forza di cose non si esprime solo nelle sentenze.
Non c'è nulla di stupefacente perché l’invettiva del presidente del Consiglio contro “25 anni di autentica barbarie legata al giustizialismo”, così come l’appello dell’ex presidente Napolitano a una riforma delle intercettazioni e a una “cooperazione” tra giustizia e politica che metta fine a presenti e passati conflitti, non sono affermazioni che cadono dal cielo. Sono gli elementi costitutivi di una riscrittura della democrazia costituzionale che sta avvenendo in numerosi Stati dell’Unione europea, che in Italia è perseguita da decenni e che non si limita a circoscrivere e svuotare l’indipendenza del potere giudiziario. L’obiettivo che si persegue,in questi Stati e nelle stesse istituzioni europee, è di accentrare i poteri nell’esecutivo e di declassare ogni potere suscettibile di frenare l’estensione dell’autorità centrale. Di qui il depotenziamento più o meno subdolo dei poteri giudiziari, di quelli parlamentari, e al tempo stesso di una serie di organi intermedi: sindacati, partiti, organizzazioni imprenditoriali e professionali, enti locali sovracomunali come le province.
Giuseppe de Rita ha descritto molto bene quel che si vuole ottenere attraverso simili esautoramenti con leggi e riforme costituzionali: “I politici, che hanno voluto la disintermediazione, si trovano circondati, premuti, circuiti, qualche volta addirittura ricattati, da gruppetti (da ‘quartierini’) di un avventuroso lobbismo” (Corriere dellaSera, 14.4.16).Le istituzioni europee tendono a favorire quest’accentramento e questa disintermediazione anche a livello comunitario. Nella famosa lettera cheTrichet eDraghi spedirono al governo italiano nel 2011, non si esitò ad attribuire alla Bce un compito costituente che nessuno le ha mai conferito e si chiese proprio questo: una riforma costituzionale he iscrivesse il Fiscal Compact nella nostra Carta e “abolisse o fondesse alcuni strati amministrativi intermedi come le Province”.
Non a caso Jürgen Habermas denuncia il degrado democratico dell’Unione europea, dandogli il nome di “federalismo degli esecutivi”.
Parlare di conflitto giustizia-politica fa dunque tutt’uno con il referendum sulla riforma costituzionale, con la diminuita rappresentanza locale del futuro Senato e con la più generale offensiva contro gli organi intermedi della società. L’oscuro oggetto del disgusto provato da molti politici non è il conflitto, da abolire in nome della “cooperazione”, ma la dialettica stessa tra i poteri e la loro netta separazione. È il motivo per cui mi preoccuperei anch’io,come Davigo, se tale conflitto non esistesse. Non mi stupisce nemmeno che le sue parole siano manipolate e deturpate, in modo tale che i cittadini possano meglio confondersi quando lo sentono parlare e non comprendere i suoi argomenti. Si dice ad esempio che il presidente dell’Anm ha denunciato i politici corrotti per poi “frenare”e far marcia indietro: cosa palesemente falsa, perché ovviamente le sue parole erano rivolte ai “politici che rubano”. Se avesse voluto accusare tutti, anche i politici onesti,davvero non ci sarebbe più bisogno d’indagini e processi.
Indagini e processi sono utili proprio perché mostrano che esiste una differenza tra chi ruba e chi no. In un certo senso, si fa giustizia per proteggere l’innocenza. Idem per gli altri argomenti discussi in questi giorni:tra cui le intercettazioni e la presunzione di innocenza.
Intercettazioni. Dovrebbe essere noto a chi governa e a chi riforma la giustizia italiana che esiste una vasta giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo in difesa della libertà di stampa, e che il giornalista ha il diritto di pubblicare notizie se le ritiene non solo penalmente, ma anche moralmente rilevanti. Il dibattito italiano è inoltre incredibilmente vecchio in materia. Si accusa continuamente il “circo mediatico-giudiziario", fingendo di ignorare fenomeni come quelli dei whistle blower (ostinatamente chiamati talpe o spie sui nostri giornali) o di Wikileaks. A ciò si aggiunga che in Italia già esistono norme sulla diffamazione e la violazione della privacy.
Presunzione d’innocenza.Viene continuamente e giustamente invocata, ma nell’esclusiva speranza che il politico condannato in primo grado sia prosciolto nel secondo o nel terzo, magari tramite la prescrizione. I tre gradi di giudizio sono un’anomalia tutta italiana, che naturalmente facilita le prescrizioni facili. Il politico condannato in primo grado dovrebbe lasciare le cariche che ricopre sin da quando è sospettato di non adempiere le funzioni pubbliche con disciplina e onore (art. 54 della Costituzione). Tantopiù deve farlo se condannato in primo grado.
Se così stanno le cose, sarebbe l’ora di rivolgere l’accusa di giustizialismo ad altri soggetti, sempre che si abbia a cuore l’uso della logica nell’informazione dei cittadini. I veri “giustizialisti” sono i politici specializzati nel lamentare il conflitto con la giustizia. Sono loro a far dipendere le proprie carriere, le proprie cariche, il proprio potere da tutti e tre i gradi di giudizio. Sono loro ad affidare ai magistrati e alle sentenze la selezione delle classi dirigenti. Non sarebbe male se ci spiegassero come mai, a questo punto, se ne dolgano tanto.
. Il manifesto, 27 aprile 2016
È sicuro ormai che l’Europa è solo all’inizio di un processo di decomposizione politica. I segnali si moltiplicano. La vittoria dell’estrema destra in Austria, la crisi polacca, il regime di Orbán, l’affermazione dell’AdP in Germania, la chiusura delle frontiere, il referendum sul Brexit. Ma il voto con cui la Camera dei comuni inglese ha rifiutato di accogliere i 3000 bambini di Calais è qualcosa di molto più profondo e sinistro di una crisi politica continentale. È, come hanno notato i critici della decisione, di qualcosa di vergognoso.
Perché in gioco, oltre al destino migliaia di orfani, c’è un confine che le cosiddette democrazie occidentali non dovrebbero, almeno ufficialmente, varcare: il senso minimo di umanità, quello che per gli apologeti distinguerebbe la «civile» Europa dagli altri mondi.
Oddio, anche sequestrare beni ai profughi, come fanno la Danimarca e altri stati della Ue, è vergognoso, proprio come lasciarli alla deriva a Idomeni e Lesbo, o dare un po’di quattrini a Erdogan perché non ce ne mandi altri. Ma i bambini non dovrebbero essere sacri, nell’Europa cristiana, cattolica, anglicana o luterana che sia? Con il voto alla Camera dei comuni, la risposta è stata semplicemente «No!» D’altra parte, i leader della Afd tedesca non hanno forse dichiarato che è legittimo sparare ai profughi che attraversano illegalmente i confini, anche quando sono donne e bambini? Certo, i conservatori inglesi a parole non arrivano a tanto. Ma il risultato non è molto diverso.
Che fine faranno i bambini che il socialista Hollande fa marcire a Calais, tra assalti xenofobi e manganellate? Nessuno lo sa e a nessuno interessa.
La motivazione del voto inglese è sublime nella sua ipocrisia squisitamente british. Noi non li accogliamo, per dissuadere altri profughi dal chiedere asilo in Inghilterra. Con la stessa scusa, le navi militari inglesi non soccorrono più la carrette del mare dei migranti nel Mediterraneo. Ora, immaginiamo dei bambini che scampano alla morte in Siria e poi ai naufragi nell’Egeo o nel canale di Sicilia. Ebbene, qualcuno pensa che si faranno dissuadere dal passare in Europa, e magari dal raggiungere dei parenti in Inghilterra, pensando al voto della Camera dei comuni? Quando la Svizzera respinse i profughi ebrei che scappavano dalla Germania con la motivazione che «la barca piena», si macchiò della stessa vergogna, ma con meno ipocrisia.
Noi europei, dopo la Shoah, non dovremmo sorprenderci più di nulla. E nemmeno pensare che, con la sconfitta del nazismo e del fascismo, siamo al sicuro dagli stermini di massa. Migranti e profughi muoiono a migliaia per raggiungere le nostre terre benedette dalla ricchezza.
Dopo un po’ di lacrimucce sui bambini annegati sulle spiagge greche e turche, ecco che prendiamo a calci quelli che non sono annegati, o semplicemente ne ignoriamo l’esistenza. Noi europei, così civili e democratici, stiamo gettando le premesse di nuovi stermini, magari per omissione, disattenzione o idiozia. Ma per le vittime non fa nessuna differenza.
Il manifesto, 26aprile 2016 (c.m.c.)
La memoria – diceva Primo Levi – è sempre a rischio. Anche questo 25 aprile l’ha confermato: neppure un accenno alla pur fondamentale ricorrenza su la Repubblica di ieri; milioni di austriaci – per i quali un qualche ricordo sulla fine del nazifascismo dovrebbe esser restato – che allegramente votano per una sua nuova edizione. Certo, è vero, ogni volta che arriva il 25 aprile prima di decidersi ad andare alla manifestazione dell’Anpi, ci si chiede: ma serve? Sì, serve. Ma sapendo che anche la memoria è soggetta alla storia, le cose si ricordano a seconda dei tempi, non perché si relativizzino, ma perché il tempo aiuta a capirne aspetti prima rimasti in ombra.
La forza degli eventi si misura d’altronde proprio su quanto continuino o meno a produrre attualità. Il 25 aprile è uno degli eventi mai rimasto materia immobile; in questo 2016 credo a tutti sia evidente che la data è caldissima. Non perché ci siano i fascisti alle porte – ci mancherebbe ! – ma perché in questi anni si è guastato il mondo in un modo così plateale che a tutti ci spaventa e a tanti ha fatto perdere la fiducia di poterlo riparare.
Per questo ricordare la Resistenza ci aiuta. Perché si trattò di un’avventura al limite dell’impossibile, un azzardo senza precedenti e perciò torna a dirci che si può sempre osare se c’è uno scatto di soggettività. Quando dico che fu un evento straordinario non penso solo al dato militare. Penso alla cosa gigantesca che fra il ’43 e il ’45 si riuscì a fare: dare all’Italia – che non l’aveva avuto mai – uno stato che tutti sentissero legittimo.
L’Italia, come si sa, uno Stato legittimato a livello di massa, davvero popolare, non l’aveva avuto mai: non col Risorgimento, che fu eroico ma elitario; non con i governi del Regno dopo l’Unità, che mai conquistarono il cuore degli operai e contadini su cui i loro prefetti spararono massicciamente e disinvoltamente per poi mandarli a morire a centinaia di migliaia in una guerra che non era la loro. Poi venne il fascismo. Per questo la resistenza italiana è stata così speciale. Non c’era, dietro, uno stato da reinsediare, si trattava di reinventarsene uno nuovo: uno finalmente decente e democratico.
Ce l’abbiamo fatta non solo perché il fattore militare e quello strettamente politico – l’accordo fra i partiti antifascisti – non esaurirono la vicenda resistenziale. Ci fu, e fu decisiva, quella che un grande storico, comandante della Brigata Garibaldi in Lunigiana, Roberto Battaglia, chiamò “società partigiana”, un espressione con cui volle indicare l’autorganizzazione del territorio, l’assunzione – grazie ad uno scatto di soggettività popolare e di massa – di una responsabilità collettiva per rispondere alle esigenze non solo delle proprie famiglie ma della comunità tutta. Fu il “noi” che prevalse sul’ “io”. L’antifascismo, inteso come sostanza penetrata nel senso comune, ha in Italia questa radice: l’esperienza, autonoma e diretta, di sentirsi tutti – “attraverso scelte che nascono dalle piccole cose quotidiane” come scrisse Calamandrei – fino in fondo protagonisti della costruzione di un nuovo stato, finalmente davvero patria.
Se abbiano questa Costituzione è perché essa è il riflesso, l’incarnazione di questa presa di coscienza. Che non a caso avverte che ogni cittadino non ha solo diritti e garanzie individuali, ma soprattutto quel diritto politico fondamentale che incarna la democrazia: di contribuire a determinare le scelte del paese.
Proprio riflettendo su quanto da più di un decennio sta accadendo, a me sembra che la crisi della democrazia che stiamo vivendo non sia solo la conseguenza del venir meno di quel patto di vertice dei partiti che l’avevano sottoscritto, ma più in generale dell’impoverirsi del tessuto politico sociale che con la Resistenza ne aveva costituito il contesto. Se la Costituzione non è più sentita come l’asse della nostra morale politica è perché la nostra società non è più “partigiana”, ma passiva, priva di soggettività, estranea alla politica di cui non si sente – e infatti non è – più protagonista, chiusa come è nelle angustie dell’ “io”, sempre più disabituata a declinare il “noi”. Se lasciamo passare questa trasformazione senza reagire, la celebrazione del 25 aprile diventerà davvero solo retorica. Voglio dire che per celebrare bene occorre ritrovare quella voglia, quell’impegno, quella fantasia della fondazione della Repubblica.
Questa nostra festa si chiama “della liberazione”, e non della “libertà” come qualche anno fa aveva furbescamente suggerito Berlusconi, perché la nostra parola dà conto di un processo storico, ci sollecita a dire chi la libertà ce l’aveva tolta e contro chi abbiamo dovuto combattere per recuperarla. La memoria che la celebrazione del 25 aprile rievoca ci ricorda che non ci siamo liberati dai tedeschi – come si trattasse di un conflitto fra Germania e Italia – ma dal fascismo, che fu anche italiano e non un fenomeno un po’ ridicolo fatto di parate e divise col fez, ma violenza antipopolare. E infatti cominciò con l’aggressione alle sedi sindacali, alle organizzazioni popolari comuniste socialiste cattoliche.
Le celebrazioni servono a aprire gli occhi, grazie alla memoria che sollecitano, sulla emarginazione dalla nostra Repubblica del suo contenuto antifascista, che ne è la sostanza. Serve a richiamarci alla urgenza di un impegno a ricostituire la società partigiana; e cioè a riassumere la responsabilità della nostra comunità, a rimettere il noi al posto dell’io.
Sapendo che il noi oggi si è dilatato. Non è più quello di chi vive all’ombra del nostro campanile e nemmeno entro i nostri confini. Il mondo è ormai entrato nel nostro quotidiano, lo straniero – e con lui la politica estera un tempo affidata agli specialisti – lo incontriamo al supermarket, nella scuola dei nostri figli, nelle immagini dei disperati che approdano alle nostre coste o affogano nei nostri mari. La loro libertà vale la nostra, la nostra senza la loro non ha più senso. Per questo è giusto festeggiare il 25 aprile con immigrati e palestinesi, così come con chi è ancora vittima dell’antisemitismo. Non è un debordare dal tema “Liberazione”, vuol solo dire sentirsi parte della condizione delle vittime e al tempo stesso responsabili della loro sofferenza.
Il comandante Rendina, che dell’Anpi di Roma è stato presidente, diceva che la memoria “serve a riattivare il circuito delle ragioni che ci spingono a continuare la battaglia per un mondo migliore”. Di riattivare questo circuito oggi c’è estremo bisogno, per ritrovare fiducia nella politica, e cioè nel fare collettivo di ogni cittadino, politica come esercizio di cittadinanza attiva, riconquista della soggettività che l’antipolitica ha annegato. Contro questa minaccia alla democrazia non serve prendere le armi come nel ’43, serve però ricostruire relazioni, liberarsi dalle paure, guardare all’altro che ormai popola le nostre contrade per assumere insieme le responsabilità che ci toccano. Tornare a sentirci, e a diventare davvero, protagonisti.