

 Un giusto colpo di frusta da parte di chi aprì sul giornale comunista lil dibattito sulla "morte della politica" e sulla liquefazione della sinistra novecentesca , e insieme alcuni punti dai quali ripartire.
Un giusto colpo di frusta da parte di chi aprì sul giornale comunista lil dibattito sulla "morte della politica" e sulla liquefazione della sinistra novecentesca , e insieme alcuni punti dai quali ripartire.
Ilmanifesto, 14 settembre 2016
C’è un fatto curioso e significativo. Benché sia evidente e foriero di nuove disfatte, il vuoto desolante nel quale ci troviamo stenta a essere riconosciuto nella sua radicalità, per così dire epocale. Così il discorso sulla «morte della politica», che potrebbe e dovrebbe offrire le premesse per ripensare in tempo utile natura e funzioni delle soggettività della sinistra – compreso questo piccolo glorioso giornale – in un contesto totalmente mutato dagli anni della cosiddetta prima Repubblica e del bipolarismo mondiale della Guerra fredda, questo discorso è derubricato a faccenda di ordinaria amministrazione, quando non frainteso nel ricorso a puntualizzazioni fini a se stesse.
Queste ultime – la politica non muore perché tutto è politica – lasciano il tempo che trovano, e il tempo è prezioso.
Noi cerchiamo di correre contro di esso perché sentiamo che è in gioco anche una questione in senso largo generazionale. Chi non ha vissuto gli anni Sessanta e Settanta, chi è venuto all’età della ragione quando la politica era già, nel mondo, lo scatenamento neoliberale degli spiriti animali e, in Italia, la mercificazione berlusconica delle istituzioni – in una parola la post-democrazia – ha motivo oggi di identificare l’esistente con l’orizzonte del possibile o di scambiare tutt’al più le proprie aspirazioni soggettive per istanze critiche.
Ma in questa polverizzazione molecolare la sinistra evapora. E nella rassegnata introiezione del dato come unico quadro di senso, la politica – la politica come pratica storico-critica volta alla trasformazione – muore o si riduce a simulacro.
Non dovrebbe essere dunque difficile intendere che questa nostra discussione investe temi vitali. Che ne va, ormai a breve, della sopravvivenza dei residui della sinistra politica, al netto delle grottesche autoinvestiture renziane o bersaniane.
Negli Stati Uniti, che restano di fatto un modello trainante della società europea, la sinistra è da sempre «puro pensiero» critico per dir così disincarnato, annidato nelle Università e nei think tank, affidato paradossalmente al samisdat di ristrette élites intellettuali. È un eccesso preconizzare che nel giro di pochi anni anche in Europa e nella provincia italiana – finalmente normalizzata – sarà questo lo scenario, a meno di mutamenti oggi imprevedibili? Se non lo è, abbiamo dinanzi un destino ineluttabile o un terreno disponibile all’analisi e all’intervento pratico?
Benché la stessa resistenza a riconoscerla, prima ancora che a farsene carico, testimoni l’intensità della crisi, un minimo di lungimiranza consiglierebbe, a mio avviso, di assumere seriamente la questione, con tutto il suo portato quotidiano di frustranti evidenze.
Il punto è: da dove cominciare finalmente questo discorso, consapevoli della sua urgenza e della sua complessità? La crisi della sinistra italiana ed europea è – su questo in molti conveniamo – «organica». Cioè profonda, strutturale. E pervasiva: trasversale agli spazi della cultura e della moralità dei soggetti individuali e collettivi, oltre che incombente sul grado della loro efficacia materiale.
Forse, allora, è proprio da qui che conviene muovere: dalla qualità del «fattore soggettivo», che al dunque rappresenta sempre un aspetto decisivo nello sviluppo delle crisi.
Vorrei fare qualche nome, per entrare a questo punto in medias res. Proprio Gramsci, la cui lezione spesso ritualmente evochiamo; ma anche altri nostri maggiori a cavallo tra l’Otto e il Novecento (Lenin e Lukács, per esempio; e Antonio Labriola) insistettero sull’importanza dell’autonomia culturale e ideologica delle organizzazioni del movimento operaio. Scorgendovi non un corollario ma l’aspetto determinante la loro costituzione e capacità d’intervento.
Autonomia, per un verso, dall’ideologia (e dalla moralità) dominante. Costruzione autonoma, per altro verso, di strumenti concettuali e di criteri di giudizio per la determinazione delle finalità della prassi politica.
Quel che era indispensabile ieri lo è forse meno oggi? O oggi lo è semmai in maggior misura, dato che molto è mutato nel frattempo nelle coordinate di fondo della realtà economica, sociale e politica in cui si tratta di operare? Passaggi di alcuni interventi nella nostra discussione sembrano variamente convenirne.
Valentino Parlato muove dal silenzio assordante della cultura critica; Alfonso Gianni lamenta l’incapacità di leggere la crisi attuale; Stefano Fassina l’assenza di ragioni fondative in una riflessione stagnante. Da ultimo, per contrasto, Luciana Castellina rivendica la densità della presa di coscienza collettiva degli effetti perversi della modernizzazione capitalistica che, all’altezza del ’68-69 e nel decennio successivo, sorresse la sinistra di classe in Italia.
Mi pare che una diagnosi comune circoli in queste considerazioni e che da questa dovremmo partire, senza indulgenza.
Siamo oggi innegabilmente al cospetto di una pochezza disarmante di cui andrebbero individuate le cause. Il respiro corto della politica politicante non è innocuo né – suppongo – accidentale: risente di certo di una fase storica regressiva segnata dall’accentrarsi della sovranità presso oligarchie sottratte al controllo democratico e dal crollo delle grandi ipotesi trasformative; ma tradisce anche le motivazioni di buona parte di un ceto politico e sindacale balbettante e disorientato, sganciato dal conflitto, non di rado disponibile alle seduzioni dell’opportunismo.
Al tempo stesso il silenzio apolitico o il conformismo di quella che fu la cultura democratica impegnata al fianco delle lotte operaie e studentesche pongono un problema di prima grandezza, a meno di non assumere deterministicamente l’inerzia complice dell’intellettualità.
Insomma, forse è arrivato il momento di fare tesoro di un’intuizione che segnò secoli addietro la nascita dell’antropologia moderna: partire da noi senza vie di fuga ed esorcismi di comodo è indispensabile per comprendere le ragioni della crisi della sinistra e scongiurare la morte della grande politica.


I fantasmi respinti
Una voce sguaiata al megafono della moschea ricorda all’improvviso che Allah èil più grande. È l’ora della preghiera che precede l’aurora. Sono le quattro ediciannove. Addio sonno. Fino alle tre e mezzo avevamo il tormento della musicaafro dalla baracca appena fuori il recinto, lì dove i gangster nigeriani fannoprostituire le ragazzine. Poi due auto si sono sfidate con frenate e sgommatelungo la Pista. Quindi un ragazzo ha telefonato al fratello in Africa e parlavacosì forte che sembrava volesse farsi sentire direttamente. Adesso chiamanoalla preghiera anche dalla misteriosa moschea degli afghani. Le voci deimuezzin erano scomparse da questo cielo il 15 agosto del 1300, giorno d’iniziodel massacro dei musulmani a Lucera. Migliaia di morti, i sopravvissuti venduticome schiavi: le radici europee del cristianesimo non sono più pacifiche dicerti fanatici islamisti di oggi.
Ogni angolo protetto dalla luce dei fari è occupato da qualcuno che prova adormire all’aperto. Un po’ per il caldo asfissiante. Un po’ perché dentro nonc’è posto. Lo sanno anche le zanzare. Quando il sole è ormai a picco, Suleman,24 anni, nel Cara da tre mesi, esce a raccogliere babbaluci, le lumacheaggrappate agli arbusti. «Al mercato di Foggia», spiega, «gli italiani lecomprano a tre euro al chilo». Già. E le rivendono su Internet a sette. Maservono ore a mettere insieme un chilo. Da dove vieni? «Dal Ghana, ho chiestoasilo», rivela Suleman. Il Ghana è una Repubblica. Forse è un oppositoreperseguitato. Alla domanda, lui guarda stupito: «No, spero di ottenere idocumenti e trovare un lavoro qualsiasi in Italia o in Europa. Dove non lo so.E tu?». Meglio non dire la verità, l’inchiesta è ancora lunga. È il momento dicollaudare il nome preso in prestito da Steve Biko, l’eroe sudafricano dellalotta contro l’apartheid: «Sono senza documenti e voglio raggiungere miasorella a Londra». Lui non capisce subito. «Sono un sudafricano bianco. Laterra di Mandela. Conosci Nelson Mandela?». «No Steve, who is this man, chi èquest’uomo? Ma hai il tesserino da rifugiato?», vuol sapere Suleman. No.«Allora non hai mangiato Steve, hai fame?», chiede con apprensione. No, grazie.«Però non dormire qui fuori. È pericoloso. Dentro nessuno controlla. Puoi anchemangiare. Stasera mi trovi dopo la preghiera quando distribuiscono la cena. Tuvieni in moschea?».
Il muezzin ancora non ha chiamato alla preghiera. E i primi ragazzi venuti arifornirsi d’acqua alla fontanella sono già in viaggio. Erano tornati ieri seraquasi alle dieci. Si sono fatti la doccia. Hanno lavato e steso gli abiti dalavoro. Poi hanno mangiato la pasta della mensa, tenuta da parte da qualchecompagno di stanza. Era mezzanotte passata quando sono andati finalmente adormire. Dopo appena tre ore di sonno già pedalano silenziosi, uno dietrol’altro, che sembra il via di una tappa a cronometro. Scavalcano bici in spallail muretto sotto i fari e le telecamere. Poi si dissolvono nel buio comebersaglieri del lavoro, chiamati in prima linea a riempire i nostri piatti.
Le spie dei gangster nigeriani
L'assalto dei cani randagi
Qualche riga oggi bisogna dedicarla alla pet therapy. È quella prassi secondocui l’interazione uomo-animale rafforza le terapie tradizionali. Allaprefettura di Foggia, responsabile della fisica e della metafisica di questoGhetto di Stato, devono crederci profondamente: perché il Cara è infestato dicani, ovunque, perfino dentro le docce. Nessuno fa nulla per tenerli fuori.Quando è ancora buio, subito dopo la preghiera, tre braccianti escono inbicicletta dal buco a Ovest, dove la recinzione è stata smontata. Le lorosagome sfilano nel chiarore della luna. Un cane abbaia e la sua voce richiamaun’intera muta che si lancia all’inseguimento dei tre poveretti. Sono unadecina di grossi randagi. Corrono. Ringhiano e si mordono. Poi diligentementetornano a sdraiarsi tra gli ospiti del centro.
Nasrin, 27 anni, afghano di Tora Bora, si tiene alla larga dai cani. Una seraparliamo davanti alla partita di cricket improvvisata dai pakistani, sul piazzalevicino ai rifiuti. Nasrin dice che se ne intende di viaggi fino in Inghilterra.È andato e tornato, rinchiuso nei camion. Un suo conoscente, che dorme allaPista, conferma più tardi che può trovare i contatti. Deve solo verificare iprezzi. Dopo Brexit sono aumentati. «In Inghilterra i caporali pakistani paganobene con la raccolta di spinaci e ortaggi: 340 sterline a settimana», spiegaNasrin. Con i documenti? «No, senza. Però si lavora 18 ore al giorno. In seianni ho messo via ottantamila euro. E in Afghanistan mi sono costruito unabella casa». Allora perché sei qui? «Perché per avere i documenti avevo chiestoasilo in Italia».
Quattro sedie separano dall’angolo cottura i tranci di gommapiuma, usati comematerassi. Per terra la serpentina elettrica incandescente sta riscaldando dueuova, la pasta avanzata ieri sera, una teiera. Un sacchetto di plastica e unrotolo di carta igienica sono pericolosamente vicini al calore. Pentole, unpiatto, due bicchieri. Tutto per terra. Non c’è lo spazio per un tavolo. Nelcortile al centro del Cie, per terra ci dormono pure. Il piccolo loculo diCumpà al confronto è un lusso. Almeno ha un po’ di riservatezza, l’ariaintorno, i vasi con gli oleandri. Perfino l’architettura qui dentro è oscena. Èstata progettata e costruita in modo che si possa vedere soltanto uno spicchiodi cielo. La mente che l’ha pensata voleva probabilmente umiliare le donne egli uomini da rinchiudervi. L’effetto è questo, anche ora che è un centro diaccoglienza.
Lo sconto sulla dignità
I bagni e le docce non profumano mai di disinfettante. Hanno perfino sloggiatodei profughi per trasformare le loro stanzette in privatissimi negozi. Ce nesono cinque tra le casupole statali. Vendono bibite, riso, farina, pane,accessori per telefonini direttamente dalle finestre. Quattro li controllanogli afghani della Pista. Il quinto due ragazzi africani. Non ci sono cestiniper i rifiuti, solo sacchi neri appesi qua e là. Stanotte i cani li hannostrappati e hanno disperso avanzi della cena ovunque. Un favore alla catenaalimentare, sì. Perché alla fine anche i ratti hanno un motivo per uscire alloscoperto. Quello che colpisce è la rinuncia totale a spiegare, insegnare, prepararei richiedenti asilo a quello che sarà. Se i gestori lo fanno nei loro uffici, irisultati non si vedono. Qui fuori sembriamo tutti pazienti di un repartooncologico. In attesa permanente di conoscere la diagnosi: vivremo da cittadinio moriremo da clandestini?
Forse non ci sono abbastanza soldi per seguire il modello tedesco. Oppure noiitaliani siamo troppo furbi, oggi. E contemporaneamente troppo stolti perpensare al domani. Non c’è soltanto la crisi umanitaria internazionale arendere precario qualsiasi intervento. La ragione del fallimento si trova giànella gara d’appalto per gestire il Cara: premiava il «maggior ribassopercentuale sul prezzo a base d’asta, pari a euro 20.892.600». Un cifra dipartenza che equivaleva a 30 euro al giorno a persona. E il consorzio “Sisifo”di Palermo si è aggiudicato il contratto con uno sconto di 8 euro. Ha abbassatola diaria a 22 euro e rinunciato a quasi cinque milioni e mezzo in tre anni. Lalogica matematica ci suggerisce una sola cosa: o i funzionari della prefetturadi Foggia hanno sbagliato a formulare i prezzi, o il consorzio della Lega Coopsapeva di non starci nelle spese. Anche se è davvero difficile pensare che 22euro al giorno a persona non bastino a fornire il minimo di dignità. Comunqueil ministero dell’Interno chiede sempre di aumentare il numero di ospiti diqualche centinaio. E l’emergenza è pagata bene: i soliti 30 euro, ma senzagara. Così perfino lo sconto è rimborsato.
La cooperativa cattolica “Senis Hospes”, che per contodi “Sisifo” gestisce Borgo Mezzanone e altri centri, corre al galoppo.Fatturato in crescita del 400 per cento in due anni: dai 3 milioni del 2012 a15,2 milioni del 2014, ultimo bilancio disponibile. Dipendenti dichiarati: dai109 del 2014 ai 518 di quest’anno. «Tali attività...», scrive nella relazioneannuale Camillo Aceto, 52 anni, presidente di “Senis Hospes”, «rispondono allamissione che la cooperativa si prefigge dedicando l’attenzione alle categoriepiù bisognose». Ma qui dentro, nel grande stanzone degli inferi, oggi la luce èaccesa alle quattro. È domenica. Alcuni richiedenti asilo sono già partiti peri campi. Altri preparano lo zaino. Sempre sotto quella scritta sulla colonnacentrale, che martella la vista: «Benvenuti».Comune.info,11 settembre 2016 (c.m.c.)
Lo spazio pubblico, che ha nel suo atto fondativo l’esclusione delle donne, si è andato sempre più femminilizzando, ma sembra al medesimo tempo diminuita progressivamente la conflittualità tra i sessi, proprio là dove l’impatto con saperi e poteri marcatamente maschili — l’economia, la politica, la scienza, ecc.— faceva pensare che sarebbe riemersa con forza. Permangono pressoché inalterati luoghi storici, come la scuola e i servizi sociali, dove una predominante presenza femminile è garantita dalla continuità con quella “naturale” o “divina missione,” che vuole la donna «madre per sempre, anche quando è vergine,» oblativamente disposta alla cura, anche fuori dalla mura domestiche.
Ma la femminilizzazione è andata oltre, spingendosi fin nelle pieghe del tessuto sociale, esaltata come fattore di innovazione e risorsa preziosa da un sistema economico, politico, culturale che risente del declino di antichi steccati tra sfera privata e sfera pubblica, natura e cultura, sessualità e politica — quelle linee di demarcazione che hanno permesso finora alla comunità storica degli uomini di pensarsi depositaria di un marchio di umanità superiore.
Sui giornali più vicini alla Confindustria, come Il sole24ore, non c’è giorno che non si elogi il “valore D,” il contributo di qualità relazionali che le donne possono portare ai livelli alti del management, in soccorso di un sistema produttivo sempre più flessibile e immateriale. Nelle professioni, e in generale nei rapporti di lavoro, si celebrano esempi eroici di “supermamme,” capaci di eccellere allo stesso modo nella cura di un figlio e nella carriera.
Libertà, diritti acquisiti, non sembrano aver scalfito alla radice l’aspetto più accattivante dei ruoli sessuali, la complementarietà, «quel profondo, benché irrazionale istinto» — come ha scritto Virginia Woolf— a favore della teoria che solo l’unione dell’uomo e della donna, del maschile e del femminile, provoca «la massima soddisfazione,» rende la mente «fertile e creativa.» Di questo ideale ricongiungimento di nature diverse si alimenta l’amore di coppia e il suo antecedente originario, la relazione madre-figlio. Poco, o per nulla indagate dal femminismo, queste zone più intime del rapporto tra i sessi, ricompaiono oggi, deformate, sotto la maschera di una emancipazione che stentiamo a riconoscere come tale.
Al posto della rincorsa omologante a essere come l’uomo, sono gli attributi tradizionali del femminile – le «potenti attrattive» della donna, di cui parlava Rousseau, e cioè la maternità e la seduzione – a essere impugnate come rivalsa, appropriazione di potere, scalata sociale. Se l’emancipazione del passato poteva essere vista come «fuga dal femminile» screditato, oggi è il femminile stesso – il corpo, la sessualità, l’attitudine materna – a emanciparsi come tale, e a prendere nello spazio pubblico il posto che compete a un complemento indispensabile alla cultura maschile.
Il patriarcato sta divorando se stesso, scricchiolano le impalcature su cui si è costruita la polis, alle donne, le escluse-incluse di sempre, si offre l’occasione per portare allo scoperto quel potere di indispensabilità all’altro di cui si sono fatte forti finora solo nel privato. La femminilizzazione della sfera pubblica ammorbidisce il conflitto tra i sessi, e come nell’illusione amorosa, fa balenare la possibilità di una ‘tregua.’ Ma, proprio come per l’amore, lascia aperto il dubbio che sia invece, come ha scritto Pierre Bourdieu nel suo libro, Il dominio maschile (Feltrinelli 1998), la forma più insidiosa, perché invisibile, della violenza simbolica.
Quella che vediamo oggi sulla scena pubblica è una situazione molto diversa, si potrebbe dire capovolta, rispetto agli anni Settanta, e molto lontana dai cambiamenti che si prospettava il femminismo, sia riguardo al rapporto uomo-donna, sia riguardo ai legami da riscoprire tra ‘personale’ e ‘politico.’
Il corpo, e tutte le vicende che lo attraversano —nascita, morte, sessualità, maternità, malattia, invecchiamento, ecc— non è più il rimosso della sfera pubblica, la parte, pur essenziale, dei bisogni e dei comportamenti umani che è stata svalutata, perché più vicina alla natura, a pulsioni incontrollabili, consegnata al sesso femminile come destino, sottoposta a un potere patriarcale più feroce e illimitato di quello pubblico.
Particolarmente sovraesposto è il corpo femminile, come corpo vittima di violenza manifesta e psicologica — stupri, maltrattamenti, omicidi domestici, molestie, finalmente denunciati dalle donne stesse —, ma anche come corpo al centro di forme di prostituzione più o meno esplicite: corpo mercificato, usato come ‘risorsa,’ ‘capitale’ che le donne impugnano a proprio vantaggio, scambiandolo con carriere, denaro, successo.
Nasce allora spontanea una domanda provocatoria: i corpi femminili che vediamo muoversi nel luogo da cui sono stati a lungo banditi sono corpi liberati o corpi prostituiti? Sono donne che si sono riappropriate della propria vita, sciogliendola da un ‘destino naturale’ e disponendone liberamente, o sono schiave volontarie, donne che decidono di impugnare attivamente e nel proprio interesse quella che è stata storicamente la condizione del loro asservimento: il corpo oggetto, messo al servizio dell’uomo? La richiesta di ‘doti femminili,’ come ‘valore aggiunto,’ viene oggi dagli ambiti più diversi e più imprevedibili della società maschile — dall’industria dello spettacolo e dalla pubblicità, ma anche dall’economia, da una politica sempre più mediatica. Non meraviglia che siano le donne stesse a decidere di ‘usarle,’ ‘metterle al lavoro,’ ricavarne un beneficio.
A prendere rilievo sono i due attributi del ‘femminile,’ considerati a lungo ‘naturali’: la seduzione e la maternità. Se nel primo caso è più facile lo slittamento verso forme vicine alla prostituzione, a cui rimandano in parte le figure delle ‘escort,’ delle ‘veline,’ delle ‘donne immagine,’ nell’altro, quello che ha a che fare con la produzione e che valorizza le capacità relazionali, la flessibilità, le competenze ‘domestiche’ femminili, la retorica del materno impedisce di vedere l’aspetto di subalternità, di messa a servizio, che conferma, nella vita pubblica, il destino famigliare della donna, quel lavoro gratuito di cura, gratuito e invisibile perché confuso con l’amore. Non si esce, in entrambi i casi, da una soggettività femminile vista come ‘oggetto,’ merce preziosa, che resta, nonostante l’uso che oggi tendono a farne le donne stesse, in una posizione di asservimento rispetto al sesso dominante.
Femminilità al lavoro
Mentre il privato avanza minaccioso a minare le istituzioni della vita pubblica, nell’ambito lavorativo la presenza femminile, il sapere maturato in quel luogo ‘altro’ dalla polis che è la casa, appare imprevedibilmente come la via d’uscita alla crisi di un sistema produttivo rimasto storicamente il caposaldo del dominio maschile. La «potenza dell’amore» e la «coercizione al lavoro,» dopo essersi fatte a lungo la guerra, sembrano oggi destinate a un ideale ricongiungimento, per effetto della rivoluzione che sta attraversando l’economia e per l’opportunità che essa potrebbe offrire alle donne di far riconoscere il valore del talento femminile, a lungo ignorato. «Professionalità sensuale,» «intelligenza emotiva,» «pensiero emozionale,» sono le forme linguistiche che prende il sogno d’amore —armonia di nature opposte e complementari— , quando si trasferisce dalla relazione di coppia all’ambito lavorativo.
Il mito dell’interezza, che accompagna da sempre la cultura maschile, come nostalgica immaginaria riparazione a tutti i dualismi che ha prodotto, a partire dal diverso destino riservato a uomini e donne, viene oggi reclamato da versanti apparentemente opposti: da un lato, la centralità che stanno prendendo nel sistema produttivo le relazioni e i servizi alla persona, e di conseguenza il corpo, la dimensione affettiva e sessuale; dall’altro, l’affermarsi di un “desiderio” femminile che rifiuta l’alternativa tra la cura dei figli, della casa, e la volontà di «stare nel mondo,» che pensa di poter fare dell’esperienza della quotidianità «una leva per cambiare il mercato del lavoro.»
Il venir meno dei confini tra la casa e la pòlis sembra aver aperto il campo ad una ambigua ‘femminilizzazione’ dello spazio pubblico, e ad una non meno ambigua mercantilizzazione della vita intima. Se la precarizzazione, la perdita di diritti e garanzie certe, la pluralità imprevedibile delle occupazioni, fanno apparire il tempo di lavoro sempre più pervasivo e soffocante, e il capitalismo globale “un vampiro,” l’ingresso delle donne in ruoli manageriali di grandi aziende accende al contrario la speranza di poter ridefinire con un segno proprio poteri e regole organizzative della produzione, tradizionalmente riservati agli uomini.
Una volta cadute le barriere che hanno tenuto le donne, e tutto ciò che dell’umano è stato identificato col loro destino, confinati in una sorta di natura immobile, ignorata per quanto essenziale alla conservazione della specie, era inevitabile che la “differenza femminile” si mostrasse in tutta la sua contraddittorietà: potenza materna e risorsa sessuale assoggettate e poste al servizio dell’uomo, manodopera di riserva subordinata alle necessità del ciclo produttivo, libertà e creatività esaltate nell’immaginario e storicamente insignificanti.
La riflessione prodotta dal femminismo sulle esperienze lavorative di donne di età e collocazione sociale diversa hanno oscillato, non a caso, tra marcare il “vantaggio,” il “di più” di competenza che verrebbe oggi al femminile dalla nuova economia, e ammettere invece la deriva verso forme di autosfruttamento, estese alla vita intera. L’Eros, che insieme alle donne e alle attitudini un tempo nascoste nel privato si fa strada dentro le rigide, impersonali impalcature delle organizzazione del lavoro, conserva il suo volto duplice trasferendosi contemporaneamente in “lavori marchetta” e in materia emozionale, creativa, per forme inedite, armoniose, di un potere non più separato dalla vita.
Se c’è chi cerca di svincolarsi dal coinvolgimento eccessivo, scegliendo lavori che non offrono «possibilità di grande soddisfazione,» e tanto meno conferme identitarie, altre fanno dell’azienda il luogo tanto atteso della «costruzione di sé,» di una affermazione di esistenza, prima ancora che di riuscita professionale: Si chiede al dipendente di mettere in gioco una certa corporeità, ammiccante e sorridente.
E’ possibile che si vada creando un contesto prostituzionale allargato, legato al fatto che, quando l’attività relazionale tende a prendere il sopravvento, il soggetto debba anche lasciare agire, usare, sfruttare le capacità del corpo e la mimica della profferta sessuale … Nei lavori atipici la componente personale e relazionale ha un peso sempre più importante, sia nel contesto del lavoro che nella relazione contrattuale col padrone. Debbo imparare a vendermi bene, a rendermi appetibile. Non conosco i miei diritti, non saprei con chi discuterne nel mio posto di lavoro.
La discussione che riguarda le donne e il lavoro, da qualunque parte venga fatta, non riesce a sottrarsi al binomio uguaglianza/differenza, che ha contagiato anche parte del femminismo, nonostante si sia affermata da tempo la consapevolezza che si tratta di un falso dilemma imposto dal potere maschile. Se è stato facile, per la generazione degli anni ’70, prendere distanza da un’idea di emancipazione che andava a confondersi con modelli virili, più tortuoso e tuttora incerto si è dimostrato il processo di liberazione che avrebbe dovuto criticare ogni forma di dualismo, di complementarietà, di riunificazione degli opposti.
Colpisce il fatto che siano proprio le donne, nel momento in cui si sfrangiano e si eclissano le identità e le appartenenze di ogni tipo, a impugnare, come rivalsa o affermazione di autorevolezza, una ‘natura’ o un ‘genere’ femminile usati dalla civiltà dell’uomo per tenere le donne in uno stato di minorità sociale, giuridica e politica. Ma forse sta proprio in questa “incongruenza” uno dei nodi irrisolti della questione dei sessi. D’incongruenze e contraddizioni sono piene, non a caso, le analisi che più esplicitamente si sono poste l’obiettivo della «valorizzazione delle differenze di genere.»
La conciliazione di amore, cure materne e lavoro, la ricerca dell’interezza della persona, nonostante le evidenti ricadute “ancillari,” sia nel privato che nel pubblico, continua a essere perseguita dalle donne stesse, incuranti delle fatiche e delusioni a cui vanno incontro. All’accanimento nel volere che sia riconosciuta l’ “autorevolezza” femminile anche in ambito produttivo, fa riscontro la messa in ombra del potere, ancora saldamente in mano maschile, e degli interessi economici dominanti.
Ma è solo il bisogno di essere amate, l’attesa di una contropartita affettiva, a tenere le donne ancorate al sogno di una «armoniosa famiglia integrata»? Nel capovolgimento delle parti, non è forse una femminile onnipotenza -accedere al potere pubblico senza rinunciare a quello privato, seduttivo e materno- che inconsciamente le donne desiderano e gli uomini temono?
L’interrogativo si potrebbe formulare anche in un altro modo. Se oggi è il sistema produttivo, la nuova economia, ad aver bisogno del “valore D,” come vanno ripetendo da tempo i giornali della Confindustria, perché le donne in carriera notano tanta resistenza dei loro “capi” a riconoscere l’apporto creativo a un migliore funzionamento dell’azienda che esse possono dare? Perché prevale la tendenza a “usare” la loro dedizione materna, la “sovrabbondanza” del loro impegno lavorativo, come avviene per quel ‘dono d’amore’ che è, nella famiglia, il lavoro di cura?
E’ come se ci fosse, dentro l’economia capitalista, un residuo patriarcale che ne frena lo sviluppo: i dirigenti, coloro che hanno il potere di decidere avanzamenti di carriera, definire i criteri di valutazione, sono innanzitutto uomini, che non hanno alcun interesse a lasciarsi crescere al fianco, nei luoghi storici della loro autonomia, una potenza femminile più libera e più forte di quella conosciuta nel privato.
Oggi, pur restando ancora predominante nei servizi alla persona, la presenza femminile ha guadagnato terreno: a richiedere ‘competenze’ femminili, capacità relazionale, flessibilità, è il sistema produttivo stesso, la nuova economia incentrata sul lavoro cognitivo, immateriale. Alla ‘differenza’ femminile si aprono territori inaspettati, ma ancora una volta può fare la sua comparsa solo come ‘risorsa,’ ‘merce preziosa,’ ‘valore aggiunto’ e complementare di un ‘intero’ che non cambia volto, mentre potenzia, nella riunificazione dei due rami della specie umana, le sue capacità.
La scena pubblica viene a prendere la figura di un doppio, l’uomo-femmina, da sempre presente nei miti della cultura maschile, come ricomposizione armoniosa di ciò che la storia ha separato e contrapposto secondo un preciso ordine gerarchico. Il corpo femminile, nella sua duplice valenza — erotica e materna— entra prepotentemente nell’economia e nella politica, dalla televisione al mercato pubblicitario, dai Palazzi del potere alla produzione industriale.
Con un’unica differenza: mentre il corpo nudo della ‘donna-immagine,’ della ‘escort’ o della ‘velina,’ provocano sussulti di indignazione, non accade altrettanto per l’uso, a costo zero, che il potere aziendale fa delle ‘doti materne’ – cura dei rapporti interpersonali, fluidificazione dei contrasti, dispensa di affetti e di attenzione.
Contratti atipici, part-time, assunzioni personalizzate, sembrano oggi venire incontro sia alle necessità del sistema produttivo che al desiderio di molte donne di conciliare maternità e lavoro, il “doppio sì” di cui parla il Gruppo lavoro della Libreria delle donne di Milano nel Quaderno di Via Dogana 2008. La ‘cura,’ che le donne prodigano gratuitamente all’interno delle case, svalutata per la contaminazione col corpo e con la dipendenza, con i bisogni essenziali della persona, cambia segno, diventa il valore sulla base del quale rivendicare il part-time come «gesto di libertà femminile,» «autodeterminazione dei tempi di lavoro.»
Il paradosso del femminile, già descritto lucidamente da Virginia Woolf come «insignificanza storica ed esaltazione immaginativa» delle donne, prende nuovi nomi ma non cambia nella sostanza. Una nuova forma di emancipazione, scoppiettante di promesse, rivincite, privilegi inaspettati, viene a prendere il posto delle «oscure carriere» che la Woolf aveva previsto per le generazioni future di donne impegnate nella vita pubblica. Allo sforzo di somigliare all’uomo si sostituisce una strada più facile e più rapida, incoraggiata a quanto sembra da entrambi i sessi: valorizzazione delle attrattive che l’uomo ha visto nel corpo femminile e che, cadute alcune barriere di controllo patriarcale e di pudore, possono essere oggi impugnate dalle donne stesse come ‘rivalsa’ e come ‘capitale’ da far fruttare sul mercato del denaro e del successo.
Lo scambio sessuo-economico, venuto alla ribalta con le vicende berlusconiane, è solo l’aspetto più vistoso di un processo che vede il corpo, la sessualità, ma anche la maternità, emanciparsi in quanto tali. La donna celebra il suo ingresso nella polis come ‘genere’ portatore di ‘valori’ divenuti indispensabili, ma pur sempre ‘aggiuntivi.’ Il bisogno di migliorare i profitti si viene a sposare con quel desiderio di maternità «inscritto nel corpo e nella mente delle donne.»
L’ondata di critiche e di appelli, che giustamente si sono alzati contro il sessismo di Stato e contro la misoginia diffusa nei media, rischia dunque di far passare in ombra una ‘conciliazione’ senza conflitti tra la forza lavoro femminile e un sistema produttivo che, pur nel declino, non ha perso i tratti del potere patriarcale e capitalistico. Amore e lavoro, riunificati nello spazio pubblico, possono far calare di nuovo sulle coscienze il lungo sonno che ha impedito fino alle soglie della modernità di sottrarre alla natura il dominio di un sesso sull’altro.
Riportare alla maternità – come tempo da dedicare a un figlio e piacere di vederlo crescere – la mole di lavoro senza sosta che comporta la quotidiana vita famigliare, fatta di bambini, ma anche di anziani, malati e adulti perfettamente sani, avvezzi ad avere chi si preoccupa del loro buon vivere, significa, di fatto, lasciare che continui a pesare essenzialmente sulle donne la responsabilità delle condizioni indispensabili per la continuità della vita, confermare la loro ‘natura’ salvifica e la loro complementarietà rispetto a un modello dominante maschile a cui si chiede solo di farsi più attento ai desideri dell’altro sesso.
Tornare a nominare, come è stato fatto da alcuni gruppi femministi negli anni ’70, la quantità di lavoro non pagato e spesso non riconosciuto come tale dalle donne stesse, sembra un anacronismo, nel momento in cui le case si riempiono di collaboratrici domestiche e di ‘badanti’ straniere. Ma se si prende in mano un volantino di quegli anni, ci si può accorgere facilmente che la monetizzazione, là dove lo consentono le condizioni sociali, di una parte di lavoro domestico non ha sciolto né l’intreccio di lavoro e di affetti, né la svalutazione che porta ad assegnare la ‘cura’ alla parte svantaggiata della popolazione, né la convenienza per il capitalismo di avere una riserva indefinita e gratuita di servizi confinati nella sfera privata, contro l’evidenza che li vorrebbe al centro dell’etica pubblica e della responsabilità politica.
Il Fatto Quotidiano online, blog, 10 settembre 2016 (c.m.c.)
Occorre rovesciare una retorica un po’ stantia che si basa sul ragionamento elementare secondo cui cambiare significhi sempre migliorare. Il “nuovo” non soltanto non è necessariamente il “meglio”, ma non è neanche davvero e sempre “nuovo”.
Prendete la riforma costituzionale: si usa l’argomento del cambiamento come se ciò fosse sinonimo di miglioramento. E a chi (tra i sostenitori meno convinti) fa notare che neanche la riforma cosiddetta Boschi è perfetta, si risponde «Non sarà perfetta, ma intanto è un cambiamento».
Gli antichi Greci, padri della democrazia, o anche le colonie magnogreche, avevano orrore del cambiamento tanto da proteggere le leggi con un sistema di modifica che aveva chiarissima la gravità dell’atto: all’apposita commissione dei Nomoteti ad Atene spettava la decisione finale sulle proposte di nuove leggi; a Locri Epizefirî Zaleuco, estensore mitico delle leggi che governavano la città, aveva previsto la legge del laccio per la quale, secondo il racconto di Demostene, chiunque a Locri avesse voluto proporre una nuova legge, avrebbe dovuto farlo con un laccio intorno al collo. Qualora la proposta non fosse stata approvata, egli sarebbe morto soffocato. Stobeo conferma l’idea che la legge del laccio avesse lo scopo di preservare l’antico diritto e l’assetto costituzionale della colonia, affinché i fondatori della città non dovessero incorrere nuovamente nell’ingiustizia subita nella madrepatria, da cui erano stati scacciati.
Non si tratta di una tentazione passatista per un sistema lontano secoli e con enormi differenze rispetto a ciò che oggi chiamiamo “democrazia” (qualunque cosa voglia dire, dato che tale definizione spesso camuffa un governo degli ottimati o dei tecnocrati o della finanza). Si tratta solo di ribadire che “cambiare” di per sé è una parola vuota, e che i contenuti possono anche essere insoddisfacenti, o addirittura dannosi. E che “non cambiare”, invece, può voler dire cambiare molto.
Prendiamo ancora la riforma: se vince il “No” cambia tutto, se vince il “Sì” non cambia niente. Infatti con il “Sì” non cambia il ruolo invadente della politica e segnatamente del governo in tutti i gangli vitali della vita pubblica del paese: il tentativo di accentramento verticistico del potere decisionale imprimerà un’accelerazione al processo di esautoramento del pluralismo culturale e politico (processo che è già in uno stadio avanzato).
Se vince il “No” cambia tutto sul piano politico: persino un eventuale “Renzi bis” sarebbe costretto a rimettere in discussione l’ubriacatura oligarchica e decisionistica (che poi è quasi solo una retorica, una fola: decidere tutto per non decidere niente) in cui ci siamo cacciati iniziando – per stare alla cronaca, ma potremmo andare più indietro nel tempo – col Porcellum, che consentiva ai partiti di spadroneggiare sulla selezione della classe politica a discapito degli elettori, passando per la lettera di Trichet e Draghi su su fino ai governi dell’eccezione. Se vince il “Sì” tutto questo non cambia, anzi si consolida e cristallizza per sempre, dando corpo al vecchio sogno prima craxiano e poi berlusconiano di un premierato forte o del “semipresidenzialismo”, trasfigurati ormai però dall’ingerenza delle burocrazie europee e della finanza mondiale.
Se vince il “No”, l’incantesimo si spezza: nessuno, almeno per qualche anno, potrà farsi prendere dalla fregola di inseguire ancora il progetto di svuotamento della democrazia parlamentare. Se vince il “Sì”, l’idea di prendere sul serio la democrazia, di ridare parola ai cittadini, di garantire la rappresentanza, di equilibrare governo e parlamento per garantire a questo rappresentatività e pluralismo e a quello efficacia e velocità, subisce un colpo (forse) mortale. Se vince il “No” non cambia la lettera della Costituzione, ma cambia radicalmente il segno delle riforme chieste dai cittadini.
Del resto, il fatto che se la Carta non cambia può cambiare ugualmente molto è iscritto nella storia della vita della Costituzione stessa: per esempio il mutamento della legge elettorale ha prodotto, a lettera immutata, un tale scossone da far passare dalla Prima alla Seconda Repubblica. Perché il “No” non significa “No e basta”. Il “No” significa «Si cambi, ma rispettando la costituzione e i cittadini».
Chi pensa che il No sia la scelta dell’immobilismo, sbaglia. Certo in qualcuno quella tentazione passatista ci sarà pure. Ma il “No” è la posizione della mobilitazione, del movimento, della richiesta di cambiamento e novità. Il “Sì” è conservatore, insegue un progetto vecchio.
Il manifesto, 10 settembre 2016
Ho seguito con molto interesse, ma anche con altrettanto scetticismo, il dibattito sulla «morte della politica» ospitato dal manifesto. Confesso subito che la stessa espressione o «slogan» – come lo chiama Alberto Burgio – della «morte della politica» non mi convince affatto. Per almeno due ragioni.
La seconda ragione è che mai come in questo momento, se allarghiamo i nostri orizzonti al di fuori della piccola Italia, la politica – quella «grande» a cui faceva riferimento Gramsci – torna a mostrarci la sua vera natura, che per molto tempo avevamo cercato di addomesticare. Nel corso degli ultimi anni, assistiamo quasi quotidianamente ad eventi eminentemente politici: Stati che reclamano la loro sovranità, militari che inscenano (maldestri) colpi di Stato, intere popolazioni costrette a fuggire dai loro territori per motivi etnici o religiosi, nazioni che intendono difendere i loro confini nazionali con chilometri di filo spinato o con muri faraonici. L’elenco può essere allungato a piacimento, ma credo sia più che sufficiente a mostrare che la «notte della politica» (se così era) è finita e siamo all’alba di un grande risveglio.
Finora, il dibattito dedicato alla «morte della politica» si è concentrato quasi esclusivamente – direi ossessivamente (ad eccezione degli interventi di Stefano Fassina e Yanis Varoufakis) – sul contesto italiano e sulle cause «domestiche» della crisi.
La mia impressione, invece, è che per capire lo stato attuale della politica (e della sinistra) serva una prospettiva esterna, internazionale. Mi spiego meglio. A mio avviso, quando oggi si discute di crisi della politica credo che, implicitamente o no, si faccia riferimento all’idea di uno «spazio politico», quello che gli inglesi chiamano polity per distinguerlo tanto dalla politics (il «gioco del potere») quanto dalla policy (l’ambito delle politiche pubbliche).
E mi pare evidente, al di là delle nostalgie nazionalistiche dello stesso Fassina, che lo spazio politico che oggi si trova maggiormente sotto stress è quello dello Stato-nazione, che non ha più la forza, gli strumenti, le capacità per fare fronte alle pressioni delle grandi multinazionali, alle dinamiche dei mercati finanziari internazionali, ai processi migratori di scala continentale, ai disastri climatici o ambientali che superano i confini dei singoli Stati.
In questo senso, la crisi della politica su cui ruota l’intero dibattito è, in realtà, una crisi dello spazio politico nazionale, il quale, da solo, non è più all’altezza delle sfide innescate da economie sempre più integrate a livello internazionale. È qui, su questo snodo, che la crisi della politica si riflette dentro la crisi della sinistra, non solo italiana.
E su questo ha pienamente ragione Burgio nel sottolineare che l’attuale crisi della sinistra è «una crisi organica, non episodica», e cioè molto più strutturale che congiunturale. Del resto, come potremmo spiegarci l’uscita – per così dire – a destra (con crescita dei partiti populisti, nazionalisti e xenofobi) dopo la più grave crisi economica che il mondo occidentale abbia sperimentato almeno negli ultimi due secoli? Una crisi – si badi bene – prodotta da un neo-liberismo senza freni, totalmente «sregolato», che ha drammaticamente fatto tornare a crescere le diseguaglianze sociali ed economiche dopo una lunga fase di riduzione.
In teoria, tra il fallimento della ricetta neo-liberale e l’esplosione delle (nuove) diseguaglianze esistevano praterie per la crescita delle forze di sinistra. E invece stanno regredendo un po’ dappertutto perché incapaci di, o impossibilitate a, offrire risposte adeguate alla crisi economica nella quale siamo ancora tutti intrappolati. Qui sta l’elemento strutturale dell’attuale debolezza della sinistra, legata a doppio filo con la crisi della dimensione politica nazionale.
Se questa diagnosi è corretta, mi pare chiaro che (soprattutto) i partiti di sinistra debbano incominciare seriamente a interrogarsi su quale sia il nuovo spazio politico idoneo alle sfide che ci troviamo di fronte. Per le forze politiche di destra o conservatrici, che hanno da sempre fatto leva su uno «Stato minimo», la debolezza della politica è un aspetto secondario, marginale. Ci penseranno altri fattori – gli animal spirits, i singoli individui, i gruppi di interesse ecc. – a fare i loro conti con l’economia e con i mercati. Ma per la sinistra la politica – intesa come spazio politico all’interno del quale poter governare e regolare anche i fenomeni economici – è fondamentale: simul stabunt, simul cadent, o stanno assieme o non staranno per nulla.
Se c’è uno spazio politico all’interno del quale la sinistra può ritrovare la sua ragion d’essere è sicuramente quello europeo. È lì che la politica può incidere sui grandi nodi strutturali del nostro tempo (disoccupazione, immigrazione, mobilità sociale, sfide ambientali e climatiche, terrorismo ecc.) e offrire proposte e visioni alternative ai cittadini.
Certo, non è questa Europa la soluzione, ma sicuramente è dentro l’Europa che va cercata. Per questo trovo sterili le proposte di Fassina, per il quale la risposta ad un «astratto e impolitico europeismo» sarebbe il semplice ritorno alle prerogative dello Stato-nazione, cercando di rimettere il dentifricio della globalizzazione dentro il tubetto nazionale: impossibile.
Ugualmente velleitarie, ma almeno indirizzate verso il giusto bersaglio, mi paiono le soluzioni «movimentiste» di Varoufakis, secondo cui la nuova Europa potrà nascere soltanto da forme diffuse di disobbedienza sociale e territoriale. Se però sono queste le uniche soluzioni sul tavolo, ho l’impressione che la «notte della sinistra» sarà ancora molto lunga.
Repubblica, 9 settembre 2016 (c.m.c.)
Giobbe ha dovuto tenere a mente una grande verità, imparandola in maniera dura: «So questo per la verità, che nessun uomo può vincere la sua causa contro Dio. Se un uomo sceglie di discutere con lui, Dio non risponde a una domanda su mille» (Gb 9; 2-3). Da qui in avanti si capirà cosa vuol dire questa verità di Giobbe.
Molti anni fa Italo Calvino, proprio sui giornali, aveva parlato di una specie di centro “strano”, affermando che: «La società moderna tende verso un complicato set-up, che gravita verso un centro vuoto, ed è in questo spazio, che si rivela vuoto, che tutti i poteri e valori si riuniscono».
Questo processo potrebbe aver dato il via, per ricordare ancora Calvino, a una potente teoria di forza centripeta del vortice di contemporaneità, ad un centro schizzato dai “cadaveri” dei tanti che aspiravano in passato a stabilirsi in un presunto centro che in realtà si è scoperto poi vuoto. Mi sono già confrontato sul tema religioso in molte occasioni e tornerò a farlo ad Assisi nel dialogo con Papa Francesco il 20 settembre prossimo. Ora però l’aspetto più interessante, in questo scritto, è quello che riguarda una figura tradizionalmente vincente e, da qualche tempo, tragicamente perdente: il Dio Padre, il Padre, la Patria. Una precisazione.
Da quanto visto in Polonia, nei luoghi dello sterminio, ma non solo, questo discorso del “centro vuoto” non tocca neanche in parte il pontefice attuale, che esercita un ruolo di Padre sui giovani in cerca di un centro che non trovano. Tralascio al momento quest’aspetto. Non ho intenzione di affiancare il “cadavere” del Padre o di Dio Padre a quello di chi sta esercitando un grande ruolo, anche politico, come Papa Francesco.

Comincio dal «visto»: Assalto al cielo, il film sul ’68 di Francesco Munzi, presentato fuori concorso al festival di Venezia e su cui ha scritto Silvana Silvestri. Sono andata a vederlo perché Munzi è un bravissimo regista, ha fatto bei film, specie l’ultimo, Anime nere. Insomma: una garanzia preziosa visto che la materia è stata fino ad oggi quanto mai maltrattata.
Penso all’orrenda celebrazione ufficiale del quarantesimo, otto anni fa, quando il movimento che pur con tutti i suoi errori e difetti ha segnato un cambiamento d’epoca è stato generalmente ridotto a «sesso droga e rock and roll».
Non mi sono sbagliata: il film è rispettoso della serietà dell’impegno e della passione politica che hanno animato una consistente parte della generazione arrivata alla maturità quasi mezzo secolo fa e le immagini - moltissime custodite dall’Archivio del movimento operaio e democratico, ma quasi mai arrivate ad un pubblico largo - sono bellissime. Inedita e straziante l’intervista ai genitori del brigatista Walter Alasia. E però. Munzi dice a Montini su Repubblica: «Non volevo che quel movimento restasse ostaggio della memoria di quelli che l’hanno vissuto», che fossero loro gli «unici titolati a parlarne». «Ho esposto i fatti - continua - perché i giovani sappiano dove stava andando l’Italia».
Il film glielo ha davvero fatto capire? Munzi stesso, che nel ’68 non era neppure nato, si è fatto un’idea di cosa è stato? Su questo ho molti dubbi e anche qualche preoccupazione. È vero che ognuno di noi - come giustamente scrive Silvana - avrà una diversa lettura del film a seconda della propria personale esperienza di quegli anni. Il ’68 - che in realtà in Italia durò dieci anni – ha del resto avuto molte anime ed è difficile ridurlo ad una unica espressione. Ma io credo che un dialogo con chi invece all’epoca era già nato non sarebbe operazione oziosa, perché dai frammenti di assemblee infuocate e di manifestazioni violente - che certo ci sono state - non si ricava il senso più profondo, e in questo senso comune, di quella sollevazione generazionale. Che non fu una reazione disperata e puramente utopica, ma la presa di coscienza - maturata dopo il ricco decennio dello sviluppo neocapitalista - dei limiti di un modello di modernizzazione che, se chiuso entro l’orizzonte capitalista, si sarebbe rovesciato in barbarie. Fu, insomma, una precoce critica della modernizzazione in un’epoca in cui buona parte della sinistra tradizionale partecipava al balletto Excelsior.
Fu, certo, anche un movimento antiautoritario, ma la sua specifica caratteristica, fu di aver capito che la libertà non è individuale ma fonda le sue vere radici nei rapporti sociali di produzione (fu questa la frase più popolare di Marcuse). Di qui la ricerca di un rapporto con la classe operaia, che, è vero, produsse anche scontri e incomprensioni, ma fu vitale per determinare un mutamento della lotta nella fabbrica, inizialmente indotto da minoranze, poi contagioso e infatti alla fine veicolato dallo stesso sindacato, che ne garantì l’estensione. Fu merito della Cgil e della Fim-Cisl aprirsi al movimento, sia pure non senza scontri durissimi, al movimento, cosa che non avvenne che in Italia. Gli anni ’70 furono infatti ricchi di conquiste e non solo di disastri.
Poi abbiamo perso. Non solo per i nostri errori, ma anche per quelli di una sinistra tradizionale che stentò a capire. E iniziò una tragica involuzione. Il sistema operò, come così spesso nella storia, una rivoluzione passiva: assunse le istanze libertarie individuali che non mettevano in discussione il potere, e espulse quanto invece dava fastidio. Se insisto a difendere il nucleo comune e vero della memoria sessantottina non è per autodifesa, ma proprio per stabilire un dialogo critico (e autocritico) con quelli nati nei ’90.
Per quanto ho letto invece, mi riferisco all’articolo di Yanis Varoufakis sul manifesto di martedì 6. Sono contenta, perché chiarisce nuovamente e con più chiarezza di quanto aveva fatto in una assemblea a Roma qualche mese fa di essere contrario ad abbandonare il campo di battaglia europeo e a ripiegare su impossibili soluzioni nazionali. Così come auspica il gruppo che fa capo a Lexit, la sinistra pronta ad abbandonare l’Unione europea. I miei dubbi nascono dalla strategia proposta: se vogliamo restituire sovranità al popolo europeo e togliere il diritto di deliberare ai poteri extrapolitici, estranei al sistema democratico, cui il liberismo l’ha affidato, basta la ribellione? Ribellarsi è giusto e utile, ma non mi pare che reinventare «i disubbidienti» sia sufficiente, né qui e tanto meno in Europa. Proprio perché il demos europeo va costruito, decisivo è costruire quegli organismi intermedi che collegano i cittadini con le istituzioni e che possono incidere sulle decisioni riappropriandosi del diritto a deliberare che gli è stato espropriato. Voglio dire costruire un vero sindacato europeo dotato dei diritti di cui è dotato a livello nazionale; reti fra le città per progetti comuni che ripensino il modo di vivere (quanta ispirazione dalla bellissima Biennale di architettura di quest’anno, intitolata significativamente «Siamo al fronte»); rete di organismi consolidati che comincino a gestire direttamente pezzi della società; media comuni sì da evitare la frammentazione dell’opinione pubblica europea su cui gioca il potere. Anche partiti europei veri.
Ma allora non basta disubbidire, occorre invenzione, progetto, organizzazione, egemonia. Senza casematte, ci diceva Gramsci, il campo di battaglia è pericoloso.

Il Fatto Quotidiano, 8 settembre 2016 (p.d.)
Un muro separa ancor oggi la Cipro turca dalla Cipro greca: 12mila soldati greci da una parte, circa 40mila soldati turchi dall’altra. Il progetto fu sbrigativo: nel 1963 il generale inglese Peter Young prese una matita verde e tracciò una linea sulla mappa di Nicosia, creando la sola capitale divisa rimasta al mondo. Il muro di Nicosia sbudella case e strade con una terra di nessuno fatta di costruzioni sbrecciate e vicoli devastati che chiamano Zona Morta.
In attesa che Donald Trump vinca le presidenziali e costruisca il muro tra Usa e Messico (il suo “impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful, southern border wall”), formazioni di ultradestra dilagano in Europa.
In Germania l’Afd di Frauke Petry ha appena stracciato la Cdu di Angela Merkel in Meklenburgo, è già nei parlamenti di tre Laender e l’anno prossimo entrerà di certo nel Bundestag. In Francia il Front National di Marine Le Pen è ormai il primo partito. In Olanda il Pvv anti-europeo e anti-immigrati di Geerd Wilders avrebbe, negli ultimi sondaggi, un quarto delle intenzioni di voto. Il Belgio ha nel governo i nazionalisti fiamminghi dell’N-Va di Bart De Wever ha il 33%. La Slovacchia ha già un elettore su cinque che vota l’estrema destra, e i neonazisti del Sns di Marian Kotleba hanno l’8% e tre ministri. In Ungheria Jobbikha preso il 20% alle politiche del 2014 e il partito nazionalista euroscettico Fidesz esprime il premier, Viktor Orban. Un tribunale ungherese ha chiesto la condanna (rischia a due anni) di Petra Laszlo, la cineoperatrice che nel settembre scorso aveva fatto lo sgambetto ai i migranti in fuga dalla polizia. In Polonia il presidente Duida e la premier Szydlo appartengono al partito ultraconservatore Pis. In Grecia i neonazisti di Alba dorata sono la terza forza con il 7%. In Austria lo xenofobo Fpoe aveva perso di un soffio la presidenza - ma il ballottaggio andrà ripetuto. E nel Regno Unito l’euroscettico Ukip di Nigel Farage ha vinto la Brexit obbligando i tory a cambiare guida (Theresa May) e linea (a destra). Altri muri in arrivo.
 Un contributo rigoroso al lavoro di chi cerca di ricostruire la politica a partire dallo studio delle condizioni reali degli sfruttati (sul mercato del lavoro, nella città e nella società), e abbia imparato che in Italia una sinistra non c'è.
Un contributo rigoroso al lavoro di chi cerca di ricostruire la politica a partire dallo studio delle condizioni reali degli sfruttati (sul mercato del lavoro, nella città e nella società), e abbia imparato che in Italia una sinistra non c'è.
Il manifesto, 7 settembre 2016
Tutto è politico, anche il terremoto, come è visibile ora, dopo i giorni di silenzio e di lutto dovuti al dolore e alla tragedia. Sono politiche le scelte, le prospettive, i progetti realizzati e quelli mai iniziati, le speranze e perfino la corruzione. Per questo mi lascia perplessa parlare di morte della politica.
Mentre certamente è stata consumata una fine, la fine di una forma politica che a lungo abbiamo chiamato sinistra, e che comprende un insieme variegato di organizzazioni, sigle, pratiche, anche movimenti, oltre che un linguaggio e una visione del mondo. Una fine non riconosciuta, continuamente rinviata e posticipata, e per questo sì, trasformata in una cristallizzazione di parole, di pratiche che non dicono più nulla, neanche a chi le perpetua con ostinazione.
Peggio di una morte, per essere chiara, perché ci si è incaponiti a non nominarla, non vederla, e senza riconoscimento non si può elaborare il lutto, tutto si è trascina con sempre minore slancio, con nulli o quasi effetti visibili. Rimangono il rancore, le infinite accuse reciproche, la ripetizione di riti e comportamenti vuoti, parodie del potere che non c’è.
La novità è che ora, forse perché non c’è più nulla da smuovere, non ci sono più obiezioni e resistenze. Il rischio caso mai è il contrario. Confondere questa fine con la fine di tutto, della politica tout court. In un certo senso l’operazione opposta a quelle di Francis Fukuyama, quando nel 1992 proclamava la fine della Storia a fronte della caduta del muro di Berlino e della conseguente vittoria del capitalismo. Perché ha senso contemplare una fine, se si sposta lo sguardo su ciò che può cominciare. Altrimenti si tratta di una resa senza condizioni. E si lascia il campo a chi della cecità, e della confusione che ne è derivata, ha tratto il massimo profitto. In tutti sensi possibili. Economico e politico.
Un aspetto della complessità è che il fantasma della sinistra continua ad esistere, nello scenario politico italiano. Viene identificato con il Pd che pure, fin dalla sua nascita, da quando fu detto che lavoratori e imprenditori ne erano referenti allo stesso titolo, ha abbandonato la ragion d’essere di un partito di sinistra, anche moderato. La difesa della parte più debole della società, la lotta contro le ingiustizie. L’insieme del corpo politico di quel partito, e della società, in prima linea il sistema dei media, hanno assecondato il rovesciamento del campo del riformismo, bandiera nobile di una delle forme della sinistra. Altro che difesa dei deboli.
L’efficienza, la redditività assunte come valori unici hanno aperto la strada a politiche a sostegno delle esigenze di multinazionali e banche. Le riforme sono diventate ciò che favorisce il potere, l’establishment. L’inquinamento del linguaggio è una malattia grave: parole, idee, cose non dicono più ciò che dicevano. È in questa battaglia che la sinistra alternativa/radicale è stata spazzata via, una vicenda che andrebbe ripensata con attenzione e che non è solo il risultato di un’operazione mediatica.
Nel contesto di un cambiamento di segno che ha investito le socialdemocrazie europee. Senza dimenticare i segni di inversione, basti pensare alle tensioni del Labour Party, con Corbyn corpo estraneo all’establishment blairiano, o alle scelte di rottura dei partiti socialisti rispetto alle grandi alleanze in Portogallo e Spagna, quest’ultima una partita tuttora aperta. In Italia Renzi ha radicalizzato la fisionomia del Pd, con una significativa torsione verso il centro, unita a una tensione al potere personale. Molto in sintonia con i progetti dell’establishment internazionale, come è evidente nell’intreccio tra Italicum e la de-forma costituzionale.
Qui si colloca la fine della sinistra. Quella popolare, di massa, quella alternativa, che pur divise anche ferocemente, hanno una lunga storia comune di scambi vitali che hanno segnato la società, hanno portato i risultati che hanno cambiato la vita dei lavoratori, delle donne, dei più poveri. Quei risultati che ora sono attaccati uno ad uno. A cominciare dalle condizioni di vita dei più giovani. La domanda è questa. Perché le sofferenze sociali, sempre più estese e insostenibili, non trovano una voce adeguata? Perché gli 11 milioni di italiani che hanno deciso di rinunciare a curarsi, di fronte a un sistema sanitario sempre più costoso, non sono al centro delle nostre battaglie? Perché il Jobs Act, che pure è stato ampiamente criticato, è passato nel sostanziale silenzio sociale?
Una prima risposta, dolorosa, ritengo sia in quella fine non consumata, che ha reso teatrali e sempre più vuote le proteste. Non conflitto reale, ma messa in scena del conflitto. E forse per quel punto di cui ha scritto Enzo Scandurra su questo giornale: che si è finito per assomigliare, nei comportamenti e nei pensieri, a quel potere a cui ci si opponeva. Non bastano l’invocazione della legalità, la lotta anti-casta, le idee che guidano il Movimento 5stelle, a dare una visione del mondo. Movimento che occupa lo spazio dell’opposizione, e che viene votato da chi ancora va a votare, perché ha una forza ritenuta comunque utile.
Con onestà va detto che una visione non è a portata di mano. E non ci sono ricette taumaturgiche. Non c’è un re che possa imporre la mano e guarire il popolo malato. Due punti mi sembrano chiari. Occorre comprendere, conoscere, interpretare lo stato delle cose. Quello attuale, in tutte le sue dinamiche. Cioè occorre studiare, riflettere, pensare. Lo so, sembra assurdo quando ciò che urge è l’azione. Ma su cosa agire, e come? Al di là delle denunce, delle polemiche ci siamo chiesti, per esempio, perché il corpo delle donne si trova al centro dello scontro politico internazionale? Quale rovesciamento, del progressismo e dei femminismi, è in corso? A quale lavoro, quale rendimento, sono chiamati i corpi, le relazioni affettive, compresi piaceri e depressioni? Insomma, sappiamo a quale disegno sociale ci si oppone? Abbiamo gli attrezzi giusti? L’altro punto è praticare il realismo e la generosità delle battaglie. Uno dei modi per ostinarsi a non riconoscere la fine, e quindi occultare la decomposizione in corso, è rinchiudersi nei propri ambiti.
Movimenti, associazioni, gruppi. Donne, uomini, generi diversi. Un passo necessario è uscire da sé, guardarsi intorno. E scegliere insieme. Penso al referendum costituzionale. La vittoria del No non risolve i problemi specifici, è ovvio. Ma permetterà di affrontare con forza, e quadro istituzionale non compromesso, ogni battaglia
Il manifesto, 7 settembre 2016 (c.m.c.)
La vicenda dei lavoratori della Fca (già Fiat) di Pomigliano-Nola che si sono suicidati o hanno commesso gesti estremi a causa del perdurare di condizioni di lavoro insostenibili sul piano materiale e psicologico è nota ai lettori di questo giornale, così come è conosciuto «l’happening» che ha messo in scena la rappresentazione del suicidio dell’Ad Sergio Marchionne per «estremo rimorso», azione di provocazione e di satira atta ad evocare i gesti disperati dei compagni di lavoro. Questa rappresentazione ha dato il motivo all’azienda di licenziare gli operai che hanno inscenato il suicidio in effigie di Sergio Marchionne.
I lavoratori licenziati si sono rivolti al tribunale del lavoro per fare revocare il provvedimento che a mio parere ha tutti i tratti della rappresaglia. Il tribunale del lavoro, sia in primo grado che nel ricorso di competenza, ha dato ragione all’Azienda con questa fattispecie di motivazione: «un intollerabile incitamento alla violenza (…) una palese violazione dei più elementari doveri discendenti dal rapporto di lavoro gravissimo nocumento morale all’azienda e al suo vertice societario, da ledere irreversibilmente (sic!) il vincolo di fiducia sotteso al rapporto di lavoro».
In seguito, nel riesame del ricorso, il tribunale di Nola ha confermato il primo giudizio. In questa motivazione si legge che le manifestazioni messe in atto: «hanno travalicato i limiti del diritto di critica e si sono tradotte in azioni recanti un grave pregiudizio all’onore e alla reputazione della società resistente, arrecando alla stessa, in ragione della diffusione mediatica che esse hanno ricevuto, anche un grave nocumento all’immagine».
Ritengo che queste parole - dato che le sentenze non si discutono - meritino un’analisi spassionata per trarne un ammaestramento non solo sullo specifico dell’accaduto ma anche di carattere generale e persino universale. L’azienda ritiene che l’azione drammatica della messa in scena di un suicidio in effigie rechi nocumento all’immagine, pregiudizio all’onore, alla reputazione e nuovamente nocumento morale.
Il suicidio reale, carnale, tragico e «violento» di tre esseri umani invece non recherebbe, a quanto pare, danno di sorta al buon nome dell’azienda. Forse i vertici ritengono essere quei suicidi indipendenti dalle condizioni lavoro, dalla cassa integrazione, dallo stillicidio dell’erosione continua dei diritti sociali, dal peggioramento inarrestabile delle prospettive di vita, forse si tratta di un’epidemia suicidaria dovuta all’insostenibile pressione del benessere come in Svezia, visto che il numero di suicidi nel reparto di Nola di quella leggendaria azienda ex vanto dell’italico genio ex italico, pare essere di cento volte superiore alla media nazionale.
Il capo della Fca, imprenditore, pare non cogliere il senso di un suicidio reale quando è causato da disperanti e umilianti condizioni di vita. Mi permetto di suggerirgliene uno servendomi del linguaggio usato da un suo collega meno fortunato di lui che si è tolto la vita a seguito dei morsi della crisi che lo ha rovinato. Ai familiari ha lasciato uno scritto lapidario per spiegare le ragioni del suo gesto: «la dignità è più importante della vita!». Dovrebbe essere semplice da capire, la vita senza dignità cessa di essere tale per diventare sopravvivenza.
Da noi in Italia non c’è stato un dibattito serrato, profondo e diffuso sul concetto di dignità come è accaduto invece in Germania a partire dalla redazione della Costituzione pensata e ratificata all’indomani della micidiale esperienza nazista. Il primo articolo di quella carta recita: «Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt». (La dignità umana è intangibile. Rispettarla e proteggerla è obbligo di ogni potere statale). Ecco quale è il primo è fondante merito della giustizia sociale come del resto proclama anche il primo articolo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
L’attacco portato allo statuto dei lavoratori è un attacco all’idea stessa di dignità del lavoratore nel lavoro e nella vita. È da qui che è necessario ripartire chiedendoci «se questo è un operaio», che è privato dei diritti, che vive sotto ricatto, a cui non è concesso di progettare la propria esistenza e di costruire un futuro migliore per i propri figli, che non può neppure protestare con il legittimo linguaggio della provocazione concesso ad ogni disegnatore satirico, a cui per non perdere il posto si chiede di accettare la condanna alla disperazione senza alzare la testa, come l’ultimo dei servi.

Il manifesto, 6 settembre 2016 (p.d.)
È solo in Italia che questa espressione insignificante e fuorviante ha fatto strada, grazie al contributo indefesso di costituzionalisti di corte affetti da «nuovismo» cronico e sempre pronti ad assecondare le voglie dei potenti di turno, i quali chiedono più spazi per il (loro) governo e meno impedimenti alle (loro) decisioni. Ma il costituzionalismo non era nato per limitare, controllare, controbilanciare il potere di chi ha potere? La domanda è retorica, ma le risposte sul punto sono quasi sempre balbettanti.
Tuttavia, anche prendendo per buona l’etichetta di «democrazia governante», ci sono almeno tre ragioni per cui l’attuale progetto di revisione costituzionale non ci consegnerà una struttura di governo più stabile in grado di prendere decisioni più efficienti. La prima ragione è, per così dire, di contesto. Le democrazie nazionali – come ha scritto Peter Mair nel suo libro postumo (Ruling the void, 2013) tradotto da Rubbettino – sono destinate, e lo saranno sempre di più, a «governare il vuoto», a decidere tra alternative che non esistono, a regnare sul nulla. Ormai, le decisioni che contano e che incidono sui «margini di manovra» dei governanti nazionali sono prese altrove, al di fuori del recinto statale, da istituzioni sovranazionali dove il volere dei cittadini e la sovranità del popolo arrivano soltanto di riflesso, come un’eco lontana quasi impercettibile. Chi sognava una democrazia governante ha, dunque, sbagliato bersaglio e avrebbe fatto meglio a guardare all’Europa, non all’Italia.
La seconda ragione per cui questa fantomatica democrazia-che-decide è una, neanche troppo pia, illusione è che alla sua base c’è una diagnosi fallace. Da almeno un ventennio è sotto i nostri occhi, ma fingiamo di non vederlo: non è il «motore» (cioè l’impianto istituzionale) ad essersi inceppato, ma è il pilota, chi sta al posto di comando che non è più in grado di svolgere adeguatamente il proprio mestiere. Lo dico più chiaramente: non sono (tanto) le istituzioni che non funzionano, ma sono i partiti e i loro dirigenti, che avrebbero il compito di guidare il sistema politico, a non essere all’altezza della loro funzione. Ma, pur di non ri-formare se stessi, si industriano in ambiziosi progetti istituzionali destinati a girare perennemente a vuoto: avremo (ci dicono) un motore più veloce, ma non sapremo dove, come e con chi andare. E il riformismo dall’alto – si sa – ha sempre fatto pochissima strada, non solo in Italia.
L’ultima ragione della fallacia della cosiddetta democrazia governante in salsa italiana è che, pur progettata allo scopo prevalente di prendere decisioni rapide e «in tempi certi», manca clamorosamente il suo bersaglio.
L’impianto istituzionale che emerge dalle riforme elettorali e costituzionali ci consegna un senato sgangherato per composizione e confuso nelle sue funzioni. Il nuovo procedimento legislativo non sarà più snello, lineare o chiaro, ma dovrà percorrere un tortuoso iter – distinguendo ogni disegno di legge per tipologia, per materia e, in certi casi, anche per contenuto (generale o specifico) – che sarà foriero di numerosi conflitti inter-istituzionali e non produrrà né più leggi (come chiedono i «riformatori») né leggi migliori (come vorrebbero gli italiani).
Neanche la nuova legge elettorale, il tanto sbandierato Italicum, ci aiuterà a costruire una democrazia del buon governo. Restare immobilizzati in carica per cinque anni, a dispetto delle prestazioni e delle capacità dei governanti, oltre ad essere in contrasto con i principi del parlamentarismo, non è affatto sinonimo di stabilità politica. L’Italicum produrrà una rigidità istituzionale tipica del presidenzialismo, senza averne importato pesi e contrappesi. Alla fine, ci troveremo con un governo statico e stagnante, incapace di prendere buone decisioni, ma inamovibile dal potere.
Cercavano una democrazia governante e ci stanno propinando una «democrazia sgovernata». Meglio l’esistente che l’indecente.
 «Una timida democratizzazione e la Lexit dall’Ue sono due opzioni opposte, ma destinate entrambe alla sconfitta e a rafforzare le oligarchie economiche e finanziarie».
«Una timida democratizzazione e la Lexit dall’Ue sono due opzioni opposte, ma destinate entrambe alla sconfitta e a rafforzare le oligarchie economiche e finanziarie».
Il manifesto, 6 settembre 2016 (p.d.)
Nel giro di pochi mesi, due referendum hanno scosso l’Unione europea e la stessa sinistra europea: nel luglio 2015 l’Oxi in Grecia, e nel giugno 2016 la Brexit nel Regno unito.
Una parte della sinistra europea, esasperata dalla miscela di autoritarismo e fallimento economico che caratterizza l’Ue, propone ora di «rompere con l’Ue»; è la Lexit. DiEM25, il transnazionale Movimento per la democrazia in Europa, rifiuta questa logica e offre un’agenda alternativa ai progressisti del continente.
Il punto non è se la sinistra debba scontrarsi con l’establishment dell’Ue e le sue politiche abituali. La questione è invece in quale contesto, e all’interno di quale narrazione politica comune questo scontro debba svolgersi. Esaminiamo le tre opzioni.
L’euroriformismo standard, praticato tipicamente dai socialdemocratici, sta perdendo rapidamente terreno. Si fonda su un errore: l’Unione europea non soffre di un deficit di democrazia al quale si possa porre rimedio con «un po’ più di democrazia», «più Europa», «riforma delle istituzioni europee» eccetera.
L’Ue è stata intenzionalmente costruita per tenere il demos fuori dai processi decisionali affindandoli a un cartello composto dalle grandi imprese europee e dal settore finanziario.
Nel quadro dell’attuale regime e delle attuali istituzioni dell’Ue, «più Europa» e riforme graduali equivarrebbero alla formalizzazione e legittimazione dell’Unione dell’austerità europea secondo le linee del Piano Schäuble. Questo acuirebbe la crisi che colpisce i cittadini europei più deboli, renderebbe più attraente la destra xenofobica e in ogni caso accelererebbe la disintegrazione europea.
Un’opzione evocata, fra gli altri, da Tariq Ali: per sconfiggere la misantropia della destra xenofobica dovremmo far nostra la sua proposta di referendum nazionali per l’uscita dall’Ue.
Ma è realistico pensare che, proponendo dei referendum per l’uscita dall’Ue, la sinistra possa «bloccare le forze della destra xenofoba e nazionalista guadagnando l’egemonia e ridirezionando la rivolta popolare?» E questa campagna è coerente con i principi fondamentali della sinistra? DiEM25 risponde con due no, e per questa ragione rifiuta l’opzione Lexit.
La Lexit pone seri pericoli. I sostenitori della Lexit pensano davvero che oggi la sinistra possa vincere la battaglia per l’egemonia contro la destra xenofobica appoggiando le richieste di quest’ultima circa la costruzione di nuove barriere e la fine della libertà di movimento? E allo stesso modo, pensano davvero che la sinistra vincerà la guerra delle idee e della politica contro l’industria dei combustibili fossili sostenendo la rinazionalizzazione della politica ambientale?
Sotto la bandiera della Lexit, a mio giudizio, la sinistra subirà gigantesche sconfitte su entrambi i fronti.
DiEM25 propone un movimento paneuropeo di disobbedienza civile e governativa con l’obiettivo di consolidare un’opposizione democratica alle scelte delle élites europee a livello locale, nazionale e di Ue.
Come DiEM25 non crediamo che l’Unione europea si possa riformare con i canali abituali della politica europea. La nostra controproposta è uno scontro con l’establishment europeo sulla base di una campagna di disobbedienza alle «leggi» dell’Ue a livello locale, regionale e nazionale, senza però pensare all’uscita dall’Unione.
La posizione del DiEm25 sull’Ue riflette il tradizionale internazionalismo della sinistra, che è una componente essenziale di DiEM25.
DiEM25 propone una ribellione che porti a una democrazia autentica a livello dei governi locali e nazionali e dell’Ue. Non diamo priorità all’Ue rispetto al livello nazionale, né a quest’ultimo rispetto al livello regionale e locale.
In un recente intervento Stefano Fassina sostiene (citando Ralf Dahrendorf) che la democrazia a livello di Ue «non è possibile… perché un popolo europeo, un demos europeo per una democrazia europea, non esiste». Continua Fassina: «Fra gli idealisti e gli euro-fanatici, alcuni continuano a pensare che l’Unione europea si possa trasformare in una sorta di Stato nazionale, solo più grande: gli Stati uniti d’Europa.»
Questa obiezione di sinistra all’appello di DiEM25 per un movimento paneuropeo è interessante e stimolante. Sostiene che la democrazia è impossibile a livello sovranazionale perché un demos deve essere caratterizzato da un’omogeneità nazionale e culturale. Marx non sarebbe affatto d’accordo! E posso immaginare lo stupore degli internazionalisti di sinistra, i quali hanno sognato e combattuto per una repubblica transnazionale dall’Atlantico all’Oriente.
La sinistra ha sempre sostenuto che l’identità è qualcosa che si crea con la lotta politica (di classe, contro il patriarcato, contro gli stereotipi, per l’emancipazione dall’Impero ecc.).
DiEM25, proponendo una campagna paneuropea di disobbedienza alle élites transnazionali, per creare un demos europeo che realizzi una democrazia europea, è in sintonia con l’approccio tradizionale della sinistra: proprio quell’approccio criticato da Fassina e dagli altri che sostengono il ritorno alla politica basata su una nazione/un parlamento/una sovranità , riducendo l’internazionalismo alla «cooperazione» fra gli Stati nazionali europei.
Nello stesso spirito gramsciano, DiEM25 insiste sul fatto che la nostra ribellione europea dovrebbe avvenire a ogni livello: città, regioni, capitali nazionali e Bruxelles, a parità di priorità. Solo una rete paneuropea di città ribelli, prefetture ribelli, governi ribelli, un movimento progressista può diventare egemone in Italia, Grecia, Regno unito, ovunque.
Qualcuno potrebbe chiedere: «Perché allora fermarsi al livello dell’Ue? In quanto internazionalisti, perché non militate per una democrazia su scala planetaria?» La nostra risposta è che lo facciamo. Abbiamo forti legami con la «rivoluzione politica» di Bernie Sanders negli Stati uniti e con militanti nei vari continenti. Ma dal momento che la storia bene o male ha partorito un’Europa senza frontiere, con politiche comuni in campo ambientale e in vari altri campi, la sinistra (per definizione internazionalista) deve difendere quest’assenza di frontiere.
A chi definisce utopistico il nostro movimento per una democrazia paneuropea, rispondiamo che si tratta di un obiettivo legittimo e realistico per il lungo periodo.
Non possiamo sapere se l’Ue si democratizzerà o si dissolverà. Lottiamo per la prima eventualità preparandoci comunque ad affrontare la seconda.
L’Agenda europea di DiEM25 propone una campagna unificante grazie alla quale un’Internazionale progressista europea possa contrastare l’Internazionale nazionalista che è in continua crescita.
Lanciare e sviluppare una grande campagna internazionalista in tutta Europa per un’Unione democratica significa che l’Ue non possa e non debba sopravvivere nella sua forma attuale.
Una campagna che ha come coordinate la denuncia dell’incompetenza dell’establishment autoritario dell’Ue; il coordinamento della disobbedienza civile, civica e governativa in tutta Europa. Illustrare con la struttura stessa di DiEM25 come una democrazia paneuropea possa lavorare a tutti i livelli e in tutti gli ambiti
Tutto questo mira alla elaborazione di un’agenda europea omnicomprensiva con proposte intelligenti, modeste e convincenti per «aggiustare» l’Ue (e anche l’euro) e al tempo stesso per gestire progressivamente la disintegrazione dell’Ue e dell’euro, se e quando l’establishment la provocherà.
coordinamentodemocraziacostituzionale online, 5 settembre 2016 (c.m.c.)
Premessa
Conoscere per votare è il titolo di queste riflessioni. Un titolo che vuole parafrasare l’insegnamento di Einaudi a proposito del:“conoscere per deliberare”.
Quattro aspetti sono da tenere presente per una doverosa informazione che renda edotti i cittadini italiani sui seri e fondati motivi per votare No alla proposta governativa di riformare la costituzione.
1) Necessità di una informazione completa, testo alla mano, sui contenuti specifici della riforma che, per come hanno dimostrato autorevolissimi costituzionalisti in numerosi documenti e appelli, non è un cambiamento per migliorare, ma per peggiorare in modo pericoloso l’ordinamento costituzionale;
2) Necessità di informare i cittadini sull’intreccio tra riforma costituzionale e legge elettorale. Infatti entrambe le leggi sono state preordinate per trasformare i cittadini in sudditi di un ordinamento senza validi contropoteri, un ordinamento che sostanzialmente finirebbe per essere posto sotto l’egemonia di un uomo solo al comando;
3) Necessità di sottolineare il fatto che qualsiasi normativa, specialmente quella avente valore costituzionale, va valutata sia nei dettagli che nei significati dell’insieme del corpo normativo, atteso che ci sono effetti innumerevoli in conseguenza di un previsto cambiamento di oltre 40 articoli sui 139 che compongono la nostra Carta;
4) Necessità di evitare di personalizzare l’opposizione alla condotta del Capo del Governo per non mischiare gli aspetti del renzismo e dell’anti renzismo con i contenuti effettivi delle riforme le quali pregiudicano di per se stesse l’ordinamento democratico del nostro Paese, a prescindere dalle considerazioni riguardanti l’attuale inquilino di Palazzo Chigi.
Quest’ultimo aspetto, ispirato al rispetto dovuto alle istituzioni e alle differenti opinioni dei cittadini, sta dimostrando una sorprendente sopraffazione in danno delle ragioni del no alla riforma. Ciò accade a causa del ruolo che stanno svolgendo i vertici governativi a favore di essi medesimi. Infatti il Governo non sta svolgendo un ruolo istituzionale nell’interesse di tutti i cittadini, ruolo che è un atto dovuto per assicurare un sereno confronto tra i contrari e i favorevoli alle riforme.
Tutti stiamo toccando con mano che c’è un impari scontro tra il gigante Golia e Davide. Golia è, ovviamente, il gigantesco apparato governativo mobilitato e impiegato per perpetuare, attraverso la riforma costituzionale e la legge elettorale, il renzismo e la sua idea dell’appropriazione dei palazzi del potere nel cui interno dovrebbe regnare il metodo del “comando” senza contropoteri.
L’appropriazione della RAI in senso monopolistico da parte del Governo, è la prova visibile e incontrovertibile della natura e del contenuto delle idee-guida e degli scopi del renzismo, che sono una visione politico-programmatica tutta concentrata sulla conquista e sull’uso proprietario del pubblico potere. La chiave di lettura delle riforme, quindi, diventa inevitabilmente l’esame del perché e del percome si vorrebbe cambiare, in senso peggiorativo, una consistente e significativa parte della Costituzione.
Le date da ricordare e i due appuntamenti dell’autunno 2016
Il renzismo ha raggiunto il risultato che si era posto, cioè l’occupazione del palazzo del Potere Esecutivo, nel Febbraio del 2014, dopo due mesi dalla Sentenza N. 1 del 13 Gennaio 2014 con la quale la Corte Costituzionale ha accertato e dichiarato che la legge elettorale denominata porcellum è incostituzionale.
Le date e le modalità con le quali ha conquistato Palazzo Chigi e le date in cui è partito il disegno di stravolgere la Costituzione sono fatti che non hanno bisogno di commenti: parlano da sole.
Con la sua azione di Governo il renzismo, senza alcun mandato popolare, si è impegnato in modo sconcertante per farsi una legge elettorale e una costituzione di comodo. Queste leggi hanno il prevalente scopo, dichiarato, di perpetuare il renzismo. Sono state fatte votare con atti di imperio, richiesta di fiducia, canguri e ricatti politici vari ad un Parlamento delegittimato politicamente in quanto eletto con una legge elettorale incostituzionale. La maggioranza governativa si è allargata via via raggiungendo un record di voltagabbana accorsi in aiuto del Governo.
Dall’estate del 2016 siamo sotto il bombardamento di una indescrivibile propaganda governativa a favore del “sì” nel prossimo referendum in cui necessita votare SÌ o NO ad una riforma che, di fatto, punta a dare legittimazione politica a scelte fatte da novelli costituenti sulla cui credibilità politica c’è molto, ma molto da discutere.
Ci sono due appuntamenti importanti nel prossimo autunno.
Uno in cui il popolo potrà riprendersi la sovranità nel referendum in cui la posta in gioco è il tentativo del Governo di farsi approvare una costituzione di comodo.
L’altro concerne il giudizio che si svolgerà il prossimo 4 ottobre 2016 innanzi alla Corte Costituzionale perché i sostenitori del NO hanno eccepito presso molti Tribunali, vizi di costituzionalità nella legge elettorale denominata “italicum” e imposta dal renzismo con la richiesta di fiducia.
La propaganda governativa, le televisioni e molti giornalisti non si soffermano su questo dettaglio, che non è di poco conto. Sta di fatto che molti cittadini italiani sono stati indotti a credere che questa udienza innanzi alla Corte faccia parte di una normale procedura. Non si mette in giusto risalto che questo giudizio è subito dal Governo. Ciò comporta, a prescindere dalle decisioni che dovesse adottare la Corte, una grave disinformazione in danno dei diritti all’informazione.
Il potere costituito che diventa potere costituente
È noto il “potere di attrazione” della funzione governativa. Non è caso di soffermarsi sulla fenomenologia del “fascino” e della capacità di persuasione di chi abbia in mano le leve del potere.
Costituzionalisti, politici e intellettuali di varie scuole di pensiero, hanno sostenuto e sostengono che ci sono pericoli per la democrazia qualora il Governo non faccia un passo indietro nelle occasioni in cui si debba legiferare in materia costituzionale. Del resto non è immaginabile che ogni governo si faccia una sua costituzione di comodo. Ecco perché si usa dire che non spetta al potere costituito trasformarsi in potere costituente.
Calamandrei disse chiaramente che quando in Parlamento si discute di Costituzione i banchi del Governo devono essere vuoti.
Tutti noi abbiamo visto, invece, che la votazione della riforma costituzionale, che porta il nome Renzi-Boschi, è stata approvata con i banchi del Governo pieni di ministri e con i banchi dell’opposizione vuoti in segno di protesta per l’invadenza governativa. Una invadenza avvenuta non solo nella fase finale del voto, ma manifestatasi con atti di imperio governativi di varia natura durante tutto il processo di formazione della volontà facente capo alla funzione legislativa.
Addirittura il Governo ha preteso di rimuovere dalle Commissione Affari Costituzionali parlamentari che, invocando la libertà di coscienza, non erano d’accordo con i diktat governativi. Questa invadenza, che è stata consegnata alla storia, non la si può cancellare dalla memoria degli italiani, nemmeno dopo gli esiti del prossimo referendum costituzionale.
I pericoli che si intravedono nel ruolo invasivo del Governo in materia costituzionale non sono astratti principi enunciati dai costituzionalisti. Li abbiamo toccati con mano quando abbiamo visto e sentito le aggressioni verbali consumate dai vertici governativi contro i costituzionalisti che criticavano le riforme. Non dobbiamo sottovalutare i termini spregiativi usati: “gufi”, “rosiconi”, “professoroni”. La tecnica denigratoria è comune a quella usata nei regimi totalitari: il fascismo usava denigrare il “culturame”.
Quando voteremo un NO sonoro nel prossimo referendum sarà la volta buona, per noi cittadini, di dire grazie ai “professoroni” che non si sono lasciati né intimidire e né irretire dal “fascino del potere” e che hanno avuto il coraggio di descrivere per filo e per segno le mille ragioni per votare NO. E sia ben chiaro che il NO dei “professoroni” e il nostro NO, di cittadini, non è un NO a qualsiasi riforma, che è sempre possibile attuare in futuro come lo è stato in passato, ma un NO a questa specifica riforma per le modalità con cui è stata realizzata e per i suoi contenuti.
Qualche esempio di disinformazione
Necessita far sapere ai cittadini che il Senato non sarebbe soppresso, ma sostituito allo scopo principale di nominarlo a cura dei soliti noti e, quindi, allo scopo di togliere ai cittadini il diritto di eleggere i senatori. Si vuole mettere mano al Senato per togliere diritti, non per aumentarli.
La questione dei risparmi, se effettivamente stessero a cuore dei nuovi costituenti, sarebbe stata risolta o sopprimendo completamente il Senato oppure diminuendo del 50% il numero dei deputati e dei senatori. Autorevolissimi costituzionalisti non sono riusciti a mettersi d’accordo sul numero dei differenti procedimenti legislativi che darebbero origine le inspiegabili norme dell’art. 70. Chi parla di 7 procedimenti, chi di 10. In molti sono d’accordo nell’affermare che si passerebbe da un bicameralismo perfetto ad un bicameralismo confuso e produttivo di conflitti e paralisi legislativa.
Basta leggere il famigerato art. 70 per rendersi conto che i rottamatori hanno voluto sporcare la Costituzione vigente, che aveva ricevuto il premio letterario Strega per la sua chiarezza e per la facile comprensione del testo. È da ricordare, in proposito, che la Costituzione italiana è stata scritta, a suo tempo, con frasi di poche parole per renderle comprensibili a tutti i cittadini. Ciò per mettere il cittadino nella condizione di capire la Legge delle leggi senza il bisogno di chiedere spiegazioni ad esperti del diritto.
Spesso, come conseguenza della propaganda governativa, si sentono bugie, slogan e sorprendenti luoghi comuni.
Si può fare qualche esempio. È facile sentire dire che da 70 anni si aspetta di riformare la Costituzione, affermazione, questa, che il Presidente del Consiglio e il Ministro delle riforme hanno avuto modo di fare. Non è pensabile che i due alti esponenti del Governo ignorino che la Costituzione non ha ancora 70 anni di età perché è entrata in vigore il 1948. Ma è singolare che la medesima “bugia” sia stata diffusa al plurale, nel senso che sono stati in due a disseminarla. È da considerare, invece, che tra gli effetti della propaganda irresponsabile si verifica il tipico fenomeno così riassumibile: se butti in aria un pugno di farina non lo puoi più raccogliere.
L’immensa forza della propaganda a favore del “sì”
Pericolosa è la propaganda governativa quando il Governo da potere costituito si trasforma in potere costituente.
Non è un caso che il Governo si sia appropriato in termini monopolistici della RAI. Si possono addirittura quantificare le ore di TV messe a disposizione del governo per propagandare il “si” e lo scarsissimo spazio lasciato ai sostenitori del NO.
Non è un caso che di tutto si parla, meno del fatto che questa riforma è stata voluta, non dal popolo sovrano e non dai governati, ma dal Governo, un Governo che si regge sulla fiducia ottenuta da un Parlamento dichiarato eletto con una legge elettorale incostituzionale.
Non è un caso che il record dei voltagabbana accorsi a sostegno del Governo sia stato stabilito in questa diciassettesima legislatura.
Non è un caso che una delle parole-guida dei voltagabbana, il “cambiamento”, sia uno degli argomenti forti del Governo Renzi, che insiste sull’importanza del cambiamento a prescindere dal valutare quando il cambiamento sia introdotto per migliorare o per peggiorare.
Non è un caso che nella propaganda governativa si dica che è meglio “cambiare” la Costituzione, anche se con qualche errore di scrittura, piuttosto che non cambiare niente.
Non è un caso che il Governo abbia messo in atto un’occupazione dei palazzi del potere, RAI compresa, con modalità senza precedenti.
Il tifo e gli “aiutini” stranieri per il Governo
Non è un caso che il Governo abbia reclutato un esperto americano della propaganda, Joe Messina, per sostenere il “sì” ad una costituzione di comodo. Questo reclutamento suscita perplessità e interrogativi di varia natura e consegna alla storia un altro capitolo sullo “spirito costituente” che caratterizza l’operato dei novelli padri e madri costituenti. I Padri costituenti reclutarono i più autorevoli linguisti (di lingua italiana) per rendere chiaro e comprensibile a tutti i cittadini il testo non divisivo, ma unificante. Il Capo del Governo e Capo del suo partito (un’organizzazione di parte) ha ora reclutato un americano propagandista (di lingua inglese) per avere sostegno propagandistico a favore di un testo costituzionale incomprensibile, prevaricante e divisivo.
Non mancano aiuti dalla stampa estera al Governo con articoli che disegnano scenari apocalittici se non vincesse il “si” alla Costituzione Renzi-Boschi. La “narrazione” governativa sulla riforma e sulla finalità del progetto “renziano” convergono con questi ineffabili “aiutini”. E convergono anche nel non entrare, testo alla mano, sui contenuti della normativa. Sarebbe “curioso” chiedere a questi giornalisti se l’abbiano tradotto in lingua inglese e, quindi, letto e capito l’art. 70, che è di diffide comprensione anche per gli esperti del diritto costituzionale italiano. Ma stiano sereni gli aiutanti del Governo. Siamo in molti a voler conoscere per deliberare, quindi conoscere per votare. Votare in modo consapevole e responsabile, anche nei confronti dei nostri figli e dei nostri nipoti, significa approfondire il testo che dovremo lasciare in eredità alle future generazioni.
Le parole chiave del renzismo
Come cittadino italiano, mi duole, sinceramente, di dover mettere a fuoco i sorprendenti (per usare un eufemismo) comportamenti dei vertici governativi. Infatti mi ritrovo in sintonia con la scuola di pensiero riferibile al filosofo svizzero Amiel: «L’esperienza di ogni uomo ricomincia daccapo. Soltanto le istituzioni diventano più sagge: esse accumulano l’esperienza collettiva e, da tale esperienza, da tale saggezza, gli uomini soggetti alle stesse norme non cambieranno certo la loro natura ma trasformeranno gradualmente il loro comportamento».
Cosa viene generato dal renzismo e in particolare dal suo modo di fare e dal suo linguaggio?
L’ABC e la storia del renzismo le troviamo specchiate in tre parole chiave:
1) “Arroganza”, che si percepisce da ogni azione e da ogni parola, com’è il caso della parola “rottamazione” usata nei confronti di persone e istituzioni, Costituzione compresa;
2) “Bugia”, pronunciata con l’uso spregiudicato dei media (ad esempio “stai sereno Enrico”, il famoso messaggio rivolto al Presidente del Consiglio pro-tempore pochi giorni prima di farlo fuori per prendergli la poltrona);
3) “Comandare”, nel senso che chi vince le elezioni comanda per 5 anni e nel senso che l’idea fissa del renzismo è l’occupazione dei palazzi del potere. L’idea di “comandare” e di voler comandare all’interno di qualsiasi istituzione quasi sempre disconosce e agisce in dispregio della qualità e dell’efficacia del saper “dirigere” e del saper governare nel rispetto degli interessi generali.
Tra le parole improprie e al limite della bugia usate dal renzismo, ne cito un paio.
La prima è l’uso improprio della parola “modernità”, nel senso che il renzismo vuole e persegue, di fatto, non la modernità, ma il ritorno all’antichità dell’uomo solo al comando cancellando tutta la cultura e tutta la vera modernità iniziata con il recepimento dei principi della divisione dei poteri teorizzati da Montesquieu.
La seconda è l’uso ingannevole della parola “cambiamento”, nel senso che il messaggio del renzismo tende a persuadere la gente ad accettare l’idea di un cambiamento a prescindere dell’entrare nel merito del proposto cambiamento che, com’è noto, può essere in meglio o in peggio. Sta di fatto che le sue riforme sono tutte improntate al peggio e alla complicazione (altro che semplificazione) come si può capire, ad esempio, leggendo gli articoli 70 e 71 della sua proposta di riforma. Invero una semplificazione c’è, quella di costruire un ordinamento senza contropoteri per dare mano libera all’inquilino di Palazzo Chigi. Tra le complicazioni introdotte c’è anche l’allontanamento dei cittadini dalla politica triplicando il numero delle firme necessarie per una iniziativa popolare (da 50 mila a 150 mila firme di difficilissima e costosissima certificazione).
Alcune significative dichiarazioni dei vertici governativi
È appena il caso di ricordare che il 9 agosto 2016 è intervenuta una dichiarazione sconcertante da parte del Ministro Maria Elena Boschi. Secondo il Ministro sarebbe una mancanza di rispetto al Parlamento la proposta di votare NO alla riforma. Siccome l’art. 138, secondo e terzo comma, della Costituzione prevede la possibilità di referendum popolare su revisioni costituzionali che non abbiano ottenuto il voto di due terzi dei componenti il Parlamento, l’affermazione del Ministro confligge con quanto stabilito da questo articolo e quindi equivale ad ingannare i cittadini per poter far loro credere che solo il voto “SÌ” rispetterebbe la democrazia parlamentare. È di solare evidenza, altresì, che l’affermazione del Ministro configura due gravissimi attacchi ai principi, uno alla libertà del cittadino e uno all’autodifesa normativa sancita dalla Costituzione.
Quasi contemporaneamente alle dichiarazioni del Ministro Boschi sono rimbalzate nelle TV le notizie di una affermazione de capo del Governo Renzi che promette di distribuire ai poveri i presunti risparmi conseguenti al suo progetto di sopprimere il Senato. In proposito ha dato i numeri: 500 milioni che darà alla povertà.
Conclusioni
Non ci sono parole innanzi al discredito e allo sfregio messi in campo contro le istituzioni e contro l’architettura costituzionale da parte della subcultura della rottamazione. Stiamo assistendo ad una propaganda di regime e a linguaggi che hanno i connotati tipici della sopraffazione per perpetuare l’occupazione dei palazzi del potere.
Un cenno è d’obbligo alla legge elettorale imposta dal Governo con voto di fiducia ed intrecciata con la riforma costituzionale. Essa è denominata ‘italicum’, ma si dovrebbe chiamare “Acerbum” per le sue similitudini con la legge elettorale Acerbo a suo tempo destinata a legittimare il fascismo. Questa legge “Acerbum”, peraltro, uccide il principio liberale “una testa un voto” previsto dalla Costituzione.
In questi tempi caratterizzati da una legislatura, la XVII, eletta con una legge elettorale incostituzionale, è diventata di solare evidenza una “resistibile ascesa” nei palazzi del potere di una grande voglia di trasformare i cittadini in sudditi di un uomo solo al comando. Si vorrebbero restringere, non allargare i diritti dei cittadini. Addirittura si vorrebbe togliere per sempre il diritto dei cittadini di eleggere il Senato in capo al quale sono stati previsti compiti e funzioni per paralizzare in futuro riforme razionali (anche di natura costituzionale) di segno diverso da quello attualmente egemone.
L’egemonia dell’attuale Governo non è rappresentativa della maggioranza degli italiani, come ha dimostrato la Sentenza N. 1 del 2014 della Corte Costituzionale. In pratica una minoranza fattasi maggioranza col trucco dell’incostituzionale porcellum e con l’aiuto di voltagabbana, ha predisposto un intruglio di norme che, per come avvertono costituzionalisti autorevoli, sta tentando di far passare una sostanziale modifica dell’art. 1 della Costituzione nella parte in cui è previsto che la sovranità appartiene al popolo.
Tra sudditanza e cittadinanza attiva è chiara la differenza. La differenza la farà il voto per il NO alla riforma Renzi-Boschi con la consapevolezza che la Costituzione si potrà in futuro cambiare in meglio, non in peggio.
Il Fatto Quotidiano online, blog lettori, 5 settembre 2016 (c.m.c.)
La sgangherata campagna per il Fertility Day promossa dal Ministero della Salute, ha però avuto il pregio di sollevare l’attenzione sulla condizione femminile in Italia, dal punto di vista sia lavorativo che “riproduttivo”. Innanzitutto, alcuni dati.
Nel 2015 sono state registrate circa 488mila nascite, quindicimila in meno rispetto al 2014. Si tratta del minimo storico mai raggiunto dallo Stato italiano. Per trovare dati simili bisogna tornare al 1917-18, quando una buona fetta di popolazione maschile in età fertile era al fronte, nelle trincee. È anche vero che l’età del concepimento si sposta sempre più avanti: l’Italia è il Paese con le mamme più vecchie d’Europa. Per dire: in Romania le neo-mamme over 35 sono il 10,9%, in Italia il 34,7%. In Liguria, Lazio, Sardegna un bambino su dieci nasce da mamme ultraquarantenni.
I numeri vanno tutti nella stessa direzione: l’Italia è il terzultimo Paese europeo per numero di donne occupate, davanti alle sole Grecia e Macedonia. In Italia lavora solo il 57% delle donne tra i 25 e i 54 anni e la media è di 1,3 figli per coppia.
Sempre in Italia, più di 5 donne su 10 sono senza reddito da lavoro e, per quelle che il reddito lo hanno, la retribuzione media pro capite (calcolata tra impiegate e operaie) si ferma sotto i 25mila euro annui, mentre quella di un uomo sfonda il tetto dei 31mila.
In Svezia le donne che lavorano sono l’83% e la media-figli sale a 1,9. Il motivo è piuttosto semplice: il lavoro della donna porta alla coppia uno stipendio in più. E se lavori e decidi di fare un figlio è perché hai un sistema di welfare che ti permette di conciliare i tempi della famiglia con quelli della professione.
Analizzando gli investimenti statali, la spesa pubblica per la famiglia, pari a 16,5 miliardi, spiegano gli autori di uno studio curato dall’Ufficio studi di Confartigianato, è appena l’1% del Pil, a fronte degli interventi per gli anziani che, tra pensioni e spesa per la salute, corrispondono al 20% del Pil. In pratica, per 1 euro speso a favore della famiglia se ne dedicano 20 agli over 65.
Il basso livello di spesa per la famiglia colloca l’Italia al 22° posto tra i Paesi Ue per la quantità di risorse dedicate a questo capitolo di interventi pubblici che, nella media dei Paesi europei, si attesta all’1,7% del Pil. Al contrario, la spesa pubblica per anziani in Italia supera del 4,9% la media europea che si attesta ad una quota pari al 15,1% del Pil.
L’esigua quantità di spesa pubblica in servizi per la famiglia incide negativamente sulla natalità e penalizza l’occupazione femminile. Secondo lo studio di Confartigianato, infatti, per le donne tra 25 e 44 anni senza figli il tasso di attività lavorativa è dell’82,1%, ma scende al 63% per le donne della stessa età con figli, con un gap di oltre il 19%. Segno che lo Stato non offre quei servizi che consentono alle madri di conciliare il lavoro con la cura della famiglia. E per la cura dei figli le donne si affidano soprattutto a reti di aiuto informale con il 51,4% dei bambini con meno di due anni accudito dai nonni, mentre il 37,8% frequenta un asilo nido. La baby sitter viene scelta come modalità di affido prevalente soltanto dal 4,2% delle madri lavoratrici. L’arrivo di un figlio costa il posto di lavoro a un’italiana su due.
Secondo l’Istat, 800 mila donne, con l’arrivo di un figlio, sono state costrette a lasciare il lavoro, perché licenziate o messe nelle condizioni di doversi dimettere. A subire più spesso questo trattamento, non sono le donne delle generazioni più anziane ma le più giovani, le residenti nel Mezzogiorno (10,5 per cento) e le donne con titoli di studio basso (10,4). Una volta lasciato il lavoro solo il 40,7 ha poi ripreso l’attività, con delle forti differenze: su 100 donne licenziate o indotte a dimettersi riprendono a lavorare 15 nel Nord e 23 nel Sud.
In un paese come il nostro, già segnato da una bassa occupazione femminile un nuovo, possibile anticorpo alla “resa” delle donne è la riforma del welfare aziendale introdotta dalla Legge di Stabilità, ora in attesa del decreto attuativo.
Al contrario che in Italia, la Francia è la patria delle mamme-lavoratrici in Europa. Oltralpe il 74% delle madri con figli sotto i 15 anni ha un lavoro e il Paese vanta il tasso di natalità più alto: 2,1 figli per donna ed è al quarto posto nella classifica della Cnn dei Paesi dove è più facile vivere da mamma e papà.
Su otto Stati recensiti dal network americano, sette (l’ottavo è il Canada) si trovano in Europa: Islanda, Svezia, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Finlandia e Norvegia.
In Islanda lavora l’85% delle madri con figli sotto i 15 anni, e in Danimarca l’84%, dove la spesa per le famiglie è l’8,6% e la legge prevede 6 mesi al 100 per cento dello stipendio, in Norvegia 10 mesi al 100 per cento oppure 12 all’80 e vi è una percentuale di 1,8 figli per donna.. Dove esiste il congedo per padri, circa l’85 per cento dei neopapà ne usufruisce.
Tutti questi Paesi sono accomunati da un welfare molto attivo e attento a permettere alle famiglie a trovare un nuovo equilibrio vita-lavoro dopo l’arrivo dei figli e, non a caso, lì si fanno più figli. Al sud Italia la dinamica occupazionale è peggiore che al nord. E’ sempre stato così, però ora è ancora peggio.
Qui, a fronte di uomini capifamiglia che hanno perso il lavoro e che si sono ritrovati costretti a casa, ci sono state parecchie donne che si sono messe alla ricerca di un lavoro al posto del marito o del compagno per far fronte alle gravi criticità familiari. Sono infatti aumentate le donne capofamiglia occupate che si sono accontentate di qualsiasi tipo di lavoro pur di garantire un reddito per la famiglia. Aumento delle occupate immigrate, maggiore permanenza sul lavoro delle ultracinquantenni e riattivazione nella ricerca del lavoro da parte delle donne del sud spiegano quindi la maggiore tenuta dell’occupazione femminile . Anche se le donne hanno pagato un prezzo a tutto ciò: il peggioramento della qualità del lavoro.
Quello della sovra-istruzione è un altro fenomeno che purtroppo è anche aumentato e non solo al Sud. Laureate che risultano occupate ma che svolgono impieghi per cui la laurea non è affatto necessaria. Inoltre, sono diminuite le professioni tecniche e cresciute quelle non qualificate. E poi è letteralmente esploso anche il part-time involontario.
In questa situazione vi è un segmento anagrafico che sta peggio ed è quello delle giovani, fino a 34 anni di età. Per loro il calo dell’occupazione è continuo dall’inizio della crisi. In questo senso sono colpite come i loro coetanei maschi, e in alcuni casi di più.
«Repubblica, 4 settembre 2016 (c.m.c.)
Non c’è scampo alla retorica della purezza in politica: funziona fino a quando chi la brandisce non amministra.
Si tratta di una logica polemica, adatta a chi sta all’opposizione. Il problema è che quando un movimento di questo tipo si candida al governo della cosa pubblica, si espone fatalmente a subire gli effetti della retorica dei puri. Nella dimostrazione di impotenza che sta dando il Movimento 5 Stelle con il tentativo di formare una giunta nella Capitale vi è forse la prova più inequivocabile della logica aberrante e distruttiva cresciuta dalla macerie di Tangentopoli, sulla quale ha preso forma il movimento di Beppe Grillo: quella che identifica il buon governo con la purezza della coscienza morale, che crea un’alternativa tra “trasparenza”e “competenza”.
Lo scriveva molto bene Massimo Giannini in chiusura della sua analisi, due giorni fa: il «motto “meglio inesperti che disonesti”, per quanto rassicurante, non può più bastare».
Non solo non può bastare, ma è suicida; assurdo, sbagliato alla radice. Si sorregge sull’idea che la capacità politica sia diabolica e corrotta. Che l’ingenuità sia miglior divisa della prudenza; che anzi, a ben guardare, non ci sia nulla che si possa a ragion veduta chiamare “competenza politica”.
La competenza sarebbe infatti solo di un tipo: quella che si misura nei campi professionali, frutto di conoscenze tecniche e di valutazioni oggettive. Su queste premesse impolitiche ha preso corpo il metodo del M5S di raccogliere i curriculum vitae per scegliere candidati politici e amministratori. Come se essere un buon professionista sia lo stesso che essere un buon attore politico. Questa è l’idea di buon governo coltivata dall’antipolitico Movimento Cinque Stelle.
Il Movimento sta annaspando e, diciamo pure, rischiando di fallire la sfida per il governo di Roma (una sfida che, certo, è il frutto di decenni di cattivo governo e di illegalità di cui i cinquestelle non sono responsabili). Rischia di fallire a causa del suo rifiuto della politica e della forma partito come organizzazione moderna e, vivaddio, democratica della politica. Che ci siano stati e ci siano partiti e politici corrotti non vale a liquidare partiti e attori politici. La patologia non squalifica la fisiologia. Da qui i pentastellati dovrebbero procedere se vogliono far sì che il loro progetto di buon governo di Roma non fallisca e che l’appello alla trasparenza sia efficace.
La “trasparenza” nell’agire pubblico è definita da leggi e norme etiche condivise che danno certezza di conoscenza. Un gruppo politico ha alcuni obiettivi che tutti devono essere messi nella condizione di sapere se e come sono attuati; perché, per esempio, le persone preposte per la loro attuazione si sono ritirate. Quali sono le ragioni dei dissensi. La trasparenza non nasce per magia da una serie di commenti pubblicati sulla pagina Facebook della sindaca, scriveva Giannini, e non coincide con «una lettura banalmente burocratica delle dimissioni del suo capo di gabinetto». È il giudizio politico, la valutazione sulle ragioni di quelle dimissioni come di ogni altra scelta pubblica che fa di un documento un documento politico. La trasparenza non consiste nel dare conto del fatto “nudo e crudo”.
Se i giudizi politici sono annullati per non uscire dal tracciato secco e spoglio del fatto, se la burocratica comunicazione è identificata con la trasparenza, allora la capacità di scelta e di azione, e infine di giudizio politico degli attori è gravemente menomata. Il blog al posto del partito e il resoconto scarno al posto del giudizio politico: sono queste le strategie che decretano la fatale impotenza del M5S. Mesi fa avevamo parlato dell’insostenibilità pratica della retorica della purezza, un ideale di onestà come qualità della morale soggettiva non dell’etica pubblica. Oggi gli effetti di quella logica si mostrano nell’impasse in cui si trovano Raggi e i “suoi” amici o gli “altri”, i non “suoi”.
È fatale: se la politica per essere nobilitata si fa una succursale o del comportamento privato o di quello burocratico, l’esito sarà non la buona politica ma una guerra tra gruppi. È paradossale che per evitare il “compromesso” (svilito spesso ad inciucio) e per praticare la regola della professionalità tecnica i cinquestelle finiscano per dare corpo al peggio della corruzione in politica: la lotta tra fazioni. Mentre chi sta fuori non è messo nella condizione di sapere e capire.
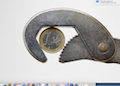 «Unione europea e euro. Priva di una cultura politica aggiornata alle contraddizioni del liberismo, la sinistra rimane ai margini della storia e diventa complice di una spirale distruttiva della Ue, oltre che della moneta unica».
«Unione europea e euro. Priva di una cultura politica aggiornata alle contraddizioni del liberismo, la sinistra rimane ai margini della storia e diventa complice di una spirale distruttiva della Ue, oltre che della moneta unica».
Il manifesto, 3 settembre 2016
Per noi, nell’euro-zona, l’insostenibilità del liberismo reale è un dato politico ancora più rilevante poiché abbiamo «costituzionalizzato» la versione più estrema del paradigma oramai alle corde: lo statuto della Bce da un lato e il fiscal compact dall’altro, nel quadro delle politiche di svalutazione del lavoro iniziate in Germania dalle «riforme Hartz», l’atto di gran lunga più anti-europeo compiuto nella Ue nel secondo dopo guerra.
Nonostante i caratteri di fondo dei trattati europei e dell’unione monetaria, nella sinistra storica europea, riformista o critica, e nei giovani movimenti genericamente anti-establishment, la discussione rimane prigioniera di un astratto e impolitico europeismo alternativo. La «stagnazione della cultura» a sinistra oggi è il principale ostacolo all’affermazione di movimenti, sindacati e partiti orientati a ricostruire soggettività sociale e politica del lavoro, condizione necessaria per rivitalizzare la democrazia, ridurre le diseguaglianze e riavviare l’economia all’insegna della riconversione ambientale.
Per aprire una discussione utile, in particolare per chi è in fase costituente, l’ultimo saggio di Joseph Stglitz, premio Nobel nell’economia e icona della sinistra, offre una preziosa opportunità. Il professore della Columbia University, difficile da scomunicare con l’accusa di moda di sovranismo o neo-nazionalismo, nel suo «The Euro. How a common currency threatens the future of Europe», ripropone un’analisi consolidata, da tempo espressa da tanti economisti eterodossi e mainstream, anche in Italia: l’ordine economico e sociale dell’euro è insostenibile poiché determina dinamiche divergenti tra i paesi partecipanti, genera stagnazione e nel migliore dei casi, grazie a una politica monetaria disperata, equilibri sempre più arretrati di sotto-occupazione.
In altri termini, l’assenza o la prolungata anemia dell’economia non è soltanto conseguenza di risposte sbagliate a incidenti esogeni. La «stagnazione secolare» è la fisiologia del sistema euro in quanto fondato sulla svalutazione del lavoro e sulla marginalizzazione delle classi medie. Il problema dell’euro-zona non è l’austerità, ma l’impianto dei trattati e la politica economica mercantilista praticata con largo consenso bipartisan dal paese leader. In sintesi, l’euro è stato un errore politico di portata storica.
In astratto, le soluzioni esistono per orientare in senso pro-labour la moneta unica. Nel testo di Stiglitz si ritrova una rubrica di «riforme strutturali». Il problema, chiaro al prof Stiglitz ma inavvertito dai nostri spinelliani senza se e senza ma, è l’assenza del consenso minimo richiesto nei contesti nazionali per approvare le correzioni necessarie. Purtroppo, il demos europeo non esiste. Il demos è nazionale per radici culturali, storiche e sociali. La democrazia o è nazionale o non è.
In tale quadro, data l’impraticabilità politica del Piano A, Stiglitz propone il «suo» Piano B: il superamento cooperativo dell’euro («amicable divorce») per arrivare a un euro del Nord e un euro del Sud o, scenario preferibile, all’uscita della Germania dalla moneta unica.
Alle medesime conclusioni di Stiglitz, sebbene con argomenti di superficie, era arrivata un’altra icona della sinistra critica italiana, Luciano Gallino, nel suo testamento politico, rimosso anche dai discepoli più intimi: «Come (e perchè) uscire dall’euro ma non dall’Unione europea».
Allora, che fare per salvare l’Unione europea dall’euro? Innanzitutto, una lettura fondata della fase, l’abbandono del miraggio degli Stati Uniti d’Europa e l’archiviazione della richiesta del Ministro del Tesoro dell’Euro-zona (a trattati vigenti, sarebbe ulteriormente regressivo sul piano democratico e recessivo sul versante economico). Quindi, l’avvio di una discussione ordinata, protetta dalla Bce, per un Piano B sulle linee raccomandate da Stiglitz. Immediatamente, l’innalzamento delle retribuzioni in Germania per consentire un significativo aumento degli investimenti pubblici nei paesi più in difficoltà dell’eurozona senza effetti dirompenti sulle loro bilance commerciali.
Invece, come fossimo negli anni ’90, il governo, supportato dall’establishment, ripropone ulteriori misure supply-side: tagli al welfare per ridurre le tasse sulle imprese e smantellamento del contratto nazionale di lavoro. Svalutazione del lavoro per ridurre il gap di competitività e puntare alla domanda interna di qualcun altro. Una ricetta seguita da tutti i Paesi euro. Quindi, inutile a migliorare la posizione relativa della singola economia ma efficacissima a deprimere la domanda interna dell’eurozona, a incancrenire la stagnazione e spingere le classi medie verso la chiusura nazionalista.
Priva di una cultura politica aggiornata alle contraddizioni del liberismo reale e della sua versione estrema incarnata dall’europeismo reale, la sinistra qui e oltre confine rimane al margine della storia e si fa involontariamente complice di una spirale distruttiva dell’Unione europea, oltre che della moneta unica. Il dibattito su il manifesto è una preziosa occasione per recuperare.
Comune.info, 2 settembre 2016 (c.m.c.)
Se oikos, nel tempo presente della “modernità globalizzata” (Habermann), è diventato la casa-mondo, allora i nomos, le regole, gli accordi, le leggi che stabiliscono le modalità d’uso della casa comune dovrebbero essere improntati alla cura dello spazio vitale, limitato e fragile. Una constatazione, questa, che Ina Praetorius nel suo L’economia è cura (traduzione di Adriana Maestro, edizioni IOD, marzo 2016, con licenza Creative Commons, scaricabile gratuitamente dal web grazie alla Società Consortile Mediterraneo Sociale) considera ovvia.
Se l’economia (oikonomia) è la scienza sociale che studia come poter soddisfare i bisogni di tutte le persone presenti e future ospitabili sulla faccia della terra, allora le prime attività di cui si dovrebbe occupare sono quelle che riguardano il mantenimento delle precondizioni della vita, la riproduzione, il nutrimento e l’allevamento dei figli, l’accudimento degli anziani, la tenuta in buon ordine degli habitat naturali, l’ascolto, l’inclusione e la custodia di ogni diversità, le buone relazioni tra le persone e tra queste e la natura. Insomma, tutto ciò che dà un senso al vivere in pace e con dignità. Secondo Praetorius, invece, nel corso dei secoli è avvenuta una tremenda distorsione pratica e teorica del concetto di economia.
La metà (almeno) del lavoro socialmente necessario alla soddisfazione dei bisogni (e dei desideri) umani fondamentali non viene contemplato dalle scienze economiche convenzionali. Si tratta delle prestazioni “fuori mercato” fornite in ambito domestico dalle donne (in grandissima prevalenza non o male retribuite) e dai popoli indigeni che preservano i “servizi ecosistemici” forniti dai cicli biologici naturali. L’economia, con l’avvento del capitalismo industriale, si è ridotta ad essere un prontuario per massimizzare lo sfruttamento delle risorse umane e naturali trattate come mezzi e strumenti – al pari delle macchine e del denaro – che devono essere impiegate (sacrificate) nel processo produttivo delle merci.
Avviene così un rovesciamento dei fini: gli scopi della cooperazione sociale non sono più il miglioramento della “vita buona” delle persone, la joia de vivre, il buen vivir, il Sumak kawsay andino, ma l’estrazione, l’appropriazione e l’accumulazione di denaro.
L’economia oggi concepisce e codifica solo due tipi di rapporti umani: la prestazione in cambio di denaro e l’estorsione diretta previa costrizione di persone discriminate a causa del genere, del luogo di nascita, dell’età, del censo.
Per Praetorius all’origine di tutto ciò vi sono duemilacinquecento anni di “ordine dicotomico” patriarcale, di dualismo tra uomo-maschio-bianco-possidente-capofamiglia-libero e natura-femminile ridotta a materia sottomessa. La Care Revultion è un nuovo movimento e un nuovo paradigma scientifico che chiede di mettere al centro dell’economia le buone pratiche concrete di vita quotidiana, “il bisogno di qualità di relazioni soddisfacenti”. Quando sentiamo parlare la sindaca di Barcellona, Ada Colau, di ecofemminismo, troviamo molta economia della cura.
 Che cosa significa utilizzare il proprio cervello critico? Le giovani generazioni si trovano davanti a scelte difficili da decifrare. Occorre scommettere sulla "terapia" della scuola».
Che cosa significa utilizzare il proprio cervello critico? Le giovani generazioni si trovano davanti a scelte difficili da decifrare. Occorre scommettere sulla "terapia" della scuola».
Il manifesto, 3 settembre 2016 (p.d.)
Risultano perciò inaccettabili alla logica prima ancora che all’etica i privilegi di chi nasce ricco e ha goduto delle facilitazioni di un ambiente adeguato, ma anche di amicizie, di favori più o meno leciti. La loro condizione di privilegio si mantiene grazie alla esistenza dei molti che invece di privilegi non ne hanno e con la loro opera rendono possibile i loro salari stratosferici e perfino i loro comportamenti offensivi con cui ostentano la loro ricchezza per mostrare il loro potere e diversità, manifestazioni volgari che gridano vendetta davanti a Dio.
Ricordo a proposito alcune parti dell’Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti di Italo Calvino: «C’era un paese che si reggeva sull’illecito (…) Avrebbero potuto dunque dirsi unanimemente felici, gli abitanti di quel paese, non fosse stato per una pur sempre numerosa categoria di cittadini cui non si sapeva quale ruolo attribuire: gli onesti. Dovevano rassegnarsi all’estinzione?»
L’onesto è relegato alla posizione di una sottospecie di fessi non degni di salire nella casta dei furbi. Il cervello, il buon senso, la critica, l’onestà sono in rivolta. La mia non è una ribellione violenta, perché la violenza genera violenza, ma è un richiamo all’uso del cervello pensante e critico, è la rivolta della ragione contro quel’1 per cento della popolazione che possiede più ricchezze del restante 99 per cento (rapporto Oxfam 2016). Ho raccolto queste riflessioni in un mio piccolo libro Elogio della ribellione uscito per Il Mulino.
In questo spirito di inquietudine e di rivolta rifletto su alcuni aspetti del mondo moderno, sulla globalizzazione, sul rapido invasivo sviluppo delle tecnologie che hanno procurato vantaggi ma anche problemi.
Le tecnologie della comunicazione hanno creato un nuovo tipo di solitudine, che possiamo chiamare paradossale perché causata da un eccesso di stimoli, da una saturazione di tutti i recettori, in particolare uditivi e visivi, che induce un’attività frenetica del cervello, levando spazio alla riflessione e ostacolando la libertà del pensiero intasato dalle entrate sensoriali come le connessioni in rete o la Tv. È la solitudine di un cervello che, solo in una stanza, invia e riceve notizie unicamente attraverso messaggeri informatici, ma spesso ha perso il contatto affettivo con gli altri. Il cervello troppo connesso è solo, perché rischia di perdere gli stimoli dell’ambiente, del sole, della realtà palpitante di vita che lo circonda.
La mia preoccupazione di vecchio insegnante è rivolta principalmente ai giovani, per i quali le nuove tecnologie hanno oltrepassato la soglia di strumenti utilissimi per diventare «cervello», neuroni senza i quali non si può più pensare, producendo così una pericolosa restrizione dello spazio della libertà di ragionamento e della fantasia. Lo spazio del pensiero lento è stato invaso dal pensiero rapido.
Per me, neurofisiologo, che cerca di ragionare sui meccanismi cerebrali che stanno alla base di questo cambiamento, ciò non è sorprendente. La plasticità del cervello, cioè la sua capacità di cambiare funzione e anche struttura anatomica in dipendenza degli stimoli ricevuti è massima nei giovanissimi. Basta ricordare che le sinapsi, elementi essenziali del funzionamento cerebrale, numerosissime intorno ai due-tre anni cominciano a diminuire dopo l’adolescenza in maniera sempre più veloce e questa diminuzione è il substrato della vecchiaia del cervello.
La grande plasticità dei giovani ha assorbito naturalmente i messaggi del nuovo mondo e ne è rimasta ingolfata. Probabilmente la generazione degli adulti è responsabile per non aver dato, come educatori gli antidoti contro queste «droghe» pericolose. È interessante ricordare che Steve Jobs, per evitare il sorgere di una dipendenza, aveva proibito ai suoi bambini l’uso degli strumenti da lui stesso inventati. Il cervello dei giovanissimi può essere manipolato: ne è esempio l’educazione dei bambini di alcuni gruppi islamici che induce giovanissimi a pianificati gesti di suicidio.
La nostra scuola non è riuscita a incanalare tempestivamente la rivoluzione tecnologica nella sua pur forte tradizione formativa, rinforzando l’educazione al ragionamento critico, al dubbio su tutto e su tutti. Scriveva Voltaire: «Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola.
Solo gli imbecilli sono inadeguati che spesso mirano al sonno cerebrale, e le altre forme di comunicazione della rete che insieme a messaggi importanti e civili portano disinformazione e possono al limite diventare strumenti pericolosi in mano a delinquenti e terroristi.
Come terapia io non vedo che la scuola e nella scuola l’insegnamento delle materie umanistiche, e per materie umanistiche intendo tutte quelle guidate dalla curiosità, incluse la matematica che è puro pensiero, e tutte le discipline che, rimandando all’esperimento, educano all’argomentazione e al ragionamento. Purtroppo questo è oggi reso difficile dal progressivo degrado della scuola pubblica, della ricerca: insegnanti e ricercatori che preparano il futuro di un paese sono stati privati della loro dignità di funzione.
Internazionale online, 1 settembre 2016 (c.m.c.)
In un’Italia sommersa dalle immagini di valanghe di rovine e di cadaveri, che vengano da Amatrice o da Aleppo (nessuno l’ha notato, ma sono pressoché sovrapponibili). In un’Italia ossessionata dalla fobia dei migranti, che non si sa mai dove mettere e che sarebbero l’unica garanzia contro la crescita zero, demografica ed economica. In un’Italia massacrata da una crisi economica senza uscita, dove i diritti sociali sono carta straccia, il welfare è un vago ricordo e la precarietà è diventata una forma di vita.
In un’Italia depressa, ansiosa e rancorosa, dove la politica non offre più canali positivi all’insoddisfazione sociale. In un’Italia che puzza di vecchio, per la senescenza delle idee e per la depressione delle energie più che per l’età media della popolazione. In un’Italia dove sembra che più nulla di pubblico possa essere detto nella lingua materna, il governo lancia una campagna pubblicitaria per un “Fertility Day” che fa venire voglia ai pochi che ci viviamo ancora di fare le valigie, altro che allestire culle con trine e merletti.
Ci vogliono riportare agli anni cinquanta, paventano molte reazioni femminili sui social. Sì e no. È vero che la tipa (triste) con la clessidra in mano della prima cartolina pubblicitaria ricorda le ragazze (allegre) con la bottiglia di Coca-Cola in mano del decennio del boom, ma l’intera serie delle cartoline ministeriali va a pesca nell’immaginario di parecchi decenni, compreso quello attuale. Evoca l’imperativo fascista di fare figli degli anni venti e trenta, tanto per cominciare: dato che siamo in Italia, dove il fascismo è sempre endemico, si va sul sicuro.
Ma strizza l’occhio allo slang della sinistra radicale, con lo slogan “la fertilità è un bene comune”. E solletica l’etica neoliberale, col riferimento alla “creatività” delle generazioni precarie. Che volete di più da una campagna ministeriale? L’agenzia di comunicazione che l’ha prodotta deve averci pensato su bene. Col risultato di mandare in bestia tutte, e molti: c’è un troppo che storpia, e suona più o meno come una presa per i fondelli. Un messaggio di pedagogia autoritaria camuffato da pedagogia auto-imprenditoriale, in perfetto stile neolib-neocon. Troppo smaccato: perfino Renzi ha dovuto prenderne le distanze.
Epperò dev’essere vero che ogni società ha il governo che si merita. Perché le reazioni contro la pubblicità-regresso riescono a essere a loro volta non meno regressive del messaggio ministeriale. Si va dalle proteste, alla Saviano, contro l’uso statuale della fertilità come “bene comune”, che sarebbe lesivo della sua intangibilità individuale e privata, alle sollevazioni femministe contro l’ingiunzione a procreare in un paese in cui tutto, dalla disoccupazione ai bassi stipendi e dalla precarietà alla mancanza degli asili nido, fa ostacolo al desiderio di maternità.
Su tutto domina un linguaggio statistico-economico che con la lingua del desiderio ha pochissimo a che fare: è vero, il problema c’è, in Italia il tasso di natalità è troppo basso, il paese invecchia, i giovani tardano a farsi una famiglia, le donne non ce la fanno a tirare avanti lavoro (quando c’è, ma non c’è) e figli, ci vogliono politiche per la famiglia non campagne pubblicitarie a effetto… Ma siamo sicure?
Tanto per cominciare, il problema della bassa crescita, o della decrescita, demografica è un classico problema che andrebbe affrontato in termini globali e non nazionali. E in termini globali, notoriamente, il problema non c’è, semmai c’è il problema opposto. Che l’Italia, e l’Europa tutta, invecchino e mettano al mondo pochi bambini non è solo un effetto della crisi economica e dello smantellamento del welfare: è anche un effetto dei muri che si alzano, dell’arroccamento xenofobo e razzista, di politiche dell’immigrazione ossessionate dalla sicurezza e senza alcuna sensibilità demografica, di politiche militari incuranti della vita che nasce e cresce oltreconfine, per tacere di altri fattori culturali che pesano come macigni, dalla crisi dell’idea di futuro al declino dell’egemonia occidentale.
In secondo luogo, il calo della fertilità non è attribuibile solo a ostacoli di natura economica. Non si può affrontare il tema come se il desiderio di maternità fosse un dato certo, ostacolato dalla mancanza di reddito, sussidi e strutture. Un lavoro fisso, uno stipendio e un asilo nido sotto casa di certo incoraggiano a mettere al mondo un figlio più di quanto scoraggino la disoccupazione, il precariato e l’assenza di incentivi, ma poi, anzi prima, c’è dell’altro.
C’è la logica, e l’ambivalenza, del desiderio, che non è mai un dato certo: c’è e non c’è, ci può essere e può non esserci, va e viene, può imporsi e può fallire, senza per questo diminuire la pienezze della vita di una donna. C’è la logica, e la fragilità, delle relazioni fra i sessi scosse dalla fine del patriarcato, che si ripercuote per vie spesso insondabili sull’infertilità delle coppie. Ci sono le incertezze dell’identità sessuale, il gender trouble che non si sa perché siamo tutte pronte a rivendicare come fattore di libertà ma non sempre facendoci carico del trouble che comporta anche sul piano procreativo. C’è la logica imprevedibile della sessualità, che ha che fare con le ragioni dell’inconscio e non con la contabilità della spesa sociale. C’è la logica più prevedibile ma tutt’altro che certa delle tecnologie riproduttive che l’infertilità ambirebbero a risolverla. E c’è, su tutto, la libertà di non fare figli, che nel femminismo abbiamo guadagnato come libertà di grado non inferiore a quella di farli.
Quando si parla di fertilità e crescita, o decrescita, demografica, il catalogo è questo, non, o non solo, quello di un esercizio di buona volontà, come vorrebbe la pubblicità-regresso del governo, o quello delle politiche sociali inesistenti, come vorrebbe chi la contesta. È il catalogo che fu scoperchiato, agli albori del femminismo, dalla pratica dell’autocoscienza, una pratica che ci insegnò fra l’altro, vorrei dire a Roberto Saviano, come si rende politico un problema personale senza per questo renderlo disponibile a imposizioni statuali. È quel catalogo che va ripreso in mano contro l’album delle cartoline ministeriali: a patto di non pararsi, questo invece vorrei dirlo alle giovani amiche femministe, dietro una retorica di auto-vittimizzazione economica che non aiuta l’economia del desiderio.
 «È inaccettabile che una società politica che non ha mai compreso e riflettuto sui cambiamenti avvenuti nella vita delle donne, e quindi di tutti, entri nel merito solo per stigmatizzarlo. E per ricondurre le donne al loro essere corpo e natura».
«È inaccettabile che una società politica che non ha mai compreso e riflettuto sui cambiamenti avvenuti nella vita delle donne, e quindi di tutti, entri nel merito solo per stigmatizzarlo. E per ricondurre le donne al loro essere corpo e natura».
Il manifesto, 2 settembre 2016
.
Ora che Renzi ha detto in una intervista a radio RTL 102.5 «non ne sapevo niente», il flop del fertility day sembrerebbe definitivo. Il sito è collassato, le cartoline non sono più accessibili, solo la ministra della Salute Beatrice Lorenzin si ostina a dare appuntamento al 22 settembre, la data fatale.
Ma a parte Matteo Renzi, sempre pronto ad allontanare da sé tutto quello che profuma di fallimento, non si può proprio tacere sullo stile, sul modo di raccontare e comunicare un tema che potrebbe perfino avere qualche interesse. Anche se non si capisce perché lo si debba chiamare fertilità, e non parlare di una più complessa e articolata educazione sessuale. Non sono i punti di informazione-conoscenza a essere offensivi. Lo sono le immagini, lo sono le parole. A cominciare dal lezioso cuoricino rosa, penetrato dallo spermatozoo-fumetto, trasposizione bamboleggiante dei crudi fotogrammi della fecondazione artificiale, allusione senza ironia, neanche un’eco del viaggio avventuroso raccontato da Woody Allen travestito da spermatozoo in «Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere» (1972).
Peccato che l’immagine clou della campagna sia un’enorme clessidra in primo piano, una giovane donna che si tiene il ventre con una mano, e lo slogan: «La bellezza non ha età, la fertilità invece sì». Che sembra ideato da un team di untori, pronti a spargere l’ansia e la paura ovunque. Ma dove si rivela del tutto l’ideologia che sottintende a questi messaggi è in «fertilità bene comune», o il definitivo «prepara una culla per il tuo futuro», primo piano di una pancia femminile appena piena, con l’universale gesto della mano che la sostiene, quello della Madonna del Parto di Piero della Francesca, per intenderci.
L’elemento pericoloso è che a questa conclusione si arriva dopo una perlopiù corretta esposizione, utilizzando le serie statistiche fornite dall’Istat. È della donna italiana contemporanea di cui si parla: quella che studia a lungo, che è più istruita degli uomini, che coltiva e persegue progetti di parità, di realizzazione di sé, di libertà. Eppure si conclude: «Cosa fare, dunque, di fronte ad una società che ha scortato le donne fuori di casa, aprendo loro le porte nel mondo del lavoro sospingendole, pero, verso ruoli maschili, che hanno comportato anche un allontanamento dal desiderio stesso di maternita?».
È inaccettabile che una società politica che non ha mai compreso e riflettuto sui cambiamenti avvenuti nella vita delle donne, e quindi di tutti, entri nel merito solo per stigmatizzarlo. E ricondurre le donne al loro essere corpo e natura. Non è una tendenza isolata. La libertà delle donne suscita inquietudini profonde, se il premier francese Manuel Valls, per sostenere che le occidentali si spogliano perché sono libere, non ha trovato nulla di meglio che dire che la Marianna, il simbolo della Francia, è a seno nudo perché «lei nutre il popolo».
Inquietudini e rovesciamenti che investono in pieno la cultura che un tempo si definiva progressista. E soprattutto mettono a dura prova i femminismi. Sono molte le femministe che sostengono che l’essere madri è assecondare la natura autentica della donna, il suo essere corpo. Un ribaltamento di tutte le battaglie fatte. E se perfino Renzi riesce a dire che per favorire la fertilità occorrono interventi di sostegno sociale, non farsi ricacciare nella natura riguarda tutte. E tutti, perfino.

Riparto allora da un esempio dall’attualità. Sergio Marchionne, nel suo endorsement a favore della «deforma» costituzionale, così si è espresso : «Non voglio giudicare se la soluzione è perfetta, ma è una mossa nella direzione giusta e io sono a livello personale per il Sì, serve stabilità». A lui quindi non interessano i dettagli e neppure gli strumenti con cui affermare l’obiettivo che gli sta a cuore, ovvero quella stabilità del sistema politico che coincide con il rigor mortis della democrazia ma assicura libertà di manovra al mercato.
Si tratta di un obiettivo politico ambizioso, per il quale le classi dirigenti stanno lavorando da decenni, dal primo proclama della Mont Pelerin Society nell’immediato dopoguerra, passando poi attraverso i vari Gruppo Bilderberg, la Trilateral Commission, la Loggia P2, versione nostrana e un po’ maccaronica di quello stesso progetto fino al berlusconismo dal lungo corso e via dicendo.
Strada facendo quel disegno a-democratico e oligarchico si è fatto sempre più spavaldo. Ha avuto sempre meno bisogno di esprimersi all’interno di think tank, più o meno segreti o aperti a giornalisti embedded, e si è manifestato direttamente, attraverso la voce diretta degli attori economici dominanti e dei poteri finanziari. Così siamo giunti al famoso documento della JP Morgan del giugno 2013, vera matrice della «deforma» costituzionale portata avanti con intemerata energia dal governo Renzi.
Ma ciò non toglie che siamo di fronte a una potente e tenace costruzione politica, a un pensiero che si è fatto interprete degli spiriti animali del capitalismo nell’epoca della globalizzazione e del dominio della finanza.
Non si è trattato di semplice conservazione, ma di una rivoluzione restauratrice. Ovvero la categoria più alta della politica, cioè la rivoluzione, è stata curvata verso fini ad essa contrari. Di conseguenza il riformismo è diventato la foglia di fico di corpose controriforme.Ben scavato, vecchia talpa! Ci tocca riconoscere.
Il neoliberismo non si è mai privato, anche nei suoi momenti di massimo fulgore e non solo nella crisi attuale, dell’aiuto determinante dello stato. Le logiche di mercato da sole non ce l’avrebbero fatta. La prova sta proprio nel fatto che per prevalere esse hanno bisogno di smontare Costituzioni, violentare leggi elettorali, strozzare canali democratici, cancellare spazi giuridici internazionali e crearne dei propri (come si tenta di fare con il Ttip, oggi per fortuna ad una battuta d’arresto).
Senza rinunciare a colpi di stato, a dittature, a populismi rivoluzionari manipolati dall’alto nelle zone del mondo di maggiore frizione, tutto ciò viene fatto – almeno nei paesi a capitalismo maturo – prevalentemente con le armi della politica, solidamente fondata su una disgregazione del fronte sociale avverso, attraverso le modificazioni dell’organizzazione del lavoro e conseguentemente della società. Una politica da cui è stata espunta qualunque forma di dialettica, che quindi si pone l’obiettivo della distruzione della democrazia nella teoria e nella prassi.
Naturalmente questa politica subisce anche i suoi rovesci. Si scontra contro resistenze e resilienze. Non c’è un deserto pacificato. La stabilità si trasforma spesso in cronica instabilità, a tutti i livelli. Gli status e i confini delle e fra le cose si confondono o spariscono. Persino quelli tra la guerra e la pace. Metaforicamente si può dire che il mondo viva oggi in uno stato «quantico».
È a sinistra che invece si può parlare di morte della politica. Il che ha permesso alle destre, nelle loro variegate versioni, di affondare i propri colpi in un ventre molle.
Questo è accaduto per una sorta di rovesciamento delle parti. Mentre la destra pensava a come travolgere le regole e i confini di quel mondo che gli era stato consegnato dagli esiti della seconda guerra mondiale, la sinistra, non senza lodevoli e significative eccezioni, si prometteva di conservarlo, al massimo di fare opera di manutenzione, in qualche caso di troppo timida e fragile trasformazione.
Una costruzione troppo debole per reggere l’offensiva avversaria. Per di più minata dal frantumarsi di un modello di riferimento con la crisi autodistruttiva del cd. socialismo reale e contemporaneamente da una letale separazione della cultura dalla politica che ha costituito una versione capovolta di quel «tradimento dei chierici» di cui scriveva Julien Benda alla fine degli anni venti.
Se per cultura si intende ciò che una generazione storica trasmette all’altra come risultato della sua autoproduzione umana e che la seconda modifica e prosegue secondo le nuove condizioni, si avverte un vero e proprio iato attorno alla fine degli anni settanta. I nodi sono venuti al pettine alla fine dei «trenta anni gloriosi», che colsero la sinistra nella sua parte preponderante priva di strumenti analitici per comprendere il significato di quel periodo.
In Italia qualcosa si avvertì – si ricordino i convegni dell’istituto Gramsci sulle tendenze del capitalismo italiano e europeo – ma troppo poco e non furono le analisi e le tesi migliori a prevalere. Non parliamo poi dell’incapacità di leggere la crisi attuale, sia nel suo sopraggiungere che nel suo svilupparsi.
Ora non si tratta di stringere i bulloni sulle vecchie viti. C’è un «a capo» da cui dobbiamo ricominciare. Ed è l’analisi concreta della situazione concreta a livello mondiale. L’elenco fatto da Burgio sarà parziale, ma è già prezioso. Il capitalismo galleggia – che altro è la stagnazione secolare di cui si parla? – sul fallimento del suo modello di società. Se sprofonda, in assenza di alternativa, trascina tutti con sé. Non possiamo quindi accontentarci di una «terza via» fra il pessimismo di un Robert J. Gordon, di cui ha parlato PierLuigi Ciocca, e la ripetitiva fiducia nelle «magnifiche e progressive sorti» dell’innovazione di un Alec Ross, consigliere della Clinton. Né possiamo farci imbrigliare da polemiche un po’ nominalistiche a proposito del carattere postcapitalistico (Paul Mason) o precapitalistico (Evgenji Morozov) di alcune esperienze produttive autonome e dal basso.
L’alternativa non può essere cercata solo nel campo della politica e una certa sperimentazione di nuovi rapporti sociali e produttivi va iniziata da subito. La politica ci è appunto indispensabile per legare nuove esperienze pratiche alla delineazione di una idea modello produttivo e di società.
Quando era ufficiale, Tolstoj ammonì un graduato che fustigava un sottoposto che non teneva la fila: «Non si vergogna a trattare così un suo simile? Non conosce il Vangelo?» E l’altro: «E lei, non ha letto i regolamenti militari?». Ma di «regolamenti» a sinistra si muore.
Gli altri articoli del dibattito:
Repubblica, 1 settembre 2016 (c.m.c.)
Il mito liberale e quello anarchico si incontrano in un punto: la possibilità e la desiderabilità che la società si governi da sola, senza un governo politico né una classe politica separata che ne diagnostichi i bisogni e imponga soluzioni.
Robert Nozick dedicò a questa utopia anarco-liberista riflessioni importanti e più che mai attuali. Pochi anni fa il Belgio riuscì a cavarsela egregiamente senza un esecutivo per un anno e mezzo. Oggi una simile situazione si ripropone in Spagna, dove la società civile sembra farcela molto bene pur senza un esecutivo che funzioni e con la prospettiva di una nuova tornata elettorale che, si spera, faccia uscire il Paese dal blocco del tripolarismo. Dallo scorso dicembre la Spagna è senza un governo stabile eppure, scriveva Ettore Livini ieri su Repubblica, non vi è alcuna catastrofe: il Pil cresce “a ritmi da tigre asiatica”, crescono i posti di lavoro, lo spread con i Bund è più basso di quello dell’Italia.
Certo, la deregulation è dominante, il lavoro è precario, e la sicurezza pensionistica un sogno. Eppure tutto sembra andare per il meglio, come nel paese di Pangloss.
Le discussioni politiche sulla necessità di governi forti corrono parallele alla cronaca di queste rare situazioni in cui sembra imporsi il mito di un apparato immateriale di norme condivise capace di tenere insieme la società con lacci meno arbitrari di quelli imposti dalla politica, dominata dalle volontà elettorali e dalle trattative tra i partiti. Ovviamente si deve presumere che la società sia coesa abbastanza da procedere pacificamente, con interventi coercitivi minimi o isolati. In tale condizione di forte omogeneità egemonica, la relazione tra governo politico e società civile può allentarsi. Questa è la premonizione del movimento liberista.
Commentando il collasso dei regimi socialisti e la conseguente consunzione delle ideologie politiche classiche nei Paesi occidentali, Francis Fukuyama sosteneva anni fa che queste trasformazioni post-democratiche avrebbero rafforzato la percezione che non solo non ci sarebbe stata alternativa al dominio neoliberale, ma inoltre che questo dominio sarebbe stato essenzialmente di natura non politica, capace di sopravvivere senza un governo centrale come quello messo in essere dagli Stati nel corso degli ultimi due secoli. Il declino della motivazione individuale a partecipare alla vita politica elettorale era secondo Fukuyama un fenomeno correlato al costituzionalismo funzionale di una società che si autogestisce. E gli esempi rari ma non irrilevanti come quelli del Belgio e della Spagna sono indicazioni conturbanti di quanto poco irrealistico sia il mito del nuovo ordine della self- governace society.
È interessante anche osservare come questi fenomeni eccentrici di autogovernance procedano paralleli all’argomento pressante a favore di esecutivi forti che vadano a correggere la democrazia parlamentare classica, iperpolitica e basata su una società strutturata per corpi intermedi e partiti. In entrambi i casi si auspica un minimalismo democratico.
Un’aspirazione che gli estensori del documento sulla Crisis of democracy per la Commissione Trilaterale avevano caldeggiato già nel 1975: per correggere una società civile troppo politicizzata e con una rappresentanza politica troppo direttamente nadprotagonista nelle scelte dei governi. Interrompere questo circolo vizioso tra società e politica era possibile, si legge nel documento della Trilaterale, correggendo il sistema istituzionale in senso esecutivista e nello stesso tempo liberando la società civile dai vincoli delle politiche redistributive e dallo stato sociale. Il minimalismo democratico è coerente con questo progetto di depoliticizzazione. In questa diagnosi, il declino della partecipazione nei partiti e nella politica elettorale non è soltanto desiderabile, ma segno della funzionalità dell’ordine sociale: l’apatia politica è indice di buona salute del sistema e di autonomia della società civile dallo Stato.
Tale concezione della governabilità nel volgere di pochi anni è entrata a far parte del discorso pubblico corrente, legata a un’idea secondo la quale gli individui sono meno desiderosi di associarsi, soprattutto in partiti, assorbiti dal perseguimento delle loro carriere. La politica è sempre più un orpello dunque e, come nel caso spagnolo, quasi il residuo di un mondo disfunzionale e antico.
Antonio Arroyo, 24 anni e una laurea in Economia aziendale mai sfruttata così sintetizza lo stato delle cose nell’intervista di Livini: «La politica ha fallito. Siamo orfani del bipolarismo. In questi giorni i partiti litigano persino su dove sedersi in Parlamento eppure le cose non vanno proprio male: da quando la Spagna non ha più medici al capezzale sta molto meglio!».
 «Il merito delle riforme non conta nulla. La guerra è dichiarata per proteggere i simboli minacciati. E tutti i rappresentanti di accanite agenzie mondiali del denaro accorrono a difesa del simbolo diventato per loro più sacro di tutti: il potere in ultima istanza di sua maestà il mercato».
«Il merito delle riforme non conta nulla. La guerra è dichiarata per proteggere i simboli minacciati. E tutti i rappresentanti di accanite agenzie mondiali del denaro accorrono a difesa del simbolo diventato per loro più sacro di tutti: il potere in ultima istanza di sua maestà il mercato».
Il manifesto, 30 agosto 2016
Non poteva mancare la voce grossa del padrone che getta il suo pesante pullover blu sulla bilancia del referendum. «Marchionne è per il sì, personalmente» dice, parlando di sé, il manager di Detroit. Le truppe schierate per il governo sono molteplici, e impressionano per la loro potenza di fuoco: influenti giornali economici internazionali, grandi banchieri, spericolati finanzieri, Confindustria, cooperative arcobaleno. I poteri forti sono tutti in riga al presentat arm, altro che rottamazione strappata da un manipolo di ragazzi incontaminati.
Per garantire il controllo totale dell’informazione, già da un pezzo omologata alla narrazione del governo, è stata rimossa Berlinguer dalla tv pubblica e persino il battitore libero Belpietro è stato detronizzato dalla carta stampata privata. Oltre alle parabole immateriali dell’immaginario che si sintonizzano sulle frequenze dei media amici, il governo si avvale anche delle truppe di terra. La Coldiretti è stata arruolata per aggiungere un tocco di Vandea bianca, proprio della vecchia bonomiana, in una competizione che altrimenti avrebbe consegnato la difesa del governo soltanto ai signori della finanza e alle sentinelle del rigore.
La portata della battaglia è, dal loro punto di vista, palese nella sua drammaticità: il pericoloso risveglio di una sovranità dei cittadini contro la bella dittatura del denaro che neanche la grande contrazione economica è riuscita a scalfire imputandole i suoi disastri. Nel tramonto dei ceti politici europei, ridotti a maschere che giocano battaglie surreali (il costume da bagno sulle spiagge) e non osano ribellarsi agli ordini impartiti dal capitale per la potatura dei diritti di cittadinanza, il referendum è una delle ultime eccentricità, una dismisura, un intoppo che allarma non poco.
Qualcuno, per incutere timore agli elettori, dice che il referendum di novembre è ancora più importante di quello inglese per le sue implicazioni su scala continentale. Può essere, ma non perché il voto a sostegno della Carta evochi un salto nel buio. I cittadini, rigettando la negazione del principio della sovranità popolare nella designazione di un organo di rappresentanza, hanno la possibilità di rimediare al fallimento dei ceti politici europei che hanno strappato ogni apertura sociale e quindi lanciano il populismo delle destre come risorsa plausibile per i marginali, i perdenti, gli esclusi.