 «“La nuova generazione di guerrieri per la giustizia”. Per la maggior parte degli afroamericani l’uguaglianza è un traguardo lontano dall’essere raggiunto».
«“La nuova generazione di guerrieri per la giustizia”. Per la maggior parte degli afroamericani l’uguaglianza è un traguardo lontano dall’essere raggiunto».
Il manifesto, 27 settembre 2016 (m.p.r.)
Non si ferma la protesta a Charlotte, in North Carolina, dove da una settimana migliaia di persone continuano a scendere per strada tutte le notti per chiedere giustizia e risposte che nemmeno la divulgazione del video della polizia, riguardo l’omicidio di Keith Lamont Scott, è riuscita a dare. Dopo le prime due notti di violenze la protesta è tornata pacifica, tanto che polizia e guardia civile non hanno mai applicato il coprifuoco previsto per la mezzanotte, ma i cortei non diventano comizi stanziali, continuano a spostarsi attraverso la città.
Si parla di centinaia di persone che ogni notte si riuniscono e non si stancano di chiedere giustizia, come, in uno splendido reportage via Twitter, ha mostrato il giornalista del Washington Post, Wesley Lowery, che sabato notte ha chiesto a decine di persone di spiegare cosa li avesse portati a scendere per strada e camminare per ore, a volte sotto la pioggia. Ne è scaturito il quadro di un’umanità diversa, prevalentemente afroamericana, ma non solo, dove i bianchi riconoscevano una chiave della loro libertà nel veder rispettati i diritti civili dei loro concittadini neri, i quali esprimevano con termini chiari come l’essere «black» sia in sé un pericolo, nell’America del 2016. «A due anni da Ferguson, dov’è la riforma della polizia a livello federale che doveva essere attuata?», chiede Lowery, giornalista afroamericano che a Ferguson era stato anche arrestato.
Di questa riforma non c’è traccia, tranne che in alcuni casi, affidati alla volontà dei singoli sindaci, che devono poi fare i conti con i propri capi della polizia. La sensazione di essere abbandonati a se stessi traspare dalle micro interviste di Lowery, così come il grado di consapevolezza che la lotta sarà ancora lunga e dura, che i diritti civili, anche quello di non essere sparati dalla polizia senza ragione, non sono dati e andranno conquistati.
C’è anche la consapevolezza che qualche decina di persone che mette a ferro e fuoco la città catalizza l’attenzione dei media molto più di centinaia che ogni sera scendono per strada senza spaccare nemmeno un vetrina. Eppure questa protesta non sembra voler terminare, così come a Ferguson era andata avanti per mesi, anche a telecamere spente, quando gli occhi di tutti non erano puntati più lì.
Quando domenica Obama ha inaugurato il museo di storia e cultura afroamericana, che da 100 anni aspettava di vedere la luce, ha definito Deray McKesson e Brittany Packnett di Black Lives Matter «la nuova generazione di guerrieri per la giustizia» e in quella frase, come nel lungo abbraccio silenzioso tra il presidente e il membro del congresso John Lewis, storico attivista per i diritti civili degli afro americani, c’è il senso di questa lotta che non è finita negli anni ’60, che ha portato dei risultati, ma non tutti, per cui anche se alla Casa bianca c’è ora un uomo non bianco, per la maggior parte degli afroamericani l’uguaglianza è un traguardo lontano dall’essere raggiunto.
Questa consapevolezza da settimane ormai trova visibilità nel mondo dello sport. Da quando, 5 settimane fa, Kaepernick dei San Francisco 49 si è inginocchiato per non onorare l’inno americano stando in piedi con la mano sul cuore, in quanto, da nero, non si sente protetto da quell’inno e da quella bandiera, ben 40 giocatori professionisti di football, provenienti da 14 squadre diverse, hanno seguito il suo esempio, oltre a innumerevoli squadre junior, come ad esempio a Madison, in Wisconsin, dove domenica entrambe le squadre in campo si sono inginocchiate, arbitro incluso, come anche il clarinettista afroamericano della banda che stava suonando l’inno, mentre un gruppo di studenti del North Carolina che assisteva alla partita ha alzato il pugno chiuso, in solidarietà con la protesta dei giocatori.
Nel mondo della pallacanestro femminile, con la Wnba sabato al Madison Square Garden di New York, Brittany Boyd ha seguito l’esempio di Kaepernick, di cui indossava la maglietta che ora è diventata uno dei simboli di Black Lives Matter, rimanendo seduta in panchina. Queste proteste plateali del mondo dello sport americano probabilmente entreranno nei sussidiari di qualche anno a venire, e rendono l’idea del bisogno di visibilità per un problema sociale e etico, enorme, che trova spazio solo quando sono coinvolti morti, ma che riguarda la vita quotidiana di ogni persona con la pelle scura che si trova in America, consapevole che un incontro casuale con la polizia potrebbe essergli fatale.

Intervista di Giovanna Casadio a Massimo Cacciari. Sciagurato il popolo che ha perduta la capacità di aiutare il suo prossimo quando lo vede ferito e disperato. Infelice il popolo i cui intellettuali non abbiano parole che per se stessi. La Repubblica, 27 settembre 2016
«Se l’Europa ci sarà ancora o no, si deciderà entro un anno, cioè dopo il ballottaggio in Austria per le presidenziali, il referendum costituzionale in Italia, le elezioni in Francia e in Germania ». Massimo Cacciari, filosofo, ex sindaco di Venezia, dice di non essere una Cassandra, ma semplicemente di indicare quanto è sotto gli occhi di tutti: la crisi di sistema, strutturale, di un’Europa che non sa governare. E la paura dei cittadini italiani che all’83% rivogliono le frontiere nell’area Schengen - fotografata dal sondaggio Demos-Repubblica - è «comprensibile, legittima, razionalissima, perfino inevitabile».
Professor Cacciari, non la sorprende che gli italiani a stragrande maggioranza si ribellino alla libera circolazione delle persone nella Ue, vogliano più controlli e addirittura muri?
«Bisogna collocare questi fenomeni all’interno di una visione d’insieme. Non è possibile che una crisi di questa portata, che coinvolge tutti gli aspetti della vita, sia riducibile a un aspetto o a un altro di cronaca. C’è un profondissimo disagio, che vivono tutti i popoli e le nazioni europee e non soltanto. Non solo immigrazione, ma anche crisi economica, disuguaglianze, i figli che stanno peggio dei padri. La gente sta male a 360 gradi e sta infinitamente peggio di come sperava di potere stare. I popoli europei hanno avuto una grande speranza, che con l’Europa unita si potesse stare meglio. Questa era la promessa della leadership europea. Negata, ora».
Inevitabile insomma l’anti europeismo?
«Se le leadership europee non cessano di inseguire le emergenze e non puntano invece a una strategia di sistema, l’Europa naufraga, perché dietro la paura dell’immigrazione c’è il non governo dell’immigrazione. Manca il buon governo delle cose».
E i populismi però ingrassano?
«Il gioco davvero sporco, e che bisogna attaccare, è proprio quello di chi invece di dire che senza Europa siamo davvero perduti di fronte alle sfide globali, strumentalizza. Però io non ci sto a dire che è irragionevole questa paura, al contrario è ragionevolissima. L’immigrazione di massa è una grande novità che sarebbe stupefacente non creasse paura: i popoli non sono formati da intellettuali».
È un formidabile testacoda che l’attualità mostra: da un lato gli italiani chiedono muri dall’altro sono respinti dalla Svizzera che in un referendum ha votato contro i pendolari italiani.
«Sono le immagini simbolo dell’impotenza europea. Va detto tuttavia che un organismo anche animale se non riesce a riorganizzarsi, si difende ed è questo l’inizio della sua fine. In Svizzera cavalcano le paure per prendersi i voti e giocano con fuoco che brucerà anche loro».
Renzi ha avviato un conflitto con Merkel e Hollande sulla flessibilità ma anche per lo scarso sostegno sull’immigrazione. Ha qualche ragione?
l «Le leadership tedesca e francese sono al muro. Noi in definitiva siamo quelli che facciamo la figura migliore. Sull’immigrazione Renzi ha molte ragioni, anche se non è con buffonate tipo “facciamo da soli” o mostrandosi offeso per non essere stato invitato, che si trovano soluzioni. Mentre sul piano economico, della flessibilità, non è chiedendo la paghetta che si possono affrontare i problemi. La questione vera che dovrebbe essere posta per salvare la moneta unica ad esempio, riguarda le politiche fiscali punto strategico nella Ue».
Quindi la paura si aggira in Italia?
«Paura dice tutto e non dice niente. I cittadini non si sentono governati, non sanno cosa fa chi li guida: è il crollo di una “auctoritas” , da qui legittimamente la paura. Bisogna ficcarsi nella zucca che il vero deficit europeo è la mancanza di autorità. Quando la Merkel reagì con autorevolezza alla prima forte ondata migratoria, mise a tacere populisti e demagoghi».
C’è un rischio razzismo?
«Il razzismo non c’entra. Il rischio è la dissoluzione dell’Europa, lo sapremo tra un anno dopo il voto in Austria, il referendum costituzionale italiano, le elezioni in Francia e Germania dove è in discussione anche la Merkel. È puro realismo dire che l’Europa collasserà, se non riesce a trovare coesione».
 Parole di saggezza che vengono da esperienze e sentimenti del passato, ma che sono di stringente attualità per chi voglia comprendere e praticare la Politica senza perdere ciò che lega ogni uomo agli altri uomini.
Parole di saggezza che vengono da esperienze e sentimenti del passato, ma che sono di stringente attualità per chi voglia comprendere e praticare la Politica senza perdere ciò che lega ogni uomo agli altri uomini.
Il manifesto, 27 settembre 2016
Tra il dicembre del 2009 e l’estate del 2012 Maria Luisa Boccia e Alberto Olivetti hanno intrattenuto una fitta serie di conversazioni con Pietro Ingrao che ci ha lasciato un anno fa, il 27 settembre del 2015. Sono state registrate e trascritte per realizzare un volume. Alcuni capitoli sono pronti per la stampa, altri attendono una revisione.Nel marzo del 2011, frutto di quegli incontri, fu pubblicato Indignarsi non basta presso l’editore Aliberti, che ebbe grande diffusione ed è statoGli stralci qui proposti sono invece inediti, risalgono a un incontro seguente della primavera del 2011. Li abbiamo scelti, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, per l’attualità che i giudizi di Pietro Ingrao rivestono riguardo alle discussioni su Parlamento e legge elettorale.
*****
Ci accade ogni giorno di essere presi nelle maglie di una struttura artificiale. E questo sembra esserci “da sempre”. L’ordine ti prende e stringe fin dalla nascita, come se fosse un dato naturale appartenervi. “Stato” è il nome che diamo ad un insieme composito, forse per nulla ordinato e coerente, di regole, istituti, funzioni, dentro il quale svolgiamo le nostre vite.
La norma non realizza una parte insopprimibile della relazione e dell’esperienza umana. Che non può essere rimossa, relegata alla sfera privata. Non può essere cancellata, sia pure come eccedenza e differente dicibilità, nell’agire politico, o in quella sua peculiare manifestazione che è l’atto legislativo.
Se non altro come consapevolezza del limite, come dubbio sulla pretesa di imparzialità della legge. Personalmente non mi sono affidato in primo luogo alla scrittura di norme. Quando dico “volevo la luna”, nomino l’esigenza di un salto, prima di tutto nel linguaggio e nelle relazioni.
Nella politica è questo che mi coinvolge: nella vita umana le leggi contano, e dunque l’attività legislativa è importante, non può essere sottovalutata. Ma c’è un di più nella politica che è comunicazione, relazione. Una relazione che assume le forme più strane, particolari. Questo in me si è unito spesso con… come lo vogliamo chiamare? ma sì, chiamiamolo amore per la natura. I cieli, le inclinazioni del tempo che scorre, l’alzarsi della luna nelle notti di estate: mi ha sempre trascinato, mi ha dato molta emozione.
Sono stato immerso, incollato alla politica, nel suo farsi quotidiano, ma ho sempre avvertito chiaramente una riserva interiore. Lo testimonia la poesia che amo terribilmente… c’è un di più che la politica non esaurisce in sé stessa. E dal quale, tuttavia, non può prescindere.
Non credo alla separazione tra sfere distinte, segnate da confini definiti: privato e pubblico, interiorità ed esteriorità, individuo e collettivo, società civile e Stato. Non è così nella vita di ognuno di noi e la politica non può non intrecciarsi alla complessità dell’essere umano. Anche se non potrà mai comprenderla e darne conto, per intero.
Conosco bene la realtà del sistema istituzionale e dunque so quanto siano fondate le ragioni della critica. So quanto di tecnico e separato vi è nel Parlamento, e quanto questo contrasti con il suo ruolo costituzionale, di esercizio della sovranità popolare. Ho potuto verificare, soprattutto da presidente della Camera, quanto fosse difficile far funzionare il Parlamento, quale luogo effettivo di formazione delle scelte, di mediazione e di sintesi per le decisioni. Tuttavia non mi persuade la riduzione a “Palazzo” dell’Assemblea elettiva, e degli eletti a “casta”: un mondo separato, chiuso nei suoi privilegi e nei suoi meccanismi di autoconservazione.
La rappresentanza, di questo sono convinto, non è mai mera delega. È una relazione attiva, quali che siano concretamente le sue modalità. Ed è qui il problema. Se è una relazione costruita sullo scambio di interesse, o sul messaggio mediatico. O, viceversa, su una condivisione di esperienze, un dialogo sulle idee, in qualche modo un patto tra soggetti, diversamente coinvolti nella politica. Nella Costituzione è scritto che il parlamentare rappresenta la nazione, senza vincoli di mandato. Nella storia politica di cui sono stato partecipe sono stati i partiti a dare costrutto pratico, materiale, alla rappresentanza.
Crisi dei partiti di massa e crisi della rappresentanza sono due facce della stessa medaglia. O restituiamo sostanza e trasparenza alla relazione tra rappresentanti e rappresentati, e le Assemblee elettive tornano ad essere un luogo di confronto che conosce momenti di conflitto e momenti di mediazione e sintesi, oppure si acuirà la divaricazione tra procedure del consenso e sedi della decisione. Da un lato la personalizzazione della politica, affidata a poche figure di leader e al loro messaggio, dall’altro una miriade di tecnici, concentrati su questioni settoriali, nei vari gabinetti e vertici di concertazione corporativa.
È davvero singolare che mentre si invoca ad alta voce una semplificazione della politica ed un rapporto più diretto ed immediato dei cittadini con chi li governa, lo Stato si dilata. Cresce e si articola attraverso un insieme di apparati e organismi più o meno informali, in ogni modo sottratti ad ogni forma controllo e di trasparenza democratica. Ognuno di noi ne ha esperienza diretta.
Lo Stato è un prisma di specchi nel quale si rifrange ogni giorno, sui diversi aspetti della vita, una particolare modalità del potere politico. E né come individui, né come gruppi sociali possiamo fronteggiare questa influenza, senza le necessarie mediazioni. A questo sono servite le istituzioni della rappresentanza, sociale e politica. Francamente non vedo altri strumenti, altre forme politiche che possano svolgere questa funzione, in modo più efficace.
Nella Costituzione è il Parlamento, non il governo, a rappresentare la sovranità popolare. E’ vero, nei fatti ha prevalso una diversa, perfino opposta, concezione politica. Ma i guasti che ha prodotto, di inefficienza e degenerazione, sono ormai cronaca quotidiana. Sono stato sempre convinto che la prima riforma è il monocameralismo. Una platea di mille membri non può funzionare. Più alto è il numero, più cresce a dismisura la lentezza e l’inefficienza dell’istituzione.
Se riduci il numero dei parlamentari ed hai una sola sede rappresentativa la selezione dei deputati corrisponderà più a criteri politici che non ai mille rivoli degli interessi corporativi e delle clientele locali. Non è la sola riforma da fare. Anche la legge elettorale deve essere adeguata alla centralità dell’istituzione rappresentativa. Il modo in cui si formano le Assemblee elettive orienta le scelte dei partiti, il loro modo di organizzarsi, di scegliere i propri dirigenti, di rivolgersi all’opinione pubblica e costruire partecipazione e consenso.
Democrazia è parola che uso con sobrietà. Tanto più oggi. Ma non so ridurre la democrazia a mera procedura di legittimazione dei governanti. Se guardo al modo in cui ho agito politicamente la valorizzazione dell’istituto rappresentativo è un punto fermo. Sono stato Presidente della Camera in anni cruciali di transizione. Ho visto affermarsi culture e pratiche di frantumazione e scomposizione del sistema politico ed istituzionale. Si avvertiva già con forza la spinta verso il decisionismo e la governabilità assieme a quella, apparentemente opposta, alla proliferazione di sottosistemi, al peso crescente degli apparati e delle burocrazie. Mi sono convinto che non dipendevano da condizioni contingenti, ma avevano radici profonde.
Per capire ho ritenuto necessario studiare, ho rinunciato alla Presidenza della Camera e sono andato a presiedere il Centro studi per la Riforma dello Stato. Vorrei fosse chiara qual è stata la ragione di fondo che mi ha spinto: il coinvolgimento delle classi popolari nella formazione delle scelte, costruendo l’indispensabile raccordo tra la loro azione politica e le istituzioni.
Come si può realizzare questo coinvolgimento, se non si assicura trasparenza e libertà di confronto nelle Assemblee elettive? Come possono, altrimenti, esercitare un effettivo potere, a fronte della concentrazione e specializzazione dei poteri economici e finanziari, militari e burocratici, tecnologici e dell’informazione? In quel breve testo, Indignarsi non basta, riflettevo sulla mancanza di un comune collante politico.
Cambiano ovviamente le modalità con cui i poteri agiscono per dividere e frantumare, ma il deficit di rappresentanza ha un peso rilevante nella perdita di coesione sociale. In questo trovo conferma di una mia convinzione di fondo. Se la democrazia non si organizza e non si dota di poteri effettivi anche i conflitti sociali cambiano natura, muta e si restringe il senso di cosa è politica.
Non dimentico quanto fosse acuta, drammatica, la preoccupazione nel Pci che si riproducesse la frattura tra le classi popolari e le classi dirigenti, che la rivolta sociale assumesse le forme del “sovversivismo”. Se il Pci ha avuto una funzione nella storia politica di questo paese è stato quello di aver lavorato tenacemente a costruire legami tra le classi popolari e le istituzioni democratiche.
Non sempre ci siamo riusciti, ma non è arretrando da questo sforzo che si troveranno alternative ai nostri limiti e sbagli.
 Non stupisce l'atteggiamento di Renzi, interprete fedele dell'ordine di emarginare i più poveri per inseguire il mito dello Sviluppo. Amareggia e inquieta la paura del "diverso" che emerge dalla maggioranza degli italiani.
Non stupisce l'atteggiamento di Renzi, interprete fedele dell'ordine di emarginare i più poveri per inseguire il mito dello Sviluppo. Amareggia e inquieta la paura del "diverso" che emerge dalla maggioranza degli italiani.
La Repubblica, 26 settembre 2016, con postilla
MatteoRenzi ha avviato un conflitto permanente, in Europa. In particolare con gli azionisti di riferimento dell’Unione. Germania e Francia. Con i quali ha polemizzato per il mancato invito al prossimo vertice di Berlino. Si tratta, peraltro, di un atteggiamento sperimentato dal premier, in diverse occasioni. Più che euro-scettico: euro-tattico. A fini esterni e ancor più interni. All’esterno, nei confronti dei governi forti della Ue, Renzi mira a ottenere più flessibilità nei conti. E maggiore sostegno di fronte al problema dell’immigrazione. Verso l’interno: cerca di allargare i propri consensi. Oltre la cerchia del Pd. Perché gli italiani sono anch’essi euro-tattici, come il premier. Hanno bisogno degli aiuti della Ue, ma la guardano con diffidenza. E temono gli immigrati. Si sentono esposti e vulnerabili ai flussi migratori. Così Matteo Renzi parla a Bruxelles e a Berlino. Ma si rivolge al proprio Paese. Agli elettori che lo sostengono, ma anche — ancor più — a quelli più tiepidi e distaccati. Tanto più in questo periodo di campagna elettorale in vista del prossimo referendum costituzionale.
D’altronde, come abbiamo osservato altre volte, l’atteggiamento degli italiani verso l’Unione si è sensibilmente raffreddato, dopo l’ingresso nell’euro, nei primi anni 2000. Allora eravamo i più eu(ro)forici in Europa. Quasi il 60% esprimeva, infatti, fiducia verso le istituzioni comunitarie. Ma il clima d’opinione è cambiato in fretta. Fino a scendere sotto il 30%, negli ultimi anni. Oggi è al 27%. E i più delusi sono gli elettori incerti, che Renzi contende ai partiti decisamente euro- scettici. In primo luogo: Lega e M5s. Tuttavia, non bisogna pensare che gli italiani se ne vogliano andare dalla Ue, seguendo Salvini e la Lega. Né che intendano abbandonare l’euro, come vorrebbero Grillo e il M5s. La maggioranza, anche se largamente insoddisfatta, preferisce, comunque, restare. Perché la Ue e l’euro non ci piacciono. Però non si sa mai… Fuori potrebbe andarci molto peggio.
Tuttavia, il percorso verso l’unificazione lascia gli italiani sempre più insoddisfatti. Non solo sotto il profilo economico, monetario. E, naturalmente, politico. Ma, ancor più, territoriale. Perché, per esistere, uno Stato deve avere un territorio de-finito. Cioè, de-limitato. Uno Stato — federale — europeo deve avere confini esterni precisi. E confini interni, cioè, fra gli Stati nazionali, aperti. Comunque: sempre più aperti. Invece, i confini esterni appaiono sempre più incerti, mentre quelli interni si ripropongono, sempre più evidenti. Marcati, talora, da muri (come in Austria e Ungheria). Mentre le frontiere diventano barriere. Come ha previsto il Regno Unito. D’altronde, la minaccia terroristica ha spinto a rafforzare i controlli. In Francia, anzitutto. Ma questa domanda è cresciuta anche altrove. In Italia, ad esempio. Dove le paure “globali” si diffondono in misura crescente, come ha sottolineato il Rapporto dell’Osservatorio sulla sicurezza dei cittadini (curato da Demos con l’Osservatorio di Pavia e la Fond. Unipolis).
Oggi, infatti, nel nostro Paese la richiesta di marcare e sorvegliare i confini appare largamente condivisa. Solo il 15% degli italiani (del campione rappresentativo intervistato da Demos nei giorni scorsi) pensa che il trattato di Schengen vada mantenuto. Garantendo la libera circolazione dei cittadini europei fra gli Stati (membri). Mentre una quota molto più ampia, prossima alla maggioranza assoluta, (48%) ritiene che occorra sorvegliare le frontiere. Sempre. E una componente anch’essa estesa, oltre un terzo della popolazione, vorrebbe che i confini nazionali venissero controllati “in alcune circostanze particolari”. Il sogno europeo, immaginato e perseguito da “visionari, come Altiero Spinelli, Jean Monnet, Robert Schuman e Konrad Adenauer, rischia, dunque, di fare i conti con un brusco risveglio. Almeno in Italia. Dove una larga maggioranza dei cittadini pensa di rientrare dentro alle mura, o almeno, alle frontiere, degli Stati nazionali. Questo sentimento si associa a orientamenti politici precisi. Raggiunge, infatti, livelli elevatissimi fra gli elettori della Lega (oltre 70%) e di Centro-destra (due terzi, nella base di Forza Italia). Ma incontra un sostegno ampio (quasi 50%) anche tra chi vota M5s. Mentre si riduce sensibil- mente (sotto il 40%) nella base del Centro-sinistra. La richiesta di frontiere, peraltro, declina in modo particolare fra i giovani e gli studenti. Abituati a frequentare le Università europee, grazie al programma Erasmus.
Tuttavia, se valutiamo le principali ragioni che concorrono ad alimentare questo orientamento, una, fra le altre, assume particolare rilievo. Il timore suscitato dagli immigrati. L’arrivo e la presenza degli stranieri. Più della sfiducia nell’Unione europea e nelle sue istituzioni di governo, infatti, è la “paura degli altri” che alimenta la domanda di rafforzare il controllo delle frontiere. E contribuisce, in qualche misura, a far crescere la nostalgia dei muri. Come se le frontiere e gli stessi muri potessero “chiudere” (e proteggere) un Paese “aperto” come il nostro. Verso Est, l’Africa e il Medio Oriente. Circondato, in larga misura, dal mare. In tempi di globalizzazione. Dove tutto ciò che avviene dovunque, nel mondo, può avere effetto immediato sulla nostra vita. Sulla nostra condizione. Sul nostro contesto. Per questo il dibattito politico sulle frontiere, in Europa ma anche in Italia, appare dettato da ragioni politiche e ideologiche. Perché le frontiere servono a riconoscere gli altri e de-finire noi stessi. E, in quanto tali, come ha scritto Régis Debray, possono costituire “un rimedio contro l’epidemia dei muri”. Ma quando diventano muri ci impediscono di guardare lontano. Alimentano solo la nostra in-sicurezza. Non alleviano le nostre paure. Ma rafforzano solo gli imprenditori politici
delle paure.
postilla
"Italiani brava gente"? Le “mosse” di Renzi nonstupiscono più nessuno, né stupisce la delusione degli italiani nei confrontidell’Unione europea. Sia pur confusamente una parte molto consistente deglieuropei patisce sulla propria pelle il disagio dell’austerity imposta ai popolibenestanti dall’ideologia e dalle pratiche del neoliberismo, di cui UE è fedeleinterprete; sebbene non molti ne vedano le ragioni e ne individuino iburattinai. Neppure stupisce molto l’ansia che molti nutrono di ritornare nellacuccia della nazione, protetta da una sicura frontiera.
Meraviglia invece, e addolora, che la paura del “diverso” renda tanti italiani ciechidi fronte alla sofferenza delle persone che fuggono dai paesi dell’Africa versol’Europa. Ciechi e sordi dinnanzi a una fuga di massa che è stata ingrandissima parte provocata dallo sfruttamento diretto e indiretto dellerisorse della Terra esercitato dagli stati e dalle aziende del Primo mondo conil colonialismo dei secoli scorsi, e che prosegue indisturbato con quelneocolonialismo che il Primo e il Secondo mondo - governi e aziende italianecompresi - esercitano in modo ancora più virulento oggi.
“Italiani brava gente”,è il titolo che abbiamo dato a questa cartella. Lo riprendemmo da un film delregista Giuseppe De Santis del 1964; lo riprese a sua volta nel 2005 lo storicoAngelo Del Boca aggiungendovi un punto interrogativo e rovesciandone il senso, ripercorrendoin un suo libro la storia delle numerose atrocità compiute dagli italiani dalRisorgimento al Fascismo. Allora, ai tempi cui si riferiva la narrazione di DelBoca la mancanza di pietas poteva essere attribuita ai Capi (dai Savoia aiMussolini e ai loro generali), non vorremmo che oggi dovesse essere attribuitaa un intero popolo, quello cui apparteniamo.

Il manifesto, 25 settembre 2016
Tra vecchi e nuovi iscritti, i seicentomila che hanno avuto fede in lui sono stati premiati: ieri a Liverpool la parusia – il secondo avvento – di Jeremy Corbyn si è finalmente compiuta. La conferenza di Liverpool ha tributato al leader una vittoria monumentale, col 61% del voto totale contro il flebile 38,2% di Owen Smith, un Giufà immolato all’ultimo momento dai centristi del partito alla forsennata ricerca di un inesistente supereroe moderato che non terrorizzasse gli amichetti della City.
Allo spoglio, con un’impressionante affluenza al voto del 77,6% su 640.500 tra iscritti al partito, al sindacato e sostenitori, Corbyn ha intascato 313.209 preferenze contro le 193.229 del rivale: un esito ampiamente atteso ma che nulla toglie al congresso più atteso della storia del partito laburista, che si apre ufficialmente oggi. Un mandato definitivo, che supera di gran lunga quello che già lo vide improbabile protagonista lo scorso settembre, quando surclassò gli altri tre candidati con un già assai ragguardevole 59,5% delle preferenze.
Nel suo secondo discorso d’insediamento, Corbyn ha fatto voto di rammendare lo strappo profondo confermato da questo suo bis vittorioso. Ha confermato la linea di questi ultimi giorni, aprendo ai dissidenti, sottolineando l’eredità comune che riguarda tutti i laburisti indipendentemente dalle correnti e dichiarandosi disposto a riaccogliere a braccia aperte i cospiratori. «Le elezioni sono una faccenda appassionante e partigiana, in cui a volte nella foga del dibattito da più parti si dicono cose di cui poi ci si pente. Ma ricordiamoci che nel nostro partito sono molte più le cose che abbiamo in comune di quelle che ci dividono. Per quanto mi riguarda, da oggi, voltiamo definitivamente pagina e facciamo assieme quello che dobbiamo fare come partito, tutti assieme».
Secondo Nina Power, senior lecturer in filosofia all’università di Roehampton, la sua travolgente vittoria tra i membri del partito dimostra, nonostante i continui attacchi nei media e le lotte intestine, «che Corbyn si batte per cose che la gente considera importanti: la lotta alla guerra, alle armi nucleari, per l’istruzione gratuita, anche quella superiore, per la sanità pubblica, per l’equa tassazione di coloro che la eludono, contro l’austerità e per il welfare, per la ri-nazionalizzazione delle ferrovie».
Il segretario ha poi affrontato direttamente l’antifona dell’ineleggibilità del partito sotto la sua guida, fino a ieri argomento principale dei suoi tanti detrattori. «Uniti verso il vero cambiamento che il paese necessita, non ho dubbi che questo partito possa vincere le prossime elezioni quando il primo ministro deciderà di convocarle e di formare il prossimo governo». E non si tratta solo di retorica sul filo dell’entusiasmo. I continui tentativi di sabotaggio e soprattutto la frenetica campagna di questi ultimi due mesi, lungi dal fiaccare quest’uomo di 67 anni, l’hanno reso più coriaceo, scaltro e lucido. Non potrebbe trattarsi di esito più crudele e beffardo per le truppe blairiane, ormai malconce e sbandate, che hanno temprato il nemico anziché sconfiggerlo.
L’aforismo nietzschiano «Quel che non mi uccide mi rafforza», gli si addice perfettamente.
Da oggi il sogno della base del partito (e l’incubo dei suoi deputati) si sono irrevocabilmente avverati: il partito laburista cessa di essere quello che era diventato ormai da un buon ventennio, ossia il consiglio di amministrazione di un bieco esistente, capace solo di riverniciarne le sozzerie anziché affrontarne veramente le cause. «È una storica sconfitta per la destra del partito, che lo ha dominato per quasi tutta la sua storia» commenta Jeremy Gilbert, professore di Cultural and Political Theory all’università di East London, «Ora un partito a guida Corbyn si trova di fronte sfide enormi: media ostili, un movimento operaio debole, una destra populista in ascesa, e un’enorme divisione alla base sulla questione dell’immigrazione. Ma sono sfide che si possono raccogliere. La questione è se la vasta maggioranza del partito parlamentare, aduso com’era a un’epoca d’inattaccabile consenso neoliberista, saprà scendere a patti con la nuova situazione, o se invece continueranno a comportarsi come bambini isterici, senza comprendere il danno che recano o la futilità della propria rabbia».
Il trionfo di ieri segna comunque un dato inoppugnabile: il ritorno in questa Gran Bretagna post-Brexit della politica intesa come prassi sul reale, non più dettata dagli uffici stampa e dei pr, capace di parlare non in soundbites o slogan pubblicitari. Come sottolinea Power, «L’era dello spin è finita, nessuno vuole più questi politici leccati, che paiono degli avvocati, non è vero che viviamo in un’epoca “post-verità”: le persone conoscono la differenza fra una persona integra e un bugiardo: e di bugiardi non ne vogliono».
 «La commissione sulle diacone potrebbe segnare anche la rottura di tre assordanti silenzi che soffocano le chiese da decenni». La
«La commissione sulle diacone potrebbe segnare anche la rottura di tre assordanti silenzi che soffocano le chiese da decenni». La
Repubblica, 24 settembre 2016 (c.m.c.)
Ha iniziato i propri lavori questa settimana la commissione istituita da papa Francesco sul diaconato femminile: atto interno alla vita della chiesa ma cruciale per la fisionomia del cattolicesimo romano del secolo XX.
La commissione, per certi versi, ha un compito “facile”: deve suggerire solo quando e come “restaurare” un ministero femminile attestato nel Nuovo Testamento, là dove Paolo saluta la greca Febe, “diacono della chiesa di Cencre”. “Diacono”, non “diaconessa”, come si farà al concilio di Nicea, indicando figure che non avevano ricevuto l’imposizione delle mani.
Nella fluida situazione della prima comunità neotestamentaria c’è dunque un appiglio lessicale e teologico: che non basterà a chi sta cercando di creare la “maggioranza ostile” al papa che è loro mancata in materia matrimoniale.
Tutti, per altro verso, sono consapevoli che una “restaurazione” del diaconato potrebbe ridursi ad una operazione sterile. Il concilio Vaticano II “restaurò” ad esempio il diaconato permanente, come ministero di una chiesa serva e povera che scioglieva il nesso fra celibato e ministero affermatosi solo alla fine del primo millennio. L’esito è stato modesto: il diacono è rimasto l’unico ministro sposato della chiesa latina (fino alla decisione di Benedetto XVI di ammettere preti e vescovi sposati, ma solo se provenienti dalla chiesa anglicana) e s’è ridotto al ruolo di un chierichettone nella liturgia e di capufficio dei volontari fuori da essa.
La “restaurazione” del diaconato femminile (dunque di “diacone” ordinate e/o di “diaconesse” prive dell’imposizione delle mani) potrebbe fare la stessa fine: una onorificenza per suore e per nonne, senza impatto sulla riforma e sulla missionarietà della chiesa.
Eppure la commissione sulle diacone potrebbe segnare anche la rottura di tre assordanti silenzi che soffocano le chiese da decenni.
Il primo è il silenzio sul sacerdozio che tutte le donne e tutti gli uomini battezzati hanno già: quello che la chiesa latina chiama sacerdozio comune (in opposizione al sacerdozio ministeriale che viene dal sacramento dell’ordine). La stantia cultura che rivendicava la promozione dei “laici” — sudditi desiderosi di essere mobilitati e promossi — che si è rigenerata nell’attivismo e nel clericalismo dei movimenti, non è ancora stata scalzata da una teologia sulla dignità di quelli che il codice di diritto canonico chiama Christifideles. Se santa Febe facesse un miracolo, la commissione o un sinodo sul ministero potrebbero essere l’occasione per interrogarsi su questo.
L’altro riguarda il ripensamento teologico di una espressione — in persona Christi — grazie alla quale la cultura della subordinazione femminile del mondo antico ha vinto la concezione cristiana del battesimo in Cristo nel quale non c’è più “né maschio né femmina”. Molte chiese si sono liberate da quel paradigma alla fine del secolo XX ordinando pastore, prete e vescove cristiane in possesso dei doni di Dio necessari alla santità di una comunità: la chiesa cattolica reagì alla accelerazione con una chiusura che voleva essere “definitiva” e dichiarando nel 1994 che il tema era “indisponibile” alla chiesa.
La successione apostolica al maschio-Gesù degli apostoli- maschi vincolava la capacità di agire in persona Christi a un solo genere: come se la mascolinità di Gesù non fosse una componente necessaria alla verità dell’incarnazione, ma un privilegio sessista. Ciò che è normativo di Gesù non è la sua mascolinità dichiarata dalla nudità della croce (il velo del crocifisso serve a nascondere la circoncisione non il sesso): ma la croce e la morte di croce alla quale ogni cristiano, maschio o femmina, è unito nel battesimo trinitario. Portare le donne nella sfera dell’unico ordine sacro romperebbe una reticenza e ristabilirebbe un equilibrio necessarissimo alla cristologia.
Il terzo silenzio con cui la commissione sul diaconato femminile si misura è quello sul sacerdozio ministeriale maschile ora in essere, prigioniero di un misero duello di retoriche celibatarie e anticelibatarie. Oggi in larghe parti della chiesa si vive una alternativa fra celibato ed eucarestia: perché in assenza di celibi da ordinare, si condannano le comunità a vivere senza eucarestia: una alternativa in cui un naso sano sente odore di zolfo. E che va affrontato senza furbizie e senza superficialità: non dal papa solo, ma dai vescovi che non possono nascondersi dietro un dito.
I non pochi nemici di Francesco, giovani o vegliardi, non sono contrari a che questa discussione si apra: sperano l’arcipelago antibergogliano si palesi, man mano che si avvicinano le due scelte — la nomina dell’arcivescovo di Milano e del vicario di Roma — dalle quali dipenderà non solo il futuro conclave, ma anche l’unità presente d’una chiesa. Che il papa chiama a non essere una federazione pelagiana di attivismi, ma una comunione di quelli che il Vangelo definisce “servi inutili”, e che sono gli unici indispensabili.

(segue)
Che nella nostra epoca vada in scena, su scala mondiale, un declino della politica appare poco dubitabile. Politica, intendo, come capacità di governo degli uomini, secondo ordinamenti e scelte largamente condivisi dai governati, dunque con carattere egemonico, da parte dei ceti dominanti. E politica come capacità di conflitto organizzato, per rovesciare o comunque trasformare radicalmente l’ordine esistente, da parte della classe operaia e dei ceti popolari. Ambedue gli ambiti appaiono in rotta, e il loro degrado culturale e operativo è a mio avviso, intimamente connesso. Il sovrastante dominio dei ceti economici dominanti sulle classi popolari ha ridotto gravemente l’antagonismo storico che per tutta l’età contemporanea è stato il motore della modernizzazione capitalistica. Qui cercherò di individuare, in rapida sintesi, le ragioni più rilevanti che riguardano la fragilità dell’azione politica nel campo della sinistra.
1 La prima causa credo sia da individuare nello squilibrio tra la dimensione ancora nazionale, territoriale, della lotta popolare e di classe e la natura transnazionale del capitale, aterritoriale della finanza. La politica moderna nasce, per i ceti popolari, come conflitto contro il modo di produzione capitalistico, che ha, nei suoi caratteri genetici, la dimensione mondiale. Ricordano Marx ed Engels, nel Manifesto, che il capitale domina «l’intero globo della Terra» (die ganze Erdkugel). Perciò la scala della lotta contro di esso deve essere mondiale: «proletari di tutto il mondo unitevi». Se nel conflitto tra capitale e lavoro, nelle vertenze dentro la fabbrica, il capitale gode del vantaggio di poter fuggire, di trasferirsi altrove, per gli operai, che in questo altrove non hanno alcun rappresentante, la sconfitta è certa. La possibilità del conflitto è mutilata in partenza. Vero è che nelle società avanzate accanto alla classe operaia operano molti altri ceti e figure, ma a parte il fatto che anche questi sono spesso alle prese con una controparte mobile sul piano mondiale, l’impotenza che si è creata nel cuore originario dell’antagonismo anticapitalistico si riverbera su tutto il resto. Se il nemico scompare, la lotta non ha più direzione, la politica si spegne.
Una prima considerazione di natura propositiva. Il Forum mondiale nato a Seattle nel 1999, che ormai lavora un anno per organizzare un incontro di pochi giorni, mostra l’esaurimento della formula. I movimenti non durano a lungo se non si solidificano in istituzioni. Oggi occorrerebbe poter organizzare uno sciopero internazionale anche di una sola categoria di lavoratori. Oppure mobilitare il boicottaggio commerciale dei prodotti di una multinazionale con la quale si è aperta una vertenza. Se si riuscisse a colpirla sul piano delle vendite, creando allarme sul titolo in borsa, ecc. e infine si vincesse la vertenza , l’esito politico sarebbe immenso. L’esempio vittorioso diventerebbe contagioso. La mobilità mondiale del capitale apparirebbe vulnerabile, la lotta contro di esso premiata e incoraggiata.
Ricordo, a contrario, per limitarci al campo europeo, che i vari sindacati nazionali non hanno neppure provato a creare un coordinamento continentale della rappresentanza operaia. Perciò oggi costituisce un obiettivo di rilievo sostituire i vecchi gruppi dirigenti dei sindacati, eredi di una situazione storica tramontata.
2 A sinistra dimentichiamo facilmente l’evento che ha fatto epoca e il cui fragore non si è ancora spento nei nostri cieli. Il crollo dell’URSS, preceduto da un trentennio di immobilità autoritaria del potere sovietico, ha coperto di un’ ombra di fallimento il più grande progetto realizzato dalla politica nel XX secolo: la rivoluzione d’Ottobre. Quella sua vittoria è degradata in gestione illiberale del potere.
Le critiche di F. A.von Hayeck all’economia pianificata (The Road to the Serfdom, 1944) trovavano, a partire dagli anni ’80, una conferma travolgente. Da allora il pensiero neoliberista, intimamente antipolitico, dilaga. E’ stato agevole ai gruppi dirigenti capitalistici estendere gli attacchi anche ai governi socialdemocratici europei, alle prese con una crescente crisi fiscale dello Stato. Da quel momento si è aperta una divaricazione di valori tra Stato e impresa, politica ed economia. La politica (soprattutto grazie alle retoriche della Thatcher) è stata vestita coi panni del corporativismo sindacale, dell’assistenzialismo scroccone, dell’inefficienza burocratica, dell’incapacità della decisione, di nemica delle libere scelte dell’individuo. Con queste critiche si è affermata una nuova visione del mondo: gli uomini sono incapaci di altruismo e di operare per il bene comune. Solo se perseguono il loro privato interesse agiscono con efficacia e producono ricchezza. Il pessimismo ontologico del pensiero protestante ridava smalto a un Adam Smith ridotto a cantore del libero mercato fondato sugli egoismi umani. L’etica veniva fatta sparire dalle istituzioni pubbliche e dai partiti e fatta rinascere nei liberi appetiti del mercato. L’imprenditore diventa la nuova figura eroica nell’immaginario collettivo.
3 Siamo ancora dentro tale corrente spirituale, non solo per l’effetto perdurante del passato, ma perché essa ha trovato nuove fonti di alimentazione. Una di queste è la spinta del capitalismo finanziario a trasformare lo Stato in azienda. Le procedure di scelta e decisione dei parlamenti e dei governi appaiono troppo lente rispetto alla velocità dell’economia e della finanza. Se un operatore può spostare immense somme di danaro con un gesto che dura pochi secondi, all’interno di società capitalistiche in competizione su scala mondiale, è evidente che la struttura degli stati democratici appare ormai come un organismo arcaico.
4 Il deperimento dello Stato sociale, che non distribuisce più ricchezza, che non favorisce la mobilità sociale, ecc., svaluta agli occhi dei cittadini il valore delle istituzioni pubbliche, dei partiti, delle forze politiche, che appaiono impotenti, divise, litigiose.
5 Il declino e il disfacimento dei grandi partiti popolari, anche per effetto del venir meno degli antichi collanti ideologici, per la frammentazione sociale del post-fordismo, ha immesso dentro quel che è rimasto di questi organismi collettivi il virus della competizione individualistica. E’ indubbio che nel frattempo si è verificato un mutamento antropologico, come sappiamo da tanti studi, da Bauman ai teorici della biopolitica: l’ economia si è imposta alla società anche come una nuova soggettività che plasma il comportamento individuale. Non si crede più nella possibilità di cambiare il mondo ( se non altro per le grandi difficoltà da affrontare, visti i rapporti di forza dominanti) ma si crede nella possibilità del proprio personale successo. Occorrerebbe aggiungere anche che oggi l’individuo, oltre ad essere assorbito lungamente dall’orario di lavoro, è soggetto a una moltitudine di “offerte” pressioni quotidiane – dagli sms alla telefonate, dalle partite di calcio allo spettacolo televisivo, dagli acquisti (on line o al supermercato) ai giochi elettronici, dalla gestione della posta elettronica al disbrigo delle pratiche correnti per la gestione della casa. Il tempo della giornata dell’individuo adulto è frantumato e lo spazio per la politica, che comporta impegno e continuità diventa sempre più residuale.
6 La debolezza dei partiti - ad es. l’impossibilità di generare posti di lavoro attraverso l’azione pubblica - li spinge ad allontanarsi sempre di più dai ceti che prima rappresentavano e a guadagnarne il consenso attraendo investimenti con politiche di sostegno alle imprese. Per questa via la politica ratifica la sua definitiva subordinazione all’economia. Ma, se il successo dell’”imprenditore politico”, che non gode più di sostegni nel mondo popolare, è legato ai mezzi personali di cui dispone, è evidente che egli è esposto alla tentazione di usare a proprio vantaggio risorse pubbliche o illecite e quindi alla corruzione per vincere la competizione con i suoi colleghi.
7 La politica, ridottasi al “discorso” del ceto politico, appare gravemente impoverita rispetto alla ricchezza delle culture che la società oggi esprime. A fronte della multiformità di conoscenze che percorrono il corpo sociale, il sapere della politica - che non si nutre più di teoria e analisi sociale - degrada nella retorica pubblicitaria della società dello spettacolo. Un tempo la politica, la strategia dei partiti di massa sorti nel dopoguerra, era ispirata dall’analisi sociali, dalla conoscenza storica del passato, dall’indagine dei mutamenti economici e sociali. Molteplici discipline scientifiche conncorrevano al suo specifico sapere. I partiti della sinistra, sino a un certo momento, sono stati ispirati dalla teoria, vale a dire la creazione più geniale della politica moderna, che concepisce il corso storico come assoggettabile alla volontà umana attraverso un progetto. Oggi la cultura dei partiti si alimenta di sondaggi elettorali perché loro fine ultimo è l’affermazione nei luoghi del potere e della rappresentanza. La loro pratica intellettuale si riduce alla mera propaganda.
Qualche considerazione di proposta. La politica rinasce se sa pensare nuovi mondi possibili. L’idea della crescita infinita, in cui il capitale ci vuol trascinare, è un assurdo. Il pianeta trabocca di ricchezza in forma di merci ed è minacciato dal suo stesso incremento. Teoricamente, un accordo cooperativo mondiale tra i vari paesi frenerebbe il saccheggio delle risorse, consentirebbe una vita dignitosa a tutti i popoli, ridurrebbe la competizione a pochi ambiti, limiterebbe la corsa individuale di soggetti e forze dentro i capitalismi nazionali. Sotto il profilo culturale l’ipotesi apre un vasto orizzonte alla lotta politica, poggiante su drammatiche necessità ambientali. La sinistra ha a disposizione un nuovo universalismo, quello ecologico, di cui non è riuscita a fare materia di supremazia politica sull’avversario.
La lotta per salvare il pianeta può ricomporre un fronte sociale vastissimo. Infine i partiti. In Italia i tentativi di crearne nuovi sono stati, o sono diventati, progetti di ricostituzione di rappresentanze parlamentari. Purtroppo non sono sufficienti programmi e discorsi diversi dal conformismo dominante se si indossa la stessa divisa del medesimo ceto politico.Deve cambiare il comportamento, non solo il verbo. Il consenso da un popolo frustrato e deluso non viene. E invece occorre organizzare la società in frantumi, prima di tentare di rappresentarla. Poi regole, leggi, statuti per organizzare la volontà collettiva dentro nuovi organismi. Se non possediamo la sostanza ideale per tenere insieme il pluralismo competitivo dei soggetti, per imbrigliane la ricchezza inconcludente, non ci restano che i vincoli delle norme.
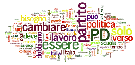 Estratto dell’intervento dell’autore al "Festival del diritto" a Piacenza; quest’anno il tema su cui studiosi di varie discipline si stanno confrontando è quello della dignità. La
Estratto dell’intervento dell’autore al "Festival del diritto" a Piacenza; quest’anno il tema su cui studiosi di varie discipline si stanno confrontando è quello della dignità. La Repubblica
, 24 settembre 2016 (c.m.c.)
C’e' una piccola frase, apparentemente alquanto banale, in La sera del dì di festa di Giacomo Leopardi che dice «tutto al mondo passa e quasi orma non lascia». Desidero richiamare l’attenzione su quel “quasi”. Certo, la vita e le nostre opere sono effimere, ma non del tutto. C’è un residuo, il “quasi”, che resta, che si accumula e che forma ciò che chiamiamo umanità, un termine che può tradursi in cultura: il deposito delle esperienze che vengono da lontano e preparano il futuro, un deposito al quale tutti noi, in misura più o meno grande, partecipiamo. O, meglio: dobbiamo poter partecipare. Altrimenti, siamo fuori della umanità.
Per questo, troviamo qui il primo, il primordiale diritto, che condiziona tutti gli altri. La violazione di questo diritto equivale all’annientamento del valore della persona, alla sua riduzione a zero, a insignificanza.
Eppure, viviamo in un mondo nel quale non è nemmeno possibile stabilire con precisione quanti sono gli esseri umani che non conoscono questo elementare diritto che possiamo chiamare “diritto al segno” o, leopardianamente, “diritto all’orma”.
Si misurano a milioni, cioè a numeri approssimativi, senza che — ovviamente — a questi numeri possano associarsi nomi. Milioni di anonimi, che giungono a noi come fantasmi, mentre le loro sono esistenze concrete, anche se durano spesso lo spazio d’un mattino o di pochi mattini, consumandosi in fretta in condizioni disumane, in luoghi dove la lotta per la mera sopravvivenza
materiale sopravanza qualunque possibilità di relazioni, dove i neonati vengono al mondo sotto la maledizione di leggi statistiche che li condannano alla sparizione entro pochi giorni o settimane di vita.
Ciò che ci interpella inderogabilmente è che non possiamo dire, come forse si sarebbe potuto un tempo, nel mondo diviso per aree, storie, politiche separate e indipendenti le une dalle altre: sono fatti loro, loro è la responsabilità, il nostro mondo non è il loro, ognuno pensi per sé alle proprie tragedie. Non possiamo dirlo, perché il mondo, come ci ripetiamo tutti i momenti, è diventato uno solo, grande, globale. Noi, in un tale mondo, osiamo parlare kantianamente, senza arrossire, di “dignità” come universale diritto al rispetto. Il “diritto all’orma” detto sopra è legato a tutti gli altri diritti come loro premessa e condizione: è davvero quello che è stato definito da Hannah Arendt, con una formula che ha avuto successo (Rodotà), il “diritto di avere diritti”.
C’è un diritto che potremmo dire essere un altro modo d’indicare il diritto di avere diritti, ed è il diritto al nome: un diritto al quale i trattati di diritto costituzionale, se non l’ignorano, dedicano poche righe. La nostra Costituzione, all’art. 22, tra i diritti umani fondamentali stabilisce che nessuno può essere privato del suo nome perché i Costituenti sapevano il valore di quel che dicevano. “Nominando” si specifica, si riconosce, si creano le premesse per creare un rapporto.
Questo non accade, oggi, alle centinaia di migliaia e, in prospettiva, dei milioni di migranti che sono, per noi, milioni non solo di senza nome, ma anche di senza terra. «Quel che è senza precedenti — scriveva Arendt con riguardo alla tragedia del suo popolo negli anni ’30 e ’40 del Novecento — non è la perdita della patria, ma l’impossibilità di trovarne una nuova». Tale impossibilità, allora, era determinata dalle politiche razziali e colpiva comunità umane determinate. Oggi, deriva dalla condizione generale del mondo saturo globalizzato.
Questa situazione estrema è la sorte delle persone private dei diritti umani. I diritti umani sono una realtà per chi sta sopra, e il contrario per chi sta sotto. Lo stesso, per la dignità. Per chi sta sopra, le rivendicazioni di chi sta sotto e chiede di emergere all’onor del mondo sono attentati allo standard di vita “dignitoso” di chi sta sopra. Quando si chiede lo sgombero dei migranti che intasano le stazioni, dormono nei parchi pubblici e puzzano, non si dice forse che danno uno spettacolo non dignitoso? Ma, dignità secondo chi? Non secondo i migranti, che della dignità non sanno che farsene, ma secondo noi che da lontano li guardiamo.
Ci sono parole, dunque, che non valgono nello stesso modo per i divites e gli inanes. Si dovrebbe procedere da questa constatazione per un onesto discorso realistico e riconoscere che le parole che hanno valore politico non sono neutre. Servono, non significano; sono strumenti e il loro significato cambia a seconda del punto di vista di chi le usa; a seconda, cioè, che siano pronunciate da chi sta (o si mette) in basso o da chi sta (o si mette) in alto nella piramide sociale. Occorre, perciò, diffidare delle parole e dei concetti politici astratti. Assunti come assoluti e universali, producono coscienze false e ingenue, se non anche insincere e corrotte.
Potremmo esemplificare questa legge del discorso politico parlando di democrazia, governo, “governabilità”, libertà, uguaglianza, integrazione, ecc. e di diritti e dignità. Si prenda “democrazia”: per coloro che stanno sopra e hanno vinto una competizione elettorale, significa autorizzazione a fare quello che vogliono; per coloro che stanno sotto e sono stati vinti, significa pretesa di rispetto e di riconoscimento: fare e non fare; prepotenza e resistenza. Oppure “politica”: forza sopraffattrice dal punto di vista dei forti, come quando la si usa in espressioni come “politica di espansione”, “politica coloniale”, “politica razziale”, “politica demografica”; oppure, esperienza di convivenza, coinvolgimento e inclusione sociale. Oppure ancora: la (ricerca della) “felicità”.
Oggi, sono i potenti che rivendicano la propria felicità come diritto, la praticano e la esibiscono come stile di vita, quasi sempre osceno e offensivo. Ma non sentiremo un disoccupato, un lavoratore schiacciato dai debiti, un genitore abbandonato a se stesso con un figlio disabile, un migrante senza dimora, un individuo oppresso dai debiti e strangolato dagli strozzini, uno sfrattato che non ha pietra su cui posare il ca- po, una madre che vede il suo bambino senza nome morire di fame: non li sentiremmo rivendicare un loro diritto alla “felicità”. Sarebbe grottesco. Sentiremo questo eterogeneo popolo degli esclusi e dei sofferenti chiedere non felicità ma giustizia.
Ma, anche la parola giustizia non sfugge alla legge dell’ambiguità. Giustizia rispetto a che cosa? Ai bisogni minimi vitali, come chiederebbero i senza nome e i senza terra; oppure ai meriti, come sostengono i vincenti nella partita della vita? La giustizia degli uni è ingiustizia per gli altri. Si comprende, allora, una verità tanto banale quanto ignorata, nei discorsi politici e dei politici: se si trascura il punto di vista dal quale si guardano i problemi di cui ci siamo occupati e si parla genericamente di libertà, diritti, dignità, uguaglianza, giustizia, ecc., si pronunciano parole vuote che producono false coscienze, finiscono per abbellire le pretese dei più forti e vanificano il significato che avrebbero sulla bocca dei più deboli.
Onde, la conclusione potrebbe essere questa: queste belle parole non si prestano a diventare stendardi che mobilitano le coscienze in un moto e in una lotta comuni contro i mali del mondo, per la semplice ragione che ciò che è male per gli uni è bene per gli altri. La vera questione è la divisione tra potenti e impotenti. Tanto più le distanze diminuissero, tanto più l’ambiguità delle parole che usiamo diminuirebbe. Ma, è chiaro, qui il discorso deve finire, perché si deve uscire all’aperto, dove non bastano le parole ma occorrono le azioni.
 «Dal lavoro al web, dalla famiglia al fine vita:in un'intervista di Simonetta Fiori Stefano Rodotà analizza una delle parole chiave della nostra contemporaneità: “Le leggi devono proteggerla, è ciò che ci rende umani”». La
«Dal lavoro al web, dalla famiglia al fine vita:in un'intervista di Simonetta Fiori Stefano Rodotà analizza una delle parole chiave della nostra contemporaneità: “Le leggi devono proteggerla, è ciò che ci rende umani”». La
Repubblica, 23 settembre 2016 (c.m.c.)
Tra le parole chiave del nuovo millennio è la più abusata. Forse la più calpestata. La dignità è anche un lemma centrale nel dizionario autobiografico di Stefano Rodotà, che dai diritti sul lavoro a quelli dentro la famiglia, dalla tecnocrazia alla tutela della privacy, ne ha fatto la bussola di una ricerca intellettuale e politica cominciata oltre mezzo secolo fa. Dignità è oggi il tema del nuovo Festival del diritto, da lui fondato a Piacenza otto anni fa.
Perché oggi si parla molto di dignità?
«È la parola che evoca direttamente l’umano, il rispetto della persona nella sua integrità. Ed è ancora più immediata di parole storiche come eguaglianza, libertà, fraternità. C’è una bellissima frase scritta da Primo Levi: per vivere occorre un’identità, ossia una dignità. Senza dignità l’identità è povera, diventa ambigua, può essere manipolata».
Ma la parola rischia di essere contraddetta dai fatti. L’Ue, ad esempio, esordisce nella sua carta dei diritti fondamentali con il termine dignità. Ma sembra dimenticarsene con i migranti, alzando muri.
«Sì, c’è uno scarto fortissimo. Quando nel Duemila è stato scritto quel documento, nel preambolo si è voluto rimarcare che l’Europa pone al centro della sua azione la persona. Lo sta facendo? No. Una contraddizione che incrina il patto cittadini-istituzioni».
Una promessa non adempiuta.
«Con conseguenze molto gravi. Il mancato rispetto della dignità produce un effetto di delegittimazione. Tu non mi riconosci nella mia pienezza di persona degna e io non ti riconosco nella tua sovranità istituzionale. Da qui la rabbia sociale che alimenta il terrorismo e il caos geopolitico. Difendere la dignità è difendere la democrazia».
La parola dignità ha segnato l’epoca successiva alla seconda guerra mondiale.
«Non è un caso che quando la Germania ha cercato un termine per reagire alla devastazione nazista ha trovato proprio dignità. Compare nel primo articolo della costituzione. E compare nella carta costituzionale dell’altro grande sconfitto, l’Italia».
In Italia la parola acquista una coloritura più forte.
«Sì, le si affianca un attributo fondamentale: dignità sociale. La dignità è anche nel rapporto con gli altri. Tu non puoi negarla al prossimo nel momento in cui la rivendichi per te stesso. I costituenti italiani strapparono la dignità da una condizione di astrattezza, fornendole una solida base materiale. Prendiamo l’articolo 36: il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro e sufficiente a garantire a sé e alla sua famiglia un’esistenza dignitosa. Cosa volevano dire i nostri padri? La dignità non è a costo zero. Esistono diritti che non sono a costo zero».
L’aver introdotto nella nostra carta il pareggio di bilancio indebolisce questi diritti?
«Non c’è dubbio. L’articolo 81 è un vincolo fortemente restrittivo e non necessario. Giustificato con il solito ritornello: ce l’ha chiesto l’Europa».
La crisi economica ha giocato contro.
«Sì. Ma ha inciso soprattutto la pretesa di spostare nella sfera economica il luogo dove si decidono i valori e le regole. Questo ha comportato uno spostamento del potere normativo: poiché sono io quello che gestisco il danaro e investo, sono io che detto le regole. Il tramonto dello Stato costituzionale dei diritti».
La dignità è una parola flessibile, adatta alla contemporaneità liquida. Come cambia nell’epoca della tecnologia?
«Un primo importante cambiamento riguarda la costruzione stessa dell’identità. Quando io posso raccogliere una serie di informazioni su una persona, e sono anche in grado di fare valutazioni prospettiche — se ha fatto questo, farà anche quest’altra cosa — in sostanza io sto partecipando alla costruzione della sua identità».
L’identità e dunque la dignità vengono manipolate. Ma c’è un’altra offesa della dignità che riguarda le persone che mettono in piazza la propria intimità. Con esiti che possono condurre al suicidio.
«Qui entriamo in un terreno molto complicato. Quando io metto in circolazione delle informazioni che mi riguardano devo sapere che la rete determina effetti di moltiplicazione. E quando io ricevo informazioni che riguardano altre persone dovrei riconoscere una sfera privata che non posso manipolare».
Ma come si tutela la dignità dei sentimenti in rete?
«La prima cosa che mi viene da dire: tieniteli per te. Ma il problema dei sentimenti è un problema di relazione: sono in gioco i miei rapporti con un’altra persona, con un gruppo. E allora bisogna porre dei paletti: prima di far circolare contenuti che riguardano altri devo preoccuparmi che ci siano il consenso o la consapevolezza di quelle persone».
Un altro versante riguarda la dignità del morire. In Italia non esiste ancora una legge sul testamento biologico.
«E per fortuna, oserei dire. La legge prospettata era molto restrittiva, rispetto a una coraggiosa sentenza della Corte Costituzionale che nel 2008 riconobbe il diritto del governo del corpo esercitato in piena autonomia. Il legislatore ha il vizio o la propensione a impadronirsi della vita delle persone. In Italia abbiamo diffidenza verso le decisioni autonome: la libertà non è vista come bene da salvaguardare ma rischio da tenere sotto controllo».
Dalle tecnoscienze alla bioetica, dalla privacy ai diritti d’amore, dignità è la parola chiave del suo impegno.
«Sì, ma l’ho scoperto piano piano: la dignità è un modo antropologico di vivere. Se io riconosco a una persona dignità, non posso comportarmi come se questa consapevolezza non l’avessi mai acquisita».
 «Nella città che esattamente un anno fa chiuse la stazione ferroviaria di Keleti per chiudere ai profughi di guerra le porte della fortezza Europa, si è discusso anche di migrazione denunciando i respingimenti».
«Nella città che esattamente un anno fa chiuse la stazione ferroviaria di Keleti per chiudere ai profughi di guerra le porte della fortezza Europa, si è discusso anche di migrazione denunciando i respingimenti». Il manifesto,
22 settembre 2016 (c.m.c.)
Articolo firmato da Silvio Cristiano (Università Iuav di Venezia), Viviana Asara (Vienna University of Economics and Business), Federico Demaria (Universitat Autonoma de Barcelona), Giacomo D’Alisa (Universitat Autonoma de Barcelona), Barbara Muraca (Oregon State University)
Si è conclusa con grande successo a Budapest la Quinta Conferenza Internazionale sulla Decrescita per la Sostenibilità Ecologica e l´Equità Sociale (LINK), finora ignorata dai quotidiani italiani. Spesso fraintesa e bistrattata in Italia, all’estero la decrescita è invece sempre più discussa come possibile alternativa a un modello economico in crisi.
Dalla Francia alla Catalogna, dalla Germania agli Stati Uniti, dal Canada all´India, chi parla di decrescita – né “felice” né “infelice” – invoca non il contrario della crescita del prodotto interno lordo, bensì un approccio completamente alternativo al dogma della crescita-ad-ogni-costo. Quella di Budapest è stata la quinta edizione di un ciclo di conferenze che dal 2008, dopo Parigi, Barcellona, Venezia, Montreal e Lipsia, offrono il contesto adatto per discutere e scambiare risultati scientifici ma anche “buone pratiche” all´interno di un movimento sociale-accademico che non smette di crescere.
Dal 30 agosto al 3 settembre, a Budapest sono affluiti oltre seicento tra accademici e attivisti provenienti da tutti i continenti, mentre in città in migliaia stavano animando la prima “Settimana della decrescita” per le strade, negli spazi sociali, culturali e di economia sociale che a Budapest hanno dato vita a una serie di esperienze umane e politiche basate sul vivere la società in un modo altro, al di fuori della logica del profitto. Perché uscendo dalla nostra penisola il concetto di decrescita è piuttosto e innanzitutto una proposta politica per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e della giustizia sociale e ambientale, ben diversa quindi da quell’attitudine più o meno naif con la quale viene spesso liquidata in Italia.
Nella cinque giorni ungherese è stato ribadito come la decrescita sia prima di tutto un tentativo di ri-politicizzare i discorsi sulla sostenibilità, concetto troppo spesso distorto nelle sue declinazioni di “crescita verde”, “economia verde” o “sviluppo sostenibile”, e affidato al mito di una maggiore efficienza tecnologica e mercificazione della natura, a mascherare il fatto che una crescita infinita, oltre che non sostenibile, non è neanche fisicamente possibile su un pianeta finito.
Nella sessione introduttiva della conferenza, Federico Demaria (ricercatore dell’Università Autonoma di Barcellona e del collettivo accademico catalano Research & Degrowth) ha domandato alla platea se la decrescita possa costituire “un progetto politico di sinistra per una trasformazione socio-ecologica della società”.
Come ha spiegato Barbara Muraca (professoressa all´Oregon State University), la crescita ha ormai esaurito la sua funzione di “stabilizzazione dinamica della societá” (concetto caro ai sociologi) o di “pacificatore sociale” che aveva un tempo nelle socialdemocrazie europee. La dipendenza della nostra società dalla crescita in quello che ormai anche il Fondo Monetario Internazionale ha dipinto come uno scenario di “stagnazione sistemica” sta minando le vere basi di riproduzione socio-economica, politica e culturale delle nostre società contemporanee. I limiti della crescita non sono solo di tipo ecologico, ma anche sociale e culturale.
La conferenza di Budapest ha affrontato un vasto spettro di tematiche: si è discusso di energia e di produzione alimentare, di stato sociale e di questioni di genere, di conflitti ambientali e di rapporti tra il nord e il sud del mondo, di urbanistica e di alternative post-capitaliste, di reddito minimo, di reddito massimo e di movimenti sociali. Nella città che esattamente un anno fa chiuse la stazione ferroviaria di Keleti per chiudere ai profughi di guerra le porte della fortezza Europa, si è discusso anche di migrazione denunciando i respingimenti.
Proprio sul manifesto, recensendo il saggio “Vie di fuga” di Paolo Cacciari, lo scorso anno Mauro Trotta ravvisava nei discorsi sulla decrescita una possibile strada verso il processo di ricomposizione della sinistra. Una strada che, per la sua storia e il suo presente, su queste pagine potrebbe effettivamente valere la pena se non altro di discutere.
Dopo il successo delle sue dieci edizioni, la pubblicazione in italiano del volume “Decrescita: vocabolario per una nuova era” (a cura di G. D’Alisa, F. Demaria e G. Kallis per Jaca Books) con contributi di più di cinquanta autori e la significativa prefazione di Luciana Castellina, potrebbe costituire un prezioso punto di partenza in questa direzione. La decrescita non significa recessione o stagnazione, ma il necessario progetto di riforma radicale delle nostre società contemporanee e delle loro istituzioni fondanti, che possa far fronte alla crisi multidimensionale (ambientale, politica e economica) che stiamo vivendo.
 «Quando capiamo il nesso tra crisi climatica, crisi economica e la nostra personale sofferenza, allora c’è davvero il potenziale per cambiare il mondo».
«Quando capiamo il nesso tra crisi climatica, crisi economica e la nostra personale sofferenza, allora c’è davvero il potenziale per cambiare il mondo».
italiachecambia online, 22 settembre 2016 (c.m.c.)
Il 2 ottobre, nella Giornata internazionale della nonviolenza e nell’anniversario della nascita di Gandhi, Firenze ospiterà un convegno internazionale interamente dedicato a quella che Helena Norberg-Hodge, analista economica vincitrice del Right Livelihood Award (il “Premio Nobel alternativo”) e del Goi Peace Award, definisce l’“economia della felicità”. Insieme a lei saranno protagonisti di questo evento relatori del calibro di Serge Latouche, Jeremy Irons e Vandana Shiva.
Italia che Cambia è mediapartner dell’VIII Conferenza Internazionale dell’Economia della Felicità promossa dall’organizzazione non profit Local Futures e dall’associazione Mani Tese, con la collaborazione ed il sostegno di Terra Nuova e Gruppo Macro.
L’evento consiste in una sessione plenaria di conferenze aperta al pubblico la domenica 2 Ottobre sul tema Economia della Felicità. La conferenza fiorentina segue una serie di fortunate edizioni precedenti, svoltesi in Australia, USA, India e Korea, di enorme successo.
Lo scopo principe dell’evento è quello di ri-pensare l’economia, allontanandosi dal modello di crescita globale condotto dalle multinazionali, a favore di un nuovo modello economico in cui siano centrali la persona e l’ambiente. La struttura stessa dell’attuale economia globale causa instabilità, scarsità (artificiale) e competizione, squarciando il tessuto di comunità e producendo distruzione ecologica su scala massiccia. Collasso finanziario, scandali bancari, debiti enormi, surriscaldamento globale, crisi del petrolio, livelli di disoccupazione in aumento, crescita dei livelli di alienazione personale: tutti questi sono segni della disfunzionalità dell’attuale modello basato sulla egemonia dell’economico e sul mito della crescita globale.
Tuttavia un crescente numero di persone, tra cui ecologisti, filosofi, economisti, attivisti, stanno guardando verso un nuovo modello: quello basato su un’economia localizzata.
La conferenza di Firenze si prefigge in particolare di:
- Dare il via ad un dibattito informato sui temi della economia della crescita globale, in primo luogo i cosiddetti trattati di libero scambio che hanno determinato e determinano il passaggio di potere dai governi nazionali alle multinazionali o Big Corporation.
- Raccogliere esempi concreti di progetti di localizzazione per esplorare un nuovo paradigma economico che beneficia le persone, le loro comunità e l’ecologia – piuttosto che le banche e le grandi aziende.
- Avviare uno studio sistemico e un dibattito sulle idee e le mode culturali che hanno portato nell’epoca moderna all’egemonia dell’economico e del monetario su gli altri aspetti della vita. Solo un analisi accurata delle radici culturali del mito della crescita globale, può portarci ad invertire radicalmente la tendenza perché in realtà un altro mondo è possibile, anzi necessario.
- Esplorare i programmi di gruppi e organizzazioni locali rispetto al passaggio da globale a locale e rivitalizzare le economie e comunità
- Condividere strategie efficaci per un cambiamento sistemico. Questo deve passare per cambiamenti di politica attraverso leggi, tasse e sussidi che penalizzino il commercio e l’economia globale per favorire il locale, l’ecologico, le comunità di territorio.
- Contribuire alla costruzione di un movimento internazionale forte a favore del cambiamento da globale a locale, attraverso il International Alliance for Localization (IAL) ed altre piattaforme condivise.

«Dopo i cinque anni al vertice, Kim si affaccia al secondo mandato senza avere rivali. Una farsa che in Banca mondiale va avanti da parecchi anni». Re:Common, 22 settembre 2016 (p.d.)
La settimana scorsa è scaduto il termine per la presentazione delle domande per l’ambita posizione di Presidente della Banca mondiale. L’unico a farsi avanti su proposta del governo statunitense – serve infatti un esecutivo che avanzi le candidature – è stato proprio l’attuale capo dell’istituzione, Jim Yong Kim.
Dopo i cinque anni al vertice, Kim si affaccia al secondo mandato senza avere rivali. Una farsa che in Banca mondiale va avanti da parecchi anni, dal momento che per tradizione è il governo americano di fatto a nominare il Presidente – così come i governi europei “indicano” il Direttore del Fondo monetario internazionale.
Questa volta tutti si attendevano che emergesse un candidato più forte e credibile. Anche perché Kim ha clamorosamente fallito. Il dottore americano di origini sudcoreane, fortemente voluto da Barack Obama per il suo passato nella lotta all’Hiv, ha infatti deluso tanti, che ne hanno chiesto le dimissioni, o quanto meno un non rinnovo del suo mandato. In primis l’Associazione dello staff della Banca stessa, che ha criticato ferocemente la sua riforma della struttura interna e la mancanza di leadership su molti dossier.
Inoltre Kim è stato giudicato in maniera negativa da diverse organizzazioni della società civile internazionale, che sotto la sua guida hanno constatato un annacquamento delle politiche ambientali e sociali, un utilizzo di nuovi strumenti finanziari opachi e un ritorno del sostegno alle grandi dighe in Africa e altrove, progetti che comportano spesso pesanti impatti ambientali e sociali. Kim ha fatto inorridire molti attivisti quando recentemente ha affermato che lo sviluppo comporta inevitabilmente spostamenti di massa.
Per dovere di cronaca va aggiunto che mai come negli ultimi cinque anni la Banca mondiale ha vissuto accesi conflitti Nord-Sud al suo interno, o per meglio dire paesi occidentali contro paesi emergenti. Diversi dossier sono stati fermati proprio dall’opposizione dei governi del Sud globale che oramai contano davvero, Cina in primis.
Nonché la World Bank per la prima volta vive la competizione di nuove istituzioni finanziarie internazionali create fuori dall’orbita statunitense, quali la Banca Asiatica per gli Investimenti nelle Infrastrutture e la Nuova Banca di Sviluppo dei paesi BRICS. Una competizione tutta geopolitica, più che riguardo cosa queste realtà vogliano finanziarie, dal momento che parliamo sempre di grandi opere vecchio stile condite della solita ideologia liberista – vedi il nuovo mantra del settore privato come unico e indiscutibile motore di sviluppo.
Così la “vecchia” World Bank compete al ribasso, anch’essa tornando a finanziare mega opere infrastrutturali, facendo un po’ meno attenzione all’ambiente e ai diritti sociali, non parlando di diritti umani per non urtare le sensibilità di alcuni, sebbene a parole la difesa del clima e dei diritti delle donne sono la priorità.
Che succederà a questo punto? Kim facilmente otterrà il secondo mandato, già agli incontri di ottobre di Banca e Fondo monetario. Per i governi del Sud una Banca mondiale debole, ma che presta sempre tanto, è utile. I paesi del Nord, quali quelli europei, cercano sempre di prendere sufficienti appalti per le loro imprese, cercando di far contribuire un po’ di più i paesi emergenti. Insomma, tutto cambi affinché nulla cambi alla Banca mondiale.
 , con postilla (m.c.g.)
, con postilla (m.c.g.)
Roma, 14 settembre 2016
Oggetto: Udienza pubblica del 20 settembre 2016. Internazionalizzazione (inglesizzazione) di atenei e scuole italiane.
Illustre Presidente, illustre Relatore,
illustri Giudici della Corte Costituzionale,
non entreremo giuridicamente nel merito del perché e del come, la cosiddetta internazionalizzazione” si attui nazionalizzando in inglese l’istruzione in italiano della Repubblica, partendo dall’alta formazione per proseguire verso il basso distruggendola in radice, né entreremo nel merito della questione di legittimità costituzionale dei provvedimenti adottati dal Politecnico di Milano in relazione all’art. 2, comma 2, lett. l) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte di cui in motivazione, in riferimento agli articoli 3, 6, e 33 della Costituzione, come recita il dispositivo del Consiglio di Stato.
È però nostro compito di Partito, attento da sempre ai diritti delle minoranze, allarmarci per quanto sta succedendo, addirittura, ad un popolo sovrano, qual è quello italiano, che vede sempre più lesi i propri diritti linguistici in Italia, e non difesi in Europa, dove la Commissione consulta la popolazione europea quasi esclusivamente in inglese persino su argomenti, come quelli dell’immigrazione, che coinvolgono massicciamente la popolazione italiana.
Umberto Eco in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia in Quirinale ebbe a dire che “Un dialetto è una lingua a cui è mancata l’università, e cioè la pratica della ricerca e della discussione scientifica e filosofica”, ne consegue che governi, ministri, parlamentari, rettori, docenti, e chiunque altro tolga spazio allo studio in italiano di qualsivoglia materia nell’università, vuole la dialettizzazione della lingua italiana. Svolge un’azione sovversiva tesa alla perdita di sovranità linguistica dell’Italia per consegnarla in mano straniera. Oggi persino extracomunitaria, in quanto con la Brexit, esce anche l’inglese (notificato all’UE dal solo Regno Unito quale lingua ufficiale), dalle lingue comunitarie. Entra così in cortocircuito anche il sistema della lingua straniera in Italia che ha assegnato all’inglese il ruolo di prima lingua tra le 4 maggiori dell’Unione.
Quanto sta accadendo va sotto il nome di Imperialismo delle Menti, dicitura coniata da Churchill nel 1943 quale prefigurazione di quelli che avrebbero dovuto essere gli Imperi del futuro con, al centro dell’azione distruttrice, la lingua degli altri popoli, in quanto «Il potere di dominare la lingua di un popolo offre guadagni di gran lunga superiori che non il togliergli province e territori o schiacciarlo con lo sfruttamento». Ed oggi le forze, materiali ed ideologiche, alle spalle dell’inglese sono così forti che il suo ruolo egemonico è stato interiorizzato. L’inglese tende ad essere promosso nel mondo come se fosse apolitico, e se non servisse interessi speciali. Gli usi e le forme dell’inglese ricevono perciò un contributo all’occupazione globale delle menti con modalità che verosimilmente sono al servizio degli scopi del controllo aziendale e dell’intimidazione, cooptazione e coercizione, perpetuando l’imperialismo linguistico-culturale. Là dove vogliamo che gli essere umani non debbano essere dominati dalle cose, e che la subordinazione di alcune persone ad altre cessi per sempre.
Al Politecnico di Milano nell’anno accademico 2014/15, su 39 corsi di laurea magistrale, 33 sono in inglese e solo 6 in italiano ma, questi ultimi, non resisteranno a lungo perché, persino chi opera con la doppia lingua italiano/inglese, viene penalizzato dal Rettore, il quale eroga 90.000 euro solo per i corsi di studio che scelgono l’ordinamento della laurea magistrale esclusivamente in inglese. Opera di corruzione vera e propria tesa ad espropriare la lingua e la cultura italiana alla Repubblica. Così, anziché arricchire la cultura italiana, partecipare e nutrire il dibattito pubblico, si crea una roccaforte d’intellettuali inglesizzati che non hanno nessun tipo di relazione con il paese dove l’università opera, che sono pagati coi soldi dei contribuenti italiani, ma che non ricambiano il salario con un lavoro intellettuale accessibile a tutti gli italiani.
Le università divengono, di fatto, enclave straniere in Italia, dalle quali escono studenti non più mentalmente italiani, incapaci di pensare scienza e tecnica in italiano, di fatto “agenti” stranieri promotori, a loro volta, d’impoverimento occupazionale italiano e arricchimento straniero o trasformazione anglofona delle imprese italiane, di emarginazione del resto della popolazione italofona.
Si pensi ancora al caso del PoliMi, con circa 12.800 iscritti alle lauree magistrali, ipotizzando una media di 14 esami nel biennio per corso di laurea, un solo libro di 25 € per esame, l’84% degli iscritti ai 33 corsi di laurea solo in inglese, la per dita biennale per la sola editoria scientifica italiana ed, evidentemente di tutto il sistema occupazionale di settore e di filiera, è di circa 125.086.500 Euro (25x14x33x10830). poi da prevedere una futura classe di laureati magistrali docenti nei licei scientifici e tecnologici che insegneranno termini scientifici e tecnici inglesi, innescando un meccanismo perverso che distruggerà per sempre il lessico tecnico-scientifico in lingua italiana.
Basta aggiungere questa cifra alle altre risultanti dai vari corsi solo in inglese delle molteplici università italiane, delle scuole secondarie, delle materie insegnate solo in inglese col metodo CLIL e, sotto i nostri occhi, l’accecante evidenza è che, attraverso l’istruzione, si sta perpetrando il genocidio linguistico e culturale della Repubblica italiana.
Distinti ed ossequiosi saluti, Giorgio Pagano
Responsabile della campagna per la lingua comune della specie umana
Una delibera del Senato Accademico del Politecnico di Milano del 21 maggio 2013, in nome dell’internazionalizzazione tanto ambìta dal Rettore Giovanni Azzone, rese l’inglese lingua obbligatoria per tutti i corsi di specializzazione e per i dottorati. Un nutrito numero di docenti (circa 100), critici sul carattere esclusivo della decisione, fece ricorso al TAR Lombardia denunciando il fatto che la decisione del senato accademico violava il diritto costituzionale ad accedere a corsi universitari erogati nella lingua ufficiale della Repubblica italiana, garantito ai cittadini in ragione del principio di eguaglianza di tutti di fronte alla legge. Una sentenza del TAR diede sostanzialmente ragione ai ricorrenti (n. 1348/2013) provocando un contro-ricorso del Politecnico, e del ministero dell’Istruzione dell’epoca, che trasferirono la questione al Consiglio di Stato il quale, a sua volta, si appellò alla Corte Costituzionale: questi i fatti all’origine dell’udienza prevista per il 20 settembre 2016.
La lettera inviata dai Radicali, pur prendendone spunto e approfondendone criticamente gli esiti indesiderabili, travalica la questione avanzata dai docenti nei confronti delle autorità accademiche del Politecnico, e affronta problematiche, quali il rischio di “dialettizzazione” della lingua italiana e di “imperialismo delle menti”, che chiamano in causa la dimensione politica ed economica delle strategie dei poteri forti in ambito europeo (e globale) che dell’uso esclusivo dell’inglese si avvalgono non soltanto come forma di dominio culturale. Nella lettera si colgono altresì alcune affinità con le riflessioni critiche contro l’inglesizzazione e la discriminazione linguistica avanzate in seno al Parlamento Europeo da Barbara Spinelli.
Nel frattempo il Rettore del Politecnico, in procinto di terminare il suo mandato - il cui indubbio merito è stato di suscitare un dibattito e una conflittualità vivacissimi all’interno di un corpo docente che sembrava ormai anestetizzato - si prepara a svolgere compiti strategici a livello nazionale. Giovanni Azzone infatti, già nominato nel marzo 2016 Presidente di AREXPO, la società (partecipata da Regione Lombardia, Comune di Milano e, dal febbraio 2016, dal Governo) che si occuperà della ‘valorizzazione’ dell’area exEXPO, è stato scelto da Matteo Renzi come project manager (eccolo di nuovo l’irritante e inutile anglicismo) di “Casa Italia”: il piano di prevenzione contro i terremoti allo studio del Governo dopo la ennesima tragedia che ha colpito Amatrice e i comuni limitrofi. Mai scelta fu più “inappropriata”. (m.c.g.)
Saggia prudenza dei custodi della Costituzione, o "aiutino" a chi vuole distruggerla in nome della "governabilità"? Ancora difficile comprenderlo. Il manifesto, 20 settembre 2016
Tanto tuonò che piovve. I rumors su un rinvio da parte della Corte costituzionale, e su contrasti nel merito, erano diventati insistenti. È ora ufficiale la notizia del rinvio dell’udienza del 4 ottobre, di cui non si conoscono al momento le motivazioni. È uno strappo non insignificante. Sarebbe fragile l’argomento di un’attesa per l’ultima ordinanza di Perugia, perché la Corte ben avrebbe potuto decidere su quanto è agli atti, e tornare poi sulla questione con sentenza o ordinanza. Ugualmente fragile sarebbe una motivazione fondata sull’attesa del referendum, dal momento che le questioni sollevate davanti alla Corte hanno a oggetto una legge formalmente non toccata dal voto. Nasce il sospetto che siano proprio i contrasti di merito che suggeriscono alla Corte di prendere tempo. O forse la consapevolezza che una riaffermazione anche parziale dei principi posti con la sentenza 1/2014 avrebbe di fatto inferto un colpo alla strategia referendaria del governo.
Vedremo se il rinvio sarà breve, e se la nuova data cadrà comunque prima del voto. In caso contrario, avremmo preferito, per la salute delle istituzioni e per la stessa Corte, che il rinvio non vi fosse. Il rinvio diventa un altro capitolo del romanzo referendario, che si arricchisce sempre più anche di personaggi stranieri più o meno autorevoli che offrono consigli e raccomandazioni agli italiani. L’ultimo è Weidmann, presidente della Banca centrale tedesca, e falco tra i falchi sui temi del bilancio e dell’austerity. Per lui, Draghi è un pericoloso guastatore, e Renzi una zecca fastidiosa. Ma Italicum e Jobs Act – e l’accostamento è di per sé suggestivo e preoccupante – sono la soluzione giusta per il nostro paese.
A Berlino troviamo conferma di un processo in atto da tempo. In Germania, come in Gran Bretagna, in Francia o in Spagna, partiti storici che hanno monopolizzato i consensi per decenni vedono progressivamente disgregarsi la propria base elettorale. Il bipolarismo si frantuma. Questo non è stato impedito da nessun sistema elettorale. I paesi citati hanno sistemi molto diversi, dal maggioritario
uninominale secco di collegio britannico al proporzionale misto della Germania, passando per il doppio turno francese e i microcollegi spagnoli. Per tutti la frantumazione del sistema politico si è verificata irresistibilmente, e non è stata impedita la nascita di partiti antagonisti o antisistema. Questo può certo condurre a giudizi politici negativi. Ma comunque ci insegna che nessun artificio elettorale o marchingegno istituzionale può impedire alla politica di prendere il sopravvento. Il paese reale, con le sue domande, i suoi bisogni, le sue pulsioni, le sue paure, alla fine viene fuori. Ne viene che una deriva politica che non piace si combatte con la politica, e non con gli algoritmi. È per questo che in nessuno dei paesi citati ci si inventa una legge elettorale pensata per mettere le brache al sistema politico. È quello che invece ha fatto Renzi, quando per ovviare al tramonto del bipolarismo italiano ha messo in campo un megapremio che dà ad una delle minoranze un surplus di seggi parlamentari tale da farne una maggioranza truffaldina, blindata e inattaccabile, e per di più al servizio del premier. Personalmente sono da tempo convinto che una cura di proporzionale sarebbe essenziale per restituire buona salute al sistema politico. È mai possibile che in Italia non esista più un’assemblea elettiva – una sola, dai municipi al parlamento – che esprima il paese com’è, senza artifici e distorsioni? E dovremmo prendere atto che l’ubriacatura del decisionismo non ha dato efficienza alla politica e alle istituzioni.
Maggiori è più difficili sono i problemi, più ampia deve essere la partecipazione democratica e la condivisione. La risposta non può mai trovarsi nel modello istituzionale autoreferenziale e oligarchico imposto da Renzi, e che i sostenitori pomposamente definiscono «democrazia decidente». È il modello che piace a Weidmann. Ma non è un caso che ai classici del costituzionalismo questa formula sia ignota, per l’ossimoro che fatalmente viene dal decidere restringendo la partecipazione. Suggeriamo a Weidmann di interrogarsi sul perché, a fronte del terremoto berlinese che segue a quello del Meclemburgo-Pomerania, non si proceda in Germania a copiare Renzi. E vogliamo aggiungere una parola per l’ambasciatore Usa, per il suo endorsement al governo e alle riforme. Forse l’ambasciatore non sa che negli Stati Uniti si è discusso per decenni della riforma del sistema elettorale presidenziale, che molti pensano sia un’elezione diretta ma che tale non è, posto che l’elezione in senso proprio ha luogo in un Collegio Elettorale che è un’invenzione di stampo settecentesco. Pensate alla felicità della Boschi se potesse dire che da oltre duecento anni si era in attesa di una riforma. Potremmo prestarla al paese amico, come si fa con le opere d’arte. Magari anche senza assicurazione.

Il manifesto, 20 settembre 2016 (p.d.)
Parlare della vicenda dei licenziamenti di rappresaglia nello stabilimento di Nola-Pomigliano, di quella rappresentazione del suicidio dell’amministratore delegato di Fiat-FCA addotta come motivo del licenziamento degli operai che l’avevano messa in scena, è difficile perché è una vicenda che coinvolge una grande mole di sofferenza. Mi è difficile soprattutto circoscrivere alla sola categoria della satira quello che in realtà è un urlo disperato che, di fronte a un atto estremo come il suicidio di lavoratori colpiti dal dispotismo padronale, fa appello alle coscienze. Non certo alla coscienza di Marchionne. Quella è protetta da una corazza fatta di denaro, di potere e del suo ruolo, che difficilmente la rende raggiungibile dal rimorso. Bensì alle coscienze di coloro che per il lavoro che svolgono sono stati coinvolti in questa vicenda: i capi della gerarchia di fabbrica, innanzitutto; poi quei sindacalisti che trovano l’emarginazione a vita dal mondo del lavoro di quegli operai il prezzo da pagare per non turbare gli accordi firmati o che vorrebbero firmare; poi i giornalisti che in qualche modo sono venuti a conoscenza della vicenda, ma che non hanno dedicato a un moto di indignazione per quei suicidi niente di più dello spazio di routine che è stato loro concesso dai rispettivi direttori.
Ma oggi quell’urlo è rivolto soprattutto alla coscienza di quei magistrati che hanno perseguito, giudicato e di fatto condannato al licenziamento gli autori di quella recita, contraddicendo, prima ancora che la lettera e lo spirito della legge, il più elementare senso della giustizia: quello che dovrebbe accomunare tutti gli esseri umani. Sia quel senso della giustizia che, almeno per ora, lo spirito e la lettera della legge non impongono certo l’obbligo di parlar bene del padrone, o di non farlo sfigurare quando mette in atto misure talmente gravi da portare al suicidio, e non una sola volta, di un lavoratore .
È a loro, a quei magistrati, alla loro coscienza, che va riferito ora il senso profondo di quella rappresentazione, che è, o dovrebbe essere, il rimorso. Come è possibile non provare rimorso per una sentenza che antepone al rispetto della pari dignità e al diritto alla vita di tutti i lavoratori l’ego tronfio di un padrone e di una gestione aziendale? Di un sistema che include tra i materiali e i fattori del processo produttivo anche la pretesa di essere esentati da una critica che porta in piazza le gravissime conseguenze di quelle discriminazioni?
Si è lasciato volutamente per strada quel briciolo di umanità che dovrebbe impedire di invertire le parti tra una serie di suicidi veri, di lavoratori ridotti alla disperazione, e un suicidio finto, e solo rappresentato con un’effige di stracci e cartone. Di quei suicidi veri si è scritto in sentenza che è impossibile ricondurli alla discriminazione e alla conseguente miseria che li hanno generati. Mentre quel suicidio finto e solo rappresentato è stato invece considerato un irrimediabile intoppo alla produzione o alla possibilità di dargli un adeguato sbocco sul mercato. Perdere quel briciolo di umanità con una inversione delle parti come questa, e non senza un gravissimo stravolgimento dello spirito e della lettera della legge, dà la misura di quanto siamo ormai precipitati, o stiamo precipitando, in un clima di barbarie.
Una barbarie che non è più confinata solo entro i muri della fabbrica, un luogo in cui ai lavoratori non sono mai stati garantiti giustizia e benessere, perché diritto e amministrazione della giustizia se ne sono sempre tenuti lontani per non disturbare l’«ordinario andamento» dei processi produttivi. Ma qui c’è qualcosa di più: c’è una barbarie che si è mossa alla difesa del processo produttivo anche all’esterno della fabbrica, circondandola con un «cordone sanitario», per impedire che anche solo l’eco delle malefatte che si perpetrano al suo interno possa raggiungere le orecchie dei non addetti ai lavori. Con questa sentenza i giudici che l’hanno emessa ci stanno dicendo che la discriminazione all’interno della fabbrica è una componente «naturale» dell’ordine produttivo; che non va denunciata neanche quando porta a conseguenze gravissime come il suicidio; che il suicidio di chi è stato discriminato non è che una «opzione» individuale; e che il richiamo alla coscienza dei responsabili di quelle discriminazioni e di quei suicidi – e di chi dovrebbe farsi carico di quell’urlo di disperazione – è un atto indebito. È un maldestro tentativo di far ricorso a quel senso di umanità che dovrebbe albergare in ciascuno di noi e che invece va spento una volta per sempre, perché il processo produttivo e le prospettive di mercato non subiscano intoppi.
La cattiveria umana, e non il caso, ha fatto sì che proprio in questi giorni venisse messo in chiaro dove portano sentenze secondo cui la vita di un operaio o di una operaia non vale niente, mentre le esigenze della produzione sono tutto. Al grido di «Spianatelo come con un ferro da stiro» un lavoratore che partecipava a un picchetto è stato ucciso da un camion lanciato contro di lui su incitazione di un manager. Aveva cinque figli ed era egiziano. Due ragioni in più per sostenere che non era niente. Infatti sembra che la Procura di Piacenza abbia declassato quel l’omicidio a «incidente stradale».
 ».
».
Il manifesto, 18 settembre 2016 (c.m.c.)
Giovedì l’uccisione a Piacenza di Abdesselem El Danaf all’ingresso della Seam, azienda di logistica dell’indotto Gls. Ieri la morte di un operaio dell’impresa appaltatrice Steel nell’Ilva di Taranto e di un dipendente Atac, azienda dei trasporti romana, folgorato durante una riparazione.
I sindacati metalmeccanici Fim, Fiom e Uil hanno dichiarato un’ora di sciopero nazionale per mercoledì prossimo. «Dall’inizio dell’anno sono 500 i dipendenti morti mentre lavoravano – spiegano i leder sindacali di categoria Marco Bentivogli, Maurizio Landini e Rocco Palombella -. È un dato inaccettabile, che rappresenta una situazione drammatica. Queste morti non sono mai la conseguenza della fatalità ma sempre della mancanza di rispetto delle imprese per le procedure e le regole di sicurezza e, in generale, della inadeguatezza dei sistemi di prevenzione tali da assicurare effettive garanzie per i lavoratori».
Landini, le condizioni in Italia sembrano peggiorare.
Il prossimo 21 settembre abbiamo chiesto alle Rsu non solo di scioperare ma di organizzare assemblee nei siti produttivi per discutere di sicurezza. La precarietà, le catene di appalti e subappalti stanno peggiorando le condizioni di lavoro fino ad arrivare a livelli non più sopportabili. Tutta l’organizzazione ruota intorno a profitti e ricavi, quello che viene considerato un costo è tagliato via. Del resto se si posso comprare i voucher dal tabaccaio come un pacchetto di sigarette allora la prestazione del dipendente è diventata una merce come un’altra. Il 28 settembre si riapre la trattativa sul rinnovo dei contratti per i metalmeccanici, in quella sede chiederemo che la sicurezza sia un punto qualificante della discussione.
La riforma del Testo unico sulla sicurezza sul Lavoro sembra però andare nella direzione della riduzione delle responsabilità penali in capo alle aziende.
Siamo contrari a qualsiasi peggioramento del testo attuale, ci vogliono anzi leggi che assegnino la responsabilità solidale anche all’azienda appaltante, che oggi invece sempre di più scarica le colpe lungo la catena dei subappalti. Del resto nei casi di Piacenza e Taranto ci troviamo di fronte a due aziende dell’indotto. Sempre più spesso ai lavoratori precari non viene fatta la formazione proprio per risparmiare. Ridurre i costi a qualsiasi prezzo non ha prezzo per l’impresa. La sicurezza non è più vista come un obbligo e una prescrizione così stiamo assistendo a un arretramento culturale generalizzato. Il risultato è che aumenta la disoccupazione, aumenta la cassa integrazione ma i morti sul lavoro, invece di diminuire, crescono.
Venerdì la Fiom aveva suonato un campanello d’allarme per la situazione all’Ilva, scrivendo al governo che il problema delle manutenzioni non veniva affrontato.
Avevamo chiesto un incontro urgente ai commissari e al governo, bisogna discutere della sicurezza e della salute dentro e fuori gli impianti di Taranto. Chiediamo un impegno di Cassa depositi e prestiti come garanzia che lo Stato non abbandoni l’Ilva. Gli investimenti necessari non sono sostenibili dal privato o da un gruppo di privati.
A Piacenza Abdesselem El Danaf è stato ucciso perché chiedeva che venissero rispettati i diritti dei suo colleghi precari.
Il settore della logistica è uno di quelli dove l’imbarbarimento è più alto. Non solo i subappalti ma anche le finte cooperative hanno reso le condizioni di lavoro difficilissime. È evidente che non può andare avanti così anche perché tutto questo ha favorito l’ingresso della malavita organizzata. In Italia attualmente ci sono interi pezzi di economia reale in mano alla malavita. Non è un problema che riguarda solo il privato, ma anche il pubblico. Pensiamo ad esempio alla sanità dove da anni si utilizzano i bandi al massimo ribasso, dove poi si inseriscono anche aziende legate ai clan. Dove si ritrovano lavoratori che fanno lo stesso mestiere ma con paghe, condizioni e diritti differenti.
Come si cambiano le cose?
Bisogna corregge le leggi sbagliate che sono state fatte in materia in questi anni. Il 29 settembre terminerà la raccolta firme della legge di iniziativa popolare della Cgil per la Carta dei diritti universali del lavoro, un nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori che rovescia l’idea che sia l’impresa, il soggetto più forte, a determinare le condizioni di chi lavora. E poi abbiamo promosso tre referendum contro la logica che c’è dietro al Jobs Act. Avranno come oggetto l’eliminazione dei voucher che, così come sono, destrutturano il lavoro; gli appalti, con la responsabilità sociale che resta anche in chi dà il lavoro in appalto; i licenziamenti, per correggere le storture introdotte dalla riforma Fornero e dal Jobs Act. Bisogna prevedere il reintegro dei lavoratori a partire dalle aziende che hanno cinque dipendenti.
«Ma è davvero giusto che il dibattito su temi di civiltà e libertà così essenziali si apra solo grazie alla disperata volontà di tormentati protagonisti, che affrontano la violenza ideologica dei pareri contrari?».
La Repubblica, 18 settembre 2016 (m.p.r.)
L’idea di effettuare l’eutanasia su un minore provoca un rifiuto immediato, anzi un senso di ribellione e poi di condanna per chiunque abbia osato anticipare la morte di un bambino. Anche se a chiederlo sono genitori desiderosi di porre fine all’agonia di un figlio, inutilmente prolungata da terapie dolorose e invasive. È una reazione più che comprensibile in un Paese in cui non c’è un quadro legale per le questioni di fine vita e l’eutanasia, anche se richiesta o addirittura implorata da un malato terminale cosciente e adulto, è un crimine.
Tuttavia nei Paesi che hanno sviluppato una cultura civile e giuridica sui temi del rifiuto dell’eccesso di cure (il cosiddetto accanimento terapeutico) e del rispetto della volontà di dire basta a una vita resa insopportabile da una malattia incurabile, l’atto di porre fine anticipatamente alla vita di un bambino straziata dal dolore, è invece oggetto di dibattito approfondito e di riflessione politica. Il Belgio, dove è stato riportato il caso di eutanasia su minore, è, insieme all’Olanda, uno dei Paesi più avanzati in questo senso, essendo riuscito a controllare le eutanasie clandestine con una legge che disciplina le problematiche di fine vita in modo scientifico, rigoroso e completo.
I casi dei minori sono molto complessi non solo per l’evidente carico emotivo, ma soprattutto perché viene a mancare il principio su cui l’eutanasia si basa, che è la volontà del paziente, a sua volta fondata sul diritto di autodeterminazione individuale. Ovvio che un bambino non può esprimere una volontà cosciente, e dunque la decisione spetta ai genitori, che in genere sono riluttanti a prendere qualsiasi posizione, combattuti come sono tra lo strazio di vedere un bambino soffrire e lo strazio di perderlo per sempre. Anche in queste situazioni drammatiche una buona legge è di grande aiuto, perché sia i genitori che i medici sanno che la società e le istituzioni tutelano le loro decisioni e, ove possibile, le sostengono, creando commissioni di esperti ad hoc e fornendo ogni tipo di assistenza e di consulenza. In Italia i genitori che si trovano in una situazione analoga sono completamente soli nella loro disperazione.
Molti ricorderanno il caso di Davide, il bimbo con la sindrome di Potter, nato cioè senza reni e uretere. I genitori volevano che il neonato vivesse il più a lungo possibile, ma senza arrivare a torturarlo. Quando i medici hanno chiesto l’autorizzazione alla dialisi, pur confermando che per la vita di Davide non c’era nulla da fare, la mamma Maria Rita ha chiesto un giorno per riflettere. Allora i sanitari si sono immediatamente rivolti alla magistratura, che d’ufficio ha tolto ai genitori la patria potestà, aggiungendo l’umiliazione al dolore immenso per Davide. Risultato: Davide ha vissuto 80 giorni alimentato con un sondino alternato al biberon, con dialisi di sette ore quasi ogni giorno e respirazione assistita per le crisi che lo assalivano regolarmente. In più ha subìto interventi invasivi come l’applicazione di un catetere all’ombelico, uno alla giugulare, che il piccolo si è strappato con le sue stesse manine, e anche uno all’inguine.
Dopo questo inutile calvario Davide è morto, mentre intorno al suo corpicino martoriato infuriavano le polemiche sui genitori annichiliti, umiliati e accusati di volerlo assassinare in nome del mito del “bimbo perfetto”. Oggi Maria Rita fa campagne di sensibilizzazione, insieme a Mina Welby, Beppe Englaro e gli altri parenti di vittime dei pregiudizi sociali, oltre che di terribili malattie, che scendono in piazza per evitare che la loro tragedia accada ad altri. Ma è davvero giusto che il dibattito su temi di civiltà e libertà così essenziali si apra solo grazie alla disperata volontà di tormentati protagonisti, che affrontano la violenza ideologica dei pareri contrari? Io credo di no. Ripeto: la libertà di cura (e dunque anche di rifiutare la cura) è un diritto sancito dalla nostra Costituzione. E se c’è un diritto una legge dovrebbe tutelarlo.
«Siamo in una situazione critica», ha confermato la cancelliera Merkel. «Il rischio di sfaldamento dell’Europa non è mai stato così grande. Parlo proprio della separazione, del ritorno alle frontiere, del rifiuto della solidarietà, della fine dell’euro».
La Repubblica, 17 settembre 2016 (m.p.r.)
Un padre troppo rigido che vuole solo risparmiare. Una madre troppo frivola che pensa solo a spendere. Dei figli ingrati e ribelli che non aiutano in casa e pensano solo alla paghetta. Ora che la vecchia zia inglese, ricca ma rompiscatole, ha annunciato che se ne va, salvatela voi una famiglia così. Poiché l’Unione europea non si è ancora dotata di un consultorio familiare, i leader dei Ventisette si sono trovati ieri a Bratislava per cercare di risolvere «la crisi esistenziale» dell’Europa innescata dalla Brexit. Ma, proprio come succede a certe famiglie disfunzionali, non hanno trovato soluzione migliore che ignorare i troppi motivi di contrasto per concentrarsi sui pochissimi punti di possibile consenso. Non c’è da stupirsi che Renzi, ieri, abbia usato toni così duri nella conferenza stampa finale, prendendo le distanze da Berlino e Parigi e sottolineando senza perifrasi la sua insoddisfazione.
Tra i potenziali terreni di intesa c’è il rafforzamento di una vera Difesa europea, sulla base di un documento messo a punto dall’Alta rappresentante Federica Mogherini e ripreso da una lettera congiunta di Merkel e Hollande. Potrebbe essere un passo avanti molto importante sulla via dell’integrazione. Ma certo da solo non basta per tenere insieme una famiglia che appare sempre più divisa. E se la compagine non ritrova le ragioni della propria convivenza, anche la Difesa comune, in prospettiva, va a farsi benedire.
Uno dei pochi segnali veramente incoraggianti che è arrivato dal vertice informale di ieri, il primo senza la partecipazione degli inglesi, è nel linguaggio usato dai capi di governo. Per una volta, i leader europei hanno smesso di fare finta di nulla, hanno riconosciuto la profondità dei fossati che li separano e hanno ammesso esplicitamente la gravità del momento. «Siamo in una situazione critica», ha confermato la cancelliera Merkel. «Il rischio di sfaldamento dell’Europa non è mai stato così grande. Parlo proprio della separazione, del ritorno alle frontiere, del rifiuto della solidarietà, della fine dell’euro», ha detto Hollande che, forse perché è il più debole, appare anche il più sincero.
Alla fine, Merkel e Hollande hanno scelto di tenere una conferenza stampa congiunta. Anche questo, nonostante l’irritazione di Renzi, è un buon segnale, perché mostra che l’asse franco tedesco, nonostante tutto, continua a resistere. Se Francia e Germania reggeranno l’urto dell’ondata populista alle elezioni dell’anno prossimo, e non è detto che accada, c’è speranza che il nocciolo duro dell’Europa possa continuare a garantire l’Unione.
Dietro i troppi silenzi del vertice di Bratislava, proprio questa è infatti la partita che si sta delineando sul dopo Brexit. Una partita che avrà tempi necessariamente molto più lunghi della scadenza di marzo che si sono dati i capi di governo. L’uscita della Gran Bretagna dalla Ue, tema che ieri è stato sfiorato solo di sfuggita, dimostra infatti che l’idea di una Europa troppo elastica, capace di allargarsi all’infinito diluendo le ragioni di fondo del proprio esistere, non è in grado di reggere alle tensioni politiche che genera. Oggi la Ue non può permettersi nuove secessioni. Ma in prospettiva la soluzione di un nucleo centrale più ristretto, attorno al quale possano trovare una collocazione i Paesi che non vogliono più condividere la loro sovranità politica, come appunto gli inglesi e la galassia dell’Europa centro-orientale, appare come l’unica strada possibile a chi non vuole perdere quanto finora è stato costruito.
Sono stati proprio i Paesi del “gruppo di Visegrad”, Polonia, Slovacchia, Cechia, Ungheria, a porre ieri con più forza la necessità di ridefinire gli equilibri tra sovranità nazionali e sovranità europea. È una questione vitale, ma che la Vecchia Europa non può affrontare adesso per due motivi. Il primo è che deve innanzitutto sopravvivere alla sfida dei populisti, che dominerà nel prossimo anno le elezioni olandesi, francesi e tedesche. Il secondo è che in questa fase il patto fiduciario, indispensabile per ricompattare il nocciolo duro, è reso impossibile dalle crescenti divergenze sulla strategia economica da seguire. Il danno che deriva dall’incomprensione tra “falchi” e “colombe” sull’austerità va ben al di là dell’ambito contabile in cui si è formato. È diventato unvulnus politico, un deficit generale di fiducia che rende impossibile continuare sulla strada dell’integrazione, come dimostrano i toni irritati usati ieri dal presidente del Consiglio Renzi.
Come nelle vere famiglie, occorre che il padre avaro e la madre spendacciona ritrovino le ragioni del vincolo di fiducia e di solidarietà che li unisce. Solo a quel punto, se ci arriveranno, potranno confrontarsi con i figli. E costringerli a scegliere se restare in famiglia accettandone le regole e la coesione, oppure uscirne e decidere quale strada imboccare per il loro futuro. Ma, a Bratislava, questo momento della verità appare ancora lontano nel tempo.
«Dove sta l’errore strategico che ha condotto il comunismo allo scacco dopo il crollo dell'Urss?» Una riflessione a due voci tra due autorevoli esponenti del versante politico e del versante sociale del mondo operaio del secolo scorso, che fornisce utili materiali al dibattito della sinistra oggi. il manifesto, 16 settembre 2016
«Ma dove sta, alla fine, il nodo irrisolto, il punto cruciale che ha portato non solo al crollo dell’Urss e del suo impero, ma più largamente a una sconfitta del movimento operaio mondiale nel chiudersi di questo secolo: insomma dove sta l’errore strategico che ha condotto il comunismo allo scacco? Sta nella linea della dittatura militare imboccata subito e fatalmente dai bolscevichi nel 1917? Oppure ha la sua fonte nello stesso marxismo e socialismo europeo, prima ancora di Lenin, facendo salva (ma non proprio tanto) la barba augusta di Karl Marx?».
Sono domande che si rivolge Pietro Ingrao nel quindicesimo (e penultimo) capitolo, «Liberazione e statalismo», di un volume inedito concluso nel luglio del 1998. Il libro, con il titolo «Promemoria», è in corso di stampa presso la casa editrice Ediesse nella collana Carte Pietro Ingrao.
Gli interrogativi che si pone Ingrao costituiscono il costante riferimento problematico che dà senso, ed orienta, le riflessioni sulle vicende e le scelte del Pci e della sinistra italiana negli anni della Repubblica, fino all’assassinio di Aldo Moro.
Ma, in questo capitolo finale, quelle domande e la tematica relativa alla ‘liberazione’ (così presente nell’impegno politico di Ingrao) sono mosse dalle argomentazioni che Bruno Trentin svolge ne «La città del lavoro», pubblicato da Feltrinelli nell’autunno del 1997: «La tesi centrale del libro, scrive Ingrao, è che, nella sinistra europea, già a partire dalla sua culla tedesca, c’è stata una lettura ‘statalista’ del processo di liberazione della classe operaia».
Una scelta che secondo Trentin, riassume Ingrao, «opacizza le nuove, radicali forme di alienazione del lavoro subordinato e che, alla fine, affida la fuoruscita dall’oppressione capitalistica e la transizione verso una società socialista alla conquista dello Stato. È così elusa e alla fine cancellata – sostiene Trentin – la questione essenziale della liberazione del lavoro subordinato, espropriato della sua creatività nel luogo della produzione, e quindi ferito nella sua identità umana, schiacciata dall’universo macchinale».
Ne «La città del lavoro» Trentin illustra bene la dinamica di quella che considera una fatale deriva. La sinistra ha spostato la ‘rivoluzione’ sociale dal cuore della ‘società civile’, ovvero dal conflitto nel luogo di produzione, alla conquista dello Stato.
Trentin, pertanto, contrappone nettamente la ‘società civile’ all’ambito e alla azione del potere politico statale. Ingrao ritiene che non corrisponda ai fatti descrivere, come fa Trentin, una ‘società civile’ che si possa affermare «a sé», distinta da «un potere pubblico che ha il volto (e la complessità articolata) che la sfera dello Stato è venuta via via assumendo nella modernità».
Il nesso tra ‘pubblico’ e ‘privato’ è destinato a dilatarsi. Così Ingrao ritiene necessaria, da parte degli attori sociali, «più politica, ma anche più connessioni fra iniziativa nell’intimo della produzione (per usare l’antico termine gramsciano) e un’immaginazione nuova (oggi quasi inesistente) di istituzioni».
Trentin vede nella ‘creatività’ del lavoro la fonte viva di una liberazione piena della ‘individualità’. Ingrao replica che il «tragico» Novecento ha svelato «una complicazione della soggettività umana».
Allora l’«individualità», «rimanda a un universo assai complesso e multiforme, radicalmente ambiguo ed oscillante: mescolare di più le sfere della vita e del produrre, se vogliamo fare i conti con queste complicazioni e oscurità e se non vogliamo che il nodo del lavoro resti drammaticamente isolato e frantumato, e alla fine perdente».

«La Repubblica, 17 settembre 2016
Comunemente si ritiene che fede e dubbio siano opposti, nel senso che chi ha fede non avrebbe dubbi e chi ha dubbi non avrebbe fede. Ma non è per nulla così. L’opposto del dubbio non è la fede, è il sapere: chi infatti sa con certezza come stanno le cose non ha dubbi, e neppure, ovviamente, ha bisogno di avere fede. Così per esempio affermava Carl Gustav Jung a proposito dell’oggetto per eccellenza su cui si ha o no fede: «Io non credo all’esistenza di Dio per fede: io so che Dio esiste» (da Jung parla, Adelphi, 1995). Chi invece non è giunto a un tale sapere dubita su come stiano effettivamente le cose, non solo su Dio ma anche sulle altre questioni decisive: avrà un senso questa vita, e se sì quale? La natura persegue un effettivo incremento della sua organizzazione? Quando diciamo “anima” nominiamo un fenomeno reale o solo un arcaico concetto metafisico? Il bene, la giustizia, la bellezza, esistono come qualcosa di oggettivo o sono solo provvisorie convenzioni? E dopo la morte, il viaggio continua o finisce per sempre?
Dato che i più su tali questioni non hanno un sapere certo, generalmente si risponde “sì” all’insegna della fede oppure “no” all’insegna dello scetticismo, in entrambi i casi privi di sapere, al massimo con qualche indizio interpretato in un modo o nell’altro a seconda del previo orientamento assunto. Così, sia coloro che hanno fede in Dio sia coloro che non ce l’hanno, fondano il loro pensiero sul dubbio, cioè sull’impossibilità di conseguire un sapere incontrovertibile sul senso ultimo del mondo e della nostra esistenza. La fede, in altri termini, positiva o negativa che sia, per esistere ha bisogno del dubbio.
La tradizionale dottrina cattolica però non la pensa così. Per essa la fede non si fonda sul dubbio ma sul sapere che scaturisce da una precisa rivelazione divina mediante cui Dio ha comunicato se stesso e una serie di ulteriori verità dette “articoli di fede”. Tale rivelazione costituisce il depositum fidei, cioè il patrimonio dottrinale custodito e trasmesso dalla Chiesa. Esso conferisce un sapere denominato dottrina che illumina quanti lo ricevono su origine, identità, destino e morale da seguire. Non solo; a partire da tale dottrina si configura anche una precisa visione del mondo: l’impresa speculativa delle Summae theologiae medievali, di cui la più nota è quella di Tommaso d’Aquino, vive di questa ambizione di possedere un sapere certo su fisica, metafisica ed etica, di essere quindi generatrice di filosofia.
Tale impostazione regnò per tutto il medioevo ma venne combattuta dalla filosofia moderna e dalla rivoluzione scientifica. Il fine non era negare la fede in Dio bensì il sapere filosofico e scientifico che si riteneva discendesse da essa, per collocare la fede su un fondamento diverso, senza più la presunzione che fosse oggettivo: Kant per esempio scrive di aver dovuto «sospendere il sapere per far posto alla fede» (Critica della ragion pura, Prefazione alla seconda edizione, 1787), mentre più di un secolo e mezzo prima Galileo aveva dichiarato che «l’intenzione dello Spirito Santo è d’insegnarci come si vada al cielo, e non come vada il cielo » (Lettera a Cristina di Lorena del 1615). Non furono per nulla atei i più grandi protagonisti della modernità, tra cui filosofi come Bruno, Cartesio, Spinoza, Lessing, Voltaire, Rousseau, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, o scienziati come Copernico, Galileo, Keplero, Newton. Il loro obiettivo era piuttosto di ricollocare la religiosità sul suo autentico fondamento: non più un presunto sapere oggettivo, ma la soggettiva esperienza spirituale.
A tale modello di fede non interessa il sapere, e quindi il potere che ne discende, ma piuttosto il sentire, e quindi l’esperienza personale. Non è più l’obbedienza a una dottrina dogmatica indiscutibile a rappresentare la sorgente della fede, ma è il sentimento di simpatia verso la vita e i viventi. In questa prospettiva, ben prima di creden- za, fede significa fiducia. Quando diciamo che una persona è “degna di fede”, cosa vogliamo dire? Quando alla fine delle nostre lettere scriviamo “in fede”, cosa vogliamo dire? Quando un uomo mette l’anello nuziale alla sua donna e quando una donna fa lo stesso con il suo uomo, cosa vogliono dirsi? C’è una dimensione di fiducia che è costitutiva delle relazioni umane e che sola spiega quei veri e propri patti d’onore che sono l’amicizia e l’amore. Se non ci fosse, sorgerebbero solo rapporti interessati e calcolati: nulla di male, anzi tutto normale, ma anche tutto ordinario e prevedibile. Solo se c’è fiducia-fede nell’altra persona può sorgere una relazione all’insegna della gratuità, creatività, straordinarietà, e può innescarsi quella condizione che chiamiamo umanità.
E la fede in Dio? Quando si ha fiducia-affidamento nella vita nel suo insieme, percepita come dotata di senso e di scopo, si compie il senso della fede in Dio (a prescindere da come poi le singole tradizioni religiose concepiscano il divino). Nessuno veramente sa cosa nomina quando dice Dio, ma credere nell’esistenza di una realtà più originaria, da cui il mondo proviene e verso cui va, significa sentire che la vita ha una direzione, un senso di marcia, un traguardo. Credere in Dio significa quindi dire sì alla vita e alla sua ragionevolezza: significa credere che la vita proviene dal bene e procede verso il bene, e che per questo agire bene è la modalità migliore di vivere.
Ma questa convinzione è razionalmente fondabile? No. Basta considerare la vita in tutti i suoi aspetti per scorgere di frequente l’ombra della negazione, con la conseguenza che la mente è inevitabilmente consegnata al dubbio. In tutte le lingue di origine latina, come anche in greco e in tedesco, il termine dubbio ha come radice “due”. Dubbio quindi è essere al bivio, altro termine che rimanda al due: è vedere due sentieri senza sapere quale scegliere, consapevoli però che non ci si può fermare né tornare indietro, ma che si è posti di fronte al dilemma della scelta.
Ha affermato il cardinale Carlo Maria Martini: «Io ritengo che ciascuno di noi abbia in sé un non credente e un credente, che si parlano dentro, che si interrogano a vicenda, che rimandano continuamente domande pungenti e inquietanti l’un l’altro. Il non credente che è in me inquieta il credente che è in me e viceversa» (dal discorso introduttivo alla Cattedra dei non credenti). Ragionando si trovano elementi a favore della tesi e dell’antitesi, e chi non è ideologicamente determinato è inevitabilmente consegnato alla logica del due che genera il dubbio. Il dubbio però paralizza, mentre nella vita occorre procedere e agire responsabilmente. Da qui la necessità di superare il dubbio. Il superamento però non può avvenire in base alla ragione che è all’origine del dubbio, ma in base a qualcosa di più radicale e di più vitale della ragione, cioè il sentimento che genera la fiducia che si esplicita come coraggio di esistere e di scegliere il bene e la giustizia. Ma perché alcuni avvertano in sé questo sentimento di fiducia verso la vita e altri no, rimane per me un mistero inesplicabile.
 «La distanza tra le due verità è enorme. Così enorme che non si riesce a farla rientrare nel fisiologico arco dei diversi punti di vista di chi racconta un fatto».
«La distanza tra le due verità è enorme. Così enorme che non si riesce a farla rientrare nel fisiologico arco dei diversi punti di vista di chi racconta un fatto».
La Repubblica, 17 settembre 2017 (m.p.r.)
,Abdel Salam El Danaf, operaio egiziano di 53 anni, padre di cinque figli, è morto schiacciato da un camion nel piazzale di carico e scarico dell’azienda Gls, Piacenza, settore logistica. I suoi colleghi di lavoro dicono che era in corso una manifestazione sindacale e che il camionista è stato esortato da imprecisati “dirigenti dell’azienda” a forzare il picchetto. La magistratura inquirente sostiene che non c’era nessun picchetto e si è trattato di un omicidio stradale come ce ne sono tanti.
La distanza tra le due verità è enorme. Così enorme che non si riesce a farla rientrare nel fisiologico arco dei diversi punti di vista di chi racconta un fatto. Così enorme che è inevitabile pensare alla distanza crescente tra la voce operaia - che sta tornando a essere di debolezza ottocentesca, quasi presindacale - e un palcoscenico sociale che sembra averla relegata dietro le quinte: come un rumore di fondo. È esattamente nel nome di questa debolezza, politica e mediatica, che è indispensabile parlare di Abdel. E di pretendere che gli attori sociali toccati dalla vicenda - la Procura di Piacenza, il governo e in specie il Ministero del Lavoro, l’azienda presso la quale Abdel lavorava e davanti alla quale Abdel è morto, i media - cerchino di ricomporre i brandelli di verità disponibili, con la stessa pietà e lo stesso rispetto con il quale si ricompone il corpo di una vittima.
Il manifesto, 15 settembre 2016
Il trionfalismo dell’establishment non riesce a nascondere la realtà: la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, come hanno spiegato domenica scorsa su queste pagine Pagliassotti e Vittone, è ancora di là da venire. Intanto, dopo ventisette anni, i No Tav, gli «indiani di Valle» non demordono e anzi rilanciano, contrapponendo all’alta velocità l’alta felicità (per riprendere il titolo della grande festa di Venaus del luglio scorso che ha visto la partecipazione di decine di migliaia di persone e di artisti di prim’ordine). A sostegno dell’opera resta una repressione crescente e sempre più scoperta. Non bastavano l’evocazione di una valle di black bloc, i 1.500 indagati negli ultimi sei anni e mezzo (con una punta di 327 nel 2011 e di 183 dal luglio 2015 al giugno 2016: più di un indagato ogni due giorni), un centinaio di misure cautelari, una gamma di reati che vanno dalle violazioni della zona rossa a fantasiosi attentati con finalità di terrorismo (dichiarati infine insussistenti, dopo lunghe carcerazioni in isolamento, dai giudici di merito e dalla Cassazione). Non bastavano e, puntuali, sono arrivati nuovi dispositivi repressivi. Un caso per tutti, tra i molti quest’estate.
Chiunque è stato in Valsusa sulle tracce del movimento No Tav conosce l’osteria «La Credenza» di Bussoleno (luogo di incontro e di confronto di persone provenienti da ogni dove) e la sua animatrice, Nicoletta Dosio, per tutti semplicemente Nicoletta, già professoressa nel locale liceo, esponente politica della sinistra non omologata, personaggio di primo piano nell’opposizione al Tav. Ebbene, con ordinanza 26 maggio 2016 del gip di Torino, a Nicoletta è stata imposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana all’autorità di polizia per fatti commessi un anno prima di fronte al cantiere di Chiomonte, integranti, nell’ipotesi accusatoria, il delitto di resistenza e violenza a pubblico ufficiale (consistente nel lancio di oggetti contundenti e di artifici pirotecnici). Nicoletta non ha lanciato pietre o alcunché ed era, come sempre, a viso scoperto. Ciò che le viene contestato è altro: aver «contribuito a consegnare una fune munita di arpione ad altra persona che, arrampicata sulla griglia di un betafence, agganciato l’arpione alla griglia, ne determinava il successivo abbattimento». La battitura e l’abbattimento delle reti e delle strutture connesse è, come tutti sanno, uno degli obiettivi di sempre del movimento per dimostrare che il cantiere può essere violato e che la determinazione della valle è più forte della militarizzazione.
Ma per pubblici ministeri e giudici della cautela tutto ciò scompare e quella condotta non ha finalità dirette ma è strumentale «a disturbare le forze di polizia ed a consentire ad altri di compiere i lanci di pietre e ordigni direttamente sulle forze dell’ordine senza necessità che il lancio dovesse, con una parabola, superare il betafence». Di più, «l’avvicinarsi non travisati, impugnanti palloncini rosa, striscioni e bandiere», lungi dall’essere una modalità di protesta responsabile e civile è un subdolo inganno «per far credere alle forze dell’ordine che l’intenzione fosse di manifestare pacificamente con grida e al più compiere la c.d. battitura delle reti».
Così il cerchio si chiude e Nicoletta diventa concorrente nel reato di resistenza perché, contribuendo ad abbattere il betafence, ha fatto sì che altri potessero lanciare degli oggetti contro la polizia con una traiettoria rettilinea anziché con la parabola necessaria a superare un ostacolo dell’altezza di poco più di due metri. Non è la prima imputazione singolare elevata dalla procura torinese ma prudenza avrebbe almeno voluto che la verifica di una costruzione fattuale e giuridica tanto opinabile venisse sottoposta al giudice del dibattimento con l’imputata (reperibilissima e prossima ai 70 anni) in stato di libertà. E invece no: il pubblico ministero chiede addirittura l’obbligo di dimora e il gip dispone la presentazione quotidiana all’autorità di polizia!
Ma le torsioni della legge della Valsusa non finiscono qui. I valsusini, come noto, vivono la militarizzazione del territorio e la valanga di processi e misure cautelari come una vessazione e da tempo hanno deciso di non subirla passivamente. Di conseguenza Nicoletta rifiuta, e lo dichiara pubblicamente, di collaborare all’esecuzione della misura («Che sia chiaro, io non accetterò di andare tutti i giorni a chiedere scusa ai carabinieri, non accetterò che la mia casa diventi la mia prigione. Io a firmare non ci vado e nemmeno starò chiusa in casa ad aspettare che vengano a controllare se ci sono o non ci sono!»). Dopo qualche settimana, in considerazione «della personalità dell’imputata estremamente negativa, intollerante delle regole e totalmente priva del minimo spirito collaborativo», la misura cautelare viene trasformata in obbligo di dimora, aprendo la strada a ulteriori possibili aggravamenti fino alla custodia in carcere. Il copione è scolastico (e destinato a estendersi ad altri esponenti No Tav). Tutti dicono che Nicoletta può manifestare liberamente la sua opposizione alla grande opera ma, poi, le modalità – per quanto la riguarda – pacifiche di tale protesta vengono parificate ad azioni violente. Nessuno penserebbe di applicarle in prima battuta la custodia in carcere (non foss’altro per la scarsa rilevanza della condotta e per l’età) ma a tale esito si può arrivare per la sua mancata “collaborazione”: secondo lo schema del diritto penale del nemico quel che rileva non sono le esigenze cautelari ma la mancata collaborazione dell’imputata, la sua alterità al sistema.
Così si compie lo snaturamento delle misure cautelari non detentive. Introdotte per limitare la custodia carceraria ai casi di assoluta necessità, esse vengono applicate a imputati che, in loro assenza, sarebbero non in carcere ma in libertà e si convertono così da alternativa al carcere in sua anticamera.
Parallelamente, in particolare con l’applicazione di obblighi tanto gravosi quanto immotivati, si realizza, in sintonia con le prassi dei regimi autoritari, la trasformazione dei provvedimenti cautelari in misure di sicurezza, la cui unica finalità è la neutralizzazione del “nemico”: a sorreggerle non c’è alcuna esigenza cautelare in senso proprio (mancando ogni pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) ma solo la previsione che gli indagati possano commettere (non delitti di particolare allarme sociale ma) ulteriori reati della stessa specie, cioè partecipare ad altre manifestazione di protesta…
La posta in gioco, anche in termini generali, è elevata e ben chiara ai valsusini, che hanno lanciato la campagna «mettiamoci la faccia» facendosi fotografare a centinaia con il manifesto: «Io sto con chi resiste violando le imposizioni ingiuste del tribunale di Torino».
Quando un segno di vita della cultura garantista e dei magistrati democratici?
 Se il genere umano vuole progredire e non spegnersi non basta far funzionare meglio le macchinette che hanno fatto diventar ricchi e ricchissimi i pochi e poveri e poverissimi i molti. «Una riflessione su scuola discipline umanistiche e formazione dei cittadini. Estratto del libro
Se il genere umano vuole progredire e non spegnersi non basta far funzionare meglio le macchinette che hanno fatto diventar ricchi e ricchissimi i pochi e poveri e poverissimi i molti. «Una riflessione su scuola discipline umanistiche e formazione dei cittadini. Estratto del libro
Il presente non basta (Mondadori). La Repubblica, 15 settembre 2016
La parola «scuola» evoca una stagione della nostra vita, un titolo di studio, la Cenerentola dei nostri Ministeri, il ricordo di un ottimo insegnante, l’origine dei nostri fallimenti o successi. Non si ricorderà mai abbastanza che «scuola» deriva da «scholé», parola greca che indica il tempo che il cittadino riservava alla propria formazione, quella che i Greci chiamavano «paideía» e che volevano non specialistica e monoculturale, bensì completa e integrale: «enkýklios», «circolare». Secondo questa prospettiva originaria, la scuola è il contrappeso di certa modernità polarizzata sul «presente», sull’«adesso», sull’«ora» (modo, da cui appunto derivano sia «moderno» che «moda»). Essa è il luogo dove si formano i cittadini completi e non semplicemente — direbbe Nietzsche — «utili impiegati ». In un Paese civile e colto, centrale è la figura dell’insegnante, del docente, del maestro ( magister), vale a dire «colui che sa di più e vale di più» ( magis) e che si mette in relazione con gli altri (- ter); in opposizione a minister, «colui che sa e vale meno». Sono termini del linguaggio religioso: magister era il celebrante principale, minister era il celebrante in seconda, l’assistente, il servitore. Segno dei tempi: noi oggi abbiamo sostituito al rispetto per i Maestri l’ossequio per i Ministri.
Alternativa ciclicamente ricorrente è quella che si chiede se la scuola deve avere lo sguardo rivolto al passato o al futuro, privilegiare la conoscenza o la competenza, mirare alla formazione o alla professione. A chi sostiene che la scienza è destinata a scalzare inesorabilmente le humanities e che i problemi del mondo si risolvono unicamente in termini ingegneristici e orientati al futuro, si dovrà rispondere che, se la scienza e le tecnologie hanno l’onere della risposta ai problemi del momento, il sapere umanistico ha l’onere della domanda; e pertanto tra scienza e humanities ha da essere un’alleanza naturale e necessaria, perché i linguaggi sono molteplici ma la cultura è una. Steve Jobs ci ha ricordato la necessità del ritorno alla figura dell’ingegnere rinascimentale.
Ma cosa rispondere a chi – pur consapevole che la scuola, intesa come scholé, ha il compito di insegnare ciò che non si apprende né dalla famiglia né dalla società né dalle istituzioni – deve fare i conti con la realtà aggressiva e incontrovertibile di un mondo extrascolastico parallelo, di un’altra educazione, di un altro apprendimento? Di fronte a questo nuovo scenario giova continuare a credere che la scuola è l’unico luogo di incontro reale rispetto al mondo immateriale dei nuovi media? Che siamo in presenza di puri strumenti, mentre i valori sono altri? O piuttosto sarà bene riconoscere che con la realtà «fisica» convive la realtà «digitale» e che le tecnologie e i social network creano un nuovo «ambiente», il che significa nuovi pensieri, nuove relazioni, nuovi stili che entrano nella vita di tutti i giorni?
Indubbiamente questa nuova cultura e formazione ha rischi seri: su tutti, quello che Eliot chiamava «il provincialismo di tempo », proprio di chi crede che la vita e il mondo inizino con noi e col nostro presente; e quello che Byung-Chul Han chiama «l’inferno dell’Uguale»: un mondo senza il pathos della distanza e l’esperienza dell’alterità. Cosa sa del presente chi conosce solo il presente? Cosa sa di tecnologia chi conosce soltanto la tecnologia? Cosa sa dell’altro chi con un clic ne vede la faccia ma non il volto?
Solo la scuola può - e, io aggiungo, deve - comporre tale querelle, coniugare il momento «noto» dell’insegnamento dell’aula (docere) con quello «nuovo» dell’apprendimento della rete (discere), tradurre ( trans-ducere) la comunicazione in comunione e fare dei tanti «io» il «noi», che dovrà essere il pronome del terzo millennio. Compito della scuola è insegnare che le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha fatto con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere che la macchina non può sostituire l’insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali ma diversi perché il libro racconta, il tablet rendiconta. Una sfida tanto auspicabile quanto utile sarebbe la compresenza del professore di «latino» - e in generale dei professori delle discipline umanistiche - e del professore di «digitale», ora infelicemente denominato dalla burocrazia ministeriale «animatore digitale», come se si trattasse di un ruolo ludico e ricreativo. Da tale confronto i ragazzi capirebbero sia la differenza tra il tempo e lo spazio sia la necessità della coabitazione tra l’hic et nunc («qui e ora») e l’ubique et semper («ovunque e sempre»).
Non ho mai capito la rovinosa alternativa per cui l’inglese o l’informatica debbano sostituire, e non piuttosto integrare, altre discipline come il greco e il latino. Errore ben rappresentato da quanto proponeva l’ex ministro Luigi Berlinguer: «Rendere opzionale il latino, dando così spazio alla necessaria accentuazione scientifica». Ma io dico: cosa di più arricchente e convincente di un liceo classico dove il ventaglio dei saperi umanistici si dispieghi e si coniughi con quelli scientifici? Aumentare e accrescere, non diminuire e sottrarre; et et e non aut aut deve essere la misura della scuola. Questo è possibile con provvedimenti seri e investimenti veri: dilatando gli orari scolastici, abolendo i compiti a casa, pagando adeguatamente gli insegnanti. L’unica riforma degna della scuola: crocevia del futuro.
Il nostro Paese, fino a non molti anni or sono, ha conosciuto – e riconosciuto anche economicamente – l’importanza e la nobiltà della figura dell’insegnante, del docente, del professore: colui che «professa» (dal latino profiteri) la ricerca, il fondamento e la trasmissione del sapere e dei saperi. Figura cardine di un Paese civile che abbia il futuro nel sangue: da riscoprire e riabilitare, perché oggi maldestramente delegittimata da politici e famiglie e sciaguratamente derubricata a dimensioni amministrative e mansioni burocratiche. Peggio: ridotta al ruolo di «facilitatore», una sorta di «super-capoclasse»; e così si fa un torto triplice: agli insegnanti, che sanno che per alcuni traguardi culturali occorre munirsi – avrebbe detto Mandel’stam – di «scarponi chiodati»; agli studenti, che chiedono testimonianze di coerenza e verità; e alla scuola, che non è e non deve essere il luogo dove si attenuano o si occultano le difficoltà; dove, per una malintesa idea di democrazia o egualitarismo, si rendono deboli i saperi anziché forti gli allievi.
L’autore, latinista, è stato rettore dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

«Il manifesto, 14 settembre 2016
L’insistenza di Confindustria e governo sulla «produttività del lavoro» potrebbe far sperare in un loro ritorno ai Classici dell’economia politica: se non a Karl Marx, almeno ad Adam Smith: «Il lavoro svolto in un anno è il fondo da cui ogni nazione trae in ultima analisi tutte le cose necessarie e comode della vita che in un anno consuma».
Un concetto che si ritrova nel primo articolo della Costituzione: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Si potrebbe anche sperare che così si voglia riconoscere al lavoro di essere l’unico «fattore produttivo» capace di produrre un sovrappiù.
Temo, tuttavia, che non sia così. Lo slogan del Presidente della Confindustria, il suo «grido di guerra» ampiamente ripreso, è «Vogliamo una più alta produttività per pagare salari più alti»: una esortazione a che, prima di tutto, i lavoratori si mettano a lavorare di più.
Il vero slogan dovrebbe invece essere: «Pagheremo salari più alti perché vogliamo una più alta produttività».
Dalla crisi del ‘29 Italia e Germania uscirono con il fascismo e il nazismo; gli Stati Uniti proprio con una politica di alti salari, con il «Fordismo» di Henry Ford e di Franklin Delano Roosvelt, cui Gramsci dedicò grande attenzione. Come lo stesso Gramsci aveva previsto, la lunga stagione del Fordismo non poteva durare in eterno, e così fu; né il Fordismo può essere preso oggi a modello per tentare di uscire dalla lunga serie di crisi che alla sua fine seguì, dai primi anni Ottanta del secolo scorso. Tanto meno in Italia, dove non c’è né un Ford né un FDR.
Tuttavia il Fordismo contiene una lezione per il nostro presente, proprio per quanto riguarda la questione della produttività del lavoro.
A misura della «produttività del lavoro» normalmente si prende il rapporto tra Pil e numero di ore lavorate. Questa misura, in verità molto rozza, nulla però ci dice circa le determinanti della produttività del lavoro. Una e ovvia, che ho il sospetto sia quella implicita nello slogan «Vogliamo una più alta produttività per pagare salari più alti», è la voglia di lavorare dei lavoratori. Le vere determinanti sono però altre e più complesse, di ordine qualitativo: il così detto «progresso tecnico» e il contesto in cui il lavoro viene prestato: l’impresa e lo Stato.
Ho messo tra virgolette «progresso tecnico», perché sarebbe meglio parlare di «cambiamento tecnico».
La prima locuzione suggerisce che un cambiamento nelle tecniche di produzione comporti un miglioramento nelle condizioni di vita dell’intera società, ma poiché la scelta delle tecniche di produzione è riservata ai proprietari delle macchine, e non anche a chi a le fa funzionare, quell’esito è improbabile.
Fin dal 1930 Keynes aveva avvertito che «Siamo colpiti da una nuova malattia: vale a dire la disoccupazione tecnologica. Il che significa che la disoccupazione dovuta alla scoperta di strumenti economizzatori di manodopera procede con ritmo più rapido di quello con cui riusciamo a trovare nuovi impieghi per la stessa manodopera».
Per medicare le conseguenze patologiche del «progresso tecnico» occorrerebbe dunque che le imprese si assumessero le loro responsabilità, per quanto riguarda la qualità della produttività del lavoro, e che altrettanto facesse lo Stato per quanto riguarda le condizioni di vita dei lavoratori in quanto cittadini.
Pochi, tuttavia, sono nel nostro paese gli imprenditori che ciò fanno, e per miopia: poiché ciò sarebbe anche nel loro interesse. E pochissimi sono gli imprenditori «schumpeteriani», che a differenza dei tanti imprenditori-rentier non si riconoscono nell’insulsa definizione del nostro codice civile all’articolo 2082: «È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi»; imprenditori «schumpeteriani» che creano e realizzano nuovi prodotti o nuove qualità di prodotti, che introducono nuovi metodi di produzione, che creano nuove forme organizzative dell’industria, che aprono nuovi mercati di sbocco e nuove fonti di approvvigionamento.
Assenti, in Italia, un Ford e un FDR, e in presenza di pochi veri imprenditori, tutto ricade sulla spalle dello Stato; ma dovrebbe essere uno Stato che provvedesse a risanare, sviluppare e consolidare quel poco di stato sociale che ancora c’è: Scuola Università Ricerca Sanità Assistenza, e questo non con la beneficenza ma con nuovi investimenti.
Al presidente della Confindustria di recente è stato chiesto: «Come pensa che possa risalire il Pil senza sostenere la domanda?»; il Presidente rispose: «Alla domanda ci si arriva attraverso la politica dell’offerta e non facendo l’inverso.» È questa una tesi, la così detta «legge degli sbocchi», che risale al Jean-Baptiste Say del suo Traité d’économie politique (1803): una «legge dell’economia» che nessuno rispetta, né nella teoria né nella pratica.
Ora un governo che davvero volesse fare ciò (risanare il contesto, e rilanciare la produttività e la domanda effettiva), ciò potrebbe fare. Mi aspetto l’obiezione: «Dove si trovano i fondi, senza trasgredire le regole comunitarie?».
La domanda è legittima, ma la risposta è semplice: i fondi si troverebbero rispettando e facendo rispettare l’articolo 53 della Costituzione: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Un articolo che questo governo non ha rispettato con molti suoi provvedimenti: dall’abolizione dell’IMU alla Voluntary disclosure. Termine, quest’ultimo, che evoca il Manuale del confessore: «Dóminus noster Jesus Christus te absólvat et ego absólvo te a vínculo excommunicatiónis, in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen».
Se invece quell’articolo si rispettasse e si facesse rispettare come si deve, poiché l’evasione fiscale è un furto, si rimedierebbe all’ingiusta distribuzione del reddito e della ricchezza, che è una delle cause della forma attuale e più perniciosa delle crisi economiche: la deflazione; e inoltre una redistribuzione del reddito (sia chiaro: dai ricchi ai poveri) farebbe aumentare la domanda per consumi, e dunque degli investimenti; e rimarrebbero ancora fondi per rendere più civile questo povero paese.
 «Nella città che esattamente un anno fa chiuse la stazione ferroviaria di Keleti per chiudere ai profughi di guerra le porte della fortezza Europa, si è discusso anche di migrazione denunciando i respingimenti». Il manifesto, 22 settembre 2016 (c.m.c.)
«Nella città che esattamente un anno fa chiuse la stazione ferroviaria di Keleti per chiudere ai profughi di guerra le porte della fortezza Europa, si è discusso anche di migrazione denunciando i respingimenti». Il manifesto, 22 settembre 2016 (c.m.c.)






 «La commissione sulle diacone potrebbe segnare anche la rottura di tre assordanti silenzi che soffocano le chiese da decenni». La
«La commissione sulle diacone potrebbe segnare anche la rottura di tre assordanti silenzi che soffocano le chiese da decenni». La 
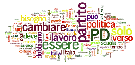

 «Quando capiamo il nesso tra crisi climatica, crisi economica e la nostra personale sofferenza, allora c’è davvero il potenziale per cambiare il mondo».
«Quando capiamo il nesso tra crisi climatica, crisi economica e la nostra personale sofferenza, allora c’è davvero il potenziale per cambiare il mondo».



 ».
». 




