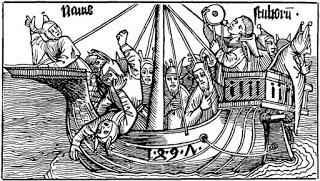«Mantenere indefinitamente nella non appartenenza migliaia di bambini e adolescenti è non solo ingiusto, ma rischia di produrre estraneità e rancore». l
«Mantenere indefinitamente nella non appartenenza migliaia di bambini e adolescenti è non solo ingiusto, ma rischia di produrre estraneità e rancore». l
a Repubblica, 18 giugno 2017 (c.m.c.)
Diritti sociali contro diritti civili: un copione che in Italia si ripete spesso, non tanto per spingere i primi quanto per bloccare i secondi. Come se i diritti civili (degli altri, naturalmente, non i propri) fossero un lusso che può essere sempre rimandato, e le difficoltà economiche o la mancanza di diritti sociali un buon alibi per non rispettare neppure quelli civili. È successo, a suo tempo, per i diritti delle donne, più recentemente per quelli delle persone omosessuali. Quando non li si negavano tout court, si diceva che dovevano aspettare, che c’erano altre priorità più urgenti.
Un po’ sorprendentemente, con una notevole dose di cinismo, hanno fatto proprio questo copione anche i Cinquestelle. Il loro aspirante futuro premier Di Maio, per spiegare perché il Movimento non voterà la legge sulla cittadinanza, ha denunciato: «È mai possibile che prima di pensare al lavoro, o a un piano per dare incentivi e sgravi alle imprese che assumono giovani, oppure a un reale sostegno per le famiglie monoreddito con figli a carico, il Pd pensi a far approvare lo ius soli?».
Non sarò certo io a negare che in questo paese manca un sostegno adeguato al costo dei figli e che politiche del lavoro che si limitano al lato dell’offerta non vanno molto lontano. Ma non vedo come questo possa essere contrapposto al diritto di chi nasce e cresce nel nostro paese, sentendosene parte e seguendo le sue leggi, di esserne riconosciuto pienamente come cittadino, se lo desidera, senza essere costretto in un limbo che di fatto lo riduce ad uno status di apolide: perché non è cittadino italiano, ma neppure di fatto del paese da cui provengono i suoi genitori e dove, se questi sono rifugiati, spesso non può neppure andare.
Negando l’importanza di questo riconoscimento, un movimento che si riempie la bocca della parola “cittadinanza” e “cittadini” non sembra davvero aver compreso in che cosa consiste l’essere cittadino: non il sangue, o il colore della pelle, e neppure la nazionalità dei propri genitori, ma l’identificazione con una collettività, incluso l’accesso ai diritti e doveri che ne derivano, così da maturare la disponibilità a partecipare alla formazione del bene comune.
Negare questo accesso, mantenendo indefinitamente sulla soglia e nella non appartenenza migliaia di bambini e adolescenti è non solo ingiusto, ma miope, perché rischia di produrre quel senso di estraneità e di rancore che può sfociare in fenomeni estremi di disidentificazione con la nostra società. Per altro, la legge in discussione, niente affatto affrettata come suggerisce da parte sua Alfano, desideroso anch’egli di defilarsi, stante che se ne sta discutendo da anni e da due anni è già passata al vaglio della Camera, configura uno Ius soli molto temperato.
Richiede che almeno uno dei genitori abbia ottenuto il permesso di lungo soggiorno, quindi abbia risieduto regolarmente in Italia per almeno cinque anni, o, in alternativa, che il bambino o ragazzo (nato qui o arrivato entro i dodici anni) abbia completato almeno un ciclo di studi quinquennale. Non vi è nessun rischio di incentivare arrivi di massa di donne incinte, o pronte a diventarlo, che trasformeranno l’Italia in un enorme reparto di maternità, come ha evocato qualcuno. Il percorso verso la cittadinanza continua ad essere impegnativo.
Anche l’altra obiezione di Di Maio — che la questione della cittadinanza deve essere affrontata a livello europeo — appare strumentale, oltre che paradossale in bocca ad un cinquestelle che di solito condanna gli interventi della Ue come attacchi alla sovranità. Non si capisce perché l’Italia debba demandare alla Ue di regolare l’accesso alla cittadinanza italiana, visto che finora tutti gli altri paesi, anche quando hanno modificato le proprie norme negli ultimi anni, non lo hanno fatto.
Quindi coloro che sono diventati cittadini tedeschi o irlandesi o francesi con regole diverse dalle nostre, in quanto cittadini europei possono circolare liberamente, venendo anche in Italia. Cominciamo a definire le nostre regole e poi impegniamoci pure a verificare l’opportunità di una armonizzazione a livello Ue. Ma non usiamo questa scusa per rimanere fermi e negare la cittadinanza a chi cresce, gioca, studia quotidianamente fianco a fianco con i nostri figli e nipoti, condividendone abitudini, interessi, desideri, aspirazioni.
 «In una società diseguale come la nostra, un pensiero di sinistra, una forza di sinistra non può che lottare contro una politica che regala diseguaglianze (mai viste così profonde nel secolo scorso nei paesi europei), come fossero eventi naturali.
«In una società diseguale come la nostra, un pensiero di sinistra, una forza di sinistra non può che lottare contro una politica che regala diseguaglianze (mai viste così profonde nel secolo scorso nei paesi europei), come fossero eventi naturali.
il manifesto, 17 giugno 2017
Oggi in piazza San Giovanni ci saranno i dimenticati in carne e ossa, italiani e immigrati, lavoratori condannati alla precarietà, disoccupati, giovani che un lavoro non lo hanno mai visto. Sono una parte del nostro mondo, le loro battaglie fanno parte delle nostre radici.
Nello sfascio generale dei partiti, la Cgil resta un’organizzazione con una storia, un seguito di massa e un programma alternativo disegnato con il nuovo statuto dei diritti dei lavori insieme alle proposte di un’altra politica economica contro la crisi. Ieri impegnata nel referendum in difesa della Costituzione, oggi la Cgil è all’attacco sull’ultima vergogna del governo Renzi-Gentiloni che prima ha gambizzato il referendum contro i voucher, poi ha inserito la nuova normativa nel pacchetto della manovrina economica imposta con la novantreesima fiducia.
Se quel referendum fosse stato celebrato, gli italiani non si sarebbero astenuti e sarebbe stato un voto sulle condizioni sociali del lavoro, un voto tutto politico.
Susanna Camusso e Maurizio Landini, i leader sindacali di piazza San Giovanni, potrebbero ben essere i volti del partito laburista italiano. I due sindacalisti hanno nulla da invidiare ai Corbyn, ai Sanders, agli Igliesias, agli Tsipras. Sarebbero le persone giuste al posto giusto per un partito con la testa a una nuova programmazione economica europea e con il cuore tra le periferie sociali che nessuno ascolta più, salvo mettersi sui giornali a interpretarle dopo i risultati elettorali.
Piazze come quella di oggi riassumono le idee, nonostante la crisi abbia coinvolto tutti, Cgil compresa, di una forza di lotta e di governo, come tutta la variopinta galassia che si muove a sinistra del Pd ripete ogni giorno di voler diventare.
E, a proposito del Pd, non sarà secondario osservare che il suo segretario, con il jobs act e i voucher, a piazza San Giovanni non sarebbe bene accolto. Lui sta su un altro pianeta, esprime una cultura del lavoro e dell’impresa che con la sinistra non si intende.
La piazza e la leadership piddina rappresentano due mondi diversi. E non è ben chiaro come potrebbero, questi due mondi, ritrovarsi domani alleati in un centrosinistra di governo. Prima di arrampicarsi sugli specchi delle future alleanze, bisognerebbe rispondere a questa semplice domanda: che partito di sinistra è quello che vedrebbe oggi espulso dalla piazza del lavoro il suo leader?
Un’altra visione del lavoro e in sostanza dell’identità politica di un partito che vive di illusioni ottiche. Andrebbe smontata, per esempio, quella che mostra in bella evidenza le battaglie per i diritti civili come il necessario e sufficiente marchio di fabbrica di una moderna sinistra doc. Necessario non c’è dubbio, ma non sufficiente.
Si può essere liberali, di destra e a favore dei diritti civili, viceversa non si può essere liberali o di destra e battersi per i diritti che i lavoratori portano oggi in piazza. A cominciare dal ripristino dell’articolo 18, sostituito con il marketing politico del contratto a tutele crescenti. Quanti sinceri liberal democratici di destra sono per l’articolo 18? E quanti sono contro la vergogna dei voucher e di tutti gli altri strumenti di flessibilità che schiacciano il lavoratore al rango di merce sul mercato?
Destra e sinistra esistono ancora, basta volerle vedere. Per questo oggi il Pd di Renzi, paladino dei diritti civili (ma sempre con moderazione: unioni civili sì ma stepchild-adoption no; ius soli sì ma temperato…) e inflessibile avversario dei diritti del lavoro, è un partito che ha cambiato la sua natura. Per questo sembra fantascienza solo immaginare la sua presenza tra i lavoratori di piazza San Giovanni.
Paradossale ma non troppo, la storica piazza romana, viceversa, accoglierebbe benvolentieri papa Francesco, specialmente dopo il suo discorso all’Ilva di Genova. Dove il papa ha espresso un pensiero avanzato sul lavoro ma non solo. Il suo giudizio sulla bandiera renziana del “merito” è una lucida analisi sulla mistificazione di chi la sventola come principio di uguaglianza quando è vero che il “merito”, al contrario, esclude i più svantaggiati, colpevolizza chi viene respinto perché emarginato da ogni competizione che non ristabilisca l’uguaglianza dei punti di partenza.
In una società diseguale come la nostra, un pensiero di sinistra, una forza di sinistra non può che lottare contro una politica che regala diseguaglianze (mai viste così profonde nel secolo scorso nei paesi europei), come fossero eventi naturali e non frutti avvelenati di un’economia capitalistica globale, brutale e arida che desertifica le nostre società come la siccità che sta desertificando il pianeta.
 «E’ ora di dichiarare in cosa crediamo, di unirsi e dimostrare che cambiare si può».
«E’ ora di dichiarare in cosa crediamo, di unirsi e dimostrare che cambiare si può». il manifesto,
17 giugno 2017 (c.m.c)
Facciamo una scommessa? Attorno a un programma di rottura, ambizioso e convincente, è possibile creare unità e coinvolgere milioni di persone in un progetto di radicale rinnovamento del nostro Paese e del nostro continente. Basta alzare lo sguardo. Dinnanzi alla grandezza delle sfide che ci confrontano la piccolezza della politica che ci governa suona una triste, stridente nota di rinuncia.
Stride il rifiuto delle
élite di governo di accettare la necessità di un profondo mutamento di un sistema palesemente ingiusto. Stride lo spettacolo di una sinistra divisa. Stride un dibattito politico totalmente avulso dalla realtà, un teatrino di personalità narcise e ignoranti, una savana in cui sciacalli si avventano per una manciata di voti sui corpi di chi muore in mare.
E tutto ciò stride ancora di più perché ci troviamo nel mezzo di una grande trasformazione che nessuno pare interessato a governare. Il mondo di oggi è già quello che Stefan Zweig chiamava il mondo di ieri. Le contrazioni del futuro sono sotto gli occhi di tutti. A livello economico: stagnazione, picco delle ineguaglianze, scomparsa della classe media.
A livello produttivo: automazione, crisi ecologica, digitalizzazione. A livello politico: crisi della globalizzazione, crisi dell’Unione europea, migrazioni di massa. Abbiamo bisogno di un manifesto di rottura con un passato che non deve e non può più tornare. Ci servono parole chiare sulla ridistribuzione della ricchezza.
Perché se 8 uomini cumulano un patrimonio pari a quello della metà più povera del mondo, questo non è solamente uno scandalo morale, ma anche un incredibile ostacolo allo sviluppo, come perfino il Fondo Monetario Internazionale arriva ad ammettere. Tassazione progressiva, patrimoniale intelligente e tassa sulle grandi successioni sono politiche giuste quanto necessarie a rimettere in moto l’economia.
Parole chiare sull’evasione fiscale. Perché se le multinazionali cumulano miliardi di profitti grazie all’elusione permessa dal sistema dei paradisi fiscali questo rappresenta un’ipoteca sul futuro di milioni di persone e un’illegalità paragonabile a quella dei grandi trust criminali contro cui si scagliavano i versi di Bertolt Brecht. E’ scandaloso vedere i capi di stato europei accanirsi su un decimale di deficit di bilancio mentre sono proprio i Paesi considerati più virtuosi – quali l’Olanda, dove la finanziaria degli Agnelli ha trasferito la propria sede – a permettere l’emorragia fiscale che aumenta quel deficit.
Sul futuro del lavoro. Il reddito di cittadinanza è una misura ovvia, tra l’altro presente nella maggior parte dei Paesi a capitalismo avanzato. Ma bisogna andare oltre. Perché era il 1930 quando Keynes predisse per i suoi nipoti – che saremmo noi – una settimana lavorativa di 15 ore. E oggi si sta scoprendo che ridistribuire il lavoro farebbe crescere occupazione e produttività e diminuire inquinamento e ineguaglianze. E restituirebbe tempo libero alle persone. Perché si lavora per vivere, e si vive per essere liberi. E’ l’ora della settimana corta, incentivata da sgravi fiscali e diritto al part-time.
Sulle migrazioni. Perché non basterà il coraggio e l’umanità di chi salva donne e uomini in mare se non saremo in grado di governare un sistema di migrazione legale, circolare, che razionalizzi una richiesta di mobilità che non andrà a cessare. Servono canali sicuri che permettano l’ottenimento di un visto per la ricerca di lavoro nei Paesi di origine e un accesso semplificato alla cittadinanza.
Sulla democrazia europea. Perché non reggerà un’Unione incentrata sulla paura, sul ricatto e sullo schiacciamento dei diritti. Non reggerà un’Unione imperniata su un ottuso metodo intergovernativo in cui 27 capi di stato, i primi responsabili delle politiche nefaste di questi anni, gettano il sasso e nascondono la mano. Ma senza Europa unita e democratica saremo staterelli alla deriva in balia del potente di turno, dei muscoli di Putin e dei tweet di Trump.
Il cantiere europeo va riaperto. O non resteranno che macerie. E per farlo bisogna costruire una grande alleanza europea come non siamo stati in grado di fare durante la primavera calda di Atene. E poi sulla trasformazione del nostro sistema produttivo, perché il susseguirsi di crisi quotidiane non può farci dimenticare la grande crisi ecologica che ci attende.
Sul capitalismo monopolistico che va delineandosi nella Silicon Valley. Sull’automazione e sulla condivisione dei profitti derivanti dalla rivoluzione delle macchine. Sulla centralità dell’istruzione e della ricerca, per fermare la competizione al ribasso del lavoro. In breve: sulle grandi questioni necessarie a ridefinire un sistema in stallo fra trasformazione e implosione. Non sono questi tempi per il piccolo cabotaggio.
Il 18 giugno, in seguito all’appello di Montanari e Falcone, ci incontreremo a Roma. Con il movimento europeo DiEM25 abbiamo già dato la nostra adesione – convinti che non si possa cambiare questa Europa senza partire anche dall’Italia. Il primo luglio è stato invece Giuliano Pisapia a chiamare una piazza romana. Per avere successo partiamo dalle politiche e non dai nomi.
Partiamo da dieci punti attorno ai quali costruire uno spazio nuovo in cui confluiscano tutte le persone, le associazioni e i partiti che credono a questo obiettivo. Perché non sono le idee a dividerci. Non è più il tempo dei posizionamenti. E’ ora di dichiarare in cosa crediamo, di unirsi e dimostrare che cambiare si può. Perché ci giochiamo il futuro. E non è più consentito sbagliare.
 «Storia antica e complessa, ma mai invecchiata, se è vero che ritorna puntualmente a galla quando ci si pone la questione di chi sono i nostri concittadini».
«Storia antica e complessa, ma mai invecchiata, se è vero che ritorna puntualmente a galla quando ci si pone la questione di chi sono i nostri concittadini».
la Repubblica, 17 giugno 2017 (c.m.c.)
Vi è nell’idea dello Ius soli una ragione così umana e fondamentale della quale ci sfugge la portata se prestiamo attenzione alle cronache parlamentari: l’idea che la condizione di tutti noi su questa terra sia quella di ospiti e viaggiatori, più o meno nomadi o stanziali, più o meno accasati da qualche parte o pendolari. Chi più chi meno, tutti abbiamo radici trasportabili (e che molto spesso trasportiamo per davvero), e siamo nati per caso qui o là. E questo la dice lunga sulle roboanti s-ragioni della destra, leghista o pentastellata che sia. Pochi riflettono sul fatto che giustificare democraticamente, o addirittura con l’appello ai diritti umani, i confini degli Stati, è molto complicato, anzi impossibile — chi ci ha provato è caduto in tante aporie che ha dovuto alla fine riconoscere che di Stati c’è bisogno; che sono una fatticità impossibile da ignorare; che, insomma, i confini rispondono a ragioni di prudenza.
Insoddisfatti di queste ragioni storiche, alcuni filosofi hanno cercato a partire dall’Ottocento di dare ragioni più spesse, e perfino natuali o congenite alle culture nazionali — gli Stati sono allora diventati etici, o perché resi essi stessi un valore primario (che veniva prima dei sudditi che contenevano) o perché al servizio di un valore ritenuto ancora più alto, la nazione. E da quel momento, da quando queste idee sono state propaganda elettorale, una divisione nuova è emersa nelle dispute ideali e politiche: fra posizioni che riprendevano le radici universalistiche, religiose o secolari, e posizioni nazionalistiche. Insomma, destra e sinistra, si sono da quel momento misurate anche in ragione della posizione di fronte alla priorità della persona o invece delle appartenenze nazionali. Storia antica e complessa, ma mai invecchiata, se è vero che ritorna puntualmente a galla quando ci si pone la questione di chi sono i nostri concittadini, e che cosa fa di un residente che paga le tasse e parla la nostra lingua, un cittadino italiano a tutti gli effetti.
L’Italia ha un rapporto a dir poco difficile e strabico con il “diventare” cittadini, visto che ha una legge (che porta il nome di un ex-fascista, Mirko Tremaglia) che riconosce il diritto di voto a italiani di razza, a figli di bisnonni italiani, anche se mai vissuti in Italia. Quanti sono gli elettori italiani sparsi per il mondo che a malapena sanno pronunciare parole italiane, eppure hanno il diritto di decidere sulle questioni pubbliche di chi vive, lavora e paga le tasse qui, in Italia? Sono tanti, e sono un problema serio per chi sostiene le ragioni dello Ius soli. Il diritto del suffragio che fa perno sul diritto del sangue è un problema.
Si potrebbe almeno desiderare che con quella passione (a giudizio di chi scrive mal posta) con la quale si è difesa la causa del voto agli italiani all’estero, si difenda oggi la causa della cittadinanza riconosciuta a chi è nato nel nostro paese, da genitori non italiani (e con almeno uno dei due residente in Italia) e a chi, pur non essendo nato qui, ha frequentato la scuola in Italia per almeno 5 anni. Questa è una legge minima (moderata) e giusta.
Anche per una ragione sulla quale vale la pena riflettere un poco: che i popoli delle democrazie non sono come famiglie che gestiscono l’appartenenza secondo criteri affettivi, o semi-natuali, appellandosi magari a legami ancestrali, dei quali nessuno può con cognizione di causa parlare con certezza, dire dove finiscono, dove cominciano e in che cosa consistono.
I popoli delle democrazie, quelle moderne soprattutto, sono composti di persone che sono straniere tra loro e che, proprio per questo, si danno leggi basate sul principio del rispetto e dell’eguaglianza di considerazione. Si riconoscono in tal modo come non appartenenti a nessun “ceppo” natuale, simil-famigliare (o familistico) — è questa la base universalistica per la quale abbiamo ragione di pensare che le democrazie siano governi buoni; imperfetti per tante ragioni, hanno dalla loro il fatto che ci rendono davvero difficile giustificare le esclusioni, anche quando proviamo a scomodare ragioni etiche o sentimentali. Questa difficoltà è quel che ci salva dall’essere tentati, in casi di crisi economica o di follia nazionalistica, di pensare che escludere sia giusto e buono; che essere parte del demos sia un privilegio che passa per ragioni non decidibili, come il colore della pelle o l’essere nato in una parte specifica di mondo, per caso.
 La paradossale riflessione del filosofo sloveno su un comportamento dell sinistra nei confronti delle migrazioni. «Dovremmo chiederci se essere politicamente corretti sia davvero qualcosa che appartiene alla sinistra: non si tratta invece di una strategia di difesa contro le istanze della sinistra radicale?».
La paradossale riflessione del filosofo sloveno su un comportamento dell sinistra nei confronti delle migrazioni. «Dovremmo chiederci se essere politicamente corretti sia davvero qualcosa che appartiene alla sinistra: non si tratta invece di una strategia di difesa contro le istanze della sinistra radicale?».
il Fatto quotidiano, 16 giugno 2017
Se qui in Occidente volessimo davvero sconfiggere il razzismo, il primo passo sarebbe farla finire con questo processo politicamente corretto di auto-colpevolizzazione. Anche se le critiche di Pascal Bruckner (uno scrittore francese, tra i nouveaux philosophes, ndr) agli approcci della sinistra di oggi spesso sfiorano il ridicolo, questo non gli impedisce di fare qualche analisi utile: non si può che essere d’accordo con lui quando identifica nella auto-flagellazione politicamente corretta dell’Europa il rovescio di una rivendicazione di superiorità.
Ogni volta che l’Occidente viene attaccato, la sua prima reazione non è una difesa aggressiva ma colpevolizzarsi: cosa abbiamo fatto per meritarci tutto questo? In ultima analisi, la colpa di ogni male è soltanto nostra, per le catastrofi del Terzo mondo e la violenza dei terroristi è soltanto una reazione ai nostri crimini… la forma positiva del “fardello dell’uomo bianco” (la responsabilità di colonizzare i barbari) viene rimpiazzata dalla sua versione negativa (la colpa dell’uomo bianco): se non possiamo più essere i dominatori benevoli del Terzo mondo, possiamo almeno essere la fonte privilegiata dei suoi mali, privandoli con paternalismo di ogni responsabilità riguardo al loro destino (se un Paese del Terzo mondo si macchia di terribili crimini, non è mai pienamente sua responsabilità: sta soltanto imitando quello che faceva il padrone coloniale ecc.).
La logica del politicamente corretto attiva quei meccanismi che possiamo chiamare di “sensibilità delegata”, spesso secondo questa linea di argomentazione: “Io sono un duro, non mi urtano i discorsi sessisti o razzisti o di odio, o chi si prende gioco delle minoranze, ma io parlo a nome di quelli che potrebbero essere offesi da quelle parole”. Il punto di vista è quindi quello di questi “altri” che, viene dato per scontato, sono così ingenui e indifesi da aver bisogno di protezione perché non capiscono l’ironia o non sono in condizione di rispondere agli attacchi. Deleghiamo l’esperienza passiva di una sensibilità da pastore su un “altro” ingenuo, producendo così una sua infantilizzazione. Per questo dovremmo chiederci se essere politicamente corretti sia davvero qualcosa che appartiene alla sinistra: non si tratta invece di una strategia di difesa contro le istanze della sinistra radicale? Di un modo per neutralizzare l’antagonismo invece che affrontarlo in modo esplicito? Molti degli oppressi percepiscono chiaramente come la strategia del politicamente corretto aggiunga insulti alle ingiurie: mentre l’oppressione rimane, loro – gli oppressi – devono anche ringraziare per come i liberal li proteggono…
Uno dei sottoprodotti più sgradevoli della ondata di rifugiati che è arrivata in Europa nell’inverno 2015-2016 è stata l’esplosione dell’indignazione moralista tra molti progressisti di sinistra: “L’Europa sta tradendo la sua tradizione di libertà e solidarietà! Ha perso la sua bussola morale! Tratta i rifugiati come invasori, bloccando il loro ingresso con filo spinato, chiudendoli in campi di concentramento!”. Questa empatia astratta, combinata con la richiesta di aprire le frontiere senza condizioni, merita la grande lezione hegeliana dell’Anima bella: quando qualcuno dipinge il quadro della definitiva degenerazione dell’Europa, bisognerebbe chiedersi che grado di complicità ha questa posizione con ciò che critica, in che modo coloro che si sentono superiori al mondo corrotto in realtà, segretamente, vi partecipano. Nessuna sorpresa che, con l’eccezione degli appelli umanitari alla compassione e alla solidarietà, gli effetti di questa auto-flagellazione siano completamente nulli… E se gli autori di questi appelli sapessero perfettamente che non contribuiscono in alcun modo ad alleviare la piaga dei rifugiati ma che l’effetto finale dei loro interventi è soltanto quello di nutrire il sentimento anti-immigrati? E se segretamente fossero ben consapevoli del fatto che quanto chiedono non succederà mai perché scatenerebbe all’istante una rivolta populista in Europa? Perché, quindi, si comportano così?
C’è soltanto una risposta coerente: il vero scopo di questa loro attività, dei paladini del politicamente corretto, non è quello di aiutare davvero i rifugiati, ma attraverso le proprie accuse raggiungere il Lustgewinn.
Il processo dell’ “ottenimento del piacere / Lustgewinn” opera attraverso la ripetizione: chi manca l’obiettivo ripete il movimento, provando ancora e ancora, così che alla fine il vero scopo non è più l’obiettivo desiderato ma il movimento ripetitivo del tentativo di raggiungerlo in se stesso. Mentre il contenuto desiderato (oggetto) promette di offrire piacere, un piacere ancora maggiore può essere ottenuto dalla forma stessa (procedura) di inseguimento dell’obiettivo. L’esempio classico: mentre l’obiettivo di succhiare un seno è di essere nutriti dal latte, l’aumento di libido è prodotto dal movimento ripetitivo di succhiare che quindi diventa un fine in se stesso.
Dopo la chiusura serale, nei supermarket della catena Walmart si trovano molti carrelli pieni di prodotti ma abbandonati tra gli scaffali: sono stati lasciati lì dagli appartenenti alla classe media impoverita che non sono più in grado di fare davvero acquisti. Così visitano il supermercato, attraversano il rituale dello shopping (mettendo le cose di cui hanno bisogno o che desiderano nel carrello) e poi abbandonano tutto nel negozio. In questa triste accezione, ottengono il surplus di piacere dovuto allo shopping in questa forma puramente isolata, senza comprare nulla. Non ci impegniamo spesso in attività simili la cui “irrazionalità” non è però altrettanto visibile? Facciamo qualcosa – come lo shopping stesso – senza uno scopo preciso, ma in realtà siamo indifferenti a quale dovrebbe essere questo scopo perché la vera soddisfazione deriva dalla attività stessa? Con il Lustgewinn, lo scopo del processo non è il suo obiettivo ufficiale (la soddisfazione di un bisogno), ma la riproduzione stessa del processo.
Il Lustgewinn prodotto delle accuse sui rifugiati è il sentimento di superiorità morale rispetto agli altri che prova chi le lancia. Più rifugiati vengono respinti e più crescono i populismi anti-immigrati, più queste “anime belle” si sentiranno giustificate: “Vedete, gli orrori continuano, avevamo ragione noi!”.
 Un caloroso invito all'incontro del 18 giugno, che può rovesciare la decadenza della politica e ridare un senso a chi vuole unirsi per costruire un mondo migliore. Ma è decisivo che cosa si sarà capaci di fare dal giorno dopo.
Un caloroso invito all'incontro del 18 giugno, che può rovesciare la decadenza della politica e ridare un senso a chi vuole unirsi per costruire un mondo migliore. Ma è decisivo che cosa si sarà capaci di fare dal giorno dopo.
il manifesto, 16 giugno 2017
Si sarebbe tentati di iniziare come si faceva una volta nei congressi di partito: dall’analisi della situazione internazionale per poi arrivare al «caso italiano». Varrebbe la pena perché fuori dall’Italia succedono cose interessanti. Corbyn, Mélenchon, Sanders, Podemos, Syriza.
Esiste una sinistra, dai valori antichi e alle adesioni giovani. Che cresce essendo sinistra, non cercando i voti al centro o realizzando il programma della destra, come da noi. Perché – alla rovescia dal secolo scorso – il caso italiano è un disastro. Siamo quasi l’unico paese d’Europa in cui non c’è una sinistra decente. E non come “etichetta” ideologica buona a coprire pratiche di ogni tipo. Su questo ha ragione Podemos. Come cultura politica vissuta, non solo dichiarata, senso della giustizia e della libertà. Costruire l’uguaglianza, liberare le differenze, era scritto su un muro del sessantotto parigino.
E però il voto del 4 dicembre indica che una certa idea di democrazia nel paese esiste – come contenuti, linguaggio, stile di vita.
Sono i contenuti che Falcone e Montanari hanno indicato nella loro proposta. Quelli della disuguaglianza crescente, ormai oltre i livelli di Balzac e Austen, come ha dimostrato Piketty; quelli dei migranti, dello Stato sociale, del paesaggio, della pace, della scuola e della sanità. Insomma i temi della carta costituzionale. Che ha dato prova in due referendum di non essere solo carta ma di avere radici profonde nella testa e nell’anima di una grande parte dell’Italia.
Ma adesso che fare?
L’appello conferma ancora una volta che esiste un mondo e una cultura diffusa che non sono rappresentati dai partiti e dai raggruppamenti della sinistra esistente. Dimostra anche, forse, che viviamo una crisi della rappresentanza e della politica; che c’è l’esigenza di inventare nuove forme della comunicazione e delle relazioni politiche, legate alla vita delle donne e degli uomini che vivono e soffrono la nuova antropologia del neoliberismo: solitudine, paura, competizione. E che sono radicali. Non stanno nell’orizzonte di questa Europa dell’austerità e della finanza. Non stanno dunque nemmeno nei paradigmi di pensiero e di pratiche che hanno tristemente definito e tristemente definiscono il centrosinistra in Italia. E la socialdemocrazia in Europa.
Perché la crisi italiana della “sinistra di governo” non nasce con Renzi. È l’incapacità di leggere le trasformazioni per gestirle e non esserne gestiti. È la caduta di un pensiero critico. Renzi le ha dato solo un di più di spettacolarità, cialtroneria e arroganza.
Il 18 giugno a Roma di sicuro una parte importante di questa società civile e politica si ritroverà al teatro Brancaccio. Sarà bello. Sarà la dimostrazione che un’altra Italia esiste, come comunità di cultura, impegno, solidarietà, associazionismo, come desiderio di partecipazione e di polis. Esiste, può resistere e costruire altro.
Però sarà soprattutto fondamentale il 19 giugno. Il giorno dopo, quello più difficile.
Sarebbe importante che quell’incontro non restasse solo una bella discussione. Tutte e tutti coloro che interverranno avranno naturalmente pari dignità, semplici cittadini o dirigenti di partito. Ognuno con la sua storia.
Ma quella parte di cittadinanza politica che chiama al confronto ha una responsabilità in più, diversa e notevole. Quella di non salutarsi felici e poi lasciare il campo agli addetti ai lavori di sempre. Ognuno ha le proprie competenze e il lavoro di tutte e di tutti ha una connotazione politica, ma se si resta chiusi nel proprio mondo, allora il rischio grave è che la politica continuino a farla i politici. E questo nell’Italia di oggi non ce lo possiamo permettere.
C’è bisogno di qualcosa di radicale e di radicalmente nuovo per uscire dalla crisi – dalla «frantumaglia» di Elena Ferrante. Qualcosa di travolgente. Una proposta che non si può rifiutare, che attragga e trascini con sé i soggetti adesso confusamente sulla scena. Non è possibile delegare ancora una volta le responsabilità ai partiti esistenti, né immaginare una semplice sommatoria, neppure un coordinamento o federazione di sigle polverizzate. Anche nel pensiero. C’è bisogno di una proposta netta, decisamente centrata su alcuni contenuti di fondo. Forse oggi di natura più etica che politica.
L’atteggiamento nei confronti dei migranti, la difesa dell’umano di fronte al disumano, come ha scritto Marco Revelli per la manifestazione di Milano del 20 maggio. L’attenzione verso le povertà, per la dignità del lavoro, i diritti civili cioè la libertà di inventare la propria vita ed essere se stessi, la liberazione delle donne dalla violenza del potere maschile, proprietario e la liberazione degli uomini dalla prigione del potere.
Per dare vita a un processo del genere occorre il protagonismo di soggetti nuovi. Occorre progettare un percorso diffuso sul territorio. Assemblee incontri iniziative. Che parlino e diano voce a quella società che soffre e cerca una dimensione collettiva della propria vita. Vuole esserci. Non solo come comparsa o spettatore disincantato dello show politico dominante da televendita.
La proposta elettorale che potrebbe uscire dovrà essere naturalmente la più ampia e inclusiva possibile. Presentarsi alle elezioni con l’obiettivo massimo di superare un qualche quorum è la cosa più minoritaria, triste e perdente, che si possa fare. La maniera migliore per non raggiungere lo scopo. Potrà essere effettivamente unitaria se appunto metterà al centro temi e obiettivi, rendendo ben riconoscibile la cultura politica che li produce. Un’identità forte ma tutt’altro che di nicchia.
Ci vorrà una notevole dose di creatività e invenzione. Anche di pazienza e capacità di mediazione. Si tratta di dare vita a uno spazio pubblico di confronto che sarà naturalmente anche il luogo di una competizione per l’egemonia. Ma va bene così: la diversità delle visioni e degli orizzonti può rendere tutto più difficile e faticoso, però può anche spingere finalmente alla costruzione di una soggettività fatta di un tessuto di relazioni politiche decenti. Forti quanto miti. Umane.
Dove non domini l’aggressività e il narcisismo di chi sa appartenere solo all’identico a sé; dove si accetti la presenza di letture anche diverse della realtà che ci circonda, se ci si riconosce compagne e compagni. Capaci di spezzare il pane insieme. E donarlo al mondo.
 «Intervista a Susanna Camusso. La segretaria della Cgil lancia la mobilitazione di sabato contro la reintroduzione dei
«Intervista a Susanna Camusso. La segretaria della Cgil lancia la mobilitazione di sabato contro la reintroduzione dei
voucher». MicroMega online, 15 giugno 2017 (c.m.c.)
“Si è sottratta al Paese la possibilità di poter decidere: ne esce sconfitta la democrazia. Prima, ad aprile, si sono abrogate le leggi che erano oggetto di referendum, poi si sono riproposte dentro una manovrina”. Susanna Camusso ci accoglie nel suo ufficio, al quarto piano del palazzo Cgil di Roma. È indaffarata a preparare la piazza di sabato 17 giugno dal titolo inequivocabile Uno schiaffo alla democrazia contro la reintroduzione dei voucher. Una manifestazione che si focalizzerà soprattutto sul mancato funzionamento dell’articolo 75 della Costituzione: “Il governo ha scelto coscientemente di violare le regole della nostra Carta”. Non si fanno previsioni sui numeri dei partecipanti, anche se i sentori fanno presagire una manifestazione imponente.
Il governo ha deciso di anticipare il voto sul maxi emendamento ad oggi, prima della piazza di sabato. È sempre più scippo della democrazia?
Hanno paura di confrontarsi con l’opinione delle persone, come se il lavoro non meritasse un pronunciamento dei cittadini. E, attenzione, ponendo la fiducia, dimostrano di aver paura persino del dibattito parlamentare. Un doppio inganno se consideriamo che è stato inserito in un decreto d’urgenza in violazione del dispositivo con cui la Corte costituzionale ha autorizzato i referendum.
Si spieghi meglio...
La Corte dice che le norme sono abrogabili perché sono prive di una definizione di cosa sia il lavoro occasionale, cosa che si ripete esattamente con questo nuovo provvedimento, al di là del cambio di nome: invece di chiamarlo voucher viene chiamato contratto di prestazione occasionale, ma è un’autodefinizione.
Eppure il governo insiste che non hanno nulla a che vedere con i vecchi voucher. Rispetto a prima si alza il compenso per chi svolge attività presso le imprese. Sale anche la quota contributiva a carico del datore (al 33%). Vengono poi stabiliti dei limiti: non sono ammesse le aziende con più di 5 dipendenti, quelle del settore dell’edilizia e prestazioni inferiori alle 4 ore. Infine, la gestione delle operazioni sarebbe infatti affidata a un portale ad hoc dell’Inps. Come controbatte?
Molti, sia nel Governo che nel Parlamento, quando discutono di lavoro non sanno concretamente di cosa parlano. Sono così convinti che debba esistere un lavoro occasionale che non lo sanno neanche definire: l’unica definizione è che debba costare 5000 euro all’anno. Un po’ poco, no? La precarietà è questione più complessa...
Sì, ma rispetto ai vecchi voucher non ci sono cambiamenti?
Innanzitutto è ridicolo parlare delle poche imprese con 5 dipendenti a tempo indeterminato, in realtà stiamo parlando di più del 90% delle imprese italiane! Inoltre nei PrestO la quota previdenziale è aumentata con una beffa perché riporta la contribuzione all’equivalenza col lavoro dipendente, ma la inserisce nella gestione separata. Quindi per quei lavoratori si ha una contribuzione previdenziale inutilizzabile e in più non si hanno gli stessi diritti come la malattia. Una seconda beffa è sulla tracciabilità: viene inserito l’obbligo di comunicazione a inizio lavoro ma contestualmente vengono concessi tre giorni per smentire quanto si è dichiarato e negare la prestazione. E’ assolutamente evidente che con un’efficacia dei controlli molto discutibile, gli abusi e I raggiri saranno all’ordine del giorno.
Secondo il giuslavorista Piergiovanni Alleva i PrestO sarebbero addirittura peggiorativi rispetto ai voucher. È d’accordo?
L’elemento peggiorativo sta nel fatto che, rispetto a una scelta giusta e necessaria, cioè ridurre le forme di precarietà, siamo di fronte ad una norma che le moltiplica e le peggiora.
Proprio ieri Matteo Renzi si è rivendicato il Jobs Act. Possibile che sul lavoro abbia procurato più danni lui dei governi Berlusconi?
Beh, mi soffermo su due aspetti. Con la manomissione dell’art. 18 il governo Renzi ha legittimato il paradigma secondo cui è giustificato che un’azienda licenzi un lavoratore senza giusta causa, un vero e proprio rovesciamento dei rapporti di forza. Un provvedimento con effetti più nefasti di quelli che ebbe la legge Fornero sul mercato del lavoro. Altro aspetto da considerare: il rapporto tra spesa e risultati. Il Jobs Act ha ridotto i diritti dei lavoratori e col tempo si è svelato anche il bluff sull’aumento dell’occupazione che era dovuta alla decontribuzione delle imprese facendo così venire meno la propaganda del governo sui successi della riforma. Quelle risorse pubbliche dovevano essere utilizzate per interventi strutturali capaci di creare nuovi posti di lavoro e crescita del Paese.
Susanna Camusso, come siamo arrivati ai voucher? Veniamo da anni di smantellamento dello Stato sociale, di compressione dei diritti dei lavoratori e di aumento delle forme di precarietà, il sindacato non ha responsabilità su questo sfacelo? In passato la Cgil non poteva avere atteggiamenti meno concertativi?
Sfatiamo una leggenda: se vuole le elenco tutti gli scioperi generali della Cgil dall’approvazione della legge 30 ad oggi. E sono molti. Negli ultimi anni non ricordo una riforma sul mercato del lavoro passata con atteggiamenti dialoganti col governo. Le riforme condivise tra le parti sociali sono un antico ricordo nel Paese. Se c’è un’autocritica da fare l’abbiamo anche fatta riguardo a un’interpretazione che per lungo tempo abbiamo dato, cioè l’idea che le forme di precarietà potessero essere transitorie e non fossero un intervento che avrebbe determinato una strutturalità nell’organizzazione dell’impresa fondata in parte consistente sulla precarietà. Abbiamo invertito la rotta con la Carta dei diritti universali del lavoro, che ha l’ambizione di riordinare la giurisprudenza sul lavoro e dare con essa diritti a tutti i lavoratori siano essi dipendenti, autonomi, precari o altro. Pensiamo che i diritti del e nel lavoro debbano essere in capo alle persone. Contemporaneamente, abbiamo raccolto le firme contro i voucher, che sono l’emblema della nuova frontiera di precarietà perché sanciscono la definitiva destrutturazione del rapporto di lavoro.
Mi vorrei soffermare sull’aspetto generazionale: in Italia gli under 30 si trovano di fronte un mercato del lavoro iper-precario e senza garanzie. Una generazione che, a differenza di quella dei genitori, non conosce il contratto a tempo indeterminato. Da questo punto di vista, non andrebbe riformata l’idea del sindacato, visto che è cambiato il mondo del lavoro, oppure crede che sia sufficiente la Carta dei diritti universali che avete recentemente elaborato?
È indubbio ci sia una questione anche generazionale, ma la rottura di una costruzione dei rapporti di lavoro sta diventando un tema trasversale che riguarda tutti. La precarietà diventa una condizione riproponibile in qualunque momento e a chiunque. Se pensi a un settore come l’agricoltura, dove si hanno dalla diffusione dei voucher al caporalato, non stai parlando solo dei giovani ma di tante figure e contraddizioni: migranti, dumping salariale, competizione tra lavoratori etc...
Rimane il fatto che i giovani non sanno cosa sia un sindacato come la Cgil...
I giovani non conoscono il sindacato in molti luoghi perché spesso il sindacato non c’è, ed è una sua responsabilità, ma in tantissime altre realtà i giovani sono anche al centro delle politiche delle nostre categorie. Penso alla Filcams dove l’età media è attorno ai 30-35 anni. Ragazzi che hanno anche inventato forme nuove di sindacalizzazione e di determinazione della loro possibilità di avere lotte e risultati, rispetto ai diritti.
Il sindacato o si riforma o muore?
Riformare se stessi è sempre essenziale, il sindacato deve evolversi in ragione di come cambia il mondo del lavoro e rispetto alle sfide da affrontare. Bisogna inventarsi nuovi strumenti: ad esempio è una piattaforma lo strumento con cui interloquisci coi lavoratori della gig economy? Come costruire dei luoghi di aggregazione per lavoratori fisicamente dispersi? Sono le domande che ci stiamo ponendo come sindacato. Come ci insegna la storia delle nuove catene, quelle che abbiamo sindacalizzato, per far vivere la Cgil resta essenziale che quei lavoratori entrino intanto in una relazione fra di loro, cioè nell’idea che serva un’organizzazione collettiva, che è esattamente il messaggio opposto di quello che viene socialmente proiettato. L’interrogativo è quali sono i rapporti che tu puoi costruire, su cui stiamo ragionando noi e altri sindacati europei – non è un tema esclusivamente nostro – e su come intercetti un mondo che non ha un luogo fisico di lavoro o è composto da poche persone. Penso sia questa la vera sfida del sindacato.
State pensando ad uno sciopero generale? Abbiamo una faticosa relazione con Cisl e Uil su questo punto di vista e certo si rischia la rottura dell’unità sindacale invocando uno sciopero generale su un tema, come quello dei voucher, sollevato attraverso una raccolta firme soltanto dalla Cgil. Però... non lo escludiamo, sta nei nostri strumenti.
Passiamo ad una questione che a sta a cuore a MicroMega: l’Ilva di Taranto. Lì il sindacato ha fatto prevalere, negli anni, il diritto al lavoro sul diritto alla salute dei cittadini. Almeno di questo vi accusano a Taranto, dove la Cgil ha avuto un calo di iscritti. Fate autocritica? Siete arrivati in ritardo a capire il problema dell’inquinamento dell’Ilva? Sinceramente penso che la salute nei luoghi di lavoro e la salute intorno ai luoghi di lavoro debbano andare di pari passo. È un dato ormai acquisito in Cgil che ha complessivamente cambiato condotta. Inoltre c’è un grande tema che riguarda le norme differenziate nel nostro Paese: non esistono i controlli e questo nodo andrebbe affrontato seriamente per il bene del mondo del lavoro ma anche per l’ambiente, il clima e la salute dei cittadini. Su un punto rimango ferma: la soluzione dell’Ilva di Taranto non passa per la chiusura degli impianti, che significherebbe la sconfitta dell’innovazione verso nuove strade. Penso ai processi di riconversione o alle ricerche per rendere l’Ilva compatibile con l’esterno, salvaguardando così i posti di lavoro e la salute. Nei casi di siderurgia si può intervenire, la chiusura dell’impianto è un simbolo di resa.
Ultima domanda: il dibattito a sinistra. Sabato in piazza con voi ci saranno tutti i partiti della cosiddetta sinistra radicale. Mentre il 18 giugno, il giorno dopo, al teatro Brancaccio di Roma si discuterà dell’appello lanciato da Tomaso Montanari ed Anna Falcone. Qual è il suo giudizio sui confronti in corso?
Come sempre la Cgil è molto interessata all’evoluzione della politica ma esprime delle valutazioni di interesse quando si affrontano i temi del lavoro, per il resto non commento.
Si esponga Camusso... Cosa auspica a sinistra? Vorrei semplicemente una sinistra o un centrosinistra – non mi formalizzo sulla definizione e sui trattini – che abbia il lavoro come perno centrale. Bisogna ripartire da qui. Per troppo tempo il lavoro è stato invece il grande assente del dibattito della politica, anche e specialmente a sinistra.

il Fatto Quotidiano, 16 giugno 2017 (p.d.)
"I voti? Quanti voti? La sinistra ha perso il suo popolo durante i suoi governi, che io chiamo del suicidio. Lo ha regalato all’astensione, alla disperazione, ai Cinquestelle, alla Lega e persino a Fratelli d’Italia. Quindi mi terrei prudente, conterrei le speranze".
Luciano Canfora, il principe della filologia classica e sempre schierato sul limite estremo del pensiero di sinistra, è inesorabile nello stimare le percentuali di successo dell’arcipelago progressista nel caso si ritrovasse unito.
«Forse perché sono troppo vecchio e ricordo il flop dell’unificazione socialista. O perché in mente mi viene lo sfracello di voti che doveva prendere la Margherita quando diede vita al simbolo unico. E poi: flop. Oppure, ricorda?, all’altro sfracello annunciato dal Pd, il partito a vocazione maggioritaria. Walter Veltroni e la Giovanna Melandri ogni sera in tv con questa benedetta vocazione maggioritaria. Si autoproclamavano maggioritari. Mi ricordavano quelli che alla domanda perché il papavero facesse dormire, rispondevano: perché ha la virtus dormitiva. Irresistibile come spiegazione».
Le viene in mente il fallimento delle varie fusioni fredde.
«È la storia che ce lo dice. Anche quando si promosse Rifondazione comunista, e io facevo parte del gruppo di Cossutta, la cosiddetta terza mozione, parvero spalancarsi chissà quali porte, chissà quali praterie davanti a noi. Dopo un po’di tempo le percentuali si assottigliarono fino a divenire quasi irrilevanti».
Quindi Bersani & co non si facciano troppe illusioni.
«Io mi accontenterei della cifra che teme di perdere il Pd, ormai definitivamente partito di centro insieme a Forza Italia. Quel sei per cento che l’avversario Matteo Renzi paventa sarebbe già un bottino significativo».
Il Pd di Renzi?
«Questo partito ha prodotto un aborto. Ora lo votano i nipoti degli elettori democristiani, le élites urbane, i benpensanti. È definitivamente e dichiaratamente un partito di centro.
Se il Pd copre unicamente il centro, facendo concorrenza a Forza Italia, ci sarà dunque una speranza a sinistra? Saranno paragoni inappropriati, ma altrove, dove la sinistra si è presentata nel suo vestito più classico e con i volti persino datati dell’americano Sanders e del britannico Corbyn, il proprio popolo l’ha ritrovato eccome.
Anzitutto si ricordi che in America, e non da ora, esiste un pezzo della sua società illuminato che vota a sinistra. Bernie Sanders ha perso il confronto con la Clinton perché anche lì le primarie sono una buffonata. Però c’è u n’altra verità da riferire: negli Usa la sinistra non ha mai governato. E in Gran Bretagna i laburisti invece non si sono mai suicidati».
Invece in Italia la sinistra, governando, si è suicidata.
«Non so perché si parli con una tale sfrontatezza di ventennio berlusconiano. Silvio Berlusconi ha governato dodici anni, il resto è opera di altri. L’emorragia di voti che ne è conseguita, aver regalato temo definitivamente alla Lega la classe operaia lombarda, o quel che resta di essa, aver prodotto migrazioni bibliche verso i Cinquestelle e financo dalle parti di Fratelli d’Italia è l’esito di un disastro politico».
La sinistra non ha un popolo, dunque, e nemmeno un leader.
«La sinistra ha quel che ha, non la sopravvaluterei. Si affacceranno al voto nuove generazioni, vedremo come voteranno. Sul voto resto cauto. Sul leader possibile aggiungo che non bisogna trovare immediatamente il Giulio Cesare. Il leader deve uscire dal confronto delle idee, dal corpo a corpo nell’agone politico».
Torna in campo persino il nome di Prodi. E Bersani risulta addirittura più popolare di Pisapia. Di nomi nuovi e volti giovani nemmeno l’ombra.
«A parte che Giuliano Pisapia è quasi coetaneo di Pierluigi Bersani e non vedo perché dovrebbe essere più popolare, ma che fesseria è questa dell’anagrafe? Il più giovane presidente del Consiglio che abbiamo avuto si chiamava Benito Mussolini. E ho detto tutto».
 «Il viaggio in Italia va fatto senza ansie di compiacimento o di denuncia. Abbiamo bisogno di creature rivoluzionarie, non di manovali del rancore».
«Il viaggio in Italia va fatto senza ansie di compiacimento o di denuncia. Abbiamo bisogno di creature rivoluzionarie, non di manovali del rancore».
comune.info, 14 giugno 2017 (c.m.c.)
Si potrebbe pensare che l’immiserimento della natura abbia riflessi anche sull’immiserimento della lingua. Oggi le immagini, le parole, i ritmi non sono più suggeriti dalla Natura, ma dalla Rete. E così abbiamo una lingua e una politica che sa di chiuso. Bello sfuggire alla tentazione dello sguardo apocalittico sull’Italia di oggi. Bello cercare i luoghi che non sono stati riempiti, i luoghi che non interessavano a nessuno, quelli poveri, impervi, fuori mano. In questi luoghi l’Italia si dà ancora.
E allora ti puoi stupire guardando il muso delle vacche nel bosco di Accettura, guardando un vecchio in un orto del Salento o un contadino che ara in un pomeriggio sardo. Il viaggio in Italia va fatto senza ansie di compiacimento o di denuncia. Andare in giro, guardare come cambiano città e paesi, Torino oggi è molto diversa da come era negli anni settanta, l’Aquila è una città doppia: la città dei monumenti e quella delle rovine. E doppia è anche Taranto, città di mare circondata dalla città dell’acciaio. Nel guardare l’Italia tenere insieme l’occhio di Leopardi e quello di Pasolini, il Pasolini che teneva insieme Casarsa e Caravaggio, quello che scrisse nel 1959 La lunga strada di sabbia, un viaggio costiero da Ventimiglia a Trieste, un atto di amore verso un’Italia dalle cento province non ancora devastata dal “genocidio culturale” che ha prodotto il paesaggio italiano che attraversiamo adesso.
Non mi piace l’Italia costruita negli ultimi decenni, quella delle città, ma anche quella dei paesi. Mi irrita vedere tante case sparse nelle campagne. E non mi piacciono neppure i paesi imbellettati, quelli con le pietre finte, quelli che non sono paesi, ma trappole per turisti.
L’Italia che cerco è quella che sa di Italia e di altrove. Penso ad Aliano, ai suoi calanchi che mi fanno pensare all’oriente. Mi piace molto l’Italia ionica. Mi piacciono i paesi che hanno un residuo arcaico, un nodo che non si è fatto rovistare dalla modernità incivile.
Sto male negli areoporti, tutta quella gente che crede di andare chissà dove, non mi piacciono neppure i silenziosi viaggiatori della freccia rossa, l’Italia che fila dritta e ignora il canto, ignora che la vita prende spazio quando sbaglia, quando s’incaglia.
Mi piace incontrare i vecchi dei paesi. Sto bene quando li ascolto. Non credo di avere più strada e più di futuro di loro. Il mio secondo è sempre in bilico, nessun attimo in me ha una fiducia assoluta, è come se dovessi ogni giorno patteggiare col tempo un altro poco di tempo. Nel mio girare per l’Italia non perdo mai di vista il corpo. È il corpo che guarda, è il corpo che prende avvilimenti ed euforie, è il corpo che incontra gli altri o li sfugge.
Mi piacerebbe vivere in un’Italia in cui la maggioranza sia fatta di percettivi e non di opinionisti. Non mi piace l’Italia che si è seduta sui divani, quella che guarda la televisione, che va in pizzeria, che tiene il bicchiere in mano davanti al bar, l’Italia dei giovani che prendono la notte a branchi, i giovani che mettono in posa compagnie che non hanno, vicinanze che non ci sono.
Gli Italiani che amo sono quelli che mettono assieme poesia e impegno civile, malinconia e ardore, indugio e frenesia. Abbiamo bisogno di creature rivoluzionarie, non di manovali del rancore. Non mi piacciono gli scoraggiatori militanti, i luminari del disincanto, i piromani dell’entusiasmo. Mi fa schifo il sentire stitico, il rimanere rigidi perfino nel calarsi.Non credo al centro, non credo ai potenti, ai famosi. Credo che il successo sia una forma di sventura, che rovina la pace e la lingua. Mi interessano i paesi e le persone arrese. La resa che non sa di rassegnazione, ma qualcosa che somiglia alla disperazione senza sgomento di cui parla Giorgio Caproni.
Abbiamo bisogno di un’Italia attenta alle cose che coltiva, attenta a quello che accade nelle scuole, negli ospedali. Un’Italia che sa ammirare e sa essere devota, alta e libera, e non laida e meschina.
Credo che non dobbiamo aspettare niente, non dobbiamo aspettarci niente. Nessuno ce la regala l’Italia che vogliamo. Bisogna andare avanti in quello che c’è, sentire la terra sotto i piedi, sapere che ovunque c’è aria e ci sono gli alberi, e c’è tanto da guardare.A me più di tutto danno fiducia questi due gesti: guardare e camminare. Mi pare che possiamo accedere a una qualche forma di grazia fino a quando possiamo guardare e camminare.
Abbiamo bisogno di immettere un po’ di sacralità nella nostra immiserita compagine civile. Non si può andare avanti col gioco del consumare e del produrre. La letizia può arrivare solo dall’amore e dall’immaginazione, viene quando non esci ai caselli stabiliti, ma ti apri all’impensato, sfuggi anche ai tuoi progetti, alle tue mire. Essere umani in un tempo autistico e vorticoso è un mestiere molto difficile. Non ci sono rotte definite, te le devi costruire attimo per attimo, devi cucire e strappare nello stesso tempo, devi capire che stiamo guarendo e stiamo morendo, stanno accadendo le due cose assieme.
Abbiamo bisogno di stare in ginocchio, di pregare, abbiamo bisogno di pensare a Dio, alla morte, alla poesia. Non sono pensieri da poeti, sono pensieri utili per essere buoni cittadini, semplici essere umani che passano il tempo dentro il tempo, che filano la vita per fare un vestito che indosseranno altri.

«L». la Repubblica, 15 giugno 2017 (c.m.c.)
È davvero difficile “orientarsi nel disordine del mondo”, come recita il titolo della Repubblica delle Idee di quest’anno. Perché il disordine, agli occhi dei cittadini, regna sovrano. Complicato dall’incertezza che avvolge il futuro, ma anche il presente, delle persone. Non ci sarebbe bisogno di statistiche per dimostrarlo. Basterebbero gli indicatori del senso comune. Tracciati dalle nostre percezioni. Ricavati dai discorsi della gente. Tuttavia, in questo caso, le statistiche, per una volta, danno fondamento al senso comune.
Per questo mi limito a riproporre dati e indici ricavati da sondaggi condotti da Demos (per Unipolis e per Repubblica) negli ultimi sei mesi. E dunque in tempi recenti. Il 76% degli italiani — dunque: oltre 3 persone su 4 — si sentono gravati da un senso di “insicurezza globale”. Temono, cioè, le minacce che vengono da lontano ma risuonano forte nella loro vita quotidiana, scandite e riprodotte dai media. In primo luogo, il terrorismo che compie i suoi massacri dovunque, in Europa, con attenzione e competenza mediatica. Ma poi, l’impatto della crisi economica, finanziaria, che si riflette sui nostri risparmi e sulla nostra condizione personale e familiare. Minacce lontane e dunque vicine. Che spaventano di più proprio perché non hanno volto e nome.
Ricordo mio padre, anni fa, quando, molto anziano e malato, mi chiedeva, angustiato, preoccupato per i propri risparmi, frutto del lavoro di una vita, e, quindi, della pensione: «Ilvo, ma chi è questo Spread? Che faccia ha? E dove abita? Perché ce l’ha con me? Con i miei risparmi?». Naturalmente non era facile rispondergli. E non lo è neppure oggi. Anzi, lo è sempre di meno. Perché le fonti dell’incertezza si sono moltiplicate. Perché non abbiamo più il privilegio dell’ignoranza. Il significato della globalizzazione è questo, ben evocato da Giddens.
Tutto ciò che avviene dovunque, nel mondo, si ripercuote su di noi. In modo im-mediato. Perché lo vediamo e lo sappiamo subito. Perché i nuovi media, il digitale, ci permettono di re-agire in modo im-mediato. Subito. In modo “digitale”. Con il nostro smartphone. Protagonisti e al tempo stesso bersagli di ogni messaggio. Di ogni informazione, circa ogni evento che avviene ovunque. Tanto più e tanto meglio se ansiogeno. Così e per questo l’incertezza si riproduce. E il mondo ci sembra sempre più largo. Al tempo stesso, più im-mediato e più incontrollabile. Anche perché l’im-mediato ci priva del futuro. Perché, se il futuro è adesso, allora è già passato. Nel momento stesso in cui lo evochiamo e lo sperimentiamo. Il futuro.Immaginarlo, se non prevederlo, sarebbe necessario per ridurre il disordine del mondo. Perché se hai un progetto, allora è più facile saper cosa fare, dove — e verso dove — muoversi.
Ma se il futuro si riduce, fino a venire riassorbito nel “quotidiano”, nell’immediato, allora il disordine prende il sopravvento. D’altra parte il nostro futuro è affidato ai giovani. Ai nostri figli. Ma noi siamo una società vecchia. Sempre più vecchia. Dove si fanno sempre meno figli. Le stesse famiglie di nuovi italiani, gli immigrati, quando si stabilizzano in Italia, assumono i nostri modelli e stili di vita. E fanno sempre meno figli. D’altronde, 3 italiani su 4 ritengono che i giovani nel nostro Paese avranno, nel prossimo futuro, una posizione sociale e professionale peggiore rispetto ai loro genitori.
Per la stessa ragione, una percentuale simile di persone ritiene che i giovani, se ambiscono a fare carriera, debbano lasciare l’Italia. Ed è ciò che effettivamente avviene, visto che da tre anni siamo in declino demografico. Peraltro, i nostri “emigranti” sono, soprattutto, i giovani con maggiori competenze e livello di istruzione più elevato. Per questo rischiamo di divenire sempre più pessimisti. Per ragioni “realiste”. Infatti, se lasciamo partire i più giovani e i più preparati, compromettiamo il nostro futuro. E allora: perché dovremmo essere ottimisti? Peraltro, l’ottimismo declina con l’età. I (più) vecchi difficilmente sono più ottimisti dei (più) giovani.
Eppure, quando chiediamo agli italiani se si sentano “felici”, circa 8 su 10 rispondono in modo affermativo (Demos). Sì: ci sentiamo “abbastanza” felici. E ciò potrebbe sorprendere. Apparire contraddittorio. Come fanno gli italiani ad essere pessimisti e insicuri, ma, al tempo stesso, abbastanza felici? Dipende dalle nostre risorse sociali. E di socialità. Perché l’incertezza si riduce in misura coerente con il nostro “capitale sociale”.
Noi, cioè, resistiamo all’insicurezza ricorrendo alle relazioni sociali. E, in primo luogo, alla famiglia. L’incertezza e le preoccupazione verso il futuro, infatti, si riducono tanto più quanto maggiore è il livello di partecipazione sociale. Ma anche quanto più forti sono i nostri legami di vicinato. La nostra vita associativa. Allora la fiducia negli altri, che da anni tende a calare, riprende a crescere. E il futuro ritorna. Dopo essersi perduto nel passato.
Così, per “orientarsi nel disordine del mondo”, occorre (in)seguire un percorso obbligato. Coltivare la fiducia negli altri. E, dunque, rafforzare i legami con gli altri. Partecipare. Perché “con gli altri” si sta meglio che “da soli”. E la partecipazione aiuta. A stare in mezzo agli altri. A camminare insieme. Verso una meta comune.
 «Oggi, che siamo tutti connessi e illusi di avere radar tentacolari e altoparlanti potenti, abbiamo l’impressione, fondata, di essere inascoltati – il rumore resta un brusio indecifrabile».
«Oggi, che siamo tutti connessi e illusi di avere radar tentacolari e altoparlanti potenti, abbiamo l’impressione, fondata, di essere inascoltati – il rumore resta un brusio indecifrabile».
Libertà e Giustizia online, 11 giugno 2017 (c.m.c.)
L’età dell’indifferenza: questo il titolo che possiamo dare alle ricerche demoscopiche più recenti sullo stato della coscienza politica dei cittadini italiani. Indifferenza, soprattutto nel caso dei giovani tra i 18 e i 34 anni, per le tradizionali divisioni tra destra e sinistra. Lo conferma il Rapporto Giovani 2017 dell’Istituto Toniolo, realizzato in collaborazione con Fim Cisl. I giovani non sono indifferenti alle questioni di giustizia (e di ingiustizia) sociale – alla crescita della diseguaglianza, al declino delle eguali opportunità, al valore tradito del merito personale: insomma agli ideali che dal Settecento in poi sono stati rubricati sotto le bandiere delle varie sinistre. E dunque, in questo senso, non vi è indifferenza per quella divisione antica.
L’indifferenza (comprensibile) è verso i partiti che si sono fin qui incaricati di rappresentare quelle idee di giustizia, e che oggi sono giudicati (giustamente) come misere macchine elettorali, finalizzati a favorire coloro (i pochi) che più sono attratti dall’ esercizio del potere e dai privilegi ad esso associati. Sono le élite politiche, il cosiddetto establishment, a generare la “politica politicata” e, insieme, ad affossare i valori della politica, le ragioni delle politiche di giustizia. Questo è il senso dell’analisi dell’ Istituto Toniolo e delle impressioni che ciascuno di noi si fa navigando online o praticando la quotidiana comunicazione casuale e non premeditata. Osserva Alessandro Rosina, a commento del Rapporto Giovani, come quello dei ragazzi sia «l’elettorato più difficile da intercettare » perché critico della retorica politica e, aggiungiamo, del monopolio del potere della voce che chi è dentro le istituzioni ha e difende.
L’esclusione dalla partecipazione alla formazione delle opinioni, non solo alle decisioni, ha effetti devastanti, perché dimostra come ad essere irrilevante non è solo il voto ma anche la voce dei cittadini.
Avere un blog, postare messaggi, commentare su Twitter: tutto questo partecipare è poco soddisfacente perché non produce effetti. Anche partecipare con le sole opinioni si rivela dispendioso perché senza un ritorno. Che il web serva a darci democrazia diretta è un’illusione. Senza partiti le voci del web restano inefficaci.
E i cittadini lo capiscono. Soprattutto i giovani, abituati ad avere “ritorni” immediati alle loro esternazioni sul web.
E invece la politica resta un muro di gomma, nonostante la facilità delle comunicazioni. Inarrivabile. Anzi, si potrebbe pensare che fino a quando l’arma della partecipazione erano i rapporti faccia a faccia, anche la parola aveva più forza. Oggi, che siamo tutti connessi e illusi di avere radar tentacolari e altoparlanti potenti, abbiamo l’impressione, fondata, di essere inascoltati – il rumore resta un brusio indecifrabile. È questa impotenza a generare demoralizzazione, un malanno grave nella democrazia che è per antonomasia un fenomeno di fiducia nel potere della volontà politica, individuale e associata.
Eugenio Scalfari suggerisce spesso nei suoi editoriali di rileggere Alexis de Tocqueville. In effetti, sembra di un’attualità disarmante: la società come una grande audience, interpellata ad ogni soffio di vento per assicurarsi consenso, eppure senza effetti visibili, testabili. Una grande melassa nella quale la politica – che è invece distinzione di posizioni, partigianeria e schieramento, anche a costo di essere (o sembrare) perdenti – si scioglie in chiacchiericcio poco credibile. È questa l’indifferenza di cui si parla oggi, tra i giovani soprattutto: prevedibilmente, poiché se non c’ è più spazio per il bricolage dei collettivi, allora ci si scaglia contro chi sta dentro le istituzioni. I giovani (e meno giovani) scrive Rosina, «si chiudono» alle grandi idee propositive e «si avvicinano ai partiti anti-sistema come M5S e Lega, che sono quelli che urlano di più». Nella politica audience-melassa è l’urlo che fora il muro di niente. Non crea, ma si fa sentire.
L’ anti-establishment, che l’indifferenza per i partiti e i loro leader hanno partorito e alimentano nel corso degli ultimi anni, è la porta spalancata a quel che con un termine poco preciso viene chiamato populismo, e che sarebbe meglio chiamare anti-partitismo, uomoqualunquismo arrabbiato. A chi vuole arrivare in fretta al potere, questi sondaggi indicano che per cavalcare l’indifferenza occorre imitare la retorica demagogica e qualunquista. A chi vuole riannodare i fili di un desiderio della politica degli ideali, questi sondaggi possono indicare una strada, forse più impervia ma che potrebbe pagare domani: ricomporre un collettivo di persone unite da idee, partigiani coraggiosi che non solo denuncino ma propongano. La lotta per qualcosa che vada oltre la propria persona ha una bellezza alla quale né i giovani né i meno giovani sono insensibili.
 «Esperti e tecnici che si dedicano solo a contare e ottimizzare sono pericolosi».
«Esperti e tecnici che si dedicano solo a contare e ottimizzare sono pericolosi».
L'Espresso, 11 giugno 2017 (c.m.c)
Se è vero che siamo nell'epoca della post-politica, certo non siamo nella post-economia. Ma chi sono gli economisti di cui ascoltiamo le proposte? Bisognerebbe distinguere fra "numeristi" e umanisti. I primi corrispondono a una fantasia che il profano ha dell'economia: una specie di super-ragioneria, che amministra i conti nazionali. Visione falsa. La vera economia, come dice l'etimo della parola, ha per oggetto la vita quotidiana, il governo dei suoi affanni: le misurazioni quantitative ne sono solo uno strumento.
Václav Havel ha chiarito il pericolo della economia "numerista" nella prefazione al testo di T. Sedlácek L'economia del bene e del male (Garzanti). Gli economisti dediti solo a contare e ottimizzare sono pericolosi. Se affidassimo loro l'amministrazione delle orchestre, eliminerebbero le pause dalle sinfonie di Beethoven. Perché pagare i musicisti quando non lavorano? Forse perché, eliminandole, la sinfonia sparirebbe. La mente umana cerca l'armonia: che include l'eccitazione ma anche la pausa.
Il dilemma numerismo-umanismo tocca le grandi questioni economiche, rivelando la loro profonda natura psicologica. Il fisco sta al centro di ogni politica: particolarmente per il cittadino italiano, consapevole dei compiti sociali, eppure – per secolare mancanza di identificazione con lo stato – spesso suo evasore. Immaginiamo un paese A dove le spese pubbliche corrispondano al 40% del prodotto nazionale (PIL). Se A è un paese virtuoso, lo stato imporrà tasse per il 40% del PIL: i cittadini le pagheranno e il bilancio pubblico resterà in pareggio. Immaginiamo ora un paese B. Anche qui le necessità della spesa pubblica corrispondono al 40% del PIL: ma i cittadini in media nascondono metà dei loro redditi. Cosa farà lo stato? Se li tassasse al 40% andrebbe in bancarotta. Sceglierà una tassazione nominale dell'80%. Presumibilmente ne incasserà metà, cioè 40%. Così, anche il paese B manterrà i conti in ordine.
Per il numerista i due sistemi sono equivalenti: sia A che B riescono a pareggiare il bilancio e a fornire prestazioni pubbliche pari al 40% del PIL. Non per quello umanista. I costi numerici sono apparentemente uguali, quelli psicologici ben diversi. In B il cittadino medio dovrà tenere una contabilità doppia per i suoi redditi, ufficiali e nascosti; avrà costantemente paura di confonderli e di essere scoperto; nasconderà i guadagni evasi "sotto il materasso", rischiando di dimenticarli o farseli rubare; spesso rinuncerà a mezzi di pagamento moderni come la carta di credito o il bonifico per internet.
Ma soprattutto, anche se negherà di avere veri sensi di colpa, proverà un disagio indefinibile: qualcosa in lui "sa" che non dovrebbe andare così. Insomma, se risparmierà sulle tasse sosterrà un "costo psicologico" che non è misurabile numericamente, ma è molto alto. Avrà un reddito pari al cittadino di A, ma una qualità della vita decisamente peggiore. Non è finita: anche la sua controparte, il rappresentante dello stato, pagherà costi psicologici seri. Incontrando il cittadino, darà per scontato che questi ha la coscienza sporca. Non potendolo dimostrare, e non potendo nascondere soldi a sua volta, sentirà di essere il babbeo, sacrificato a una maggioranza di furbi; reagirà trattando il cittadino in modo freddo, o altezzoso, o ostile: quando non si farà addirittura tentare dal "ognuno deve pensare a se stesso", chiedendo pagamenti sottobanco. Anche lui sarà spesso di malumore e stressato. Perderà la fede nel suo lavoro e nella società cui esso è destinato. Come un disperato abbandonato dal suo Dio, tanto l'uomo dello stato che il cittadino non "crederanno" più in un ordine sociale, ma nel circolo vizioso della diffidenza.
Se il calcolo della evasione sarà stato corretto, a fine anno i numeri torneranno: ma durante tutto l'anno ognuno avrà vissuto nello stress, perché si basava su una stima indiretta della frode, non su dati certi. E, proprio come la cattiva coscienza, anche l'insicurezza costante ha un alto costo psicologico.
Prendiamo ora un altro esempio. Una valuta stabile è da sempre apprezzata perché evita l'incertezza dei prezzi. È il motivo per cui in tutto il mondo si convertono i risparmi in Dollari o Franchi Svizzeri. Purtroppo, i politici sono eletti per un periodo limitato di tempo. Se l'economia è stagnante, per saziare gli elettori qualcuno propone la svalutazione. Per riavviarla oggi in Italia bisognerebbe innanzitutto tornare alla lira, abbandonata a costo di lacrime e sangue proprio per la sua instabilità. Il politico che la suggerisce si affida però a un numerista, che dimostra con cifre il suo argomento. Se svalutiamo del 20%, sul mercato internazionale le nostre merci costeranno 20% di meno.
Aumenterà l'esportazione: non per maggior fiducia nella produzione del nostro paese (che al contrario si riprenderà la reputazione di esser poco stabile) ma per immediata convenienza (in altre parole: gli stranieri saranno incoraggiati a comprare, ma scoraggiati dall'investire in Italia). Naturalmente molti prezzi internazionali – come quello del petrolio, quotato in Dollari – resteranno invariati: cioè costeranno il 20% in più per noi che abbiamo svalutato. Questo aumenterà sia le spese di chi usa l'auto sia quelle dei produttori: che però ora esportano di più. Logicamente anche i dipendenti vorranno qualche beneficio: il loro costo della vita (che include petrolio e altri beni importati) sta crescendo. Sommando tutti questi aumenti, dopo un po' le nostre merci costeranno un 20% in più. Il vantaggio è svanito. Il numerista interverrà: Svalutiamo ancora, magari del 30%! E, quando avremo esaurito lo slancio, un'altra volta. Insomma, se abbiamo creato un vantaggio esportativo, e poi lo abbiamo perso, abbiamo trovato un equilibrio: la produzione funziona, anche se a singhiozzo.
Non con nuove tecniche, ma con quella del criceto, che crede di viaggiare quando corre nella ruota. Una trappola che ha torturato l'Argentina: che però, non essendo popolata da criceti, è scivolata nella esasperazione. Mentre l'inferno circolare ruota, produttori e dipendenti vivono nell'insicurezza: senza vedere un orizzonte in cui terminerà, perché la via della svalutazione è un viaggio di cui si conosce l'inizio, ma difficilmente la fine. Non potendosi stimare le spese per gli anni futuri, si faranno sempre meno contratti a lungo termine e si programmerà sempre più alla giornata. Questo lascerà cicatrici perfino nel rapporto tra le generazioni, un cui asse portante è lo sguardo dei genitori lanciato verso il futuro dei figli.
Impariamo anche questo dal Sud America, dove continue inflazioni hanno disabituato a pensare se stessi nel futuro lontano: in qualche caso contribuendo addirittura alla diffusione dell'Aids, perché la malattia si manifesta solo nei decenni. Alla lunga, qualunque costo psicologico viene presentato all'incasso: quelli della manipolazione numerica sono silenziosi veleni. Governare gli uomini come se fossero numeri e non psicologia è l'errore più grave che i politici possano commettere.
 «Anche in questo caso sembra prevalere la figura che Alain Deneault ha definito lo “stupido funzionale”».
«Anche in questo caso sembra prevalere la figura che Alain Deneault ha definito lo “stupido funzionale”».
doppiozero, 11giugno 2017 (c.m.c.)
Dunque alla fine appena un pugno di voti (13,6 milioni contro 12,8) e un paio di punti percentuali (42,4 a 40) separano i Conservatives dal Labour. Anzi Theresa May da Jeremy Corbyn, perché nel bene (il secondo) e nel male (la prima) sono stati loro due a giocarsi la partita. Nemmeno lo sciagurato maggioritario secco inglese, che allunga in modo sproporzionato le distanze in termini di seggi (una sessantina in più al partito “maggiore” anche se di poco) stravolgendo il principio di rappresentanza, assicura una governabilità certa (mito di tutti gli aspiranti oligarchi). Il parlamento britannico rimane hang, “appeso” come si dice in gergo: in questo caso appeso all’alleanza con gli unionisti irlandesi del DUP (Democratic Unionist Party), che – se la May sopravviverà al voto di fiducia - sosterranno (“caso per caso”) il futuro governo conservatore come la corda sostiene l’impiccato, garantendogli con i loro 10 seggi una risicatissima maggioranza (di 2 voti).
Sono fondamentalisti protestanti, ultrareazionari, antiabortisti, omofobi (“right-populists” sono definiti), nemici degli human rights, secondo l’imprinting impostogli negli anni settanta dal fascistoide reverendo Paisley, che lo fondò (insieme alla propria milizia paramilitare) per opporsi strenuamente a ogni tentativo di soluzione concordata della questione irlandese. Non i migliori compagni di strada sul difficile sentiero della Brexit.
Ma quello che colpisce, della straordinaria giornata elettorale inglese, e soprattutto della notte che ne è seguita, è il generale rovesciamento di tutte le premesse (e di tutte le promesse). Nulla è andato come previsto all’inizio della campagna. Theresa May le ha “chiamate”, queste elezioni “fuori tempo” e non dovute, senza in realtà averne alcun bisogno. Stava seduta su una propria maggioranza - 330 seggi -, ma per un attacco di bulimia parlamentare ne voleva di più, “voleva tutto”, convinta di poter banchettare con i resti di un’UKIP a cui aveva rubato la bandiera e di poter sfondare su un Labour messo fuori gioco dall’"ingenua” leadership di un uomo considerato anacronistico. È finita a gambe all’aria, perdendo 12 seggi, la maggioranza parlamentare e anche la faccia. Si era giocata la campagna elettorale sullo slogan STRONG AND STABLE: è finita debolissima e totalmente instabile. Voleva affrontare gli “euro-oligarchi senza popolo” di Bruxelles armata di un plebiscitario mandato popolare per imporre manu militari la propria hard brexit. Si trova azzoppata, sola e soprattutto male accompagnata a dover affrontare i sorrisini ironici nelle stanze europee, e le andrà bene se alla trattativa ci arriverà, o se non verrà sostituita durante il suo corso.
Dall’altra parte Jeremy Corbin “il rosso”. Il vincitore morale. L’uomo “del miracolo”. Quello che all’inizio, quando il Labour era dato nei sondaggi sotto di 20-25 punti, tutti guardavano con neanche malcelato scherno, l’ "inadeguato”, il “perdente per vocazione”, l’"obsoleto” – magari simpatico nella sua innocenza ma votato irrimediabilmente al disastro suo e del partito che irresponsabilmente era stato chiamato a guidare -, e che invece li ha stupiti (e dimostrato stupidi) tutti. Ha guidato, in meno di due mesi, una rimonta che non ha precedenti nella storia elettorale, ricuperando giorno dopo giorno punti percentuali, a catena, fino a sfiorare il pareggio se non il sorpasso (cosa sarebbe successo se avesse avuto a disposizione un altro paio di settimane, visto il ritmo assunto dalla rincorsa negli ultimi giorni: in fine velocior). Ha guadagnato al suo partito 3 milioni e mezzo di voti in più rispetto alle elezioni del 2015 (Ed Miliband ne aveva presi 9,3 milioni). Ne ha aumentato il peso di 10 punti percentuali (dal 30% del 2015 al 40%, appunto: uno scatto in avanti paragonabile a quello compiuto nel 1945 dal Labour di Attlee). Ha riconquistato 30 seggi, salvando il posto in parlamento anche a un bel po’ di notabili del suo partito che l’avevano considerato con sufficienza e qualcuno anche tentato di sfiduciarlo per nostalgia blairiana.
E quanto a Tony Blair è bene ricordare (soprattutto ai suoi nostalgici, quelli che pensano che se ci fosse “ancora Lui” sì che le cose andrebbero diversamente…), che al suo ultimo mandato, nel 2005, non andò oltre i 9 milioni e mezzo di voti (3 milioni e passa meno di Corbyn) e vinse solo perché il suo competitor conservatore Michael Howard era peggio di lui e convinse solo 8,7 milioni di elettori (partecipò al voto allora solo il 61% degli aventi diritto, contro quasi il 70% di oggi).
Tra le tante possibili, due chiavi di lettura mi sembrano, a caldo, prioritarie. La prima è la “questione sociale”. O meglio la questione della società. Margaret Thatcher – la vera lady di ferro a cui la May si ispira – aveva dichiarato che “la società non esiste. Esistono solo gli individui”. Jeremy Corbyn, oggi, la smentisce. Rianimando, con il proprio programma aggressivamente “sociale”, una società non estinta ma costretta al mutismo dall’assenza di politiche adeguate, la rimette al centro della scena. Cambia il volto – o meglio lo scenario – della politica britannica. Riconfigura il discorso politico intorno ai suoi “fondamentali”, alla materialità dei suoi processi, anziché alla sua dimensione mediatico-virtuale.
La cifra del suo “inimmaginabile” successo (inimmaginabile per chi vive dentro la bolla virtuale del racconto prevalente) sta nella centralità assegnata nell’ordine del suo discorso ai bisogni, alle domande, al disagio diffuso della “propria gente” e di una parte ampia del proprio “popolo”. Nel suo ritorno a un’origine della sinistra moderna che non si è del tutto estinta ma solo atrofizzata: la vocazione a rappresentare la parte non privilegiata della piramide sociale, il mondo del lavoro e le classi medio-basse: la parte che ha subito il trentennio neo-liberale, che non è più stata né vista né raccontata e tantomeno rappresentata da nessuno in queste “trenta ingloriose”, e che ora ha ritrovato una voce e un “padre”. E’ rientrata, come espressione sociale, in gioco. E insieme ai “bisognosi” il vecchio Corbyn ha riportato in campo i giovani: sta al 66% dei consensi tra quelli sotto i 34 anni (quelli di classe media, acculturati e addottorati, ma anche quelli di periferia, di slum), parlando loro col linguaggio dei rapper arrabbiati, apparendo finalmente “vero” tra tanti avatar che popolano la terra straniera della politica per chi vive tra le pieghe e le piaghe del quotidiano.
Se è vero che il neo-populismo che si aggira come il vecchio spettro per l’Europa (e non solo), è la “forma informe del vuoto lasciato dalla sinistra nel passaggio oltre il Novecento” (e io credo che sia vero: è la tesi centrale del mio ultimo libro), allora bisogna dire che l’operazione inglese di Jeremy il rosso ne è il principale antidoto. È il fattore che può riportare la dialettica politica a un suo ordine conflittuale razionale, prosciugando quell’immenso serbatoio di un’ira non dilazionabile né riconducibile a costruzione di un’alternativa (tale è la sindrome populista, dall’incubo americano con Trump alla parabola dell’UKIP inglese fino al nazionalismo sovranista lepeniano in Francia).
Corbyn si prende quasi tutta Londra, l’area metropolitana dove il Remain aveva stravinto, le constituencies dei quartieri centrali (tranne quelli degli straricchi, soldi e status, come la City) e quelle dei sobborghi, compresi i più problematici dove la rabbia urbana si era orientata sul Leave). Vince nei distretti industriali del Galles, old working class anch’essa schierata per la Brexit, e a macchia di leopardo nelle midlands, tagliando a metà gli schieramenti referendari grazie al nuovo cleavage sociale chiamato a incrociare e neutralizzare quello neonazionalistico e identitario.
È quanto non ha capito la May, la quale invece ha fatto un mortale errore di calcolo quando ha voluto anticipare il voto pensando di potersi aggregare così, grazie alla sua linea hard sulla Brexit, tutto il voto Ukip, considerato espressione di un neo-nazionalismo asociale, o di una vocazione identitaria nazionale e neo-imperiale priva di radici e di motivazioni nell’assetto della società e nelle sue contraddizioni. Non è stato così: la radice “sociale” – il radicamento nel disagio e nella protesta per le proprie “condizioni materiali” del voto per il Leave – è riemersa e si è presa la propria rivincita distribuendo i voti in uscita dall’UKIP lungo la loro discriminante profonda, materiale, e convergendo non solo su un partito conservatore ultra-nazionalista ma anche su un partito laburista di nuovo socialmente rappresentativo e conflittuale.
Il che ci porta alla seconda chiave. Meno nettamente definibile, ma non per questo meno visibile. Non so bene come chiamarla: “Cognitiva”? “Intellettiva”? “Mentale”? Mi viene in mente un passaggio dell’ultimo libro di Luciano Gallino – un testamento, per certi versi – che mi colpì molto quando lo lessi: si riferiva ai due crucci che, in quel suo ultimo tratto di vita, lo tormentavano e che indicava come il “trionfo della stupidità” e la fine dello “spirito critico”. Il primo, soprattutto mi è tornato in mente, nella giornata e nella serata di giovedì 8 giugno, seguendo sulla BBC lo spoglio in diretta da Londra, ma anche sulla stessa rete l’interrogatorio di Comey a Washington, e – si parva licet – l’esito caotico del voto sulla legge elettorale a Montecitorio. Ovunque messaggi da “teoria del caos”. Perdita di controllo sugli eventi. Tendenziale entropia. E su tutto l’insufficienza – meglio, l’"inadeguatezza” – delle classi dirigenti, spinta fino all’autolesionismo.
Al suicidio neppur troppo assistito. Verrebbe da dire la “stupidità” delle classi dirigenti. Stupidità non in senso letterale, come deficit di QI (in qualche caso anche questo), ma in senso funzionale. Incapacità di comprensione strategica. Di misurazione delle conseguenze del proprio operare se non nel tempo brevissimo o istantaneo. Di previsione sistemica. Così è stato per Theresa May, ma allo stesso modo era stato per David Cameron, che aveva lui stesso indetto il referendum sulla permanenza in Europa che ha decretato la sua rovina; e per Matteo Renzi con la riforma costituzionale e il referendum che allo stesso modo di Cameron l’ha travolto (anche se lui a differenza dell’altro non è sparito dalla scena politica come aveva invece annunciato e promesso).
E così sta avvenendo con Donald Trump negli Usa, che prometteva un’America Great Again e che la sta portando nella peggior crisi istituzionale della sua storia. O per Hollande, che in cinque anni di Presidenza (apparentemente un punto di forza per un politico di mestiere) è riuscito a distruggere il proprio partito conducendolo all’irrilevanza. E l’elenco potrebbe allungarsi. In tutti questi casi quella che sembra prevalere è la figura che Alain Deneault (filosofo canadese dalla penna tagliente) ha definito lo “stupido funzionale” o come sintetizza nel titolo il “mediocre”: uno che fa tutto quello che sembra al momento giusto, perché così è richiesto dai suoi pari, e che però produce come risultato disastri (per sé e per gli altri).
“Non c’è stata nessuna presa della Bastiglia – scrive Deneault -, niente di paragonabile all’incendio del Reichstadt, e l’incrociatore Aurora non ha ancora sparato un sol colpo di cannone. Eppure di fatto l’assalto è avvenuto, ed è stato coronato da successo: i mediocri hanno preso il potere”. E quando parla di potere pensa a quello economico, banca e finanza soprattutto; a quello universitario (le pagine sulla degenerazione dell’universo accademico sono tanto più feroci quanto più espressione di un’esperienza vissuta); a quello giornalistico ed editoriale; oltre naturalmente a quello politico.
L’ambito in cui l’impatto della mediocrità in quanto “stupidità funzionale” è più devastante. Ed è il prodotto temo “sistemico” – dunque scarsamente contrastabile con misure di semplice restyling istituzionale o con settoriali “riforme” – di un fondamentale meccanismo della nostra vita pubblica: la sconnessione drammatica tra livello istituzionale e livello sociale. Per dirla con Carlo Galli, nel suo ultimo interessantissimo libro sulla Democrazia senza popolo, il fatto – terminale – che “le istituzioni stanno funzionando senza saper analizzare la realtà sociale (e quindi senza saperne risolvere i problemi) e anzi respingendola come un fattore di disturbo e cercando di sopperire con ‘narrazioni’ agli esiti disastrosi delle politiche che impongono”.
Si spiega solo così, con questa secessione dell’"alto” e del “dentro” (all’interno delle casematte del potere istituzionale ma anche mediatico) rispetto a tutto ciò che sta in “basso” e nel “fuori” (da quei cerchi magici che sembrano possedere il monopolio della validazione sociale), da una parte l’ostilità senza risposta, spesso il rancore, il deficit di rappresentanza che produce le tante “insorgenze” cosiddette populiste. E dall’altra parte la vacuità, l’inefficacia, la contraddittorietà e l’insensatezza del discorso “ufficiale”, delle “verità sistemiche” assunte dalle “sedi autorevoli” e propagate dai media mainstream ma puntualmente smentite dall’evolversi dei fatti.
La nostra memoria pubblica è corta, effimera, ma non più di un paio di anni fa, quando l’ondata giovane alle primarie del Labour aveva portato alla leadership Corbyn, il coro degli autorevoli si era scatenato, nelle forme più pittoresche: si andava dal “Corbyn … perderà a manetta” (Gianni Riotta) a “Al Labour piace perdere” (Matteo Renzi) fino al “Chi sarà più felice, Ken Loach o Cameron?” (Sergio Staino)… Tutti chiusi nel proprio involucro stagno, impegnati a confermarsi a vicenda nella damnatio imaginis dell’unico che da quella loro bolla stava fuori, e per questo poteva indicare una via diversa. Difficilmente rinunceranno a pontificare ancora. Ma più difficilmente potranno continuare a monopolizzare la comunicazione pubblica e impedire di “cercare ancora” uno spiraglio di alternativa.
Micromega online, 10 giugno 2017
Il patatrac del sistema elettorale finto tedesco, ah quanti guai in Italia a voler imitare la Germania, allontana la data delle elezioni. Questo forse depotenzierà l'urgenza della
proposta di Anna Falcone e Tommaso Montanari, ma permetterà un confronto più rigoroso su di essa, senza l'assalto soverchiante di tutti quelli che: "mamma mia come superiamo il 5%?".
Non basta affermare che una proposta di sinistra unita debba essere nuova perché essa effettivamente lo sia. Dal 2008 queste proposte si susseguono, spesso con le stesse premesse e gli stessi risultati, catastrofici. Le liste della sinistra unita hanno sempre fallito il loro obiettivo elettorale tranne che alle elezioni europee, dove la lista Tsipras ha superato lo sbarramento, salvo poi frantumarsi un minuto dopo il voto, come le precedenti esperienze sconfitte.
Quindi il primo elemento di novità della proposta dovrebbe essere quello di non ripetere le esperienze del passato e di porre condizioni e discriminanti affinché il nuovo sia davvero tale. Sinceramente, non trovo chiarezza sufficiente al riguardo nel testo di Falcone e Montanari.
Si parte dalla Costituzione, anzi dalla sua anima sociale e antiliberista affermata meravigliosamente dall'articolo 3, e si sostiene che si deve prima di tutto rispondere a quel popolo di sinistra che in nome di quell'anima ha votato NO il 4 dicembre. Benissimo, questo però significa esplicitare subito alcune discriminanti.
Prima di tutto non possono essere interlocutori di questa proposta coloro che hanno votato SÌ, per capirci sono fuori Giuliano Pisapia e Romano Prodi. Il problema si pone però anche verso chi ha votato NO, ma prima ha sostenuto il Jobs Act, la legge Fornero e soprattutto quella mina ad orologeria contro i principi sociali della Costituzione, quale è il nuovo articolo 81 che obbliga al pareggio di bilancio in ottemperanza al mostruoso Fiscal Compact.
Durante il governo Monti il parlamento quasi unanime ha costituzionalizzato quella austerità che giustamente Falcone e Montanari vogliono rovesciare. E se non sono solo buoni propositi, la rottura con l'austerità significa soppressione immediata delle misure che emblematicamente la realizzano. Chi le ha votate naturalmente può ammettere di essersi sbagliato e sostenere un programma che proponga di cancellare quelle misure, ma lo deve fare con rigore e sofferenza e non per furbizia.
Jeremy Corbyn ha riconquistato fiducia nel mondo del lavoro, dopo essere stato svillaneggiato dalle sinistre liberali e dai loro mass media, accettando il voto sulla Brexit e proponendo un programma secco di nazionalizzazioni. Questa parola da noi è tabù nei sindacati confederali e anche in buona parte della sinistra più radicale, eppure è proprio sul terreno delle privatizzazioni che si gioca la possibilità di arrestare e veder dilagare ancora le politiche economiche liberiste. Alitalia e Ilva sono i primi banchi di prova, poi seguiranno le Poste, le Ferrovie, Enel ed Eni e naturalmente ciò che resta del sistema bancario. O torna l'intervento pubblico diretto nell'economia, o da noi va tutto in mano alle multinazionali, visto che la grande borghesia italiana non esiste più come classe autonoma dai poteri della globalizzazione. O il pubblico, o si e si svende ciò che resta del paese, questa è l'alternativa reale oggi e che scelta fa al riguardo la sinistra prefigurata da Falcone e Montanari?
Lavoro con diritti, scuola pubblica e stato sociale, ambiente, territorio e beni comuni sono dichiaratamente al centro della proposta di nuova sinistra. Anche qui possiamo solo dire giustissimo, ma dobbiamo però aggiungere: che misure concrete si vogliono subito attuare, che leggi si vogliono cancellare, che nuovi atti si vogliono varare? Naturalmente ci sono programmi decennali da individuare, ma il buongiorno si vede dal mattino, ad esempio dall'impegno a cancellare tutta la buona scuola e la controriforma della sanità, a quello a fermare tutte le grandi opere, a partire dalla famigerata Tav in Valle Susa. Non è solo questo che basta, ma è questo che serve per capire se si vuol fare sul serio.
Il bilancio delle spese militari dello stato italiano è in continua ascesa e Gentiloni si è impegnato quasi a raddoppiarlo per raggiungere quel 2% del PIL posto dagli accordi NATO. Si ribalta questa scelta nel suo opposto con il taglio delle spese ed il ritiro dalle missioni all'estero, o ci si accontenta di partecipare alla sfilata del 2 giugno con la spilla della pace? Anche qui le scelte programmatiche, che Falcone e Montanari pongono giustamente come discriminanti, se sono vere individuano già di che pasta e di quali persone dovrebbe essere composta la nuova sinistra.
Che alla fine dovrà misurarsi con la questione di fondo: le politiche del lavoro, dell'ambiente e dello stato sociale, in alternativa alla austerità e alle spese di guerra, sono realizzabili accettando i vincoli UE e NATO? Noi che abbiamo costituito Eurostop pensiamo di no, che senza la rottura con quelle istituzioni nulla di buono sia possibile per i poveri e gli sfruttati. Noi pensiamo così, ma siamo disposti ad accettare la sfida di chi invece pensa che quelle istituzioni siano positivamente riformabili. Chi crede a questo però deve essere disposto a rompere se poi dovesse verificare che il suo programma è posto all'indice proprio da quelle istituzioni. E deve dirlo.
Chi ha votato NO il 4 dicembre non può dimenticare che tutta la governance europea si era spesa per il SI. Né può ignorare che la Costituzione del 1948 e i trattati di Maastricht e Lisbona sono formalmente e concretamente incompatibili. Si può non volere la rottura con la UE nel programma, ma si deve essere disposti a farla se le istituzioni comunitarie quel programma ti impediscono di realizzarlo. Tsipras tra il rispetto del referendum popolare e quello dei diktat della Troika ha scelto il secondo. La sinistra proposta da Falcone e Montanari è disposta a fare la scelta esattamente opposta?
Siccome nel testo di Falcone e Montanari non ho trovato risposte chiare a domande per me decisive per capire cosa essi vogliano fare, mi sono permesso alcune di quelle domande di formularle io. Mi permetto di suggerire ai due estensori dell'appello di parlarne esplicitamente nell'assemblea del 18 giugno. Magari si affermi l'opposto di quanto scritto qui, ma per favore si faccia chiarezza. E non si parli d'altro per favore, sappiamo tutti che i nodi sono questi e non si sciolgono coprendoli di grandi valori e buoni propositi.
il manifesto, 10 giugno 2017 (c.m.c.)
Dalla riproposizione di un maggioritario ormai privo di ogni appeal e di qualsivoglia praticabilità alla disinvolta rincorsa di proporzionali di importazione, di risulta o misti. Con la sola preoccupazione di arrivare al più presto al voto e di non intaccare il potere degli apparati di designare i futuri parlamentari.
Poi, in un giorno, è di nuovo cambiato tutto. La spallata referendaria del 4 dicembre, che ha chiuso una stagione politica fallimentare, non ha travolto – né era realistico pensarlo – un’idea di politica e un ceto di governo. E oggi il re è nudo. È in questo contesto che si colloca l’appello di Falcone e Montanari per un soggetto politico a sinistra del Pd: proposta interessante, soprattutto per il suo collocarsi nel solco della vittoria referendaria del 4 dicembre, ma non a qualunque costo, essendo sempre in agguato – come mostrano le prime reazioni – letture che tendono a riportarla nella prospettiva di un centrosinistra morto e sepolto o nella pura sommatoria dei vari (e non rigogliosi) cespugli nati fuori dal suo recinto.
Per non ripetere esperienze del passato ci sono alcune condizioni.
1) Prima i contenuti, poi gli schieramenti
Nella costruzione di un nuovo soggetto occorre abbandonare ogni logica di schieramento e puntare esclusivamente sui contenuti. Tanto più se si voterà con un sistema proporzionale (come è di fatto il Consultellum), il punto fondamentale sarà portare in Parlamento posizioni chiare e impegnative da immettere nel confronto politico in una prospettiva di medio termine e non di (irrealistiche) immediate alleanze. E il ricatto del “voto utile” o del “meno peggio” perderà di senso, qualunque sia la soglia di sbarramento.
2) La grande questione della diseguaglianza
Sui contenuti, la grande questione, evidenziata nell’appello di Falcone e Montanari, è quella della disuguaglianza, accentuata a dismisura dalla crisi. Alcuni – le destre, il Pd e i suoi satelliti – la considerano, nei fatti, un dato inevitabile, se non positivo, e ritengono che la ricetta per uscire dalla crisi sia interna al liberismo e che non possa prescindere dalla riduzione della spesa pubblica, dall’abbattimento dello stato sociale, dalla diminuzione delle tutele del lavoro, dall’espansione del privato, dall’investimento in opere faraoniche: è una linea politica che viene da lontano e solo chiudendo gli occhi si può pensare che, senza una sconfitta elettorale, possa cambiare nei tempi brevi.
Altri pensano che la strada sia quella opposta, cioè una rinegoziazione delle politiche europee a partire della esigenze dei paesi del Sud e un nuovo corso (finanziato con il taglio delle spese militari e di quelle per le grandi opere, una imposizione fiscale equa ed efficiente, il recupero delle risorse concesse a fondo perduto alle banche) fondato su un piano di interventi pubblici sull’obiettivo della piena occupazione, sulla razionalizzazione del welfare, sul reddito di cittadinanza, sulla riconversione ecologica, sul riassetto del territorio e delle infrastrutture del paese, sulla valorizzazione delle migrazioni e via elencando.
Sono due prospettive inconciliabili tra cui non esistono vie intermedie. Occorre scegliere in maniera esplicita senza furbizie tattiche (e il voto inglese di ieri mostra che una scelta netta può essere pagante anche in chiave elettorale);
3) Una forte discontinuità
Non si va da nessuna parte senza una forte discontinuità in punto di metodo, persone, linguaggio. Una discontinuità che accantoni apparati impresentabili (anche al di là delle loro reali responsabilità) e sappia aggregare movimenti, associazioni, singoli, amministratori di piccole e grandi città in un progetto di rinnovamento delle stesse modalità della rappresentanza.
Una discontinuità che sappia anche fare i conti con un sistema comunicativo semplificato, assertivo, spesso demagogico che non ci piace ma da cui non si può prescindere (pur mantenendone il necessario distacco critico). Già sentito, certo, e più volte. E negli ultimi dieci anni vi si è risposto con proposte verticistiche, burocratiche e perdenti come quella della Sinistra Arcobaleno del 2008 e di Rivoluzione civile del 2013… Cosa autorizza a pensare che, oggi, si possa voltar pagine?
Un punto di partenza c’è: la mobilitazione referendaria che ha dimostrato come, qualche volta, l’impossibile diventa possibile.
4) Le buone idee non bastano, serve l'organizzazione
C’è un ultimo problema. In tutti i recenti tentativi di costruzione di esperienze alternative ci si è mossi sul presupposto che le buone idee siano da sole capaci di produrre l’organizzazione necessaria (e sufficiente).
Non è così. Lo dico pur consapevole, da vecchio movimentista, delle degenerazioni burocratiche e autoritarie che si annidano nell’organizzazione. Contro queste derive va tenuta alta la guardia ma la sottovalutazione del momento organizzativo (e della sua legittimazione) è stata una delle cause principali della rissosità e della inconcludenza di molte aggregazioni politiche ed elettorali dell’ultimo periodo, a cominciare da quella di “Cambiare si può” (nata con grande entusiasmo e partecipazione ma presto paralizzata dalla mancanza di luoghi di decisione e, per questo, diventata facile preda di una nefasta e alienante occupazione).
C’è – pare – un po’ di tempo prima delle elezioni: sarebbe bene sfruttarlo sin dal 18 giugno.
 Left, 9 giugno 2017 (c.m.c.)
Left, 9 giugno 2017 (c.m.c.)
Perché elezioni anticipate? E chi decide che debbano essere anticipate? È paradossale che non appena i maggiori partiti si sono accordati per darci una legge elettorale si sentono legittimati a mettere in circolo l’idea di andare a elezioni anticipate subito, appena dopo l’estate. Perché non aspettare la fine naturale della legislatura? Ha una qualche giustificazione questo anticipo? Ha la stessa giustificazione, di quella di colei che, comprando un cappotto in estate per approfittare dei saldi lo voglia indossare subito, proprio perché appena comprato.
Vannino Chiti su Huffington Post ha scritto con molta ragione a proposito della poca cultura costituzionale che anima gli attuali partiti. «Può darsi che sia fuori moda – scrive Chiti – ma per me il rispetto delle regole e della Costituzione resta fondamentale: non si può ridurre, in un accordo tra partiti, a quello di semplice notaio il ruolo del presidente della Repubblica. Spetta a lui fissare la data delle elezioni! Non si può, in incontri tra Forza Italia e Pd, stabilire il giorno di conclusione per l’approvazione della legge elettorale, dimenticando che spetta farlo alla Conferenza dei capigruppo convocata e diretta dal presidente del Senato. Oltre al 7 di luglio, è stata decisa anche l’ora?».
Gli attori politici di questa fase storica sono mediocri e deludenti, e la causa non è l’esito del referendum del 4 dicembre. Se fosse passato il Sì, i partiti non sarebbero per incanto diventati “partiti politici” propositivi e di buon conio; sarebbe restati esattamente gli stessi ma così ingombranti (quelli al governo, soprattutto) da poter permettersi di essere mediocri con protervia.
Oggi, che devono dimostrare sul terreno di essere forze politiche capaci nella loro diversità di avanzare proposte che siano diverse e capaci di produrre risultato, oggi, i partiti mostrano la loro pochezza, che cercavano di nascondere scaricando i problemi sulla Costituzione. Sono partiti “cartello” – cioè tutti loro prima di tutto istituzionali ed essenzialmente parlamentari – con addentellati sociali labili e spesso assenti, e con uno sforzo che è solo volto ad avere pubblicità, ma senza lasciar intendere ai cittadini-elettori quale prodotto offrono che non sia anche offerto dagli altri.
Il mainstreamismo è la malattia dei partiti apparato elettorale: loghi (non luoghi) simbolici e strutturalmente quasi inesistenti e leggerissimi, vuoti di idee-principi portanti che riescano a dare visibilità non solo ai loro leader e leaderini.

il manifesto, 8 giugno 2017, con postilla
In vita mia, – ormai piuttosto lunga, direi, – penso che non mi sia mai capitato d’imbattermi in una situazione politico-istituzionale come quella cui stiamo assistendo in Italia da alcune settimane, e che avrà fra poco la sua ultima sanzione e ricaduta. Intendo l’accordo di ferro stretto fra i quattro maggiori partiti italiani, il Pd, Forza Italia, Movimento 5Stelle e Lega Nord, - per varare una nuova legge elettorale e andare di corsa al voto. Sì, certo, nel 1953 il tentativo della Dc di far passare la cosiddetta “legge truffa”… I pericoli corsi dalla Repubblica nel 1960 con il governo Tambroni… L’ascesa al potere nel 1992 dell’esecrabile Berlusconi… Sì, certo, tutto questo e molto altro è già accaduto nel nostro instabile e stravolto paese. Ma la differenza, rispetto alla situazione di oggi, è che in tutti questi altri casi esisteva un’alternativa, un punto di riferimento visibile e consistente, in grado di opporsi ai disegni eversivi che attraversavano la nostra repubblica.
Oggi no, non c’è, o non si vede, o non ha abbastanza forza, per ora, per farsi vedere. Ciò consente, - e questo è un dato incontestabile sul piano pratico-storico, - di procedere d’amore e d’accordo tra quattro forze politiche (apparentemente) fra loro opposte allo scopo di realizzare una rivoluzione, appunto, politico-istituzionale, da cui sarà estremamente difficile tornare indietro.
Naturalmente tutto questo non sarebbe stato possibile, se non fosse il prodotto di un processo globale che viene avanti da anni (con responsabilità ampiamente diffuse anche nelle attuali minoranze); e cioè il mutamento di natura e di destinazione di quelle forme collettive che sono state il cuore del sistema democratico in Italia, in Europa e nel mondo, e cioè i partiti politici. Concepiti all’origine, e poi vissuti a lungo, con ideologie spesso contrapposte ma con modalità sostanzialmente omologhe, come espressione di larghi (o comunque significativi) settori della società contemporanea, essi hanno perduto a poco a poco questa funzione di rappresentanza allargata e sono diventati strumenti di ristretti gruppi dirigenti, anzi, nell’ultima e più significativa fase, semplicemente di un uomo solo.
Questo, forse, nella situazione italiana non è stato colto ancora fino in fondo. Nella gestione dei partiti si è fatta avanti, e alla fine si è imposta, la pratica di una categoria eminentemente privatistica come quella dell’utile riservato a uno solo, e da lui compiutamente e ormai incontestabilmente gestito (persino con una distribuzione, che si direbbe percentuale, degli utili fra i fedeli). Ha cominciato Berlusconi; ha continuato, con indiscutibile genialità creativa, Grillo; Salvini è puramente e semplicemente nato da questo; e Matteo Renzi, a colpi di primarie, ha plasmato il Pd su tale modello, talvolta sopravanzandolo nell’audacia delle proposte innovative.
Si capisce dunque perchè “i quattro dell’Orsa maggiore”, presunti protagonisti di una lotta morale fra loro nella vita politica italiana, si siano trovati così facilmente e rapidamente d’accordo su caratteristiche e finalità della legge elettorale, di cui in questi giorni si sta parlando. Il fatto è che essi hanno un interesse comune, che va ben al di là delle possibili (e peraltro molto ipotetiche) differenze di linea. Questo interesse comune consiste nel procurare e ottenere che la situazione prima sommariamente descritta, - partiti di natura profondamente diversa rispetto a quella lasciataci in eredità dalla tradizione, - diventi parte integrante del sistema istituzionale italiano: mediante una legge elettorale che ne consenta la perpetuazione, al di là dei limiti normalmente concessi all’avvicendamento delle forze politiche di governo.
Non entro nel merito dei particolari più tecnici della futura legge elettorale, perché voci più esperte della mia lo hanno già fatto e senza dubbio continueranno a farlo, ma mi soffermo sui punti per me più qualificanti.
1) La scelta, indiscussa e indiscutibile, da parte del Sovrano (capilista bloccati o no), degli individui, - di tutti gli individui, - che andranno a rappresentare il suo Partito, - che andranno a rappresentare lui medesimo, - in Parlamento;
2) La cancellazione di qualsiasi altra forza di rappresentanza popolare, che, affiancata o contrastante con le quattro principali forze politiche, ne metta in pericolo in qualche modo, – anche limitatamente, anche discrezionalmente, - la egemonica rappresentanza di quell’area;
3) La riduzione del sistema politico italiano ai quattro partiti facitori della nuova legge elettorale , in maniera che, dopo il voto, sia lasciato indiscussamente a ognuno di loro il gioco delle maggioranze e delle minoranze il patto del Nazareno, che anticipò eloquentemente queste conclusioni della legislatura, potrebbe essere uno di modi con cui il prossimo governo verrà fatto; ma perché no, nelle condizioni date, un patto fra i due antieuropeisti amici di Trump e Putin, Grillo e Salvini? Ma le previsioni in questo senso non possono essere che avventate: diciamo che tutto diventerebbe possibile).
Le leggi elettorali dovrebbero in generale consentire di esprimere al meglio il consenso, e favorire quindi di volta in volta l’alternanza delle diverse forze politiche al governo. Questa invece serve a rendere stabile, anzi permanente, lo status quo: i quattro Sovrani si trovano d’accordo sul principio che, innanzi tutto, la rappresentanza parlamentare venga statualmente divisa fra loro quattro: alleanze e combinazioni si vedranno poi, ma non c’è da dubitare che, in base alla loro scelta originaria, qualche “inciucio” ne salterà fuori. Dunque, una sorta di “colpo di forza” in veste compiutamente democratica? Del resto, soluzioni autoritarie di ogni tipo sono sempre state rese possibili, oltre che dall’esercizio puro e semplice della violenza, anche da maggioranze democraticamente espresse, che si trovano d’accordo nel legittimare formalmente un restringimento degli stessi spazi di democrazia, che avevano reso possibile il formarsi di quelle maggioranze.
Siamo dunque fra l'incudine del mutamento elettorale impostoci e il martello delle future deformazioni democratiche: non più la democrazia come un campo ampio di partecipazione, confronto e lotta, ma un serraglio ben delimitato della legge assunta a tale scopo.
Se altri argomenti non fossero persuasivi, ce n’è uno che chiarisce senza ombra di dubbi la situazione: la volontà, anche questa assolutamente condivisa e comune, di abbattere il più presto possibile il governo Gentiloni e di andare subito dopo al voto (con una campagna elettorale limitatissima nel tempo e nelle intenzioni, quasi tutta estiva: tanto che bisogno c’è di persuadere gli elettori, basta portarsi dietro, ognuno, le propri truppe). Ora, non si ripeterà mai abbastanza che l’abbattimento, in questa chiave e con tali metodi dell’attuale governo, costituisce un vulnus alla credibilità dell’Italia, ai sui bilanci, alla sua (sia pur limitata) coesione sociale (a questo proposito: esiste forse la possibilità che il Presidente Mattarella, solitamente attento a questo aspetto delle cose, respinga tale sciagura in nome dei “superiori interessi nazionali”?).
Dunque, cosa spinge “i quattro dell’Orsa maggiore” a imboccare una strada così perigliosa così in fretta? Non potrebbero anche loro, votata la “loro” legge elettorale, aspettare il naturale esaurimento della legislatura? No, non possono aspettare. Popolo, forze politiche e intellettuali, associazioni, opinione pubblica organizzata (la stampa, ad esempio, ed altro) potrebbero maturare un’opposizione più netta, più convinta, persino più ruvida, di quanto finora non sia avvenuto (ma in parte è già avvenuto). Dunque, fa parte della riuscita dell’impresa anche la rapidità fulminea con cui viene concepita, messa in opera e realizzata: anche il costringere a pensare poco, a riflettere meno e a discutere ancora meno, costituisce un connotato non irrilevante dell’intera operazione.
Un aspetto positivo va tuttavia riconosciuto alle proposte di riforma elettorale di cui abbiamo cercato di discutere. E cioè: le forze oppositive sopravviventi, quasi tutte per ora (si sarebbe detto una volta) “a sinistra”, se si presentassero al confronto politico e al voto così come sono, uscirebbero tranquillamente di scena, che è un altro fondamentale obiettivo dell’attuale riforma elettorale. La condizione della sopravvivenza, e dunque del perdurare di un effettivo gioco democratico, per quanto inizialmente difficilissimo, è che tali forze presentino un solo volto del paese: da Orlando (se possibile) a Bersani a Pisapia a D’Alema a Civati a Fratoianni…
E questo per due motivi. Il primo è il più ovvio: per entrare nel prossimo Parlamento bisognerà presentare un volto unico al paese, ossia, se si vuole entrare di più nel linguaggio elettorale di cui stiamo parlando, una sola lista.
Il secondo motivo è invece molto, molto più importante. Un’alternativa oggi non c’è: dunque va costruita, anch’essa rapidamente, finché c’è tempo. L’esperienza Macron in Francia, incomparabilmente più dignitosa e rilevante di quanto sta accadendo nel nostro paese, dimostra anch’essa tuttavia che le “vecchie sinistre”, prese ognuna per sé, nella grande maggioranza dei casi europei, non ce la fanno più a interpretare e rappresentare l’enorme mutamento che società e politica hanno attraversato in questi decenni in Europa (nel mondo?).
C’è uno spazio, identificabile con vaste aree di cultura dell’alternativa e della partecipazione, con cui sarebbe possibile anche in Italia incontrarsi e colloquiare. A patto, ovviamente, che, anche su questo versante, come sarebbe paradossale, non si realizzi un mero incontro elettorale, ma si proceda a una rifusione profonda delle forze in gioco, per arrivare a un organismo unico totalmente diverso. Non si parla più di “Costituente della sinistra”? Si torni a parlarne. La questione, infatti è tutt’altro che teorica, come ho cercato di argomentare dall’inizio di questo articolo. È, innanzi tutto, una questione di sopravvivenza: non dei singoli partiti; ma del sistema democratico-rappresentativo in Italia.
postilla
L'insieme dei gusci e dei nomi del millennio scorso saranno capaci di attrarre nell'arena delle decisioni elettorali una parte consistente del popolo di oggi?

Nave dei folli, la Stultifera navis di Sebastian Brant. Sono stipati in uno spazio stretto, non sanno dove vanno; chi indica avanti, chi guarda indietro e chi a destra o a sinistra; altri sono inebetiti». la Repubblica, 6 giugno 2017 (c.m.c.)
Chi sa perché si debba chiudere la legislatura qualche mese prima della normale scadenza e votare in autunno? Se ce lo chiediamo, non sappiamo rispondere. Se lo chiedessimo, non avremmo chiare risposte. Infatti, non ci sono ragioni evidenti e, in mancanza, la stragrande maggioranza dei cittadini interpellati è per la prosecuzione fino alla scadenza naturale: c’è un governo, ci sono leggi importanti da approvare definitivamente, ci sono scadenze legislative importantissime da rispettare in materia finanziaria, ci sono rischi per la tenuta dei conti pubblici, ci sono apprensioni per le conseguenze di possibili violazioni dei parametri europei di stabilità finanziaria, per non parlare dei rischi della speculazione internazionale.
Vorremmo una risposta che riguardi non gli interessi di questo o quel partito in Parlamento e nemmeno di tutti o della maggior parte dei partiti, ma il bene del nostro Paese, quello che si chiama il “bene comune”. Nel nostro sistema costituzionale, a differenza di altri, non è previsto l’auto-scioglimento deciso dai partiti per propri interessi o timori. La durata prefissata e normale della legislatura (cinque anni) è una garanzia di ordinato e stabile sviluppo della vita politica.
La stabilità è stato il Leitmotiv invocato quando faceva comodo, anche quando si sono rese evidenti ragioni oggettive di scioglimento delle Camere, come dopo la dichiarazione d’incostituzionalità della legge elettorale, all’inizio dell’anno 2014.
Una risposta istituzionale non c’è. Ci sono anzi molta ipocrisia e reticenza che nascondono ragioni che sono, infatti, di mero interesse partitico. Da parte del maggior partito di maggioranza, il Partito democratico, si dice che votare in autunno o alla scadenza normale nella primavera dell’anno venturo non fa una grande differenza, ma poi si lavora forsennatamente a una legge elettorale nuova per andare al voto il più presto possibile.
Lo muove il desiderio del suo segretario e della cerchia che gli sta intorno di una rivincita dopo la sconfitta nel referendum del 4 dicembre? Oppure, il desiderio di fare piazza pulita degli oppositori interni, privandoli della candidatura alle elezioni? Oppure, la volontà di ostacolare, strozzando i tempi, l’organizzazione di forze concorrenziali a sinistra? Oppure, il timore di dover sostenere misure impopolari da “lacrime e sangue” in autunno, che farebbero perdere consenso e voti alle elezioni a scadenza normale? Oppure, perfino la volontà di non dover sostenere riforme importanti e da lungo tempo attese su diritti fondamentali, come quelle che questo giornale ha segnalato e continua a segnalare, riforme che potrebbero essere in dirittura d’arrivo ma col rischio di far perdere consensi tra porzioni dei suoi elettori (misure antimafia, riforme della giustizia, lo ius soli al posto dello ius sanguinis per la cittadinanza, il cosiddetto testamento biologico, il delitto di tortura, ecc.)? Dal Pd viene la spinta e gli altri partiti pro-elezioni anticipate si accodano per loro ragioni: chi perché pensa di poter subito incassare successi (M5Stelle, Lega), chi per rientrare in gioco (Forza Italia).
C’è pervicacia, ma se le ragioni sono quelle anzidette le si dovrebbe definire “interessi di bottega”. Al di sopra, ci dovrebbe essere l’interesse nazionale di cui custodi sono il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica. Né l’uno né l’altro hanno il potere di costringere qualcuno, se non vuole più, a sostenere il governo in carica, ma entrambi hanno almeno il potere di promuovere un chiarimento in Parlamento, prima di qualunque crisi di governo e di scioglimento delle Camere, e di chiamare i partiti ad assumere esplicitamente le loro responsabilità di fronte al Paese: “esplicitamente”, cosa in questa fase non facile per assenza di argomenti degni della posta in gioco ma, proprio per questo, doverosa.
Il voto anticipato s’intreccia con la nuova legge elettorale senza la quale, si dice, non si può votare. Poiché il voto è urgente, la legge è urgentissima. Tralascio le assurdità contenute nel testo iniziale, spiegabili in parte col voler continuare con i “nominati” e non con gli “eletti”, in parte con la cementificazione degli oligarchi di partito, in parte con la sfrenata fantasia creativa degli autori. Di questo s’è ampiamente scritto e detto e, del resto, ad alcuni dei macroscopici abusi sembra che qualche volenteroso voglia porre rimedio. Ciò che colpisce, sopra tutto, è che, pur di avere una legge, si rinnegano tante cose dette centinaia di volte nel passato recente: che non ci sarebbero più stati compromessi dopo le elezioni (gli “inciuci”); che “la sera stessa” si sarebbe saputo chi avrebbe vinto e governato per cinque anni, che il bipolarismo e l’alternanza erano dati acquisiti e che mai e poi mai si sarebbe ritornati agli obbrobri della prima repubblica.
Tutto questo era diventato quasi una questione di fede, ma in un lampo s’è dileguato. Anzi, si sente il contrario. Certo, proporzionale o maggioritario è questione opinabile e, infatti, le opinioni divergono. Ma, che si sia passati da un momento all’altro, senza una riflessione di merito, da ballottaggi e premi di maggioranza, cioè dalla logica maggioritaria, alla proporzionale, questo è piuttosto sconcertante e si spiega con la voglia di voto anticipato. Che cosa potrà accadere, se si potranno formare maggioranze e quali, se si dovrà tornare a rivotare, se si dovrà rimettere mano, ancora una volta, alla legge elettorale, tutto questo sembra interessare poco o nulla i partiti che chiedono elezioni subito. Vogliono cogliere il loro frutto. Poi si vedrà.
E pure, la legge elettorale non è solo un mezzo di realizzazione d’interessi immediati, ma è una prefigurazione del sistema delle relazioni politiche a venire e di questo si tace. Che cosa s’immagina? Di poter governare da soli? Se non da soli, con chi? Il dopo, naturalmente, è nelle mani degli elettori, ma questi avranno pure il diritto di sapere prima come sarà poi utilizzato il loro voto! Ma, sul dopo esistono sospetti, reticenze e, sulle ipotesi meno presentabili ai propri elettori, silenzi o tiepide smentite. Come potranno orientarsi gli elettori? Non è la stessa cosa se il Pd si prepara a una coalizione con Forza Italia, oppure con una qualche formazione alla sua sinistra; non è la stessa cosa se il M5Stelle è o non è disposto a collaborare con la Lega. Non si può trattare gli elettori come burini e considerare i loro voti come “bottino” o massa di manovra. Meritano altro. L’astensione diffusa dovrebbe essere presa in considerazione come un segnale di secessione interiore: un segnale ancora più forte a sentire i tanti, sempre di più, che dicono che a queste condizioni non sono disposti a votare ancora.
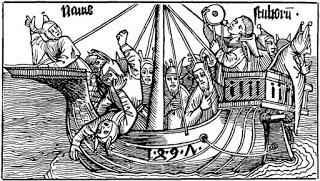
Sia consentito un accenno personale, che forse rispecchia uno stato d’animo anche d’altri. Guardo le convulsioni di questa fine-legislatura e non posso fare a meno di pensare alla Nave dei folli, la Stultifera navis di Sebastian Brant. Potrebbe essere istruttiva l’immagine che ne diede Albrecht Dürer per l’edizione del 1494. Sono stipati in uno spazio stretto, non sanno dove vanno; chi indica avanti, chi guarda indietro e chi a destra o a sinistra; altri sono inebetiti; uno è colpito da un pugno e cade in mare. Tutti hanno le classiche orecchie d’asino. Non c’è allegria. È un triste carnevale. L’unico che sembra divertirsi sta attaccato alla fiaschetta. La pazzia, però, è generale. Nessuno si preoccupa di dirigere la nave. Non c’è segno di consapevolezza del pericolo che incombe. Che un minuto dopo si possa affondare tutti insieme, non interessa a nessuno. Questa è la pazzia: stare o agitarsi ciascuno per proprio conto, girare in tondo, ciechi, senza connessioni, senza futuro. Credere di poter sopravvivere solo sopravvivendo.
S’avvicinano le elezioni e la frenesia sulla nave impazza. Nella poesia di Rimbaud, il Bateau ivre danza sui flutti, leggero come un tappo, ed è abbandonato alle correnti. Noi, invece, l’abbiamo tra noi e danziamo con lui.
 Imbellettata da qualche spruzzo di "civili",mascherata dalle ipocrite parole pacifiste, si è ripetuta una volta ancora la marcia in (dis)onore dei produttori e commercianti di morte, fomentatori e alimentatori di guerre (a spese del contribuente) in ogni parte del mondo.
Imbellettata da qualche spruzzo di "civili",mascherata dalle ipocrite parole pacifiste, si è ripetuta una volta ancora la marcia in (dis)onore dei produttori e commercianti di morte, fomentatori e alimentatori di guerre (a spese del contribuente) in ogni parte del mondo.
il manifesto, 3 giugno 2017
Non c’è niente di più menzognero che far sfilare civili insieme a truppa armata, tank e cacciabombardieri. È il nuovo «politicamente corretto» che accompagna l’ideologia della guerra umanitaria disseminata a partire dalla guerra Nato del 1999 e confermata in Libia soltanto sei anni fa.
Un «politicamente corretto» andato in onda, come negli ultimi anni, anche ieri 2 giugno. Come se la ripetizione delle marce trionfali dell’Occidente militarizzato, imbellettata qui e là di presenze civili, possa giustificare fino a nascondere, la sostanziale maschera della vocazione alla guerra che ci circonda.
Certo, ha ragione il presidente Sergio Mattarella: vogliamo «per le giovani generazioni un futuro di pace». Che altro?! Ma come se, secondo il vecchio motto imperiale «para bellum», prepariamo la guerra? Perché spendiamo in armi e spese militari più di 70 milioni di euro al giorno (secondo gli ultimi dati internazionali dell’autorevole Sipri); perché raddoppia l’autorizzazione all’export di armi italiane e il governo se ne rallegra perché così “il Pil cresce”, arrivando a ben 14,6 miliardi di euro (l’85% in più rispetto al 2015), per esportazioni verso paesi come Arabia saudita, Kuwait, Turchia, Pakistan, Emirati Arabi, tutti – tanti i petro-regimi – impegnati in guerre sanguinose. Un commercio i cui effetti si faranno sentire proprio nei prossimi anni. Ecco che la guerra si riproduce a mezzo di guerra e deve continuare. Secondo il dettato del neofita presidente statunitense Donald Trump.
Così, pendendo incredibilmente dalle sue labbra, stiamo raddoppiando, fino al 2%, le nostre spese militari per sostenere la Nato, che pericolosamente si allarga a Est a cercare nuovi conflitti; e abbiamo impegnato ben 15 miliardi (per ora) per l’acquisto di 90 cacciabombardieri F35 (che possono montare armi nucleari).E, mentre trasformiamo la vocazione naturale di intere regioni italiane in vecchie e ammodernate servitù militari, siamo pronti alla Nuova Difesa Europea, non sostitutiva ma aggiuntiva dei costi atlantici; per una Unione europea che chiede alle aziende statali di ogni Paese di produrre armi: lì naturalmente nessuno pone vincoli di bilancio. Che invece tagliano salari, lavoro, società, giovani, sanità, scuola, servizi sociali. E per finire, i militari italiani sono impegnati – da Mosul a Kabul – su ogni fronte aperto di guerra. Lì dove a morire sono in prima fila i civili.
Stiamo in armi a raccogliere il dividendo dei falliti conflitti precedenti che abbiamo innescato. Dalla guerra in Iraq del 1991, poi in Afghanistan – la più lunga e controproducente della storia contemporanea – fino a quella del 2003 sempre in Iraq; e poi in Libia e in Siria, e chi più ne ha più ne metta. C’è un solo modo per festeggiare il 2 giugno, la festa della nascita della Repubblica. Rinunciare alla marcia trionfale, alla sfilata militare che strumentalmente vuole mimetizzare il macigno delle spese militari – che non preparano un «futuro di pace» – con pennellate di «civile».
Del resto è già accaduto. Nel 1976 i militari non vennero fatti sfilare per l’impegno a sostenere i terremotati del Friuli. Oggi c’è una evoluzione machiavellica e perversa: i sindaci delle zone terremotate hanno dovuto aprire la sfilata militare. Provocando gravi ed ulteriori divisioni nel cuore sconvolto del Belpaese, perché in tanti si sono rifiutati di marciare visti i risultati delle loro terre ancora sotto le macerie, dopo troppe parole e promesse.
Bene dunque hanno fatto i pacifisti a rendersi visibili, a tornare in piazza ieri a Roma, a Cagliari e a Camp Darby (Pisa-Livorno). Perché si festeggia la nascita della Repubblica praticando e facendo viva la Costituzione repubblicana che all’articolo 11 – maltrattato, cancellato, vilipeso – dice che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La marce trionfali militari sono senza futuro.

«». il Venerdì di Repubblica, 1 Giugno 2017 (c.m.c.)
L’Italia è una Repubblica. Democratica, fondata sul lavoro.
L’abbiamo deciso in un 2 giugno come questo, settantuno anni fa: quando gli italiani (e per la prima volta anche le italiane) chiamarono se stessi a votare, per decidere cosa doveva essere l’Italia. E decisero: non un regno, non più. Ma una Repubblica.L’Italia, naturalmente, esisteva già. Come luogo fisico: una penisola immersa per tre lati nel mare, e coronata dalle Alpi. Ma anche come comunità. Come nazione.
Appena nata, la Repubblica dichiarò solennemente che avrebbe protetto la Nazione. Lo scrisse nella Costituzione, che è il progetto, la mappa, il programma della Repubblica. Lo scrisse nell’articolo 9: «La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione». È l’unica volta che, tra i principi fondamentali della nostra nuova Italia, si usa questa parola: «nazione». E la si usa per dire questo: l’Italia è la sua storia, la sua natura, la sua arte. Non il sangue, la stirpe, la lingua o la religione: ma la cultura. Come matrice, ma anche come progetto.
Anche Cimabue, il più antico padre della pittura italiana, la pensava così. Quando Dante aveva circa quindici anni, sugli altissimi ponteggi della Basilica Superiore di Assisi – la grande chiesa nata sulla tomba di Francesco, che d’Italia divenne il patrono – Cimabue dovette rappresentare in poco spazio, e in modo che fosse visibile dal pavimento, proprio l’Italia. Anzi l’«Ytalia», come si scriveva allora.
La dipinse come una città: e non una qualunque, ma Roma. La capitale naturale di Italia. La dipinse non come una veduta, ma come un’idea: un catalogo di monumenti, tutti ben riconoscibili. Ci sono Castel Sant’Angelo, la Piramide di Cestio e la Torre delle Milizie. Ne riconosciamo la cattedrale: San Giovanni in Laterano con la sua antica facciata in mosaici dorati. E poi il Pantheon, con la sua meravigliosa cupola bucata. E ancora: campanili, marmi. Le mura: con la porta aperta. E in alto il Campidoglio: il palazzo del potere civico.
Proviamo a leggerne il messaggio: l’Italia è come una città bellissima, e la sua porta è aperta a tutti coloro che vengono in pace. Una nazione aperta, una città a cui tutti possono aggiungere qualcosa di bello, una Repubblica il cui palazzo più alto appartiene a tutto il popolo. In sette secoli la visione di Cimabue è diventata il progetto della Costituzione: ma quanto lavoro ci resta da fare per costruire l’Italia!

Altreconomia. newsletter 194, 1 giugno 2017 (c.m.c.)
L’aspetto più frustrante della democrazia moderna occidentale sono le campagne elettorali. Il periodo delle promesse, dei proclami, delle minacce, dell’ipocrisia, delle fazioni che si combattono senza particolare stile, regole, rispetto reciproco. Le campagne elettorali hanno molteplici tratti distintivi. Uno di questi è la necessità di rivolgersi, con tutti i mezzi, a quella parte sempre minore di popolazione che va ancora a votare, quella che ha resistito, nonostante tutto, alla tentazione antidemocratica dell’astensione. Dentro quella parte c’è un po’ di tutto: convinzione, protesta, abitudine, senso di responsabilità, disillusione. “Con tutti i mezzi” vuol dire oggi soprattutto televisioni e social media, con il portato che questa deriva ha definitivamente assunto in termini di linguaggio, superficialità, velocità ed evanescenza.
Un altro tratto caratteristico delle stagioni pre urne è la scelta di pochi temi sui quali concentrarsi, affinché siano idonei a convincere gli elettori attraverso i mezzi a disposizione. Mascherando la scelta come “necessaria” per parlare “a tutti”, si abdica alla complessità a favore di slogan e programmi che sembrano liste della spesa. È accaduto negli Stati Uniti e in Francia, accadrà fra poco in Germania, in Gran Bretagna e, fra non molto, anche in Italia -che in realtà è entrata in una campagna elettorale perenne ormai dal periodo precedente al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.
Nelle democrazie moderne occidentali, dato il contesto storico, il tutto è facilmente riconducibile a una sola parola: paura. La paura che provano le persone -e quindi gli elettori- va rispettata. Le cose sono ben cambiate nel corso degli ultimi 20 anni, e i cambiamenti, quando non li si comprende, mettono timore. Ma se rispettare la paura è giusto, alimentarla, cavalcarla, sfruttarla è indegno. Perché quando il perno della politica è la paura dei cittadini, la risposta è innanzitutto ridimensionare i problemi reali del mondo. Ovvero i cambiamenti climatici, lo strapotere delle multinazionali che eludono le tasse, l’incredibile iniquità nella distribuzione planetaria dei redditi, l’esaurimento delle risorse, l’impunità della finanza predatoria, dei corrotti e dei corruttori, la criminalità organizzata internazionale. Troppo difficili da capire, troppo difficili da spiegare. Troppo potere da mettere in discussione. Poca volontà di contrastarlo.
Il passaggio successivo consiste nella ricerca di un capro espiatorio. E il capro espiatorio delle democrazie moderne occidentali sono i miserabili: migranti, disoccupati, mendicanti. E ovviamente chi li aiuta. Facili da attaccare, praticamente indifesi. Vittoria certa, agevole, pulita. Consenso a buon prezzo. Non tutti ci cascano ovviamente. Al Salone del Libro di Torino, a maggio, nel silenzio compiacente della platea (“la cultura è l’oppio dei popoli” direbbe Goffredo Fofi) tre ragazzi hanno contestato il ministro dell’Interno Marco Minniti per i decreti di sedicente sicurezza che portano il suo nome e quello del ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Dietro il paravento di tanta retorica, l’operato del Governo punta a un modello ben lontano dall’accoglienza diffusa che ci si era prefissi, fatto anche di accordi con Paesi tutt’altro che democratici per il “contenimento” dei flussi migratori. La protesta è stata facilmente repressa, ma ci sono voluti tre ragazzi coraggiosi per dire che il re è nudo.
La paura è la stessa arma del terrorismo internazionale, che non colpisce il potere, non colpisce l’ingiustizia: colpisce gli indifesi, le vittime, chi non ha alcun potere, come quei ragazzini -e le loro famiglie- a Manchester il 22 maggio. Ragazzini per i quali la società multiculturale è la normalità. La filosofa Donatella Di Cesare parlerebbe di “fobocrazia”: «Il terrore incrina l’etica, sfida la politica, muta la forma di vita. Scaturito dalla modernità, il terrore è la forza violenta che si oppone alla globalizzazione».
 Il Renzusconismo non è una spuma passeggera, ma il prodotto del fluire costante di correnti profonde. Per combatterlo con efficacia i tatticismi non bastano. «Per ora possiamo contare solo su una credibilità che deve venire da chiarezza di analisi e di obbiettiv
Il Renzusconismo non è una spuma passeggera, ma il prodotto del fluire costante di correnti profonde. Per combatterlo con efficacia i tatticismi non bastano. «Per ora possiamo contare solo su una credibilità che deve venire da chiarezza di analisi e di obbiettiv
i». il manifesto, 2 giugno 2017
So benissimo quanto sia poco elegante autocitarsi, con il sottointeso, inoltre, di suggerire: «vedete che avevo la vista lunga». Per ragionare, però, su quello che abbiamo oggi sotto gli occhi dobbiamo ragionare anche su quello che ci avevamo ieri e che la politica politicante aveva ignorato e che continua ad ignorare. «Molti commentatori odierni, purtroppo anche da sinistra, scambiano una partita di poker (…) con un mutamento strategico. Scambiano cioè la spuma di superficie mossa da venti incostanti, con il fluire costante delle correnti profonde (…). È sulle culture che lo ispirano, sulle strutture di ogni tipo che lo sorreggono, che vanno misurate le ragioni del ’lungo Nazareno’, non sulle necessità contingenti della tattica» (Le radici profonde del Nazareno, il manifesto, 10 febbraio 2015). Di fronte alla nuova partita di poker dei nostri giorni i cui risultati sembrano invertire la «svolta a sinistra» renziana relativa al metodo di elezione di Mattarella (così fu considerata dai sostenitori del centrosinistra «buono»), si potrebbero usare gli stessi termini dell’articolo di due anni e mezzo fa. E del resto non si sono certo modificate le coordinate che vengono da lontano e che si concretizzano, come ci spiega autorevolmente un ex economista critico, fortemente pentito proprio della dimensione «critica»
[Michele Salvai -n.d.r], nella consapevolezza che «entrambi i leader» hanno del «nesso che lega (…) indirizzi europei (…) alle riforme interne che dovranno essere attuate al fine di adeguarsi ad essi» (Il riformismo dei moderati Renzi e Berlusconi,
Corriere della sera, 20 maggio 2017).
Su questo punto, quello davvero dirimente per l’analisi «critica» e le politiche che intendono ispirarvisi, fin dagli anni ’90 le logiche dell’alternanza tra governi Berlusconi e governi di centrosinistra non sono mai state conflittuali se non su questioni marginali o su tattici aggiustamenti legati alla contingenza. L’ideologia economica condivisa e vissuta come seconda natura giustifica il «pilota automatico» che guida l’attuale fase dell’accumulazione. I due leader «riformisti» devono assicurarsi che niente interferisca con tale centro di controllo dell’economia e della società, ed una volta garantito il meccanismo possono dedicarsi in tutta libertà ai più gratificanti giochi dell’esercizio del potere. Giochi tutt’altro che innocenti peraltro.
Da «quali fragilità della nostra storia» (G. Orsina) sia derivato quel fenomeno che è stato chiamato berlusconismo sono ormai noti i lineamenti generali. Attenti studiosi (A. Gibelli, P. Ginsborg, N. Tranfaglia…) hanno impostato in termini storici, e dunque nei tempi della storia, l’ascesa e la pervasività del fenomeno. Se la commistione politica-affari attiene in generale alla tendenza «regressiva» che interessa l’Occidente nel suo complesso da più di trent’anni, i modi del «berlusconismo» sono connotati dalla storia italiana, dalla particolare estensione della sua «zona grigia». In nessun altro paese analogo l’accumulazione di ricchezza e potere personale avrebbe avuto spazi fuori legge tanto vasti. In nessun altro paese analogo le condanne definitive ed infamanti ai principali esponenti (Berlusconi, Previti, Dell’Utri) di un’operazione politica di tale centralità non avrebbe lasciato segno sulla continuità dell’operazione stessa.Questo non è avvenuto perché la cornice politico-culturale seguita all’eclissi (parziale) di Berlusconi altro non è stata, e non è, che una nuova forma di berlusconismo. Uno stato della «miseria della politica» a cui Berlusconi ha dato corpo ed immaginario, ma che trascende la sua persona.
Ora questo quadro politico con un nucleo centrale sostanzialmente compatto, un nucleo centrale che è espressione di un reticolo di strutture anch’esso sostanzialmente compatto, si appresta a cercare conferma in una tornata elettorale assai vicina. Una tornata elettorale importante anche per una definizione non provvisoria, non immediatamente funzionale alla scadenza, del processo di costruzione (ahimé infinito e ed ancora inficiato da insopportabili tatticismi) di un campo di sinistra radicalmente critico e politicamente efficace. Un appuntamento importante, certo, ed è necessario lasciare un segno nei risultati, ma non è il caso di farsi eccessive illusioni su spazi elettorali facili da conquistare. Il risultato francese di Melenchon, quasi il 20%, ha alle sue spalle una durissima lotta sociale durata mesi e sostenuta dalla Cgt. Non mi pare che ci possano essere paragoni con la situazione italiana.
Per ora possiamo contare solo su una credibilità che deve venire da chiarezza di analisi e di obbiettivi. Leggo che il 29 maggio la capogruppo Mdp al Senato ha dichiarato: «… noi ragioniamo nell’ottica di un centrosinistra coalizionale». Ebbene chiarezza e credibilità significano ragionare esattamente nella maniera opposta.
 Anche nel Veneto vistosi episodi di sfruttamento del lavoro di chi viene da lontano e non ha garanzie. Il ruolo perverso della forma cooperativa, divenuta nuova veste del padronato.
Anche nel Veneto vistosi episodi di sfruttamento del lavoro di chi viene da lontano e non ha garanzie. Il ruolo perverso della forma cooperativa, divenuta nuova veste del padronato.
Corriere del Veneto, 31 maggio 2017 (m.p.r.)
Padova, Avrebbero accettato qualsiasi cosa. Avevano bisogno di quel lavoro da magazzinieri nei locali dell’Interporto di Padova che avrebbe permesso loro di sopravvivere e garantito il permesso di soggiorno. E così centinaia di stranieri, provenienti per lo più dal Bangladesh, non hanno mai rifiutato le condizioni, a tratti disumane, imposte loro da chi, per almeno due anni, ha gestito una vera organizzazione di caporalato, la prima accertata in Veneto in un settore diverso da quello agricolo.
Vera eminenza grigia era Floriano Pomaro, 52 anni, originario di Lendinara e da anni a Padova, un nome conosciuto nel polo della logistica padovana, e da ieri agli arresti al Due Palazzi. Ad aiutarlo, Riccardo Bellotto e Mario Zecchinato, entrambi padovani ed entrambi ai domiciliari. Per loro le accuse arrivate al termine di un’indagine condotta dalla Digos e dalle Mobile e coordinate dal procuratore capo Matteo Stuccilli, dall’aggiunto Valeria Sanzari e dal sostituto procuratore Federica Baccaglini, sono a vario titolo di caporalato e riciclaggio.
Un’inchiesta avviata nel 2013, quando agli inquirenti è arrivata la voce di malumori tra le cooperative che si occupavano dello stoccaggio merci nei locali dell’Interporto. Qualcuno, si diceva, giocava sporco. Gli agenti della questura di Padova, così, hanno concentrato l’attenzione su alcune cooperative, tra cui la Easy Società Cooperativa e la B.B. Società Cooperativa che gestiscono i magazzini della Gottardo Spa, l’azienda guidata da Tiziano Gottardo, fondatore della catena di profumerie Tigotà ed estraneo all’inchiesta. Tra i dipendenti di queste coop, centinaia di stranieri, quasi tutti del Bangladesh, con contratti a tempo determinato e part time. Qualcosa, però, non quadrava. Perché se da una parte figurava che i dipendenti lavoravano mezza giornata, con uno stipendio da mille euro, dall’altra nei magazzini trascorrevano più di 70 ore a settimana.
È così emerso il capo indiscusso del sistema, Pomaro, già implicato in passato per frode fiscale in inchieste che hanno coinvolto diverse aziende della logistica padovana. Attraverso prestanome, Pomaro avrebbe costituito cooperative ad hoc. Era lui a gestire tutta l’organizzazione. Un sistema che si occupava di ogni fase: dal reclutamento dei lavoratori all’estero, soprattutto dal Bangladesh («Sono quelli più malleabili», si sente dire nelle intercettazioni ambientali), alla loro assunzione. Gli aspiranti dipendenti, per essere assunti, versavano mille euro. Una volta arrivati in Italia, accettavano un contratto di tre mesi e firmavano le dimissioni in bianco. Scaduto il primo periodo, poi, pagavano altri 500 euro per un rinnovo. E così andavano avanti, di scadenza in scadenza, sempre in pugno di Pomaro e soci.
Figuravano come dipendenti part time, anche se le ore di lavoro erano decine nell’arco di una settimana. Parte dei loro compensi figuravano come «indennità di missione», vale a dire rimborso spese: uno stratagemma per abbassare le tasse e che permetteva un risparmio da centinaia di migliaia di euro.
A dare una parvenza di legalità era Riccardo Bellotto, classe 1981, il contabile del gruppo. Era lui a occuparsi dei contratti e che procurava agli stranieri il tanto agognato permesso di soggiorno. I dipendenti, inoltre, erano costretti ad aprire un conto corrente nel quale ricevere lo stipendio. Le credenziali dei conti, però, erano gestite da Mario Zecchinato, 62 anni e un’accusa alle spalle per favoreggiamento della prostituzione. Una volta versato lo stipendio, Zecchinato si occupava di prelevarne il 30 per cento, una cifra che tornava nelle tasche dell’organizzazione.
Impossibile, per gli stranieri, ribellarsi, o aderire a scioperi. Qualsiasi tentativo di protesta poteva essere pretesto per il mancato rinnovo, il che comportava la perdita del permesso di soggiorno. «Dobbiamo renderli ricattabili», si dicevano i tre indagati. E così hanno fatto.
Oggi Pomaro sarà interrogato dal gip Domenica Gambardella, mentre domani sarà il turno di Belotto e Zecchinato. L’inchiesta, però, non è finita qui. Se per ora nel mirino del gip sono finiti gli organizzatori del caporalato, non si escludono sviluppi che possano coinvolgere altre persone. Nell’ottobre scorso, infatti, è cambiata la legge sul caporalato, rendendo perseguibile anche il datore di lavoro. L’operazione, quindi, procede.

Sbilanciamoci.info, newsletter, 30 maggio 2017
Nel 2016 l’export militare italiano ha registrato un aumento dell’85% rispetto all’anno precedente. Numeri da capogiro, documentati dalla Relazione annuale sul commercio e sulle autorizzazioni all’esportazioni di armi
“Nei concili di governo dobbiamo stare in guardia contro le richieste non giustificate dalla realtà del complesso industriale militare. Esiste e persisterà il pericolo della sua disastrosa influenza progressiva. Non dobbiamo mai permettere che il peso di questa combinazione metta in pericolo la nostra democrazia. Solo il popolo allertato e informato potrà costringere ad una corretta interazione la gigantesca macchina da guerra militare….in modo che sicurezza e libertà possano prosperare insieme”. Queste parole non sono di un pacifista: le pronunciò nel lontano 1961 nel suo discorso di addio alla Nazione l’allora Presidente degli Stati Uniti Dwight Eisenhower, membro del Partito Repubblicano ed ex comandante delle Forze Armate statunitensi in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale e Capo di Stato Maggiore dell’esercito.
Parole che suonano strane se ripetute da un ex militare: perfino Eisenhower, politicamente molto conservatore, aveva capito il pericolo che può rappresentare il complesso militare – industriale per le istituzioni democratiche. Tuttavia, le sue affermazioni suonano ancora vuote ai nostri giorni, visto che il giro d’affari intorno ad armi e armamenti realizza lauti profitti, ed aumenta il suo volume di anno in anno.
Il caso del nostro Paese è emblematico: nel 2016 l’export militare italiano ha registrato un aumento dell’85% rispetto all’anno precedente. Numeri da capogiro, documentati dalla Relazione annuale sul commercio e sulle autorizzazioni all’esportazioni di armi, che il Governo ha consegnato al Parlamento lo scorso aprile.
Ma analizziamo i dati in termini assoluti. Nel 2016 il valore complessivo delle licenze di esportazioni è stato di 14,6 miliardi di euro, un vero e proprio boom se guardiamo agli anni precedenti: “solo” 7,8 miliardi nel 2015, mentre nel 2013 la cifra si attestava intorno ai 2,5 miliardi. Rispetto all’exploit degli ultimi anni, i numeri delle vendite dei primi anni 2000 appaiono irrisori (1,9 miliardi) e ancor di più lo sono quelli del lustro immediatamente successivo alla fine della Guerra Fredda, 1991 – 1995 (1 miliardo). Dati che, secondo Sergio Andreis, della campagna Sbilanciamoci! sono “sottostimati”, in quanto “il modo di calcolo non permette la trasparenza assoluta: in molti casi si tratta di contratti legati alla sicurezza nazionale coperti dal segreto di Stato, quindi non pubblicati né pubblicabili”.
Ma a chi vengono vendute queste armi? Dalla relazione emerge che il numero di Paesi destinatari delle licenze di esportazione nel 2016 è stato di 82, in diminuzione rispetto ai 90 dell’anno precedente. Inoltre, il volume dei trasferimenti militari ai membri Ue e Nato dello scorso anno ha rappresentato il 36,9% sul totale, mentre il restante 63,1% è andato a Stati extra Ue e extra Nato. Tendenza inversa rispetto al 2015, quando questi valori sono stati pari, rispettivamente, al 62,6% e 37,4%. Ad un primo sguardo, il dato potrebbe rafforzare la tesi di chi vede l’Unione e l’Alleanza Atlantica come due organismi oramai “obsoleti”. Ma se guardiamo alla lista dei principali partner a cui forniamo materiale bellico made in Italy, è interessante notare come al primo posti spunti il Kuwait – al quale abbiamo venduto armi per un valore complessivo di 7,7 miliardi – seguito da quattro Paesi europei, Regno Unito (2,4 miliardi, mentre nel 2015 era primo con 1,3 miliardi), Germania (1 miliardo), Francia (570 milioni) e Spagna (470 milioni).
Sono proprio i rapporti commerciali tra l’Italia e la monarchia mediorientale la causa principale di questo aumento vertiginoso dell’export militare: lo scorso l’anno il nostro Paese ha effettuato una commessa record al Kuwait di 28 Eurofighter Typhoon della Leonardo, per un valore di 7,3 miliardi di euro. Il progetto, sviluppato da un consorzio di 400 aziende italiane, inglesi, tedesche e spagnole, ha come capofila l’italiana Finmeccanica, impresa leader del settore della difesa partecipata dal Governo italiano (al 30,2%): proprio all’azienda di Via Monte Grappa, secondo gli analisti, andrà circa il 50% dell’intera somma. “Si tratta del traguardo commerciale più grande mai raggiunto” sosteneva un anno fa un entusiasta Mauro Moretti, amministratore delegato della società, durante la solenne firma del contratto a Kuwait City, alla quale erano presenti anche il ministro della Difesa Roberta Pinotti ed il suo omologo Khaled Al Jarrah Al Sabah. Secondo i dati dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), tra il 2013 e il 2014 Finmeccanica ha occupato il nono posto nella classifica mondiale delle aziende fornitrici di materiali bellico, con un volume di vendite in armi pari, rispettivamente, a 10.540 e 10.560 milioni di dollari. Tra le altre società che occupano i primi otto posti, sette sono di origine statunitensi, mentre una, il Gruppo Airbus – al settimo posto – è un consorzio transeuropeo.
Ad oggi, il numero complessivo di Eurofighter venduti raggiunge quota 599 unità in otto Paesi diversi: secondo le stime, il giro d’affari che ruota intorno a quello che è considerato dal consorzio «il più avanzato aereo da combattimento multiruolo attualmente disponibile sul mercato mondiale» assicura in Europa oltre 100 mila posti di lavoro; tra i 20 e i 30 mila si trovano in Italia. Per il periodo 2017 – 2021 si prevede un aumento della redditività dell’azienda stimato tra il 3% e il 5% dopo la battuta d’arresto degli ultimi anni, possibilità non più remota grazie al complessivo aumento delle spese militari in tutto il mondo.
Ma non c’è solo il Kuwait. Tra gli acquirenti del nostro Paese figurano petro-monarchie come l’Arabia Saudita (427 milioni, al quinto posto), e subito dopo gli Stati Uniti il Qatar (341 milioni). La Turchia, invece, in decima posizione (133 milioni). Tutti Paesi che dei diritti umani se ne infischiano allegramente, e che ricorrono sistematicamente a pratiche illegali secondo il diritto internazionale, quali repressione della libertà di espressione, tortura e sfruttamento dei lavoratori migranti.
Il caso più grave è sicuramente quello dell’Arabia Saudita: un Paese che, oltre a reprimere duramente e sistematicamente i diritti delle donne e delle minoranze religiose, sta conducendo una guerra con il vicino Stato dello Yemen da circa due anni. Più che un conflitto si tratta di un vero e proprio massacro – che ha lasciato sul terreno, per l’Onu, oltre 10 mila morti e 40 mila feriti – per il quale Riyad è stata a più riprese condannata dalle Nazioni Unite e da altre Ong, come Amnesty. La causa principale delle stragi sistematiche, secondo l’Alto Commissario dell’Onu, sono i bombardamenti che la coalizione a guida saudita continua a perpetrare nei confronti dello Stato adiacente. Tra il 2014 e il 2015 la Relazione annuale del Governo italiano segnalava un aumento del 58% dell’export militare italiano verso il Paese degli Sceicchi, da 163 milioni a 257 milioni, prima di quadruplicare nel 2016. Un exploit riconducibile soprattutto alle bombe prodotte dallo stabilimento sardo della Rwm Italia Spa di Domusnovas, in provincia di Cagliari – ma con sede a Ghedi (Brescia). É la relazione a parlare: tra il 2014 e il 2015 abbiamo consegnato a Riyad 600 bombe Paveway (per 8,1 milioni di euro), 564 bombe Mk82 (3,6 milioni), 50 bombe Blu109 (3,6 milioni) e cento chili di esplosivo da carica Pbxn-109 (50mila euro). Recentemente il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che prevede il divieto di vendere armi ai Paesi coinvolti nel conflitto nello Yemen, ossia Arabia Saudita, Qatar ed Emirati. Risoluzione che l’Italia continua a violare. Come continua a infischiarsene, oltre che dell’articolo 11 della nostra Costituzione, anche della legge 185 del 1990 “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento” approvata dal Parlamento sotto il Governo Andreotti sulla spinta dei movimenti pacifisti. Nello specifico, il provvedimento vieta l’esportazione e il transito dei materiali d’armamento verso Paesi in stato di conflitto armato, responsabili di violazioni accertate dei diritti umani e verso quelli in cui è in vigore un embargo da parte dell’Onu. In poche parole, Stati come l’Arabia Saudita, il Qatar e la Turchia: Paesi che oltretutto “hanno avuto influenze dirette nel fomentare organizzazioni radicali legate al terrorismo internazionale” sostiene Antonio Mazzeo, giornalista impegnato nei temi della pace. “Se da un lato dichiariamo di voler combattere il terrorismo internazionale” conclude Mazzeo, “dall’altro lo fomentiamo esportando armi, aumentando le spese militari o la proiezione italiana all’estero”.
Nonostante la palese violazione, perché nel dibattito pubblico quasi nessuno contesta all’Italia di non applicare la 185 né di rispettare le leggi? “Perché non c’è nessuno che le fa rispettare”, dice Sergio Andreis, “né che porta il Governo in Tribunale su queste inadempienze. Quindi tutti gli attori dell’esportazione di armi si muovono in questo quadro.” La soluzione, secondo Andreis è che “le organizzazioni schierate per la pace e i parlamentari a cui sta a cuore il tema dovrebbero intraprendere azioni giuridiche per portare il nostro Paese e gli altri che violano le risoluzioni di fronte ai tribunali nazionali e internazionali affinché queste violazioni abbiano fine”.
Ci sono poi i dati del Sipri, che fotografa attentamente la situazione a livello mondiale. Secondo il think tank svedese, il 2016 ha visto un aumento complessivo della spesa militare dello 0,4% (+1686 miliardi di dollari); con il suo +11% la pole position dell’aumento delle spese in Europa occidentale spetta proprio all’Italia. Anche le superpotenze hanno aumentato considerevolmente il proprio budget bellico: al primo posto gli Stati Uniti registrano un aumento dell’1,6%; seguono poi Cina (+5,4%), Russia (+ 5,9%), Arabia Saudita (che passa dal terzo al quarto posto rispetto al 2015) e India +8,5%.
Oltre a questo ci sono altre questioni aperte. In primo luogo i progetti di ammodernamento delle bombe nucleari in corso, che oltre ai Paesi minori coinvolgono soprattutto le grandi potenze, in primis gli Usa, che secondo Mazzeo “prevedono di spendere da qui a 20 anni circa 300 miliardi di dollari per rinnovare il proprio arsenale atomico”. Nel dicembre del 2016, l’Assemblea Generale dell’Onu ha adottato a larga maggioranza una risoluzione per l’inizio di negoziati che diano vita ad un Trattato che vieti le armi nucleari. Tra i Paesi, 123 hanno votato a favore, 16 si sono astenuti, mentre 38 erano contrari – e tra questi vi era anche l’Italia. La strada è in salita, ma nel 2017 sono previsti ulteriori sforzi per intensificare la cooperazione sul disarmo atomico. C’è poi il terrorismo, che secondo l’attivista diventa “la narrazione con la quale giustificare l’aumento delle spese militari e il coinvolgimento dei Paesi occidentali in nuove missioni internazionali”. Last but not least c’è il problema del dual use, le tecnologie che possono essere usate sia per scopi pacifici che per quelli militari. “L’Italia si era data una legge su questo” dice Sergio Andreis, “che fu poi abrogata dal Governo Berlusconi”. “C’è la necessità di normare queste tecnologie, e il Parlamento europeo sta finalmente discutendo una normativa Ue” continua Andreis, che poi conclude “sarebbe bene che anche il legislatore italiano adotti provvedimenti per regolare questo settore”.
C’è poi stato l’ultimo G7 di Taormina. La scelta della location del summit non è stata casuale: andando oltre l’apparente discordia tra i leader mondiali e la retorica trumpiana – e ora anche tedesca – della Nato come obsoleta, la Sicilia rimane uno dei principali hubmilitari del Mediterraneo, sia per gli Usa che per l’Alleanza atlantica. Soprattutto per la presenza della base Nato di Sigonella, che nei prossimi mesi, sostiene Antonio Mazzeo “sarà ulteriormente potenziata con un sistema di controllo di droni militari e potenziata sia rispetto agli scenari di guerra mediorientali, che a quelli dell’Est Europa, in quanto”, puntualizza il giornalista “in Ucraina e Crimea sono attivi droni che sono installati, di base a Sigonella”.
Insomma, l’Italia si muove in sintonia con le dinamiche di riarmo e ripresa delle tensioni e dei conflitti a livello internazionale, quando sarebbe invece urgente che Governo e Parlamento – nel rispetto dell’articolo 11 della Costituzione – facciano pressione sulle istituzioni europee affinché l’Unione diventi soggetto promotore in sede Onu di un dialogo globale sul tema del disarmo. Altrimenti possiamo solo sperare che si comincino a costruire nuove bombe intelligenti: come recita un famoso detto, “così intelligenti da non scoppiare più”.
 «E’ ora di dichiarare in cosa crediamo, di unirsi e dimostrare che cambiare si può». il manifesto, 17 giugno 2017 (c.m.c)
«E’ ora di dichiarare in cosa crediamo, di unirsi e dimostrare che cambiare si può». il manifesto, 17 giugno 2017 (c.m.c)

 «Mantenere indefinitamente nella non appartenenza migliaia di bambini e adolescenti è non solo ingiusto, ma rischia di produrre estraneità e rancore». l
«Mantenere indefinitamente nella non appartenenza migliaia di bambini e adolescenti è non solo ingiusto, ma rischia di produrre estraneità e rancore». l
 «Storia antica e complessa, ma mai invecchiata, se è vero che ritorna puntualmente a galla quando ci si pone la questione di chi sono i nostri concittadini».
«Storia antica e complessa, ma mai invecchiata, se è vero che ritorna puntualmente a galla quando ci si pone la questione di chi sono i nostri concittadini».

 «Intervista a Susanna Camusso. La segretaria della Cgil lancia la mobilitazione di sabato contro la reintroduzione dei
«Intervista a Susanna Camusso. La segretaria della Cgil lancia la mobilitazione di sabato contro la reintroduzione dei 
 «Il viaggio in Italia va fatto senza ansie di compiacimento o di denuncia. Abbiamo bisogno di creature rivoluzionarie, non di manovali del rancore».
«Il viaggio in Italia va fatto senza ansie di compiacimento o di denuncia. Abbiamo bisogno di creature rivoluzionarie, non di manovali del rancore». 
 «Oggi, che siamo tutti connessi e illusi di avere radar tentacolari e altoparlanti potenti, abbiamo l’impressione, fondata, di essere inascoltati – il rumore resta un brusio indecifrabile».
«Oggi, che siamo tutti connessi e illusi di avere radar tentacolari e altoparlanti potenti, abbiamo l’impressione, fondata, di essere inascoltati – il rumore resta un brusio indecifrabile».  «Esperti e tecnici che si dedicano solo a contare e ottimizzare sono pericolosi».
«Esperti e tecnici che si dedicano solo a contare e ottimizzare sono pericolosi».  «Anche in questo caso sembra prevalere la figura che Alain Deneault ha definito lo “stupido funzionale”».
«Anche in questo caso sembra prevalere la figura che Alain Deneault ha definito lo “stupido funzionale”».

 Left, 9 giugno 2017 (c.m.c.)
Left, 9 giugno 2017 (c.m.c.)