


il Fatto quotidiano, 18 ottobre 2017 «
Sulla nuova legge elettorale e il patto scellerato che ne ha assicurato l’approvazione alla Camera si è ormai detto tutto. O quasi. Un punto mi pare sia rimasto ancora al margine nei commenti di questi giorni: il reale rapporto fra la legge e il crescente astensionismo. La legge Rosato istiga alla sfiducia nelle istituzioni perché disprezza la Costituzione e le sentenze della Consulta, insiste sulle liste bloccate, è pensata come una conventio ad excludendum di alcuni partiti ai danni di altri; inoltre, ha costretto il governo a un improprio voto di fiducia che lo delegittima, e, se sarà firmata da Mattarella, ne appannerà la figura.
La sfiducia nelle istituzioni genera astensionismo, questo lo dicono tutti; ma il prevedibile calo di affluenza alle urne viene di solito presentato come un by-product della legge elettorale, un effetto previsto ma collaterale. E se allontanare i cittadini dalle urne fosse invece, in una strategia perversa ma tutt’altro che fantapolitica, scopo primario di una legge come questa? Gli indizi abbondano, a cominciare dai grandi festeggiamenti dopo le Europee del 25 maggio 2014 per il 40,81 % del Pd, definito da Renzi “risultato storico”.
Perciò, un anno dopo aver contestato l’appoggio alla riforma costituzionale del presidente emerito Napolitano con una lettera aperta pubblicata da Repubblica il 4 ottobre 2016 (con risposta di Napolitano), stavolta mi trovo in pieno accordo con le sue pesanti osservazioni sul cosiddetto Rosatellum. Ma non sarebbe forse l’ora, alla vigilia di nuove elezioni, di fare il bilancio degli errori compiuti all’indomani delle elezioni del febbraio 2013 ? Allora il Pd, anziché tentare altre coalizioni anche di limitato scopo e durata, scelse l’abbraccio mortale con Berlusconi. Allora il capo dello Stato pretese irritualmente dal presidente incaricato Bersani di garantire una maggioranza parlamentare prima di presentarsi alle Camere, e Bersani piegò la testa rinunciando al mandato. Allora Beppe Grillo derise apertamente chi invitava M5S e Pd a negoziare una coalizione d’obiettivo, con il programma di risolvere annose questioni come una sana legge elettorale e una legge sul conflitto d’interessi, e i due appelli in merito (9 marzo: Un patto per cambiare, se non ora, quando? e poi 10 marzo: Facciamolo!), pur raccogliendo 200 mila firme in pochi giorni, restarono lettera morta.
Molto è cambiato da allora, ma qualcosa di uguale è rimasto: la scarsa democrazia interna dei partiti, dal Pd al M5S, che favorisce l’astensionismo creando condizioni favorevoli a una politica che sull’astensionismo fa leva; mentre i fuoriusciti dal Pd non trovano nemmeno la strada per far blocco tra loro. La legge elettorale contribuisce a tener fissa la bussola del discorso politico sul “come” e non sul “che cosa”, sulle coalizioni e non sulle necessità del Paese, sui giochi di potere e non sui programmi di governo. Proprio nessuno vuol provare a porvi rimedio? Nessuno vuol provare a capovolgere le regole del gioco, facendo leva sulla democrazia interna di partito e su un chiaro progetto di attuazione dei diritti costituzionali per riportare alle urne quegli stessi giovani elettori che il 4 dicembre mostrarono fiducia nella Costituzione?
la Repubblica,
Dopo le elezioni tedesche, anche quelle austriache confermano le trasformazioni politiche in corso nel vecchio continente, la cui faccia sta decisamente prendendo una fisionomia di destra, e perfino nazi-fascista. Il populismo è lo stile e la strategia che le vecchie idee di destra (il razzismo, l’intolleranza, l’ideologia identitaria nazionalista, il mito maggioritarista e anti-egualitario) adottano per conquistare gli elettori moderati. I partiti di destra sono quelli che meglio usano questa strategia; ne hanno anzi bisogno per uscire dall’isolamento nel quale l’ideologia socialdemocratica li aveva condannati per decenni.
Sebastian Kurz, alla guida del partito dei popolari, ha trasformato il suo partito in un movimento elastico, aggressivo sui social, attento all’immagine e capace di usare gli argomenti giusti: la paura dell’immigrazione, la preoccupazione per la precarietà occupazionale, l’erosione del benessere.
L’Austria è tra i Paesi più ricchi d’Europa e con una popolazione residente straniera che sfiora il 15%. La campagna elettorale di Kurz è stata radicalmente personalistica (il suo nome ha dato il nome alla lista) e ossessivamente imbastita sulla paura, tanto da fare apparire l’Austria come un Paese straniero agli austriaci, sul baratro economico e con il rischio di avere una maggioranza religiosa islamica. La personalizzazione e la radicalizzazione del messaggio hanno fatto volare il suo partito. Altrettanto vincente la strategia del partito di estrema destra neo-nazista, detto della libertà, guidato da Heinz-Christian Strache che potrebbe essere alleato del partito di Kurz.
La ricetta per il governo del Paese di questa ipotetica coalizione è un misto di protezionismo e liberismo: chiusura delle frontiere agli immigrati, difesa dell’identità culturale cattolica, sicurezza e taglio delle tasse. Liberisti e nazionalisti alleati. Il restyling dei due partiti di destra ha pagato, smussando il messaggio nazista e islamofobico e insistendo su una strategia che da qualche anno sta facendo proseliti a destra.
La critica alla tecnocrazia di Bruxelles non porta più alla proposta di uscire dall’Unione. L’Europa va conquistata, non lasciata. Il populismo transnazionale di destra non propone il ritorno agli stati nazionali indipendenti, non ha nostalgie per un’Europa pre-Trattato di Roma. Comprende l’utilità dell’Unione e vuole però guidarla in conformità a quella che il leader ungherese Viktor Orbán (il primo ad aver lanciato la proposta di una destra populista transnazionale) ha definito come l’identità spirituale del continente: la cristianità. La secolarizzazione, soprattutto nella parte occidentale del continente, è un fatto difficilmente negabile. E quindi l’appello alla cristianità ha poco a che fare con la spiritualità religiosa e molto con l’identità nazionale. Il populismo di destra è oggi un progetto identitario transnazionale.
La storia del populismo è innestata nella storia della democrazia; una competizione con la democrazia costituzionale sulla rappresentanza e la rappresentazione del popolo, che nei Paesi europei è in effetti la nazione. La tendenza a identificare il popolo con un’entità organica omogenea è il motore che muove questa potente interpretazione della sovranità come sovranità di una parte, maggioritaria, contro un’altra, per umiliare l’opposizione e soprattutto le minoranze culturali.
Le democrazie del dopoguerra hanno neutralizzato questa tendenza olistica articolando la cittadinanza nei partiti politici. E il dualismo destra/sinistra è stato un baluardo di protezione della battaglia politica dalle pulsioni identitarie, nazionaliste e fasciste. La fine di questa distinzione è oggi il problema; essa è stata favorita dalla sinistra stessa che, nel solco del blarismo ha sostenuto la desiderabilità di andare oltre la divisione destra/sinistra. Una iattura che ha preparato il terreno alla destra.
L’uso di strategie comunicative populiste si dimostra vincente anche perché l’audience è informe e con deboli distinzioni idelogiche; facile da conquistare con messaggi generici, gentisti diremmo, ovvero basati sul buon senso e capaci di arrivare a tutti indistintamente. La caduta di partecipazione elettorale, che l’erosione della distinzione destra/ sinistra ha portato con sé, è un segnale preoccupante di cui purtroppo quel che resta della sinistra non si avvede. L’esercito elettorale di riserva è pronto, depoliticizzato abbastanza da essere catturato da messaggi populisti di destra, generici, e molto semplici.
Il caso austriaco, come quello tedesco di poche settimane fa, è quasi da manuale nel dimostrare quanto danno abbia fatto alla democrazia la convinzione che destra e sinistra appartengano al passato. Di questa insana idea si approfitta la destra, che da parte sua non ha mai messo quella distinzione in soffitta.

il manifesto, 14 ottobre 2017.
L’intervento è stato fatto in chiusura dell’incontro organizzato nel cuore del Tuscolano, in piazza Giulio Agricola, davanti alla gigantesca basilica di San Giovanni Bosco, la stessa che è stata ingiustamente resa nota nel 2015 dai funerali di Vittorio Casamonica, già considerato uno dei «Re di Roma», accusato di usura, racket e traffico di stupefacenti. La stessa chiesa fu negata nel 2006 per i funerali di Piergiorgio Welby, militante del Partito Radicale, deceduto dopo l’intervento del personale medico che decise di rispondere alla sua volontà di terminare la sua agonia. La «Rete dei numeri pari» ha voluto organizzare l’incontro per dimostrare l’esistenza di una società diversa. «Da qui vogliamo dire che esiste un’altra Italia – ha detto Giuseppe De Marzo (Rete Numeri Pari) che pensa che la solidarietà sia un elemento distintivo della democrazia e provano a evidenziarlo costruendo percorsi di mutualismo in tutto il paese». In piazza si è tenuto un pranzo sociale, mentre il giornale di strada «Shaker, pensieri senza fissa dimora» – prodotto dal centro di accoglienza e di prima assistenza ai senza fissa dimora «Binario 95» alla stazione Termini – è stato distribuito dai suoi redattori.
Dal palco della manifestazione è stata declinata un’agenda politica basata sul diritto alla casa, su quello allo studio, sui diritti delle donne e la dignità delle persone. A questi temi Don Ciotti ha aggiunto due nodi importanti: lo «Ius soli» e la legge elettorale. «Lo Ius Soli – ha detto – è una legge giusta, mi fa piacere l’impegno del presidente del Consiglio ad approvarlo in questa legislatura». E sulla legge elettorale: «È terribile, è la democrazia che viene calpestata». «L’inclusione sociale sta alla base della democrazia – ha aggiunto Don Ciotti – Alzate la voce quando gli altri scelgono un comodo silenzio. Se molti diritti sono stati calpestati è anche colpa nostra che non li abbiamo difesi abbastanza». «La speranza si costruisce partendo dai poveri ha aggiunto – Da lì si deve partire – ha aggiunto – ad alta voce, per restituire l’economia alla vita, perché se così non è, non sappiamo che cosa farcene di questa economia».

la Repubblica,.» (c.m.c.)
La maggior parte dei commentatori della legge elettorale in discussione in Parlamento assume come punto di vista le ragioni, buone o cattive che siano, dei partiti e di coloro che ne fanno parte. Ma, una legge elettorale deve essere considerata anche, anzi soprattutto, dalla parte degli elettori, i cui diritti mi paiono sottovalutati, per non dire ignorati. I cittadini, invece che come protagonisti di quel momento-clou della democrazia che sono le elezioni, sono trattati come pedine d’un gioco nelle mani di chi sta sulla loro testa. In democrazia, dovrebbe essere piuttosto il contrario. Si tratta di cose ovvie e il fatto che debbano essere dette indica di per sé che si è perso il contatto con la realtà.
In primo luogo, non qualunque legge elettorale è compatibile con il rispetto dell’elettore, ma solo la legge sufficientemente chiara da essergli facilmente comprensibile. Si deve sapere qual è il valore del proprio voto, cioè come verrà utilizzato nel procedimento elettorale che parte da lui e si conclude con l’assegnazione dei seggi in Parlamento. La storia dei sistemi elettorali in Italia è una storia di progressiva complicazione, giunta ora al punto dell’incomprensibilità.
È nata perfino una nuova figura professionale: quella degli esperti-tecnici di sistemi elettorali. Solo loro ne capiscono qualcosa e non sempre sono d’accordo su ciò che credono di avere capito. Ogni complicazione rispetto a idee chiare e semplici corrisponde all’interesse particolare di questo o di quel partito o gruppo politico, onde è facile concludere: tante complicazioni, altrettante manipolazioni. Oggi siamo arrivati a un vertice forse non più superabile. Si dirà: i sistemi elettorali, tutti, sono congegni complicati. Ma, c’è un limite che sarebbe bene non superare per evitare che i cittadini, quando vanno a votare, non sappiano quello che fanno, che siano marionette mosse da fili che nemmeno riescono a vedere e a comprendere. Esagerazione? Si vada agli articoli 77, 83 e 83 bis della legge ora approvata dalla Camera e si dica se si capisce qualcosa circa il computo e la valenza del voto per l’elezione dei candidati nelle due quote previste, la quota uninominale e quella proporzionale.
Il legislatore si è reso conto della perversione e ha pensato due cose. La prima è di affiancare “esperti” agli organi cui spettano lo scrutinio e la proclamazione dei risultati e degli eletti (questa, per la verità, non è cosa nuova, ma una conferma che sul legislatore elettorale le complicazioni esercitano un’irresistibile forza attrattiva). La seconda è di scrivere sulla scheda elettorale le “istruzioni per l’uso”. Così l’elettore, ricevuta la scheda, dovrebbe studiare prima di votare. Se ha dei dubbi, forse potrebbe interpellare il presidente del seggio. Il presidente del seggio, eventualmente, potrebbe voler sentire qualche parere, perché si tratta di cose importanti.
Basta immaginare che cosa potrebbe accadere per rendersi conto della ridicolaggine o, se si vuole, della presa in giro. Molti saranno scoraggiati dall’andare a votare, più di quanti già siano. La platea dei votanti, e con essa la democrazia, si sta contraendo a coloro che in qualche modo e per qualche ragione militano in un partito o in un movimento. Ma, le elezioni non dovrebbero essere solo per i “militanti”. Si diffonde così l’idea della politica come cosa riservata a una nuova oligarchia che degli interessi generali poco si cura, preferendo dedicarsi principalmente agli interessi suoi e a regolarli al proprio interno. A qualunque oligarchia e anche a questa, la partecipazione politica importa niente. Anzi, è un fastidio. Per questo la crescente diserzione dalle urne non suscita preoccupazione, non suona come un campanello d’allarme.
Ancora dal punto di vista dei diritti dell’elettore, un punto critico della legge è il voto unico che vale per due fini diversi. Il sistema elettorale è congegnato in modo tale da sommare una parte di eletti con un sistema uninominale maggioritario (il 36 per cento) con un’altra parte di eletti secondo un sistema proporzionale di lista (il 64 per cento). Per questa seconda parte, le liste dei candidati sono prestabilite dai partiti e sono bloccate, non esistendo il voto di preferenza. Qui s’innesta la polemica sui “nominati”, che continueranno a prosperare per i due terzi o, dicono alcuni, per il cento per cento, posto che anche i candidati nei collegi uninominali saranno necessariamente indicati dai partiti. Di questo si è discusso ampiamente e non è il caso di ritornarci su.
Invece da discutere è il meccanismo per cui l’elettore è chiamato a esprimere il suo unico voto per scegliere il candidato nel collegio uninominale e quel suo voto è calcolato anche per eleggere i candidati nelle liste proporzionali a lui collegate. Uninominale e proporzionale sono due sistemi basati su logiche addirittura opposte. Mescolarli significa di per sé fare confusione e adulterare artificiosamente la rappresentanza che può essere concepita o nell’un modo o nell’altro, ma non e nell’uno e nell’altro: le idee di giustizia elettorale sono incompatibili. Come può lo stesso voto valere la prima volta per un sistema e la seconda per il sistema opposto? Si dirà: anche in passato c’è stato questo mescolamento, con il sistema detto Mattarellum. Tuttavia, allora l’elettore disponeva di due voti, per l’una e per l’altra quota della rappresentanza. Oggi, egli può trovarsi nella contraddittoria posizione di volere eleggere il candidato maggioritario, ma di non voler contribuire a eleggere i candidati proporzionali della lista bloccata preconfezionata per lui (qualcuno direbbe: propinata) dal partito, oppure viceversa.
È un sistema tecnicamente bastardo che nell’uno o nell’altro caso coarta la libera volontà dell’elettore. Anche a questo proposito si vede con quanto poco rispetto i cittadini elettori siano considerati dal loro legislatore. Poiché più volte la Corte costituzionale in passato e con insistenza ha ritenuto illegittimi i sistemi di voto che coartano in questo modo la libera volontà dell’elettore, cioè i sistemi nei quali non è garantito il rapporto uno a uno, una scelta un voto, è facile di previsione che i dubbi d’incostituzionalità su questo punto tutt’altro che marginale siano difficilmente superabili.
Si poteva sperare che l’occasione della legge elettorale fosse colta per cercare di colmare l’enorme fossato che separa la maggioranza dei cittadini dalle espressioni della politica. Bisogna riconoscere che l’occasione è andata sprecata, che anzi ciò che abbiamo davanti agli occhi è l’allargamento del fossato. Che cosa ci dicono le piazze contrapposte al “palazzo”? Le prime ribollenti, il secondo che procede imperterrito come se niente fosse. Che cosa ci dice l’astensione già altissima che si preannuncia ancora più alta, a testimonianza di umori, questi sì, antipolitici perché intrisi di rabbia e di repulsione nei confronti di una politica sempre più, come si dice, “autoreferenziale”? C’è poco da consolarsi guardando all’astensionismo di altri Paesi: là c’è disinteresse ma qui c’è disprezzo. E dove tra i rappresentanti e i rappresentati c’è disistima diffusa, lì la democrazia è a rischio. Il coperchio può saltare da un momento all’altro e sprigionare energie di qualunque temibile natura. C’è qualcuno che seriamente si rende conto di questo pericolo?
Tra governanti e governati, quale che sia il sistema costituzionale, è sempre esistito un solco. È inevitabile. La dimensione, però, è variabile, e la democrazia non può permettersi che s’allarghi oltre misura. Oggi la misura è certamente già superata. Solo il fatto che vi sia un movimento che finora ha parlamentarizzato e quindi politicizzato lo scontento impedisce di vedere chiaramente quanto il solco sia largo e profondo. Per rendersene conto basterebbe ascoltare i discorsi che si fanno liberamente nelle strade e nelle piazze tra persone che, una volta, si sentivano parti d’una comunità politica e ora non più. Vogliono solo essere lasciati in pace. Con questo popolo dei diseredati della politica, i politici hanno progressivamente perso il contatto.
Per lo più, nel migliore dei casi, ascoltano quello che resta dei loro militanti e dei loro elettori e lì tra loro, ovviamente, trovano consolazioni. Ma, così, si condannano ad avere una visione distorta e tranquillizzante della realtà. Oppure, avvertono pericoli e s’inquietano. Ma, per arginare questo risentimento, invece di conoscerne e riconoscerne le ragioni, finiscono per rinforzarlo chiudendosi nel bunker ch’essi stessi hanno eretto a propria difesa. Tanti mezzi difensivi sono utilizzabili; tra questi anche le leggi elettorali. Che le elezioni servano a una classe politica per difendersi, e non per aprirsi, non è, però, cosa della democrazia.

Internazionale
Contraddizioni
La lotta in questi contesti è più aspra che altrove, ed è lì che sta emergendo una generazione nuova di delegati sindacali stranieri: sia nei sindacati confederali, sia – e spesso soprattutto – in quelli di base. Cominciano a essere loro la prima forma di rappresentanza di un’Italia diversa. Ma da qui a una rappresentanza più vasta ancora ce ne vuole. Finora, non si è ancora superata la dimensione locale o quella dei sindacati di categoria.

il manifesto
E’ imperdonabile dopo una legge elettorale rigettata dalla Consulta per i suoi tratti incostituzionali. Imperdonabile che una legge rigettata e prodotta per emendare una precedente formula invalidata perché anch’essa contraria ai principi della Carta, il governo riprovi nel mestiere della manipolazione della tecnica di trasformazione dei voti in seggi. Un capo politico che ha per ideologia la “rottamazione” non può che sprigionare una immensa carica distruttiva.
Desta semmai meraviglia che gli osservatori che lo hanno a lungo incensato parlino solo oggi di “colpo di mano” o persino di legge “fascistellum” non cogliendo che le laceranti prove di forza in aula sono i frutti del tutto prevedibili dell’ideologia della rottamazione. Che Renzi conduca all’eutanasia il suo non-partito è irrilevante. Che distrugga, con la sua opera provocatoria, anche degli assi portanti della repubblica è invece una cosa piuttosto grave.
Il successo del no a dicembre era un macigno scagliato non solo contro il governo, costretto ad archiviare la grande riforma che “da 70 anni il paese attendeva”. Conteneva anche una censura esplicita verso la condotta poco accorta di ben due presidenti. Di sicuro non si può invocare il soccorso del Quirinale per arginare prove di arbitrio che attengono per intero alla deriva della cultura politica del Pd che è diventato il principale attore dell’agguato alla costituzione. Ma la campana del 4 dicembre ha suonato anche per il Colle.
Che dopo 10 anni di elezioni illegali di nuovo aleggi lo spettro di una condotta corsara per fabbricare una legge conveniente ai capi (per la nomina del ceto politico obbediente e per la penalizzazione dei concorrenti alla conquista di Palazzo Chigi) è uno scenario che non può che allarmare i custodi. Il capo dello Stato, in condizioni normali, deve tenersi lontano dal gioco politico. Quando però si persevera nell’emergenza, e la competizione si svolge con forzature illiberali delle regole, il distacco non è di sicuro un inchino doveroso all’autonomia della politica ma un gesto di indifferenza al gioco che diventa sempre più sporco.
Rispetto all’abuso di potere, il capo dello Stato è uno degli argini di cui il sistema dispone. Quando nel 2005 Ciampi non si oppose, come invece doveva, al Porcellum seguì una condotta censurabile perché la nuova legge era approvata a ridosso del voto e non si era ancora affermata la consuetudine di un possibile pronunciamento della Consulta. Quindi, in quel tempo, il presidente era il custode fondamentale dell’ordinamento e il suo silenzio sulla legge Calderoli comportò guasti sistemici prolungati. Accettare il conflitto tra poteri è un bene per l’equilibrio delle istituzioni, un malinteso spirito conciliativo provoca invece tensioni istituzionali irreparabili.
Il fatto nuovo della possibilità di un coinvolgimento della corte nel giudizio di costituzionalità del diritto elettorale attenua certamente la responsabilità del controllo iniziale spettante al capo dello Stato. Il sistema delle garanzie alla fine, inventando il controllo della Consulta, ha ritrovato il modo di espellere un intervento incostituzionale denominato Porcellum prima e Italicum dopo. Però la ristrettezza dei tempi che separano dal voto, questa volta non consente un tempestivo vaglio della Consulta per ristabilire la legalità contro gli abissi di una nuova legge elettorale imposta a colpi di voti di fiducia.
Il calcolo (per Renzi e Salvini) è di celebrare il voto di marzo con una formula imposta manu militare con tutti i suoi evidenti vizi per poi rinviare alla prossima legislatura il compito eventuale di rimediare alla manomissione ormai compiuta. Per questo spregiudicato uso del potere, il Quirinale non può rifugiarsi nello scudo della responsabilità affievolita: i margini di correzione a protezione del principio di legalità sono tutti nella penna del presidente.
Il rischio sistemico, dinanzi a deputati nominati in liste solo approvate dal popolo, e con i risvolti di incostituzionalità paventati da Napolitano nella figura del “capo della coalizione”, è di tramutare il presidente in funzionario della minoranza che rinunciando all’intervento sanzionatorio priva l’equilibrio dei poteri di un supporto terzo che è indispensabile.
La conseguenza della firma concessa all’Italicum è stata attenuata dalla riparazione ex post della Consulta. Però sono ancora attive le pesanti conseguenze di una scommessa istituzionale che, su una mera ipotesi (assetto monocamerale), ha costruito il meccanismo elettorale maggioritario per la sola camera.
Può il capo dello Stato firmare una seconda legge imposta alle camere con l’arma indebita del voto di fiducia che umilia la funzionalità del parlamento e stravolge la base di una democrazia competitiva con un uso partigiano della tecnica elettorale? La repubblica non sarebbe più la stessa, costretta ad un pendolo pauroso che oscilla tra abuso di potere e ribellione del popolo.

il Fatto Quotidiano
Il Bacio feroce ha il sapore del sangue, come quasi tutto in questa storia di cuccioli selvaggi, vittime e carnefici negli stessi corpi, divisi tra i compiti a casa, i messaggi alle fidanzatine e gli omicidi. Undici mesi dopo La paranza dei bambini, Roberto Saviano torna in libreria con il seguito del romanzo criminale ambientato a Forcella.
Si è, provocatoriamente, candidato contro Luigi Di Maio alle consultazioni dei 5 Stelle: perché?
vocidall'estero, (c.m.c)
Riprendiamo dal sito Voci dall'estero la traduzione in italiano di un articolo comparso sulla webzine Counterpunch l'8 ottobre 2017. Si trattauna ampia analisi sulle origini e la pratica di un fenomeno finora poco esplorato ma già fortemente penetrato nelle mentalità, soprattutto della gente di sinistra: la moderna ideologia “antifascista”, che nel nome si richiama alla rispettata tradizione dei combattenti per la libertà, usurpandone il credito grazie al facile meccanismo associativo, ma nei fatti non è che una degenerazione che include nel concetto di “fascismo” tutto quel che esula dal “politicamente corretto”.All'argomento abbiamo già dedicato un'ampia rassegna su eddyburg.v
“I fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti” – Ennio Flaiano, scrittore italiano e coautore di soggetti e sceneggiature dei più grandi film di Federico Fellini.
Nelle ultime settimane, una sinistra totalmente disorientata è stata esortata da più parti a unirsi intorno ad un’avanguardia a volto coperto che si definisce Antifa, per antifascista. Incappucciata e vestita di nero, Antifa è sostanzialmente una variante dei Black Bloc, famosi per scatenare violenza nelle manifestazioni pacifiche in molti paesi. Importata dall’Europa, l’etichetta Antifa suona più politica. Serve anche allo scopo di stigmatizzare gli obiettivi che attacca come “fascisti”. Nonostante il suo nome europeo importato, Antifa è fondamentalmente solo un altro esempio della continua degenerazione nella violenza dell’America.
Precedenti storici
Antifa è salita alla ribalta per il suo ruolo nel rovesciamento della orgogliosa tradizione di “libertà di espressione” di Berkeley, per aver impedito di parlare lì a esponenti della destra. Ma il suo momento di gloria è stato il suo scontro con i conservatori a Charlottesville il 12 agosto, soprattutto perché Trump ha commentato che c’erano “persone valide da entrambe le parti”. Con esuberante Schadenfreude, i commentatori hanno colto al volo l’opportunità di condannare l’odiato Presidente per la sua “equivalenza morale”, dando così una benedizione ad Antifa.
Charlottesville è stata per Antifa l’occasione per il lancio di un successo editoriale: il Manuale Antifascista, il cui autore, il giovane accademico Mark Bray, è un Antifa sia in teoria che in pratica. Il libro “sta avendo un rapido successo“, si è rallegrato l’editore, Melville House. Infatti ha ottenuto subito il plauso di importanti media mainstream, come il New York Times, The Guardian e NBC, che finora non si erano distinti per precipitarsi a recensire libri di sinistra, men che mai quelli di anarchici rivoluzionari.
Il Washington Post ha accolto con favore Bray come il portavoce dei “movimenti di attivisti rivoluzionari” e ha osservato che «il contributo più illuminante del libro è quello sulla storia dell’impegno antifascista del secolo scorso, ma la sua parte più rilevante per il mondo di oggi è la sua giustificazione del soffocamento della libertà di espressione che colpisce i suprematisti bianchi».
Il “contributo illuminante” di Bray è quello di raccontare una versione lusinghiera della storia di Antifa a una generazione la cui visione dualistica della storia, basata sull’Olocausto, l’ha privata delle informazioni e degli strumenti analitici per giudicare eventi multidimensionali come la recrudescenza del fascismo. Bray presenta l’Antifa di oggi come il glorioso erede legittimo di ogni nobile causa dall’abolizionismo in poi. Ma non c’erano antifascisti prima del fascismo, e l’etichetta “Antifa” non si applica in alcun modo a tutti i numerosi avversari del fascismo.
La pretesa implicita di portare avanti la tradizione delle Brigate Internazionali che hanno combattuto in Spagna contro Franco non è altro che un ingenuo meccanismo associativo. Dato che dobbiamo rispettare gli eroi della Guerra Civile Spagnola, una parte di questa stima dovrebbe riversarsi sui loro autoproclamati eredi. Purtroppo, non esistono veterani della Brigata di Abraham Lincoln ancora vivi che possano indicare la differenza tra una grande difesa organizzata contro l’invasione di eserciti fascisti e le schermaglie sul campus di Berkeley. Come per gli anarchici della Catalogna, il brevetto dell’anarchismo è scaduto molto tempo fa, e chiunque è libero di mettere in commercio il proprio generico.
Il movimento Antifascista originale fu uno sforzo dell’Internazionale Comunista di cessare le ostilità con i partiti socialisti europei al fine di costruire un fronte comune contro i movimenti trionfanti guidati da Mussolini e Hitler.
Dal momento che il fascismo si è affermato, e Antifa non è mai stata un serio avversario, i suoi apologeti puntano sull’argomento dello “stroncare sul nascere“: “se solo” gli antifascisti avessero battuto i movimenti fascisti abbastanza presto, questi sarebbero stati stroncati sul nascere. Dato che la ragione e il dialogo non sono riusciti a fermare l’ascesa del fascismo, sostengono, dobbiamo usare la violenza di strada – che, a proposito, fallisce ancora più decisamente.
Questo è totalmente astorico. Il fascismo esaltava la violenza e la violenza era il suo banco di prova preferito. I comunisti e i fascisti combattevano per le strade e l’atmosfera della violenza ha aiutato il fascismo a crescere come un bastione contro il bolscevismo, guadagnando il sostegno fondamentale dei grandi capitalisti e militaristi nei loro paesi, che li hanno portati al potere.
Dal momento che il fascismo storico non esiste più, l’Antifa di Bray ha allargato il proprio concetto di “fascismo” per includere tutto ciò che viola l’attuale canone di Identità Politica: dal “patriarcato” (un atteggiamento prefascista, quantomeno) a “transfobia” (problema decisamente post-fascista).
I militanti mascherati di Antifa sembrano essere più ispirati da Batman che da Marx o anche da Bakunin. Storm Trooper del Partito di Guerra NeoliberaleDal momento che Mark Bray offre le credenziali europee per l’attuale Antifa Usa, è opportuno osservare ciò che Antifa rappresenta in Europa oggi.
In Europa, la tendenza manifesta due forme. Gli attivisti Black Bloc invadono regolarmente diverse manifestazioni di sinistra per distruggere le vetrine e combattere contro la polizia. Queste manifestazioni di testosterone hanno un significato politico minore, se non provocare pubblici appelli a rafforzare le forze di polizia. Sono fortemente sospettati di infiltrazioni della polizia.
Ad esempio, lo scorso 23 settembre, diverse dozzine di ruffiani mascherati in nero, tirando giù manifesti e lanciando pietre, tentavano di assaltare il palco da cui lo smagliante Jean-Luc Mélenchon doveva arringare la folla di La France Insoumise, oggi partito leader della sinistra francese. Il loro messaggio inespresso sembrava affermare che per loro nessuno può essere abbastanza rivoluzionario. Di tanto in tanto, effettivamente individuano a caso uno skinhead da picchiare. Ciò serve a confermare le loro credenziali “antifasciste”.
Usano queste credenziali per arrogarsi il diritto di diffamare gli altri, in una specie di inquisizione informale autoproclamata. Come primo esempio, alla fine del 2010, una giovane donna di nome Ornella Guyet è comparsa a Parigi alla ricerca di lavoro come giornalista in vari periodici e blog di sinistra. Ha “cercato di infiltrarsi dappertutto”, secondo l’ex direttore di Le Monde diplomatique, Maurice Lemoine, che quando l’ha assunta come tirocinante “da subito, intuitivamente, non ha avuto fiducia in lei“.
Viktor Dedaj, che gestisce uno dei principali siti di sinistra in Francia, Le Grand Soir, è stato tra coloro che hanno cercato di aiutarla, solo per avere una spiacevole sorpresa pochi mesi dopo. Ornella era diventata un inquisitore, dedito a denunciare “il cospirazionismo, la confusione, l’antisemitismo e il rosso-bruno” su Internet. Questo ha preso la forma di attacchi personali nei confronti di individui che lei giudicava colpevoli di questi peccati. Quello che è significativo è che tutti i suoi obiettivi si opponevano alle guerre di aggressione degli Stati Uniti e della NATO in Medio Oriente.
In effetti, i tempi della sua crociata coincidevano con le guerre dei “cambi di regime” che distrussero la Libia e la Siria. Gli attacchi prendevano di mira i principali critici di quelle guerre.
Viktor Dedaj era in cima alla sua lista. E c’era anche Michel Collon, vicino al Partito dei Lavoratori belga, autore, attivista e direttore del sito bilingue Investig’action. E anche François Ruffin, produttore cinematografico, editore del giornale di sinistra Fakir, eletto recentemente all’Assemblea Nazionale nella lista del partito di Mélenchon La France Insoumise. E così via. L’elenco è lungo.Le personalità prese di mira sono diverse, ma tutti hanno una cosa in comune: l’opposizione alle guerre di aggressione. Per di più, a quanto ne so, quasi tutti quelli che si oppongono alle guerre sono nella sua lista.
La tecnica principale è la colpa presunta per associazione. In cima alla lista dei peccati mortali sta la critica dell’Unione Europea, associata al “nazionalismo” associato al “fascismo” associato all’ “antisemitismo”, con una tendenza al genocidio. Ciò coincide perfettamente con la politica ufficiale dell’UE e dei governi dei suoi paesi aderenti, ma Antifa usa un linguaggio molto più duro.
A metà giugno 2011, il partito anti-UE Union Populaire Républicaine guidato da François Asselineau è stato oggetto di insinuazioni feroci su siti Internet di Antifa firmati da “Marie-Anne Boutoleau” (uno pseudonimo di Ornella Guyet). Temendo la violenza, i responsabili hanno annullato gli incontri del UPR a Lione. L’UPR ha fatto una piccola indagine, scoprendo che Ornella Guyet era nell’elenco degli oratori di un seminario del marzo 2009 sui media internazionali organizzato a Parigi dal Centro per lo Studio delle Comunicazioni Internazionali e dalla Scuola dei Media e degli Affari Pubblici presso la George Washington University. Un’associazione sorprendente per una così zelante attivista contro i “rosso-bruni”.
Nel caso in cui qualcuno abbia dubbi, “rosso-bruno” è un termine usato per macchiare chiunque abbia generalmente opinioni di sinistra – cioè “rosso” – con il colore fascista “marrone”. Questa accusa può basarsi sul fatto di avere lo stesso parere di qualcuno di destra, sul parlare sulla stessa piattaforma con qualcuno di destra, pubblicare accanto a qualcuno di destra, essere visti in una manifestazione contro la guerra a cui partecipa anche qualcuno di destra, e così via. È un qualcosa di particolarmente utile per il Partito della Guerra, poiché ai giorni nostri molti conservatori si oppongono alla guerra più della gente di sinistra, che si è bevuta il mantra della “guerra umanitaria”.
Il governo non ha bisogno di reprimere le manifestazioni contro la guerra. Ci pensa Antifa.
L’umorista franco-africano Dieudonné M’Bala M’Bala, stigmatizzato per antisemitismo dal 2002 per la sua scenetta televisiva in cui ironizzava su un colono israeliano come parte dell’ “Asse del bene” di George W. Bush, non è solo un obiettivo, ma serve come presunzione di colpevolezza per associazione per chiunque difenda il suo diritto alla libertà di parola – come il professore belga Jean Bricmont, praticamente nella lista nera in Francia per aver cercato di spendere una parola in favore della libertà di espressione durante un talk show televisivo. Dieudonné è stato bandito dai media, denunciato e multato innumerevoli volte, persino condannato al carcere in Belgio, ma nei suoi spettacoli continua a fare il pienone di sostenitori appassionati, e il principale messaggio politico è l’opposizione alla guerra.
Tuttavia, le accuse di essere tolleranti su Dieudonné possono avere gravi effetti sugli individui in posizioni più precarie, in quanto in Francia il semplice accenno di “antisemitismo” può distruggere una carriera. Gli inviti vengono annullati, le pubblicazioni rifiutate, i messaggi non ottengono risposta.
Nell’aprile del 2016, Ornella Guyet è sparita dalla circolazione, in un contesto di forti sospetti sulle sue personali associazioni.
La morale di questa storia è semplice. Rivoluzionari radicali auto-proclamati possono essere la psicopolizia più utile per il partito della guerra neoliberale.
Non voglio dire che tutti, o la maggior parte, degli Antifa siano agenti dell’establishment. Solo che possono essere manipolati, infiltrati o qualcun altro si può spacciare per uno di loro, proprio perché si autorizzano da soli e di solito sono più o meno a volto coperto.
Silenziare il necessario dibattito
Chi è certamente sincero è Mark Bray, autore di The Intifa Handbook. È chiaro da dove proviene Mark Bray, quando scrive (p.36-7): «… la soluzione finale di Hitler uccise sei milioni di ebrei nelle camere a gas, con plotoni di esecuzione, per fame e mancanza di cure mediche in campi squallidi e nei ghetti, con le percosse, facendoli lavorare fino alla morte e portandoli al suicidio per disperazione. Nel continente circa due ebrei su tre sono stati uccisi, compresi alcuni dei miei parenti».
Questa storia personale spiega perché Mark Bray sente con tanta passione il tema del “fascismo”. Questo è perfettamente comprensibile in una persona ossessionata dalla paura che “possa accadere di nuovo”. Tuttavia le ondate emotive, anche le più giustificate, non portano necessariamente saggi consigli. Le reazioni violente alla paura potrebbero sembrare forti ed efficaci quando in realtà sono moralmente deboli e praticamente inefficaci.
Siamo in un periodo di grande confusione politica. Etichettare ogni manifestazione “politicamente scorretta” come fascismo impedisce la chiarezza del dibattito su questioni che hanno molto bisogno di essere definite e chiarite. La scarsità di fascisti è stata compensata identificando la critica dell’immigrazione come fascismo. Questa identificazione, in connessione con il rifiuto delle frontiere nazionali, deriva gran parte della sua forza emotiva soprattutto dalla paura ancestrale della comunità ebraica di essere esclusa dalle nazioni in cui si trova.
La questione dell’immigrazione ha aspetti diversi in luoghi diversi. Nei paesi europei non è la stessa cosa che negli Stati Uniti. C’è una distinzione di base tra immigrati e immigrazione. Gli immigrati sono persone che meritano considerazione. L’immigrazione è una politica che deve essere valutata. Dovrebbe essere possibile discutere la politica senza essere accusati di perseguitare la gente. Dopo tutto, i leader sindacali tradizionalmente si sono opposti all’immigrazione di massa, non per razzismo, ma perché può essere una strategia capitalista deliberata per ridurre i salari.
In realtà, l’immigrazione è un soggetto complesso, con molti aspetti che possono portare a ragionevoli compromessi. Ma estremizzare il problema fa cadere la possibilità di compromesso. Facendo dell’immigrazione di massa la regina delle prove sull’essere fascisti o meno, l’intimidazione di Antifa impedisce una discussione ragionevole. Senza discussione, senza la disponibilità ad ascoltare tutti i punti di vista, la questione semplicemente dividerà la popolazione in due campi, pro e contro. E chi vincerà un tale confronto?
Un recente sondaggio* mostra che l’immigrazione di massa è sempre più impopolare in tutti i paesi europei. La complessità della questione è dimostrata dal fatto che nella maggior parte dei paesi europei la maggioranza della gente crede di avere il dovere di accogliere i rifugiati, ma non approva la continua immigrazione di massa. L’argomento ufficiale secondo cui l’immigrazione è cosa buona e utile è accettato solo dal 40%, rispetto al 60% di tutti gli europei, i quali ritengono che “l’immigrazione è un male per il nostro Paese”. Una sinistra la cui causa principale sono le frontiere aperte diventerà sempre più impopolare.
Violenza infantile
L’idea che il modo per far tacere qualcuno sia di assestargli un pugno sul muso è americana come i film di Hollywood. È anche tipica della guerra tra gang di alcune zone di Los Angeles. Fare banda con quelli “come noi” per combattere le bande degli “altri” per il controllo del territorio è caratteristica dei giovani in circostanze incerte. La ricerca di una causa può conferire a questi comportamenti uno scopo politico: sia fascista che antifascista. Per i giovani disorientati, è un’alternativa all’entrare nei Marines.
L’Antifa americano assomiglia molto a un matrimonio della classe media tra l’Identità Politica e la guerra tra gang. Mark Bray (pag. 175) mostra la sua fonte di Antifa di Washington affermando che il motivo per voler fare parte dei fascisti è di schierarsi dalla parte del “ragazzo più potente del quartiere” e tirarsi indietro in caso di paura. La nostra banda è più dura della tua.
Questa è anche la logica dell’imperialismo statunitense, che dice abitualmente dei suoi nemici: “Non lo capiscono che con la forza”. Anche se Antifa afferma di essere un movimento rivoluzionario radicale, la loro mentalità è perfettamente tipica dell’atmosfera di violenza prevalente nell’America militarizzata.
In un altro verso, Antifa segue la tendenza degli eccessi della Identità Politica che stanno schiacciando la libertà di parola in quella che dovrebbe essere la sua cittadella, il mondo accademico. Le parole sono considerate così pericolose che devono essere istituiti degli “spazi sicuri” per proteggere le persone dalle parole. Questa estrema vulnerabilità al danno causato dalle parole è stranamente legata alla tolleranza per la violenza fisica reale.
Caccia all’oca selvatica
Negli Stati Uniti, l’aspetto peggiore di Antifa è lo sforzo di guidare la disorientata sinistra americana in una caccia all’oca selvatica, seguendo “fascisti” immaginari invece di mettersi apertamente insieme per elaborare un programma positivo coerente. Gli Stati Uniti hanno la loro parte di individui strambi, aggressioni gratuite, idee pazzesche, e individuare questi personaggi marginali, da soli o in gruppi, è una distrazione enorme.
Le persone veramente pericolose negli Stati Uniti sono al sicuro a Wall Street, nei Think Tanks di Washington, negli uffici dirigenziali della sterminata industria militare, per non parlare delle redazioni di alcuni dei media mainstream che attualmente stanno adottando un atteggiamento benevolo verso gli “anti -fascisti”, semplicemente perché sono utili per concentrarsi sull’anticonformista Trump invece che su se stessi.
Antifa USA, definendo la “resistenza al fascismo” come resistenza nei confronti delle cause perse – la Confederazione, i suprematisti bianchi e, per quel che conta, Donald Trump – sta in realtà distraendo l’attenzione dalla resistenza all’establishment neoliberale dominante, che si oppone anch’esso alla Confederazione e ai suprematisti bianchi ed è già in gran parte riuscito a catturare Trump attraverso la sua implacabile campagna di denigrazione. Quel corpo dirigente che, con le sue insaziabili guerre in paesi lontani e l’introduzione di metodi di polizia, ha usato con successo la “resistenza popolare a Trump” per renderlo ancora peggiore di quanto già non fosse.
L’uso facile del termine “fascista” ostacola la identificazione ragionata e la definizione del vero nemico dell’umanità di oggi. Nel caos contemporaneo, i più grandi e pericolosi sconvolgimenti del mondo derivano tutti dalla stessa fonte, difficile da definire, ma a cui possiamo dare l’etichetta provvisoria semplificata di Imperialismo Globalizzato. Questo equivale a un poliedrico progetto di ridefinizione del mondo per soddisfare le esigenze del capitalismo finanziario, del complesso industriale militare, della vanità ideologica degli Stati Uniti e della megalomania dei capi delle potenze “Occidentali” minori, in particolare Israele. Potrebbe essere chiamato semplicemente “imperialismo”, tranne che è molto più vasto e più distruttivo dell’imperialismo storico dei secoli precedenti. È anche molto più mascherato. E poiché non contiene alcuna chiara etichetta di “fascismo”, è difficile denunciarlo in termini semplici.
La fissazione sulla prevenzione di una forma di tirannia che sorse oltre 80 anni fa, in circostanze molto diverse, ostacola il riconoscimento della mostruosa tirannia di oggi. Combattere la guerra precedente porta alla sconfitta.
Donald Trump è un outsider a cui non sarà permesso di entrare. L’elezione di Donald Trump è soprattutto un grave sintomo della decadenza del sistema politico americano, totalmente governato dal denaro, dalle lobby, dal complesso militare-industriale e dai grandi media. Le loro menzogne stanno minando la base stessa della democrazia. Antifa ha portato avanti l’offensiva contro l’unica arma ancora nelle mani del popolo: il diritto alla libertà di parola e di riunione.
Note.
*«Où va la démocratie?», inchiesta della Fondazione per l’innovazione politica a cura di Dominique Reynié, (Plon, Parigi, 2017).

Un governo illegittimo, sostenuto da una maggioranza fittizia figlia di una legge elettorale incostituzionale e spalleggiato da un capo dello Stato eletto da quella falsa maggioranza e già firmatario di una legge elettorale incostituzionale, impone la fiducia a se stesso su una nuova legge elettorale incostituzionale senza averne il potere (la legge non è di iniziativa governativa, ma parlamentare) per impedire al Parlamento di discutere, emendare ed eventualmente bocciare una norma studiata a tavolino da quattro partiti per favorire se stessi e far perdere le elezioni alla prima forza politica del Paese (il M5S) e alla sinistra non allineata, e per consentire a un pugno di capi-partito di nominarsi i due terzi delle prossime Camere, truccando le regole del gioco a pochi mesi dalle urne in barba alla raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2003 (citata anche da sentenze della Corte di Strasburgo) di non modificare le leggi elettorali nell’ultimo anno prima delle elezioni. Stiamo parlando della legge “nostra” per antonomasia: quella che regola il diritto di voto, la sovranità popolare sancita dall’articolo 1 della Carta e ora confiscata dai partiti come “cosa loro”.
I precedenti di un voto di fiducia sulla legge elettorale sono, nell’ultimo secolo, appena tre e tutti poco rassicuranti: il primo sulla legge Acerbo del 1923, che assicurò a Benito Mussolini una maggioranza in Parlamento che non aveva nel Paese; il secondo sulla cosiddetta “legge truffa” del 1953 (un modello di democrazia al confronto degli ultimi obbrobri: assegnava un piccolo premio di governabilità a chi si aggiudicava il 50% dei voti più uno); il terzo nel 2015 sull’Italicum, poi dichiarato incostituzionale dalla Corte. Infatti ieri è inorridito persino Napolitano, il che è tutto dire. Nemmeno B. aveva osato tanto nel 2005, quando impose il Porcellum, anche lui alla vigilia del voto. E dire che la legge Calderoli, portando la firma del ministro delle Riforme, era di iniziativa governativa, così come l’Italicum firmato dieci anni dopo dalla ministra Boschi: dunque in quei casi, per quanto forzata, la fiducia un senso poteva averlo. Stavolta il governo Gentiloni si era volutamente e dichiaratamente tenuto fuori dalla legge elettorale, infatti il Rosatellum-1, il Tedeschellum e il Rosatellum-2 sono stati tutti di iniziativa parlamentare. Il Rosatellum prende il nome dal capogruppo del Pd alla Camera, previo accordo con Pd, Ap, FI e Lega: due forze di maggioranza e due di opposizione. Che c’entra il governo Gentiloni?
E perché mai chi del Rosatellum non condivide il metodo (l’accordo con B. e Salvini) o il merito (coalizioni finte e solubili, nominati à gogo, niente voto disgiunto, 6 pluricandidature) dovrebbe affossare il governo? E quali cause di forza maggiore giustificano la fiducia per approvarlo in blocco, senza emendamenti né dibattiti, visto che il Parlamento ha il tempo e i numeri per votarlo con le normali procedure? E che fine hanno fatto i moniti del Quirinale contro gli abusi di fiducia anti-Parlamento?
la Repubblica
UN COLPO DI MANO
di Ezio Mauro
NON è un colpo di Stato, come urlano i grillini in piazza, ma questa decisione del governo di mettere la fiducia sulla legge elettorale è un colpo di mano: gravissimo per la materia delicata di cui tratta (una materia di garanzia per tutti) e per il momento in cui avviene, a pochi mesi dalle elezioni politiche.
Giunge così a compimento nel modo peggiore una vicenda emblematica dell’impotenza dell’intero sistema politico, e della vacuità della legislatura tutta intera, e cioè l’incapacità del Parlamento e dei partiti di trovare un’intesa alla luce del sole che doti il Paese di una regola elettorale non basata su furbizie contingenti e vantaggi di parte, ma su un meccanismo in grado di restituire ai cittadini la piena potestà di scegliere i loro rappresentanti, con una regola riconoscibile dagli elettori e riconosciuta dall’intero sistema, capace di durare nel tempo al di là dei calcoli miopi di breve periodo. Restituendo così al meccanismo della rappresentanza quella stabilità e quella neutralità che sono parte indispensabile della fiducia nella politica e nelle istituzioni, oggi perduta.
C’è una contraddizione logica nel chiamare indecentemente in causa nell’atto finale il governo che non è intervenuto nel percorso della riforma - Gentiloni lo aveva sempre escluso, dunque deve spiegare cosa l’ha convinto a cambiare idea - perché faccia scattare il lucchetto della fiducia, troncando il confronto parlamentare per paura delle imboscate nascoste nel voto segreto.
PROPRIO lo spettro dichiarato dei franchi tiratori, che agita questa legge elettorale come i fantasmi abitano i castelli d’Inghilterra, è la prova patente di quanto poco i partiti-padri di questa legge si fidino della sua capacità di convincere e coinvolgere i loro parlamentari, come capita ad ogni confisca di sovranità politica da parte dei vertici più ristretti.
C’è poi una contraddizione tutta politica, clamorosa e sotto gli occhi di tutti: cosa c’entra un patto di maggioranza (riconfermato e blindato a forza con il voto di fiducia) con un provvedimento che nasce trasversale, a cavallo tra gran parte dell’area di governo e una certa opposizione, anzi per dirla tutta da un’intesa tra il Pd e Forza Italia con il concorso interessato della Lega e del partitino di Alfano? In questo modo si svilisce anche l’istituto parlamentare e lo stesso voto di fiducia, uno dei momenti più significativi del rapporto tra il governo e le Camere: qui invece ridotto a puro espediente tecnico, dove non è in gioco la fiducia e nemmeno il governo, ma entrambi diventano puri strumenti servili di un consenso indotto e forzato, con la destra che esce dall’aula per far passare in un giorno pari la fiducia ad un governo a cui si oppone nei giorni dispari.
L’ultima contraddizione - in realtà la prima - è del Pd, il partito che regge la maggioranza, il governo e ha chiesto la fiducia. In epoca di crisi conclamata della rappresentanza, queste operazioni servono solo a testimoniare un arrocco di forze politiche spaventate per un’autotutela ad ogni costo, dando fiato ai partiti antisistema che quanto più sono incapaci di produrre politica in proprio, tanto più ricevono forza dagli errori altrui. Avevamo sempre chiesto una legge elettorale: ma non a qualsiasi costo. Non con il capolavoro di un voto che sembra costruito apposta per creare sfiducia.
TRE FIDUCIE, POI ALTRE TRE
di Andrea Fabozzi
«Legge elettorale. Cambia la maggioranza, a chiedere la fiducia sul Rosatellum sono il Pd con Forza Italia, Lega e Ap. Gentiloni "non era entusiasta" ma si adegua grazie alla copertura del Quirinale. Mattarella preoccupato soprattutto di andare al voto con le attuali leggi non omogenee. Renzi vuole andarci presto e per questo la forzatura, sulla quale potrebbe essere chiamata presto la Corte costituzionale, si ripeterà al senato»
Non si sente niente. Quando la presidente della camera Boldrini dà la parola alla ministra Finocchiaro per consentirle di porre la questione di fiducia sulla legge elettorale, dai banchi M5S si urla «venduta» e si lanciano fascicoli e rose rosse («per simboleggiare la morte della democrazia»), dai banchi di Sinistra italiana e Mdp si grida «vergogna». La ministra fa la sua comunicazione resistendo a un tentativo di placcaggio di La Russa, poi quasi scappa via. Si vede che non è contenta, nei giorni scorsi aveva lasciato intendere che la fiducia non era necessaria, appartiene alla corrente del ministro Orlando che è l’unico ad aver sollevato dubbi nel governo.
Gentiloni, che per mesi ha ripetuto di voler solo «seguire» e «spronare» il lavoro del parlamento sulla legge elettorale, «non era affatto entusiasta» della richiesta di mettere la fiducia arrivata dal Pd, per conto anche di Forza Italia, Lega e Ap. Il racconto è del capogruppo democratico Rosato e l’auto-retroscena fa parte dell’accordo con il capo del governo: il Pd mette in scena con il massimo della teatralità una richiesta prevedibile, perché già sperimentata con l’Italicum. Da Mattarella, oggi come allora, arriva il via libera, con una nota in cui si liquida la questione fiducia come «attinente al rapporto parlamento governo» ma si insiste sul valore positivo della riforma elettorale.
Il comunicato del Colle è identico a quello con cui due anni fa Mattarella non si oppose alla fiducia sull’Italicum, deludendo le opposizioni (anche, all’epoca, Forza Italia e Lega). In più adesso c’è la preoccupazione del presidente della Repubblica per un risultato elettorale affidato alle due leggi «non omogenee» consegnate dalla Consulta (risultato che toccherà a lui gestire) e la considerazione che ancora più pesante, perché senza reali precedenti, sarebbe stato un decreto elettorale. Sotto l’ombrello del Quirinale si posiziona anche la presidente Boldrini – «la fiducia è una prerogativa del governo» – che due anni fa aveva riconosciuto «una logica» a chi faceva notare come per il regolamento della camera non si possono chiedere fiducie quando è prescritto il voto segreto, che è sempre possibile sulle leggi elettorali.
Non mancano altri argomenti, visto che l’articolo 72 della Costituzione impone «la procedura normale di esame e approvazione» per le leggi elettorali. In questo caso gli unici due precedenti contrari precedenti all’Italicum non fanno testo, perché uno risale al fascismo (legge Acerbo) e l’altro alla legge «truffa» quando l’ostruzionismo bloccava l’aula e il presidente del senato si dimise. È infatti il precedente dell’Italicum a consentire la nuova fiducia. Allora Napolitano non era più al Quirinale, ma caldeggiò la fiducia malgrado anche quella legge contenesse l’indicazione del «capo della forza politica» che, adesso il presidente emerito ha chiesto di correggere. Fuori tempo massimo e invano.
Perché non ci sarà nessuna discussione sugli emendamenti, soprattutto quelli a voto segreto (un centinaio) che avrebbero potuto fermare il Rosatellum. Oggi le prime due fiducie, domani quella sull’articolo tre – una delega che in pratica il governo dà a se stesso per ridisegnare i collegi – e i voti sugli ultimi due articoli (senza rischi, contengono norme favorevoli a Mdp sulla raccolta delle firme). Poi, forse venerdì, il voto finale. Inevitabilmente segreto, ma che preoccupa meno il Pd rispetto agli emendamenti. Il margine di vantaggio è ampio, circa duecento voti.
Proprio l’inevitabilità alla camera dell’ultimo voto segreto, dove i franchi tiratori potrebbero conquistare il bottino pieno, abbattendo la legge, aveva alimentato gli scetticismi sulla fiducia. La giornata di ieri ha chiarito che la vera ragione di questa mossa è quella di fare presto, per ripetere lo stesso aut aut ai senatori. Dai primi di novembre – orientativamente dalla settimana che comincia il 6, ma anche in questo caso è il governo che dà le carte – il senato sarà in sessione di bilancio; l’obiettivo del Pd è di far approvare definitivamente la legge, ancora con la fiducia, entro quella data. Servirà un’altra corsa, una settimana di lavoro in commissione e una in aula.
I numeri con cui ieri a palazzo Madama è passata la legge europea (solo 118 sì) testimoniano la difficoltà. Se alla camera i berlusconiani non hanno dovuto votare la fiducia, al senato l’assenza al momento della chiama potrebbe non dare sufficienti garanzie.
Ma è un altro il rischio che governo e maggioranza accettano di correre, approvando ancora una legge elettorale con la fiducia. È vero che la precedente, l’Italicum, non è stata sanzionata dalla Corte costituzionale per questa ragione (lo è stata com’è noto per altre) ma solo perché nessun tribunale aveva sollevato il problema davanti ai giudici delle leggi. Che anzi, rifiutando di auto assegnarsi il quesito, nulla avevano detto sulla pertinenza di questo genere di dubbi di costituzionalità. Accade adesso che già venerdì (a Messina) e poi per tutto il mese di ottobre, quattro tribunali (gli altri sono Lecce, Venezia e Perugia) potrebbero accogliere queste nuove osservazioni sollecitate dall’avvocato Besostri. Il problema della fiducia sulle leggi elettorali, allora, può arrivare comunque alla Consulta. A ridosso delle prossime elezioni
Il Fatto Quotidiano ha lanciato una petizione per chiedere che gli elettori possano scegliere i parlamentari: finora le firme raccolte sono 79mila (clicca qui per firmare).

la Repubblica
Guai a considerare il latino una lingua morta. Il primo striscione che gli operai dell’Ilva stringono fra le loro mani recita “Pacta servanda sunt”. E mica latino maccheronico, ma addirittura una perifrastica (passiva) per ricordare che i patti firmati a suo tempo vanno rispettati.
La rabbia di Genova si sveglia all’alba. Alle cinque del mattino sono già in mille dentro la fabbrica di Cornigliano, la stessa che a fine maggio ha ospitato Papa Francesco in vista pastorale, che qui aveva parlato di “dignità del lavoro”. «Eccola la risposta alle parole del Papa, quattromila esuberi e diecimila riassunti con il Jobs Act» spiega Ivan. «Ivan di nome, incazzato di cognome» aggiunge quando i mille dalla fabbrica sono già usciti in strada e iniziano a marciare verso il centro, destinazione finale la Prefettura.
I numeri degli tagli sono minori di quelli di Taranto, ma non la voglia di urlare tutto il proprio no a un piano che qui, a Cornigliano, cancella seicento operai su millecinquecento, il 40% della forza lavoro e, di fatto, azzera l’accordo di programma. Eccolo “il patto”, o meglio “i patti” dello striscione latino. Qui l’accordo di programma si ripete come un mantra, mentre gli operai camminano lenti dal ponente operaio fino al centro borghese della città. Con loro ci sono i camalli del porto, ma anche i vigili del fuoco, e tanti altri.
E poi c’è la chiesa, con i cappellani del lavoro che ogni settimana si chiudono in fabbrica a parlare con gli operai. La linea l’ha data per primo il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, che ha chiesto di “trattare fino allo strenuo”. Gli operai parlano di lui e delle sue parole. «È uno di noi quando c’è da parlare di lavoro» spiega Luca che si è fermato a bere un caffé con un amico. Davanti a tutti cammina un “Hyster”, gigantesco mezzo meccanico da 65 tonnellate usato per spostare i rotoli d’acciaio che a Cornigliano arrivano da Taranto a Genova via treno o via mare per essere lavorati e trasformati in prodotti finiti.
Un tempo anche qui a Cornigliano si produceva l’acciaio, ma nel 2005 l’altoforno, dopo anni di battaglie fra ambiente e lavoro, è stato chiuso. È allora che è nato l’accordo di programma, un’intesa fra governo, azienda e sindacati che scrivendo la parola fine alla “colata continua” manteneva però i posti di lavoro in attività “a freddo”, di laminazione dell’acciaio. All’epoca il padrone delle ferriere si chiamava Emilio Riva. I conti li faceva ancora con il “lapis”, lui che si era diplomato in ragioneria alle serali e che aveva iniziato nel dopoguerra vendendo rottami. L’Emilio con i lavoratori si scontrava, ma poi li portava in trattoria al Sassello e tornava la pace. In quel 2005 si sancì che nessuno sarebbe più uscito dalla fabbrica, se non di sua volontà.
All’epoca i dipendenti erano 2.200, oggi sono 1.500 e la differenza l’hanno fatta prepensionamenti ed esodi agevolati. Di quei millecinquecento, quattrocento sono in cassa integrazione, ma la speranza era che una nuova proprietà interessata a investire su Cornigliano per aumentare la produzione desse anche a chi era fuori la possibilità di rientrare. Certo, nessuno si aspettava una passeggiata, ma all’annuncio dei 600 esuberi Cornigliano non ha atteso un secondo per far esplodere la sua rabbia. «Più che una lettera, quella di AmInvestCo è una provocazione – spiega Ivano Bosco, segretario della Camera del Lavoro di Genova, sindacalista-operaio che ha iniziato poco più che ragazzo a difendere i suoi colleghi ai bacini di carenaggio del porto – Seicento fuori, tutti gli altri licenziati e riassunti senza scatti d’anzianità e integrativi. Si può considerare una proposta?».
Ora il governo ha dato un colpo di freno, in attesa di un piano più dettagliato, che tenga conto degli accordi stabiliti a suo tempo. Davanti alla Prefettura, più d’uno ricorda di quando, chiuso l’altoforno, Emilio Riva avesse proposto la costruzione di un forno elettrico, per rifare l’acciaio senza più inquinare l’ambiente. Ma non se ne fece nulla.

il Fatto quotidiano, 10 ottobre 2017.
Esce Pisapia, entra la “sinistra del Brancaccio”. All’indomani della rottura con l’ex sindaco di Milano, lo scenario si aggiorna: Tomaso Montanari e Anna Falcone presentano la loro iniziativa con una conferenza nella sede di Stampa Romana. “Vogliamo la sinistra che non c’è”, dicono. Ovvero: una lista civica, nata dalla battaglia in difesa della Costituzione e costruita dal basso. Da fare anche insieme ai partiti – da Mdp fino a Rifondazione comunista – purché non siano i partiti a guidarla. Stelle polari: gli spagnoli di Podemos e i laburisti di Jeremy Corbyn.
Falcone e Montanari, insomma, vogliono contribuire alla nascita della lista unitaria – di cui si parla ormai da mesi – ma solo alle loro condizioni. Lo storico dell’arte lo spiega con una battuta. Neanche a dirlo, su Massimo D’Alema: “Abbiamo perso tanti mesi a discutere su chi dovesse guidare l’autobus (Pisapia, ndr), non è il caso di perdere tempo anche sui passeggeri”. Un messaggio feroce: se qualcosa può nascere a sinistra, i partiti non devono guidare un bel niente. D’Alema e Bersani sarebbero “passeggeri” e non conducenti. “Chi ha già avuto a lungo incarichi politici – spiega – potrebbe fare un passo di lato”. Montanari (forse involontariamente) utilizza la stessa, identica espressione di Pisapia su D’Alema. Ieri, per inciso, l’ex premier è stato omaggiato anche da uno dei suoi nemici storici: Achille Occhetto, l’uomo della svolta dal Pci al Pds, era di passaggio alla Camera. Interpellato su D’Alema, ha sibilato: “L’Italia è ancora nelle mani di un serial killer”… La replica del lider Maximo a Montanari arriva nel pomeriggio, da Milano.
Quella che è stata raccontata come una rottura, dunque, potrebbe non essere ancora tale. Al massimo un’accelerazione: “Non si poteva continuare a tergiversare – spiega D’Alema – perché le elezioni sono vicine e andare avanti senza avere né un nome né un simbolo non sarebbe stato giusto. Così ci ha pensato Roberto Speranza”. Lo stesso Speranza che D’Alema definisce “leader” della nuova sinistra.
La confusione, nell’universo al di là del Pd, continua a regnare. Ricapitolando: c’è la proposta civica di Falcone e Montanari, la rottura (o presunta tale) con Pisapia, le ondeggianti posizioni dei padri nobili di Mdp, le richieste di Pippo Civati e Nicola Fratoianni. Il famoso “campo largo” per adesso è ancora un campo di battaglia.
Se ne capirà qualcosa in più in vista del 19 novembre, la data indicata da Speranza per l’assemblea fondativa. Fondativa di cosa, non si sa: sarà la costituente di Mdp o l’atto di nascita di una nuova lista unitaria? Risponde Speranza: “Sarà aperta a tutti coloro che vogliono costruire un’alternativa progressista alle politiche sbagliate di Renzi”. Chi vivrà, vedrà.
postilla
Difficile immaginare che si possa essere così vecchi come dimostra di esserlo la vecchia sinistra. Pensare che D'Alema, Bersani e Pisapia possano vincere contro la lista che scaturirà dall'"Alleanza popolare democrazia e giustizia" rientra nel campo delle possibilità, pensare invece che possano stare insieme di fronte agli elettori significa non aver compreso nulla. Se non lo hai letto, scorri l'articolo Una tesi sulla sinistra.

la Repubblicaevoca «un lungo passato di servaggio femminile di cui solo di recente abbiamo recuperato la consapevolezza, ma ci costringe ugualmente a ricordare che per molte donne il Medioevo non accenna a finire».
Maria Serena Mazzi, Donne in fuga. Vite ribelli nel Medioevo, ( Il Mulino, pagg. 180, euro 14)
«Io t’amaçerò se tu non stai cheta e ferma, e lascimi usare techo a qualunque modo io voglio», ripeteva, tra una percossa e l’altra, un maestro muratore lombardo alla moglie Leonarda, colpevole di non lasciarsi sodomizzare. La frase figura negli atti del processo tenutosi nel 1477 a Firenze, città natale della malcapitata che, dopo tre mesi di matrimonio, aveva cercato rifugio nella casa paterna, sporgendo denunzia contro il marito. Il suo coraggio fu premiato, e i giudici le concessero lo scioglimento del matrimonio: sebbene, sul piano giuridico, l’autorità del marito fosse legge, la sodomia era condannata dalla Chiesa ed era inconciliabile con la procreazione, fine primario dei coniugi. Ma se quella di Leonarda può sembrarci una storia a lieto fine, rimane pur sempre un’eccezione, come ci ricorda Maria Serena Mazzi nelle sue Donne in fuga. Vite ribelli nel Medioevo (Il Mulino, pagg. 180, euro 14).
Dopo avere contribuito con Prostitute e lenoni nella Firenze del Quattrocento (Il Saggiatore, 1991) allo sviluppo di quegli studi sulla condizione femminile di cui la Storia delle donne in Occidente (Laterza 1990), diretta da Georges Duby e Michel Perrot, costituisce in Europa una consacrazione, Mazzi riprende in mano una tematica che le è cara proponendocene una sintesi eloquente. Per fare uscire dal loro lungo silenzio le donne vissute, tra il XII e il XVI secolo, in una società dove i soli ad avere diritto alla parola erano gli uomini, la studiosa ha infatti raccolto un campionario di storie esemplari che non lascia dubbi sulla durezza della loro condizione subalterna.
Sono storie di ribellione, di fuga, di sconfitte, di punizioni atroci, suddivise in base all’appartenenza sociale – aristocratica, borghese, popolare – e alla diversità dei ruoli – figlie, mogli, madri, religiose. In parte la studiosa ripercorre storie già note, come quella di Cristina di Markyate, figlia di un ricco mercante inglese del XII secolo, che si sottrae a un matrimonio imposto, consacrandosi a Dio, o della sua contemporanea, la belga Juette, che vedova di un marito ripugnante, pur di non risposarsi si fa murare viva. Oppure quella della francese Dhuoda, secondo Gerda Lerner ( The Creation of Feminist Consciusness, Oxford University Press, 1993) la prima scrittrice in Europa a prendere la penna in mano per parlare di sé.
Andata sposa nell’824 a Bernardino di Settimania, un grande signore della Linguadoca, e relegata nel castello di Uzès mentre il marito era ciambellano alla corte imperiale, Dhuoda si vide portar via i due figli ancora bambini e scrisse per il primogenito, che non avrebbe mai più rivisto, un manuale di comportamento. «Quest’opera quando ti sarà giunta inviata dalla mia mano – ella gli scrive, forte della sua autorità materna – io voglio che tu la stringa con amore». Altre, invece, sono testimonianze riemerse di recente dal fondo degli archivi e che, riportando alla luce brevi frammenti di esistenze dimenticate, vengono così ad arricchire l’appassionante casistica di Donne in fuga. Unendo all’autorità della studiosa uno stile elegante e scorrevole, Maria Serena Mazzi sa infatti evocare con efficacia un lungo passato di servaggio femminile di cui solo di recente abbiamo recuperato la consapevolezza, ma ci costringe ugualmente a ricordare che per molte donne il Medioevo non accenna a finire e la fuga continua.
Nell'icona: miniatura medievale raffigurante un marito che picchia la moglie (Zurigo, Zentralbibliothek)
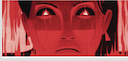
La Repubblica
Un bollore intorno al cuore. La migliore definizione della rabbia si deve ad Aristotele, ma c’è anche chi sente un grande battito nelle tempie o un dolore dietro il collo. La rabbia può essere un’emozione pubblica o privata, può riguardare una comunità intera o una relazione personale. Se dovessimo affidarci al celebre marziano di Eric J. Hobsbawm che annusa per la prima volta l’aria del nostro pianeta, potremmo ricavarne che la nostra è l’età della rabbia. Come spiegargli altrimenti Trump alla Casa Bianca, la scelta dirompente di Brexit, l’infuriare dei venti populisti in Europa? E gli attentati, lo scontro di civiltà, la Terza guerra mondiale stigmatizzata da papa Francesco? Non è un caso che proprio nella rabbia si sia imbattuta la più grande esploratrice morale delle emozioni, Martha Nussbaum, che le ha dedicato il libro Anger and Forgiveness, ora tradotto dal Mulino (Rabbia e perdono). Un saggio che attraversa la politica e i codici più intimi, toccando anche la “sfera di mezzo”, i contatti con le persone estranee. E come accade con i libri della Nussbaum — settant’anni, professoressa di Law and Ethics all’Università di Chicago — ogni pagina comporta un dilemma morale, e dunque una sorta di autoanalisi da cui si esce più ricchi e con qualche certezza in meno.

il manifesto,
Una marea bianca di decine di migliaia di persone ha invaso ieri le piazze centrali delle principali città spagnole, come Madrid, Barcellona, Valencia, Saragozza, Santiago, Siviglia e molte altre. Alle 12, convocate dall’associazione appena costituita chiamata «Hablemos/Parlem?», senza bandiere e indossando magliette bianche, hanno chiesto a gran voce che il dialogo torni a prevalere.
Una richiesta sensata, dato che né una dichiarazione di indipendenza, né una repressione selvaggia sembrano strade promettenti per stabilizzare una situazione che è arrivata a preoccupare persino i mercati e i grandi poteri finanziari che finora erano stati poco sensibili al dibattito catalano. Non c’erano partiti fra gli organizzatori di questa protesta gentile, ma alcuni membri di partiti e sindacati hanno partecipato a titolo individuale a queste manifestazioni auto organizzate in pochi giorni attraverso le reti sociali (soprattutto via twitter).
A Madrid si sono sentiti slogan come «meno odio, più conversazione», o «meno bandiere e più dialogo». Bandiere che invece non sono mancate a poche centinaia di metri dove un’altra manifestazione, assai più numerosa (si parla di 50mila persone contro le 1.500 di «bianchi» nella capitale) e decisamente schierata a destra (non a caso vi partecipava il vice segretario popolare Pablo Casado), di bandiere spagnole rojigualdas ce ’’erano una marea, in mezzo a grida da stadio «Yo soy español, español», «¡Viva España!» o l’ormai classico belligerante «Coi golpisti non si parla». La polizia ha tenuto separate le due manifestazioni.
A Barcellona per la manifestazione in favore del dialogo c’erano anche Ada Colau e Miquel Iceta, leader dei socialisti catalani, che hanno chiesto «dialogo, negoziato e patto. Si tratta di parlare e risolvere». Oltre ai palloncini bianchi liberati nel cielo, fra gli slogan che invitavano a parlare, anche quelli rivolti al presidente della Generalitat come quelli che dicevano «La Catalogna non è vostra, è di tutti» e «Fate il vostro lavoro».
La manifestazione di oggi, sempre alle 12, ma solo a Barcellona, sarà certamente molto più controversa. Organizzata dall’associazione filo-unionista «Società Civile catalana», è appoggiata entusiasticamente da Pp e Ciudadanos. Il Pp, per bocca del portavoce Fernando Martínez Maillo, ha chiesto alla «maggioranza silenziosa», che di solito non scende in piazza, di manifestare avvolta da bandiere spagnole, catalane (ma non quella indipendentista, ça va sans dir) ed europea. Soprattutto per chiedere a Puigdemont «che si fermi e riconduca la situazione e smetta di far male alla Catalogna».
Il segretario del Psoe Pedro Sánchez ha parlato invece a Valencia, dove ha detto che lo Stato spagnolo attraversa un momento «traumatico» e che secondo lui «noi cittadini viviamo e dormiamo pensando all’integrità territoriale del nostro paese». Ha appoggiato la marcia dei bianchi giacché «il Psoe è per il dialogo», in cui, ha detto, «c’entra tutto meno l’intransigenza, l’unilateralità e l’illegalità».
La Cup invece ribadisce che martedì la sessione plenaria del Parlament catalano sarà «un’opportunità storica e un momento chiave per esercitare l’autodeterminazione» e che la loro volontà «è che effettivamente si produca una dichiarazione unilaterale di indipendenza», anche se ha riconosciuto che la Catalogna non avrà capacità per rendere effettiva la legge di transitorietà giuridica, per cose come il controllo delle frontiere, degli aeroporti, dell’economia.
Secondo gli anticapitalisti il processo costituente dovrebbe iniziare immediatamente. La Cup chiede anche che sia i cittadini, sia le istituzioni boicottino banche come Sabadell, La Caixa e il Bbva, che hanno deciso di trasferire le sedi sociali fuori dalla Catalogna per esercitare pressione sul Govern di Barcellona. I Mossos, secondo la Candidatura unitaria popolare, dovrebbero al più presto «smettere di essere la polizia della Giustizia spagnola».
Mossos che rimangono al centro di 16 indagini giudiziarie aperte in Catalogna per «disobbedienza per inattività» non essendo intervenuti domenica nelle operazioni di ritiro delle urne o di allontanamento dei votanti.

il Fatto Quotidiano,
Da anni siamo costretti a parlare di leggi elettorali: i vertici politici, che non si rassegnano all’idea di doversi misurare continuamente con le istanze del corpo sociale, cercano di soffocarle con ogni artificio, contro l’ art. 1 “La sovranità appartiene al popolo” dove il verbo “appartiene” non è scelto a caso. I Costituenti dopo attenta discussione, lo sostituirono a “emana”, proposto inizialmente, per evitare il rischio che venisse interpretato nel senso che il popolo, attraverso il voto, trasferisce la sua sovranità. Era loro fermissimo intento affermare, senza equivoci, che la sovranità è del popolo e nel popolo continua a rimanere. Non è legittimo recidere i canali di trasmissione delle domande sociali alle istituzioni: alla legge elettorale non è consentito.
La Costituzione del 1948 è frutto dell’impegno collettivo di persone animate da grandi speranze e profondi ideali, unite nell’intento di dar vita a un sistema nuovo fondato sui valori di libertà e democrazia appena ritrovati, che si volevano salvaguardare in futuro. In una straordinaria stagione ricca di fermenti vitali ogni scoria del cupo passato era allontanata, così come ogni artificio antidemocratico di cui si era avvalso il regime: maggioranze truccate, premi per dominare schiacciando gli avversari politici, liste bloccate imposte agli elettori . L’obiettivo era la partecipazione “la partecipazione di tutti” come dice l’art. 3; e lo conferma l’art. 49: i cittadini, “Tutti i cittadini” – precisa la norma – hanno il diritto associarsi in partiti “per concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale”. Nessuno escluso.
Nello spirito del 1948 non poteva esserci che un sistema proporzionale con una modalità di voto in grado di tener saldo il rapporto fra elettori ed eletti: “La sovranità spetta tutta al popolo che è l’organo essenziale della nuova costituzione… l’elemento decisivo, che dice sempre la prima e l’ultima parola”. E dunque, il fulcro dell’organizzazione costituzionale è nel Parlamento “che non è sovrano di per se stesso; ma è l’organo di più immediata derivazione dal popolo”, si legge nella Relazione di Meuccio Ruini all’Assemblea costituente.
E il popolo è costituito da tutti i cittadini, altrimenti si ha una democrazia dimezzata. Secondo “la definizione minima” di Norberto Bobbio, per “regime democratico s’intende primariamente un insieme di regole e di procedura per la formazione di decisioni collettive, in cui è prevista e facilitata la partecipazione più ampia possibile degli interessati”. Era questo il pensiero dei Costituenti.
Durante i lavori della Commissione dei 75 (Seconda Sottocommissione, 7 novembre 1946), il grande costituzionalista Costantino Mortati propose di inserire in Costituzione il principio della rappresentanza proporzionale “perché costituisce un freno allo strapotere della maggioranza e influisce anche, in senso positivo alla stabilità governativa”. Prevalse invece l’idea di lasciare la materia elettorale alla legge ordinaria anche più tardi, quando se ne discusse in aula; un emendamento presentato dall’on. Giolitti non fu approvato.
Ma il suo contenuto, è importante ricordarlo, trasformato in ordine del giorno, venne invece approvato: “L’Assemblea costituente ritiene che l’elezione alla Camera dei deputati debba avvenire secondo il sistema proporzionale” (23 settembre 1947). È un impegno solenne. Non si può dunque affermare, come di recente Fusaro, che la Costituzione “nulla dice… su come trasformare i voti in seggi. Nulla. Ma proprio nulla di nulla”. Se la Costituzione non ne parla espressamente, il principio della rappresentanza proporzionale è implicito nel sistema complessivo oltre che in precise disposizioni: articolo 72 – le Commissioni in sede legislativa devono essere composte “in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari”; articolo 82 – ciascuna Camera, esercitando il potere parlamentare d’inchiesta, nomina “fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione fra i vari gruppi”; art. 83 – all’elezione del presidente della Repubblica “partecipano tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze”. Un sicuro “plurale” che non ha nulla di generico.
Il modello dei Costituenti, sottolineava Livio Paladin, è quello delle “democrazie di stampo liberale e dunque pluralistico che vuole temperare il principio maggioritario sia attraverso la rigidità della Costituzione e il controllo di costituzionalità sulle leggi, sia garantendo le libertà fondamentali, a cominciare dalla libertà di associazione e di manifestazione del pensiero”.
Le minoranze sono l’essenza del costituzionalismo liberale e sulla possibilità di far sentire la loro voce sono basati gli istituti giuridici posti a tutela dei diritti costituzionali , dai diritti di libertà ai diritti sociali. Per garantirli le Costituzioni esigono che la loro disciplina sia riservata alla legge, approvata dal Parlamento dove hanno voce anche le minoranze e non da fonti del governo dove la sola maggioranza è presente.
La distorsione della rappresentanza – dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale – alterando la composizione delle Camere si ripercuote pesantemente sulla vita dei cittadini: in assenza di voci in grado di difenderli i diritti sono gravemente incisi, il pensiero minoritario sacrificato. Ormai, che la norma sia fatta dal governo o dal Parlamento dove la maggioranza domina incontrastata, è la stessa cosa. Soffocate le minoranze, a nulla vale la rigidità della Costituzione; a tutelarla non bastano le garanzie giuridiche: se non sono accompagnate dalle garanzie politiche assicurate dal pluralismo risultano del tutto inefficaci. Una maggioranza artificialmente creata non trova più i limiti politici consueti in democrazia; le altre forze, ridotte all’irrilevanza, come possono svolgere un’opposizione efficace?
Qualche idea per le prossime elezioni politiche, nella speranza che siano elezioni vere e non una nuova truffa
Le elezioni politichesi avvicinano. Non sappiamo ancora con quale strumento quelli che comandanooggi ci obbligheranno a ridar loro il potere. Meno che meno sappiamo seriusciremo a sconfiggerli.
lasinistraquotidiana,
Sono molteplici i fattori che stanno alla base della gravissima crisi che sta attraversando l’unità nazionale spagnola (ovvero dell’indipendenza della Catalogna): elementi di natura storica, politica, istituzionale, economica.
La crisi spagnola (ovvero dell’indipendenza della Catalogna), così come tante altre situazioni sparse principalmente sullo “storico” territorio europeo (ma anche fuori, come nel caso del Kurdistan e di diverse situazioni africane), rappresenta anche (e forse soprattutto) il nuovo punto di espressione di quell’arretramento dell’entità politica denominata “Stato – Nazione” che, in relazione al processo di globalizzazione economica, molti pensavano potesse essere risolto all’intero di nuove dimensioni denominante appunto “sovranazionali”.
In questo momento alcuni pensano che questa crisi esplosa violentemente in uno dei maggiori paesi dell’Unione Europea potrebbe essere vista proprio dal lato dell’indipendenza catalana per costruire, più facilmente, un’Europa di “piccole patrie” non vincolate alla rigidità dei grandi Stati (questa è l’opinione anche del Ministro degli Esteri della Generalitat catalana, Raul Romeva).
Sorprende (ma non troppo) l’utilizzo “a sinistra” della teoria delle due “tigri di carta”, utilizzata per esprimere una pilatesca equidistanza.In realtà l’analisi sulla quale si potrebbe lavorare è quella che ci troviamo di fronte ad una situazione creata per certi versi da un intreccio di contraddizioni del tutto inedite mai affrontate nel tempo recente, almeno dalla fase post – caduta del muro di Berlino.
Si sono connessi, infatti, a questo punto sia l’arretramento del fenomeno che è stato definito come “globalizzazione” e che ha provocato l’arresto o almeno il rallentamento nel processo di disfacimento dello “Stato – Nazione” e, insieme, quella che è stata definita “fine della società liquida”.Quella “società liquida” che Bauman aveva teorizzato a suo tempo (“Modernità liquida”, Laterza 2000).
A sostegno della tesi sulla”fine della società liquida” il filosofo docente alla Normale Roberto Esposito in un suo saggio utilizza molti autori: da Kenichi Omae (Il mondo senza confini, il Sole 24 ore), Carlo Bordoni (Fine del mondo liquido, il Saggiatore) a Daniele Giglioli (Stato di minorità, Laterza).
La tesi che si sostiene nell’intervento di Esposito, è quella che la già definita “geniale metafora” mostra il suo tempo, non solo perché troppo indeterminata, ma perché incapace di dar conto di un ulteriore passaggio che sembra spingerci del tutto fuori dalla modernità così come questa è stata concepita facendola coincidere con il trionfo del “pensiero unico” e la “fine della storia”. Due punti questi ultimi sui quali sarà il caso di ritornare.
Secondo Esposito infatti: «Gli stati sovrani dichiarati anzi tempo finiti rialzano la testa, mentre la geopolitica ridisegna vecchie e nuove zone d’influenza. Nel linguaggio dell’inclusione torna a lavorare la macchina dell’esclusione. I confini che sembravano dissolti riprendono a suddividere quanto si era immaginato di unire. Non solo ma fuori da ogni metafora liquida, si solidificano muri di cemento, in barriere di filo spinato, in blocchi stradali. Un mondo terribilmente solido, striato di frontiere materiali, subentra a quello liscio, promesso dai teorici dell’età globale»..
Riemergerebbe, in sostanza, un forte richiamo identitario che troverebbe la sua espressione non tanto e soltanto in richieste di tipo economico, ma anche e proprio (come accade nel caso ispano/catalano) da una molteplicità di elementi fra i quali reciterebbe un ruolo fondamentale quello della “identità storica” ( riassumibile nel caso in questione della Spagna/Catalogna nelle “fratture” ancora in atto dalle vicende della guerra civile e dalla contrapposizione Monarchia/Repubblica).
Nel caso ispano/catalano si nota, infatti, l’elemento del confronto tra monarchia accentratrice (come si è visto nell’uso della forza nel giorno del referendum) versus repubblica popolare: ed è questo un elemento che sul piano politico ha dimostrato comunque di mantenere un peso molto rilevante.
Il richiamo identitario si sviluppa proprio a livello di grandi masse sul terreno storicamente e culturalmente più prossimo, quella della propria immediata dimensione territoriale: quella della riconoscibilità della “propria patria” in questo caso fieramente repubblicana.Tanto è vero che l’UE (costruita mille miglia lontano da questo tipo di tensioni) e le cancellerie europee si sono palesate quanto mai perplesse nell’assumere posizione al riguardo se non con espressioni di mera circostanza.
Torniamo però al tema più generale: quello della fine della “società liquida” e, insieme, dell’inaspettato ritorno sulla scena dello “Stato – Nazione” (fattore alimentato anche dalla vicenda dei migranti) e della “geopolitica” (con accenti, in questo caso, addirittura da “nuova guerra fredda”).
Nel corso di questi ultimi anni abbiamo verificato l’evolversi di nuove dimensioni dell’agire politico sviluppatesi in particolare in Occidente e poste in relazione a profondi mutamenti avvenuti sul piano dell’innovazione tecnologica nel campo della comunicazione di massa, della struttura della società e della modificazione nel rapporto tra forme di gestione del potere da parte delle classi dominanti e il concetto stesso di rappresentatività politica.
E’ stato analizzato il fenomeno di una globalizzazione economica velocizzata al massimo dall’uso di nuove tecnologie e sono sorti movimenti testi a contrastarne gli effetti più dirompenti al riguardo delle stridenti diseguaglianze sociali che – a livello planetario – il fenomeno definito come “globalizzazione” ha provocato.
Nel frattempo hanno acquistato grande peso quelle contraddizioni definite post –materialiste “in primis” quelle ambientale e di genere; si è sviluppato fortemente il processo di finanziarizzazione nel ciclo di gestione capitalistica; la “politica” è stata sempre più esercitata nel segno del “comando” e dell’interventismo sulle sfere della vita quotidiana ( è questo l’elemento di maggiore difficoltà della cosiddetta “democrazia liberale”, nella dimostrazione di una sempre più crescente incompatibilità tra di essa e il capitalismo iperfinanziarizzato che non lascia margini al pluralismo politico e al welfare ma si intende come totalizzante nell’accentramento della gestione del potere).
Addirittura, sulla spinta della fine dell’esperienza sovietica si parlò, da parte di politologi conservatori come Fukuyama e Huntington di “fine della storia” e addirittura di unico confronto possibile quello dello “scontro di civiltà” tra l’Occidente e l’Islam.Del resto questo esito della “fine della storia” non coincideva altro che con il trionfo dell’ideologia capitalista travestita da non-ideologia era apparso possibile grazie all’egemonia assunta dal concetto neo-liberista insito nella ventata conservatrice propiziata dall’offensiva di Reagan negli USA e di Margaret Tachter in Gran Bretagna: USA e Gran Bretagna.
USA e Gran Bretagna si dimostravano ancora una volta dopo la fine della seconda guerra mondiale i paesi-guida nell’economia e anche nella riflessione politica, campo nel quale il sociologismo di marca USA pareva ormai sopravanzare l’idealismo del modello renano.
Insomma: era il tema del “pensiero unico” sul piano economico, politico e soprattutto filosofico:Una sola strada sembrava tracciata e l’unico scontro possibile era dunque quello “di civiltà” versus i “nuovi barbari” dell’islamismo terrorista (salvo, ovviamente, gli affari con i sauditi, ecc.).
Ora la fine della società liquida sta mandando in una difficoltà forse definitiva il “pensiero” ed il “mercato” unico, con grande fastidio di coloro che detengono il potere in quella “plutocrazia” ancora così definita da Noam Chomsky nel suo fondamentale “Le dieci leggi del potere” recentemente apparso anche in Italia.
Oggi, nel relativamente “piccolo” della crisi spagnola (ovvero dell’indipendenza catalana) è proprio questo punto del pensiero e del mercato unico che va in discussione.
In questo quadro di visione complessiva schematicamente riassunto , sul piano più strettamente politico, emergono alcuni fenomeni molto importanti : quello della già richiamata evidente crisi di quella già classicamente definita come “democrazia liberale” e, di conseguenza, in Occidente della completa dismissione di identità da parte dei partiti socialisti e socialdemocratici (compreso il PDS, poi DS italiano, che proveniva da una storia affatto diversa).
In questo quadro emergono evidenti :Il passaggio degli ex- socialisti e socialdemocratici nel campo liberista attraverso la scorciatoia del blairismo e dell’ulivismo (certo con contraddizioni, ma nella sostanza della schematicità di un intervento di questo tipo il giudizio di fondo non può che essere quello appena pronunciato);la marginalizzazione, non solo elettorale ma soprattutto di radicamento sociale, delle forze rimaste antagoniste, soprattutto di quelle di matrice comunista costrette a nascondersi, in pratica, in Francia, in Spagna, in Italia, in Grecia all’interno di generiche alleanze “di sinistra” e prive della capacità di affrontare, a livello di masse, il nuovo quadro di contraddizioni che si sta presentando.
Due punti di riassunto per concludere:la globalizzazione, così com’era stata intesa negli ultimi 20 anni si è arrestata;così come ha sicuramente rallentato, rispetto alle previsioni, quel processo di cessione di sovranità dello “Stato – Nazione” che pure era stata considerato alla base di ipotesi politiche di grande portata come quella della costruzione dell’Unione Europea. Concetto di “Stato – Nazione” attaccato dunque non in dimensione sovranazionale ma all’opposto dall’emergere di specificità territoriali di tipo economiche e culturale sbrigativamente definite nel linguaggio giornalistico corrente come “regionaliste”.
Si è così dimostrato che, in sintesi, il laissez-faire e la tecnocrazia internazionale non forniscono una valida alternativa allo Stato-nazione eppure i popoli premono per affermare una più diretta vocazione alla piena espressione della loro volontà.
Forse ci sarebbe da riflettere su di una frase dell’economista e premio Nobel Amartya Sen che parla infatti di “identità multiple” (etnica, religiosa, nazionale, locale, professionale e politica), molte delle quali oltrepassano i confini nazionali o stanno dentro a quei confini forzatamente tracciati nell’epoca dei nazionalismi e degli imperialismi, in quel secolo definito “breve” da Eric Hobsbawm.
“Identità multiple” che l’internazionalismo marxista risolveva declinando come l’avversario dell’internazionalismo fosse il nazionalismo borghese e considerando la divisione del mondo in classi il vero ostacolo allo sviluppo della società umana. Ci troviamo di fronte a contraddizioni evidentemente stridenti non affrontate dal punto di vista del pensiero politico.Un pensiero politico quello corrente mai apparso, come in questa fase, legato esclusivamente nelle sue espressioni maggioritarie a esigenze contingenti di sopravvivenza per ceti privilegiati. Forse è proprio quest’ultimo il punto, quello della sopravvivenza dei ceti privilegiati: come sempre il punto riguardante l’egoismo, la conservazione, lo sfruttamento, la disuguaglianza .
Una situazione che reclama urgentemente una proposta di modello alternativo naturalmente rivolta non solo alla Catalogna.

il Fatto quotidiano
«Pubblichiamo parte dell’intervento che il professor Azzariti ha tenuto nel convegno dei Comitati del No lunedì 2 ottobre 2017»
Così è per l’ultima proposta, elaborata dagli stessi protagonisti che pochi mesi addietro si erano accordati per introdurre un sistema del tutto diverso, che ora immaginano di poter escogitare un meccanismo grazie al quale - secondo le parole dei commentatori più accreditati e dei più scaltri esponenti politici - si garantisca a Berlusconi di ottenere la leadership nel centrodestra, a Salvini di fare il pieno nei collegi del nord, ad Alfano di provare a non scomparire, a Renzi di tacitare gli avversari interni e orchestrare un trappolone per Pisapia, a quest’ultimo di affrancarsi dall’ingombrante D’Alema e abbandonare la sinistra soi-disant radicale.
È questo un terreno di discussione inaccettabile. L’espressione unicamente del livello di assoluta autoreferenzialità della politica, un’ostentazione della politica che si allontana sempre più dal mondo reale. Allora, il nostro primo sforzo credo debba essere quello di riportare con i piedi per terra il confronto sulla legge elettorale. Ricordare, che questa non serve per assicurare il risultato ai giocatori, bensì a permettere al popolo sovrano di esprimere e scegliere i propri rappresentanti.
Sulla riforma della legge elettorale mi limito qui a due considerazioni. In primo luogo, ricordo che entrambe le decisioni della Consulta sui sistemi elettorali hanno rilevato che le ragioni della governabilità - obiettivo politico legittimo - devono però essere perseguite “con il minore sacrificio possibile per la rappresentanza politica nazionale”, la quale “si pone al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo prefigurati dalla Costituzione”.
A me sembra chiaro il senso di un tale rilievo: l’ansia di governabilità che ha dominato la politica in Italia nell’ultimo quarto di secolo è andata troppo oltre ed è giunta a comprimere eccessivamente il valore supremo della rappresentatività dell’assemblea parlamentare. Dopo queste sentenze, il buon legislatore non perderebbe un attimo del suo tempo e - ringraziata la Corte per averla avvertita del pericolo incorso - rimedierebbe al mal fatto, riscoprendo le virtualità della rappresentanza politica che si pone alla base della nostra democrazia costituzionale.
V’è, poi, una seconda ragione che dovrebbe sollecitare a invertire la rotta. Ed è la constatazione dello stato in cui ci troviamo. Dopo venticinque anni di democrazia maggioritaria nessun risultato auspicato è stato conseguito: non la promessa semplificazione del sistema politico, che è invece esploso e s’è frammentato al suo interno; non la reclamata stabilità dei governi, costantemente ostaggio di maggioranze sempre più litigiose; non l’illusione della scelta del governo rimessa al corpo elettorale, che non decide ormai più nulla, non solo non sceglie il governo, ma neppure i propri rappresentanti, neppure l’ultimo dei peones.
Non solo non si sono raggiunti gli obiettivi perseguiti ma si sono pericolosamente inaridite le fonti che alimentano la democrazia costituzionale. Il Parlamento in primo luogo. Quest’ultimo io credo sia stato il peccato più grande.
Se vi è un organo sacrificato dal lungo regresso che ha accompagnato il progressivo, apparentemente inarrestabile, declino del paese questo è stato l’organo della rappresentanza popolare. Oggi il Parlamento italiano non conta più nulla, schiacciato dal governo che ne domina i lavori, impedito al confronto da regolamenti fatti apposta per poter decidere senza discutere. Il Parlamento sembra aver perduto ogni autonomia di organo costituzionale, posto ai margini della nostra forma di governo, che pure si vuole ancora qualificare come “parlamentare”. Questa “riduzione al nulla” del Parlamento è il più grave dei peccati e la più imperdonabile delle leggerezze perché - come scriveva Kelsen - “alla sorte del parlamentarismo è legata la sorte della stessa democrazia”.
In verità, il Parlamento oggi non è stato solo abbandonato dalla classe politica, che discute altrove, ma anche dal popolo che si indigna, ma non va più a votare, che non si riconosce più nelle istituzioni democratiche. Ed è questo il lato più preoccupante perché non c’è democrazia senza consenso. Invero, non c’è neppure un governo democratico senza consenso. Eppure le ultime leggi elettorali sembrano essere state pensate proprio per governare senza popolo, con l’unico scopo di avere un governo la sera stessa delle elezioni, anche se queste fossero andate deserte e comunque a prescindere dalla rappresentanza effettiva, dal peso reale delle forze in campo.
Oggi abbiamo l’occasione di rimettere al centro della nostra riflessione la questione della rappresentanza reale, cercando di ridurre il terribile gap tra rappresentanti e rappresentati; provando a recuperare un po’ di popolo alle ragioni della democrazia e del parlamentarismo.
Per far questo è necessario sfatare un po’ di luoghi comuni. Mai stati veri, sebbene ostinatamente ripetuti. Non è vero, ad esempio, che si vota per “scegliere” il governo: si votano i membri dell’organo legislativo, i rappresentanti della nazione, che poi svolgeranno le proprie funzioni senza vincolo di mandato. La democrazia parlamentare è cosa ben diversa dalla democrazia del capo. Poi, dei parlamentari autorevoli, perché realmente rappresentativi della nazione, potranno assicurare un sostegno duraturo e responsabile ai governi, i quali - dopo le elezioni, in base all’esito di esse, e dopo la nomina effettuata dal presidente della Repubblica - si presenteranno di fronte ad essi per esporre un programma di governo. Sono dunque i parlamentari a dover conferire - con mozione motivata - la fiducia al governo e non viceversa. Dunque il parlamento viene prima del governo.
Un Parlamento davvero rappresentativo non può essere il frutto esclusivo di torsioni maggioritarie, premi, sbarramenti e altre diavolerie immaginate solo per giungere ad un esito voluto. La richiesta di una legge elettorale di tipo proporzionale vuole preservare l’essenza e il valore del parlamento di una democrazia realmente pluralista.
il Fatto Quotidiano,
HANNO DISTRUTTO
Quello che a Padellaro sfugge è che il mutamento non sta solo nel fatto che un berlusconcino come Matteo Renzi si sia impadronito di ciò che restava del Pci, ma che è cambiato il carattere antropologico degli ex militanti della sinistra italiana, e che contemporaneamente è cambiato il mondo nel quale la vecchia sinistra combatteva. Il personale che è rimasto nel PD di Renzi e che continua a votare per lui è costituito da schegge della sinistra del millennio scorso, ma il significato di quella sinistra non ha più alcuna rilevanza di fronte ai problemi dei nostri giorni (vedi il nostro La parola "Sinistra". Da qui anche la profonda disaffezione verso i partiti di quell'epoca scomparsa, e il fenomeno dell'astensione dal voto.. L'intelligenza politica di Anna e Tom è di aver compreso questo cambiamento e di avere di conseguenza proposto una piattaforma politica radicalmente diversa da quelle delle tradizionali sinistre Per quello che so di loro, non verranno mai a patti: non si metteranno nella situazione in cui "le mort saisit le vif"("il morto afferra il vivo", e lo trascina con se).

il manifesto
La situazione là fuori è desolante. Come descrivere un mondo capovolto? Capi di stato che twittano minacce di distruzione nucleare, intere regioni sconvolte dai cambiamenti climatici, migliaia di migranti che affogano lungo le coste dell’Europa e partiti apertamente razzisti che guadagnano terreno, nel caso più recente – e allarmante – in Germania.
Faccio solo un esempio, i Caraibi e gli Stati Uniti del Sud sono nel pieno di una stagione degli uragani senza precedenti. Porto Rico è completamente senza energia elettrica, e potrebbe restarlo per mesi, il suo sistema idrico e quello di comunicazione sono gravemente compromessi.
Su quell’isola, tre milioni e mezzo di cittadini americani hanno un disperato bisogno dell’aiuto del loro governo. Ma, come durante l’uragano Katrina, la cavalleria stenta ad arrivare. Donald Trump è troppo impegnato a cercare di far licenziare atleti neri, colpevoli di aver osato attirare l’attenzione sulla violenza razzista.
Per quanto sia incredibile, non è ancora stato annunciato un pacchetto federale di aiuti per Porto Rico. Secondo alcune analisi, sono già stati spesi più soldi per rendere sicuri i viaggi presidenziali a Mar-a-Lago.
E se tutto questo non fosse già abbastanza, hanno anche cominciato a spuntare gli avvoltoi: la stampa economica ribolle di articoli che spiegano come l’unico modo per far tornare la luce a Porto Rico sia vendere il loro sistema energetico nazionale. Magari anche le loro strade e i loro ponti.
Ho soprannominato questo fenomeno la «Dottrina dello Shock»: lo sfruttamento di crisi strazianti per approvare politiche che erodono la sfera pubblica e arricchiscono ulteriormente una ristretta èlite. Abbiamo visto questo lugubre circolo vizioso ripetersi ogni volta: dopo la crisi finanziaria del 2008, e oggi con i Tories che vogliono sfruttare la Brexit per far passare senza dibattito dei disastrosi accordi commerciali che avvantaggeranno le corporation.
Ho messo in evidenza Porto Rico perché lì la situazione è particolarmente urgente, ma anche perché rappresenta il microcosmo di una crisi globale molto più vasta, che contiene molti degli stessi elementi: un caos climatico sempre più rapido, storie colonialiste, una sfera pubblica debole e trascurata, una democrazia completamente disfunzionale.
La nostra è un’epoca in cui è impossibile separare una crisi dall’altra: si sono tutte fuse insieme, rinforzandosi e sprofondandosi a vicenda, come un mostro a più teste sull’orlo del collasso.
Si può pensare al presidente degli Stati uniti nello stesso modo. Avete presente quell’orribile blob di grasso che sta intasando le fogne londinesi, che voi chiamate fatberg? Trump è il suo equivalente politico. Un concentrato di tutto ciò che è nocivo a livello culturale, economico e politico, tutto appiccicato insieme in una massa autoadesiva che abbiamo molte difficoltà a rimuovere.
Che si tratti di cambiamento climatico o di minaccia nucleare, Trump rappresenta una crisi che rischia di echeggiare attraverso molte ere geologiche. Ma i momenti di crisi non devono necessariamente seguire la strada della «Dottrina dello Shock», non sono destinati per forza a creare opportunità per chi è già schifosamente ricco di arricchirsi ancora di più. Possono anche andare nella direzione opposta.
Possono rappresentare dei momenti in cui scopriamo il meglio di noi, e riusciamo a fare appello a riserve di forza e determinazione che non sapevamo di avere.(…) Ma non è solo a livello della società civile che possiamo osservare il risveglio di qualcosa di ammirevole in noi quando si verifica una catastrofe. Esiste una lunga e gloriosa storia di trasformazioni progressiste a livello sociale innescate dalle crisi. Basta pensare alle vittorie della working class per quanto riguarda l’edilizia popolare all’indomani della prima guerra mondiale, o per il sistema sanitario nazionale dopo la seconda.
Questo ci dovrebbe ricordare che i momenti di grande difficoltà e pericolo non devono necessariamente riportarci indietro: possono anche catapultarci in avanti. Queste lotte progressiste però non vengono mai vinte solo resistendo, o opponendosi all’ultimo di una lunga serie di oltraggi.
Per trionfare in un momento di vera crisi dobbiamo anche essere in grado di pronunciare dei coraggiosi e lungimiranti «sì»: un piano per ricostruire e affrontare le cause che soggiacciono alla crisi. E questo piano deve essere convincente, credibile e, più di tutto, accattivante. Dobbiamo aiutare una società stanca e timorosa a immaginarsi in un mondo migliore.
Caos climatico, colonialismo, élite dedite alla rapina, democrazia disfunzionale. È impossibile separare una crisi dall’altra: si sono tutte fuse insieme, come un mostro a più teste
Theresa May ha condotto una campagna elettorale cinica facendo leva sulla paura e sui traumi degli inglesi per accaparrarsi più potere – prima la paura di un cattivo accordo per la Brexit, poi quella per gli orribili attentati terroristici a Manchester e Londra.
Il Labour e il suo leader hanno invece risposto concentrandosi sulle cause: una «guerra al terrore» fallita, le diseguaglianze economiche e una democrazia indebolita. E soprattutto avete presentato agli elettori un programma coraggioso e dettagliato, un piano per migliorare in modo tangibile la vita di milioni di persone: istruzione e sanità gratuite, un’azione aggressiva contro il cambiamento climatico.
Dopo decenni di aspettative al ribasso e di un’immaginazione politica asfittica, finalmente gli elettori hanno avuto qualcosa di promettente ed entusiasmante a cui dire «sì». Le persone vogliono un cambiamento profondo – lo richiedono a gran voce. Il problema è che in fin troppi paesi è solo l’estrema destra a offrirlo, con un mix tossico di finto populismo economico e reale razzismo.
In questi ultimi mesi il partito laburista ha dimostrato che esiste un’altra via. Una via che parla la lingua della decenza e della giustizia, che non teme di chiamare col loro nome le forze responsabili di questa crisi, senza timore del loro potere.
Le passate elezioni hanno anche evidenziato un’altra cosa: che i partiti politici non devono temere la creatività e l’indipendenza dei movimenti civili – e che a loro volta i movimenti civili hanno molto da guadagnare dall’incontro con la politica tradizionale. È un dato molto importante, perché i partiti tendono a voler esercitare il controllo, mentre i movimenti dal basso tengono alla loro indipendenza e sono quasi impossibili da controllare. Ma ciò che testimonia il rapporto tra Labour e Momentum (il movimento che sostiene Corbyn, ndr), o con altre ottime organizzazioni, è la possibilità di combinare il meglio di entrambi questi mondi e dare vita a una forza al contempo più agile e incisiva di qualunque impresa condotta in solitudine da partiti o movimenti.
Ciò che è accaduto in Gran Bretagna è parte di un fenomeno globale. È un’ondata guidata da giovani che sono entrati nell’età adulta nel momento del collasso del sistema finanziario, e mentre la catastrofe climatica ha iniziato a bussare alla porta. Molti vengono da movimenti come Occupy Wall Street, o gli Indignados in Spagna.
Hanno cominciato dicendo no: all’austerità, ai salvataggi delle banche, al fracking e agli oleodotti. Ma col tempo hanno capito che la sfida più grande è il superamento della guerra dichiarata dal neoliberismo al nostro immaginario collettivo, alla nostra capacità di credere in qualcosa al di là dei suoi cupi confini. L’abbiamo visto accadere con la storica campagna alle primarie di Bernie Sanders, alimentata dai millennial consapevoli che una prudente politica centrista non offre loro alcun futuro. Abbiamo visto qualcosa di simile con il giovane partito spagnolo Podemos, erettosi sulla forza dei movimenti di massa sin dal primo giorno.
Campagne elettorali, le loro, che si sono infiammate a velocità incredibile. E sono arrivati vicini alla vittoria – più vicini di qualunque altro movimento politico genuinamente progressista statunitense o europeo di cui sia stata testimone nel corso della mia vita. Ma non abbastanza vicini. Per questo, nel tempo che ci separa delle elezioni, dobbiamo pensare a come assicurarci che, la prossima volta, i nostri movimenti arrivino fino in fondo.
In tutti i nostri paesi, dobbiamo fare in modo di sottolineare il legame tra ingiustizia economica, razziale e di genere. Ci spetta capire, e spiegare, come i sistemi di potere che mettono un gruppo in posizione dominante rispetto agli altri – sulla base del colore della pelle, della religione, dell’orientamento sessuale e di genere – servano sempre gli interessi del potere e del denaro.
È nostro dovere evidenziare il rapporto tra gig economy – che tratta gli esseri umani come materie prime da cui estrarre ricchezza per poi buttarle – e dig economy, quella delle industrie estrattive che trattano la terra con la stessa indifferenza. Dobbiamo indicare la strada per passare a una società fondata sulla cura reciproca e del pianeta, dove il lavoro di chi protegge la nostra terra e la nostra acqua viene stimato e rispettato. Un mondo dove nessuno, da nessuna parte, viene abbandonato – che si tratti di un edificio popolare in fiamme (come Grenfell a Londra, ndr) o di un’isola prostrata da un uragano.
È il momento di innalzare le nostre ambizioni e dimostrare come la battaglia al cambiamento climatico sia una sfida epocale per costruire una società più giusta e democratica. Perché mentre usciamo rapidamente dall’epoca dei combustibili fossili, non potremo replicare la concentrazione del benessere e l’ingiustizia proprie dell’economia del petrolio e del carbone, in cui le centinaia di miliardi di profitti sono stati privatizzati, mentre i tremendi rischi che ne conseguono sono pubblici.
Sanders, Podemos e Corbyn dimostrano che partiti e movimenti devono allearsi. I millennial non sopportano le false promesse
Il nostro motto deve essere: lasciamoci alle spalle il gas e il petrolio, ma non lasciamo indietro nessun lavoratore. Ci spetta immaginare un sistema in cui sia chi inquina a pagare la maggior parte del costo della transizione. E in paesi ricchi come la Gran Bretagna o gli Stati Uniti, abbiamo bisogno di politiche sull’immigrazione e di una finanza internazionale che riconoscano il nostro debito nei confronti del sud del mondo – il nostro ruolo storico nella destabilizzazione delle economie e delle ecologie di paesi poveri per lunghissimi anni, e l’immensa ricchezza estratta da queste società sotto forma di esseri umani ridotti in schiavitù.
Più il partito laburista sarà ambizioso, perseverante e globale nel dipingere l’immagine di un mondo trasformato, più credibile diventerà un suo governo.
In tutto il mondo, vincere è un imperativo morale per la sinistra. La posta in gioco è troppo alta, e il tempo che ci resta troppo poco, per accontentarci di niente di meno.
Traduzione in italiano di Giovanna Branca
L’ultimo libro di Naomi Klein si chiama «No is not enough» ed è stato pubblicato da Haymarket books a giugno scorso. L’edizione italiana uscirà per Feltrinelli

il manifesto,
Se lo fosse, infatti, il Rosatellum-bis non sarebbe stato presentato. Non lo sarebbe stato per l’eclatante, immediata, grossolana, irrimediabile violazione del principio fondante e qualificante il tipo di manifestazione indefettibile della volontà popolare, il voto. Voto che il Rosatellum schiaccia e distorce. Lo schiaccia amputandone la gamma delle potenzialità, quelle di scegliere il candidato o i candidati alla propria rappresentanza. Perché scelta che risulterà già operata nella lista da chi ha presentato la lista.
Il Rosatellum lo fa. E con conseguenze devastanti del sistema politico, quella di trasformare la figura di membro del parlamento, coinvolgendo immediatamente la stessa configurazione dell’istituzione di cui farà parte, e così il carattere e l’essenza della Repubblica parlamentare. Devastante perché preclude una credibile rappresentanza della base popolare della Repubblica che solo la proporzionale potrebbe assicurare all’attuale sistema politico italiano. Il Rosatellum è invece esattamente funzionale all’investitura dei «capi delle forze politiche che si candidano a governare», l’eversiva formula contenuta nel testo unico delle norme sulle elezioni al parlamento come modificato dal Porcellum. Formula che elude, esclude la funzione rappresentativa dell’elezione in parlamento per sostituirla con l’investitura di un «capo» di «forza politica» (si badi) non forza parlamentare. Formula che avrebbe imposto il rinvio di quella legge al parlamento per «manifesta incostituzionalità», rinvio sciaguratamente omesso dal presidente della Repubblica Ciampi.

Internazionale
E' un martedì pomeriggio di settembre e Carles Puigdemont, presidente della Catalogna, ha appena finito di spiegare i suoi piani per l’indipendenza, quando il suo assistente ci propone di fare una visita alla sede del governo. Puigdemont lavora nel Palau de la Generalitat, nel centro storico di Barcellona. Alcune parti dell’edificio, una delle strutture più belle in una città ricca dal punto di vista architettonico, hanno più di seicento anni.
Il suo assistente ci mostra il cortile nella parte più antica dell’edificio, le colonne decorate e gli scintillanti pavimenti di marmo che, spiega, “sono originali”. Indica le croci di san Giorgio che decorano l’edificio, per secoli un simbolo della capacità dei catalani di difendersi, ma anche della fiducia con cui questa regione rivendica la sua libertà dal governo centrale spagnolo. Passiamo per il giardino degli aranci, dove l’amministrazione organizza i ricevimenti e dove, dice l’assistente, continuerà a organizzarli quando la Catalogna sarà indipendente. Ci fa notare i pilastri della facciata, fatti con il marmo che i romani portarono sulle coste catalane dalla città di Troia.
Antichità, medioevo, cristianità, rinascimento ed età moderna. In questo luogo è riassunta tutta la storia dell’Europa, e l’assistente di Puigdemont non ha dubbi sul fatto che questo edificio, questa città e questa terra meritino più di quanto stiano ricevendo dal governo centrale. È questa la posta in gioco del referendum indetto dai separatisti: il ritorno della Catalogna sulla scena europea. Ma è anche possibile che, invece, ci troviamo di fronte agli ultimi sussulti di quello che un tempo era un grande sogno.
La mattina dopo l’incontro con Puigdemont, il 20 settembre, la polizia ha fatto irruzione in alcuni uffici della Generalitat, nelle sedi di partito e nei magazzini, arrestando quattordici persone, tra cui un vice- ministro del governo locale, e confiscando più di nove milioni di schede elettorali. Le lettere indirizzate agli scrutatori erano già state requisite. Quella sera il capo del governo spagnolo Mariano Rajoy ha tenuto un discorso in tv in cui chiedeva agli indipendentisti di annullare il referendum.
Puigdemont e Rajoy si scontrano a distanza da mesi. Si sono lanciati provocazioni reciproche come fanno i pugili prima di un incontro. La resa dei conti è prevista per il 1 ottobre, il giorno scelto per il referendum. Le perquisizioni del 20 settembre sono state il tentativo di Rajoy di impedire il voto. Puigdemont ha risposto che il referendum si farà. Ma senza organizzatori, schede elettorali e scrutatori è difficile.
I separatisti sperano che il referendum dia vita a un processo politico che conduca, alla fine, all’indipendenza. Ma il governo spagnolo non vuole fare nessuna concessione. Per mesi Madrid si è riifutata anche solo di valutare le richieste del governo catalano, preferendo affidarsi a perquisizioni e azioni legali, come se gli indipendentisti fossero un’organizzazione criminale.
Presidente fiducioso
È evidente che l’indipendenza della Catalogna comporterebbe gravi rischi. Innanzi- tutto, non è chiaro quali sarebbero le conseguenze economiche per i catalani. Per l’Unione europea, invece, potrebbe essere l’inizio di una difficile fase politica, con i separatisti di Corsica, Fiandre e Norditalia pronti a seguire l’esempio dei catalani.
L’atteggiamento intransigente di Madrid sembra destinato a far crescere le proteste. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza il 20 settembre. La rabbia cresce e non è escluso che possa arrivare alla violenza, anche se gli indipendentisti hanno ribadito che le proteste resteranno pacifiche. Ma Rajoy non vuole correre rischi e ha sospeso le ferie di tutti gli agenti in servizio in Catalogna. In sostanza Madrid ha realizzato un piccolo colpo di stato contro il governo di un paese che non è ancora nato. Puigdemont, 54 anni, ex giornalista di Girona, una città al confine con la Francia, guida la Generalitat da meno di due anni. Ma ha guidato la campagna per l’indipendenza in maniera così prudente da guadagnare sostenitori anche fuori dalla Catalogna. Ha fama di essere un appassionato d’arte: quando era sindaco di Girona ha comprato per la città una collezione di opere per 3,7 milioni di euro, che include quadri di Picasso e Mirò, addebitando parte dei costi all’ente per i servizi idrici del comune.
In questo senso, il nazionalismo catalano è estremamente peculiare. A differenza dei movimenti di altri paesi, non punta sulla differenziazione. Più del settanta per cento dei catalani ha un genitore nato fuori dalla regione: per i catalani questo non è un problema anzi, è una fonte di arricchimento culturale. Gli indipendentisti considerano la Catalogna una regione lavoratrice, prospera e cosmopolita governata da un governo centrale autoritario, con sede a Madrid.
Il fronte separatista è estremamente variegato. Il movimento di Puigdemont si chiama Junts pel sí (uniti per il sì) ed è un’alleanza tra filo- europeisti, partiti di destra e il movimento di sinistra Esquerra republicana de Catalunya, che nel parlamento europeo fa parte del gruppo dei Verdi. Nell’alleanza c’è anche il gruppo Candidatura d’unitat popular (Cup), una formazione di sinistra che nel suo simbolo ha ancora una stella rossa, e non solo per ragioni sentimentali. Il programma politico del partito include la richiesta di case popolari, gas ed elettricità gratuiti, un reddito minimo garantito e la nazionalizzazione delle banche. L’unico elemento che tiene insieme questa variegata coalizione è il desiderio di una Catalogna indipendente.
Comunista e indipendentista
Una cosa che il nazionalismo catalano condivide con altri movimenti regionalisti europei è il fatto di essere un fenomeno per lo più provinciale, nel senso che la sua spina dorsale è formata dalle zone rurali e dai piccoli centri. Le comunità favorevoli all’indipendenza formano una sorta di mezzaluna intorno a Barcellona.
Il movimento è particolarmente forte in posti come Argentona, una cittadina di dodicimila abitanti a nordest di Barcellona. La bandiera degli indipendentisti, con le sue strisce gialle e rosse e una stella bianca su sfondo blu, sventola da molti balconi e finestre. La scritta “Sí” è visibile sui cartelloni pubblicitari, sulle facciate degli edifici e su adesivi appiccicati ai finestrini delle auto, uno accanto all’altro e spesso persino uno sull’altro. Gli alberi delle zone pedonali sono avvolti in teli di plastica su cui si legge “Democrazia”. E nella piazza centrale della città campeggia un enorme cartello a favore dei profughi, dove c’è scritto “Europa vergognati. Argentona si oppone al maltrattamento dei migranti”. I separatisti catalani sono forse degli estremisti, ma non degli estremisti di destra.
Eudald Calvo, un uomo di 31 anni con la barba da hipster, scarpe da tennis e un braccialetto di plastica colorato, è stato eletto sindaco di Argentona due anni fa, con il Cup. “Sono comunista. E indipendentista”, dice. Calvo sta aspettando che la polizia si presenti nel suo ufficio e gli consegni un mandato di comparizione. Anche solo concedere un’intervista sul referendum è teoricamente illegale, perché ai sindaci è proibito occuparsi del tema durante il loro orario d’ufficio.
La procura di stato ha perfino dichiarato che metterà sotto indagine tutti i settecento sindaci catalani che hanno intenzione di consentire il voto. Il governo di Madrid, sostiene Calvo, ha fatto sapere ai sindaci che potrebbero essere incriminati per disobbedienza civile, abuso d’ufficio e appropriazione indebita di denaro pubblico.
Calvo dice che ancora non sono venuti a cercarlo, ma che è solo questione di tempo. Poi indica fuori dalla finestra del suo ufficio, verso un cartello sui cui è scritto “I referendum sono la democrazia”, e dice di non aver paura di essere arrestato. “Se devo andare in prigione, allora dovranno arrestare altri 750 sindaci, oltre ad alcuni parlamentari e funzionari del governo catalano”, dice. “All’improvviso la Spagna si troverebbe con duemila prigionieri politici. Non riesco a immaginarlo”.
Per questo è convinto che il referendum si farà: “Se ricorrono alla violenza per evitare il referendum, noi non risponderemo con la violenza”, dice. “Ma immaginate la cosa in termini pratici. Con la polizia che si mette di fronte alle urne e migliaia di persone che si presentano. La polizia avrà il coraggio di fermarle?”.
Molti giovani si sono uniti al movimento per l’indipendenza. Rappresentano la generación cero, la generazione zero, quella diventata adulta negli anni della crisi economica, della disoccupazione altissima e della mancanza di opportunità. Molti di loro sognano una società nuova e migliore, un nuovo inizio e perino una rivoluzione.
Il separatismo catalano di oggi non è il prodotto di secoli di aspirazioni che si stanno finalmente manifestando. È nato dalla crisi economica spagnola e dal fatto che il governo di Madrid non ha voluto concedere maggiore autonomia alla Catalogna.
Madrid e Barcellona avevano raggiunto un accordo nel 2006, ma quattro anni dopo la corte costituzionale di Madrid, incoraggiata dal Partito popolare di Mariano Rajoy, lo ha invalidato. Questo succedeva proprio nel momento più duro della crisi economica. La conseguenza è stata che molti catalani hanno perso fiducia nei confronti del governo centrale. I catalani sono convinti di aver fatto troppe concessioni a Madrid. La Catalogna è la regione autonoma con l’economia più forte, sede di molte aziende importanti. Ma una parte rilevante delle tasse che raccoglie finisce a Madrid. Secondo gli esperti questo produce un deficit che corrisponde a una quota tra il cinque e l’otto per cento del pil catalano.
Questi conflitti non spariranno. Più Rajoy usa il pugno duro con i separatisti, più lo scontro è destinato a crescere. Anche perché a molti catalani il suo comportamento ricorda la repressione subita durante la dittatura di Francisco Franco.
Misura estrema
Artur Mas, il predecessore di Puigdemont, ha governato la regione per mezzo decennio ed è considerato il padre intellettuale del movimento indipendentista. Nonostante le perquisizioni, i sequestri e gli arresti, è convinto che il referendum si farà. “I preparativi per il referendum continuano”, dice nel suo ufficio. Mas sostiene che le schede possono essere stampate in venti- quattr’ore. “Abbiamo le urne. Abbiamo i seggi elettorali. E presto la gente saprà dove andare il giorno del voto”.
Secondo Mas il governo spagnolo è già riuscito a mettersi contro metà della popolazione catalana, e potrebbe ritrovarsi a fare i conti con un numero ancora più alto di cittadini che lo contestano. “Il movimento democratico non ha mai avuto tanti sostenitori”, afferma. “Anche i catalani che non vogliono l’indipendenza sono contrari a questo stato di polizia”.
L’ultima arma a disposizione di Rajoy sarebbe una misura estrema: potrebbe chiedere al senato di ricorrere all’articolo 155 della costituzione, che metterebbe la Catalogna sotto il controllo dello stato centrale. Ma così Rajoy, capo di un governo di minoranza, rischierebbe di perdere il potere. È già stato accusato di essere una minaccia per la democrazia, e non solo da chi simpatizza con i catalani.
Il capo del governo, per ora, non arretra di un millimetro.
Tradotto dall'Internazionale, originariamente pubblicato sul Der Spiegel, Germania

il manifestoDifendere l’università come istituzione ancora sana, è un’impresa improba. Tuttavia bisogna farlo, è necessario e doveroso farlo», con postilla
Era da poco cessata la campagna contro l’università pubblica (luogo di malaffare, di familismo, di scansafatiche), ed ecco che ci risiamo. Ora per riguadagnare la dignità perduta a causa di alcuni “baroni” corrotti, ci vorranno anni.
Anni per dimostrare che, nonostante tutto, l’università è un luogo dove si può ancora (fino a quando?) discutere e ricercare in (quasi) libertà. E’ una cittadella accerchiata dove i nemici sono sia fuori che dentro, come dimostrano le recenti vicende di cronaca. Difenderla non certo come ha fatto la ministra Fedeli affermando che «le notizie terribili di oggi dimostrano che il terreno della corruzione e dell’illegalità è nazionale». Così si sparge benzina sul fuoco facendo grave danno proprio all’istituzione che si vuole proteggere.
Difendere l’università come istituzione ancora sana, è un’impresa improba e si corre il rischio di essere accusati di complicità nel malaffare. Tuttavia bisogna farlo, è necessario e doveroso farlo.
Innanzitutto perché rappresenta, malgrado le tentazioni ministeriali, un argine contro la logica del mercato che considera inutile e, anzi, dannosa, la conoscenza critica e la conoscenza in generale. E’ una deriva pericolosa le cui conseguenze, a distanza di anni, possono farci precipitare nella barbarie.
La seconda è che i ricercatori che vi lavorano sono nella stragrande maggioranza dei casi animati solo dal desiderio di far progredire questa conoscenza, come dimostrato dai tanti riconoscimenti e attestati che essi raccolgono in giro per il mondo, sia pure a fronte di finanziamenti pubblici irrisori. Se venisse stilata una classifica mondiale delle università in base al rapporto tra produzione scientifica e finanziamenti alla ricerca, non c’è dubbio che, in molti settori, l’università italiana risulterebbe al primo posto.
La terza è che i tagli alla ricerca e il blocco, da diversi anni, del turn over hanno danneggiato irreversibilmente questa istituzione. In tutti i paesi occidentali i finanziamenti di ricerca sono cresciuti, nonostante la crisi economica, salvo che in Italia. Ed è ben noto come la scarsità di risorse aumenti la corruzione.
Nonostante queste condizioni, l’università italiana ha continuato a funzionare, ed è già un «miracolo» che sia avvenuto. Queste condizioni nessuno le ha denunciate pubblicamente: numero chiuso, tagli alla ricerca, stop al turn over, una selva di regolamenti e di adempimenti burocratici che quasi impediscono ai docenti di fare il proprio lavoro: «Nessun altro comparto della pubblica amministrazione ha subito un salasso di questa portata. E nessun altro paese europeo ha risposto alla crisi indebolendo le strutture dell’alta formazione e della ricerca», ha sostenuto Walter Tocci.
Clientelismo e mercimonio, corruzione e servilismo, sono mali da tempo presenti nelle nostre università (anche se a fare la parte del leone sono sempre o soprattutto le facoltà di Medicina e Giurisprudenza), ma di certo la riforma Gelmini non solo non li ha curati, ma la sua ispirazione aziendalistica insita nelle “riforme”, ha finito con l’essere peggiore dei mali.
La valutazione del cosiddetto “merito” è stata affidata agli algoritmi escogitati dall’Anvur incentivando il conformismo (pubblicazioni scritte in inglese, bibliometria, case editrici compiacenti, eccetera).
Per non parlare della invenzione dell’«eccellenza» che è stata la porta d’ingresso per professori entrati, senza concorso, dall’estero per chiamata diretta e che ha reso possibile le cosiddette «cattedra Natta» assegnate a docenti e ricercatori per giudizio politico (i presidenti delle commissioni dovrebbero essere di nomina del Presidente del Consiglio).
I recenti fatti di malaffare e corruzione rendono ancora più difficile, per i docenti universitari che hanno a cuore le sorti dell’università, riuscire a difenderla. Ma solo loro possono farlo dissociandosi pubblicamente da questi scandali e promuovendo un Il «processo auto riformatore dall’interno, il solo che possa salvare questa università malata.
Come può una università seria non essere un fortino assediato in una società in cui il pensiero critico è considerato un turpiloquio, in cui la menzogna propagandistica cancella ogni verità, il dissenso èun reato da reprimere, ogni tentativo di cambiare il mondo migliorandolo un tentativo di sovversione? E dove per le armi si spende mille volte di più che per la formazione? Il «processo auto riformatore dall’interno», potrà «salvare questa università malata» solo se investirà, e cambierà, la società nel suo insieme.

Sul banco degli imputati chi sfratta per trasformare le città e i territori in musei e parchi e i loro abitanti in comparse. La Giuria del Tribunale, costituita da attivisti ed esperti provenienti da tutto il mondo, analizzerà i casi e redigerà il verdetto e le raccomandazioni.
La Giuria Popolare, costituita dalle organizzazioni sociali che lottano per la difesa degli abitanti di Venezia, contribuirà al dibattito e alle decisioni.
La Sessione 2017 del Tribunale è un seguito del Foro Sociale Popolare Resistenza ad Habitat III (Quito, 2016), ed è organizzato nel quadro delle Giornate Mondiali Sfratti Zero da IAI assieme le organizzazioni sociali impegnate a Venezia nelle lotte per il diritto alla casa e contro lo spopolamento della città.
Il Tribunale Internazionale degli Sfratti (ITE) è un tribunale popolare e di opinione fondato nel 2011 dalla Alleanza Internazionale degli Abitanti con la collaborazione di organizzazioni della società civile nel quadro delle Giornate Mondiali Sfratti Zero per mettere praticamente ee interattivamente sul banco degli imputati i responsabili degli sfratti forzosi in tutto il mondo. Il Tribunale si avvale dell’esperienza di una Giuria internazionale competente e riconosciuta, oltre che sulla Convenzione Internazionale sui Diritti Economici Sociali e Culturali e altri strumenti della normativa internazionale per giudicare casi reali di sfratti forzosi che costituiscono violazioni dei diritti umani.Qui i casi presentati quest'anno alla Sessione di Venezia, che si tiene dal 28 al 30 settembre.