 «Sinistra. L’arma pedagogica è spuntata. Più proficuo rivolgersi alle centinaia di associazioni e movimenti auto-organizzati. Come agli albori del socialismo europeo».
«Sinistra. L’arma pedagogica è spuntata. Più proficuo rivolgersi alle centinaia di associazioni e movimenti auto-organizzati. Come agli albori del socialismo europeo». Il manifesto
, 24 giugno 2016 con postilla
I risultati elettorali impongono alle forze di sinistra una riflessione critica non facile e che proseguirà nei prossimi mesi. Da anni si lavora per la costituzione di un nuovo soggetto politico di sinistra capace di colmare il vuoto che separa milioni di persone dai partiti di governo. Un vuoto che si esprime sia in un astensionismo crescente ad ogni tornata elettorale sia in un disorientamento nelle scelte da compiere.
Al fondo c’è un malessere sociale diffuso in ampi strati della popolazione ma che sembra non trovare sbocco in un progetto di trasformazione sociale e politica in grado di interpretarlo adeguatamente. Il fenomeno non riguarda solo l’Italia, ma anche altri paesi. E per trovare elementi di spiegazione utili occorre risalire alla fine degli anni ’90 ed alla rottura che allora si consumò con quel che restava del riformismo e della tradizione socialdemocratica europea.
La frattura si espresse nella «terza via» teorizzata da Tony Blair, nel «nuovo centro» proposto da Gerhard Schröder, contrassegnò i ripiegamenti dei socialisti francesi e provocò la crisi del secondo centro-sinistra in Italia.
Nell’ultimo decennio l’ulteriore rafforzamento e concentrazione del sistema di potere dominante ha imposto un appiattimento ancor maggiore degli equilibri politici. I governi di coalizione o di pseudo-alternanza in vari paesi europei hanno accentuato il vuoto di proposte politiche alternative. Si aggiungano politiche di rigore a senso unico, flessibilità del lavoro, tagli alle spese sociali predicate dall’Unione europea e diligentemente adottate dai governi degli stati membri, e ci si renderà ragione di quella sorta d’ingabbiamento politico dal quale sembra difficile uscire.
Occorre chiedersi se sia sufficiente che un raggruppamento politico elabori un programma di cambiamento, per quanto articolato e corrispondente a bisogni reali, e lo propagandi diffusamente per far convergere su di esso un ampio consenso da tradurre in voti e, per questa via, modificare l’assetto politico. L’esperienza dimostra che programmi del genere possono risultare inefficaci.
In altri termini, non si può pensare di svolgere un’azione politica efficace per via “pedagogica”. Quando si è davanti a vasti strati di popolazione che, già di per sé passivi, sono sfiduciati e distaccati, gli appelli all’impegno politico sono destinati a cadere nel vuoto. La strada da percorrere sembra piuttosto quella di far riferimento a quei settori della popolazione che sono politicamente attivi e in movimento.
Basta ricordare come sono nati i sindacati di massa e i primi partiti socialisti nell’Europa di fine Ottocento. Da tempo esistevano gruppi socialisti di varie tendenze, ma la loro azione a lungo ebbe un seguito assai limitato. Però quando masse di operai e contadini, colpiti dai duri effetti della seconda rivoluzione industriale e dalla più decisa trasformazione capitalistica delle campagne furono costretti ad auto-organizzarsi per difendersi e resistere, allora e solo allora alcuni gruppi socialisti riuscirono a collegarsi con lavoratrici e lavoratori che erano già in movimento.
L’insegnamento che viene da quella e da altre fondamentali tappe della storia del socialismo in Europa consiste appunto nel fatto che gruppi, o «avanguardie», promotori di mutamenti sociali e politici hanno raggiunto dimensioni di massa quando sono riusciti a interpretare bisogni e rivendicazioni espressi da movimenti in essere.
Anche oggi la sinistra europea deve cercare la connessione con soggetti sociali già attivi. Basta guardarsi intorno. In Italia, come in altri paesi, vi sono centinaia di associazioni e movimenti auto-organizzati che si battono per vari obiettivi politici e sociali. Si va dalla difesa dei diritti umani alla salvaguardia dell’ambiente, dalla lotta contro le discriminazioni di genere a quella contro la precarietà del lavoro, dai movimenti in difesa della scuola pubblica a quelli contro i tagli alla sanità. Le numerose lotte per i diritti dei lavoratori non di rado si sono consolidate in organizzazioni durevoli che si affiancano o competono con l’azione dei sindacati tradizionali.
Sempre più numerose e di varia ispirazione sono le associazioni che si mobilitano in difesa dei diritti degli immigrati e per politiche di accoglienza. Altrettanto significativo è l’impegno di quanti militano in associazioni pacifiste, per debellare fame e malattie endemiche nei paesi più poveri. O nelle organizzazioni in difesa dei beni comuni o della stessa Costituzione.
Molte di queste organizzazioni svolgono la loro azione in modo implicitamente o esplicitamente alternativo alla mappa degli interessi, poteri e politiche dominanti. Con tratti d’unione potenziali o in atto tra i diversi movimenti. Realtà testimoniata anche dal fatto che molte persone militano in più movimenti e organizzazioni di questo tipo. D’altra parte, non c’è dubbio che le rivendicazioni e gli obiettivi perseguiti attingono a livelli di consapevolezza politica decisamente alti. Né si può trascurare minimamente il fatto che molte di queste organizzazioni hanno carattere internazionale o si collegano ad omologhe attive in altri paesi. È a questi movimenti che occorre guardare. È con essi che si può e si deve cercare la saldatura comprendendone la maieutica e le nuove forme di espressione politica.
In che modo è avvenuto il coagulo di movimenti come gli Indignados spagnoli poi sfociati nella formazione di Podemos? Come è lievitato il movimento di Occupy Wall Street e come si è intrecciato ad altri fino a costituire la base più attiva dell’elettorato di Bernie Sanders nelle primarie americane? E da dove nasce la forza insospettata e irriducibile del movimento di protesta contro la Loi Travail in Francia? Perché nulla di simile si è verificato nel contrastare il Jobs Act italiano, che pure è decisamente peggiore?
Auto-organizzazione, trasversalità, maieutica dei movimenti ci sembrano elementi da cui non si può prescindere se si vogliono innescare processi di trasformazione in una società in cui i vincoli sembrano prevalere sulle possibilità.
postilla
La metà degli italiani (tra astenuti e voti M5S) ha votato contro il sistema e gli uomini che si riallacciano alle sigle della sinistra novecentesxa. Non è forse arrivato il momenti di abbandonare tutte le croste del passato per cercarne l'anima, e ritrovarla in un nuovo modo di fare politica? Per esempio, Podemos
 .
.
La Repubblica, 24 giugno 2016 (c.m.c.)
Valutando i risultati dei ballottaggi, Matteo Renzi ha voluto subito sottolineare che la capacità attrattiva dell’M5S dipendeva dal fatto che era stato percepito come soggetto del “cambiamento”. Ed ha aggiunto che da questo portava con sé la conclusione che il governo doveva insistere con ancor maggiore determinazione sulla strada delle “riforme”.
Ma proprio le parole adoperate per una diagnosi così sbrigativa mostrano gli equivoci politici che la caratterizzano e l’intenzione di sfuggire alle domande più stringenti che le elezioni hanno proposto.
Non si può certo dimenticare il fatto che il Presidente del Consiglio ha sempre insistito in maniera martellante proprio sul cambiamento che il suo governo avrebbe già determinato in tutte le materie più significative.
Perché l’opinione pubblica non ha dato rilievo a questo fatto proprio nel momento in cui il governo si presentava al giudizio dei cittadini? Non credo che ci si possa rifugiare nell’argomento del difetto di comunicazione, visto che proprio la comunicazione ha costituito l’ossessione di Renzi, sì che si potrebbe, se mai, addirittura azzardare l’ipotesi che la sua presenza in ogni luogo e in ogni tempo, il suo tono perennemente assertivo abbiano provocato una reazione di rigetto da parte degli elettori.
Se, però, si ragiona seriamente sull’accoppiata “cambiamento”/” riforme”, diventa più aderente alla realtà la conclusione che vede nel voto amministrativo il rifiuto del cambiamento incarnato dalle politiche governative. Due cambiamenti a confronto, dunque, uno dei quali prospetta un cambio di passo.
Non facile, perché la dimensione locale non rende agevole la messa a punto di politiche che abbiano in qualche modo un significato alternativo rispetto a quelle governative. Ma pure con gli interventi consentiti dalle specifiche competenze dei comuni è ben possibile dare concreti e visibili segnali di un diverso modo di selezionare le domande sociali, di determinare priorità corrispondenti agli interessi e ai bisogni che sono state rese visibili dal voto.
Due sono le dimensioni da prendere in considerazione. Riferimenti come quelli alla trasparenza, alla partecipazione, alla legalità dell’agire pubblico hanno trovato un denominatore comune nel rifiuto di ogni logica oligarchica, che non è solo un retaggio del passato, ma il tratto caratteristico del modo in cui si sono venuti organizzando i partiti. Qui si coglie la spinta a ripensare le forme del rapporto tra i cittadini e la politica, anzi la stessa cultura politica.
Non è una esigenza astratta. Le oligarchie producono un duplice effetto di esclusione — delle persone legittimate ad aver voce effettiva nella politica e delle domande sociali da prendere in considerazione.
Le riforme del governo Renzi sono profondamente segnate da questo duplice limite, del quale le persone hanno potuto direttamente misurare il peso considerando la subordinazione dei loro diritti sociali al primato attribuito al calcolo economico. Di questo, di un nuovo protagonismo delle persone e dei loro diritti hanno cominciato a rendersi conto diversi tra i commentatori dei risultati elettorali, con riferimenti e parole che, come eguaglianza e solidarietà, rinviano a una diversa idea di società.
Anzi, mostrano come la certificata morte della distinzione tra destra e sinistra abbia avuto come esito politico una ideologizzazione ben orientata, che ha attribuito alla logica di mercato le sembianze di un invincibile diritto naturale. Sottolineare questo dato di realtà non significa invocare uno sguardo rivolto al passato, il recupero di vecchie categorie. Pone la ben diversa questione di costruire il futuro secondo principi e diritti nei quali ci si possa comunemente riconoscere.
Poiché un altro dei luoghi comuni che hanno afflitto, e ancora affliggono, la discussione italiana, è rappresentato da una contrapposizione schematica tra conservatori e innovatori, bisogna pur ricordare che non basta proporre un qualsiasi cambiamento per essere automaticamente ascritti alla benemerita categoria degli innovatori. È indispensabile individuare i criteri necessari per valutare la compatibilità del cambiamento con libertà e democrazia. Non vi è dubbio che, altrimenti, dovremmo attribuire a Donald Trump la medaglia dell’innovatore.
I risultati elettorali dovrebbero spingere a una riflessione in questa direzione, non solo per ricondurre alla rilevanza dei criteri costituzionali le politiche di riforma di nuovo promesse, ma per valutarne l’effettivo carattere innovativo. Proprio considerando i valori di riferimento, ben può dirsi che in Italia (e non solo) si sia venuto costituendo un blocco sociale fondato sul primato di interessi e ceti che concretamente revocano indubbio la rilevanza primaria di eguaglianza e solidarietà.
Una politica così fatta assume le sembianze della restaurazione, e non può essere definita che conservatrice. A questa conclusione, consapevoli o no, giungono molti commentatori di questi giorni che insistono sui guasti drammatici della diseguaglianza, senza dire una parola sul fatto che questa diseguaglianza non nasce da dinamiche incontrollabili, ma è l’effetto di politiche deliberate, perseguite con determinazione pari all’arroganza.
Poiché, tuttavia, il perno di una rinnovata stagione di riforme è, per quasi quotidiana insistenza del Presidente del Consiglio, quella legata alla riforma costituzionale, anche questa deve essere valutata considerando i criteri che i risultati elettorali suggeriscono.
La confusione è massima, perché la debolezza culturale del ristrettissimo ceto di governo ha messo spietatamente in luce l’uso strumentale delle istituzioni. Dopo aver personalizzato al massimo la campagna referendaria, ora Matteo Renzi sembra incline a seguire altre strade, non perché si sia reso conto degli effetti distorsivi della trasformazione di un referendum in plebiscito (altro palese segnale conservatore), ma per una convenienza elettorale che non può distogliere da una valutazione nel merito della riforma e della sua innegabile connessione con la legge elettorale.
Proprio l’invocata discussione sul merito si sta rivelando impietosa. Ricordo, da ultimo, l’analisi di Ugo De Siervo, che non mostra soltanto con chiarezza come la sbandierata semplificazione del procedimento legislativo sia contraddetta dalla farraginosità delle procedure previste, ma sottolinea anche l’alterazione di delicati equilibri e prerogative costituzionali.
Vengono pure rafforzati i meccanismi di esclusione, come accade con l’eccessivo accentramento delle competenze statali rispetto a quelle delle regioni, che evoca la riduzione della rappresentanza dei cittadini prevista dall’Italicum (ancora un tratto conservatore). Proprio l’analisi puntuale, di dettaglio, fa così emergere “gravi rischi di un complessivo peggioramento della nostra democrazia”.
Questo è il contesto nel quale si svolgeranno le discussioni dei prossimi mesi. I risultati elettorali lo hanno reso più chiaro, hanno individuato poteri e responsabilità delle diverse forze politiche, che devono esser ben consapevoli anche della necessità di non farsi incantare da un altro argomento che viene speso nella discussione pubblica, secondo il quale, poiché non si toccano formalmente articoli del prima parte delle Costituzione, i principi e diritti lì considerati non correrebbero rischi.
Non è così. Poiché la garanzia dei diritti è affidata alle leggi, nel momento in cui in cui queste vengono variamente manipolate, la soglia di quelle garanzie si abbassa. La discussione dei dettagli della riforma si fa giustamente impietosa, non può dar spazio a convenienze di breve periodo. Se si incrina il patto fondamentale tra i cittadini, la convivenza civile, la buona politica, il reciproco riconoscimento tra i cittadini diventano sempre più difficili.
La Gran Bretagna esce dall’Unione europea. Oltre 17 milioni di sudditi di sua maestà (51,89%) hanno votato a favore del Brexit.
Il manifesto, 24 giugno 2016 (m.p.r.)
Remain: 16.141.241 (48.11%)
Leave: 17.410.742 (51.89%)
Affluenza molto alta al referendum (72,2%), che dopo i conteggi della notte ha consegnato un verdetto storico, che ora quasi sicuramente scatenerà un effetto domino per tutto il continente. Diverse forze anti-europeiste infatti hanno già chiesto il referendum sull’Unione.
Sterlina ai minimi storici, crollo delle borse mondiali. La Banca d’Inghilterra assicura che prenderà “tutti i passi necessari per la stabilità finanziaria e monetaria”.
Il leader dell’Ukip, Nigel Farage, ha chiesto le dimissioni del premier David Cameron: «E’ il nostro giorno dell’indipendenza, una vittoria della gente vera, una vittoria della gente ordinaria, una vittoria della gente per bene».
Preoccupazioni anche per la tenuta del Regno Unito, visto che Scozia e Irlanda del Nord hanno votato massicciamente a favore dell’adesione all’Europa. Lo Scottish National Party (Snp) si prepara in ogni caso a chiedere a Westminster di partecipare al negoziato tra Regno Unito e Ue per il ritiro. E’ altamente probabile che contestualmente sarà richiesta la possibilità di un secondo referendum limitato alla sola Scozia. Alex Salmond (Snp): «L’esito del referendum cambia completamente tutto il contesto dell’indipendenza scozzese».
Secondo i trattati l’uscita di Londra andrà ora negoziata con l’Ue ma la trattativa e l’uscita definitiva dovrebbe concludersi entro due anni (salvo proroghe).
Non è escluso che in questo lungo processo di uscita, la Scozia scelga di tenere un nuovo referendum definitivo sulla permanenza o no nell’Ue a differenza del Regno Unito.
Critiche all’interno del Labour anche per il leader Jeremy Corbyn, a favore del Remain. Il Guardian parla di manovre rapidissime dietro le quinte per votare la sfiducia al segretario e costringerlo alle dimissioni.
Previste per la mattinata riunioni in tutte le cancellerie del mondo.
Rinviata a data da destinarsi la direzione del Partito democratico che era stata convocata per oggi dopo la sconfitta alle elezioni comunali.
Si è tenuta questa mattina presso la Sala Situazioni della Presidenza del Consiglio una riunione convocata da Matteo Renzi. Alla riunione hanno partecipato il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, il Ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Marco Minniti (servizi segreti) e il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco.
Alle 11.30 conferenza stampa a Parigi di Marine Le Pen (in Francia le presidenziali si terranno l’anno prossimo). La leader del Fronte Nazionale ha già chiesto l’indizione di un identico referendum in Francia e in tutti i paesi Ue che lo vorranno.
Il premier belga Charles Michel ha chiesto la convocazione immediata di un vertice europeo senza la presenza inglese.
Le tre istituzioni che guidano l’Europa (il premier olandese Rutte come presidente di turno, Juncker per la Commissione, Tusk per il Consiglio) si riuniranno oggi alle 10.30.
Convocato nel pomeriggio in Lussemburgo un vertice di tutti i ministri degli Esteri europei.
Nel suo discorso alla nazione, in diretta televisiva (alle 9.20 ora italiana, le 8,20 a Londra), il premier David Cameron ha detto che Galles, Scozia e Irlanda del Nord saranno coinvolte nei negoziati con Bruxelles.
Cameron si dimette da primo ministro e affida al congresso del Partito Conservatore di ottobre la scelta di individuare il suo successore, continuerà dunque a governare per i prossimi tre mesi.

Articoli di Beppe Severgnini, Andrea Cerretelli, Francesco Merlo, Ivo Caizzi, Gianni De Fraja. Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 OreLavoce.info, 24 giugno 2016 (m.p.r.)
Corriere della Sera
La SCELTA PEGGIORE
PAGHEREMO TUTTI
di Beppe Severgnini
Phileas Fogg, qui dentro, fece una scommessa da ventimila sterline: avrebbe compiuto il giro del mondo in ottanta giorni. Ai membri del Reform Club, riuniti nello stesso luogo, ieri sera ne avevo suggerita un’altra: se la Gran Bretagna uscirà dall’Unione Europea se ne pentirà, anche prima di ottanta giorni. E la posta in gioco, stavolta, è ben più alta. È accaduto. Leave (lasciare la UE) ha ottenuto il risultato che pochi aspettavano e molti temevano. Little England batte Gran Bretagna. Gli inglesi scappano, e non succede spesso. Il Regno Unito non è più una grande potenza: è una media potenza che sa fare alcune cose molto bene (parlare inglese, vendere servizi, andar per mare, coltivare l’arte, esportare musica e calcio). I problemi del pianeta sono troppo vasti e complessi – le migrazioni e i conflitti, gli accordi commerciali e la finanza globale – perché le democrazie europee li affrontino in ordine sparso. Gli inglesi, da soli, non ce la possono fare. Avrei voluto gridarle, queste cose: ma le regole del club lo impediscono.
Sono membro del Reform da trent’anni: è la mia casa londinese (dopo averci vissuto, non ho mai dormito in un albergo in questa città). Ed è importante trovarsi a casa quando i proprietari prendono decisioni fondamentali per la loro vita. E la nostra, in questo caso.
Il referendum britannico sull’Europa era storico: per una volta, l’aggettivo non è abusato. E il Reform Club ha dimestichezza con la storia. Come gli inglesi, del resto, che la masticano con una passione sconosciuta ad altri popoli (e non usano rimuoverla, anche quando provoca imbarazzo).
Il club ha aperto le porte centottanta anni fa, nel 1836. Esattamente dov’è oggi: 104 Pall Mall, dentro un edificio modellato su Palazzo Farnese a Roma. L’architetto, Sir Charles Barry, non voleva copertura sull’atrio centrale, come nel modello originale. Poi è stato convinto che il clima di Londra non era il clima di Roma, e ha aggiunto una cupola di vetro.
Eravamo in tanti là sotto, la notte scorsa. Un salone dove sono passati Disraeli e Gladstone, Lloyd George e un giovane, iracondo Churchill. Tutti ad aspettare, con un bicchiere in mano e un po’ di preoccupazione nello sguardo.
Per la Referendum Evening — è solo la terza consultazione nella storia del Regno Unito — il club aveva piazzato grandi televisori all’ingresso, esteso l’orario della Coffee Room (il ristorante, non servono il caffè) e tenuto aperta la Smoking Room (la sala di lettura, dove non si può fumare). Noi ci siamo chiusi a scrivere nella Study Room dove c’era poco da studiare, ormai: bisognava solo aspettare i risultati finali, che sono arrivati all’alba.
Nella Study Room, verso le 20, sono entrati un australiano, una sudafricana, un inglese. Ha detto il primo: «Io spero fortemente che rimangano! Perché la permanenza del Regno Unito è fondamentale per l’Europa, l’Europa è fondamentale per la pace del mondo, e l’Australia fa parte del mondo. Lo sa anche lui, questo pom (inglese)!». Avremmo dovuto dirgli: illuso! Ma non l’abbiamo fatto.
Un socio, esperto di statistica, verso le 21 si è alzato e tutti hanno taciuto per ascoltarlo: «Otto sondaggi su dieci per Remain», afferma sicuro. Ha detto un altro, verso le 22: «Vengo da Downing Street: Remain chiuderà al 58%». Un terzo, poco dopo: «Secondo me si resta in Europa, ma con una percentuale più bassa: 52%». Un quarto, intorno a mezzanotte: «Stasera decideremo che tipo di nazione vogliamo essere».
Ora lo sappiamo: una nazione che ha scelto il passato, 52% contro 48%. Speriamo non debba pentirsene.
Il barista, ieri sera, aveva preparato due cocktail: Remain (Prosecco, Schnapp, Pesca) e Leave (Prosecco, Blue Curaçao, Arancia). Diceva di vendere più il primo, ma a un certo punto — mentre l’atrio, lentamente, si svuotava — ha chiuso bottega.
I dipinti, dentro le cornici dorate, la notte scorsa hanno assistito a uno spettacolo inconsueto: il Regno Unito ha deciso il suo destino in modo emotivo, e non l’aveva mai fatto. Chissà cos’avrebbero votato Charles Dickens, William Makepeace Thackeray e Arthur Conan Doyle — tutti, in passato, membri del Reform Club. I primi due avevano i titoli giusti per l’occasione: Grandi speranze (da una parte e dall’altra) e La fiera delle vanità (non si spiegherebbe la trasformazione di Boris Johnson da europeista convinto a leader della Brexit). In quanto a Conan Doyle, avrebbe potuto affidare a Sherlock Holmes un’indagine affascinante: cos’è venuto in mente a David Cameron di indire un referendum su un tema tanto complesso e così facile da strumentalizzare?
La campagna prima del voto è stata perfida e, quel che è peggio, superficiale. I paladini del Leave hanno puntato sulla paura dell’immigrazione, senza considerare i fatti. La Gran Bretagna vive — letteralmente — sugli immigrati: dai medici agli infermieri, dai camerieri ai calciatori, dagli autisti ai dentisti. Anche i sostenitori del Remain hanno provato a spaventare i cittadini. Non hanno detto che l’Unione Europea fosse meglio; hanno ripetuto, allo sfinimento, che uscirne era peggio. Solo l’omicidio della parlamentare laburista Jo Cox ha scosso le coscienze. Ma non ha cambiato il risultato.
Il Reform Club non si schiera e non rappresenta un campione statistico; ma l’impressione è che, tra i soci inglesi, sette su dieci abbiano votato per restare nell’Unione. I Brexiteers, però, si sono fatti sentire. I nomi non sono consentiti: ma uno di loro, con un incarico di partito, ha provocato un certo sconquasso quando cercato di coinvolgere il club nella sua crociata pro-Leave.
Una posizione che sembra poco congeniale allo spirito di questo posto. Il Reform Club prende infatti il nome dal Reform Act del 1832, che modificava il sistema elettorale e allargava il diritto di voto alla borghesia. E’ stato, nel corso del XIX secolo, il club liberale di Londra, «noto per lo spirito radicale e progressista». E’ rimasto tale nel XX secolo. E’ stato il primo ad ammettere le donne come soci, nel 1981; a concentrarsi sulla qualità della cucina; e a fornire stanze da letto per i soci venuti da lontano (ora ne ha 48, di cui 26 con bagno). Ancora oggi, al momento dell’adesione, i membri devono sottoscrivere un’adesione ai principi liberali. Quando firmò anche un consigliere dell’Ambasciata Sovietica, negli anni Ottanta, in molti si chiesero se fosse sincero.
Mentre la luce torna sugli Waterloo Gardens, i liberali e i progressisti insonni del Reform Club hanno qualcosa da festeggiare? Non sembra proprio. Il Regno Unito scappa, e non l’ha mai fatto. E’ uscito dal club sbattendo la porta: e non si fa.
La Repubblica
ESSERE O NON ESSERE UN'ISOLA
di Francesco Merlo
«Dai prati ai corgi della Regina, i britannici restano un’umanità speciale perché anfibia. E il voto sulla loro identità rilancia il Regno Unito come luogo della libertà»
Mia moglie è inglese e ho due figli che hanno votato “Remain” «per non cacciare papà di casa», che è la formula scherzosa che riassume bene l’idea del mare aperto, del bisogno d’Europa intesa però come mondo. E tuttavia mia moglie ha zie e cugini che hanno votato “Leave” per la stessa identica ragione: «Perché l’Europa ci allontana dal mondo». Non sono gli estremisti della paura, non sono i populisti, non sono i nativisti alla Nigel Farage né gli eccentrici alla Boris Johnson, ma sono persone colte e intelligenti che hanno vissuto in Svizzera, in Francia, in Nuova Zelanda. Gli uni e gli altri, quelli che hanno votato “Remain” e quelli che hanno votato “Leave”, credono nella europeità dell’open sea di Winston Churchill, nella sua difformità rispetto ai progetti, ai sogni e qualche volta anche ai deliri franco-tedeschi, perché credono - scrive Shakespeare nel Riccardo II - in «questa isola di maestà, questa dimora di Marte, questo nuovo Eden e Paradiso Terrestre… questa pietra preziosa incastonata nel mare d’argento che la difende contro l’invidia di paesi meno felici come un muro e un fossato difendono una casa».
È questa l‘insularità degli inglesi che non sarà mai addomesticata né da un Parlamento sovranazionale e neppure da Internet. Ed è un’insularità tutta racchiusa nella sfumatura negativa con cui gli inglesi pronunziano l’aggettivo continental, una vaga ironia che esprime estraneità e commiserazione. Continental è il breakfast che non sa di niente, è il vino, è la terrazza, è lo snob pacchiano, è salutarsi baciandosi sulle guance, è la precedenza a destra, è parlare con le mani, è la lingua inglese inevitabilmente masticata, è il barocco di chi mette più di quel che serve: «The French are glad to die for love» (i francesi sono felici di morire per amore) cantava Marylin e subito aggiungeva che il baciamano è «quite continental», molto continentale. Quando il 6 maggio del 1994 la Regina Elisabetta e il presidente Mitterrand inaugurarono l’Eurotunnel sotto la Manica un titolo spiritoso del Times riassunse così la paura dell’omologazione: «Mamma mia che puzza d’aglio».
Anche l’odore dell’isola - che è il luogo senza storia che dà origine alla storia - è speciale perché è unico. Ed è inutile contrapporre all’aglio del continente l’insularità fritta dei fish and chips mischiati al legno umido dei Piers, dei moli, e delle pietre bagnate da un mare sempre agitato. E c’è pure l’afrore di stalla dei garzoni che ravviva lo spirito di Lady Chatterley, l’odore del cavallo che è ancora l’odore tipico dell’Inghilterra, quello che diventa americano in Martin Eden, l’odore della fatica «dei bifolchi e dei facchini, dei sobborghi sozzi, puzza di verdure andate a male: quelle patate stanno marcendo, annusale, maledizione, annusale».
La ur-Pflanze, la pianta originaria che Goethe cercava nelle isole, secondo gli inglesi è la rosa d’Inghilterra, “lo splendido odore” con cui si apre Il ritratto di Dorian Gray, la rosa bianca di York fusa con quella rossa di Lancaster, la rosa dei Tudor a cui si aggiunge «l’effluvio greve dei lillà e la fragranza più delicata dei cespugli dell’eglantina, i fiori del citiso, dorati e dolci come il miele…». In realtà anche il giardino inglese è nato come un opt-out, direbbe l’europeista con moderazione David Cameron, come un’opzione di uscita, qualche secolo prima che da Schengen e dalla moneta unica, dall’eccesso di geometria dei giardini continentali all’italiana e alla francese: il prato rasato, ma libero, contro la burocrazia di Bruxelles che imprigiona la bellezza negli arabeschi cromatici.
Il punto è che la Gran Bretagna deve, comunque, rimanere isola perché è il luogo che sta fuori dal tempo e dallo spazio, o forse è il punto in cui spazio e tempo si incontrano, un punto senza svolgimento dove tutto si conserva e dove le modificazioni, impercettibili, durano millenni. L’odore del giardino inglese di cui parla Oscar Wilde è in realtà una leggenda della botanica. E il Corgi, il famoso cane britannico che la Regina alleva, protegge e seppellisce nel castello di Balmoral, il Pem- broke Welsh Corgi che - scrisse spiritosamente il Guardian - «forse the Queen ama più del principe Filippo, dei suoi figli e dei suoi nipoti», piccolo, goffo, gambe troppo corte e testa volpina, è così strano che forse davvero è l’ur-Hund, il cane originario, il quale somiglia a tutti i cani ma non è un cane.
Nelle isole, e tanto più in Gran Bretagna che è l’isola che non è stata mai invasa, tutte le forme portano tracce di antichità, sono come le ombre della caverna di Platone, e anche gli uomini e le donne sono prototipi e stereotipi di razze dimenticate o superate, con quel tanto di selvatico che affascina i cercatori di sensazioni forti, profonde e sensuali, come quando si addenta una pork pie o come quando il corpo acerbo, forte e nudo di Lady Godiva cavalcava per le vie di Coventry accecando tutti i giovani (tutti i Tom) di Inghilterra. Nell’opera di Mascagni, Lady Godiva è una vittima, nei versi di Bukowski è invece la fonte di ogni ispirazione artistica: «Una poesia è una città dove Dio cavalca nudo per le strade come Lady Godiva».
Dunque il codice mentale dell’inglese è come il Corgi della regina, inattuale e perciò dirompente, sorprendente e scandaloso. Quella isolana è infatti un’umanità speciale perché anfibia: cool, calm and collected (fresca, calma, composta) come la terra saggia e buona del Kent, e al tempo stesso rough, stormy, unruly (agitata, tempestosa, e indomabile) come il mare sconfinato della Land’s End, la punta Ovest della Cornovaglia. Aspettando il D-Day Churchill disse a De Gaulle: «Ogni volta che l’Inghilterra dovrà scegliere tra l’Europa e il mare aperto, sceglierà sempre the open sea. E ogni volta che io dovrò scegliere tra te e Roosevelt, io sempre sceglierò Roosevelt».
E qui si capisce bene come l’insularità possa diventare, anche senza la demagogia di un referendum, libertà o reclusione, che sono gli opposti simbolici di ogni isola del mondo. Nel 1969 tutti i ragazzi della terra si radunarono e si riconobbero nell’isola di Wight, nel Sud dell’Inghilterra: la libertà dell’isolacontro i doveri, gli obblighi e le convezioni del continente. Ma l’isola è anche la punizione dell’uomo: Napoleone morì a Sant’Elena; a Ventotene fu fiaccata la dignità di Giorgio Amendola, Altiero Spinelli, Sandro Pertini, Ernesto Rossi…; Paul Gauguin mise in salvo nelle isole Marchesi la fantasia e i colori aggrediti dal grigio fumo della nebbia e delle ciminiere dell’Ottocento europeo. Alcatraz è il contrario di Mikonos, Guantanamo è il contrario della Key West di Hemingway. E però sempre i contrari sono complici. Ed è infatti questa doppia faccia della separatezza insulare a rendere gli inglesi così aperti e al tempo stesso così chiusi: l’isola è il mondo, è il luogo di ogni utopia (Thomas More), ma è anche il piccolo posto segreto dove si conserva la ricchezza, l’altrove dei dobloni che confortano il grigio continente, “l’Isola del Tesoro” come fierezza di essere diversi, necessari al mondo proprio perché unici e migliori, come vuole il paradosso di quel poeta veneziano, Mario Stefani, che scrisse un libro intitolato: Se Venezia non avesse il ponte, l’Europa sarebbe un’isola.
Chiuso il referendum, stamani ogni inglese che si è guardato allo specchio si è comunque ritrovato più orgogliosamente inglese. Al di là del risultato, infatti, il rito del voto sull’identità ha rilanciato l’Inghilterra che celebra in se stessa l’isola-mare come il luogo della libertà e della civiltà occidentali, l’unico spazio d’Europa davvero transnazionale, il fuori mano e l’eccezione assunte come forza. È l’Inghilterra che ogni anno a Portsmouth rende onore alla Victory di Nelson rispettata come una chiesa. Gli inglesi credono infatti nel mare aperto, che è la sostanza della loro storia, e hanno in Nelson il vero eroe nazionale, il piccolo ammiraglio il cui cadavere fu conservato dentro un barile di brandy, l’uomo con un braccio solo, cieco da un occhio, goffo sulla terra e bellissimo in acqua, maldestro, imbranato e isterico in porto, ma intelligentissimo sulla nave che è sempre inglese perché è l’isola che va per isole, governata da un comandate che ne traccia la rotta e non può mai abbandonarla. La nave, dove libertà e reclusione coincidono perfettamente, è il luogo in cui l’inglese si illude di sentirsi più vicino alla propria origine. Scrisse Stevenson: «Noi inglesi abbiamo la pretesa che il mare sia inglese. Anche sotto i cannoni e negli spazi più ostili delle nazioni straniere e lontane, sul mare siamo in patria. È il cimitero dove i nostri avi riposano aspettando le trombe del giudizio universale, il nostro accesso al mondo e il nostro baluardo».
Ci voleva davvero un referendum, così terribile e appassionato, perché l’Inghilterra tornasse a proporsi come laboratorio dell’Occidente, lo scrigno dei suoi valori, la banca delle risorse del navigatore cosmico, dell’isolano primordiale che è l’uomo del futuro, dell’inglese come pirata d’Europa. È infatti l’insularità che ha trasformato la pirateria in civiltà. Il pirata, senza l’isola che gli è solidale, non sarebbe mai esistito e mai potrebbe esistere. Il pirata e l’isola sono come l’astronauta e le stelle.
Il Sole 24 Ore
BREXIT,
LA CATTIVA COSCIENZA DELL'EUROPA
di Adriana Cerretelli
Fallimento della Ced, la Comunità di euro-difesa, affondata nel 1954 dall’Assemblea nazionale francese. Nove anni dopo, politica della sedia vuota: il generale De Gaulle blocca per 7 mesi il mercato comune per ritorsione contro partner troppo ansiosi di integrazione, troppo poco leali alla sua Europa delle patrie, alla fine garantita dal compromesso di Lussemburgo, lo scudo a difesa degli interessi nazionali.
«I want my money back»: da poco premier Margaret Thatcher, che pure nel referendum inglese del ’75 si era battuta per il “Remain”, apre un conflitto che bloccherà per 4 anni la vita comunitaria, fino a quando non otterrà soddisfazione sul taglio del contributo britannico all’euro-bilancio.
Fine anni ’80, caduta del Muro di Berlino, riunificazione tedesca prima ed europea 15 anni dopo: bagno improvviso di nuovo disorientamento e antiche paure, conclusosi però con il balzo in avanti verso il mercato e la moneta unica.
Poi, è storia recente, otto anni di crisi finanziaria, la peggior recessione dal dopoguerra, disoccupati alle stelle, euro in bilico sull’abisso non solo greco, il salvataggio di Mario Draghi ma quasi tutti i problemi restano ancora irrisolti.
Ne ha vissute di crisi l’Europa! Tanto da entrare nel suo Dna, spesso per trasformare drammi immediati in successi futuri. Finirà così anche questa volta dopo l’ennesimo pronunciamento popolare sul vecchio dilemma inglese dell’essere o non essere europei? Verrebbe voglia di sdrammatizzare, mettendo l’intera vicenda in prospettiva storica per concludere che l’Europa alla fine macinerà anche questa crisi, come ha fatto con tutte le altre.
Questa volta però non sarà come le altre. La Gran Bretagna che esce dalla prova referendaria è un Paese irriconoscibile: fazioso, bugiardo, violento, spaccato. Come ai tempi della guerra civile, di Oliver Cromwell e dei suoi “bravi” che incendiavano chiese lasciandosi indietro scheletri vuoti, sognavano di rovesciare la monarchia e instaurare la repubblica. Solo che oggi l’assalto è alla cattedrale europea e ai suoi odiati sacerdoti.
Trasformata nel male assoluto, l’Europa acceca i suoi nemici, tanto che non riescono più a vedere gli enormi benefici che regala. Però è essa stessa accecata, non dalla stessa violenza ma dai propri limiti. Sempre più evidenti.
Ha fatto molto l’Unione sulla strada della propria integrazione ma ha fatto tutto a metà: dal mercato unico, all’euro, all’unione bancaria, al micro-bilancio comune. Quasi niente su energia, digitale, innovazione tecnologica, servizi, investimenti, politica macroeconomica comuni. Per non parlare della politica migratoria.
Sono queste le nuove sfide? Certo. Ma come e con chi quando nazionalismi, protezionismi ed egoismi dovunque rialzano la testa, la sfiducia reciproca la fa da padrone insieme alla paura di populismi ed euroscetticismi che dovunque paralizzano azione e visione dei Governi in carica?
Mancano leader veri? Certo. L’Europa a 28 è un progetto spezzato? Anche. Dietro malessere e cacofonie generali c’è anche la sua incapacità di tenere il passo con la globalizzazione ineluttabile che avanza sul filo di una travolgente innovazione tecnologica e digitale, riduce il mondo al formato di un click, stravolgendone il modello di sviluppo e di società.
C’è la caduta demografica che rema contro la sua crescita economica e la tenuta del welfare. C’è la democrazia che cambia, spiazzata dal tramonto di ogni forma di intermediazione politica, economica e finanziaria, costretta alla concorrenza con populismi e social media nella ricerca di un consenso irrinunciabile ma di sicuro più volatile e instabile. Sullo sfondo di questo storico rivolgimento, le divergenze intra-europee appaiono danni collaterali da aggiungere al groviglio dei problemi interni aperti. E da superare per restare nella partita globale.
Non sarà facile. Da tempo l’Unione si è brexizzata sull’onda di rabbia, frustrazioni e disincanto dei suoi cittadini, che non sono solo inglesi. In questo senso Brexit, quella vera, appare lo specchio impietoso della cattiva coscienza europea, di un’Unione da tempo ai ferri corti con se stessa. I negoziati con Londra, sulla base degli accordi di febbraio, saranno comunque lunghi, difficili, in parte imprevedibili perché l’interdipendenza con l’Europa è molto stretta e perché quasi mai la realtà si conforma alla perfezione agli schemi giuridici che dovrebbero regolarla. Saranno complicati e poco inclini al compromesso, contrariamente a una lunga tradizione europea, perché questa volta bisognerà a tutti i costi evitare l’effetto imitazione.
E lo saranno ancora di più perché l’anno prossimo andranno alle urne Olanda, Francia e Germania, le prime due da anni logorate da incontenibili spinte nazional-euroscettiche, la terza con sindrome anti-immigrati e anti-euro diffusa. Senza contare la Spagna: domenica potrebbe decretare la vittoria di Podemos ed estrema sinistra, tutti anti-rigore.
Dunque un duro colpo da incassare e gestire con le mani legate almeno per un anno e mezzo. Anche per questo la partita che va a incominciare assomiglia a un salto nel buio.
Corriere della Sera
DA BRUXELLES A FRANCOFORTE
SCATTA IL PIANO DI EMERGENZA
di Ivo Caizzi
Bruxelles. L’Europa schiera le istituzioni comunitarie per affrontare le conseguenze della clamorosa vittoria di Brexit nel referendum sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea, che nelle proiezioni della rete tv Bbc è stata prevista a 52% contro 48% davanti al vantaggio di circa un milione di voti con 335 delle 382 aree scrutinate.
I presidenti del Consiglio dei governi, il polacco Donald Tusk (stabile) e il premier olandese Mark Rutte (di turno), insieme a quelli della Commissione europea, il lussemburghese Jean-Claude Juncker, e dell’Europarlamento, il tedesco Martin Schulz, sono stati delegati a fornire da Bruxelles la prima reazione istituzionale «a caldo».
La loro riunione è programmata subito dopo l’annuncio ufficiale dell’esito del voto su Brexit, atteso stamattina. Il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi resterà in contatto dalla sede a Francoforte, pronto a intervenire davanti a eccessive instabilità sui mercati finanziari con impatto sulla moneta unica e sui titoli di Stato della zona euro. L’immediato tracollo della sterlina sui mercati extraeuropei aperti nella notte fa temere manovre speculative di dimensioni imprevedibili.
Tra le capitali vengono invece discusse da giorni le possibili ricadute politiche, in vista del Consiglio dei capi di Stato e di governo di martedì e mercoledì prossimi. Questo summit Ue era in programma questa settimana. E’ stato spostato proprio per poter affrontare l’esito della consultazione nel Regno Unito. E per conoscere il risultato delle elezioni in Spagna di domenica prossima, dove una vittoria del movimento di estrema sinistra Podemos, che è molto critico sull’attuale gestione dell’Ue, può generare un devastante uno-due contro l’attuale gestione dell’apparato comunitario.
Una riunione straordinaria della Commissione europea è stata convocata per lunedì prossimo. Nel week end la cancelliera Angela Merkel, il presidente francese Francois Hollande, il premier Matteo Renzi e gli altri leader europei dovrebbero intensificare le consultazioni per favorire il raggiungimento al summit di una posizione comune su come procedere in Europa, che si avvia a fronteggiare un trauma a rischio di estensione in altri Paesi membri. Giovedì scorso il premier belga Charles Michel aveva già chiesto un ulteriore vertice dei capi di governo, indipendentemente dall’esito del referendum su Brexit, per affrontare l’evidente sfiducia verso l’Unione europea dimostrata da ampie fasce di cittadini europei. Michel ha evocato il crescente euroscetticismo, che potrebbe con solidarsi, dopo i voti nel Regno Unito e in Spagna, se non verranno attuate azioni di riavvicinamento ai cittadini. «La leadership europea deve farsi carico dell’inclusione sociale e battersi contro le disuguaglianze», ha suggerito il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. Nei Palazzi comunitari circolano indiscrezioni su possibili ricambi al vertice come segnale di rinnovamento. Il controverso Juncker, simbolo della «vecchia Europa» sotto accusa, si è affrettato a far smentire le voci su un suo dimissionamento.
Lavoce.info
REGNO DISUNITO
di Gianni De Fraja
Il voto pro Brexit ci consegna un Regno Unito molto diviso. È probabile che la Scozia torni a chiedere l’indipendenza. Anche le linee di reddito segnano una divisione: le aree ricche hanno scelto “remain”, quelle meno benestanti hanno optato per il “leave”. E si apre una questione generazionale.
Il giorno dopo
Difficile esprimere una reazione così vicino all’annuncio del risultato che vede l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, avvenuto verso le 8 italiane a Manchester. L’esito del voto, in realtà, era chiaro dalla sera del 23 giugno. Lo preannunciavano, verso l’1 italiana, i risultati ufficiali di due città del Nord-Est, Sunderland e Newcastle, che, pur votando entrambe secondo le previsioni, la prima per Brexit, la seconda per “remain”, lo hanno fatto con margini completamente al di là delle aspettative: Newcastle con il minimo scarto mentre a Sunderland a ogni voto per restare ne corrispondevano due pro-Brexit. Se lì va così, vuol dire che Brexit ha vinto. Entrambe le città sono tradizionalmente laburiste, quindi molti elettori che di solito votano fedelmente per il Labour hanno rifiutato di seguire le indicazioni unanimi della dirigenza del partito, e hanno votato Brexit. La tendenza è stata poi confermata a livello nazionale Quali conclusioni trarre dal voto? Sicuramente andranno fatte analisi più dettagliate e rigorose, ma queste le mie prime impressioni.
Voto diviso per nazioni
La Scozia è completamente diversa dall’Inghilterra e dal Galles, a loro volta diverse dall’Irlanda del Nord. In Scozia “remain” ha vinto in tutte le circoscrizioni, ottenendo complessivamente il 62 per cento dei voti. Per l’Irlanda del Nord, che ha votato in maggioranza “remain”, c’è una divisione geo-politica: nelle zone all’est, più protestanti-unioniste ha vinto Brexit, mentre vicino al confine con l’Eire, in aree più cattoliche e culturalmente vicine alla repubblica, gli elettori hanno scelto “remain”. Questa diversità porterà quasi sicuramente a un nuovo referendum per l’indipendenza in Scozia. Già se ne è accennato in fase di campagna elettorale, ma viste le cifre della differenza tra le due nazioni, sarà per Londra politicamente impossibile resistere a una nuova richiesta di voto.
Una questione di reddito
In Inghilterra e Galles, ed è un punto che non ho ancora sentito sottolineare, la mia impressione è che la divisione sia soprattutto lungo linee di reddito: aree ricche hanno scelto “remain”, invece quelle meno benestanti hanno optato per Brexit. Jeremy Corbyn, leader laburista, ha probabilmente ragione quando dice che molti elettori hanno voluto punire il governo per le loro difficoltà economiche e hanno semplicemente votato contro “la politica”. Alcune delle aree più ricche, dove alle elezioni politiche i Tory ottengono maggioranze schiaccianti, a nord e sud, a est e a ovest, a Londra e in zone davvero rurali, “remain” vince dove il reddito è alto: Tunbridge Wells, e Guilford, la “stockbroker belt”; la chic Kensington e Chelsea, che contiene Sloane Square; South Hams, nel profondo sud-ovest sulla Manica; Harrogate, nello Yorkshire, uno dei vertici del triangolo più ricco del paese, fino alle zone del Costwold, la zona dei ricchi villaggi pittoreschi da cartolina.
La divisione generazionale
Un’altra impressione, che dovrà però essere confermata da ulteriori sondaggi perché i dati elettorali disponibili oggi sono solo a livello di circoscrizione, è di una netta divisione generazionale: i giovani pro-Europa, i vecchi pro-Brexit. Questo ovviamente non depone bene per il futuro: non è chiaro se un giovane brillante e ambizioso vorrà restare permanentemente in Inghilterra, dove sembra prevalere una visione isolazionistica e nostalgica del mondo. Anche se politicamente inevitabili, le dimissioni di David Cameron, che passerà alla storia come uno dei peggiori premier di sempre, lasceranno la nazione con una spaventosa assenza di carisma a livello internazionale, guidata come sarà da figure quali Boris Johnson e Nigel Farage con all’opposizione Jeremy Corbyn: nessuno di loro può onestamente dire di rappresentare gli elementi più dinamici e innovativi della società e dell’economia inglese.
«Corsa a ostacoli nei prossimi quattro mesi per affrontare le emergenze. Misure per riqualificare le periferie, tagliare le tasse e ridurre la povertà». La Repubblica, 23 giugno 2016 (m.p.r.)
Roma. Prima mossa: una boccata d’ossigeno da oltre 3 miliardi ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni. Il decreto, che il governo aveva rinunciato a varare prima dei ballottaggi, approvato venerdì, arriva in Parlamento ad alimentare, con fair play, anche le affamate casse delle città ora guidate dalle sindache grilline. Così, tra aiuti agli enti locali e annunci di nuovi sgravi fiscali e interventi su periferie e povertà, il premier Matteo Renzi conta di superare la fase difficile, segnata da una ripresa fragile, tra le elezioni comunali e il referendum costituzionale di ottobre.
Il decreto contiene misure tecniche, calibrate sulla complessa contabilità che guida il rapporto tra Stato ed enti territoriali, ma è denaro sonante e spendibile. Si parte dalla cancellazione delle sanzioni per 500 milioni per le città metropolitane, tra cui Roma, Milano e Torino, si passa ai 450 milioni in tre anni per sostenere gli oltre 400 Comuni in dissesto finanziario, si arriva allo sblocco del turn over per l’assunzione di maestre degli asili nido gestiti dai Municipi.
La mano tesa dell’esecutivo si allunga anche ai governatori: le industrie farmaceutiche dovranno rimborsare alle Regioni 1,7 miliardi per compensare lo sforamento della spesa farmaceutica ospedaliera dell’ultimo triennio, soldi dovuti per legge ma fino ad oggi bloccati da un lungo contenzioso a colpi di Tar. Denari freschi arrivano alla Sicilia (che spunta 400 milioni strutturali di aumento di compartecipazione all’Irpef) e toccano la Valle d’Aosta (70 milioni per il recupero del gettito dell’accisa sui carburanti).
Le mosse successive, per il rilancio dell’economia e per dare una risposta al disagio sociale, sono all’esame dei tecnici: l’azione entrerà nel vivo dalla prossima settimana, superate le scadenze internazionali del «Brexit» di oggi e delle elezioni spagnole di domenica e il confronto interno della direzione Pd di domani. La corsa taglierà il traguardo, tra quattro mesi, con la nuova legge di Bilancio (entro il 20 ottobre alle Camere, secondo il testo approvato ieri) una volta superata probabilmente la scadenza del referendum costituzionale.
Le tre emergenze sul tavolo potrebbero essere riassunte con tre «p»: povertà, periferie e prelievo fiscale. La questione della povertà è tra le priorità, assai sentita anche all’interno del Pd che dovrà confrontarsi sulle prossime scelte: il 44 per cento delle persone in condizioni di disagio è senza il paracadute di sostegni pubblici e lo stesso Renzi, durante la riunione di «disgelo» con Cgil-Cisl- Uil di un paio di settimane fa, ha osservato che le pensioni minime, quelle da 500 euro al mese, sono «oggettivamente troppo basse». Torna dunque l’opzione di una estensione del bonus di 80 euro ai pensionati ma si punta anche ad una accelerazione sulla legge delega sulla povertà (1 miliardo per il 2017).
L’altro tema è quello delle periferie, dove le elezioni hanno suonato per il governo un campanello d’allarme. Qui la parola d’ordine è ristrutturazione degli alloggi popolari Erp: un piano è già stato finanziato con 470 milioni per 25 mila alloggi, l’obiettivo è quello di arrivare a 70 mila alloggi. Si lavora anche all’housing sociale: progetti di recupero d’intesa con le fondazioni bancarie e con l’Ance, con idee che vanno dal «rammendo » delle periferie a sconti fiscali e prestiti per gli impianti fotovoltaici dei condomini e per le centraline per le auto elettriche.
Infine il tema del prelievo fiscale: in cantiere c’è l’intenzione di Renzi di anticipare il taglio dell’Irpef al 2017, con la limatura delle aliquote intermedie del 27 e del 38 per cento o, addirittura, incidendo sulla prima del 23 per cento. Il costo è dai 3 ai 9 miliardi, secondo le modalità del piano, e il discorso torna sulle risorse: Padoan, non è contrario e anche martedì alla Guardia di Finanza ha parlato di “alleggerimento del carico fiscale”, ma in “coerenza con gli obiettivi di stabilizzare la finanza pubblica”.
Nel frattempo, in vista di una legge di Stabilità 2017 che parte appesantita da una decina di miliardi per la sterilizzazione dell’Iva e la riduzione del deficit, si conta anche su misure una tantum per trovare risorse: dalla riedizione della voluntary disclosure alla proposta lanciata ieri dal viceministro dell’Economia Enrico Zanetti di rottamazione delle cartelle di Equitalia che potrebbe fornire un gettito valutato in 1-2 miliardi. «Si pagherebbero tutte le imposte e gli interessi legali, ma a fronte di un pagamento sull’unghia, lo sconto su sanzioni e aggi potrebbe andare da un terzo alla metà del dovuto», ha dichiarato a Repubblica Zanetti.

![]()
Domenica scorsa, cinque grandi Comuni italiani hanno rinnovato la loro amministrazione e tre di essi hanno eletto sindaci nuovi. Nella Capitale della Repubblica, Roma, e nella prima Capitale dell’Italia unitaria, Torino, i cittadini hanno eletto per la prima volta sindaci espressi non da partiti o raggruppamenti tradizionali, ma dal Movimento 5 Stelle. In queste città, così come a Napoli, le maggioranze locali non sono allineate col governo centrale, da cui dipendono tuttavia flussi di risorse importanti per il normale funzionamento delle città. Quali rischi corrono i nuovi sindaci? È possibile in linea teorica che il governo nazionale riduca, nei provvedimenti di finanza pubblica, i trasferimenti alle amministrazioni locali? E può farlo in maniera asimmetrica, privilegiando i governi locali amici e danneggiando quelli avversari? Può chiudere discrezionalmente alcuni rubinetti?
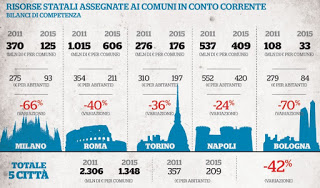 La risposta non è netta e richiede di distinguere in base alle tipologie di trasferimenti dal governo: quelli ordinari, cosiddetti di parte corrente, che sono finalizzati a contribuire alle spese di funzionamento delle amministrazioni, appaiono difficilmente modulabili su basi discrezionali. Da questo punto di vista i nuovi sindaci dovrebbero stare relativamente tranquilli. Anche quando i governi sono intervenuti in corso d’opera nell’ultimo quinquennio per tagliare risorse già assegnate ai Comuni, essi hanno dovuto concordare con la Conferenza Stato-Città i criteri di ripartizione della riduzione.
La risposta non è netta e richiede di distinguere in base alle tipologie di trasferimenti dal governo: quelli ordinari, cosiddetti di parte corrente, che sono finalizzati a contribuire alle spese di funzionamento delle amministrazioni, appaiono difficilmente modulabili su basi discrezionali. Da questo punto di vista i nuovi sindaci dovrebbero stare relativamente tranquilli. Anche quando i governi sono intervenuti in corso d’opera nell’ultimo quinquennio per tagliare risorse già assegnate ai Comuni, essi hanno dovuto concordare con la Conferenza Stato-Città i criteri di ripartizione della riduzione.
Vi è un solo caso in cui non lo hanno fatto, decidendo a monte un criterio di ripartizione, comunque oggettivo, e la Consulta lo ha dichiarato incostituzionale poche settimane fa. Le autonomie locali sono tutelate in particolare da due articoli della Costituzione, che vanno letti congiuntamente: l’art. 118, secondo comma, per il quale “i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze” e l’art. 119 il quale stabilisce che “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. (…) hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri (…). Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”. È inoltre previsto un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale. L’art. 119 stabilisce infine che “le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”.
Tale enunciato sembra collocare le autonomie locali in una botte di ferro: il governo non può sottrarre o smettere di conferire risorse finanziarie indispensabili per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Ma siamo sicuri che queste previsioni siano sempre state rispettate?
La risposta è negativa e si ritrova proprio nei tagli attuati dai governi a danno delle autonomie locali durante il processo di risanamento dei conti pubblici che ha fatto seguito alla grande recessione dell’anno 2009. A partire dal 2011 la crisi del nostro debito sovrano ha spinto i governi ad accelerare il riequilibrio della finanza pubblica, imponendo alle autonomie locali rigidi vincoli, i quali avrebbero dovuto contribuire al pareggio di bilancio dell’Italia già dal 2013.
Il problema è che gli enti locali hanno dovuto dare comunque il loro contributo ma il pareggio di bilancio non c’è stato, né poteva esserci, tanto che ancora oggi siamo su un disavanzo pubblico pari al 2,6% del Pil. Qual è stato il contributo delle amministrazioni locali (Comuni, Province e Regioni, sanità compresa) al risanamento effettivo? Un semplice calcolo: dal suo livello record del 2009 al 2015 il disavanzo pubblico si è ridotto di 40,6 miliardi. Quanti fondi statali hanno perso nel periodo tutte le amministrazioni locali? Esattamente 30,6 miliardi, dato che i trasferimenti statali di parte corrente sono diminuiti di 23,2 miliardi e quelli in conto capitale di 7,4 miliardi. Inoltre le amministrazioni locali hanno migliorato il loro saldo economico di 7,9 miliardi, portandosi complessivamente in attivo. Il loro contributo totale al miglioramento del disavanzo pubblico è pertanto di 38,5 miliardi, corrispondenti al 95% dei 40,6 miliardi di miglioramento complessivo dell’Italia. Ovviamente le funzioni svolte non sono diminuite, la Costituzione non è stata rispettata, dato che le amministrazioni locali si son fatte carico del 95% del risanamento totale del Paese, né le diverse associazioni che le raggruppano sono andate oltre deboli e poco efficaci proteste verbali.
Quanti fondi statali hanno perso nel tempo le 5 grandi città che domenica hanno votato? Confrontando coppie di anni conviene limitarci ai trasferimenti di parte corrente, data la molto maggiore variabilità di quelli in conto capitale: Milano ha perso il 66% dei trasferimenti statali tra il 2011, anno in cui si è accentuata la pressione sui comuni, e il 2015; Bologna il 70%; Torino il 36%; Roma il 40%; Napoli il 24%. Le 5 città messe assieme hanno perso nel 2015 quasi un miliardo rispetto al 2011, dato che i fondi statali correnti complessivi sono diminuiti da 2,3 a 1,35 miliardi: Roma ha perso più di 400 milioni, Milano quasi 250, Torino 100, Napoli quasi 130, Bologna quasi 80. Difficilmente, partendo da queste cifre, i nuovi sindaci possono temere ulteriori tagli, ma avranno molta difficoltà a governare proprio a causa della penuria di risorse già in essere. Ma forse è proprio per questo che sono stati eletti e i loro predecessori rimossi.
 «Profughi. Di fronte ad un fatto nuovo: la richiesta esplicita di accesso in Europa non più da canali clandestini».
«Profughi. Di fronte ad un fatto nuovo: la richiesta esplicita di accesso in Europa non più da canali clandestini».
Il manifesto, 23 giugno 2016 (m.p.r.)
Lo sgombero del campo di Idomeni in Grecia, la condizione dei rifugiati, il destino del popolo siriano e la balbuzie degli stati europei. Iniziare una rivoluzione in Siria per venire a perderne un’altra in Europa: questo sembra il destino di chi è rimasto per mesi bloccato a Idomeni. La protesta dei migranti che ha attratto l’attenzione del mondo su uno sperduto villaggio greco di collina, è finita.
Ma davanti a quel reticolato tra Grecia e Macedonia ha trovato continuità, come il secondo atto di una tragedia epica, il più potente gesto sovversivo, la più grande sconfitta collettiva e la più nobile affermazione di umanità del nostro secolo: il tentativo del popolo siriano di cambiare il proprio destino.
Gli undicimila uomini e donne che da Idomeni hanno atteso pazienti il corso avverso della storia, mettono la coscienza degli europei di fronte a un fatto nuovo: la richiesta esplicita di accesso in Europa, la fine del ricorso ai canali clandestini, il riconoscimento dell’esistenza di una condizione di fatto.
Da Idomeni non sono arrivate richieste di aiuto materiale o di accoglienza, né di legittimazione delle proprie intenzioni attraverso la formalità del diritto. Chi è rimasto a Idomeni ha lanciato un appello appendendosi alla forza di un dovere storico, a una causa umana, a una continuità con la vita per come essa più naturalmente si manifesta: il cammino delle generazioni verso una condizione migliore.
L’Europa, attendista e balbuziente, ha temporeggiato senza convinzioni, perché l’essere umano straccione e tenace che per settimane è rimasto seduto sulle traversine di una dimenticata stazione di frontiera, con le unghie sporche di terra, la voce stentorea e i bambini che gli giocano intorno, l’ha trascinata fatalmente su un piano dialettico, in cui essa non sa muoversi: per questo il progressivo irrigidimento, la paventata fine di Schengen, il ripristino dei confini, le guerre diplomatiche, le polizie schierate e, infine, lo sgombero.
Chi entra in Europa deve continuare a farlo clandestinamente, questo vuole dirci Idomeni. I trafficanti, figli illegittimi della stessa grande madre dei migranti, hanno iniziato da tempo a fantasticare su nuove rotte: Albania e Grecia, Montenegro e Serbia. Fiumi, giungle, pestaggi, nottate al chiaro di luna, eroiche traversate, corpi abbandonati alla corrente e approdi insperati saranno la nuova narrativa dell’Europa del domani, dei nostri vicini di casa.
Ma intanto Idomeni, prologo di una nuova fuga di massa, ha polarizzato sui suoi binari il più recondito e vitale spunto dell’uomo quando sottoposto a immani difficoltà: la presa di coscienza. Quanto di più temono le istituzioni europee sta avvenendo a causa della loro stessa rigidità: se il più autentico messaggio politico, la vera richiesta di cambiamento, l’unica visione di un futuro diverso dell’Europa arriva dal di fuori dei suoi confini, l’Europa stessa perde legittimità interna, e alza muri per proteggere le sue membra.
L’accampamento di Idomeni è ormai un ricordo, la massa umana che impuzzolentiva un verde tratto di pianura è stata spazzata via, come nell’immaginario collettivo è stata spazzata via la rivoluzione siriana, archiviata a guerra di interessi oscuri, cieca fame fratricida, insulto al patrimonio mondiale.
Ma cosa rende tale una rivoluzione? L’abbattimento del potere formale - un dittatore, un regime, una rete metallica - o la generazione di coscienza nuova che permea il mondo, gli umori e le idee dei figli dei figli?
 «Troppe similitudini con l’oggi. I colpevoli del dissesto del Paese, la Casta in poche parole, che spinge lucidamente i popoli gli uni contro gli altri per non pagare il dazio del suo fallimento, trasformando una lotta politica e sociale in una lotta etnica in nome del Dio Nazione. In poche parole, fascismo».
«Troppe similitudini con l’oggi. I colpevoli del dissesto del Paese, la Casta in poche parole, che spinge lucidamente i popoli gli uni contro gli altri per non pagare il dazio del suo fallimento, trasformando una lotta politica e sociale in una lotta etnica in nome del Dio Nazione. In poche parole, fascismo».
La Repubblica, 23 giugno 2016 (m.p.r.)
Ma che cos’è questo rumore di chiavistelli che percorre l’Europa, questo rugginoso agitarsi di lucchetti, serrature, reticolati e sbarre di frontiera che dalla Gran Bretagna alla Grecia raggiunge la Catalogna e i confini della Russia, così simile al grattare della lima dei galeotti nel carcere di Montecristo? E che cos’è questa banalizzazione del linguaggio che ci invade, questo diffondersi di alternative violente nascoste dietro innocue sigle da computer, “In/Out”, “Leave/“Remain”? Dove nascono l’aggressività omicida e gli osceni bisillabi che annichiliscono la complessità di eventi, come “Brexit” o “Grexit”? E soprattutto, come chiamare questa illusione che si impossessa delle nazioni, secondo la quale “Da soli è meglio”?
Non so perché esitiamo tanto. Il termine ce l’abbiamo a disposizione da un quarto di secolo, o forse da molto di più. Chiamasi “balcanizzazione”. So che non piace assimilarsi ai Balcani. Genera sollievo pensare che quello sia un focolaio di tribalismo a sé stante, dal quale l’Europa “civile” è immune. Ricordo distintamente che allora, prima che la Jugoslavia si disintegrasse, i signori economisti erano convinti che uno scoppio di follia collettiva autodistruttiva sarebbe stato impossibile. Nell’89 scrissi un libro in cui dicevo: attenti, dopo la caduta del Muro, salta in aria la Federazione di Tito. Romano Prodi lo lesse e mi scrisse che ero troppo pessimista, perché i popoli lo capiscono da soli che “separati si è più deboli”.
Non andò così. In uno stato di demenza generalizzata, la Jugoslavia - il paese della cuccagna invidiato da tutte le altre nazioni dell’ex blocco comunista - si buttò nel baratro. Ma anche allora, di fronte all’evidenza dei fatti, non si volle capire. E io avevo un bel spiegare ai miei lettori che quello che succedeva nei Balcani non era una malattia balcanica, ma europea. Il riattivarsi di una faglia, il sintomo d’inizio di un sisma di più vasta portata, così come l’attentato di Sarajevo - lungi dal provocare la Grande Guerra - ne aveva segnalato l’imminenza. Nessuno mi credeva.
E così vennero i populismi, venne la Lega, scoppiò il caso Haider (che rispetto agli agitatori di oggi pare ahimè un’educanda), esplose l’islamismo assassino. E furono le tensioni tra fiamminghi e francofoni in Belgio, la chiusura a riccio dell’Olanda, l’ondata irrazionale di indipendentismo catalano, il separatismo scozzese. Venne a galla il rancore antieuropeo dell’Ungheria e della Polonia. Esplose la rabbia lepenista in Francia e l’Inghilterra perse il suo tradizionale “à plomb”. Bruxelles era il perfetto capro espiatorio di qualsiasi malessere.
Rileggere i miei appunti jugoslavi, oggi, fa venire i brividi. Riporto in sintesi solo alcuni stralci di quello che notai nella fase di incubazione del conflitto. Rabbia giustizialista di periferie dimenticate che trovano un megafono interessato nei responsabili stessi della loro emarginazione. Incapacità dei “liberal” di ascoltare la pancia inquieta del Paese. Ritorno di mitologie tribali da strapazzo per bocca di intellettuali ignoranti. Incapacità del potere federale di proporre una visione “alta” della coabitazione fra popoli. Intossicazione mediatica, imbarbarimento del linguaggio, spazio scandaloso offerto agli urlatori rispetto ai pensatori, per motivi di audience.
Troppe similitudini con l’oggi. In particolare questa: i colpevoli del dissesto del Paese, la Casta in poche parole, che spinge lucidamente i popoli gli uni contro gli altri per non pagare il dazio del suo fallimento, trasformando una lotta politica e sociale in una lotta etnica in nome del Dio Nazione. In poche parole, fascismo. Una lebbra che prende a diffondersi non a partire dai centri, evoluti e plurali, ma dai villaggi lontani dal potere. Una rivincita dei primitivi incolti, portatori di un’idea di purezza della razza, contro gli evoluti figli di un mondo cosmopolita. Campagna contro metropoli. Se manteniamo questa visione “sismica” del contagio - Dio solo sa quanto bisogno abbiamo di visionari dopo il fallimento degli analisti - ci capita magari di vedere un pezzo di possibile futuro.
Possiamo ipotizzare un ramificarsi di crepe dopo il botto del voto inglese, un riattivarsi per contagio delle linee di faglia dormienti. L’Irlanda che si stacca, la Polonia e i Paesi baltici che danno vita a incidenti di frontiera con la Russia, la piccola Danimarca che va per conto suo, i populisti francesi che istituiscono ronde armate contro gli immigrati, Salvini e i Cinquestelle che indicono un referendum come quello inglese, e magari l’Austria che vuole riprendersi il Sudtirolo. E poi Catalogna, Grecia, Scozia, Ungheria, coinvolte in un generale cortocircuito di protezionismi, autarchie e ritorsioni.
Ecco, potrebbe franare così il nostro sogno europeo, nel silenzio attonito del suo apparato burocratico e monetario. In un perfetto copione balcanico. Speriamo non accada. Ma l’amico Andrea Mammone, ricercatore italiano a Londra, è scettico che una vittoria del “ Leave” in Gran Bretagna possa dare ai politici una salutare frustata. «Spesso è gente che crede basti un clic per sapere le cose - mi dice - e quindi temo siano incapaci di controllare la situazione». Concordo in pieno. La malattia è europea. Essa discende da una politica che non batte più i territori. Si estrinseca come vendetta epocale della geografia e della storia - espulse dal nostro immaginario nel tempo di Internet - contro l’illusione che il mondo sia uno spazio aperto, liscio e senza cicatrici.
 «Legge elettorale. Anche nella maggioranza renziana c'è adesso la preoccupazione che possa essere stato costruito un sistema perfetto, tra sistema di voto e riforma costituzionale, ma per gli avversari. E il premier non può neanche sperare nella Consulta».
«Legge elettorale. Anche nella maggioranza renziana c'è adesso la preoccupazione che possa essere stato costruito un sistema perfetto, tra sistema di voto e riforma costituzionale, ma per gli avversari. E il premier non può neanche sperare nella Consulta».
Il manifesto, 22 giugno 2016
Sull’Italicum «c’è una riflessione da fare». All’indomani della vittoria del Movimento 5 Stelle nei ballottaggi, la scoperta di Piero Fassino – personalmente colpito – è la stessa di molti renziani che fin qui avevano condiviso senza tentennamenti le riforme governative. L’idea che Matteo Renzi abbia messo in piedi un sistema perfetto – sistema elettorale ultra maggioritario e controllo del governo sul parlamento – per consegnarlo però ad altri, adesso circola e preoccupa. Se una sola camera politica, con una maggioranza blindata, scelta da una minoranza di elettori e nelle mani del capo del governo spaventava già gli avversari dell’Italicum e della riforma costituzionale, la prospettiva di 340 e più deputati contrattualmente vincolati con la Casaleggio associati non tranquillizza. La vecchia richiesta della minoranza Pd e del resto degli alleati centristi, alla quale Renzi continua a rispondere di no, è quella di correre ai ripari riportando il premio dell’Italicum alle coalizioni. Perché i grillini, com’è noto, non si coalizzano.
Eppure resta improbabile che il presidente del Consiglio possa lanciarsi anzitempo in una simile conversione a U: non solo la nuova legge elettorale non è stata mai utilizzata, ma ancora per una settimana non è neanche pienamente in vigore. Il leghista Calderoli ieri ha ipotizzato che Renzi «non potendo contraddire le posizioni già aggiunte e non potendo dar ragione alla propria opposizione interna o agli alleati, lascerà fare il lavoro sporco alla Corte costituzionale». Il riferimento è al fatto che la Consulta il prossimo 4 ottobre dovrà pronunciarsi sul primo (e unico, fino a qui) ricorso contro la legge elettorale arrivato da un tribunale civile (quello di Messina). I giudici sospettano l’incostituzionalità della nuova legge elettorale in sei punti, nessuno dei quali però ha direttamente a che vedere con la richiesta di modifica avanzata dalla minoranza Pd. Non è in discussione il premio alla lista, ma l’enormità del premio di maggioranza, che il meccanismo del ballottaggio finisce col rendere astratto da qualsiasi soglia minima di voti.
La Corte costituzionale dovrà giudicare anche sui capolista bloccati, sulla convivenza di premio di maggioranza e sbarramento, sulla ripartizione nazionale dei seggi e sul fatto che l’Italicum si applichi solo alla camera, quando il senato elettivo non è ancora stato abolito. Ci sono dentro i temi dei due referendum abrogativi della legge elettorale per i quali si stanno raccogliendo le firme, cioè quelli che producono la distorsione tra il voto popolare e la sua rappresentanza nelle assemblee (è successo anche nei comuni assegnati con i ballottaggi), ma non c’è la questione del premio alla lista che spaventa e muove la minoranza Pd. In ogni caso, se si chiede a chi ha promosso la battaglia contro l’Italicum quante speranze ci sono che la Consulta possa accogliere il ricorso di Messina, la risposta è «poche». Sei giudici costituzionali su quindici sono diversi da quelli che nel 2014 condannarono il Porcellum.
Per cambiare l’Italicum resterebbe aperta, in teoria, solo la via parlamentare. Complicata dal fatto che i 5 Stelle, che si trovano ora una legge elettorale su misura per loro, farebbero le barricate. «Non siamo disponibili a parlare di questo», diceva ieri il deputato grillino Toninelli. Ma in passato i 5 stelle sono stati anche più espliciti, arrivando a proporre un ordine del giorno che voleva impegnare il governo a non toccare una virgola dell’Italicum. Quanto alla campagna di raccolta firme per i referendum contro la legge, i grillini hanno ufficialmente aderito. Ma assai in ritardo. Solo nelle ultime settimane i loro banchetti si sono fatti notare nelle città, e la campagna si sta ormai per concludere.

«Left, 22 giugno 2016
La campagna elettorale per le amministrative ha per alcune settimane tenuto i riflettori spenti sul referendum costituzionale; o meglio abbassati. In alcuni casi, come in quello di Torino e di Bologna, i rappresentanti del NO (Zagrebelski e la sottoscritta) hanno rilasciato dichiarazioni per sottolineare come il voto per il sindaco non avrebbe dovuto essere dato secondo le preferenze espresse dai candidati (nei due casi in questione, Fassino e Merola) per il SI. Oggi, all’indomani delle consultazioni, delle vittorie e delle sconfitte, il referendum torna ad essere al centro. Ma qualche cosa è cambiato con queste elezioni: la sconfitta netta del Pd, la sua perdita del voto popolare, gettano sul referendum una diversa luce. Per alcune ragioni che meritano di essere sottolineate.
La prima ragione sta nell’effetto sorprendente dell’impatto inverso del dominio mediatico televisivo e giornalistico del Pd di Renzi: l’esposizione quotidiana del Presidente del consiglio e l’attacco nei confronti dei candidati del M5S non sembra abbia portato i risultati sperati. La sovraesposizione mediatica appare anzi una condizione ingombrante – gli italiani hanno dimostrato di comprendere l’inequità di questo potere e l’insopportabilità del disequilibrio di influenza. Questa è un’avvisaglia di quanto potrà succedere con la campagna referendaria.
La seconda ragione sta nel declino di gradimento di Renzi e del suo partito da parte di molti elettori – e anche l’astensione è un segno di questo allontanamento. Il Pd a guida Renzi non convince nemmeno coloro che più sono vicini a questo partito. Perde voti tra i ceti popolari e genera astensione, un fenomeno questo ultimo che già si era manifestato nelle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna di due anni fa. L’aver trasformato il referendum costituzionale in un plebiscito su Renzi non sembra fare intravedere scenari soddisfacenti per il Sì proprio perchè il leader piace poco.
La terza ragione sta nell’esplicita dichiarazione del leader di M5S, Di Maio, di destinare d’ora in avanti l’impegno del movimento contro la proposta Renzi-Boschi. Se il M5S si dedicherà a questa campagna ci sono buone ragioni per sentirsi più ottimisti – non per voler attribuire poteri taumatirgici a questo movimento, ma perchè i cittadini che si stanno impegnando ogni giorno per la Costituzione saranno meno soli. Abbiamo spesso parlato di cittadinanza referendaria, di solitudine dei cittadini nel caso di questo referendum – che nessun partito ha fino a questo momento guidato o sostenuto con determinazione. I proclami, i documenti, i banchetti per raccogliere firme per il NO e per chiedere il referendum sull’Italicum sono frutto del lavoro di cittadini impegnati, non di politici legati a partiti. Sembra che chi sta nelle istituzioni e il popolo siano due mondi che operano su due obiettivi: i primi per garantirsi un potere decisionale che con la Renzi-Boschi sarebbe superlativo, e il secondo per respingere quel tentativo e contenere il potere di chi ha potere. Fino a questo momento il SI e il NO hanno corrisposto rispettivament al “paese legale” e al “paese reale” per usare un dualismo che è vecchio quanta l’unità del nostro paese. Ora, benchè il M5S non sia (ancora) un movimento dell’establishment e anzi cresca nei consensi elettorali proprio per la sua posizione contro l’establishment, non è tuttavia irrilevante la dichiarazione di Di Maio. I cittadini che si impegnano per il NO possono avere un aiuto importante.
Queste tre ragioni che le recenti consultazioni hanno messo sul tappeto gettano nuova luce sulla campagna referendaria. Comincia una nuova fase.
 «I governi di centro-sinistra dopo il voto si sono ridotti alla metà: 45, mentre prima erano 90. Il centro- destra ha mantenuto e anzi allargato un poco il numero delle città amministrate. Mentre il M5S è arrivato al ballottaggio in 20 Comuni e li ha conquistati praticamente tutti».
«I governi di centro-sinistra dopo il voto si sono ridotti alla metà: 45, mentre prima erano 90. Il centro- destra ha mantenuto e anzi allargato un poco il numero delle città amministrate. Mentre il M5S è arrivato al ballottaggio in 20 Comuni e li ha conquistati praticamente tutti».
La Repubblica, 21 giugno 2016 (m.p.r.)
Queste elezioni amministrative segnano, indubbiamente, una svolta. Annunciata da qualche tempo, ma oggi evidente. E irreversibile. La riassumerei in questo modo: in Italia il voto non ha più una geografia. In altri termini: ha perduto le sue radici. E, quindi, i suoi legami con la storia, la società, le identità che gli garantivano senso e continuità. D’altronde, fino a pochi anni fa, la geografia elettorale in Italia riproduceva in larga misura il profilo emerso nel dopoguerra. Dove gli orientamenti di voto, in alcune zone, si riproponevano sempre uguali, nel corso del tempo. Nonostante il mutamento del clima politico e degli stessi partiti. Alcuni dei quali, scomparsi.
In fondo, nel 1994, Silvio Berlusconi aveva “fondato” Forza Italia sull’anti-comunismo. Recuperando le fratture sociali e territoriali del passato. Questa geografia era stata ridisegnata, profondamente, dall’irruzione del M5s, alle elezioni del 2013. Matteo Renzi ne aveva seguito le tracce, alle elezioni europee del 2014. Il suo Pd aveva sfondato il muro del 40%, affermandosi, a sua volta, in tutte - o quasi - le aree del Paese.
Così le Italie politiche si erano confuse. Zone rosse, bianche, verdi, azzurre: tutte scolorite. Ebbene, queste elezioni amplificano queste tendenze. Infatti, se osserviamo il risultato dei 143 Comuni maggiori, risulta chiara l’impossibilità di individuare una chiave di lettura. Se non l’inutilità delle chiavi di lettura che utilizziamo per analizzare e interpretare il voto. Oltre un terzo delle amministrazioni - cioè, circa 50 - ha, infatti, cambiato colore.
Nello specifico, i governi di centro-sinistra dopo il voto si sono ridotti alla metà: 45, mentre prima erano 90. Il centro- destra ha mantenuto e anzi allargato un poco il numero delle città amministrate. Mentre il M5s è arrivato al ballottaggio in 20 Comuni e li ha conquistati praticamente tutti. Cioè, 19. Tra questi, Roma e Torino sono quelli che fanno più notizia. Comprensibilmente. Però il M5s si è affermato in tutte le aree. In particolare nel Mezzogiorno. A Roma e a Torino, peraltro, le sue candidate hanno intercettato il voto dei giovani, dei professionisti, dei tecnici. Ma anche dei disoccupati. In altri termini: la domanda di futuro e la delusione del presente.
Colpisce, soprattutto, il cambiamento che ha coinvolto le regioni dell’Italia centrale. Tradizionalmente di sinistra. Tradizionalmente le più stabili. Dove, però, oltre metà dei Comuni di centrosinistra hanno cambiato colore. Ciò conferma la non-chiave di lettura suggerita in precedenza. Sottolineata dal risultato del non-partito per definizione. Il M5s. Che fra il primo e il secondo turno ha allargato i suoi consensi da 650 mila a più di 1 milione e 100 mila voti. Cioè, di oltre il 70%. Un segno della sua capacità di intercettare elettori “diversi”. Che provengono da partiti e da aree “diverse”. Ma soprattutto da “destra”, quando si tratta di opporsi ai governi di centrosinistra. Com’è avvenuto, in modo appariscente, a Roma e Torino, dove, nei ballottaggi, le candidate del M5s hanno allargato in misura molto ampia i loro consensi elettorali.
Per questo penso che il significato di questo voto vada oltre i contesti locali. Riflette una tendenza consolidata, che Matteo Renzi ha contribuito a rafforzare. Non tanto perché abbia personalizzato il voto amministrativo, anche se in qualche misura ciò è avvenuto. Ma perché ha accentuato il distacco fra politica e territorio. Enfatizzando la personalizzazione e la mediatizzazione. Il Pd, trasformato in PdR. E la campagna elettorale condizionata dal dibattito sul referendum “costituzionale”. Pardon, “personale”. Su Renzi medesimo. Così i sindaci e le città hanno perduto significato, importanza. E le elezioni amministrative sono divenute un’arena dove si giocano altre partite, con altri protagonisti. Dove il M5s, più di altri soggetti politici, è in grado di affermarsi.
Nel passato, invece, il suo rendimento elettorale risultava molto superiore nelle scadenze nazionali, quando poteva riprodurre il disagio e la protesta. Mentre nelle elezioni amministrative non riusciva a ottenere risultati analoghi, in quanto non disponeva di figure credibili, come soggetti di governo. In ambito locale. Oggi, evidentemente, non è più così. Perché il M5s è presente, ormai da anni, sul territorio. E ha raccolto, intorno a sé, militanti e attivisti. Tuttavia, più degli altri attori politici, è in grado di canalizzare la “domanda di cambiamento”. Meglio ancora: i sentimenti e i risentimenti “in tempi di cambiamento”. Come quelli che stiamo attraversando.
Così questo voto rappresenta, al tempo stesso, una risposta e un segnale. Una risposta al disorientamento che ha investito molte zone del Paese. E, soprattutto, le aree urbane e metropolitane. In particolare: le periferie. Dove la “politica” ha perduto senso e radici. Ma anche un segnale, a modo suo, fragoroso, quanto il silenzio degli astenuti. Rammenta, infatti, che la “messa è finita”. Le fedeltà si sono perdute. Liquefatte. Come i partiti. Non per nulla ne ha beneficiato un non-partito liquido come il M5s. Così, ogni scadenza elettorale diviene - e diverrà - un passaggio senza destinazioni precise. Senza mappe e senza bussole che permettano ai cittadini e agli elettori di orientarsi. E agli analisti, come me, di interpretarne - e prevederne - i percorsi. Le ragioni. Le destinazioni.
 «Quattro donne cresciute nel contrasto alla classe politica dominante, di governo o di opposizione, guidano oggi le prime città dei due Paesi europei».
«Quattro donne cresciute nel contrasto alla classe politica dominante, di governo o di opposizione, guidano oggi le prime città dei due Paesi europei».
La Repubblica, 21 giugno 2016 (m.p.r.)
Come Madrid e Barcellona in Spagna, così Roma e Torino in Italia. Là due donne sindaco elette con Podemos, qui coi Cinquestelle. In entrambi i casi: la capitale, la città simbolo del lavoro. Quattro donne cresciute nel contrasto alla classe politica dominante, di governo o di opposizione, guidano oggi le prime città dei due Paesi europei. Le analisi di quel che sta cambiando (che è già cambiato da tempo) lasciamole ad altri: non sempre e non tutti hanno avuto il dono della preveggenza. Restiamo piuttosto ai fatti, riprendiamo da dove eravamo rimasti due settimane fa. «Vorrei parlare di Virginia Raggi e Chiara Appendino », dicevo. «Di cosa stiamo parlando? », ha replicato su questo giornale qualcuno, molto vicino all’ex sindaco di Torino. Risposta: dei nuovi sindaci. Ora che hanno vinto osserviamole muoversi nei primi passi del loro primo giorno. A volte una parola, un dettaglio possono illuminare il quadro.
Sono due giovani donne, madri, in politica da più di cinque anni. Una sorpresa solo per chi non le aveva mai viste. Entrambe definite “prime della classe”, da chi le conosce come da chi le denigra. Appendino ha persino risposto: «Non sono secchiona, ho sempre passato i compiti a chi era in difficoltà». Vediamo le immagini di ieri.
Il risultato, la reazione.
Virginia Raggi, 37 anni, avvocato, un figlio, ha preso 770mila voti, più del doppio del candidato Pd Roberto Giachetti. 67,15 per cento. I dirigenti locali e nazionali del Pd hanno commentato che le destre hanno votato Cinquestelle. Raggi ha risposto che le sinistre non hanno votato Pd, circostanza per quel partito caso mai più preoccupante. Che la metà dei cittadini non è andata a votare, dato più eloquente ancora. Quelle che nella notte sono state indicate come sue lacrime sono in realtà le immagini di una lieve danza di esultanza, al telefono, come si vede bene nel video. Raggi ha raggiunto in un hotel romano Grillo e Davide Casaleggio. Grillo è comparso alla finestra con un appendiabiti, o appendino, attaccato al collo. Raggi è uscita per strada, fra i militanti in festa sotto gli ombrelli, e ha detto poche parole: «Lo sappiamo come è Roma, ma più è difficile più sarà bello. Abbiamo un programma pazzesco scritto insieme ai cittadini. Portiamo tutti i romani a lavorare per Roma, anche se siamo disabituati». Poi ha scherzato sui tormentoni della campagna elettorale. «Allora: sulle Olimpiadi…». I militanti hanno applaudito e fatto buu, indicando il disinteresse per il tema. Infine, con riferimento all’imitazione che ne fa Fiorello, ha detto: «Poi vi dico anche una poesia e gli affluenti del Po». Dopo fino alle 4 a festeggiare.
Chiara Appendino, 31 anni, economista, un figlio di pochi mesi (ha iniziato in gravidanza la campagna elettorale) ha avuto il 54,56 % dei voti, quasi dieci punti in più di Piero Fassino. Il quale - da sindaco, lei consigliera comunale – la sfidò a fare di meglio una volta al suo posto. Lo stesso Fassino alla vigilia del primo turno aveva attribuito ai Cinquestelle in un paio di occasioni pubbliche, per esempio al Salone del Libro, una scarsa presa del Movimento in città. Nel commentare il risultato Appendino ha dedicato al suo avversario una sola frase: «Non molto incisivo nella capacità di ascolto». Poi, più in generale: «La città si è sentita sola, in questi anni. Specialmente le periferie».
Il programma.
Qualche accenno al programma fin dal primo giorno. Appendino, no Tav, è stata accolta dal giubilo degli abitanti della Val di Susa. Contraria al traforo per motivi non solo ambientali ma economici («I costi sono superiori ai benefici, meglio molte piccole opere per la comunità») ieri ha detto che «un sindaco non può bloccare i lavori. Porterò al tavolo le ragioni del mio no e in base alla discussione valuterò se uscirne». Ha subito chiesto le dimissioni di Francesco Profumo dalla presidenza della Compagnia di San Paolo, il cuore economico finanziario della città, accennando al recente aumento di 400 mila euro stanziato nei giorni scorsi per aumenti agli stipendi dei dirigenti. Ha anche messo in dubbio la nomina di Paolo Peverano all’Iren, nome da poco indicato da Fassino. Nel mio mandato, ha detto, ci sarà un semestre bianco per il sindaco: non potrà fare nomine negli ultimi sei mesi di mandato. Ha annunciato anche il reddito di cittadinanza e la chiusura dei centri Cie con una politica di reinserimento scolastico per i bambini e lavorativo per gli adulti immigrati.
Virginia Raggi si è rivolta ieri agli elettori con un lungo post su Facebook nel quale non ha fatto cenno a funivie, olimpiadi e altri caposaldi della discussione televisiva delle scorse settimane. Ha detto prima di tutto: «Finalmente una donna, in un tempo in cui le pari opportunità sono una chimera», mettendo a tacere tutti coloro che giudicavano sessista sottolineare il genere del candidato. Ha poi parlato di anni di malgoverno e di Mafia capitale. «Cambia tutto, ora tocca a noi», il titolo. Fra i primi commenti quello di un ragazzo di 17 anni che dice: non ho potuto votare ma ho convinto la mia famiglia. I dati indicano che l’elettorato di Raggi (e dei candidati grillini nei municipi, vinti nel numero di 12 su 14 a Roma) è molto più giovane rispetto a quello dei partiti tradizionali.
La giunta.
Appendino ha selezionato curriculum di 400 candidati e già indicato quasi tutti i nomi. Ci sono il presidente dell’Arcigay Marco Giusta, l’uomo dei conti del leghista Cota Sergio Rolando, il docente di storia dell’architettura al Politecnico Guido Montanari, per lo Sport Roberto Finardi ex dirigente Coni, atleta e tifoso del Toro (Appendino è juventina, fino a 25 anni ha giocato terzino). Sonia Schettino che viene dalla Compagnia di San Paolo e dalla fondazione Agnelli, l’insegnante Federica Patti, che come altri arriva da associazioni e ambienti vicini alla sinistra. Ha annunciato che i lavori della giunta saranno trasmessi in diretta Facebook una volta al mese. Dal Politecnico viene anche Cristina Pronello, che Virginia Raggi vuole a Roma ai Trasporti. L’assai apprezzato urbanista Paolo Berdini e il rugbista Andrea Lo Cicero, pilone, 103 presenze in nazionale. Questi i nomi di punta. Ieri giornata di grandi consultazioni per le posizioni ancora scoperte.
Grillo.
Appendino non ha sottoscritto il “contratto” che vincola Virginia Raggi e i consiglieri capitolini allo staff del Movimento e che prevede tra l’altro multe in caso di “danno d’immagine”. Raggi ha pubblicamente ringraziato della sua elezione Grillo e Casaleggio, Appendino forse in privato. Rispetto a Raggi, che è stata indicata come candidato sindaco da 1724 persone nelle primarie on line, Appendino è stata scelta come candidato sindaco per acclamazione, in assemblea.
Carriera politica e polemiche.
Entrambe fanno politica da più di cinque anni e sono state consigliere comunali di opposizione nell’ultimo mandato. Appendino aveva una iniziale simpatia per Sel e stima per l’allora leader Nichi Vendola. Si è avvicinata ai Cinquestelle “per caso”, ha raccontato, insieme al marito, industriale e simpatizzante del Movimento. Ha proposto, a un banchetto per strada, di “dare una mano” a decifrare il Bilancio del Comune. E’ laureata in Economia alla Bocconi. Raggi ha lavorato come praticante nello studio legale Sammarco, prima di entrare in politica a 32 anni. Il praticantato in quello studio, che ha lavorato con Cesare Previti, ha suscitato polemiche in campagna elettorale. Da ultimo, alla vigilia del voto, è stata attaccata per una consulenza non dichiarata alla Asl di Civitavecchia. «Ci hanno fatto una guerra senza precedenti », ha detto ieri notte sotto la pioggia, «ma da oggi lavoriamo tutti per Roma».
ntervista di Silvia Truzzi a Barbara Spinelli sui risultati del voto. «C’è il desiderio profondo di restaurare in pieno la sovranità popolare». Il Fatto Quotidiano, 21 giugno 2016 (m.p.r.)
La parola è populismo. «Queste elezioni rappresentano una svolta che mette in dubbio molte granitiche certezze nella classe politica tradizionale. In particolare confutano slogan che sembravano punti di forza e invece si sono rivelati fragilissimi», spiega Barbara Spinelli, giornalista, scrittrice ed europarlamentare, Indipendente del gruppo GuE-Ngl (Sinistra unitaria europea). «La prima accusa che in genere viene rivolta al Movimento 5 Stelle è quella di populismo. Ma le urne di domenica ci dicono che il populismo di cui si parla con tanto disprezzo non è in fondo altro che il desiderio, profondo, di restaurare in pieno la sovranità popolare».
Il populismo è l’altra faccia della governabilità, slogan che sentiamo ripetere continuamente.
Infatti: la governabilità, che ci viene propagandata come il valore massimo, nasconde in realtà un tentativo di accentramento del potere. Del resto “governabilità” ha un significato passivo, vuol dire “essere governati”. Tra queste due parole, “populismo” e “governabilità”, c’è una connessione stretta: le urne ci hanno detto che il popolo non vuole subire il governo dall'alto. Vuole governi, non governabilità. Questo al netto dell’astensionismo, che però nei ballottaggi è abbastanza fisiologico. L’accusa di populismo in tutta Europa viene utilizzata insistentemente per screditare ogni forma di protesta o di partecipazione dei cittadini, penso per esempio ai referendum. Tutto ciò che dà voce alla volontà dei cittadini viene svilito, eppure in tutta Europa il principio della sovranità popolare è il fondamento della democrazia costituzionale. Qualche settimana fa Junker al G7 ha attaccato i populisti dell’Occidente mettendo sullo stesso piano Beppe Grillo e Donald Trump. Accusa che ha certamente fatto piacere al premier Renzi, ma che indica la cecità della classe dirigente europea rispetto a movimenti sociali sempre più rilevanti.
C’è un legame con i prossimi appuntamenti, come il referendum costituzionale di ottobre?
Un legame strettissimo. Tutta l’impalcatura oligarchica scricchiola: la riforma del Senato, che non sarà più elettivo, nella misura in cui è abbinato alla nuova legge elettorale, si contrappone a questo tentativo di recupero del principio di rappresentanza e di sovranità. Per essere coerenti, gli anti-populisti dovrebbero eliminare le elezioni: se si considera qualunque alternativa alle politiche proposte come populista, tanto vale non chiamare più i cittadini a esprimersi. Perché le elezioni ti possono dare come risultato il fatto che il popolo sceglie l’alternativa.
Si è detto che con Virginia Raggi e Chiara Appendino il Movimento 5 Stelle ha presentato un volto più rassicurante, più istituzionale.
Ho seguito la campagna elettorale e ho avuto l’impressione che le due candidate siano arrivate molto preparate e con le idee chiare all’appuntamento con le urne. Aggiungo: non ne sono affatto sorpresa. Sono al Parlamento europeo da due anni e seguo attentamente quello che i miei colleghi del Movimento 5 stelle fanno a Bruxelles e Strasburgo: con loro lavoro in modo molto proficuo perché hanno competenza di altissimo livello su questioni specifiche e tecniche. Sono documentati, studiano, sono puntuali negli interventi. Dicono che sono antieuropei, ma non è vero: si battono per un’Europa diversa e questo per me vuol dire essere pro Europa.
Quali sono le sfide che ha davanti il Movimento ora?
Queste elezioni hanno dimostrato la prevalenza della sovranità popolare, ma non basta esprimerle nel momento del voto. Deve essere un processo continuo. Una volta insediati nei municipi, i nuovi sindaci 5 Stelle dovranno continuare ad appellarsi alla sovranità popolare, e avere un legame forte con i cittadini, con la società civile: i poteri forti non si faranno da parte.
Sia Virginia Raggi che Chiara Appendino dopo la vittoria hanno fatto discorsi molto inclusivi. È un messaggio molto giusto. Non sarà semplice il loro lavoro. Virginia Raggi ha detto di voler mettere un punto e cambiare pagina, dopo gli scontri della campagna elettorale. Ma gli altri, i poteri forti, non credo lo faranno. Anche i cittadini dovranno essere molto vigili, continuando a sostenere il lavoro dei nuovi eletti.
Il Pd ha perso la connessione sentimentale con i ceti più popolari?
Non considero il Pd un partito di sinistra. Quello che i candidati e le candidate dei 5 Stelle dicono sulla povertà e le disuguaglianze sociali sono temi che un tempo erano della sinistra. Anche nella battaglia No Tav io credo che molte persone di sinistra si potrebbero riconoscere.
Commentatori e politici del Pd dicono che Renzi non avrebbe completato il processo di rottamazione e qui starebbero le ragioni della sconfitta.
Renzi rispecchia molto la tendenza oligarchica che c’è negli esecutivi di tutta Europa: è questo modo di governare che va rottamato.
 «L’assassinio di Jo Cox e il dibattito violento sulla "Brexit" definiscono ancora una volta la questione immigrazione come questione centrale del nostro tempo».
«L’assassinio di Jo Cox e il dibattito violento sulla "Brexit" definiscono ancora una volta la questione immigrazione come questione centrale del nostro tempo».
Il manifesto, 20 giugno 2016 (m.p.r.)
L’assassinio di Jo Cox ci dà una rappresentazione plastica della radicalizzazione a cui sta andando incontro la lotta politica. Da un lato abbiamo un assassino razzista e neo-nazista, legato a una rete internazionale (altro che Britain first!) di primatisti bianchi. Dall’altro, ancor prima che una parlamentare laburista, una esponente, da sempre, del volontariato, impegnata nel sostegno alle politiche di accoglienza dei profughi e migranti e di apertura verso le comunità di immigrati. Respingere contro accogliere.
Delle possibili conseguenze della "Brexit", l’uscita del Regno unito dalla Unione europea, sono piene le pagine dei giornali e i notiziari televisivi: accentuerà la crisi economica? Provocherà un caos nel mondo finanziario? Ridurrà, e di quanto, i Pil? Penalizzerà, e in che misura, il mondo del lavoro, il precariato, i disoccupati? E dove? Solo nel Regno unito, se lascia, o anche nei paesi dell’Unione, se abbandonati? Sono tutte questioni della massima importanza; ma il voto del 23 giugno sulla brexit - leave or remain - non si svolgerà prioritariamente né in misura decisiva su questi temi ma su quello che l’assassinio di Jo Cox ha messo in evidenza: respingere o accogliere?
D’altronde è il tema su cui si sta avvitando e radicalizzando la lotta politica non solo in tutta Europa ma in tutti i paesi di forte immigrazione, volontaria o forzata, a partire dagli Stati Uniti.
È il tema su cui si è votato nelle recenti elezioni presidenziali in Austria, che hanno visto la polarizzazione dell’elettorato intorno a due schieramenti contrapposti, con la dissoluzione dei due partiti centristi che avevano governato il paese, insieme o alternandosi, negli ultimi settant’anni.
È il tema che sta mettendo in crisi le maggioranze di tutti i paesi dell’Unione, che vedono nell’esito del voto austriaco l’alternativa tra la loro scomparsa e il loro allineamento con le posizioni xenofobe più estreme, solo in parte mascherate da iniziative come l’accordo con Erdogan o la proposta del Migration compact che non hanno futuro, ma che contribuiscono non poco alla moltiplicazione delle sofferenze di milioni di profughi e all’imbarbarimento della convivenza nei propri paesi.
Quando già non si sono decisamente spostate verso il primo di quei poli - respingere - con tutte le conseguenze di ordine politico che questo comporta, come è successo in molti dei paesi membri dell’Europa orientale.
Se l’eventuale uscita del Regno Unito dall’Unione rischia di aprire la strada ai molti governi già tentati di farlo per conto loro – Danimarca, Olanda, Svezia e poi, chissà? – questo non è certo per le assurde politiche economiche adottate dall’Unione, di cui quei governi sono grandi sostenitori, ma perché ormai "uscire" è diventato l’equivalente di respingere.
Ma è un tema che non sta mettendo sottosopra solo il posizionamento e l’esistenza stessa di forze politiche consolidate; divide e mette in discussione anche le fedi religiose. E non solo l’Islam, tra integralisti radicalizzati e i cosiddetti "moderati", che altro non sono che coloro che vorrebbero praticare in santa pace il loro credo.
Ma anche, e in misura crescente, i cristiani: tra chi, come papa Francesco, ha messo il tema dell’accoglienza al centro di una pratica autentica della propria fede e chi nelle "radici cristiane" dell’Europa o dell’Occidente rivendica le ragioni del respingimento dei seguaci di altre religioni, quando non di un razzismo ormai scoperto, di cui non ci si deve più vergognare. Come mette in crisi le culture, scoprendo tanti sedicenti liberali apertamente schierati contro la libera circolazione delle persone tanto quanto sono favorevoli alla libera circolazione di merci e capitali; e tanti eredi di quello che fu l’internazionalismo proletario (che in verità non ha evitato, e spesso nemmeno sconfessato, un secolo di colonialismo e due guerre mondiali) impegnati a ripetere che «così son troppi» e che «così non si può andare avanti».
Ma il fatto è che la contrapposizione tra respingere e accogliere attraversa e divide verticalmente anche le classi sociali lungo linee che in nulla corrispondono alla visione tradizionale che per lo più se ne continua ad avere: operai e capitale, proletari e borghesi, basso e alto, 99 e 1 per cento.
Vuol forse dire, questo, che la lotta di classe è finita e bisogna attestarsi su altri fronti? Certo no. Ma vuol dire che le lotte sociali, anche le più radicali, come quelle che stanno attraversando la Francia, se non sapranno misurarsi con questo problema rischiano di portare acqua anche loro al fronte di chi punta a rifondare stati e governi su basi autoritarie, antidemocratiche, nazionaliste e razziste.
Dunque la partita decisiva è questa; bisognerebbe attrezzarsi in gran fretta se non per vincerla, perché un esito del genere appare al momento fuori portata, per lo meno per non farsene sopraffare. Tenendo conto soprattutto di due elementi:
1. Se respingere è così popolare perché è semplice dirlo e sembra facile farlo, in realtà tutte le soluzioni proposte sono impraticabili; ma ricade sui suoi fautori la responsabilità di decine e decine di migliaia morti, di violenze senza fine sui corpi e sulle vite di milioni di esseri umani, dell’istituzione di veri e propri campi di sterminio che avvicina di molto l’esito pratico di questa scelta all’ideologia che ha armato la mano dell’assassino di Jo Cox.
2. Accogliere non vuol dire solo aprire le porte a chi cerca la propria salvezza nei nostri paesi, offrire loro tetto e cibo, e poi costringerli per anni a un ozio forzato mantenuti dallo stato, per poi abbandonarli alla clandestinità: cioè quello che tanto fa arrabbiare, e giustamente, chi accanto a loro fatica giorno per giorno a sbarcare il lunario.
Accogliere vuol dire anche includere, inserire i nuovi arrivati in una rete di rapporti sociali che li metta in condizione di rendersi autonomi, di lavorare, di andare a scuola, di imparare, ma anche di trasmettere e divulgare la loro cultura; e di organizzarsi per contribuire a creare le condizioni di un ritorno – per chi lo desidera, e sono molti! – nel paese da cui sono dovuti fuggire.
Profughi e migranti possono essere una risorsa straordinaria sia per l’Europa che per i loro paesi di origine. Ma bisogna capirlo, saperlo spiegare, e poi cominciare a tradurlo in pratica: con dei progetti, anche minimi, che aprano la strada a una diversa visione del problema.

«Non si vede una maggioranza diversa dall’attuale per guidare l’Italia. Ieri, tuttavia, si è aperta una stagione che cancella qualunque illusione di primato e di posizione di rendita». Articoli di Stefano Folli, Norma Rangeri, Massimo Franco, Roberto Napolitano. La Repubblica, Il manifesto, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, 20 giugno 2016 (m.p.r.)
La Repubblica
LA ROTTAMAZIONE GRILLINA
CHE BATTE IL RENZISMO
di Stefano Folli
Stamane la vittoria dei Cinque Stelle a Roma sarà su tutti i siti web e sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo. È una vittoria prevista ma clamorosa, anche nelle proporzioni. La capitale d’Italia verrà amministrata da una forza che pretende di essere un movimento e non un partito e che esiste da pochi anni. Beppe Grillo, assente durante la campagna, è piombato nella notte ad abbracciare Virginia Raggi e forse a sovrapporsi a lei. Quello che accadrà è un enigma avvolto in un rebus, ma i Cinque Stelle hanno vinto con un colpo di scena anche a Torino, il che raddoppia la loro responsabilità. Hanno gli occhi del mondo addosso e sono di fronte al passaggio cruciale della loro breve esistenza. Se intendono diventare qualcosa di diverso dal fenomeno protestatario e un po’ folkloristico che sono stati fin qui, salvo poche eccezioni, da oggi non dovranno sbagliare. Sapendo che le scelte possono essere impopolari e richiedono la capacità di riunire una classe dirigente.
Di sicuro sono scelte che turbano il raccontino manicheo dei buoni contro i cattivi. Per Matteo Renzi e il suo partito il risultato è molto negativo. È soprattutto un pessimo risultato per il “renzismo” inteso come ambizioso disegno volto a rimodellare l’Italia definendo i contorni di un partito personale costruito sul carisma del leader. Perdere Roma è grave, ma per mille ragioni inevitabile. Perderla con uno scarto percentuale così significativo è spiacevole, dimostra che Giachetti è stato un candidato dignitoso ma debole e fuori contesto. Tuttavia ciò che rende grave la sconfitta e apre un capitolo carico di incognite nel centrosinistra è la parallela caduta al Nord.
Fassino, uno dei fondatori del Pd, era in vantaggio di circa undici punti al primo turno e nonostante questo Torino ha da oggi un sindaco a Cinque Stelle. Torino, non solo Roma. La Capitale sconta un dissesto amministrativo di anni, il capoluogo del Piemonte è un’altra storia. Fassino ha adempiuto ai doveri del suo mandato con esperienza e serietà, come dimostra la realtà di una città ben gestita e sotto questo profilo non paragonabile a Roma. Eppure l’esito del voto è il medesimo al Nord come al Centro: vince l’alternativa “grillina” con le sue ricette vaghe, i mille No e le prospettive di “decrescita felice”. E se mettiamo nel canestro anche Napoli, dove De Magistris è stato confermato senza problemi, abbiamo una dorsale dell’anti-politica, della protesta e del malessere sociale che abbraccia mondi lontani e diversi da Nord a Sud, uniti da un senso di insofferenza e di rivolta contro il vecchio assetto. E infatti De Magistris, che non é “grillino”, ha assorbito e riproposto molti dei temi populisti cari ai Cinque Stelle. I quali sotto il Vesuvio quasi non esistono, mentre il Pd - come è noto - è completamente scomparso dalla contesa.
Quanto a Milano, Sala ha prevalso di misura. Nonostante questo, nessuno può davvero pensare che dal laboratorio milanese sia uscita la ricetta vincente per dimenticare Roma, Torino e Napoli. È un dato che rende meno drammatica la notte del Pd, ma non basta a costruire un’ipotesi rassicurante: troppo poco per riconciliare il centrosinistra con il suo elettorato, tanto meno per individuare le coordinate del famoso “partito di Renzi” su cui il premier ha puntato le sue carte a partire dalle elezioni europee del 2014. Così come non è sufficiente il successo di Merola a Bologna, terreno tradizionalmente favorevole, a garantire sullo stato di salute del Pd. Perché queste elezioni, pur nella diversità dei luoghi e delle situazioni, dimostrano che il Partito Democratico ha bisogno di essere ripensato dalle radici.
Travolto dai Cinque Stelle a Roma e a Torino, inesistente a Napoli, perdente a Trieste, vittorioso alla fine a Milano (e vedremo poi le altre piazze, alcune - come Varese - positive per il Pd). Un bilancio abbastanza misero per alimentare le prospettive renziane, il sogno del partito “di sistema” capace di tenersi l’ala sinistra e al tempo stesso di sfondare, novello Tony Blair, verso il centrodestra. Questo scenario non si è verificato e se Renzi conserverà Milano lo deve alla lealtà di Pisapia, che ha permesso di incollare a Sala buona parte dei voti di sinistra.
Il Pd ha bisogno di una rifondazione ideale e di un modo meno aspro di intendere la leadership. Il che non significa una trattativa di basso livello con la minoranza bersaniana. Ovvio che il premier-segretario deve attendersi qualche atto poco amichevole da parte di quel segmento del partito che è stato trattato con malcelato disprezzo negli ultimi due anni. Ma la rifondazione ideale presuppone un orizzonte assai più ampio. Temi, prospettive, ricerca di un nuovo rapporto con la base sociale e gli elettori; un rinnovamento che non sia solo la resa dei conti con gli avversari interni per promuovere il proprio gruppo di potere... c’è solo da cominciare. Il congresso del Pd potrà essere l’occasione propizia per segnare il cambio di passo, alla ricerca di un più equilibrato assetto interno. Ma nulla sarà possibile senza idee e suggestioni calate nel solco del riformismo europeo, fondate su una visione non solo propagandistica dell’Italia di oggi e del suo disagio, sullo sfondo di una ripresa economica troppo fragile e di ingiustizie percepite come intollerabili.
Il governo non corre rischi. Ma sarebbe grave se l’analisi si limitasse a tale considerazione. Questa volta è indispensabile un bagno nel realismo. A lungo, il premier si è protetto dietro uno scudo: l’assenza di alternative. Un centrodestra berlusconiano troppo debole e diviso fra moderati e “lepenisti” alla Salvini. E un movimento Cinque Stelle chiassoso ma immaturo e poco credibile come forza di governo. In parte è ancora così, ma sempre meno. Le elezioni comunali dimostrano che una forma di alternativa prende forma nelle città. Sarà incapace di esprimere, come si usa dire, una cultura di governo? Vedremo. La storia insegna che le alternative politiche con il tempo si creano sempre, per cui è pericoloso cullarsi nelle illusioni. Da stanotte anche il referendum costituzionale di ottobre diventa un’insidia da non sottovalutare. Non c’è un nesso diretto fra il voto amministrativo e la consultazione sulla riforma, salvo uno: la popolarità di Renzi è in calo insieme alle fortune del suo Pd. Per cui una certa retorica del rinnovamento, con il vezzo di dividere gli italiani fra riformisti e conservatori, rischia di essere irritante e poco utile. Anche rispetto alla strategia referendaria sarà opportuna una riflessione.
Il manifesto
UNA SCONFITTA CAPITALE
di Norma Rangeri
Il numero clamoroso che crolla in testa a Renzi sarebbe da scrivere a caratteri romani perché si tratta della valanga 5Stelle che ieri si è abbattuta sulla Capitale con percentuali bulgare. Le prime proiezioni sfioravano il 70% per la giovane Raggi, a vanificare la fatica di Sisifo del povero Giachetti, doppiato dai consensi della futura sindaca di Roma.
È la prima donna nella storia ad agguantare il governo della Capitale. E non c’è dubbio che nella scelta di far correre due donne in città importanti del paese, Raggi a Roma e Appendino che vince a Torino, c’è una marcia in più del Movimento 5Stelle. Si compensa l’inesperienza di queste future prime cittadine (hanno alle spalle una consiliatura nei precedenti governi comunali), con l’attenzione alla domanda di cambiamento radicale reclamato dalla cittadinanza: specialmente, come si è visto dalla geografia dei quartieri, di quella parte della società che paga i prezzi più pesanti della crisi.
La pesante, e inaspettata, sconfitta di Fassino a Torino è l’altro risultato che mette il piombo all’avventura nazionale di Renzi. Cade proprio sul fronte torinese la linea d’attacco del renzismo-marchionnismo rappresentata da un renziano ante-litteram come Fassino, antico dirigente del Pci-Pds-Ds-Pd, il partito che oggi perde una città che guidava da più di vent’anni.
E neppure la difficile vittoria di Sala a Milano, raggiunta con fatica e probabilmente ottenuta grazie al soccorso rosso della sinistra e dei radicali, riesce a pareggiare il pesante debito elettorale del partito democratico. Con la conferma piena della vittoria di De Magistris a Napoli, il Pd di Renzi esce dal match delle urne come un pugile suonato, perché ai risultati dei ballottaggi va affiancato quello del crollo registrato dal Pd già al primo turno. Dalle europee del 2014 sembra passata un’era geologica.
È basso ma non inedito il dato dell’affluenza che si profila intorno a un 50% dei votanti. Le elezioni comunali, un tempo le più partecipate, fin da quando inaugurarono, nel 1993, l’elezione diretta dei sindaci, oggi si rivelano poco amate e meno frequentate dagli elettori italiani. E tutto fa pensare allo scenario possibile dell’Italicum, quando ci potremmo ritrovare in una situazione analoga alle elezioni politiche, con una nuova legge elettorale che prevede il ballottaggio senza nessuna soglia per il premio di maggioranza. Configurando così un governo nazionale espressione di una minoranza di votanti.
Un obiettivo del resto perseguito con tenacia e perseveranza da Renzi, politico allergico alla filosofia decoubertiana, l’importante per lui non è partecipare ma vincere. Le urne dicono che da solo perde. La strategia dell’autosufficienza fa solo terra bruciata.
Corriere della Sera
GLI ERRORI E LE INSIDIE
di Massimo Franco
Sarà difficile minimizzare quanto è successo ieri nelle maggiori città italiane. E ancora di più catalogare come voto amministrativo ballottaggi che spediscono al governo nazionale un segnale univoco. Per mutuare il verbo crudo scelto da Matteo Renzi all’inizio della sua esperienza, l’elettorato ha «rottamato» il Pd a Roma e Torino, premiando le due candidate del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi e Chiara Appendino; e fino a notte fonda ha tenuto in bilico la vittoria a Milano di Giuseppe Sala su Stefano Parisi del centrodestra. Il capoluogo lombardo è l’unica soddisfazione, e non da poco, per Palazzo Chigi. Gli consente di tirare un sospiro di sollievo, come a Bologna. Relativo, però. Né basterebbe prendersela con gli avversari interni: le diatribe tra i Democratici interessano poco, ormai.
La sconfitta della sinistra di governo pone un problema di sistema, perché l’alternativa in incubazione ha il profilo di Beppe Grillo. Il rischio, adesso, è di gettare l’esecutivo in un limbo di paura e di logoramento che il vertice del Pd dovrà affrontare anche psicologicamente. Va ribadito che non si vede una maggioranza diversa dall’attuale per guidare l’Italia. Ieri, tuttavia, si è aperta una stagione che cancella qualunque illusione di primato e di posizione di rendita.
Al punto che viene da chiedersi se il Pd riuscirà a prevalere nel referendum di ottobre sulle riforme istituzionali: quello su cui punta tutto. Se non cambia la strategia, c’è da dubitarne. Il flop delle Amministrative non avviene per la bontà delle proposte avversarie. È figlio di errori di sottovalutazione e di un filo di presunzione. Non è esagerato dire che probabilmente, qualunque candidato del M5S avrebbe dato filo da torcere a Pd e centrodestra. E non solo perché il movimento di Grillo è una «macchina da ballottaggi» capace di pescare consensi dovunque. La sua affermazione si alimenta del fallimento delle forze tradizionali: è il sintomo della delusione verso i partiti tradizionali, e di tensioni sociali irrisolte.
Per Renzi lo schiaffo è più doloroso, perché respinge la sua narrativa ottimistica e getta ombre sul referendum. Due anni e mezzo di segreteria del Pd e oltre due di presidenza del Consiglio dovevano consacrarlo come il leader capace di riplasmare la sinistra e porsi come nuovo baricentro della politica. Il mandato era di fermare Grillo e di far ripartire l’economia attraverso le riforme. Alcune riforme ci sono, eppure i loro effetti tardano a vedersi. Già emergono, invece, i contraccolpi negativi. Il M5S ha espugnato facilmente il Campidoglio, sospinto da un consenso popolare gonfiatosi sulle macerie del Pd e del centrodestra capitolini.
E a Milano è bastato un candidato moderato come Parisi per mettere in forse fino all’ultimo la vittoria di Sala. Quanto a Napoli, cuore del Sud, i Dem non sono arrivati nemmeno al ballottaggio. Insomma, abbiamo alcune delle «capitali» d’Italia non governate dal Pd. E lo schema del partito che si percepisce così forte da ritenersi autosufficiente deve fare i conti con ballottaggi dispettosi. I risultati confermano che nessuno si può permettere l’autarchia. Sono necessarie alleanze. Gli unici a prescinderne in nome di una controversa purezza sono i grillini: almeno ufficialmente.
Bisogna prendere atto che al secondo turno si formano coalizioni di fatto, micidiali per chi ne è escluso. Si tratta di una verità che potrebbe portare a una modifica dell’Italicum, ritenuto dal premier un tabù intoccabile. Bisognerebbe aspettarsi un ripensamento dell’agenda del governo, e del modo in cui il premier ha svolto il suo doppio incarico. L’insuccesso, tuttavia, non può essere scaricato solo su di lui. I limiti di leadership si abbinano all’incapacità dell’intero Pd di trasmettere al Paese un messaggio di unità e di credibilità.
Gli elettori hanno tolto a Renzi l’aureola della grande vittoria del Pd alle Europee del 2014. Ma c’è poco da rallegrarsi. La fase che si apre presenta molte insidie. Non c’è un dopo-Renzi in vista. C’è un partito-perno che di colpo si ritrova indebolito e magari tentato dalla caccia ai capri espiatori: tutte premesse di un periodo di confusione. Bisogna sperare che, messo di fronte alla responsabilità di governare, il M5S scelga un profilo meno estremista; e riesca a battere le diffidenze verso la sua classe dirigente magari onesta ma inesperta e manichea: anche perché il tripolarismo sta diventando sfida Pd-M5S. Con la Lega ridimensionata nelle ambizioni, e l’astensione come convitata di pietra.
Il Sole 24 Ore
LA FORZA DEL SEGNALE POLITICO
di Roberto Napoletano
Il segnale “politico” per il governo Renzi si era appalesato con chiarezza al primo turno delle amministrative, e lo avevamo prontamente evidenziato, adesso rimbomba con ancora maggiore forza e certifica quanto pesino la fragilità della ripresa e il disagio sociale nell’urna. Il nemico comune da battere è la mancata crescita e per costruirla, in Italia e in Europa, in un mondo che rallenta e pieno di incognite, bisogna dimostrare di sapere fare le cose difficili. Il risultato del voto amministrativo, piaccia o no, da Roma a Torino, per non parlare di Napoli, ci consegna questo “dato politico” e non basta a mitigarlo neppure la vittoria di misura a Milano con un’amministrazione uscente che ha ben governato e in un momento d’oro riconosciuto in casa e fuori per la nostra capitale economica.
Questo Paese non si può permettere una nuova stagione di instabilità politica, alla vigilia di un appuntamento di portata storica come è quello del referendum inglese su Brexit, ma non si può neppure permettere una stagione di stabilità politica di governo che non si sporchi le mani con le cose difficili, non faccia atti concludenti per liberare il Paese dai macigni di una pubblica amministrazione opprimente e di una giustizia civile dai tempi eterni e non riesca a restituire un sentiero di certezze dove la stabile e finalmente strutturale riduzione dei prelievi fiscali e contributivi si accompagni a un’azione “politica” incisiva sui terreni della spending review e, in genere, della spesa pubblica allargata, nazionale e territoriale.
Senza fare questo, anche nello scenario migliore che è ovviamente quello che Brexit non passi, il governo italiano brucerebbe il capitale accumulato con la riforma del mercato del lavoro, i primi interventi fiscali e sulla macchina dello Stato, l’impronta meritocratica e il cammino intrapreso sul piano istituzionale (contrappesi e aggiustamenti necessari compresi). Finirebbe delegittimato nell’azione altrettanto ineludibile di un cambiamento in profondità dell’Europa che vada verso un assetto federale, una difesa comune e, soprattutto, una politica finalmente di crescita e solidaristica senza la quale è impossibile ritrovare lo spirito dei Fondatori e restituire al Vecchio Continente il ruolo che merita nell’arena della competizione globale. Mancare questa opportunità per colpa nostra è davvero imperdonabile se si pensa che tutto congiura a favore di un’Italia che recuperi non solo un ruolo di capofila dei Paesi periferici ma anche un suo peso specifico in Europa nel dialogo con la cancelliera Merkel, la Commissione europea e la stessa Bce. Dipende solo da noi: nel senso che solo noi possiamo gettare alle ortiche questa irripetibile occasione.
Non intendiamo qui dilungarci in disquisizioni più strettamente politologiche: la questione interna del Pd e l’esigenza da ambo le parti di recuperare coerenza d’azione, spirito di partito e tratti costitutivi, il peso dei movimenti cosiddetti populisti che nel caso dei cinque stelle alternano competenze inattese e spinte demagogiche ma dentro un ancoraggio civico che non va sottovalutato, gli scenari di Roma e di Milano che mostrano plasticamente in senso opposto come e quanto pesino disagio sociale, inefficienza amministrativa e malaffare rispetto alla tenuta degli schieramenti storici di centrodestra e di centrosinistra. Potremmo proseguire e il giornale offre analisi puntuali richiamate a fianco.
Il punto dirimente, però, è un altro. Il dato politico che emerge da questa consultazione è evidente: la buona governabilità viene prima del referendum costituzionale di ottobre e, se si vuole vincere questa partita, bisogna avere il coraggio di dire la verità, coinvolgere e pretendere da tutti, dentro e fuori il Pd, dalle parti sociali e nelle pieghe della società, una direzione riformistica fatta non di una tantum ma di cose che restano, che si possano toccare e esigere, non quelle semplici, ma quelle difficili con le quali tutti si sono scontrati e che nessuno è riuscito a fare. La fiducia contagiosa e duratura, quella che permette a un Paese di girare pagina per davvero e di tornare a dare lavoro qualificato ai suoi giovani migliori, passa di qui, si misura sul terreno della produttività e sulla ripresa degli investimenti. Non esistono scorciatoie per nessuno. A ben vedere, è questa l’altra grande occasione da cogliere.

Internazionale
online, 20 giugno 2016 (c.m.c.)
In occasione del Vertice umanitario mondiale dell’Onu, a maggio in Turchia, il vicepresidente keniano William Ruto ha dichiarato che è ormai definitiva la decisione di chiudere Dadaab e Kakuma, i due campi profughi più grandi del paese.
E questo nonostante le chiusure siano una violazione del diritto internazionale e le Nazioni Unite abbiano avvertito delle “devastanti conseguenze” che ne deriveranno. Più di 600mila persone residenti saranno sfollate e si troveranno in una situazione di rischio immediato. La chiusura forzata tradisce inoltre i più elementari diritti dei rifugiati e non farà altro che inaugurare una serie di violazioni dei diritti umani, dal momento che facendo ritorno nel loro paese natale i profughi dovranno affrontare conseguenze molto pesanti.
La decisione del Kenya ha dei precedenti. Nel 2012 il governo della Tanzania aveva chiuso il campo profughi di Mtabila, costringendo i suoi 35mila abitanti burundesi a trovarsi una nuova sistemazione in Burundi, il paese in cui dilagava un conflitto violento dal quale erano fuggiti. Da allora le violenze in Burundi hanno costretto più 250mila abitanti del paese a cercare rifugio nei paesi vicini, e 137mila sono tornati in Tanzania.
Soluzione definitiva
E tuttavia la situazione del Kenya è il sintomo di un problema più ampio e sostanziale. Il nodo cruciale è che i campi rappresentano la base della strategia di risposta alle crisi di profughi messa in atto dalla comunità internazionale. Sono diventati il collettore della maggioranza degli aiuti umanitari. I campi sono diventati l’inizio, e in molti casi lo scopo, dell’intervento internazionale nelle crisi di profughi sempre più numerose.
Oggi più della metà della popolazione di profughi al mondo – circa il 60 per cento – risiede in aree urbane e non nei campi
I campi, come suggerisce il nome, dovrebbero essere delle soluzioni temporanee. Eppure le cose raramente stanno così: Dadaab e Kakuma per esempio hanno già 25 anni. Dadaab è stato costruito nel 1992 per fornire un rifugio temporaneo a 90mila profughi in fuga dalla violenta guerra civile in Somalia. Oggi è il campo profughi più grande del mondo, nonché la terza “città” del Kenya per dimensioni.
La vicenda del Kenya sottolinea la necessità urgente di trovare alternative sostenibili ai campi e soluzioni sostenibili per i milioni di profughi urbani che li hanno lasciati o hanno scelto di evitarli. Oggi più della metà della popolazione di profughi al mondo – circa il 60 per cento – risiede in aree urbane e non nei campi. E una schiacciante maggioranza, l’86 per cento, si trova nei paesi più poveri.
In queste aree urbane, organizzazioni non governative di tutto il mondo mostrano la possibilità di creare alternative ai campi profughi. Con i loro programmi cercano di offrire ai profughi la possibilità di conquistare l’indipendenza dagli aiuti internazionali, trovare un modo per vivere dignitosamente e mezzi di sostentamento di lungo periodo che al tempo stesso hanno ricadute positive sulle comunità che li ospitano.
Un programma in Kenya, per esempio, fornisce un riparo e un sostegno a donne e bambini, che compongono più della metà della popolazione mondiale di profughi e sono esposti a gravi rischi di violenza sessuale e di genere. La casa famiglia garantisce la sicurezza 24 ore al giorno e fornisce importanti servizi di orientamento, assistenza legale e sanitaria e una comunità accogliente nei confronti delle ospiti. Il programma inoltre facilita le strategie di uscita positive per le donne, mettendole in collegamento con sistemazioni di lungo periodo un supporto sostenibile all’interno della comunità locale.
In molti casi sono i profughi stessi a guidare le iniziative di solidarietà nei paesi di accoglienza. Ma hanno poche risorse e nessun sostegno internazionale
In un altro programma a Irbid, in Giordania, sono state aperte delle abitazioni per accogliere i profughi siriani. A Irbid quello della casa è un problema di vecchia data. I programmi basati sull’affitto in cambio di soldi offrono soluzioni temporanee ma fanno schizzare alle stelle gli affitti nel mercato locale degli alloggi e rendono la vita più difficile agli abitanti del posto e ai profughi. Il programma di Irbid è sostenuto dal Consiglio norvegese per i profughi (Nrc) e offre ai proprietari locali fondi per completare la costruzione di edifici a più piani, creando abitazioni per i profughi e al tempo stesso stimolando l’economia locale. Fino a oggi sono state create 3.800 unità immobiliari per più di 8.700 profughi, e mentre altri ottomila sono in lista d’attesa l’Nrc può estendere le attività in altre aree urbane su tutto il territorio della Giordania.
Oltre a questo tipo di programmi messi in campo dalle ong, tante organizzazioni comunitarie forniscono un supporto vitale. Rappresentano spesso l’unica fonte di sostegno per i profughi urbani che in molti casi sono alla guida delle iniziative.
Fare promesse realistiche e mantenerle
Un esempio è l’organizzazione Young african refugees for integral development (Yarid), che dal 2008 è attiva nella comunità di profughi di Kampala, in Uganda. I fondatori di Yarid, profughi sfuggiti alle violenze nella Repubblica democratica del Congo e stabiliti in Uganda, hanno dato vita alla loro organizzazione dopo aver osservato le difficoltà affrontate dagli altri profughi come loro. Oggi Yarid rappresenta una comunità vitale che affronta questioni sociali come la disoccupazione, la salute pubblica e i conflitti etnici e fornisce servizi educativi fondamentali ai profughi urbani dell’Africa centrale. Tuttavia, a causa della scarsità di risorse e dell’assenza di un sostegno internazionale queste organizzazioni faticano a sopravvivere.
Oggi, una persona su 122 è costretta a vivere lontano dalla sua casa. La crisi è reale e la situazione in Kenya non è che un esempio di quanto sia ormai precaria la nostra dipendenza globale dal sistema dei campi. Se vogliamo che le alternative funzionino, dobbiamo investire in quello che funziona.
I campi profughi non stanno funzionando, al contrario di tanti programmi in tutto il mondo. È giunto il momento che la comunità internazionale dimostri il suo impegno a risolvere la crisi globale dei profughi investendo in soluzioni che mantengono promesse realistiche.
Articolo pubblicato dal The Guardian, traduzione di Giusy Muzzopappa
«Il Regno Unito paga le scelte sbagliate di Berlino e Bruxelles su immigrazione e moneta Ma l’alternativa produrrebbe un forte impoverimento».
La Repubblica, 20 giugno 2016 (m.p.r.)
Mancano ancora quattro mesi e mezzo alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, ma c’è un voto, questa settimana, che potrebbe pesare sul futuro del mondo quanto quello americano: il referendum della Gran Bretagna sul rimanere o meno nell’Unione Europea. Purtroppo, questo voto è una scelta tra il male e il peggio: la domanda è quale sia il peggio. Non lo nascondo: io voterei Remain. Lo farei pienamente consapevole che la Ue funziona malissimo e mostra pochi segni di volersi riformare. Ma l’uscita della Gran Bretagna - la Brexit - probabilmente peggiorerebbe le cose, non solo per i britannici, ma per l’Europa intera.
Da un punto di vista economico, è chiaro: la Brexit renderebbe la Gran Bretagna più povera. Non porterebbe necessariamente a una guerra commerciale, ma peggiorerebbe sicuramente il commercio britannico con il resto d’Europa, con un calo della produttività e dei redditi. Secondo i miei calcoli approssimativi, che sono in linea con altre stime, la Gran Bretagna diventerebbe più povera del due per cento di quanto non sarebbe altrimenti, praticamente per sempre. È un colpo duro. C’è anche il rischio, più difficile da quantificare, che la Brexit colpisca la City che è una grande fonte di esportazioni e di reddito. E questo farebbe sostanzialmente aumentare i costi.
Che cosa dire degli avvertimenti sul fatto che un Leave provocherebbe una crisi finanziaria? Questa è una paura esagerata. La Gran Bretagna non è la Grecia: ha una propria valuta e i suoi prestiti sono in questa valuta, quindi non rischia una pressione che creerebbe un caos monetario. Nelle ultime settimane, le probabilità di un voto favorevole all’uscita sono aumentate in maniera evidente, ma i tassi di interesse britannici sono scesi, non sono saliti, seguendo il calo globale dei rendimenti. Tuttavia, da un punto di vista economico, la Brexit appare una cattiva idea.
È vero, alcuni sostenitori della Brexit dicono che lasciare l’Unione Europea consentirebbe alla Gran Bretagna di fare delle cose meravigliose: di deregolamentare e scatenare la magia dei mercati, portando a una crescita esplosiva. Mi dispiace dire che questo è puro vudù avvolto nell’Union Jack; è la stessa fantasia del libero mercato che si è sempre e comunque dimostrata delirante. No, la situazione economica è buona quanto può esserlo in un momento del genere. Perché, dunque, il mio scarso entusiasmo sul Remain? Una parte della risposta sta nel fatto che l’impatto della Brexit sarebbe disomogeneo: Londra e il sud-est dell’Inghilterra sarebbero duramente colpiti, ma la Brexit vorrebbe probabilmente dire una sterlina più debole e questo potrebbe effettivamente aiutare alcune delle vecchie regioni manifatturiere del nord.
Più importante, tuttavia, è la triste realtà dell’Unione Europea che la Gran Bretagna potrebbe lasciare. Il cosiddetto progetto europeo cominciò più di 60 anni fa, e per molti anni ebbe un’enorme forza positiva. Non solo ha promosso il commercio e aiutato la crescita economica; è stato anche un baluardo per la pace e la democrazia in un continente con una storia terribile. Ma la Ue di oggi è la terra dell’euro, un grave errore aggravato dall’insistenza della Germania a trasformare la crisi provocata dalla moneta unica in un morality play dove si scontano i peccati (commessi dagli altri, ovviamente) con dei rovinosi tagli al bilancio.
La Gran Bretagna ha avuto il buon senso di mantenere la sterlina, ma non è immune dagli altri problemi dello sbilanciamento europeo, in particolare dall’istituzione di un’immigrazione libera senza un governo condiviso. Si può sostenere che i problemi causati, per esempio, dall’uso del servizio sanitario nazionale da parte dei romeni siano esagerati, e che i benefici dell’immigrazione bilanciano ampiamente questi costi, ma questo è un argomento difficile da presentare a un’opinione pubblica frustrata dai tagli ai servizi pubblici. Perché la cosa più frustrante riguardo all’Ue è questa: l’impressione che nessuno riconosca mai gli errori o impari da essi. È difficile trovare, ammesso che ci sia, qualcuno che a Bruxelles o a Berlino si faccia un esame di coscienza sulla terribile performance economica dell’Europa dal 2008. E provo una certa simpatia per i britannici che semplicemente non vogliono essere legati ad un sistema che garantisce così poca responsabilità, anche se uscirne ha un costo economico.
La questione, tuttavia, è se un voto britannico favorevole all’uscita otterrebbe qualcosa di meglio. Ma temo che, in realtà, peggiorerebbe le cose. Per questo io voterei Remain.
Articolo pubblicato sul New York Times News Service. Traduzione di Luis E. Moriones
 Turchia. Tra loro 4 bambini e 5 membri della stessa famiglia. Sarebbero almeno 60 i rifugiati ammazzati al confine nel 2016 da Ankara. Che ieri celebrava la "politica delle porte aperte".
Turchia. Tra loro 4 bambini e 5 membri della stessa famiglia. Sarebbero almeno 60 i rifugiati ammazzati al confine nel 2016 da Ankara. Che ieri celebrava la "politica delle porte aperte".
Ilmanifesto, 20 giugno 2016
Oggi si celebra la Giornata Mondiale dei Rifugiati. Ieri la Turchia l’ha celebrata a modo suo, prima con le parole e poi con le pallottole. In un comunicato il Ministero degli Esteri ha osannato quella che definisce la politica delle «porte aperte» a tutte le persone in fuga dall’oppressione «senza fare nessuna discriminazione».
Ma mentre il Ministero ribadiva il presunto impegno di Ankara nella protezione dei profughi (2,7 milioni i siriani oggi in Turchia, nei campi profughi o da invisibili nelle grandi città), al confine sud l’esercito apriva il fuoco come fatto innumerevoli volte negli ultimi mesi: almeno 11 i siriani uccisi, tra loro 4 bambini. Stavano tentando di attraversare la frontiera vicino al villaggio di Khirbet al-Jouz, dopo la fuga da Jarabulus e Idlib. Cinque appartenevano alla stessa famiglia: Obaid al-Abo, di 50 anni, e i figli Amani, 21, Fatoum, 20, Walaa, 17, Waed, 15, e Hassan di soli sei anni. La moglie ed un altro figlio sono rimasti feriti.
Secondo fonti locali, le guardie turche hanno «sparato in maniera indiscriminata contro famiglie che tentavano di passare il confine sabato notte». Alcune foto sono apparse sui social network: una mostrava una donna in lacrime con in braccio una bimba di due anni colpita allo stomaco, altre cadaveri a terra.
Non si tratta di un evento sporadico: nel 2016 almeno 60 rifugiati siriani sono stati uccisi alla frontiera, oggi blindata, della Turchia: la politica delle porte aperte non esiste almeno da due anni, quando i kurdi di Rojava cominciarono una strenua resistenza per salvare Kobane dall’avanzata dell’Isis. La chiusura è stata ufficializzata ad agosto 2015: ai migliaia di siriani in fuga, prima da Rojava, poi da Aleppo e Idlib, Ankara ha impedito l’accesso fino a costruire vere e proprie barriere fisiche, muri e reti elettrificate.
Pochissimi quelli che entrano. E chi ce la fa passa dalla brutalità della guerra civile a quella dell’esercito turco: l’11 maggio riportavamo su queste pagine dei video di Human Rights Watch che ha documentato arresti arbitrari, torture e pestaggi compiuti sui civili in fuga. Rapporti trattati come carta straccia dal presidente Erdogan che ha negato ogni accusa.
Reazioni al massacro di ieri non ne sono arrivate. Dalla Turchia nessun commento ufficiale eccezion fatta per le dichiarazioni di un funzionario anonimo che ha negato: «Le voci secondo cui i soldati turchi hanno ucciso persone che provavano ad attraversare il confine nella provincia di Hatay non sono vere. La scorsa notte c’è stato un tentativo di passaggio illegale del confine ma nessuna pallottola è stata sparata contro la gente: dopo colpi di avvertimento, un gruppo di 7-8 persone è fuggito nel bosco».
A parlare è anche la Coalizione Nazionale, principale gruppo di opposizione al presidente Assad, ampiamente finanziato e sostenuto da Ankara: in un comunicato esprime «sorpresa e condanna dopo questa terribile tragedia che contraddice l’ospitalità del governo turco». Una dichiarazione che non alcuna base, che definisce ‘tragedia’ una pratica ormai comune e che non dà all’evento la sua reale definizione, quella di crimine di guerra.
Nelle stesse ore il Dipartimento di Stato Usa parlava dell’operazione in corso per la liberazione della città di Manbij, portata avanti dalle Forze Democratiche Siriane guidate dalle Ypg kurde, come di un’azione di successo grazie alla cooperazione con la Turchia. Dimenticando che le Ypg kurde sono oggi tra i nemici numero uno di Ankara, contro i quali Erdogan non lesina l’uso di missili e artiglieria pesante e minaccia di invadere il nord della Siria.

. Il Fatto quotidiano online, 19 giugno 2016 (c.m.c.)
Il referendum costituzionale si intreccia al giudizio della Corte costituzionale sulla legge elettorale. Il 4 ottobre è fissata la prima udienza alla Consulta. «La bocciatura della legge elettorale sarebbe un pessimo viatico per i sostenitori del Sì, ecco perché vogliono fissare il referendum prima del giudizio della Corte», spiega l’avvocato Felice Carlo Besostri, il regista della strategia giudiziaria contro l’Italicum. Ma nella maggior parte dei Tribunali i nostri ricorsi sono fermi, aggiunge Besostri, come se si volesse prima conoscere il risultato del referendum e il giudizio della Corte sul primo ricorso.
Il Tribunale di Trieste è in riserva dal 2 febbraio, Torino dal 21 marzo. Dovrebbero depositare le ordinanze in 30 giorni. «Se prosegue questa inerzia, solleveremo la questione facendo presentare interpellanze e interrogazioni in parlamento». Se salta la riforma costituzionale, tuttavia, «non sta in piedi nemmeno questa illegittima legge elettorale pensata solo per la Camera».
Avvocato Besostri, facciamo il punto della strategia di ricorsi contro l’Italicum.
I Tribunali che abbiamo interpellato sono quelli civili di Torino, Genova, Milano, Brescia, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Roma, L’Aquila, Bari, Lecce, Napoli, Potenza, Catanzaro, Messina. A breve Caltanissetta e Cagliari. L’obiettivo è quello di ottenere più ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale sui quattordici motivi di ricorso. Bisognava evitare che per avere un giudizio di costituzionalità si dovesse arrivare in Cassazione, magari dopo aver già votato con l’Italicum.
Come sta andando?
Le decisioni finora depositate sono state soltanto due. La prima decisione è stata del Tribunale di Messina che ha sollevato questione incidentale di costituzionalità su sei punti: la discussione in Corte Costituzionale è stata fissata per il 4 ottobre. La seconda del Tribunale di Ancona, che ha respinto il ricorso con una motivazione copiata, compreso un errore di data, 10 luglio invece del 1° luglio come data di applicazione della maggior parte delle norme dell’Italicum, da una sentenza del Tribunale di Milano, resa in un giudizio promosso da altri elettori non associati al nostro Coordinamento per la Democrazia.
L’ordinanza di rigetto è già stata impugnata. A Bari un giudice ha messo per iscritto quello che altri stanno facendo senza dirlo: ha rinviato tutto al 7 novembre per conoscere il risultato del referendum e le decisioni della Corte Costituzionale. I giudici che si sono riservati di emettere le ordinanze sono immobili. Il Tribunale di Trieste è in riserva dal 2 febbraio, Torino dal 21 marzo. Dovrebbero depositare in 30 giorni.
Chi avete di fronte nelle udienze?
A Roma l’Avvocatura Generale, negli altri tribunali le avvocature distrettuali in ogni distretto di Corte d’Appello. La difesa è al massimo livello, ma l’impresa è disperata: l’Italicum è come il Porcellum. O la Corte Costituzionale rinnega i principi della sentenza n. 1/2014 o la sua sorte è segnata. Al ballottaggio si accede senza una soglia in voti o seggi e il premio di maggioranza è sempre di 340 seggi che si abbia il 40% o si acceda al ballottaggio con il 25%: il premio è inversamente proporzionale al consenso elettorale e prescinde anche dalla percentuale dei votanti.
Sospetta una pressione per rallentare l’esito dei ricorsi in vista del referendum e del primo dibattimento alla Consulta?
Vediamo se continua l’inerzia. Se non succede nulla solleveremo la questione facendo presentare interpellanze o interrogazioni in parlamento.
Si legge che il governo intende fissare il referendum prima dell’udienza alla Consulta.
Il Governo ha tentato invano di far celebrare il referendum in giugno in coincidenza con le amministrative perché non vuole che gli elettori siano informati. L’abbiamo impedito con la raccolta delle firme che ci ha consentito tre mesi di tempo in più. Se si vota il 2 ottobre, la prima data utile, è per evitare un voto informato: due mesi, luglio e agosto, di vacanza, la prima settimana di settembre di rientro. Di fatto ventuno giorni scarsi per la campagna. Volere la votazione due giorni prima della decisione della Corte Costituzionale è un segno di debolezza.
D’altra parte la Presidenza del Consiglio è informata di ogni passo da noi fatto nella quindicina di Tribunali. Gli avvocati dello Stato, che sono ottimi professionisti, hanno informato il governo dei rischi. C’è un nostro motivo di ricorso che può far cadere l’intera legge: alla Camera è stata approvata con un voto di fiducia, cioè con un procedimento speciale vietato dall’art. 72 della Costituzione per le leggi in materia elettorale e costituzionale. Legge elettorale e deforma costituzionale sono strettamente legate. Non sarebbe un buon viatico per il Sì al referendum un pronunciamento negativo sulla legge elettorale.
Quali sono le possibili conseguenze del referendum?
Se vince il Sì il Senato non sarà più eletto dai cittadini direttamente, ma dai consigli regionali. A differenza di quanto molti pensano, il Senato non è stato abolito. E’ stata abolita la democrazia nell’elezione del Senato. Se vince il No il Senato sarebbe eletto con una legge elettorale non proporzionale, ma con soglie di accesso alte, cioè l’8% per le liste singole e il 20% per le coalizioni. Ma tutto dipende da cosa decide la Corte Costituzionale, se i giudici si svegliano. Se salta la deforma costituzionale tuttavia non sta in piedi nemmeno la legge elettorale pensata solo per la Camera dei Deputati.
Secondo lei il governo potrebbe mettere mano all’Italicum prima delle prossime elezioni politiche?
Dipende da come vanno i ballottaggi del 19. Se Renzi li perde tornerà il premio alle coalizioni.
Uno degli argomenti del Sì è la stabilità di governo. Se vincono i no – dicono – ci sarà il caos. Come risponde?
Un governo che non risolve la crisi economica e toglie il diritto di voto per il Senato è meglio che se ne vada. Il governo deve terrorizzare gli elettori perché non ha altri argomenti.
Siamo sopravvissuti a 63 primi ministri, sopravviveremo a 64.
 «Ci dicono che tutto questo servirebbe a “modernizzare” il Paese e a governarlo. Ce lo siamo sentito dire già nell’era del decisionismo craxiano... poi ancora nel ventennio berlusconiano. Ma se alla governabilità è sacrificata la democrazia non è difficile immaginare cosa ci aspetta».
«Ci dicono che tutto questo servirebbe a “modernizzare” il Paese e a governarlo. Ce lo siamo sentito dire già nell’era del decisionismo craxiano... poi ancora nel ventennio berlusconiano. Ma se alla governabilità è sacrificata la democrazia non è difficile immaginare cosa ci aspetta».
Micromega online, 19 giugno 2016 (c.m.c.)
Settanta anni fa l’Italia andava al referendum istituzionale per scegliere tra Monarchia o Repubblica, ed eleggere l’Assemblea Costituente.Si usciva dalla dittatura fascista che aveva trascinato il Paese nella guerra del terrorismo nazista.
La Resistenza era stata il riscatto da quella vergogna, e la svolta democratica arrivava in quel 2 giugno 1946, quando non più soggiogati nel “credere obbedire combattere”, gli italiani col loro voto facevano nascere la Repubblica e si impegnavano a costruirla nel patto sociale democratico.
Attraverso la Costituente, il Popolo sovrano si dava i principi e le regole attuative della Democrazia, che nella Costituzione ha la propria stella polare. Quella stella a cinque punte che è nello stemma della Repubblica italiana.
Il popolo sovrano l’aveva decretata con quel referendum del 1946, dove per la prima volta le donne non solo votavano, ma potevano anche essere elette in una consultazione nazionale: in ventuno entrarono nell’Assemblea Costituente.Lo Stato democratico era realtà istituzionale, e la Carta repubblicana ne poneva i principi e le garanzie nel nesso inscindibile di prima e seconda parte della Costituzione, per concretizzare libertà, giustizia, uguaglianza: per ciascuno e per tutti.
In questa prospettiva, guardando al futuro della tenuta democratica, i costituenti si sono preoccupati di fissare con precisione ruoli e compiti dei poteri dello Stato, onde evitare derive autoritarie. Nella Repubblica parlamentare, nessun potere poteva essere fuori dal controllo democratico, perché al servizio della democrazia costituzionale.
E contro manomissioni costituzionali, nella rigorosa separazione dei poteri dello Stato, si istituivano pesi e contrappesi per l’equilibrio democratico e organismi di garanzia costituzionale. Primo tra tutti la Corte Costituzionale.
Quel 2 giugno 1946 iniziò questo percorso di democrazia.
E non vogliamo che venga interrotto da abusi su quanto stabilisce l’art. 138 della Costituzione, che prevede la revisione costituzionale, ma non certo la sua manomissione allargando a dismisura il potere del Governo a scapito della rappresentatività. Proprio quanto si prospetta con le attuali modifiche della Carta, profilando un inquietante cambiamento di fatto della stessa forma istituzionale dello Stato.
Quella che «non è oggetto di revisione» come con grande lungimiranza stabilisce l’art. 139.Diversamente, infatti, non è più revisione costituzionale, ma colpo di Stato.Questo pericolo fu già sventato dagli italiani nel 2006, bocciando al referendum la “riforma Berlusconi”.
Allora però il trasformismo del più grande partito di sinistra non era arrivato, a forza di metabolizzazioni in cambi di nome, finanche a perdersi l’anima della Costituzione repubblicana cambiandone ben 47 articoli.
Quando Napolitano era per il No
È interessante ricordare che, chi oggi sembra essere testimonial eccellente di queste modifiche, da Senatore della 14ª Legislatura, nella seduta n. 898 del 15/11/2005, dichiarava: «Quel che anch'io giudico inaccettabile è, invece, il voler dilatare in modo abnorme i poteri del Primo Ministro, secondo uno schema che non trova l'eguale in altri modelli costituzionali europei e, più in generale, lo sfuggire ad ogni vincolo di pesi e contrappesi, di equilibri istituzionali, di limiti e di regole da condividere».
E continuava: «il contrasto che ha preso corpo in Parlamento da due anni a questa parte e che si proporrà agli elettori chiamati a pronunciarsi prossimamente nel referendum confermativo non è tra passato e futuro, tra conservazione e innovazione, come si vorrebbe far credere, ma tra due antitetiche versioni della riforma dell'ordinamento della Repubblica: la prima, dominata da una logica di estrema personalizzazione della politica e del potere e da un deteriore compromesso tra calcoli di parte, a prezzo di una disarticolazione del tessuto istituzionale; la seconda, rispondente ad un'idea di coerente ed efficace riassetto dei poteri e degli equilibri istituzionali nel rispetto di fondamentali principi e valori democratici».
È questione cogente ancora oggi quella che poneva allora saggiamente Giorgio Napolitano, perché non si arrivi alla notte della Repubblica parlamentare.
La Costituzione innanzitutto
Ecco allora che il popolo sovrano si deve riappropriare della sua piena sovranità, perché la Costituzione continui ad essere la stella polare sopra la testa di tutti e non ostaggio di una maggioranza di turno, che per altro cerca di blindarsi al potere con l’ultrapremiale legge elettorale, varata dopo che il porcellum è stato cassato dalla Corte costituzionale.
È il controverso Italicum, pure esso in odore di anticostituzionalità (Cfr: Libero Pensiero, n°75, marzo 2016). Ci dicono che tutto questo servirebbe a “modernizzare” il Paese e a governarlo. Ce lo siamo sentito dire già nell’era del decisionismo craxiano... poi ancora nel ventennio berlusconiano.
Ma se alla governabilità è sacrificata la democrazia non è difficile immaginare cosa ci aspetta.Di regresso in regresso, di defezione in defezione costituzionale, torneremo al monarca assoluto?

Micromega online, 17 giugno 2016 (c.m.c.)
Durante le ultime settimane, il dibattito pubblico sul lavoro è stato investito da due proposte provenienti dagli ambienti industriali e dal campo degli economisti liberal. Al Festival dell’economia di Trento, Andrea Ichino ha presentato uno studio – condotto con Tito Boeri e Enrico Moretti – sulle ricadute del sistema di contrattazione nazionale sull’aumento delle disuguaglianze. Solo pochi giorni dopo è toccato invece al presidente dei Giovani Industriali, Marco Gay, puntare il dito contro le disfunzioni del sistema redistributivo e previdenziale italiano, colpevoli a suo dire di frenare la crescita economica e i livelli occupazionali.
Le due proposte riflettono una visione comune nell’attribuire al sistema della contrattazione nazionale e ai meccanismi redistributivi e solidaristici che essa implica, un ostacolo al miglioramento dell’economia generale e la conseguente ricaduta (negativa) sui livelli di reddito dei lavoratori. Nello studio presentato da Ichino, l’indice viene puntato sull’inefficienza di un regime non abbastanza differenziato di salari nominali, che unendo il paese da Nord a Sud, svantaggerebbe proprio i lavoratori del Nord costretti a far fronte ad un costo della vita più alto, principalmente dovuto al più elevato costo delle abitazioni.
A giustificazione della necessità di introdurre una volta per tutte la cosiddette “gabbie salariali”, intese dagli autori della ricerca come strumento di riequilibrio delle disuguaglianze tra lavoratori (sic!), viene utilizzato – come da tradizione liberista- il mantra della produttività, funzione esclusivamente del lavoro e non anche del sistema produttivo nella sua interezza.
L’analisi suggerisce, inoltre, che il connubio tra la bassa produttività dell’economia meridionale e salari nominali troppo elevati siano causa dell’elevato tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno.
Tuttavia, i risultati empirici della ricerca citata si basano, oltre all’approccio teorico di riferimento, su un indicatore, diverso da quello comunemente usato dall’Istat e, creato dallo stesso Moretti, per correggere le variabili monetarie legate alle abitazioni rispetto al valore dei prezzi a livello locale. Una scelta si direbbe, e infatti gli autori omettono di presentare i risultati utilizzando il deflatore standard dell’Istat, negando quindi la possibilità di valutare se e in che misura la scelta del deflatore sia neutrale oppure determini i risultati ottenuti e la loro magnitudine.
Gli autori inoltre, assumono che nelle diverse regioni, gli abitanti spendono in media quote di reddito identiche per il consumo di beni e servizi pubblici. L’unica differenza è la qualità dei servizi e il costo degli stessi, caratteristiche entrambe inferiori al Sud. Una valutazione che confligge con la realtà, dal momento che al Sud i servizi non soltanto sono mediamente inferiori in termini di qualità, ma soprattutto quantitativamente. Basti pensare alla differenza nella copertura di asili nido tra la Calabria e l’Emilia Romagna, oppure nella copertura del trasporto pubblico tra la Sicilia e il Piemonte.
Gli autori sembrano ignorare innanzitutto i fattori di lungo periodo che spiegano i divari regionali e le debolezze del tessuto economico e produttivo del Sud Italia. Si esclude ogni riferimento alla storia industriale del Meridione, perseverando nell’idea che alle divergenze territoriali bisogna far fronte comprimendo il costo del lavoro e non invece stimolando, in modo antistorico lo sviluppo industriale e la domanda aggregata, cioè la crescita e di conseguenza la produttività.
Convinzioni di senso comune tra gli industriali italiani. Un esempio tra tutti, il Presidente di Federmeccanica, Massimo Franchi, che intervenendo a un convegno sul mercato del lavoro tenutosi a Pisa in aprile, alla parola produttività più volte ripetuta non ha mai affiancato il concetto di investimenti, né tanto meno una loro declinazione concreta relativa ai settori e ambiti di potenziale intervento.
Ignorare un fatto macroscopico come la presenza strutturale del lavoro nero, funzionale alla stabilizzazione degli assetti economici e politici del Meridione, rischia di ribaltare il rapporto tra causa ed effetti, perdendo di vista il ruolo che l’economia sommersa continua a svolgere nel Sud Italia in termini di concorrenza sul costo del lavoro e sull’andamento della produttività.
Storicamente, il lavoro nero è stato creato e mantenuto da un lato per conservare un preciso assetto di potere e come fattore per comprimere i salari dell’economia formale e, dall’altro, per ridurre lo stimolo, anche per questa via, ad investire, aumentando la produttività. Quindi è il lavoro nero a fermare la produttività e i salari (ad esempio attraverso la non applicazione dei minimi contrattuali e all’assenza di una contrattazione territoriale).
Il quadro analitico proposto nasconde evidentemente un obiettivo preciso che riguarda l’attacco all’impianto della contrattazione nazionale, a favore di un regime flessibile che assegna al rapporto diretto tra aziende e lavoratori le decisioni principali sull’organizzazione del lavoro, sugli standard salariali e normativi. Si tratta di un tentativo di suggerire al governo un’ulteriore accelerazione sul piano delle riforme strutturali, svuotando l’istituto della rappresentanza democratica del lavoro, attraverso la cancellazione dell’ultimo presidio a tutela degli interessi della parte debole.
Davanti all’aumento della caduta dei redditi di lavoro della fascia più debole, in buona parte dovute ai processi di flessibilizzazione del mercato del lavoro (e l’uso distorto del part-time), la risposta dei nuovi pasdaran liberisti è la rottura del contratto sociale e l’approdo ad una società au delà du contrat, parafrasando Robert Castel. Una frattura che investe quindi l’insieme dell’ordinamento democratico, ridefinendo la cornice costituzionale del lavoro in un terreno del tutto nuovo, in cui si considera il rapporto di forza tra impresa e lavoratori non più sbilanciato, ma sostanzialmente paritario.
Una prospettiva che trova nelle parole del presidente dei Giovani Industriali un’ulteriore conferma, quando allude ad una riforma del sistema fiscale. “Via il fisco che tassa i dipendenti anche quando non si fanno profitti”, il monito del giovane presidente degli Industriali – prefigura un impianto del fisco teso a garantire prioritariamente alle imprese il perseguimento di margini di profitto, non riconoscendogli nessuna funzione sociale.
Ne è un esempio l’utilizzo sfrenato degli incentivi all’assunzione a “tempo indeterminato” a cui non è corrisposto un valido impegno nella creazione di nuovi posti di lavoro da parte delle imprese. L’idea di una spesa pubblica funzionale alle imprese piuttosto che alla questione sociale, drammaticamente peggiorata nell’ultimo decennio, pare essere un tema condiviso tra Confindustria e il governo.
Basti pensare alla proposta sulla flessibilità in uscita per le pensioni tratteggiata dal governo che non mette in discussione la riforma Fornero e in cui, da un lato, viene escluso l’intervento delle finanze pubbliche e, dall’altro, il diritto a una pensione anticipata viene subordinato all’istituzione di un mutuo che prevedere il pagamento di interessi agli istituti di credito (privati). Non a caso, per gli sgravi sul costo del lavoro si invocava la necessità di puntare sulla flessibilità rispetto ai vincoli europei, mentre nel caso delle pensioni, il Sottosegretario Nannicini richiama l’esigenza di rispettare i vincoli di bilancio.
Viene svuotato di fatto il principio della solidarietà fiscale, che aveva costruito la base dello stato sociale, rovesciando la funzione del fisco da garante dell’esercizio dei diritti costituzionali (salute, istruzione, accesso ai beni pubblici) a guardiano degli interessi dell’impresa. La richiesta di rovesciare i meccanismi redistributivi a vantaggio degli interessi forti è un suggerimento al governo a continuare quella politica di riforme, a quanto pare solo abbozzata con il Jobs Act e la proposta di riforma della Costituzione.
La prospettiva assume quindi i tratti di un tentativo di ridefinire un nuovo impianto costituzionale, che prevede la “messa a valore” del pubblico e lo spostamento dell’esercizio della sfera di giurisdizione dallo stato al mercato, il solo che competerà nella definizione dei diritti stessi dei cittadini.

«». La Repubblica, 18 giugno 2016 (c.m.c.)
Nel dibattito e nella cultura politica del Regno Unito ci sono certe realtà ineludibili su cui faremmo bene a riflettere.
La prima è che, nonostante tutti i meritati elogi per Jo Cox sulla stampa, buona parte dei nostri mezzi di informazione si dedica instancabilmente ad aizzare il pubblico contro i suoi rappresentanti eletti. Editoriali lasciano intendere regolarmente che qualsiasi aumento di stipendio per i parlamentari è uno spreco di denaro pubblico. E che “nessuno” mantiene le promesse fatte.
Se queste opinioni vengono propagate così spesso, possiamo davvero sorprenderci se fanno presa? C’è una sorta di nichilismo nei confronti della politica, un nichilismo che i necrologi di un giorno non basteranno a cancellare. La sensazione trasmessa è che Jo fosse un’eccezione, che è un modo sottile per confermare questa visione dei nostri parlamentari, invece di smentirla. «Jo non era una politica normale», ho sentito dire alla Bbc. Invece lo era. La verità è che la maggior parte delle persone che fanno politica è gente per bene che fa del suo meglio secondo i propri valori.
La seconda verità ineludibile — e sono consapevole che la campagna referendaria è stata sospesa, ma credo che vada detto — è che la campagna in corso ha scatenato nel nostro dibattito politico un odio incontenibile. In questa campagna, alimentata dai pregiudizi e dalle distorsioni dei giornali, dalla rabbia dei social media e dalla sensazione che i politici devono gridare sempre più forte se vogliono farsi ascoltare, hanno assunto un ruolo centrale l’odio e lo svilimento degli avversari e un ruolo troppo marginale la capacità della politica di offrire una visione efficace del futuro e di discutere in modo civile.
La mia speranza, pur nel poco tempo che resta prima del referendum, è che tutto questo possa cambiare. È di sentire i nostri leader politici parlare meno di statistiche e di più di che tipo di Paese stiamo diventando e che tipo di Paese potremmo essere.
Nei nostri partiti, conservatori e laburisti, la parola odio è stata fin troppo preponderante nel dibattito sul nostro futuro dentro o fuori dall’Unione Europea. Persone schierate sulla stessa posizione che non vogliono fare campagna insieme. Amici dello stesso partito che ora si danno a vicenda del bugiardo. Ma soprattutto la deliberata creazione di odio verso chi viene da fuori, con una questione complessa come l’immigrazione trattata non come un problema da affrontare, ma come un tema da sfruttare.
L’ultimissimo tweet di Jo diceva: «L’immigrazione è una preoccupazione legittima. Non è una ragione per abbandonare l’Ue». L’altroieri Nigel Farage ha lanciato un manifesto elettorale. C’è sopra la foto di un’imponente coda di persone con la pelle scura che lasciano la Siria e si dirigono verso la Slovenia.
Il messaggio è chiaro: queste persone stanno venendo qua, è colpa dell’Unione Europea e solo un voto per il “Leave” (uscire dall’Ue) il 23 giugno potrà fermarle. È un manifesto orribile, disgustoso. Se vuole che le condoglianze che ha twittato abbiano un sen- so, Farage dovrebbe rimuovere quel manifesto e chiedere scusa. Ma è un problema che va oltre la frangia minoritaria che Farage rappresentava finora.
L’intera campagna, mi sembra, ha puntato sulla generazione di sentimenti “anti”: anti-élite, anti-“esperti”, anti- politica, anti-realtà, il tutto in favore della rabbia e dell’emozione. Jo Cox si batteva per molte delle cose buone. Si batteva perché il mondo aprisse gli occhi su quello che sta succedendo in Siria e facesse di più per affrontare il problema.
Si batteva perché la Gran Bretagna si impegnasse per un approccio razionale, equo, umano all’immigrazione. Si batteva per la speranza contro l’odio e per la politica democratica come via per cambiare il mondo per il meglio. Se vogliamo che la sua morte abbia qualche valore facciamo in modo che una parte della sua eredità sia un genuino e duraturo apprezzamento della politica e dei politici come forza positiva.
 «L’Ong rifiuta 63 milioni di euro dall’Europa per protesta verso la politica dei respingimenti. È una pesante denuncia politica di tutta la politica europea sui migranti, imperniata appunto sull’accordo con la Turchia dello scorso 20 marzo».
«L’Ong rifiuta 63 milioni di euro dall’Europa per protesta verso la politica dei respingimenti. È una pesante denuncia politica di tutta la politica europea sui migranti, imperniata appunto sull’accordo con la Turchia dello scorso 20 marzo».
Il manifesto, 18 giugno 2016 (m.p.r.)
La parola shame, vergogna, ricorre più volte nel comunicato con cui ieri Medici senza Frontiere dà l’addio a tutti i finanziamenti, e alle relative collaborazioni con le istituzioni europee, per l’applicazione dell’accordo Ue-Turchia sui migranti.
«Per mesi Msf ha denunciato la vergognosa risposta europea, concentrata sulla deterrenza invece che sulla necessità di fornire alle persone l’assistenza e la protezione di cui hanno bisogno», ha detto in conferenza stampa a Bruxelles Jérôme Oberreit, segretario generale internazionale di Medici Senza Frontiere, organizzazione premio Nobel per la pace 1999, per spiegare come è arrivato il gesto del gran rifiuto.
Un gesto effettivamente eclatante perché - anche se la portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas è corsa a dire, cercando di ridimensionarne l’impatto, che «Msf non è un partner attuativo dell’aiuto umanitario in Turchia, né ha fatto richiesta di finanziamenti per le sue attività in Turchia, di conseguenza la decisione non colpirà alcuna attività umanitaria per i profughi in Turchia» - l’organizzazione ha deciso di rifiutare 63 milioni di euro che gli venivano dall’Unione europea e dagli stati membri. Si trattava, nel bilancio dello scorso anno, di 37 milioni di fondi provenienti dagli stati Ue e di 19 milioni di euro direttamente erogati dalle istituzioni comunitarie di Bruxelles.
Il blocco dei fondi europei avrà effetto immediato e si applicherà ai progetti Msf in tutto il mondo. Il budget si ridurrà ma non intaccherà la solidità dell’ong, visto che il 92 per cento dei fondi che gli consentono di fornire aiuti medici e servizi, dai soccorsi per le catastrofi naturali alla gestione di interventi di emergenza in zona di guerra, gli arrivano da risorse private, dai grandi mecenati alle piccolissime donazioni mensili di singoli cittadini.
Il rifiuto di questi soldi è una pesante denuncia politica di tutta la politica europea sui migranti, imperniata appunto sull’accordo con la Turchia dello scorso 20 marzo. Il 49enne segretario generale Oberreit, che viene da esperienze decennali in Africa, lo ha detto chiaramente: il patto tra Europa e Turchia costituisce un precedente pericoloso per gli altri Paesi che ospitano rifugiati, come dimostra la proposta fatta settimana scorsa dalla Commissione europea di replicare la logica del patto in altri 16 paesi africani e mediorientali con i cosiddetti European compact.
Questi accordi ispirati a quello con Erdogan - ha scandito Oberreit - «hanno l’unico scopo di negare il diritto d’asilo» e rischiano di bloccare in Eritrea, Afghanistan, Sudan e Somalia – i quattro paesi che forniscono la maggior parte del flusso di profughi insieme alla Siria – le persone in fuga dai conflitti armati. Il giudizio durissimo, senza appello, di Msf sull’accordo Ue-Turchia è che «mette in forse lo stesso concetto di rifugiato e asilo». E perciò Msf non risparmia neanche la Grecia, dove 50 mila profughi siriani sono ancora accampati in condizioni vergognose tra ruderi di palazzi e tende, in attesa di un improbabile ricollocamento nei paesi più sviluppati del Nord Europa o addirittura di essere rispediti indietro, oltre la frontiera turca ora tendenzialmente sigillata.
«Chiediamo ai governi europei di rivedere le priorità: invece di massimizzare il numero di persone da respingere devono massimizzare il numero di quelle che accolgono e proteggono», ha chiesto Oberreit. «Il patto Ue-Turchia è stato presentato come una risposta umanitaria ed è questo che noi rifiutiamo perché in realtà si tratta di una risposta anti-umanitaria», ha aggiunto Aurelie Ponthieu, consigliera per le migrazioni di Msf.
Ieri il ministro greco alle Migrazioni Ioannis Moulazas, prima di incontrare con Alexis Tsipras il segretario generale Onu Ban Ki-moon in visita di due giorni ad Atene e Lesbo proprio per verificare il rispetto dei diritti umani dei migranti bloccati in Grecia - ha reiterato in tv la richiesta ai vicini turchi di vigilare sulle frontiere e arrestare i migranti che intendono attraversarle, dopo che negli ultimi due giorni almeno 200 persone sono tornate a tentare la traversata dell’Egeo. Il Parlamento di Atene ha anche cambiato la costituzione della commissione preposta a rilasciare lo status di rifugiato: i due membri rappresentanti dell’Onu e della commissione nazionale diritti umani sono stati sostituiti con due magistrati. Ankara per tutta risposta ha arrestato 51 migranti – siriani e eritrei – in procinto di imbarcarsi per le isole greche. Tra questi 13 donne e nove bambini.
Lady Pesc, Federica Mogherini ha detto che la Ue è pronta a sostenere missioni europee in Niger e Mali per cooperare con questi paesi a Sud della Libia a una «gestione integrata dei controlli alle frontiere». Ad Agadez in Niger – il più grande mercato per la tratta e i trafficanti di merce umana del continente – esistono già uffici di Frontex e si sta insediando una missione congiunta Ue-Unione africana. E mentre il Kenya, in ottemperanza alle nuove direttive di respingimento europee, ha deciso di chiudere il mega campo profughi di Dadaab ricacciando in Somalia 330 mila sfollati di vent’anni di conflitti tra i signori della guerra, in Mauritania rischiano lo stesso destino i 41 mila maliani che continuano a ingrossare il campo di Mbera.

Immigrazione. Secondo il presidente dell'Inps è totalmente infondato il timore che i migranti possano assorbire tutte le risorse del welfare: "versano ogni anno 8 miliardi di euro nelle casse del sistema di sicurezza sociale e ne prelevano 3 sotto forma di pensioni e prestazioni sociali"». Il manifesto, 17 giugno 2016
Gli economisti seri lo sanno, gli immigrati che lavorano in Italia sono come un dono per le casse disastrate del nostro paese. Perché versano contributi e magari lasciano l’Italia prima di poter ricevere la pensione, oppure perché lavorano e nemmeno sanno di avere questo diritto. Secondo il presidente dell’Inps Tito Boeri questo «dono» vale quasi 1 punto di Pil.
Con una visione europea della sicurezza sociale che manca a tutti i governi del vecchio continente che si sta sgretolando sotto i colpi della crisi, il presidente dell’Inps ieri è intervenuto a Verbania al seminario organizzato dalla Cisl intitolato I giovani, le donne e l’Inps tra presente e futuro anche per dire che gli immigrati non sono un pericolo ma piuttosto una risorsa fondamentale per ripensare un’altra idea di welfare e di Europa.
«Il timore che i migranti possano assorbire tutte le risorse del welfare è una visione inesatta. Loro versano, ogni anno, 8 miliardi alle casse del sistema di sicurezza sociale e ne prelevano sotto forma di pensioni e prestazioni sociali circa tre, con un saldo attivo di cinque miliardi di euro». Col tempo questo saldo è destinato a diminuire ma, come spiega Boeri, «molti migranti che hanno lavorato per noi pagando i contributi poi sono tornati nel loro paese senza mai percepire un euro. Noi vogliamo monitorare meglio queste situazioni con gli altri paesi». Insomma, bisognerebbe ringraziarli.
I dati del rapporto Worldwide Inps presentato lo scorso anno parlano chiaro. Gli stranieri nati prima del 1949 che hanno versato contributi senza ricevere la pensione sono 198.430 (il 21% del totale): più di 3 miliardi di euro regalati allo stato italiano. Poi ci sono 4,2 milioni di posizioni contributive che hanno già erogato contributi – che valgono più di 56 miliardi – e che non sono ancora arrivate a maturare i requisiti di vecchiaia. Negli ultimi anni gli stranieri versano mediamente tra i 7 e gli 8 miliardi di euro all’anno. «Se anche solo il 5% di questi contributi non dà luogo a prestazioni – disse lo stesso Boeri a commento del rapporto – si ha un flusso di free riding annuale di circa 375 milioni di euro, che si capitalizza nel corso del tempo». Quindi è falso dire che non ci sono risorse per investire sulle politiche di integrazione per gli stranieri.
L’Inps, ha detto Boeri, si sente saldamente in Europa e ha annunciato un’iniziativa per dare un contributo a questo senso di comunità: «Abbiamo chiesto ai nostri omologhi in tutta l’Unione di rafforzare il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e di condividere informazioni sui lavoratori che si spostano da un paese all’altro, istituendo un unico numero di sicurezza sociale».
Più diritti dunque, compreso quello di varcare quei confini che non sono mai stati così blindati. «Questa iniziativa – ha aggiunto il presidente dell’Inps – potrebbe anche rappresentare un senso di appartenenza e consentirebbe di mettere in atto il principio della libera circolazione in Europa, senza alcuna perdita di diritti che sono stati acquisiti in qualcuno di questi paesi». Dunque, economia politica per l’integrazione: «Il fatto di dover monitorare la mobilità dei lavoratori, seguendoli, serve pure a vincere molte delle preoccupazioni che ci sono e che danno luogo a delle spinte centrifughe».
Se prevalesse la razionalità sulla gestione dei fenomeni migratori, paure non dovrebbero essercene.
 «Sinistra. L’arma pedagogica è spuntata. Più proficuo rivolgersi alle centinaia di associazioni e movimenti auto-organizzati. Come agli albori del socialismo europeo». Il manifesto, 24 giugno 2016 con postilla
«Sinistra. L’arma pedagogica è spuntata. Più proficuo rivolgersi alle centinaia di associazioni e movimenti auto-organizzati. Come agli albori del socialismo europeo». Il manifesto, 24 giugno 2016 con postilla

 .
. 

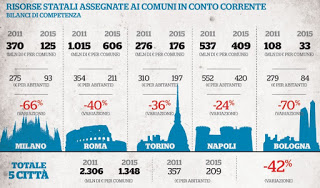












 «Ci dicono che tutto questo servirebbe a “modernizzare” il Paese e a governarlo. Ce lo siamo sentito dire già nell’era del decisionismo craxiano... poi ancora nel ventennio berlusconiano. Ma se alla governabilità è sacrificata la democrazia non è difficile immaginare cosa ci aspetta».
«Ci dicono che tutto questo servirebbe a “modernizzare” il Paese e a governarlo. Ce lo siamo sentito dire già nell’era del decisionismo craxiano... poi ancora nel ventennio berlusconiano. Ma se alla governabilità è sacrificata la democrazia non è difficile immaginare cosa ci aspetta». 


