
Internazionale
.online, 25 settembre 2016 (c.m.c.)
La morte di Abd Elsalam Ahmed Eldanf, operaio della ditta di logistica Gls ucciso da un camion della stessa azienda durante un picchetto, dovrebbe far emergere definitivamente la questione di un modello produttivo pensato al massimo ribasso dei diritti. Sebbene la notizia sia ormai stata derubricata dai giornali e la procura di Piacenza abbia imposto sull’accaduto una ricostruzione di dubbia credibilità, i fatti ci riportano a considerazioni più generali.
Le cause di questa morte vanno rintracciate in un conflitto che vive in un nuovo modello dell’organizzazione industriale e della sua filiera, dalla produzione al consumo. Provare a mettere in ordine questi argomenti è un esercizio che conduce alla complessità delle dinamiche sociali.
In un’economia funzionale al consumo e all’ibridazione tra consumo e produzione, la logistica ha un ruolo semplice: è interpretata come mero tassello utile alla fruizione del consumo stesso, che va assicurato a ogni costo. Ordino un prodotto online, deve arrivarmi il prima possibile.
L’unica cosa che conta
Nel processo produttivo – quello che va dalla produzione fisica alla vendita al dettaglio – la logistica è quel settore intermedio che consente il passaggio dei beni dai magazzini al negozio oppure, ormai sempre più di frequente, direttamente nelle nostre case. Nell’epoca dei feedback, della tracciabilità e delle promozioni sui costi di spedizione, è necessario che tutto sia puntuale, che la merce giunga a destinazione in modo efficiente, così da rendere il cliente soddisfatto delle sue scelte di acquisto. Questo vuole l’azienda che vende; perché questo massimizzerà la fiducia dei clienti permettendo di aumentare nel tempo le vendite, quindi gli utili.
L’unica cosa che conta sono i risultati, non come questi siano stati raggiunti. Si definisce così una netta separazione tra l’individuo consumatore e la società. Il consumatore vuole consumare e risparmiare: l’acquisto in tre click e il fattorino che bussa alla porta di casa. Il processo che intercorre tra questi due momenti è appunto utile alla soddisfazione privata.
Non è un caso che risulti secondario, se non del tutto indifferente, per il consumatore, in che modo i piccoli venditori e i grandi colossi del commercio siano in grado di praticare costi di spedizione minimi o addirittura nulli. Raramente si entra in contatto con un operatore della logistica, che sia un facchino, un magazziniere o un autotrasportatore.
Sotto la retorica della modernità edonistica, del “direttamente sul tuo divano”, si rafforza l’alleanza tra logica del consumo e progressivo impoverimento dei lavoratori. Scompare qualsiasi traccia che colleghi il momento della produzione con quello del consumo, cioè da una parte, il facchino che vende la sua forza lavoro per un tempo illimitato e, dall’altra parte, il consumatore che ne beneficia in un tempo brevissimo. Una rottura che chiude la possibilità della solidarietà e apre le porte alla pura estraneità: così funziona il capitalismo oggi.
Si assiste quindi a una rimozione forzata ma necessaria, in cui le miserie della sottoccupazione, del lavoro che ritorna anche a una dimensione schiavistica, sono assunte come inevitabili per conservare intatte le forme di consumo. Consumare si configura come l’unica fonte di identità. Le fabbriche di Dhaka, il lavoro minorile in Turchia, i facchini di Piacenza invece diventano strumentali al diritto-dovere del consumo, che per vivere e prosperare deve alimentarsi di una guerra tra poveri.
Allargando la lente, il settore della logistica emerge in tutta la sua ampiezza all’interno dell’organizzazione della produzione. Basta tener presente che già nel 2012 il volume d’affari di questo settore era stimato, tra i paesi dell’Unione europea, in 878 miliardi di euro, secondo uno studio riportato dalla Commissione europea.
Non stupisce se si considera che la logistica garantisce lo stoccaggio e la gestione dei magazzini delle catene commerciali, dei centri commerciali, dei magazzini e delle consegne delle piattaforme di e-commerce, della distribuzione sul territorio nazionale dei beni acquistati in appalti centralizzati dalle pubbliche amministrazioni.
Condizioni di semischiavitù
Dentro la catena della produzione la logistica occupa un ruolo centrale e non più residuale. La globalizzazione e l’aumento degli scambi al livello internazionale hanno reso necessario un ampliamento del settore legato al trasporto e l’immagazzinamento delle merci: oggi è più facile acquistare un prodotto dalla Romania e riceverlo in pochi giorni a casa, così come è normale produrre in Bangladesh e vendere in un qualsiasi negozio di una piccola città di (quasi) ogni paese.
Per renderlo possibile, le diverse fasi del processo produttivo hanno dovuto subire una netta trasformazione: dalla fabbrica che tiene insieme tutte le fasi della produzione alla frammentazione e all’esternalizzazione delle diverse funzioni che caratterizzano l’intero processo.
È avvenuta così la terziarizzazione dell’economia: le imprese produttrici hanno scoperto che gestire da sole la distribuzione dei loro prodotti implicava costi troppo elevati, soprattutto in un mercato globale. Altre imprese avrebbero potuto gestire l’immagazzinamento e il trasporto delle merci di più aziende, riducendo il costo unitario di ogni singolo prodotto trasportato. All’interno di questo schema, la logistica rappresenta allora il polo nevralgico su cui scaricare i costi del processo di accumulazione dei profitti.
La logistica, come settore di servizio, nasce e si consolida con l’obiettivo di minimizzare i costi tra il momento della produzione e quello della vendita: minori costi garantirebbero in teoria prezzi al consumo più contenuti, competitivi. Ma le aziende del settore logistico hanno anch’esse ovviamente l’obiettivo del profitto, al di là da quel che succede a monte e a valle della filiera.
Così il passaggio successivo è comprimere i costi, robotizzando alcune fasi e/o agendo sul costo del lavoro. Entrambi i meccanismi – frammentazione ed esternalizzazione da una parte, e robotizzazione dall’altra – producono un aumento del reddito dell’impresa e spesso non si escludono l’uno con l’altro. Al contrario, laddove non è possibile robotizzare, è con l’intensificazione dei ritmi di lavoro che si estrae ciò che un tempo sarebbe stato comunemente definito plusvalore.
Nel modello italiano, ma non solo, l’uso intensivo della forza lavoro è indipendente dalla dimensione delle aziende coinvolte. Al contrario, ad accomunare grandi colossi e medie imprese, nel tentativo di ridurre al massimo il costo del lavoro, c’è l’uso delle cooperative, che sono spesso cooperative di comodo. Il risultato è: condizioni di lavoro, dal salario all’orario di lavoro, sempre peggiori, in alcuni casi vicine alla semischiavitù.
La rappresentazione giornalistica delle morti sul lavoro ha spesso facilitato una sorta di scissione tra le cause scatenanti la tragedia e l’evento tragico in sé. I fatti raccontati con la puntualità della cronaca giornalistica hanno alimentato nell’opinione pubblica un sentimento di indignazione verso le tragedie consumate sui luoghi di lavoro, spostando però l’attenzione sulla dimensione emotiva e tralasciando più o meno volontariamente i fattori all’origine della tragedia.
Un’ombra copre l’analisi dei meccanismi che generano le morti bianche, privando l’opinione pubblica di un piano complessivo di osservazione. Questa tendenza del racconto giornalistico assume particolare interesse quando le morti sul lavoro investono un settore considerato ai margini del processo produttivo, come la logistica. In questo caso, infatti, la tendenza a identificare l’incidente sul lavoro come un’eccezione assume un portata ancora più vasta.
La negazione del conflitto
La logistica, infatti, è considerata come un processo periferico nell’ambito della produzione capitalistica. Le attività di stoccaggio, trasporto merci e gestione delle scorte rappresentano fasi “rimosse” di un processo produttivo che invece si compie e si materializza nell’esercizio del consumo.
Ma sotto il velo della versione del capitale, in cui il consumo assolve i tratti di una funzione liberatoria in grado di soddisfare l’appetito del consumatore, c’è la materialità di rapporti di produzione basati sulla messa a valore di ogni aspetto della vita umana. L’intensificazione dello sfruttamento nel settore della logistica diventa quindi il paradigma della trasformazione dei processi di accumulazione del capitale: e non si tratta solo della messa a valore della forza lavoro, ma riguarda anche la sfera della riproduzione sociale, ossia della nostra vita.
L’intensificazione dei tempi di lavoro, che è un tratto tipico dell’organizzazione del lavoro nel settore logistico, mette in soffitta qualsiasi distinzione temporale tra il piano dell’accumulazione dei profitti nella sfera produttiva (il tempo del lavoro) e quella riproduttiva (il tempo libero). Gli operatori della logistica sperimentano nel quotidiano della loro attività la totale privazione di un tempo di vita libero, rappresentando un esempio concreto dei meccanismi di funzionamento alla base del sistema capitalistico.
Gli orari di lavoro che si spingono fino alle dodici ore consecutive sono il tratto evidente del controllo esercitato dal nuovo modello di produzione e consumo. Inoltre, la separazione tra chi produce e chi consuma maschera anche l’impoverimento generalizzato dei lavoratori.
Un’elevata percentuale di chi lavora nella logistica è composta da immigrati a cui non è riconosciuta quella sfera riproduttiva, quel tempo libero, di cui invece gode, magari fittiziamente, il precariato italiano.
Anche in altre sfere produttive, in particolare nell’ambito del terziario (servizi, ristorazione, cura) e del lavoro cognitivo, il modo più semplice per fare profitti è il prolungamento dei tempi di lavoro. Ma da periferia del modello produttivo ad avanguardia delle nuove forme di sfruttamento, è proprio il settore della logistica che coinvolge sempre più persone, si espande, e diventa una chiave di lettura utile per riconoscere le contraddizioni di fondo del progetto neoliberista.
Le difficoltà del sindacato
Dall’introduzione del rapporto di lavoro interinale istituito dall’ex ministro del lavoro Tiziano Treu alla legge numero 276 del 2003 (legge Biagi) che introduce nel nostro ordinamento il lavoro in somministrazione, il settore della logistica è al centro di un processo progressivo di precarizzazione.
La competizione internazionale, basata sulla compressione dei costi, e la tendenza crescente del sistema delle imprese a esternalizzare alcune fasi della produzione, hanno coinciso con una serie di leggi che hanno lasciato ampio margine per frazionare l’organizzazione del lavoro. A fare le spese di questo processo è il settore della logistica, in cui si fa sempre più ricorso al subappalto di manodopera, spesso affidato a cooperative “spurie”, prive di quei connotati mutualistici riconosciuti dalla nostra costituzione.
E qui arrivano le difficoltà per i sindacati. Frammentare la produzione e l’organizzazione del lavoro ha alimentato una crescente difficoltà per le organizzazioni sindacali di costruire lotte unitarie. Si sono così create nel tempo delle divisioni nell’ambito del movimento sindacale, arrivando a una scissione di fatto tra sindacati di base, più vicini alle rivendicazioni dei lavoratori del settore, e sindacati confederali più attenti a salvaguardare un piano di mediazione generale con il sistema dell’impresa.
I sindacati non hanno saputo interpretare i tratti salienti della nuova divisione del lavoro
Questa separazione ha determinato la vera difficoltà nel cercare di ottenere contratti collettivi che possano tutelare l’intero comparto produttivo e i diritti dei lavoratori coinvolti. La marginalità della logistica e la sua espulsione progressiva da un piano di regole costituzionali ha accelerato quel processo di precarizzazione dei rapporti di lavoro, che sono all’origine delle tragiche notizie di cronaca.
Seppur con le dovute eccezioni, le grandi organizzazioni sindacali hanno registrato un limite evidente nella sottovalutazione delle nuove forme di organizzazione del lavoro funzionali agli obiettivi dell’accumulazione capitalistica. In particolare, non hanno saputo interpretare i tratti salienti della nuova divisione del lavoro, mancando di una visione complessiva sul funzionamento della macchina capitalistica. Hanno pensato di tamponare una slavina.
Si è accettato che produzione e consumo siano due dimensioni scisse, distanti, che non hanno a che fare l’una con l’altra. E la supremazia del diritto del consumatore all’acquisto della merce, come la distinzione gerarchica tra chi consuma e chi produce, hanno allontanato il sindacato dalla vera posta in gioco, che resta la messa in discussione dell’intero modello di sviluppo.
Da questa tendenza difensiva che privilegia la conservazione di una posizione di rendita per i sindacati, deriva l’incapacità di spostare la dimensione del conflitto verso l’insieme dell’organizzazione del lavoro per incidere invece su tutto il processo: produzione, logistica, vendita, consumo.
 In due articoli (Luisiana Gaita e Luca Fazio) i contenuti degli interventi che si sono succeduti al convegno che si tenuto ieri a Milano, organizzato dalla parlamentare europea Barbara Spinelli (Gue/Ngl).
In due articoli (Luisiana Gaita e Luca Fazio) i contenuti degli interventi che si sono succeduti al convegno che si tenuto ieri a Milano, organizzato dalla parlamentare europea Barbara Spinelli (Gue/Ngl).
Il Fatto Quotidiano online e il manifesto, 25 settembre 2016 (p.d.)
Il Fatto Quotidiano online
RIFUGIATI AMBIENTALI,
VIOLENZE E INQUINAMENTO.
MA SENZA ALCUN DIRITTO
di Luisiana Gaita
Scappano da conflitti per l’accaparramento delle risorse idriche o energetiche, fuggono dalla desertificazione e dal collasso delle economie di sussistenza locali. Distrutte da catastrofi naturali, ma anche da stravolgimenti indotti dall’uomo. Si chiamano ‘rifugiati ambientali’ e, a differenza dei profughi che arrivano dalle zone di guerra, non possono chiedere asilo politico e non hanno diritti. E benché l’attenzione internazionale si sia concentrata sulle centinaia di migliaia di persone che rischiano la vita per raggiungere le coste europee, le migrazioni ambientali sono in realtà per la stragrande maggioranza migrazioni interne. Secondo un rapporto presentato dall’Internal Displacement Monitoring Centre, nel 2015 i cosiddetti ‘sfollati interni’ sono stati 27,8 milioni (in 127 Paesi), costretti ad abbandonare la propria casa per catastrofi naturali, conflitti, violenze. Anche contro la loro volontà. Si tratta di 66mila persone al giorno.
Se ne è parlato in un convegno internazionale che si è svolto a Milano, intitolato ‘Il secolo dei rifugiati ambientali?’ e organizzato dall’eurodeputata Barbara Spinelli e dal gruppo Gue/Ngl, nel corso del quale scienziati, politici, medici, attivisti hanno confrontato analisi, proposte e politiche. Tra le cause che portano a conflitti e disastri ambientali, però, ci sono anche i fenomeni del land grabbing e del water grabbing (accaparramento di terra e acqua), i processi di ‘villaggizzazione’ forzata (che negli anni Ottanta hanno causato in Etiopia un milione di morti per carestia), e poi inquinamento, smaltimento intensivo di rifiuti tossici, scorie radioattive da bombardamenti.
Anche l’Italia fa la sua parte “contribuendo a sottrarre terre e risorse ai popoli più poveri del mondo, proprio mentre il presidente del Consiglio Matteo Renzi parla di un piano per l’Africa, la stessa che multinazionali ed Europa continuano a sfruttare” sottolinea Vittorio Agnoletto, membro del consiglio internazionale del Forum Sociale Mondiale e fondatore della Lega italiana per la lotta contro l’Aids. L’Italia come tanti Paesi europei, complici delle multinazionali dello sfruttamento delle terre, tutt’altro che tutelate da governi locali spesso corrotti.
I dati e le previsioni future
La principale differenza tra sfollati interni e rifugiati è che gli sfollati interni rimangono entro i confini del proprio Stato, mentre i rifugiati cercano protezione in un altro Paese. Ma cosa c’è alla base dei 27,8 milioni di sfollati interni del 2015? Guerre e violenze per 8,6 milioni di profughi, disastri ambientali per 19,2 milioni sparsi in 113 Paesi. Il Norwegian Refugee Council spiega che “nel corso degli ultimi 8 anni è stato registrato un totale di 203,4 milioni di spostamenti collegati ai disastri”. Come negli anni precedenti è stata l’Asia meridionale ed orientale ad essere la più colpita. In testa India (3,7 milioni di sfollati), Cina (3,6 milioni) e Nepal (2,6 milioni). Nel 2008-2014 hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni 157 milioni di profughi: circa un terzo della popolazione dell’Ue. L’Emergency events data base del Cred (Centre for research on the epidemiology of disaster) riporta che negli ultimi 20 anni sono state distrutte da catastrofi climatiche 87 milioni di case. Secondo un dossier di Legambiente, il numero dei profughi ambientali nel 2015 ha superato quello dei profughi di guerra. E c’è di peggio: “L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – ricorda Barbara Spinelli – ha dichiarato che entro il 2050 si raggiungeranno i 200-250 milioni di rifugiati ambientali, con una media di 6 milioni di persone costrette ogni anno a lasciare il proprio paese”.
Espropriazioni di terre e risorse
Ma non sempre è facile distinguere le migrazioni causate da calamità naturali, da quelle che hanno alla base da mutamenti ambientali indotti dall’uomo. Alla desertificazione, all’innalzamento dei livelli delle acque, all’inaridimento del suolo si aggiungono altri fenomeni:
land grabbing, sfruttamento e l’avvelenamento del suolo e delle acque causato dalla tossicità delle industrie agricola, mineraria e manifatturiera, oltre che dai bombardamenti con sostanze chimiche e radioattive.
È possibile fare marcia indietro? Grammenos Mastrojeni, coordinatore per l’eco-sostenibilità della Cooperazione allo Sviluppo, diplomatico e autore del libro L’Arca di Noè edito da Chiare Lettere è sicuro di sì, se si utilizzerà un approccio di cooperazione allo sviluppo ecostostenibile e di tutela dell’ambiente. “Le soluzioni ci sono – spiega Mastrojeni – e noi abbiamo iniziato a metterle in pratica con progetti in Senegal e Burkina Faso. Oggi si perdono 12 milioni di ettari di terreno all’anno “ma recuperare un ettaro di terreno nelle zone di emergenza costa 120 dollari”. Secondo il diplomatico sono diversi i vantaggi del recupero dei terreni, soprattutto se consegnati alla piccola agricoltura familiare. “Si crea un pozzo di carbonio – commenta – si protegge la biodiversità, si mantengono le capacità produttive di quella terra, oltre a creare reddito e lavoro per quelli che oggi sono costretti a migrare”.
Guerre e devastazione ambientale
La realtà attuale è però diversa. Tanto che dal dopoguerra a oggi bel 111 conflitti nel mondo sono da imputarsi a cause ambientali. Nel 2015 sono stati il Medio Oriente e il Nord Africa ad aver sostenuto gran parte del peso delle guerre, con 4,8 milioni di sfollati. Siria, Yemen e Iraq, da soli hanno rappresentato più della metà di tutti i nuovi sfollati interni da conflitto nel mondo. “Non è un caso se la maggior parte degli sfollati è in Africa, il continente più colpito dagli effetti dei cambiamenti climatici pur non essendo il maggior colpevole” ha spiegato Barbara Spinelli, ricordando che dal 2006 al 2010 quasi un milione e mezzo di siriani ha perso i mezzi di sussistenza ed è stato sfollato. Eppure né la Convenzioni di Ginevra né il Protocollo aggiuntivo del 1967 riconoscono lo status di chi fugge a causa di catastrofi ambientali nelle rispettive politiche migratorie nazionali. E la Commissione europea con il cosiddetto ‘approccio hotspot’, istituisce due categorie di migranti, i profughi di guerra (che hanno diritto di chiedere protezione internazionale) e i migranti economici (da rimpatriare), alla stregua dei quali sono considerati anche i rifugiati ambientali, pur fuggendo da condizioni invivibili.
Le responsabilità internazionali
E se Francesca Casella, direttrice per l’Italia di Survival International, il movimento mondiale per i diritti dei popoli indigeni sottolinea che “in Etiopia è in corso un violento accaparramento di terra che sta sfrattando le tribù della bassa Valle dell’Omo dalle terre ancestrali” riducendo migliaia di persone alla fame e alla disperazione, Vittorio Agnoletto racconta ciò che avviene in giro per il mondo “in nome dello sviluppo” e della modernità. Dietro cui ci sono (neppure troppo celati) gli interessi economici di Paesi, multinazionali e, spesso, di governi locali corrotti. L’Europa fa la sua parte. E anche l’Italia. Ad esempio con gli Accordi di partenariato economico (Epa) con cui si chiede ai Paesi Acp (Africa, Caraibi e Pacifico) di eliminare tutti i dazi all’entrata di merci, prodotti agricoli e servizi europei. Gli effetti economici sui Paesi africani? In Burundi è stata calcolata in un anno la perdita complessiva di 20 milioni di dollari, che per il Niger è di 24 milioni. Poi c’è la questione della terra, degli ettari acquistati (spesso per la richiesta di bio-combustibili dall’Europa) e sottratti all’agricoltura. Tra le nazioni coinvolte c’è anche l’Italia che partecipa all’operazione con quasi un milione di ettari, principalmente in Africa. Cosa accade in quelle terre? “Il terreno acquistato che non produce più cibo rappresenta il 44% del totale”. Ne conseguono abbandono e migrazioni. “Così – conclude – ci occupiamo di Africa, prestando il fianco alle multinazionali”.
il manifesto
IL SECOLO BUIO DEI
RIFUGIATI AMBIENTALI
di Luca Fazio
Secondo l'Onu, entro il 2050 ci saranno più di 200 milioni di rifugiati costretti a fuggire non per un conflitto ma per disastri che non si possono più definire naturali. Tra gli obiettivi della giornata di lavori, una campagna a livello europeo per definire lo status giuridico del rifugiato ambientale nel diritto internazionale.
In Europa, e nel mondo, non sono previsti cambi di strategia per gestire il fenomeno delle migrazioni che sta destabilizzando economie e società di un pianeta violentato da uno sviluppo insostenibile.
Dove la guerra è il corollario dell’ideologia dominante. Per restare alla cronaca, lo dice il fallimento dei due summit sui rifugiati di Bratislava e New York (Onu). Tra gli indicatori del disastro, con la retorica di capi o capetti di Stato, c’è uno scandalo: in un anno l’Europa, 500 milioni di abitanti, ha ricollocato 5.290 rifugiati sui 160 mila previsti. Solo profughi di guerra, gli unici ad aver diritto all’asilo in virtù della distinzione tra chi fugge da un conflitto e chi emigra per motivi economici. Viste le premesse, sono ancora più urgenti le analisi fornite dai relatori del convegno Il secolo dei rifugiati ambientali? che si è tenuto ieri a Milano su iniziativa di Barbara Spinelli, parlamentare del Gruppo della Sinistra Europea (troppi gli interventi, moderati da Guido Viale, per poterne dare conto diffusamente).
Secondo l’Onu (Unhcr), entro il 2050 ci saranno circa 200-250 milioni di rifugiati ambientali, una media di 6 milioni di persone all’anno costrette ad emigrare non a causa di un conflitto. Il fenomeno è in corso ma interessa poco i media poiché, per ora, si tratta di “sfollati interni”: nel 2015 sono stati 27,8 milioni (in Siria 6 milioni e mezzo di persone sono profughi interni). Altri numeri danno un’idea più precisa del profilo di un profugo climatico e ambientale.
Negli ultimi venti anni, «il 90% delle catastrofi sono causate da fenomeni legate al clima, quali inondazioni, tempeste e siccità» (Onu). I morti sono stati 600 mila, le case distrutte 87 milioni: l’anno scorso gli sfollati per calamità sono stati 19,2 milioni, e nel periodo 2008-2014 157 milioni di profughi hanno abbandonato le loro abitazioni.
Se risulta evidente il legame tra devastazione ambientale e migrazioni, è logico che la politica continui a tacere sui fattori di “origine antropica”. La sua vocazione predatoria è il problema. François Gemenne, docente all’università di Versaille-Saint Quentin, ha scosso la sala dicendo «tutti noi siamo responsabili» (abbiamo un conto in banca e i nostri soldi servono a finanziare energie fossili).
Siamo entrati nell’era geologica dell’Antropocene, questa la tesi. «Gli uomini sono diventati la principale forza di trasformazione del pianeta, significa che la terra è diventata soggetto politico. Non tutta l’umanità è responsabile, la verità è che questa è l’età in cui pochi uomini trasformano l’ambiente». Significa ammettere che i disastri non sono opera del fato e che, considerate le conseguenze – le migrazioni – non ha senso la «dicotomia tra rifugiati e migranti». Non è una differenza giuridica ma eminentemente politica, «il rifugiato ambientale viene screditato perché altrimenti dovremmo riconoscere le persecuzioni che esercitiamo verso quelle popolazioni».
Depoliticizzare la questione significa essere complici: «I ricercatori lo sono perché hanno creduto di poter influenzare la politica, siamo stati degli idioti». Emilio Molinari, nel suo intervento su diritto all’acqua e profughi idrici, ha chiesto alla sinistra “libertaria e laica” se davvero tutto ciò è in cima ai “nostri” pensieri. Ha ricordato un rapporto del Pentagono del 2004 (era Bush), la pianificazione di un disastro: «Diceva che Usa e Europa diventeranno fortezze virtuali per respingere i profughi ambientali e che chi non saprà difendersi verrà travolto…». E l’acqua. Ne vengono imbottigliati 50 miliardi di litri ogni giorno, un campo da golf in Africa ne consuma come una città di 6 mila abitanti, un residence in Kenia ne fornisce 3 mila litri a stanza e agli abitanti 60 a famiglia, la coltivazione di rose in Kenia e in Etiopia per il mercato europeo – milioni di tonnellate – sta prosciugando i laghi e riduce le lavoratrici in condizione di schiavitù. Poi l’affondo: «Qui un sindaco non ripubblicizza l’acqua e poi apre uno sportello per le unioni civili e noi siamo tutti contenti». La sala applaude.
Jens Holm, deputato svedese, ha messo in relazione il consumo di carne e l’uso sconsiderato della terra. Per un chilo di proteine animali servono 5 mila litri di acqua, la produzione di carne su scala globale produce le stesse emissioni del traffico automobilistico – «ma nessuno lo dice» – e l’aumento vertiginoso della produzione di soia serve unicamente per la mangimistica animali, laddove la produzione costringe le popolazioni che ci abitano ad abbandonare le terre. Succede in Brasile. Di terra ha parlato anche Vittorio Agnoletto per dire che gli accordi commerciali (nella fattispecie Epa) e il fenomeno del land grabbing (l’acquisizione di terreni da parte di governi e società straniere) producono immigrazione. «Con questi accordi i paesi africani non possono imporre dazi per proteggere i loro prodotti e così le multinazionali vendono sottocosto distruggendo intere economie».
Il Burundi ha perso 20 milioni di dollari, il Kenia 24: «La Ue sta cercando di ottenere sproporzionati vantaggi da una delle zone più povere del mondo». Quanto al land grabbing, «sono già stati acquistati 44 milioni di ettari e in Africa quasi la metà del terreno comprato non produce più cibo».
L’Italia fa la sua parte (un milione di ettari acquistati). «Noi milanesi – ha concluso – riempiamoci di vergogna: ricordiamoci la carta di Milano dell’Expo, avrebbe dovuto cambiare il mondo…». Francesca Casella (Survival International) e Luca Manes (Re:Common) hanno sottolineato il caso emblematico della valle del fiume Omo (Etiopia) dove la costruzione di una diga sta generando una “catastrofe umanitaria” che coinvolge una popolazione di 500 mila persone.
Si è parlato anche di “approccio hotspot” bocciando senza appello la politica europea dei rimpatri. E di un aspetto giuridico di fondamentale importanza, visto che la Convenzione di Ginevra non riconosce lo status di chi scappa da catastrofi ambientali (unica eccezione: Svezia e Finlandia). Oltre agli aspetti di denuncia e informazione, questo è l’obiettivo del convegno: promuovere un’azione parlamentare a livello europeo per il riconoscimento della figura del rifugiato ambientale. Un cambio di prospettiva necessario per una missione che oggi sembra disperata.
 Da Merkel a Renzi a Schulz, Tutti uguali questi governanti europei: l'unico obiettivo comune è tener rinchiusi quanti vorrebbero sfuggire alla miseria e alla morte all'interno di ferrei recinti, campi di concentramento gestiti da carcerieri assassini.
Da Merkel a Renzi a Schulz, Tutti uguali questi governanti europei: l'unico obiettivo comune è tener rinchiusi quanti vorrebbero sfuggire alla miseria e alla morte all'interno di ferrei recinti, campi di concentramento gestiti da carcerieri assassini.
La Repubblica, 25 settembre 2016
UN MILIARDO ALL’EGITTO PER
TENERE I PROFUGHI
PARTELA TRATTATIVA TRA MERKEL E AL SISI
di Tonia Mastrobuono
«La cancelliera punta a un accordo sullo stile di quello firmato con la Turchia. E Il Cairo avverte: “Nel nostro Paese sono ammassati 5 milioni di rifugiati”. La leader tedesca al vertice di Vienna: “Pronti ad accogliere ogni mese in Germania centinaia di migranti da Italia e Grecia”»
L’EGITTO è la nuova polveriera dei profughi. E Angela Merkel ci sta lavorando. Soprattutto per ragioni di politica interna, per rivendersi con il suo elettorato in fuga un secondo accordo internazionale, dopo quello firmato con la Turchia, che limiti i flussi dei rifugiati. Per Al Sisi, una felice coincidenza. Il presidente egiziano vuole incassare almeno un miliardo di euro di aiuti dalla Ue e un prestito da dodici miliardi di dollari ancora in sospeso del Fmi. L’interesse crescente della cancelliera tedesca a concludere un’intesa con lui è una manna dal cielo.
La crisi dei profughi sta raggiungendo dimensioni preoccupanti anche nel Paese di Al Sisi, e molti indizi suggeriscono che la cancelliera si sia convinta che sia arrivato il momento che l’Unione europea elabori con il Cairo un accordo simile a quello sottoscritto l’anno scorso con la Turchia. Lo ha esplicitato anche ieri, dal vertice di Vienna con altri nove Stati dei Balcani, ribadendo che per limitare i flussi «occorre concludere accordi con Paesi terzi, specificamente in Africa, ma anche con il Pakistan o l’Afghanistan». Chi non ha il diritto di restare, ha aggiunto, «deve essere rimpatriato». «La Germania ha poi aggiunto Merkel - accoglierà ogni mese da Italia e Grecia centinaia di profughi con il permesso di soggiorno ».
Alla fine di agosto, l’allora viceministro degli Esteri egiziano, Hisham Badr, rivelò le presunte dimensioni allarmanti dell’emergenza profughi nel suo Paese e mandò un messaggio piuttosto esplicito all’Unione europea. Sono cinque milioni, sostenne, i rifugiati che si stanno ammassando nel Paese, fece sapere, mezzo milione dei quali provenienti dalla Siria. E l’Egitto spende 300 milioni all’anno per loro. Badr accompagnò quelle dichiarazioni con una critica esplicita alla Turchia, che avrebbe incassato sei miliardi dalla Ue, mentre l’Egitto no. E che manderebbe clandestinamente migliaia di siriani nel Paese di Al Sisi.
Durante un vertice con la cancelliera, raccontato da un’autorevole fonte parlamentare, Al Sisi le avrebbe chiesto dunque nei mesi scorsi un miliardo di euro per tenere sotto controllo i rifugiati. Ma al recentissimo G20 cinese, sia Merkel, sia la direttrice del Fmi, Christine Lagarde, avrebbero chiarito con il presidente egiziano un concetto: Il Cairo incasserà il prestito da dodici miliardi di euro del Fmi soltanto se manterrà i profughi sotto controllo.
L’intesa con Erdogan, modello per altre intese con i Paesi africani e asiatici, come Merkel ha chiarito ieri, sta funzionando, su quel tratto di costa (purtroppo, anche l’orrendo blocco dei muri lungo i Balcani). Nei primi nove mesi di quest’anno, secondo l’Alto commissariato per i rifugiati, 300mila persone hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere le coste europee, in primo luogo l’Italia. Molti meno dei 520mila dei primi nove mesi del 2015. Certo, i numeri delle partenze dall’Egitto non sono gli stessi della Turchia, e dunque anche i tempi non sono stringenti come quelli dettati dalle centinaia di migliaia di persone che si misero in marcia l’anno scorso verso l’Europa attraverso il Paese di Erdogan e poi proseguendo per i Balcani. Numeri che costrinsero la Ue a buttare giù e ad approvare frettolosamente un accordo con Erdogan. Dall’Egitto arrivano per ora un migrante su dieci che tenta la traversata del Mediterraneo. Ma si moltiplicano le morti, come risulta anche dai tragici incidenti dei giorni scorsi nel Mediterraneo. Soprattutto, per Merkel è importante dimostrare con i suoi nemici nel partito e con l’opinione pubblica che la scommessa di non mettere un tetto agli ingressi ma di puntare piuttosto a ridurre le partenze stringendo intese con i Paesi di origine, funziona.
Certo, per difendersi da una nuova ondata di critiche feroci che piovvero su di lei quando fece l’intesa con l’autocrate Erdogan, Merkel sta mandando avanti anche altri. Nei giorni scorsi, non a caso, è stato il presidente tedesco del Parlamento europeo, Martin Schulz, a caldeggiare un negoziato con Al Sisi. «Dobbiamo intraprendere questa strada», ha detto in un’intervista con la Sueddeutsche Zeitung, dopo l’ennesimo drammatico naufragio di una barca con 600 migranti a bordo davanti alle coste egiziane, mercoledì scorso.
Un’eventuale intesa con gli egiziani, ha sottolineato il tedesco, dovrebbe includere un impegno per la lotta ai trafficanti. E Schulz ha citato esplicitamente l’intesa con il Fmi. «Non si può chiedere un prestito di quelle dimensioni e rifiutare una collaborazione sulla questione migratoria », ha sottolinato. La trattativa è partita.
QUELLA ROTTA TRA L’ITALIA E IL CAIRO
OGNI ANNO UN BOOMDI RIMPATRI
di Alessandra Ziniti
Un terzo degli “irregolari” sono diciottenni, tutti partiti dal Paese nordafricano E le organizzazioni umanitarie attaccano: rispediti nel “buco nero” del regime
GLI ULTIMI dieci sono partiti dall’aeroporto di Catania due settimane fa: destinazione Il Cairo. E ad agosto altri 42 avevano fatto lo stesso viaggio in compagnia di una cinquantina di sudanesi riportati poi a Khartoum. L’andata stipati su un gommone fatiscente rischiando la vita nel Canale di Sicilia, il ritorno in aereo, con un foglio di espulsione in mano, guardati a vista dalla polizia italiana e riconsegnati poi a terra a quella di Al Sisi prima di finire risucchiati in quello che le organizzazioni umanitarie definiscono “the big black hole”, il grande buco nero.
Un migliaio nel 2015, diverse centinaia anche quest’anno. I rimpatri forzosi di migranti egiziani entrati irregolarmente in Italia proseguono “nonostante tutto”. È Christopher Hein, del Consiglio internazionale dei rifugiati, a dar voce alle preoccupazioni delle organizzazioni umanitarie. «Nonostante la pericolosa deriva del governo egiziano di Al Sisi, i rimpatri di migranti ritenuti irregolari verso il Cairo continuano, anzi hanno ripreso vigore e costituiscono senza dubbio il numero maggiore tra tutti i cittadini respinti. E questo desta grandissima preoccupazione perché se da un lato è vero che Italia ed Egitto hanno un accordo bilaterale molto consolidato in materia, è altrettanto vero che a noi risulta che questi rimpatri vengono spesso fatti con grande fretta, senza esaminare le singole posizioni come invece prevedono le norme europee e come ha ribadito la Corte europea dei diritti dell’uomo, ma soltanto basandosi sulla nazionalità di provenienza. E spesso a chi arriva dall’Egitto o dal Sudan e viene identificato negli hotspot non viene neanche dato il tempo di richiedere la protezione internazionale. E di loro, quando vengono riconsegnati alla polizia de Il Cairo non si sa più nulla».
Degli oltre 50 rimpatriati negli ultimi due mesi, un terzo sono appena diciottenni. Sbarcati in Italia negli anni scorsi, tenuti nei centri di accoglienza destinati ai minori e rispediti a casa appena diventati maggiorenni. Alcuni pure con una condanna sulle spalle perché i ragazzini dei villaggi costieri dell’Egitto, quasi tutti figli di pescatori che conoscono il mare e che le famiglie vorrebbero mandare in Europa in cerca di lavoro, vengono spesso “arruolati” dai trafficanti di uomini come scafisti, messi al timone di un barcone in cambio del viaggio gratis verso l’Italia, individuati, arrestati, condannati e poi rispediti a casa al compimento dei 18 anni anche se lì si diventa maggiorenni a 21.
«Anche tra i minori non accompagnati gli egiziani sono una altissima percentuale e tra i migranti in fuga dall’Egitto la maggioranza sono minorenni – dice ancora Hein – Purtroppo non abbiamo numeri né denunce circostanziate perché dal momento in cui rimettono piede sul suolo egiziano non possiamo più monitorarli, ma sappiamo bene che sono moltissimi quelli che finiscono in prigione e che scompaiono nel nulla e l’Italia e l’Europa non possono voltarsi dall’altra parte».
 «I dati macroeconomici dicono che la cura dell’austerità ha funzionato. Bassi salari, depressione della domanda interna, aumento delle esportazioni, crescita della povertà. L’Italia batte il record del calo della produzione industriale del 22% dal 2007». Insomma, i potenti sono più potenti, gli altri fottuti.
«I dati macroeconomici dicono che la cura dell’austerità ha funzionato. Bassi salari, depressione della domanda interna, aumento delle esportazioni, crescita della povertà. L’Italia batte il record del calo della produzione industriale del 22% dal 2007». Insomma, i potenti sono più potenti, gli altri fottuti.
il manifesto, 24 settembre 2016
In questo periodo, i governi europei sono alle prese con i bilanci di previsione e con le leggi di stabilità, che, com’è noto, devono essere presentate alla Commissione entro il 15 ottobre. Quale migliore occasione, allora, per fare un bilancio del Patto di Stabilità, ovvero delle regole poste a fondamento della governance economica dell’Unione? Calato il sipario sull’ultimo vertice dei capi di Stato e di governo tenutosi a Bratislava, ci ha pensato Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione, a fare il punto, intervenendo alla plenaria del Cese, organismo consultivo dell’Unione, rappresentativo della società civile organizzata.
La sua considerazione: «Il patto di stabilità non è stupido e funziona, lo dimostrano le cifre. Nel 2009 il deficit medio era del 6,3%, ora la media è dell’1,9. È la prova che il consolidamento progredisce». Come dargli torto? Un successone, se non fosse che proprio in tale successo sta la chiave di lettura dei mali attuali dell’economia europea.
Facciamo un passo indietro. È acquisito, ormai, che il costo dell’ultima crisi finanziaria sia stato scaricato sul groppone dei cittadini. A differenza degli Usa, da dove il virus è partito, però, in Europa la crisi è stata anche colta come un’opportunità, per irrigidire e rendere più cogenti le regole fiscali cui soggiacciono gli Stati membri e per imporre agli stessi l’adozione di «riforme strutturali» del mercato del lavoro.
Nell’arco di un quinquennio, i deficit di bilancio si sono assottigliati ovunque, fino a centrare, o a lambire, gli obiettivi di finanza pubblica previsti dai Trattati. Chi più, chi meno, tutti i Paesi hanno fatto la loro parte, tagliando la spesa pubblica, aumentando le tasse, cambiando la legislazione sul lavoro. E i risultati si sono visti anche sul versante delle bilance commerciali. Fino al 2012, fra i principali Paesi dell’eurozona, solo Germania e Olanda vantavano un saldo positivo delle partite correnti. Tutti gli altri erano in deficit ed accumulavano debiti con l’estero, uno dei motivi, tra l’altro, per cui in alcuni Paesi periferici, la crisi ha avuto un impatto devastante.
La situazione inizia a mutare rapidamente con l’inasprirsi delle politiche di austerità: nel giro di 2-3 anni, con la sola eccezione della Francia, tutti i deficit si trasformano in surplus. Forse che tutti i Paesi della zona euro sono diventati, di colpo, locomotive dell’export? Macché, è solo che la stretta fiscale e le politiche di moderazione salariale hanno comportato una caduta dei consumi delle famiglie, quindi un calo delle importazioni. In sostanza, l’operazione di riequilibro delle bilance commerciali ha avuto come corollario una depressione della domanda interna e, più in generale, un impoverimento delle popolazioni.
Il termometro di questa situazione è senz’altro la spirale deflattiva che attanaglia molti Paesi europei, nonostante l’iniezione a dosi massicce di liquidità nel sistema da parte della Bce. Parlano chiaro anche i numeri che provengono dall’economia: crescita al palo, povertà in aumento. Gli ultimi dati forniti da Eurostat relativi al secondo trimestre dicono che l’economia europea rallenta e per alcuni Paesi torna addirittura lo spettro della recessione. In questo quadro, chi se la passa peggio è proprio il nostro Paese, per il quale l’Ocse, nel suo Outlook di settembre, ha ritoccato al ribasso le stime di crescita per l’anno in corso e per il 2017. Un vero grattacapo per il governo, visti gli obiettivi di finanza pubblica fissati per il 2016 e quelli successivi ed un debito pubblico che a luglio ha toccato la cifra record 2.252,2 miliardi di euro (oltre 132,2% del Pil).
Ieri, nel frattempo, è arrivata un’altra doccia gelata, questa volta dall’Istat, che ha ridimensionato la variazione del Pil nel 2015, da +0,8% a +0,7%. Ma si sa: l’Italia i compiti a casa li ha fatti bene in questi anni, tant’è che dal 2007 al 2016 la sua produzione industriale è crollata del 22% e gli investimenti di cinque punti di Pil.
L’unica eccezione sarebbe la Spagna. In realtà, il quadro della Spagna è più problematico di quanto la sola crescita del Pil lasci intravedere (0,8% su base trimestrale, 3,2% annuo). Alla base del “successo” spagnolo, difatti, ci sono fattori del tutto congiunturali e, soprattutto, una dinamica salariale al ribasso, favorita dalla disoccupazione di massa. Il recupero di competitività, peraltro effimero, sui mercati esteri avviene a detrimento dei redditi da lavoro e del benessere generale della società. Non è un caso che ai numeri del Pil facciano da contraltare un tasso di disoccupazione al 20% (giovanile oltre il 45%), un’esile domanda interna, una persistente deflazione.
Rispetto al 2008, mancano all’appello 5 milioni di posti di lavoro. Un quarto della popolazione europea (123 milioni di individui) sarebbe a rischio povertà ed esclusione sociale, mentre già oggi oltre 50 milioni di cittadini comunitari vivrebbero in stato di grave deprivazione materiale. Nel complesso, l’Europa si presenta oggi come un gigante sedato, avvinto da gravi problemi economici e sociali, sempre sull’orlo di una nuova crisi sistemica. D’altronde, le falle del suo sistema bancario, unite alla debolezza della sua economia ed alla crescita del debito, sia pubblico che privato, potrebbero innescare una crisi ancora più perniciosa di quella del 2007-2008.
Un rischio paventato recentemente anche dall’Ocse, che sul punto, ha sentenziato: «La lentezza della ripresa dell’Eurozona è un forte freno alla crescita globale e lascia l’Europa vulnerabile agli shock globali».
Non c’è che dire, il Patto di Stabilità sta funzionando alla grande. Probabilmente, sarà ribadito anche mercoledì a Berlino, nel corso del vertice tra Angela Merkel, Francois Hollande e lo stesso Jean-Claude Juncker, al quale il premier italiano, in segno di punizione (o avvertimento), non è stato invitato.
 «La commissione sulle diacone potrebbe segnare anche la rottura di tre assordanti silenzi che soffocano le chiese da decenni». La
«La commissione sulle diacone potrebbe segnare anche la rottura di tre assordanti silenzi che soffocano le chiese da decenni». La
Repubblica, 24 settembre 2016 (c.m.c.)
Ha iniziato i propri lavori questa settimana la commissione istituita da papa Francesco sul diaconato femminile: atto interno alla vita della chiesa ma cruciale per la fisionomia del cattolicesimo romano del secolo XX.
La commissione, per certi versi, ha un compito “facile”: deve suggerire solo quando e come “restaurare” un ministero femminile attestato nel Nuovo Testamento, là dove Paolo saluta la greca Febe, “diacono della chiesa di Cencre”. “Diacono”, non “diaconessa”, come si farà al concilio di Nicea, indicando figure che non avevano ricevuto l’imposizione delle mani.
Nella fluida situazione della prima comunità neotestamentaria c’è dunque un appiglio lessicale e teologico: che non basterà a chi sta cercando di creare la “maggioranza ostile” al papa che è loro mancata in materia matrimoniale.
Tutti, per altro verso, sono consapevoli che una “restaurazione” del diaconato potrebbe ridursi ad una operazione sterile. Il concilio Vaticano II “restaurò” ad esempio il diaconato permanente, come ministero di una chiesa serva e povera che scioglieva il nesso fra celibato e ministero affermatosi solo alla fine del primo millennio. L’esito è stato modesto: il diacono è rimasto l’unico ministro sposato della chiesa latina (fino alla decisione di Benedetto XVI di ammettere preti e vescovi sposati, ma solo se provenienti dalla chiesa anglicana) e s’è ridotto al ruolo di un chierichettone nella liturgia e di capufficio dei volontari fuori da essa.
La “restaurazione” del diaconato femminile (dunque di “diacone” ordinate e/o di “diaconesse” prive dell’imposizione delle mani) potrebbe fare la stessa fine: una onorificenza per suore e per nonne, senza impatto sulla riforma e sulla missionarietà della chiesa.
Eppure la commissione sulle diacone potrebbe segnare anche la rottura di tre assordanti silenzi che soffocano le chiese da decenni.
Il primo è il silenzio sul sacerdozio che tutte le donne e tutti gli uomini battezzati hanno già: quello che la chiesa latina chiama sacerdozio comune (in opposizione al sacerdozio ministeriale che viene dal sacramento dell’ordine). La stantia cultura che rivendicava la promozione dei “laici” — sudditi desiderosi di essere mobilitati e promossi — che si è rigenerata nell’attivismo e nel clericalismo dei movimenti, non è ancora stata scalzata da una teologia sulla dignità di quelli che il codice di diritto canonico chiama Christifideles. Se santa Febe facesse un miracolo, la commissione o un sinodo sul ministero potrebbero essere l’occasione per interrogarsi su questo.
L’altro riguarda il ripensamento teologico di una espressione — in persona Christi — grazie alla quale la cultura della subordinazione femminile del mondo antico ha vinto la concezione cristiana del battesimo in Cristo nel quale non c’è più “né maschio né femmina”. Molte chiese si sono liberate da quel paradigma alla fine del secolo XX ordinando pastore, prete e vescove cristiane in possesso dei doni di Dio necessari alla santità di una comunità: la chiesa cattolica reagì alla accelerazione con una chiusura che voleva essere “definitiva” e dichiarando nel 1994 che il tema era “indisponibile” alla chiesa.
La successione apostolica al maschio-Gesù degli apostoli- maschi vincolava la capacità di agire in persona Christi a un solo genere: come se la mascolinità di Gesù non fosse una componente necessaria alla verità dell’incarnazione, ma un privilegio sessista. Ciò che è normativo di Gesù non è la sua mascolinità dichiarata dalla nudità della croce (il velo del crocifisso serve a nascondere la circoncisione non il sesso): ma la croce e la morte di croce alla quale ogni cristiano, maschio o femmina, è unito nel battesimo trinitario. Portare le donne nella sfera dell’unico ordine sacro romperebbe una reticenza e ristabilirebbe un equilibrio necessarissimo alla cristologia.
Il terzo silenzio con cui la commissione sul diaconato femminile si misura è quello sul sacerdozio ministeriale maschile ora in essere, prigioniero di un misero duello di retoriche celibatarie e anticelibatarie. Oggi in larghe parti della chiesa si vive una alternativa fra celibato ed eucarestia: perché in assenza di celibi da ordinare, si condannano le comunità a vivere senza eucarestia: una alternativa in cui un naso sano sente odore di zolfo. E che va affrontato senza furbizie e senza superficialità: non dal papa solo, ma dai vescovi che non possono nascondersi dietro un dito.
I non pochi nemici di Francesco, giovani o vegliardi, non sono contrari a che questa discussione si apra: sperano l’arcipelago antibergogliano si palesi, man mano che si avvicinano le due scelte — la nomina dell’arcivescovo di Milano e del vicario di Roma — dalle quali dipenderà non solo il futuro conclave, ma anche l’unità presente d’una chiesa. Che il papa chiama a non essere una federazione pelagiana di attivismi, ma una comunione di quelli che il Vangelo definisce “servi inutili”, e che sono gli unici indispensabili.

(segue)
Che nella nostra epoca vada in scena, su scala mondiale, un declino della politica appare poco dubitabile. Politica, intendo, come capacità di governo degli uomini, secondo ordinamenti e scelte largamente condivisi dai governati, dunque con carattere egemonico, da parte dei ceti dominanti. E politica come capacità di conflitto organizzato, per rovesciare o comunque trasformare radicalmente l’ordine esistente, da parte della classe operaia e dei ceti popolari. Ambedue gli ambiti appaiono in rotta, e il loro degrado culturale e operativo è a mio avviso, intimamente connesso. Il sovrastante dominio dei ceti economici dominanti sulle classi popolari ha ridotto gravemente l’antagonismo storico che per tutta l’età contemporanea è stato il motore della modernizzazione capitalistica. Qui cercherò di individuare, in rapida sintesi, le ragioni più rilevanti che riguardano la fragilità dell’azione politica nel campo della sinistra.
1 La prima causa credo sia da individuare nello squilibrio tra la dimensione ancora nazionale, territoriale, della lotta popolare e di classe e la natura transnazionale del capitale, aterritoriale della finanza. La politica moderna nasce, per i ceti popolari, come conflitto contro il modo di produzione capitalistico, che ha, nei suoi caratteri genetici, la dimensione mondiale. Ricordano Marx ed Engels, nel Manifesto, che il capitale domina «l’intero globo della Terra» (die ganze Erdkugel). Perciò la scala della lotta contro di esso deve essere mondiale: «proletari di tutto il mondo unitevi». Se nel conflitto tra capitale e lavoro, nelle vertenze dentro la fabbrica, il capitale gode del vantaggio di poter fuggire, di trasferirsi altrove, per gli operai, che in questo altrove non hanno alcun rappresentante, la sconfitta è certa. La possibilità del conflitto è mutilata in partenza. Vero è che nelle società avanzate accanto alla classe operaia operano molti altri ceti e figure, ma a parte il fatto che anche questi sono spesso alle prese con una controparte mobile sul piano mondiale, l’impotenza che si è creata nel cuore originario dell’antagonismo anticapitalistico si riverbera su tutto il resto. Se il nemico scompare, la lotta non ha più direzione, la politica si spegne.
Una prima considerazione di natura propositiva. Il Forum mondiale nato a Seattle nel 1999, che ormai lavora un anno per organizzare un incontro di pochi giorni, mostra l’esaurimento della formula. I movimenti non durano a lungo se non si solidificano in istituzioni. Oggi occorrerebbe poter organizzare uno sciopero internazionale anche di una sola categoria di lavoratori. Oppure mobilitare il boicottaggio commerciale dei prodotti di una multinazionale con la quale si è aperta una vertenza. Se si riuscisse a colpirla sul piano delle vendite, creando allarme sul titolo in borsa, ecc. e infine si vincesse la vertenza , l’esito politico sarebbe immenso. L’esempio vittorioso diventerebbe contagioso. La mobilità mondiale del capitale apparirebbe vulnerabile, la lotta contro di esso premiata e incoraggiata.
Ricordo, a contrario, per limitarci al campo europeo, che i vari sindacati nazionali non hanno neppure provato a creare un coordinamento continentale della rappresentanza operaia. Perciò oggi costituisce un obiettivo di rilievo sostituire i vecchi gruppi dirigenti dei sindacati, eredi di una situazione storica tramontata.
2 A sinistra dimentichiamo facilmente l’evento che ha fatto epoca e il cui fragore non si è ancora spento nei nostri cieli. Il crollo dell’URSS, preceduto da un trentennio di immobilità autoritaria del potere sovietico, ha coperto di un’ ombra di fallimento il più grande progetto realizzato dalla politica nel XX secolo: la rivoluzione d’Ottobre. Quella sua vittoria è degradata in gestione illiberale del potere.
Le critiche di F. A.von Hayeck all’economia pianificata (The Road to the Serfdom, 1944) trovavano, a partire dagli anni ’80, una conferma travolgente. Da allora il pensiero neoliberista, intimamente antipolitico, dilaga. E’ stato agevole ai gruppi dirigenti capitalistici estendere gli attacchi anche ai governi socialdemocratici europei, alle prese con una crescente crisi fiscale dello Stato. Da quel momento si è aperta una divaricazione di valori tra Stato e impresa, politica ed economia. La politica (soprattutto grazie alle retoriche della Thatcher) è stata vestita coi panni del corporativismo sindacale, dell’assistenzialismo scroccone, dell’inefficienza burocratica, dell’incapacità della decisione, di nemica delle libere scelte dell’individuo. Con queste critiche si è affermata una nuova visione del mondo: gli uomini sono incapaci di altruismo e di operare per il bene comune. Solo se perseguono il loro privato interesse agiscono con efficacia e producono ricchezza. Il pessimismo ontologico del pensiero protestante ridava smalto a un Adam Smith ridotto a cantore del libero mercato fondato sugli egoismi umani. L’etica veniva fatta sparire dalle istituzioni pubbliche e dai partiti e fatta rinascere nei liberi appetiti del mercato. L’imprenditore diventa la nuova figura eroica nell’immaginario collettivo.
3 Siamo ancora dentro tale corrente spirituale, non solo per l’effetto perdurante del passato, ma perché essa ha trovato nuove fonti di alimentazione. Una di queste è la spinta del capitalismo finanziario a trasformare lo Stato in azienda. Le procedure di scelta e decisione dei parlamenti e dei governi appaiono troppo lente rispetto alla velocità dell’economia e della finanza. Se un operatore può spostare immense somme di danaro con un gesto che dura pochi secondi, all’interno di società capitalistiche in competizione su scala mondiale, è evidente che la struttura degli stati democratici appare ormai come un organismo arcaico.
4 Il deperimento dello Stato sociale, che non distribuisce più ricchezza, che non favorisce la mobilità sociale, ecc., svaluta agli occhi dei cittadini il valore delle istituzioni pubbliche, dei partiti, delle forze politiche, che appaiono impotenti, divise, litigiose.
5 Il declino e il disfacimento dei grandi partiti popolari, anche per effetto del venir meno degli antichi collanti ideologici, per la frammentazione sociale del post-fordismo, ha immesso dentro quel che è rimasto di questi organismi collettivi il virus della competizione individualistica. E’ indubbio che nel frattempo si è verificato un mutamento antropologico, come sappiamo da tanti studi, da Bauman ai teorici della biopolitica: l’ economia si è imposta alla società anche come una nuova soggettività che plasma il comportamento individuale. Non si crede più nella possibilità di cambiare il mondo ( se non altro per le grandi difficoltà da affrontare, visti i rapporti di forza dominanti) ma si crede nella possibilità del proprio personale successo. Occorrerebbe aggiungere anche che oggi l’individuo, oltre ad essere assorbito lungamente dall’orario di lavoro, è soggetto a una moltitudine di “offerte” pressioni quotidiane – dagli sms alla telefonate, dalle partite di calcio allo spettacolo televisivo, dagli acquisti (on line o al supermercato) ai giochi elettronici, dalla gestione della posta elettronica al disbrigo delle pratiche correnti per la gestione della casa. Il tempo della giornata dell’individuo adulto è frantumato e lo spazio per la politica, che comporta impegno e continuità diventa sempre più residuale.
6 La debolezza dei partiti - ad es. l’impossibilità di generare posti di lavoro attraverso l’azione pubblica - li spinge ad allontanarsi sempre di più dai ceti che prima rappresentavano e a guadagnarne il consenso attraendo investimenti con politiche di sostegno alle imprese. Per questa via la politica ratifica la sua definitiva subordinazione all’economia. Ma, se il successo dell’”imprenditore politico”, che non gode più di sostegni nel mondo popolare, è legato ai mezzi personali di cui dispone, è evidente che egli è esposto alla tentazione di usare a proprio vantaggio risorse pubbliche o illecite e quindi alla corruzione per vincere la competizione con i suoi colleghi.
7 La politica, ridottasi al “discorso” del ceto politico, appare gravemente impoverita rispetto alla ricchezza delle culture che la società oggi esprime. A fronte della multiformità di conoscenze che percorrono il corpo sociale, il sapere della politica - che non si nutre più di teoria e analisi sociale - degrada nella retorica pubblicitaria della società dello spettacolo. Un tempo la politica, la strategia dei partiti di massa sorti nel dopoguerra, era ispirata dall’analisi sociali, dalla conoscenza storica del passato, dall’indagine dei mutamenti economici e sociali. Molteplici discipline scientifiche conncorrevano al suo specifico sapere. I partiti della sinistra, sino a un certo momento, sono stati ispirati dalla teoria, vale a dire la creazione più geniale della politica moderna, che concepisce il corso storico come assoggettabile alla volontà umana attraverso un progetto. Oggi la cultura dei partiti si alimenta di sondaggi elettorali perché loro fine ultimo è l’affermazione nei luoghi del potere e della rappresentanza. La loro pratica intellettuale si riduce alla mera propaganda.
Qualche considerazione di proposta. La politica rinasce se sa pensare nuovi mondi possibili. L’idea della crescita infinita, in cui il capitale ci vuol trascinare, è un assurdo. Il pianeta trabocca di ricchezza in forma di merci ed è minacciato dal suo stesso incremento. Teoricamente, un accordo cooperativo mondiale tra i vari paesi frenerebbe il saccheggio delle risorse, consentirebbe una vita dignitosa a tutti i popoli, ridurrebbe la competizione a pochi ambiti, limiterebbe la corsa individuale di soggetti e forze dentro i capitalismi nazionali. Sotto il profilo culturale l’ipotesi apre un vasto orizzonte alla lotta politica, poggiante su drammatiche necessità ambientali. La sinistra ha a disposizione un nuovo universalismo, quello ecologico, di cui non è riuscita a fare materia di supremazia politica sull’avversario.
La lotta per salvare il pianeta può ricomporre un fronte sociale vastissimo. Infine i partiti. In Italia i tentativi di crearne nuovi sono stati, o sono diventati, progetti di ricostituzione di rappresentanze parlamentari. Purtroppo non sono sufficienti programmi e discorsi diversi dal conformismo dominante se si indossa la stessa divisa del medesimo ceto politico.Deve cambiare il comportamento, non solo il verbo. Il consenso da un popolo frustrato e deluso non viene. E invece occorre organizzare la società in frantumi, prima di tentare di rappresentarla. Poi regole, leggi, statuti per organizzare la volontà collettiva dentro nuovi organismi. Se non possediamo la sostanza ideale per tenere insieme il pluralismo competitivo dei soggetti, per imbrigliane la ricchezza inconcludente, non ci restano che i vincoli delle norme.
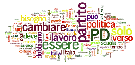 Estratto dell’intervento dell’autore al "Festival del diritto" a Piacenza; quest’anno il tema su cui studiosi di varie discipline si stanno confrontando è quello della dignità. La
Estratto dell’intervento dell’autore al "Festival del diritto" a Piacenza; quest’anno il tema su cui studiosi di varie discipline si stanno confrontando è quello della dignità. La Repubblica
, 24 settembre 2016 (c.m.c.)
C’e' una piccola frase, apparentemente alquanto banale, in La sera del dì di festa di Giacomo Leopardi che dice «tutto al mondo passa e quasi orma non lascia». Desidero richiamare l’attenzione su quel “quasi”. Certo, la vita e le nostre opere sono effimere, ma non del tutto. C’è un residuo, il “quasi”, che resta, che si accumula e che forma ciò che chiamiamo umanità, un termine che può tradursi in cultura: il deposito delle esperienze che vengono da lontano e preparano il futuro, un deposito al quale tutti noi, in misura più o meno grande, partecipiamo. O, meglio: dobbiamo poter partecipare. Altrimenti, siamo fuori della umanità.
Per questo, troviamo qui il primo, il primordiale diritto, che condiziona tutti gli altri. La violazione di questo diritto equivale all’annientamento del valore della persona, alla sua riduzione a zero, a insignificanza.
Eppure, viviamo in un mondo nel quale non è nemmeno possibile stabilire con precisione quanti sono gli esseri umani che non conoscono questo elementare diritto che possiamo chiamare “diritto al segno” o, leopardianamente, “diritto all’orma”.
Si misurano a milioni, cioè a numeri approssimativi, senza che — ovviamente — a questi numeri possano associarsi nomi. Milioni di anonimi, che giungono a noi come fantasmi, mentre le loro sono esistenze concrete, anche se durano spesso lo spazio d’un mattino o di pochi mattini, consumandosi in fretta in condizioni disumane, in luoghi dove la lotta per la mera sopravvivenza
materiale sopravanza qualunque possibilità di relazioni, dove i neonati vengono al mondo sotto la maledizione di leggi statistiche che li condannano alla sparizione entro pochi giorni o settimane di vita.
Ciò che ci interpella inderogabilmente è che non possiamo dire, come forse si sarebbe potuto un tempo, nel mondo diviso per aree, storie, politiche separate e indipendenti le une dalle altre: sono fatti loro, loro è la responsabilità, il nostro mondo non è il loro, ognuno pensi per sé alle proprie tragedie. Non possiamo dirlo, perché il mondo, come ci ripetiamo tutti i momenti, è diventato uno solo, grande, globale. Noi, in un tale mondo, osiamo parlare kantianamente, senza arrossire, di “dignità” come universale diritto al rispetto. Il “diritto all’orma” detto sopra è legato a tutti gli altri diritti come loro premessa e condizione: è davvero quello che è stato definito da Hannah Arendt, con una formula che ha avuto successo (Rodotà), il “diritto di avere diritti”.
C’è un diritto che potremmo dire essere un altro modo d’indicare il diritto di avere diritti, ed è il diritto al nome: un diritto al quale i trattati di diritto costituzionale, se non l’ignorano, dedicano poche righe. La nostra Costituzione, all’art. 22, tra i diritti umani fondamentali stabilisce che nessuno può essere privato del suo nome perché i Costituenti sapevano il valore di quel che dicevano. “Nominando” si specifica, si riconosce, si creano le premesse per creare un rapporto.
Questo non accade, oggi, alle centinaia di migliaia e, in prospettiva, dei milioni di migranti che sono, per noi, milioni non solo di senza nome, ma anche di senza terra. «Quel che è senza precedenti — scriveva Arendt con riguardo alla tragedia del suo popolo negli anni ’30 e ’40 del Novecento — non è la perdita della patria, ma l’impossibilità di trovarne una nuova». Tale impossibilità, allora, era determinata dalle politiche razziali e colpiva comunità umane determinate. Oggi, deriva dalla condizione generale del mondo saturo globalizzato.
Questa situazione estrema è la sorte delle persone private dei diritti umani. I diritti umani sono una realtà per chi sta sopra, e il contrario per chi sta sotto. Lo stesso, per la dignità. Per chi sta sopra, le rivendicazioni di chi sta sotto e chiede di emergere all’onor del mondo sono attentati allo standard di vita “dignitoso” di chi sta sopra. Quando si chiede lo sgombero dei migranti che intasano le stazioni, dormono nei parchi pubblici e puzzano, non si dice forse che danno uno spettacolo non dignitoso? Ma, dignità secondo chi? Non secondo i migranti, che della dignità non sanno che farsene, ma secondo noi che da lontano li guardiamo.
Ci sono parole, dunque, che non valgono nello stesso modo per i divites e gli inanes. Si dovrebbe procedere da questa constatazione per un onesto discorso realistico e riconoscere che le parole che hanno valore politico non sono neutre. Servono, non significano; sono strumenti e il loro significato cambia a seconda del punto di vista di chi le usa; a seconda, cioè, che siano pronunciate da chi sta (o si mette) in basso o da chi sta (o si mette) in alto nella piramide sociale. Occorre, perciò, diffidare delle parole e dei concetti politici astratti. Assunti come assoluti e universali, producono coscienze false e ingenue, se non anche insincere e corrotte.
Potremmo esemplificare questa legge del discorso politico parlando di democrazia, governo, “governabilità”, libertà, uguaglianza, integrazione, ecc. e di diritti e dignità. Si prenda “democrazia”: per coloro che stanno sopra e hanno vinto una competizione elettorale, significa autorizzazione a fare quello che vogliono; per coloro che stanno sotto e sono stati vinti, significa pretesa di rispetto e di riconoscimento: fare e non fare; prepotenza e resistenza. Oppure “politica”: forza sopraffattrice dal punto di vista dei forti, come quando la si usa in espressioni come “politica di espansione”, “politica coloniale”, “politica razziale”, “politica demografica”; oppure, esperienza di convivenza, coinvolgimento e inclusione sociale. Oppure ancora: la (ricerca della) “felicità”.
Oggi, sono i potenti che rivendicano la propria felicità come diritto, la praticano e la esibiscono come stile di vita, quasi sempre osceno e offensivo. Ma non sentiremo un disoccupato, un lavoratore schiacciato dai debiti, un genitore abbandonato a se stesso con un figlio disabile, un migrante senza dimora, un individuo oppresso dai debiti e strangolato dagli strozzini, uno sfrattato che non ha pietra su cui posare il ca- po, una madre che vede il suo bambino senza nome morire di fame: non li sentiremmo rivendicare un loro diritto alla “felicità”. Sarebbe grottesco. Sentiremo questo eterogeneo popolo degli esclusi e dei sofferenti chiedere non felicità ma giustizia.
Ma, anche la parola giustizia non sfugge alla legge dell’ambiguità. Giustizia rispetto a che cosa? Ai bisogni minimi vitali, come chiederebbero i senza nome e i senza terra; oppure ai meriti, come sostengono i vincenti nella partita della vita? La giustizia degli uni è ingiustizia per gli altri. Si comprende, allora, una verità tanto banale quanto ignorata, nei discorsi politici e dei politici: se si trascura il punto di vista dal quale si guardano i problemi di cui ci siamo occupati e si parla genericamente di libertà, diritti, dignità, uguaglianza, giustizia, ecc., si pronunciano parole vuote che producono false coscienze, finiscono per abbellire le pretese dei più forti e vanificano il significato che avrebbero sulla bocca dei più deboli.
Onde, la conclusione potrebbe essere questa: queste belle parole non si prestano a diventare stendardi che mobilitano le coscienze in un moto e in una lotta comuni contro i mali del mondo, per la semplice ragione che ciò che è male per gli uni è bene per gli altri. La vera questione è la divisione tra potenti e impotenti. Tanto più le distanze diminuissero, tanto più l’ambiguità delle parole che usiamo diminuirebbe. Ma, è chiaro, qui il discorso deve finire, perché si deve uscire all’aperto, dove non bastano le parole ma occorrono le azioni.
 sistema che condannerebbe l’Italia e i rifugiati a una condizione ingestibile».
sistema che condannerebbe l’Italia e i rifugiati a una condizione ingestibile».
Il manifesto, 24 settembre 2016 (c.m.c.)
L’Europa non sta cambiando strategia, o girando improvvisamente le spalle all’Italia su migranti e rifugiati. Sta consolidando la traiettoria che aveva abbozzato nell’Agenda europea sulle migrazioni e poi tradotto in tutti i provvedimenti che ne sono seguiti: isolamento dei paesi di “frontiera” dal resto dell’Unione, restrizione dei diritti per le persone in cerca di protezione, muri per impedire gli spostamenti interni dei richiedenti asilo. L’errore è stato valutare diversamente l’impegno europeo e non avere avuto la lungimiranza di capire dove tutto questo avrebbe portato.
Guardando ai mesi trascorsi da quell’orribile 19 aprile 2015 da cui tutto ha preso le mosse, troviamo solamente le macerie del sistema comune di asilo. Troviamo il ricollocamento beffa che in 1 anno ha ricollocato 5.290 persone su 160.000. Troviamo le innumerevoli sospensioni dello spazio Schengen, con i muri austriaci, tedeschi, ungheresi e adesso anche francesi. Troviamo la Grecia e le sue isole trasformate in un grande campo profughi, in un limbo che intrappola migliaia di rifugiati.
L’unico aspetto della politica europea che ha portato a un significativo risultato è stato l’accordo con la Turchia. Ha fatto crollare gli arrivi sulle coste greche dai 151.452 pre-accordo ai 14.618 post-accordo. Unico obiettivo era chiudere un flusso che stava mettendo a rischio lo stesso impianto comunitario, scoraggiare le partenze dalla Turchia alla Grecia, senza alcun interesse a individuare uno spazio di protezione per i rifugiati. Un gran risultato numerico, un pessimo risultato in termini di diritti.
Il governo italiano è amareggiato nel rilevare che il contenimento dei flussi sulla sponda sud del Mediterraneo non sia nelle priorità dell’Unione e che l’Africa sia sparita dalle Agende dei meeting europei, come quello di Bratislava di pochi giorni fa. Abbiamo sempre creduto che il contenimento dei flussi in Paesi di origine e di transito in cui non sono garantiti i diritti fondamentali dei rifugiati non possa assolutamente essere la soluzione per gestire la più grave crisi umanitaria dalla seconda guerra mondiale. Le proposte che potrebbero avere un reale impatto su tali paesi si giocano su un arco temporale di medio-lungo termine e non possono avere un significativo risultato sulla attuale situazione, a meno che non si vogliano completamente calpestare i diritti delle persone in cerca di protezione.
Quello che ci preoccupa davvero molto è quanto l’Italia ancora non sembra in grado di vedere. A luglio la Commissione ha presentato 2 proposte di Regolamento per modificare la normativa relativa alla procedura d’asilo e alla qualifica di rifugiato. Proposte che sembrano rispondere esclusivamente a tre ossessioni: restingere i diritti delle persone in cerca di protezione, punire qualsiasi movimento interno ai paesi dell’Unione, accelerare le procedure d’asilo in modo da capire velocemente chi può essere rispedito a casa. Proposte che se approvate in questa forma e se combinate con la proposta per il nuovo famigerato regolamento “Dublino IV” avranno conseguenze devastanti sia sui richiedenti asilo e rifugiati che sull’Italia.
I Regolamenti, se approvati, diventerebbero legge subito applicabile in tutti gli Stati Ue e imporrebbero a tutti una procedura comune in cui concetti di paese terzo sicuro, paese di origine sicuro, paese di primo asilo sicuro, procedura accelerata, manifesta infondatezza, sarebbero inseriti negli ordinamenti di tutti gli Stati membri. Creando il paradosso di una procedura sì ora davvero comune, ma che vincola, pena provvedimenti punitivi e ritorsioni per i richiedenti asilo, le persone ai primi paesi di approdo. Un’unica procedura, 28 Stati totalmente separati. Una legge che farebbe di fatto alzare quei muri che Schengen avrebbe dovuto abbattere.
Dobbiamo immaginarci uno scenario senza più alternative: i richiedenti asilo che arriveranno nei paesi di frontiera dell’Unione non potranno davvero più muoversi se non attraverso il meccanismo di ricollocamento, del quale abbiamo già sperimentato il fallimento, e all’interno dei restrittissimi spazi del boccheggiante Regolamento Dublino. Uno scenario in cui in Germania potrebbero esserci poche migliaia di richiedenti asilo, quei pochi che arriveranno agli aereoporti, e dove centinaia di migliaia di persone si affollerebbero inevitabilmente in Italia, Grecia, Malta e i paesi con confini valicabili.
Crediamo necessario concentrare l’attività italiana per cercare di modificare un sistema che condannerebbe l’Italia e i rifugiati a una condizione ingestibile, sia per uno Stato che si troverebbe davvero da solo in prima linea, sia per le persone che vedrebbero le loro possibilità di essere protetti e integrati sempre più compromesse.
 «Dal lavoro al web, dalla famiglia al fine vita:in un'intervista di Simonetta Fiori Stefano Rodotà analizza una delle parole chiave della nostra contemporaneità: “Le leggi devono proteggerla, è ciò che ci rende umani”». La
«Dal lavoro al web, dalla famiglia al fine vita:in un'intervista di Simonetta Fiori Stefano Rodotà analizza una delle parole chiave della nostra contemporaneità: “Le leggi devono proteggerla, è ciò che ci rende umani”». La
Repubblica, 23 settembre 2016 (c.m.c.)
Tra le parole chiave del nuovo millennio è la più abusata. Forse la più calpestata. La dignità è anche un lemma centrale nel dizionario autobiografico di Stefano Rodotà, che dai diritti sul lavoro a quelli dentro la famiglia, dalla tecnocrazia alla tutela della privacy, ne ha fatto la bussola di una ricerca intellettuale e politica cominciata oltre mezzo secolo fa. Dignità è oggi il tema del nuovo Festival del diritto, da lui fondato a Piacenza otto anni fa.
Perché oggi si parla molto di dignità?
«È la parola che evoca direttamente l’umano, il rispetto della persona nella sua integrità. Ed è ancora più immediata di parole storiche come eguaglianza, libertà, fraternità. C’è una bellissima frase scritta da Primo Levi: per vivere occorre un’identità, ossia una dignità. Senza dignità l’identità è povera, diventa ambigua, può essere manipolata».
Ma la parola rischia di essere contraddetta dai fatti. L’Ue, ad esempio, esordisce nella sua carta dei diritti fondamentali con il termine dignità. Ma sembra dimenticarsene con i migranti, alzando muri.
«Sì, c’è uno scarto fortissimo. Quando nel Duemila è stato scritto quel documento, nel preambolo si è voluto rimarcare che l’Europa pone al centro della sua azione la persona. Lo sta facendo? No. Una contraddizione che incrina il patto cittadini-istituzioni».
Una promessa non adempiuta.
«Con conseguenze molto gravi. Il mancato rispetto della dignità produce un effetto di delegittimazione. Tu non mi riconosci nella mia pienezza di persona degna e io non ti riconosco nella tua sovranità istituzionale. Da qui la rabbia sociale che alimenta il terrorismo e il caos geopolitico. Difendere la dignità è difendere la democrazia».
La parola dignità ha segnato l’epoca successiva alla seconda guerra mondiale.
«Non è un caso che quando la Germania ha cercato un termine per reagire alla devastazione nazista ha trovato proprio dignità. Compare nel primo articolo della costituzione. E compare nella carta costituzionale dell’altro grande sconfitto, l’Italia».
In Italia la parola acquista una coloritura più forte.
«Sì, le si affianca un attributo fondamentale: dignità sociale. La dignità è anche nel rapporto con gli altri. Tu non puoi negarla al prossimo nel momento in cui la rivendichi per te stesso. I costituenti italiani strapparono la dignità da una condizione di astrattezza, fornendole una solida base materiale. Prendiamo l’articolo 36: il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro e sufficiente a garantire a sé e alla sua famiglia un’esistenza dignitosa. Cosa volevano dire i nostri padri? La dignità non è a costo zero. Esistono diritti che non sono a costo zero».
L’aver introdotto nella nostra carta il pareggio di bilancio indebolisce questi diritti?
«Non c’è dubbio. L’articolo 81 è un vincolo fortemente restrittivo e non necessario. Giustificato con il solito ritornello: ce l’ha chiesto l’Europa».
La crisi economica ha giocato contro.
«Sì. Ma ha inciso soprattutto la pretesa di spostare nella sfera economica il luogo dove si decidono i valori e le regole. Questo ha comportato uno spostamento del potere normativo: poiché sono io quello che gestisco il danaro e investo, sono io che detto le regole. Il tramonto dello Stato costituzionale dei diritti».
La dignità è una parola flessibile, adatta alla contemporaneità liquida. Come cambia nell’epoca della tecnologia?
«Un primo importante cambiamento riguarda la costruzione stessa dell’identità. Quando io posso raccogliere una serie di informazioni su una persona, e sono anche in grado di fare valutazioni prospettiche — se ha fatto questo, farà anche quest’altra cosa — in sostanza io sto partecipando alla costruzione della sua identità».
L’identità e dunque la dignità vengono manipolate. Ma c’è un’altra offesa della dignità che riguarda le persone che mettono in piazza la propria intimità. Con esiti che possono condurre al suicidio.
«Qui entriamo in un terreno molto complicato. Quando io metto in circolazione delle informazioni che mi riguardano devo sapere che la rete determina effetti di moltiplicazione. E quando io ricevo informazioni che riguardano altre persone dovrei riconoscere una sfera privata che non posso manipolare».
Ma come si tutela la dignità dei sentimenti in rete?
«La prima cosa che mi viene da dire: tieniteli per te. Ma il problema dei sentimenti è un problema di relazione: sono in gioco i miei rapporti con un’altra persona, con un gruppo. E allora bisogna porre dei paletti: prima di far circolare contenuti che riguardano altri devo preoccuparmi che ci siano il consenso o la consapevolezza di quelle persone».
Un altro versante riguarda la dignità del morire. In Italia non esiste ancora una legge sul testamento biologico.
«E per fortuna, oserei dire. La legge prospettata era molto restrittiva, rispetto a una coraggiosa sentenza della Corte Costituzionale che nel 2008 riconobbe il diritto del governo del corpo esercitato in piena autonomia. Il legislatore ha il vizio o la propensione a impadronirsi della vita delle persone. In Italia abbiamo diffidenza verso le decisioni autonome: la libertà non è vista come bene da salvaguardare ma rischio da tenere sotto controllo».
Dalle tecnoscienze alla bioetica, dalla privacy ai diritti d’amore, dignità è la parola chiave del suo impegno.
«Sì, ma l’ho scoperto piano piano: la dignità è un modo antropologico di vivere. Se io riconosco a una persona dignità, non posso comportarmi come se questa consapevolezza non l’avessi mai acquisita».
 «Nella città che esattamente un anno fa chiuse la stazione ferroviaria di Keleti per chiudere ai profughi di guerra le porte della fortezza Europa, si è discusso anche di migrazione denunciando i respingimenti».
«Nella città che esattamente un anno fa chiuse la stazione ferroviaria di Keleti per chiudere ai profughi di guerra le porte della fortezza Europa, si è discusso anche di migrazione denunciando i respingimenti». Il manifesto,
22 settembre 2016 (c.m.c.)
Articolo firmato da Silvio Cristiano (Università Iuav di Venezia), Viviana Asara (Vienna University of Economics and Business), Federico Demaria (Universitat Autonoma de Barcelona), Giacomo D’Alisa (Universitat Autonoma de Barcelona), Barbara Muraca (Oregon State University)
Si è conclusa con grande successo a Budapest la Quinta Conferenza Internazionale sulla Decrescita per la Sostenibilità Ecologica e l´Equità Sociale (LINK), finora ignorata dai quotidiani italiani. Spesso fraintesa e bistrattata in Italia, all’estero la decrescita è invece sempre più discussa come possibile alternativa a un modello economico in crisi.
Dalla Francia alla Catalogna, dalla Germania agli Stati Uniti, dal Canada all´India, chi parla di decrescita – né “felice” né “infelice” – invoca non il contrario della crescita del prodotto interno lordo, bensì un approccio completamente alternativo al dogma della crescita-ad-ogni-costo. Quella di Budapest è stata la quinta edizione di un ciclo di conferenze che dal 2008, dopo Parigi, Barcellona, Venezia, Montreal e Lipsia, offrono il contesto adatto per discutere e scambiare risultati scientifici ma anche “buone pratiche” all´interno di un movimento sociale-accademico che non smette di crescere.
Dal 30 agosto al 3 settembre, a Budapest sono affluiti oltre seicento tra accademici e attivisti provenienti da tutti i continenti, mentre in città in migliaia stavano animando la prima “Settimana della decrescita” per le strade, negli spazi sociali, culturali e di economia sociale che a Budapest hanno dato vita a una serie di esperienze umane e politiche basate sul vivere la società in un modo altro, al di fuori della logica del profitto. Perché uscendo dalla nostra penisola il concetto di decrescita è piuttosto e innanzitutto una proposta politica per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e della giustizia sociale e ambientale, ben diversa quindi da quell’attitudine più o meno naif con la quale viene spesso liquidata in Italia.
Nella cinque giorni ungherese è stato ribadito come la decrescita sia prima di tutto un tentativo di ri-politicizzare i discorsi sulla sostenibilità, concetto troppo spesso distorto nelle sue declinazioni di “crescita verde”, “economia verde” o “sviluppo sostenibile”, e affidato al mito di una maggiore efficienza tecnologica e mercificazione della natura, a mascherare il fatto che una crescita infinita, oltre che non sostenibile, non è neanche fisicamente possibile su un pianeta finito.
Nella sessione introduttiva della conferenza, Federico Demaria (ricercatore dell’Università Autonoma di Barcellona e del collettivo accademico catalano Research & Degrowth) ha domandato alla platea se la decrescita possa costituire “un progetto politico di sinistra per una trasformazione socio-ecologica della società”.
Come ha spiegato Barbara Muraca (professoressa all´Oregon State University), la crescita ha ormai esaurito la sua funzione di “stabilizzazione dinamica della societá” (concetto caro ai sociologi) o di “pacificatore sociale” che aveva un tempo nelle socialdemocrazie europee. La dipendenza della nostra società dalla crescita in quello che ormai anche il Fondo Monetario Internazionale ha dipinto come uno scenario di “stagnazione sistemica” sta minando le vere basi di riproduzione socio-economica, politica e culturale delle nostre società contemporanee. I limiti della crescita non sono solo di tipo ecologico, ma anche sociale e culturale.
La conferenza di Budapest ha affrontato un vasto spettro di tematiche: si è discusso di energia e di produzione alimentare, di stato sociale e di questioni di genere, di conflitti ambientali e di rapporti tra il nord e il sud del mondo, di urbanistica e di alternative post-capitaliste, di reddito minimo, di reddito massimo e di movimenti sociali. Nella città che esattamente un anno fa chiuse la stazione ferroviaria di Keleti per chiudere ai profughi di guerra le porte della fortezza Europa, si è discusso anche di migrazione denunciando i respingimenti.
Proprio sul manifesto, recensendo il saggio “Vie di fuga” di Paolo Cacciari, lo scorso anno Mauro Trotta ravvisava nei discorsi sulla decrescita una possibile strada verso il processo di ricomposizione della sinistra. Una strada che, per la sua storia e il suo presente, su queste pagine potrebbe effettivamente valere la pena se non altro di discutere.
Dopo il successo delle sue dieci edizioni, la pubblicazione in italiano del volume “Decrescita: vocabolario per una nuova era” (a cura di G. D’Alisa, F. Demaria e G. Kallis per Jaca Books) con contributi di più di cinquanta autori e la significativa prefazione di Luciana Castellina, potrebbe costituire un prezioso punto di partenza in questa direzione. La decrescita non significa recessione o stagnazione, ma il necessario progetto di riforma radicale delle nostre società contemporanee e delle loro istituzioni fondanti, che possa far fronte alla crisi multidimensionale (ambientale, politica e economica) che stiamo vivendo.
 «Quando capiamo il nesso tra crisi climatica, crisi economica e la nostra personale sofferenza, allora c’è davvero il potenziale per cambiare il mondo».
«Quando capiamo il nesso tra crisi climatica, crisi economica e la nostra personale sofferenza, allora c’è davvero il potenziale per cambiare il mondo».
italiachecambia online, 22 settembre 2016 (c.m.c.)
Il 2 ottobre, nella Giornata internazionale della nonviolenza e nell’anniversario della nascita di Gandhi, Firenze ospiterà un convegno internazionale interamente dedicato a quella che Helena Norberg-Hodge, analista economica vincitrice del Right Livelihood Award (il “Premio Nobel alternativo”) e del Goi Peace Award, definisce l’“economia della felicità”. Insieme a lei saranno protagonisti di questo evento relatori del calibro di Serge Latouche, Jeremy Irons e Vandana Shiva.
Italia che Cambia è mediapartner dell’VIII Conferenza Internazionale dell’Economia della Felicità promossa dall’organizzazione non profit Local Futures e dall’associazione Mani Tese, con la collaborazione ed il sostegno di Terra Nuova e Gruppo Macro.
L’evento consiste in una sessione plenaria di conferenze aperta al pubblico la domenica 2 Ottobre sul tema Economia della Felicità. La conferenza fiorentina segue una serie di fortunate edizioni precedenti, svoltesi in Australia, USA, India e Korea, di enorme successo.
Lo scopo principe dell’evento è quello di ri-pensare l’economia, allontanandosi dal modello di crescita globale condotto dalle multinazionali, a favore di un nuovo modello economico in cui siano centrali la persona e l’ambiente. La struttura stessa dell’attuale economia globale causa instabilità, scarsità (artificiale) e competizione, squarciando il tessuto di comunità e producendo distruzione ecologica su scala massiccia. Collasso finanziario, scandali bancari, debiti enormi, surriscaldamento globale, crisi del petrolio, livelli di disoccupazione in aumento, crescita dei livelli di alienazione personale: tutti questi sono segni della disfunzionalità dell’attuale modello basato sulla egemonia dell’economico e sul mito della crescita globale.
Tuttavia un crescente numero di persone, tra cui ecologisti, filosofi, economisti, attivisti, stanno guardando verso un nuovo modello: quello basato su un’economia localizzata.
La conferenza di Firenze si prefigge in particolare di:
- Dare il via ad un dibattito informato sui temi della economia della crescita globale, in primo luogo i cosiddetti trattati di libero scambio che hanno determinato e determinano il passaggio di potere dai governi nazionali alle multinazionali o Big Corporation.
- Raccogliere esempi concreti di progetti di localizzazione per esplorare un nuovo paradigma economico che beneficia le persone, le loro comunità e l’ecologia – piuttosto che le banche e le grandi aziende.
- Avviare uno studio sistemico e un dibattito sulle idee e le mode culturali che hanno portato nell’epoca moderna all’egemonia dell’economico e del monetario su gli altri aspetti della vita. Solo un analisi accurata delle radici culturali del mito della crescita globale, può portarci ad invertire radicalmente la tendenza perché in realtà un altro mondo è possibile, anzi necessario.
- Esplorare i programmi di gruppi e organizzazioni locali rispetto al passaggio da globale a locale e rivitalizzare le economie e comunità
- Condividere strategie efficaci per un cambiamento sistemico. Questo deve passare per cambiamenti di politica attraverso leggi, tasse e sussidi che penalizzino il commercio e l’economia globale per favorire il locale, l’ecologico, le comunità di territorio.
- Contribuire alla costruzione di un movimento internazionale forte a favore del cambiamento da globale a locale, attraverso il International Alliance for Localization (IAL) ed altre piattaforme condivise.
 Ha ragione l'autore quando afferma che bisogna voler bene all'Africa, ma prende una pesante cantonata quando afferma che è amore, e non bieco interesse, quello che spinge Matteo Renzi a proporre e caldeggiare quell'orribile strumento che è il "migration compact".
Ha ragione l'autore quando afferma che bisogna voler bene all'Africa, ma prende una pesante cantonata quando afferma che è amore, e non bieco interesse, quello che spinge Matteo Renzi a proporre e caldeggiare quell'orribile strumento che è il "migration compact".
LaRepubblica, 22 settembre 2016, con postilla
Ha fatto molto discutere la netta presa di posizione di Matteo Renzi in seguito al vertice europeo di Bratislava della scorsa settimana, con le sue dure critiche nei confronti dello stallo politico sulla questione dei migranti e per la totale assenza, in quel consesso, di qualunque minimo riferimento al tema dell’Africa. Una mossa, questa del premier, da alcuni addirittura qualificata come arrogante ed esagerata, quasi da gradasso. Io penso invece che, mai come in questo momento e su questo tema specifico, la voce del nostro primo ministro doveva essere così chiara e così decisa, senza spazi per alcun accomodamento.
Un’Europa che non è in grado di prendere una posizione chiara e di perseguire una decisa politica di dialogo e collaborazione con il continente africano lasciando Grecia, Italia e gli altri paesi del confine meridionale in prima linea nella gestione dei flussi quasi fossero problemi nazionali, è il vero nodo politico di questo momento storico così complesso.
Anche perché va detto che c’è poca informazione sulle dinamiche sociali e demografiche in atto in Africa, dinamiche che porteranno l’attuale miliardo di africani (corrispondente al 15% della popolazione mondiale) a divenire, secondo proiezioni statistiche condivise, 1,8 miliardi nel 2050 e corrispondere quindi al 25% della popolazione mondiale.
Se poi si osserva che l’Africa ha la popolazione più giovane del mondo, con due cittadini su tre che hanno meno di 25 anni, bisogna prendere atto che nei prossimi anni si affacceranno sul mercato del lavoro 15 milioni di giovani africani all’anno.
Questi sono i fatti, e non c’è alcun dubbio che una politica miope da parte dell’Europa, che peraltro porta responsabilità storiche enormi nei confronti dello sviluppo africano (prime tra tutte colonialismo e neocolonialismo che per secoli hanno saccheggiato e sfruttato selvaggiamente le risorse di questo continente), porta e porterà sempre di più in futuro a pagare lo scotto di un esodo di proporzioni sempre maggiori. Questo perché non si può costringere milioni di giovani a restare in paesi senza prospettive e senza lavoro, specie quando questa situazione è creata da ingiustizie perpetrate negli anni proprio da quei paesi occidentali che oggi costruiscono muri, fatti di mattoni o di leggi che siano.
Non solo l’Europa dovrà trovare risposte adeguate, ma dovrà anche farlo in fretta.
Se da un lato la politica, come scriveva Ezio Mauro qualche giorno fa su questo stesso giornale, ha il compito ineludibile di affrontare i temi della sicurezza e della solidarietà, dall’altro lato si deve introdurre il tema della fraternità proprio in seno allo stesso dibattito pubblico. Non è poesia e nemmeno utopia ingenua, questa è realpolitik.
Nei giorni in cui a Torino si apre Terra Madre, la grande assise dei contadini del mondo, la centralità del continente africano e l’importanza, al suo interno, di un settore agricolo vitale che va dall’agricoltura di sussistenza fino alle grandi aziende agricole intensive, ci richiama a una riflessione su un processo di sostegno di economie locali che l’Europa, non per carità pelosa ma quasi per un dovere di responsabile “restituzione”, deve avere il coraggio di mettere in atto. Uno sforzo di cooperazione seria in questo senso può rappresentare una grande leva di cambiamento, un reale passo nella direzione dell’equità e della giustizia.
Davanti alla violenza delle guerre, del cambiamento climatico e all’arroganza del land grabbing, il ruolo di milioni di agricoltori di piccola scala che in Africa prendono in mano con responsabilità i destini delle comunità locali e di una sana economia territoriale è decisivo per offrire risposte serie, credibili e di ampio respiro. E su questo le istituzioni europee e nazionali non possono rimanere silenti e inattive, perché in questo processo si gioca anche il futuro del vecchio continente e dei suoi abitanti.
Se sicurezza e solidarietà sono i pilastri del mandato politico, questi non possono sussistere senza la fraternità a costituirne la base. Citando Edgar Morin “ho fede nell’amore, nella fraternità, nell’amicizia… Dobbiamo essere fratelli proprio perché siamo perduti”.
postilla
Guido Viale ed Alex Zanotelli hanno ampiamente illustrato, in due scritti che abbiamo ripreso in eddyburgIl gioco crudele del Migration compact e No Migration Compact la vergogna di quella
proposta. Essa consiste essenzialmente nello stornare i finanziamenti destinati all'Africa per opere socialmente utili per indurre invece gli stati di provenienza dei migranti a effettuare un rigido controllo delle frontiere, ridurre forzosamente i flussi migratori e cooperare e in materia di rimpatri/riammissioni. L'estensioni insomma ai regimi africani dell'accordo fatto con la Turchia di Erdogan, il cui obiettivo è trattenere i migranti nei paesi di origine, da cui fuggono per miseria, guerre, carestie. delle risorse degli africani, che proprio da quello sfruttamento, e dalla corruzione dei loro governanti, sono stati gettati nella miseria e nella disperazione. È facile intravedere dietro il migration compact quegli interessi che il governo italiano da tempo sponsorizza, e da cui si fa sponsorizzare.
 «I coniugi Calò, una famiglia del trevigiano, ospitano da oltre un anno sei profughi . "Quando soffia il vento del cambiamento, c’è chi costruisce muri e chi mulini"». La
«I coniugi Calò, una famiglia del trevigiano, ospitano da oltre un anno sei profughi . "Quando soffia il vento del cambiamento, c’è chi costruisce muri e chi mulini"». La
Repubblica, 22 settembre 2016 (c.m.c.)
«I soldi per i migranti ci sono. I progetti anche. Rendiamo trasparenti i bilanci a faremo grandi cose». Antonio Calò, docente di Filosofia di Treviso non usa mezze parole, soprattutto dopo aver letto l’intervento su Repubblica del sindaco di Milano Giuseppe Sala, tanto che ha chiesto di incontrarlo subito.
È stanco di vedere i migranti seduti nei parchi o vagabondare per le strade senza fare nulla, ma soprattutto è stanco di vedere un’Italia che non sfrutta appieno le sue risorse. Da quindici mesi lui, la moglie Nicoletta Ferrara e i loro quattro figli, vivono con sei migranti africani. Una famiglia allargata di dodici persone. Una scelta costata inizialmente una pioggia di insulti da parte di chi li accusava di speculare sui richiedenti asilo. In realtà, è proprio grazie a questa esperienza che Calò ha elaborato un sistema di accoglienza per i migranti che non è passato inosservato. E la sua proposta ha ricevuto proprio ieri l’elogio ufficiale dal presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker.
Oggi una struttura di accoglienza riceve circa 30 euro al giorno per migrante da finanziamenti europei e in parte italiani. Due euro e mezzo sono per i richiedenti asilo, il resto va alla struttura. «Condivido ogni parola di Sala — spiega Calò, premiato per il suo esempio di generosità dal presidente Sergio Mattarella — Accogliendo sei migranti ci siamo ritrovati a gestire 5400 euro al mese.
Noi siamo la dimostrazione che con quei soldi si può fare tantissimo e si può dare lavoro ad altre persone come abbiamo fatto assumendo una psicologa e una persona tuttofare per aiutarci». Calò sostiene che dovrebbe essere necessario un decreto governativo che approvi un modello organizzativo unico di accoglienza, applicabile su tutto il territorio e magari oltre. «Se ogni Comune accogliesse sei migranti — prosegue — e nelle città più grandi ne fossero collocati sei per ogni quartiere in un appartamento, si creerebbero piccoli nuclei di persone che possono essere controllate e formate».
I soldi dei Calò vengono suddivisi così: mille euro per le spese alimentari, 1400 per la signora tuttofare, 450 come paghetta, 600 euro in bollette e servizi casa, 300 per la cooperativa, 300 per spese sanitarie, 250 per benzina, 700 per la psicologa e i 400 che avanzano per altre voci come avvocato o ricongiungimento familiari.
«Qui arriva un’umanità ferita – continua – dobbiamo smetterla di considerarli ospiti, ma futuri cittadini». La novità del modello Calò è che contempla delle figure obbligatorie (la psicologa, l’insegnante di italiano, l’educatore) che attualmente sono facoltative. La famiglia abita a Camalò di Povegliano, duemila anime nel trevigiano. Qui, tra le bandiere a favore dell’indipendenza del Veneto, sul tetto dei Calò ne sventola una blu con un cerchio di dodici stelle. È il sogno dell’Europa che vorrebbero.
E a chi domanda cosa ne pensano di un’Europa che invece alza gli scudi, rispondono: «Quando soffia il vento del cambiamento, c’è chi costruisce muri e chi mulini».

«Dopo i cinque anni al vertice, Kim si affaccia al secondo mandato senza avere rivali. Una farsa che in Banca mondiale va avanti da parecchi anni». Re:Common, 22 settembre 2016 (p.d.)
La settimana scorsa è scaduto il termine per la presentazione delle domande per l’ambita posizione di Presidente della Banca mondiale. L’unico a farsi avanti su proposta del governo statunitense – serve infatti un esecutivo che avanzi le candidature – è stato proprio l’attuale capo dell’istituzione, Jim Yong Kim.
Dopo i cinque anni al vertice, Kim si affaccia al secondo mandato senza avere rivali. Una farsa che in Banca mondiale va avanti da parecchi anni, dal momento che per tradizione è il governo americano di fatto a nominare il Presidente – così come i governi europei “indicano” il Direttore del Fondo monetario internazionale.
Questa volta tutti si attendevano che emergesse un candidato più forte e credibile. Anche perché Kim ha clamorosamente fallito. Il dottore americano di origini sudcoreane, fortemente voluto da Barack Obama per il suo passato nella lotta all’Hiv, ha infatti deluso tanti, che ne hanno chiesto le dimissioni, o quanto meno un non rinnovo del suo mandato. In primis l’Associazione dello staff della Banca stessa, che ha criticato ferocemente la sua riforma della struttura interna e la mancanza di leadership su molti dossier.
Inoltre Kim è stato giudicato in maniera negativa da diverse organizzazioni della società civile internazionale, che sotto la sua guida hanno constatato un annacquamento delle politiche ambientali e sociali, un utilizzo di nuovi strumenti finanziari opachi e un ritorno del sostegno alle grandi dighe in Africa e altrove, progetti che comportano spesso pesanti impatti ambientali e sociali. Kim ha fatto inorridire molti attivisti quando recentemente ha affermato che lo sviluppo comporta inevitabilmente spostamenti di massa.
Per dovere di cronaca va aggiunto che mai come negli ultimi cinque anni la Banca mondiale ha vissuto accesi conflitti Nord-Sud al suo interno, o per meglio dire paesi occidentali contro paesi emergenti. Diversi dossier sono stati fermati proprio dall’opposizione dei governi del Sud globale che oramai contano davvero, Cina in primis.
Nonché la World Bank per la prima volta vive la competizione di nuove istituzioni finanziarie internazionali create fuori dall’orbita statunitense, quali la Banca Asiatica per gli Investimenti nelle Infrastrutture e la Nuova Banca di Sviluppo dei paesi BRICS. Una competizione tutta geopolitica, più che riguardo cosa queste realtà vogliano finanziarie, dal momento che parliamo sempre di grandi opere vecchio stile condite della solita ideologia liberista – vedi il nuovo mantra del settore privato come unico e indiscutibile motore di sviluppo.
Così la “vecchia” World Bank compete al ribasso, anch’essa tornando a finanziare mega opere infrastrutturali, facendo un po’ meno attenzione all’ambiente e ai diritti sociali, non parlando di diritti umani per non urtare le sensibilità di alcuni, sebbene a parole la difesa del clima e dei diritti delle donne sono la priorità.
Che succederà a questo punto? Kim facilmente otterrà il secondo mandato, già agli incontri di ottobre di Banca e Fondo monetario. Per i governi del Sud una Banca mondiale debole, ma che presta sempre tanto, è utile. I paesi del Nord, quali quelli europei, cercano sempre di prendere sufficienti appalti per le loro imprese, cercando di far contribuire un po’ di più i paesi emergenti. Insomma, tutto cambi affinché nulla cambi alla Banca mondiale.
Chissà se nell'ampia congrega dei governanti del Globo c'è qualcuno che comprende e condivide.. Il manifesto, 21 settembre 2016
«Tutti, con la guerra, sono perdenti, anche i vincitori». Si è conclusa con una severa condanna della guerra, sottoscritta dai leader religiosi di tutto il mondo, la Giornata mondiale di preghiera per la pace che si è svolta ieri ad Assisi, a conclusione di un meeting di tre giorni promosso dalla Comunità di Sant’Egidio e dai francescani.
Cristiani, ebrei, musulmani, induisti, buddhisti (ma non c’era il Dalai Lama, non invitato evidentemente per non turbare il percorso di riavvicinamento fra Santa Sede e Pechino), oltre 500 rappresentanti delle diverse religioni del mondo si sono ritrovati trent’anni dopo il primo incontro convocato sempre ad Assisi da Giovanni Paolo II nel 1986, quando il mondo era diviso in due blocchi, e papa Wojtyla voleva issare più in alto di tutti il vessillo della pace, anche in funzione anticomunista.
Oggi la guerra fredda non c’è più, ma c’è una «terza guerra mondiale a pezzi», come papa Francesco ha più volte chiamato l’insieme dei conflitti che devastano il mondo. E allora le religioni, sostiene il pontefice, possono collaborare per la pace, perché «mai il nome di Dio può giustificare la guerra, solo la pace è santa e non la guerra», condannando implicitamente secoli di «guerre sante» fatte pretendendo di avere Dio – anche e soprattutto il Dio dei cristiani – dalla propria parte («dobbiamo essere capaci fare autocritica», ha detto nel suo intervento finale il patriarca ecumenico ortodosso di Costantinopoli, Bartolomeo).
La guerra, più che il terrorismo. Non perché il terrorismo non vada condannato, ma perché la guerra è molto più grave. «Ci spaventiamo per qualche atto di terrorismo», ma «questo non ha niente a che fare con quello che succede in quei Paesi, in quelle terre dove giorno e notte le bombe cadono e cadono» e «uccidono bambini, anziani, uomini, donne», ai quasi «non può arrivare l’aiuto umanitario per mangiare, non possono arrivare le medicine, perché le bombe lo impediscono», ha detto Bergoglio durante la messa mattutina a Santa Marta, prima di lasciare il Vaticano per Assisi, dove è arrivato poco dopo le 11. Al convento della basilica di San Francesco ad attenderlo c’erano Bartolomeo, il primate anglicano Justin Welby, il patriarca siro ortodosso di Antiochia Ignatius Aphrem II, il rabbino capo della comunità ebraica di Roma Riccardo Di Segni, il vicepresidente dell’università islamica di Al Azhar Abbas Shuman e gli altri leader religiosi. Pranzo nel refettorio del convento, a cui hanno partecipato anche 12 rifugiati provenienti da zone di guerra.
Nel pomeriggio i rappresentanti delle fedi si sono riuniti in preghiera in luoghi separati, anche per allontanare quelle accuse di «sincretismo» e di «relativismo» rivolte dai settori cattolici più conservatori a papa Francesco – e trent’anni fa a Wojtyla – ma anche agli altri leader religiosi, perché gli integralisti non sono un’esclusiva di nessuno.
I cristiani (cattolici, ortodossi, luterani e anglicani) si sono ritrovati nella basilica inferiore di San Francesco. «Le vittime delle guerre implorano pace», ha detto il papa, «implorano pace i nostri fratelli e sorelle che vivono sotto la minaccia dei bombardamenti o sono costretti a lasciare casa e a migrare verso l’ignoto», ma «incontrano troppe volte il silenzio assordante dell’indifferenza, l’egoismo di chi è infastidito, la freddezza di chi spegne il loro grido di aiuto con la facilità con cui cambia un canale in televisione». Quindi una lunga preghiera per 27 territori dilaniati dai conflitti: dall’Afghanistan al Congo, dall’Iraq alla Libia, dal Sud Sudan allo Yemen, la Palestina, la Siria.
Tutti insieme poi – vescovi, patriarchi, pastori, rabbini, imam e tutti gli altri – in piazza San Francesco per i messaggi conclusivi. «Non ci può essere pace senza giustizia, una rinnovata economia mondiale attenta ai bisogni dei più poveri» e la «salvaguardia dell’ambiente», ha detto Bartolomeo. «La storia ci ha mostrato che la pace conseguita con la forza sarà rovesciata con la forza», ha ammonito Morikawa Tendaizasu, leader del buddhismo Tendai. «L’islam è una religione di pace, oggi ci sono gruppi che usano il nome dell’islam per perpetrare azioni violente, è responsabilità di noi musulmani mostrare il vero volto della nostra fede», ha esortato il presidente del Consiglio degli Ulema indonesiani Din Syamsuddin. La pace «non può scaturire dai deserti dell’orgoglio e degli interessi di parte, dalle terre aride del guadagno a ogni costo e del commercio delle armi», dalle «chiusure che non sono strategie di sicurezza ma ponti sul vuoto», ha detto papa Francesco.
Infine l’appello conclusivo, sottoscritto dai leader religiosi e inviato agli ambasciatori di tutto il mondo. «Imploriamo i responsabili delle Nazioni perché siano disinnescati i moventi delle guerre: l’avidità di potere e denaro, la cupidigia di chi commercia armi, gli interessi di parte, le vendette per il passato. Aumenti l’impegno concreto per rimuovere le cause soggiacenti ai conflitti: le situazioni di povertà, ingiustizia e disuguaglianza, lo sfruttamento e il disprezzo della vita umana».
 , con postilla (m.c.g.)
, con postilla (m.c.g.)
Roma, 14 settembre 2016
Oggetto: Udienza pubblica del 20 settembre 2016. Internazionalizzazione (inglesizzazione) di atenei e scuole italiane.
Illustre Presidente, illustre Relatore,
illustri Giudici della Corte Costituzionale,
non entreremo giuridicamente nel merito del perché e del come, la cosiddetta internazionalizzazione” si attui nazionalizzando in inglese l’istruzione in italiano della Repubblica, partendo dall’alta formazione per proseguire verso il basso distruggendola in radice, né entreremo nel merito della questione di legittimità costituzionale dei provvedimenti adottati dal Politecnico di Milano in relazione all’art. 2, comma 2, lett. l) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte di cui in motivazione, in riferimento agli articoli 3, 6, e 33 della Costituzione, come recita il dispositivo del Consiglio di Stato.
È però nostro compito di Partito, attento da sempre ai diritti delle minoranze, allarmarci per quanto sta succedendo, addirittura, ad un popolo sovrano, qual è quello italiano, che vede sempre più lesi i propri diritti linguistici in Italia, e non difesi in Europa, dove la Commissione consulta la popolazione europea quasi esclusivamente in inglese persino su argomenti, come quelli dell’immigrazione, che coinvolgono massicciamente la popolazione italiana.
Umberto Eco in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia in Quirinale ebbe a dire che “Un dialetto è una lingua a cui è mancata l’università, e cioè la pratica della ricerca e della discussione scientifica e filosofica”, ne consegue che governi, ministri, parlamentari, rettori, docenti, e chiunque altro tolga spazio allo studio in italiano di qualsivoglia materia nell’università, vuole la dialettizzazione della lingua italiana. Svolge un’azione sovversiva tesa alla perdita di sovranità linguistica dell’Italia per consegnarla in mano straniera. Oggi persino extracomunitaria, in quanto con la Brexit, esce anche l’inglese (notificato all’UE dal solo Regno Unito quale lingua ufficiale), dalle lingue comunitarie. Entra così in cortocircuito anche il sistema della lingua straniera in Italia che ha assegnato all’inglese il ruolo di prima lingua tra le 4 maggiori dell’Unione.
Quanto sta accadendo va sotto il nome di Imperialismo delle Menti, dicitura coniata da Churchill nel 1943 quale prefigurazione di quelli che avrebbero dovuto essere gli Imperi del futuro con, al centro dell’azione distruttrice, la lingua degli altri popoli, in quanto «Il potere di dominare la lingua di un popolo offre guadagni di gran lunga superiori che non il togliergli province e territori o schiacciarlo con lo sfruttamento». Ed oggi le forze, materiali ed ideologiche, alle spalle dell’inglese sono così forti che il suo ruolo egemonico è stato interiorizzato. L’inglese tende ad essere promosso nel mondo come se fosse apolitico, e se non servisse interessi speciali. Gli usi e le forme dell’inglese ricevono perciò un contributo all’occupazione globale delle menti con modalità che verosimilmente sono al servizio degli scopi del controllo aziendale e dell’intimidazione, cooptazione e coercizione, perpetuando l’imperialismo linguistico-culturale. Là dove vogliamo che gli essere umani non debbano essere dominati dalle cose, e che la subordinazione di alcune persone ad altre cessi per sempre.
Al Politecnico di Milano nell’anno accademico 2014/15, su 39 corsi di laurea magistrale, 33 sono in inglese e solo 6 in italiano ma, questi ultimi, non resisteranno a lungo perché, persino chi opera con la doppia lingua italiano/inglese, viene penalizzato dal Rettore, il quale eroga 90.000 euro solo per i corsi di studio che scelgono l’ordinamento della laurea magistrale esclusivamente in inglese. Opera di corruzione vera e propria tesa ad espropriare la lingua e la cultura italiana alla Repubblica. Così, anziché arricchire la cultura italiana, partecipare e nutrire il dibattito pubblico, si crea una roccaforte d’intellettuali inglesizzati che non hanno nessun tipo di relazione con il paese dove l’università opera, che sono pagati coi soldi dei contribuenti italiani, ma che non ricambiano il salario con un lavoro intellettuale accessibile a tutti gli italiani.
Le università divengono, di fatto, enclave straniere in Italia, dalle quali escono studenti non più mentalmente italiani, incapaci di pensare scienza e tecnica in italiano, di fatto “agenti” stranieri promotori, a loro volta, d’impoverimento occupazionale italiano e arricchimento straniero o trasformazione anglofona delle imprese italiane, di emarginazione del resto della popolazione italofona.
Si pensi ancora al caso del PoliMi, con circa 12.800 iscritti alle lauree magistrali, ipotizzando una media di 14 esami nel biennio per corso di laurea, un solo libro di 25 € per esame, l’84% degli iscritti ai 33 corsi di laurea solo in inglese, la per dita biennale per la sola editoria scientifica italiana ed, evidentemente di tutto il sistema occupazionale di settore e di filiera, è di circa 125.086.500 Euro (25x14x33x10830). poi da prevedere una futura classe di laureati magistrali docenti nei licei scientifici e tecnologici che insegneranno termini scientifici e tecnici inglesi, innescando un meccanismo perverso che distruggerà per sempre il lessico tecnico-scientifico in lingua italiana.
Basta aggiungere questa cifra alle altre risultanti dai vari corsi solo in inglese delle molteplici università italiane, delle scuole secondarie, delle materie insegnate solo in inglese col metodo CLIL e, sotto i nostri occhi, l’accecante evidenza è che, attraverso l’istruzione, si sta perpetrando il genocidio linguistico e culturale della Repubblica italiana.
Distinti ed ossequiosi saluti, Giorgio Pagano
Responsabile della campagna per la lingua comune della specie umana
Una delibera del Senato Accademico del Politecnico di Milano del 21 maggio 2013, in nome dell’internazionalizzazione tanto ambìta dal Rettore Giovanni Azzone, rese l’inglese lingua obbligatoria per tutti i corsi di specializzazione e per i dottorati. Un nutrito numero di docenti (circa 100), critici sul carattere esclusivo della decisione, fece ricorso al TAR Lombardia denunciando il fatto che la decisione del senato accademico violava il diritto costituzionale ad accedere a corsi universitari erogati nella lingua ufficiale della Repubblica italiana, garantito ai cittadini in ragione del principio di eguaglianza di tutti di fronte alla legge. Una sentenza del TAR diede sostanzialmente ragione ai ricorrenti (n. 1348/2013) provocando un contro-ricorso del Politecnico, e del ministero dell’Istruzione dell’epoca, che trasferirono la questione al Consiglio di Stato il quale, a sua volta, si appellò alla Corte Costituzionale: questi i fatti all’origine dell’udienza prevista per il 20 settembre 2016.
La lettera inviata dai Radicali, pur prendendone spunto e approfondendone criticamente gli esiti indesiderabili, travalica la questione avanzata dai docenti nei confronti delle autorità accademiche del Politecnico, e affronta problematiche, quali il rischio di “dialettizzazione” della lingua italiana e di “imperialismo delle menti”, che chiamano in causa la dimensione politica ed economica delle strategie dei poteri forti in ambito europeo (e globale) che dell’uso esclusivo dell’inglese si avvalgono non soltanto come forma di dominio culturale. Nella lettera si colgono altresì alcune affinità con le riflessioni critiche contro l’inglesizzazione e la discriminazione linguistica avanzate in seno al Parlamento Europeo da Barbara Spinelli.
Nel frattempo il Rettore del Politecnico, in procinto di terminare il suo mandato - il cui indubbio merito è stato di suscitare un dibattito e una conflittualità vivacissimi all’interno di un corpo docente che sembrava ormai anestetizzato - si prepara a svolgere compiti strategici a livello nazionale. Giovanni Azzone infatti, già nominato nel marzo 2016 Presidente di AREXPO, la società (partecipata da Regione Lombardia, Comune di Milano e, dal febbraio 2016, dal Governo) che si occuperà della ‘valorizzazione’ dell’area exEXPO, è stato scelto da Matteo Renzi come project manager (eccolo di nuovo l’irritante e inutile anglicismo) di “Casa Italia”: il piano di prevenzione contro i terremoti allo studio del Governo dopo la ennesima tragedia che ha colpito Amatrice e i comuni limitrofi. Mai scelta fu più “inappropriata”. (m.c.g.)
 "». La
"». La Repubblica
, 21 settembre 2016 (c.m.c.)
I Leader mondiali si sono riuniti a New York per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e in cima alla loro agenda c’è una crisi dei profughi che ha raggiunto livelli di drammaticità che non si vedevano dai tempi della seconda guerra mondiale. Il vertice delle Nazioni Unite per i rifugiati e i migranti e il vertice sui rifugiati voluto dal presidente Obama rappresentano uno spartiacque che richiama l’attenzione del pianeta sulla necessità di una risposta efficace a una crisi umanitaria sempre più grave.
Il nostro parere comune si basa su una lucida consapevolezza dei pericoli che abbiamo di fronte. Dopo l’esplosione di un ordigno nel quartiere di Chelsea a New York, lo scorso weekend, e altri attacchi in città di tutto il mondo, siamo consapevoli che la sicurezza di tutti i nostri cittadini è prioritaria in società grandi, aperte e democratiche. Ma è sbagliato dipingere le comunità di immigrati e profughi come radicali e pericolose. Dobbiamo continuare a perseguire un approccio inclusivo all’insediamento dei profughi, per contrastare l’onda crescente di dichiarazioni xenofobe in tutto il mondo, che serviranno solo a emarginare ancora di più le nostre comunità di immigrati senza renderci in alcun modo più sicuri.
Noi, sindaci di tre grandi città globali — New York, Parigi e Londra — esortiamo i leader mondiali riuniti alle Nazioni Unite a prendere misure decise per garantire soccorso e un rifugio sicuro ai profughi in fuga dai conflitti e ai migranti in fuga dalla miseria, e sostenere coloro che questo lavoro lo stanno già facendo.
Anche noi faremo la nostra parte. Le nostre città si impegnano a continuare a battersi per l’inclusività, ed è per questo che sosteniamo servizi e programmi che aiutano tutti i residenti, incluse le tante comunità di immigrati, a sentirsi bene accolti, in modo che ogni residente possa sentirsi parte delle nostre grandi città.
A New York e a Parigi, per esempio, programmi di “carte d’identità comunali” hanno migliorato notevolmente il senso di appartenenza fra gli immigrati e hanno consentito un maggior accesso a servizi come conti bancari e indennità per veterani, e a risorse comunali come biblioteche e istituzioni culturali. In meno di due anni, il programma di New York, conosciuto come IdNyc, ha registrato oltre il 10 per cento della popolazione cittadina complessiva e ha ricevuto i complimenti di una variegata coalizione di esponenti delle comunità, associazioni di supporto e partner istituzionali.
Programmi come IdNyc costruiscono città più sicure, perché gli immigrati e i profughi sanno di essere inclusi e riconosciuti dalle amministrazioni pubbliche. A New York, la polizia è stata un partner fondamentale nella creazione del programma, perché i residenti sono più disposti a denunciare reati quando hanno un documento di identità che è accettato dalle forze dell’ordine. A Parigi, nuove misure come la Carte Citoyenne e il bilancio partecipativo, che lascia decidere ai parigini come utilizzare una parte del bilancio annuale del Comune, offrono a tutti i residenti l’opportunità di partecipare alla vita cittadina e diventare stakeholder locali, senza alcuna restrizione.
Investire nell’integrazione dei rifugiati e degli immigrati non è soltanto la cosa giusta da fare, ma anche la cosa intelligente da fare. I rifugiati e altri residenti nati all’estero portano con sé competenze importanti e aumentano la vitalità e la crescita delle economie locali, e la loro presenza da molto tempo porta beneficio alle nostre tre città.
A New York, quasi metà dei proprietari di piccole imprese sono immigrati che contribuiscono a pagare le tasse e creano altri posti di lavoro per il resto dei newyorchesi. Londra recentemente ha dato il via a una campagna pubblicitaria chiamata # LondonIsOpen, che mette in evidenza storie di successo simili, scelte fra i tre milioni di londinesi che sono nati all’estero e contribuiscono alla creatività, alla vitalità e allo spirito imprenditoriale della città.
Le nostre città sono anche in prima linea per aiutare chi fugge da violenze e persecuzioni a entrare in contatto con servizi fondamentali, spesso vitali per la sopravvivenza. Parigi è una delle prime municipalità importanti ad aver aperto un centro profughi nel cuore della città. A partire da ottobre, questo centro fornirà servizi e necessità di base, oltre che supporto amministrativo, a 400 profughi. Il Comune di New York ha collocato funzionari comunali nel tribunale per l’immigrazione, per collegare le migliaia di richiedenti asilo minorenni non accompagnati del Centro America a servizi sanitari, scolastici e sociali di fondamentale importanza. L’anno scorso i distretti amministrativi di Londra hanno fornito supporto a oltre mille bambini richiedenti asilo non accompagnati, e il Comune sta elaborando nuovi metodi per lavorare insieme alle comunità e offrire supporto ai rifugiati.
Noi sappiamo che le politiche che abbracciano la diversità e promuovono l’inclusione sono efficaci. Ci appelliamo ai leader mondiali perché adottino uno spirito analogo di accoglienza e collaborazione in nome dei rifugiati di tutto il mondo, durante il vertice di questa settimana. Le nostre città sono unite in questo appello all’inclusività: è parte della nostra identità di abitanti di città ricche di diversità e prosperità.
Traduzione di Fabio Galimberti
Saggia prudenza dei custodi della Costituzione, o "aiutino" a chi vuole distruggerla in nome della "governabilità"? Ancora difficile comprenderlo. Il manifesto, 20 settembre 2016
Tanto tuonò che piovve. I rumors su un rinvio da parte della Corte costituzionale, e su contrasti nel merito, erano diventati insistenti. È ora ufficiale la notizia del rinvio dell’udienza del 4 ottobre, di cui non si conoscono al momento le motivazioni. È uno strappo non insignificante. Sarebbe fragile l’argomento di un’attesa per l’ultima ordinanza di Perugia, perché la Corte ben avrebbe potuto decidere su quanto è agli atti, e tornare poi sulla questione con sentenza o ordinanza. Ugualmente fragile sarebbe una motivazione fondata sull’attesa del referendum, dal momento che le questioni sollevate davanti alla Corte hanno a oggetto una legge formalmente non toccata dal voto. Nasce il sospetto che siano proprio i contrasti di merito che suggeriscono alla Corte di prendere tempo. O forse la consapevolezza che una riaffermazione anche parziale dei principi posti con la sentenza 1/2014 avrebbe di fatto inferto un colpo alla strategia referendaria del governo.
Vedremo se il rinvio sarà breve, e se la nuova data cadrà comunque prima del voto. In caso contrario, avremmo preferito, per la salute delle istituzioni e per la stessa Corte, che il rinvio non vi fosse. Il rinvio diventa un altro capitolo del romanzo referendario, che si arricchisce sempre più anche di personaggi stranieri più o meno autorevoli che offrono consigli e raccomandazioni agli italiani. L’ultimo è Weidmann, presidente della Banca centrale tedesca, e falco tra i falchi sui temi del bilancio e dell’austerity. Per lui, Draghi è un pericoloso guastatore, e Renzi una zecca fastidiosa. Ma Italicum e Jobs Act – e l’accostamento è di per sé suggestivo e preoccupante – sono la soluzione giusta per il nostro paese.
A Berlino troviamo conferma di un processo in atto da tempo. In Germania, come in Gran Bretagna, in Francia o in Spagna, partiti storici che hanno monopolizzato i consensi per decenni vedono progressivamente disgregarsi la propria base elettorale. Il bipolarismo si frantuma. Questo non è stato impedito da nessun sistema elettorale. I paesi citati hanno sistemi molto diversi, dal maggioritario
uninominale secco di collegio britannico al proporzionale misto della Germania, passando per il doppio turno francese e i microcollegi spagnoli. Per tutti la frantumazione del sistema politico si è verificata irresistibilmente, e non è stata impedita la nascita di partiti antagonisti o antisistema. Questo può certo condurre a giudizi politici negativi. Ma comunque ci insegna che nessun artificio elettorale o marchingegno istituzionale può impedire alla politica di prendere il sopravvento. Il paese reale, con le sue domande, i suoi bisogni, le sue pulsioni, le sue paure, alla fine viene fuori. Ne viene che una deriva politica che non piace si combatte con la politica, e non con gli algoritmi. È per questo che in nessuno dei paesi citati ci si inventa una legge elettorale pensata per mettere le brache al sistema politico. È quello che invece ha fatto Renzi, quando per ovviare al tramonto del bipolarismo italiano ha messo in campo un megapremio che dà ad una delle minoranze un surplus di seggi parlamentari tale da farne una maggioranza truffaldina, blindata e inattaccabile, e per di più al servizio del premier. Personalmente sono da tempo convinto che una cura di proporzionale sarebbe essenziale per restituire buona salute al sistema politico. È mai possibile che in Italia non esista più un’assemblea elettiva – una sola, dai municipi al parlamento – che esprima il paese com’è, senza artifici e distorsioni? E dovremmo prendere atto che l’ubriacatura del decisionismo non ha dato efficienza alla politica e alle istituzioni.
Maggiori è più difficili sono i problemi, più ampia deve essere la partecipazione democratica e la condivisione. La risposta non può mai trovarsi nel modello istituzionale autoreferenziale e oligarchico imposto da Renzi, e che i sostenitori pomposamente definiscono «democrazia decidente». È il modello che piace a Weidmann. Ma non è un caso che ai classici del costituzionalismo questa formula sia ignota, per l’ossimoro che fatalmente viene dal decidere restringendo la partecipazione. Suggeriamo a Weidmann di interrogarsi sul perché, a fronte del terremoto berlinese che segue a quello del Meclemburgo-Pomerania, non si proceda in Germania a copiare Renzi. E vogliamo aggiungere una parola per l’ambasciatore Usa, per il suo endorsement al governo e alle riforme. Forse l’ambasciatore non sa che negli Stati Uniti si è discusso per decenni della riforma del sistema elettorale presidenziale, che molti pensano sia un’elezione diretta ma che tale non è, posto che l’elezione in senso proprio ha luogo in un Collegio Elettorale che è un’invenzione di stampo settecentesco. Pensate alla felicità della Boschi se potesse dire che da oltre duecento anni si era in attesa di una riforma. Potremmo prestarla al paese amico, come si fa con le opere d’arte. Magari anche senza assicurazione.
 E' giusto che il governo si preoccupi dei comuni. Ma sarebbe ancora più giusto che si occupasse dei rifugiati non solo come balle di rifiuti da sistemare qui e là, ma come persone, magari avvalendosi delle esperienze che comuni virtuosi stanno praticando da tempo. La
E' giusto che il governo si preoccupi dei comuni. Ma sarebbe ancora più giusto che si occupasse dei rifugiati non solo come balle di rifiuti da sistemare qui e là, ma come persone, magari avvalendosi delle esperienze che comuni virtuosi stanno praticando da tempo. La Repubblica
, 20 settembre 2016
«Togliere ai grandi, per dare ai piccoli». Al Viminale il nuovo Piano nazionale d’accoglienza lo sintetizzano così: «Alleggeriremo le metropoli, come Roma e Milano, pretendendo che tutti, anche i paesi più piccoli, facciano il loro». Le nuove quote promettono infatti di rivoluzionare la distribuzione dei migranti. Nessuno sarà escluso.
I comuni verranno divisi in tre gruppi: quelli fino ai 2.000 abitanti, con più di 2.000 abitanti e città metropolitane. Le quote? Massimo 5 migranti per i primi, 2,5 ogni mille abitanti per i secondi, “solo” 1,5 profughi ogni mille residenti per i comuni metropolitani. Chi collaborerà verrà premiato con deroghe al blocco delle assunzioni e 50 centesimi giornalieri per ogni richiedente asilo ospitato.
Il nuovo piano è stato discusso il 6 settembre scorso al Viminale tra il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, il presidente dell’Anci, Piero Fassino, il capo della Polizia, Franco Gabrielli e il capo del Dipartimento libertà civili e immigrazione, Mario Morcone. Il documento ancora non è stato “firmato” dai comuni italiani, ma la bozza già circola al ministero e vuole essere una prima risposta a chi chiede (come ha fatto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ieri su Repubblica) «un’equa distribuzione sul territorio dei profughi».
Oggi infatti la rete d’accoglienza italiana è al limite. I numeri sono tutti da record: al 19 settembre sono sbarcati 130.561 migranti (il 5,53% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), i minori stranieri non accompagnati sono ben 16.611 (in tutto il 2015 non avevano superato i 12.360) e i migranti ospitati in strutture temporanee e centri governativi sono schizzati a 158.479 (l’anno scorso erano stati 103mila). A fare di più sono oggi Lombardia (20.843 migranti accolti), Sicilia (14.189), Lazio (12.874), Veneto (12.211), Piemonte (12.350) e Campania (12.089). Ma ora tutti dovranno rimboccarsi le maniche. Il nuovo piano prevede infatti un «sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati diffuso sull’intero territorio nazionale, che garantisca una ripartizione equilibrata».
Tutti saranno coinvolti. Anche i piccoli centri.
«Oggi in Italia su 8.200 comuni – spiega Christopher Hein, consigliere strategico del Cir (Consiglio italiano rifugiati) – solo poco più di 500 partecipano al piano per l’accoglienza». Cosa cambierà? Le future quote prevedono 2,5 migranti ogni mille abitanti, differenziando i comuni in tre gruppi: fino a 2.000 abitanti, con più di 2.000 e città metropolitane. Nel primo caso il massimo di profughi assegnati sarà di 5. Non è l’unica novità. Per alleggerire il peso sulle grandi città, già in prima linea nell’accoglienza, si prevede uno “sconto” per i 15 comuni metropolitani: la loro quota scende infatti a 1,5 rifugiati ogni mille abitanti. Certo, ogni città volendo potrà fare di più, ma solo su base volontaria.
Il nuovo piano prevede anche una serie di incentivi. I comuni potranno aderire volontariamente allo Sprar (il Sistema di protezione per richiedenti asilo, gestito da Viminale e Anci), altrimenti continueranno a subire i trasferimenti gestiti direttamente dai prefetti. Non solo. Nella prossima legge di bilancio si cercherà di prevedere per i comuni che aderiranno allo Sprar una deroga al patto di stabilità interno, per procedere così a nuove assunzioni necessarie a gestire l’accoglienza. E ancora: ogni comune incasserà 50 centesimi al giorno a migrante a fondo perduto, soldi che saranno tolti dai 2,5 euro che ogni richiedente asilo riceve per le proprie spese personali. «Quello che è essenziale alla riuscita del nuovo piano – spiegano al Viminale – è l’accordo con il maggior numero possibile di enti locali. Altrimenti tutto rischia di saltare».
Altra partita in corso nel governo è l’istituzione di una cabina di regia presso la presidenza del Consiglio, che coordini i vari interventi in materia d’accoglienza, rimpatri e accordi coi Paesi d’origine dei migranti. Insomma, un pool che metta assieme i tanti ministeri competenti. I primi incontri già ci sono stati. Ma, avvertono dal Viminale, quest’ultima “rivoluzione” «non è ancora formalizzata».

Il manifesto, 20 settembre 2016 (p.d.)
Come gestire 65,3 milioni di sfollati? Il problema è al centro della discussione iniziata ieri al Palazzo di vetro delle Nazioni Unite con i leader di tutto il mondo arrivati a New York per il primo vertice dedicato a rifugiati e migranti. Il summit apre la settimana dell’Assemblea generale dell’Onu che sarà l’ultima per il sudcoreano Ban Ki moon e l’ultima per Barack Obama.
Ma come si risolve una crisi del genere? Le Nazioni Unite devono affrontare il problema del più grande movimento di persone della Storia, dopo la fine della seconda guerra mondiale, quindi «si terranno riunioni, conferenze, tavole rotonde, si produrranno documenti finali, discorsi, promesse, maledizioni e vilipendi. Poi a fine giornata, si andrà a casa», ha amaramente dichiarato PassBlue, pubblicazione indipendente che si occupa di diritti umani attraverso la lente delle Nazioni Unite. PassBlue è un progetto fondato nel 2011 dal Ralph Bunche Institute per gli Studi Internazionali presso il Graduate Center dell’Università della Città di New York, non legato finanziariamente o in altro modo alle Nazioni Unite, e sono tutti molto scettici sull’esito di questo summit.
La conferenza su rifugiati e migranti è, comunque, senza precedenti per le Nazioni Unite, i capi di Stato e di governo, i leader delle Nazioni Unite e gli esperti della società civile, dovranno intervenire e cercare di trovare un soluzione per i 65 milioni di uomini, donne e bambini che nel 2015 sono stati costretti ad abbandonare la propria casa. Per il momento hanno partorito un documento, dal titolo la Dichiarazione di New York, non vincolante, con principi e impegni da cui partire per ottenere, entro il 2018, la firma di un Global Compact, un trattato che indichi come affrontare la crisi migratoria.
«È molto interessante – ha dichiarato all’Associated Press Filippo Grandi, alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati – e se saremo in grado di tradurre questo documento in una risposta concreta, in cui si impegnano molti attori politici, si potranno risolvere davvero molti problemi riguardanti situazioni di emergenza o coinvolgenti rifugiati a lungo termine, come per la situazione siriana».
Gli argomenti di discussione comprendono i modi in cui si affrontano le cause profonde dei flussi dei migranti, la futura cooperazione internazionale sul problema, le responsabilità derivanti dal diritto internazionale e la vulnerabilità dei migranti mentre tentano di raggiungere le loro destinazioni. Nel corso dei lavori saranno toccate anche le questioni dei diritti umani e l’attuazione dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.
I risultati al momento sembrano deludenti, viste le difficoltà a raggiungere anche solo una dichiarazione di intenti condivisi.
«L’amara verità è che questo vertice è stato indetto perché abbiamo in gran parte fallito – ha detto Zeid Ra’ad al-Hussein, l’alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani – Non siamo riusciti a porre fine alle sofferenze delle persone in Siria, a porre fine alla guerra al suo esordio. Abbiamo fallito, nei confronti di milioni di migranti che meritano molto di più di vite segnate, dalla culla alla tomba, da umiliazione e disperazione».
Un fallimento ancora più evidente se si considera quello che in origine, era l’ambizioso progetto che Ban Ki moon voleva realizzare: ovvero dividere tra gli Stati membri delle Nazioni unite una quota annua pari al dieci per cento profughi. Per il segretario generale delle Nazioni unite si trattava di un modo per gestire finalmente in maniera ordinata un fenomeno drammatico come quello di chi fugge da guerre, persecuzioni e catastrofi climatiche, riuscendo così a segnare anche la fine del suo mandato. Gli Stati però, non lo hanno permesso. Da settimane nel Palazzo di Vetro si sapeva che nessun impegno preciso sarebbe stato assunto per quanto riguarda un’eventuale spartizione dei profughi. Un rifiuto conseguenza anche del vuoto vissuto non solo all’interno delle Nazioni unite – visto che Ban è praticamente scaduto e il suo successore ancora non è neanche prevedibile – ma anche alla Casa Bianca dove il nome del futuro inquilino è segnato da altrettanta imprevedibilità. E per di più con uno dei due candidati che non perde occasione per dimostrare la sua ostilità nei confronti di profughi e migranti.

Il manifesto, 20 settembre 2016 (p.d.)
Parlare della vicenda dei licenziamenti di rappresaglia nello stabilimento di Nola-Pomigliano, di quella rappresentazione del suicidio dell’amministratore delegato di Fiat-FCA addotta come motivo del licenziamento degli operai che l’avevano messa in scena, è difficile perché è una vicenda che coinvolge una grande mole di sofferenza. Mi è difficile soprattutto circoscrivere alla sola categoria della satira quello che in realtà è un urlo disperato che, di fronte a un atto estremo come il suicidio di lavoratori colpiti dal dispotismo padronale, fa appello alle coscienze. Non certo alla coscienza di Marchionne. Quella è protetta da una corazza fatta di denaro, di potere e del suo ruolo, che difficilmente la rende raggiungibile dal rimorso. Bensì alle coscienze di coloro che per il lavoro che svolgono sono stati coinvolti in questa vicenda: i capi della gerarchia di fabbrica, innanzitutto; poi quei sindacalisti che trovano l’emarginazione a vita dal mondo del lavoro di quegli operai il prezzo da pagare per non turbare gli accordi firmati o che vorrebbero firmare; poi i giornalisti che in qualche modo sono venuti a conoscenza della vicenda, ma che non hanno dedicato a un moto di indignazione per quei suicidi niente di più dello spazio di routine che è stato loro concesso dai rispettivi direttori.
Ma oggi quell’urlo è rivolto soprattutto alla coscienza di quei magistrati che hanno perseguito, giudicato e di fatto condannato al licenziamento gli autori di quella recita, contraddicendo, prima ancora che la lettera e lo spirito della legge, il più elementare senso della giustizia: quello che dovrebbe accomunare tutti gli esseri umani. Sia quel senso della giustizia che, almeno per ora, lo spirito e la lettera della legge non impongono certo l’obbligo di parlar bene del padrone, o di non farlo sfigurare quando mette in atto misure talmente gravi da portare al suicidio, e non una sola volta, di un lavoratore .
È a loro, a quei magistrati, alla loro coscienza, che va riferito ora il senso profondo di quella rappresentazione, che è, o dovrebbe essere, il rimorso. Come è possibile non provare rimorso per una sentenza che antepone al rispetto della pari dignità e al diritto alla vita di tutti i lavoratori l’ego tronfio di un padrone e di una gestione aziendale? Di un sistema che include tra i materiali e i fattori del processo produttivo anche la pretesa di essere esentati da una critica che porta in piazza le gravissime conseguenze di quelle discriminazioni?
Si è lasciato volutamente per strada quel briciolo di umanità che dovrebbe impedire di invertire le parti tra una serie di suicidi veri, di lavoratori ridotti alla disperazione, e un suicidio finto, e solo rappresentato con un’effige di stracci e cartone. Di quei suicidi veri si è scritto in sentenza che è impossibile ricondurli alla discriminazione e alla conseguente miseria che li hanno generati. Mentre quel suicidio finto e solo rappresentato è stato invece considerato un irrimediabile intoppo alla produzione o alla possibilità di dargli un adeguato sbocco sul mercato. Perdere quel briciolo di umanità con una inversione delle parti come questa, e non senza un gravissimo stravolgimento dello spirito e della lettera della legge, dà la misura di quanto siamo ormai precipitati, o stiamo precipitando, in un clima di barbarie.
Una barbarie che non è più confinata solo entro i muri della fabbrica, un luogo in cui ai lavoratori non sono mai stati garantiti giustizia e benessere, perché diritto e amministrazione della giustizia se ne sono sempre tenuti lontani per non disturbare l’«ordinario andamento» dei processi produttivi. Ma qui c’è qualcosa di più: c’è una barbarie che si è mossa alla difesa del processo produttivo anche all’esterno della fabbrica, circondandola con un «cordone sanitario», per impedire che anche solo l’eco delle malefatte che si perpetrano al suo interno possa raggiungere le orecchie dei non addetti ai lavori. Con questa sentenza i giudici che l’hanno emessa ci stanno dicendo che la discriminazione all’interno della fabbrica è una componente «naturale» dell’ordine produttivo; che non va denunciata neanche quando porta a conseguenze gravissime come il suicidio; che il suicidio di chi è stato discriminato non è che una «opzione» individuale; e che il richiamo alla coscienza dei responsabili di quelle discriminazioni e di quei suicidi – e di chi dovrebbe farsi carico di quell’urlo di disperazione – è un atto indebito. È un maldestro tentativo di far ricorso a quel senso di umanità che dovrebbe albergare in ciascuno di noi e che invece va spento una volta per sempre, perché il processo produttivo e le prospettive di mercato non subiscano intoppi.
La cattiveria umana, e non il caso, ha fatto sì che proprio in questi giorni venisse messo in chiaro dove portano sentenze secondo cui la vita di un operaio o di una operaia non vale niente, mentre le esigenze della produzione sono tutto. Al grido di «Spianatelo come con un ferro da stiro» un lavoratore che partecipava a un picchetto è stato ucciso da un camion lanciato contro di lui su incitazione di un manager. Aveva cinque figli ed era egiziano. Due ragioni in più per sostenere che non era niente. Infatti sembra che la Procura di Piacenza abbia declassato quel l’omicidio a «incidente stradale».
 ».
».
Il manifesto, 18 settembre 2016 (c.m.c.)
Giovedì l’uccisione a Piacenza di Abdesselem El Danaf all’ingresso della Seam, azienda di logistica dell’indotto Gls. Ieri la morte di un operaio dell’impresa appaltatrice Steel nell’Ilva di Taranto e di un dipendente Atac, azienda dei trasporti romana, folgorato durante una riparazione.
I sindacati metalmeccanici Fim, Fiom e Uil hanno dichiarato un’ora di sciopero nazionale per mercoledì prossimo. «Dall’inizio dell’anno sono 500 i dipendenti morti mentre lavoravano – spiegano i leder sindacali di categoria Marco Bentivogli, Maurizio Landini e Rocco Palombella -. È un dato inaccettabile, che rappresenta una situazione drammatica. Queste morti non sono mai la conseguenza della fatalità ma sempre della mancanza di rispetto delle imprese per le procedure e le regole di sicurezza e, in generale, della inadeguatezza dei sistemi di prevenzione tali da assicurare effettive garanzie per i lavoratori».
Landini, le condizioni in Italia sembrano peggiorare.
Il prossimo 21 settembre abbiamo chiesto alle Rsu non solo di scioperare ma di organizzare assemblee nei siti produttivi per discutere di sicurezza. La precarietà, le catene di appalti e subappalti stanno peggiorando le condizioni di lavoro fino ad arrivare a livelli non più sopportabili. Tutta l’organizzazione ruota intorno a profitti e ricavi, quello che viene considerato un costo è tagliato via. Del resto se si posso comprare i voucher dal tabaccaio come un pacchetto di sigarette allora la prestazione del dipendente è diventata una merce come un’altra. Il 28 settembre si riapre la trattativa sul rinnovo dei contratti per i metalmeccanici, in quella sede chiederemo che la sicurezza sia un punto qualificante della discussione.
La riforma del Testo unico sulla sicurezza sul Lavoro sembra però andare nella direzione della riduzione delle responsabilità penali in capo alle aziende.
Siamo contrari a qualsiasi peggioramento del testo attuale, ci vogliono anzi leggi che assegnino la responsabilità solidale anche all’azienda appaltante, che oggi invece sempre di più scarica le colpe lungo la catena dei subappalti. Del resto nei casi di Piacenza e Taranto ci troviamo di fronte a due aziende dell’indotto. Sempre più spesso ai lavoratori precari non viene fatta la formazione proprio per risparmiare. Ridurre i costi a qualsiasi prezzo non ha prezzo per l’impresa. La sicurezza non è più vista come un obbligo e una prescrizione così stiamo assistendo a un arretramento culturale generalizzato. Il risultato è che aumenta la disoccupazione, aumenta la cassa integrazione ma i morti sul lavoro, invece di diminuire, crescono.
Venerdì la Fiom aveva suonato un campanello d’allarme per la situazione all’Ilva, scrivendo al governo che il problema delle manutenzioni non veniva affrontato.
Avevamo chiesto un incontro urgente ai commissari e al governo, bisogna discutere della sicurezza e della salute dentro e fuori gli impianti di Taranto. Chiediamo un impegno di Cassa depositi e prestiti come garanzia che lo Stato non abbandoni l’Ilva. Gli investimenti necessari non sono sostenibili dal privato o da un gruppo di privati.
A Piacenza Abdesselem El Danaf è stato ucciso perché chiedeva che venissero rispettati i diritti dei suo colleghi precari.
Il settore della logistica è uno di quelli dove l’imbarbarimento è più alto. Non solo i subappalti ma anche le finte cooperative hanno reso le condizioni di lavoro difficilissime. È evidente che non può andare avanti così anche perché tutto questo ha favorito l’ingresso della malavita organizzata. In Italia attualmente ci sono interi pezzi di economia reale in mano alla malavita. Non è un problema che riguarda solo il privato, ma anche il pubblico. Pensiamo ad esempio alla sanità dove da anni si utilizzano i bandi al massimo ribasso, dove poi si inseriscono anche aziende legate ai clan. Dove si ritrovano lavoratori che fanno lo stesso mestiere ma con paghe, condizioni e diritti differenti.
Come si cambiano le cose?
Bisogna corregge le leggi sbagliate che sono state fatte in materia in questi anni. Il 29 settembre terminerà la raccolta firme della legge di iniziativa popolare della Cgil per la Carta dei diritti universali del lavoro, un nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori che rovescia l’idea che sia l’impresa, il soggetto più forte, a determinare le condizioni di chi lavora. E poi abbiamo promosso tre referendum contro la logica che c’è dietro al Jobs Act. Avranno come oggetto l’eliminazione dei voucher che, così come sono, destrutturano il lavoro; gli appalti, con la responsabilità sociale che resta anche in chi dà il lavoro in appalto; i licenziamenti, per correggere le storture introdotte dalla riforma Fornero e dal Jobs Act. Bisogna prevedere il reintegro dei lavoratori a partire dalle aziende che hanno cinque dipendenti.
 «Uno studio della Fondazione Moressa descrive un inquietante scenario. Con le frontiere chiuse, nel 2030 verranno persi trenta milioni di lavoratori». La
«Uno studio della Fondazione Moressa descrive un inquietante scenario. Con le frontiere chiuse, nel 2030 verranno persi trenta milioni di lavoratori». La Repubblica
, 18 settembre 2016 (c.m.c.)
In epoca di sbarchi ed emergenza immigrazione, cosa accadrebbe se l’Europa potesse chiudere davvero le frontiere? L’Italia perderebbe oltre 4 milioni di lavoratori in quindici anni. I giovani diventerebbero merce rara: un milione e 300mila sparirebbero nel nulla. Boom invece di pensionati: aumenterebbero di due milioni e mezzo. Il resto d’Europa non starebbe meglio: nel 2030 dovrebbe dire addio a 30 milioni di persone in età lavorativa. Eccolo lo scenario “apocalittico” di un eventuale saldo migratorio pari a zero: «Un continente vecchio, più povero e meno produttivo».
A fotografare un’Europa chiusa nelle proprie frontiere è uno studio della Fondazione Leone Moressa, su stime Eurostat e Istat. I ricercatori partono dall’ipotesi, fantascientifica, di un saldo migratorio pari a zero. I risultati? Impressionanti. A frontiere chiuse (e con gli attuali tassi di fecondità), nel 2030 la popolazione Ue diminuirebbe dell’1,9%, sotto quota 500 milioni. Ancora più drastico il calo demografico in Germania (-7%, da 81 a 75 milioni) e in Italia (-5%, da 60 a 57 milioni). La fascia d’età lavorativa (15-64 anni), che attualmente rappresenta il 65,5% della popolazione europea, scenderebbe al 60,8%. Tradotto: 30 milioni di persone in meno. Per l’Italia si tratterebbe di una perdita di 4,3 milioni di cittadini in età lavorativa.
Ancora peggiore l’andamento in Germania: 9 milioni in meno. Calerebbero anche i giovani nella fascia 0-14 anni, dall’attuale 15,6% al 14,3%, con una diminuzione di quasi 8 milioni in Europa e un milione e 300mila in Italia. Al contrario, l’invecchiamento della popolazione porterebbe a un aumento di 6 punti percentuali tra gli over 65 (+28 milioni in Europa). In Italia gli anziani crescerebbero di 2,6 milioni, passando dal 21,7% al 27,5%.
Come sarà invece l’Italia tra 15 anni, con gli attuali flussi migratori invariati? Oggi tra gli italiani la popolazione in età lavorativa rappresenta il 63,2%, mentre tra gli stranieri il 78,1%. Gli anziani sono il 23,4% e solo il 3% tra gli immigrati, ma stando all’Istat nel 2030 saliranno al 29,2% tra gli italiani e all’8,2% tra gli stranieri. E ancora: nel 2015 gli immigrati rappresentano l’8,2% della popolazione residente in Italia. Valore che sale all’11,3% tra i bambini e scende addirittura all’1,1% tra gli anziani, «con un impatto dunque minimo sulla spesa pubblica».
Nel 2030, gli immigrati rappresenteranno ben il 14,6% della popolazione, arrivando addirittura al 21,7% nella fascia 0-14 anni e al 17,4% nella fascia 15-64. Cambierà anche il mercato del lavoro: oggi gli occupati stranieri sono oltre 2 milioni, con un’incidenza del 10% sul totale, nel 2030 saranno 4 milioni, pari al 18% degli occupati. Mantenendo gli attuali tassi di crescita, il Pil prodotto dagli immigrati ammonterà a 217 miliardi, pari al 15% del totale (attualmente è poco al di sotto del 9%).
«Oggi l’immigrazione rappresenta uno dei temi più delicati a livello europeo — scrivono i ricercatori della Fondazione Moressa, che l’11 ottobre presenteranno al Viminale il “Rapporto sull’economia dell’immigrazione” — basti pensare al referendum sulla Brexit, sul quale ha influito moltissimo la campagna anti-immigrati, al muro alzato dall’Austria o al prossimo referendum del 2 ottobre in Ungheria sui ricollocamenti dei migranti.
Nella maggior parte dei paesi Ue, il sentimento dominante è quello di chiusura delle frontiere e di contrasto all’immigrazione. Questo studio conferma invece ancora una volta l’importanza della componente straniera in Italia e in Europa, dal punto di vista demografico e di conseguenza sotto il profilo socio-economico».
La Repubblica, 19 settembre 2016 (m.p.r.)
Il Grande fratello dei semi si prepara a ridisegnare il futuro dell’agricoltura mondiale. Il suo mantra ideologico - basta leggere i siti dei colossi del settore - è sempre lo stesso. «Una persona su otto va a letto affamata - recita quello della Dupont - . Se vogliamo garantire cibo a tutti nel 2050 dobbiamo aiutare i contadini a rendere più produttivi i campi». Come è sotto gli occhi di tutti: le 7mila aziende sementiere attive nel 1981 sono quasi sparite. Un’ondata di fusioni e acquisizioni ha concentrato il 63% del mercato nelle mani di tre colossi (Dow-Dupont, ChemChina- Syngenta e Bayer-Monsanto). Le stesse società - guarda caso - che controllano il 75% del business di pesticidi e diserbanti in un groviglio di conflitti d’interessi in cui «l’industria è costretta a vendere i semi assieme ai prodotti agrochimici per non fare harakiri», come accusa Vincenzo Vizioli, presidente dell’Associazione italiana agricoltura biologia. Ultimo e più famoso esempio: il discusso ed efficacissimo glifosato (unico neo, è un sospetto cancerogeno) promosso in rigorosa abbinata con i semi hi-tech modificati per resistere ai suoi effetti.
L’era del seme unico - dicono i critici - ha già avuto effetti devastanti: la Fao ha certificato che nel ventesimo secolo, a forza di specializzare le colture, abbiamo perso il 75% della biodiversità e che un altro terzo se ne andrà entro il 2050. Uno scotto da pagare, dice l’industria: sviluppare un seme super efficiente (e spesso transgenico) può costare 136 milioni di dollari, un nuovo pesticida può arrivare a 250 milioni. «Solo le imprese di grandi dimensioni hanno i soldi per la ricerca necessaria alle sfide del futuro - spiega Lorenzo Faregna, direttore di Agrifarma, l’organizzazione degli imprenditori di settore - E la fanno con controlli rigidissimi. In Italia, per dire, siamo monitorati da tre ministeri: Ambiente, Salute e Agricoltura».
I risultati, assicura la European seed association, la potentissima lobby di settore, si vedono: incroci e selezioni usciti dai laboratori dei big dei semi «contano per il 74% degli aumenti di produttività in campo agricolo e hanno garantito carboidrati, proteine e oli vegetali per 100-200 milioni di persone aggiungendo 7mila euro di reddito agli agricoltori».
Chi lavora davvero la terra la pensa in un altro modo: «Stiamo creando un oligopolio pericoloso per contadini e consumatori - dice Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti - . Il modello proposto dai big del settore, semi standardizzati e omologati assieme ai fitofarmaci, non funziona più. Le grandi aziende controllano i prezzi, ovviamente a loro uso e consumo. E vanno controcorrente in un mondo dove le coltivazioni Ogm stanno calando e dove la tendenza è rilanciare la biodiversità e ridurre, come si fa con successo in Italia, l’uso di pesticidi e diserbanti».
La natura, in effetti, ha imparato a difendersi dall’assalto della chimica di sintesi. Il 98% delle coltivazioni di soia e il 92% di quelle di mais negli Usa sono seminati con Ogm. Ma le erbe infestanti sono riuscite in poche stagioni a sviluppare resistenza ai fitosanitari con cui vengono trattate. E molti contadini a stelle e strisce - complice pure il crollo dei prezzi delle materie prime - iniziano a dubitare che il gioco (vale a dire il prezzo altissimo di sementi e agrochimica hi-tech) valga la candela.
La “triade” del seme, ovviamente, non ha nessuna intenzione di cedere le armi facilmente. Il modello delle sementi ereditarie - quello che funziona da millenni e prevede la conservazione di parte di un raccolto per piantarlo l’anno successivo - è un pericolo per i profitti. E un paio di pionieri dell’Ogm hanno già brevettato “Terminator” (il nome dice tutto) un seme autosterile, che genera frutti e semi che non sono in grado di riprodursi, obbligando il contadino a rifornirsi da loro a ogni stagione. L’arma finale cui nessuno - per fortuna - ha dato ancora l’autorizzazione al commercio.
L’ingegnerizzazione e la privatizzazione delle piante segue però anche altre strade. Come quella, più tortuosa ma più efficace, del brevetto. L’industria ha depositato all’Ufficio europeo brevetti 1.400 richieste di autorizzazione per usare in esclusiva varietà di piante selezionate con metodi naturali, come fanno da millenni contadini e natura senza accampare diritti monetari. E 180 sono stati approvati come il Broccolo Monsanto (Ep1597965), una pianta normalissima il cui fusto è stato indebolito naturalmente solo per favorire la raccolta meccanica.
Il risiko dei semi del resto, assicurano i guru della finanza, è solo l’inizio e tra poco darà il via all’integrazione verticale tra i ricchissimi produttori di macchine (come Deere e Cnh) e i big nati dalle fusioni degli ultimi mesi. Con nel mirino le meraviglie dell’agricoltura hi-tech a base di droni e satelliti. Sarà davvero il modo per dare da mangiare a tutti? «Tutt’altro - conclude Moncalvo - . La strada è un’altra. Già oggi un terzo di quello che viene prodotto in campagna viene sprecato e non consumato. Basterebbe recuperarlo e già oggi ci sarebbe cibo per tutti i 10 miliardi di persone che abiteranno il pianeta nel 2050».





 «La commissione sulle diacone potrebbe segnare anche la rottura di tre assordanti silenzi che soffocano le chiese da decenni». La
«La commissione sulle diacone potrebbe segnare anche la rottura di tre assordanti silenzi che soffocano le chiese da decenni». La 
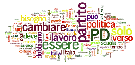



 «Quando capiamo il nesso tra crisi climatica, crisi economica e la nostra personale sofferenza, allora c’è davvero il potenziale per cambiare il mondo».
«Quando capiamo il nesso tra crisi climatica, crisi economica e la nostra personale sofferenza, allora c’è davvero il potenziale per cambiare il mondo».









 ».
». 