 «Un percorso di letture sulla storia europea e sulle sue esperienze dell’estremo, dalla Shoah in poi. Antisemitismo, trincee, recinzioni: una tragica linea che va verso la negazione della vita. Genealogia di un dispositivo di potere che ha la capacità di proiettare sul presente elementi importanti di comprensione delle forme di potere contemporanee».
«Un percorso di letture sulla storia europea e sulle sue esperienze dell’estremo, dalla Shoah in poi. Antisemitismo, trincee, recinzioni: una tragica linea che va verso la negazione della vita. Genealogia di un dispositivo di potere che ha la capacità di proiettare sul presente elementi importanti di comprensione delle forme di potere contemporanee».
ilmanifesto, 26 marzo 2017
L’idea di recinzione si incontra con quella di confine che, a sua volta, rimanda a quella di contenimento. In un moderno Stato nazionale contenere implica il selezionare: qualcosa ma, anche e soprattutto, chi possa essere parte della comunità (di popolo, di stirpe, di razza, di «destino»), idea competitiva, nella moderna esperienza della politica, a quella di cittadinanza. Allora, il primo punto da cui partire è la ristampa, arricchita di nuovi suggerimenti di lettura, di un volume di Olivier Razac, Storia politica del filo spinato. Genealogia di un dispositivo di potere (ombre corte, pp. 158, euro 14). L’autore, maître de conférences in filosofia presso l’Università di Grenoble, ricostruisce letteralmente il reticolo storico del reticolato. Il filo spinato, infatti, non è solo uno strumento materiale per spezzare, dividere, infine separare per sempre i corpi ma anche un dispositivo simbolico che ha un fortissimo impatto sulle coscienze dei contemporanei.
NEL MEDESIMO TEMPO delimita il campo della protezione da quello del rifiuto, l’habitat di ciò che va tutelato dal contesto di quanto deve essere annientato.
Il filo spinato non vale solo per quanti sono trattenuti dentro gli spazi da esso rigidamente contrassegnati ma anche e soprattutto per coloro che lo osservano da fuori, celebrandone in tale modo la sua invalicabilità. Non è quindi un caso se esso compaia, sinistramente, in tre catastrofi della contemporaneità, quasi a volerne definire i lineamenti di fondo: i processi di colonizzazione dello spazio americano, a partire dal superamento della frontiera orientale; la parossistica recinzione dell’interminabile teoria di trincee, disegnata sui campi di battaglia immobili della Prima guerra mondiale; la tragica linea di delimitazione dei campi di concentramento e di sterminio nazisti. La questione alla quale il filo spinato rimanda da subito è la rottura della linea di continuità, nel diritto alla vita, tra ciò che è considerato umano e quanto, invece, viene ridotto a mero oggetto animato. Olivier Razac ci restituisce quindi il nesso tra controllo dello spazio attraverso la sua interruzione e il legame tra discontinuità e reificazione dell’umanità.
Un percorso parallelo è quello svolto da Götz Aly in Zavorre. Storia dell’Aktion T4: l’«eutanasia» nella Germania nazista, 1939-1945 (Einaudi, Torino 2017, pp. 261, euro 30), laddove la «selezione» delle vite «non degne di essere vissute» è ricostruita dall’autore, docente al Fritz Bauer Institut dell’Università di Francoforte, come percorso di ingegneria sociale e, nel medesimo tempo, manifestazione di rimozione della responsabilità all’atto stesso della sua esecuzione.
L’ASSASSINIO SISTEMATICO di duecentomila cittadini tedeschi, considerati un peso per lo Stato tedesco, perlopiù in ragione della loro condizione psichica, ritenuta irrecuperabile, fu parte integrante del percorso di disintegrazione della varietà umana che stava al nocciolo del progetto nazista. Aly ne ricostruisce i diversi passaggi: l’impostazione politica del «problema» del trattamento degli «incurabili», la dimensione burocratica dell’azione, l’intervento sistematico degli ordini professionali e della sanità pubblica, l’opera di comunicazione con le famiglie, la feroce e infelice dialettica tra abbandono, indifferenza, rimozione ma anche il fatalismo e il pudore che connotarono una parte dei congiunti, le famiglie, in generale il pubblico tedesco. Tra il 1939 e il 1945 una macchina di distruzione collettiva operò attivamente in tal senso, colpendo non solo le vittime ma adoperandosi in un complesso processo di desensibilizzazione e anestetizzazione collettiva.
A VOLERE RIBADIRE un principio fondamentale nella fascistizzazione delle società, dove la repressione e poi l’annientamento delle minoranze, ricondotte in questo caso alla condizione di minorati irrecuperabili, viene pensata e organizzata come strumento riordinativo della maggioranza, quella composta dai «sani». Questi ultimi non sono tali solo perché esenti da degenerazioni ereditarie o da patologie ritenute incurabili, esclusivo onere economico per la collettività, ma per la loro totale adesione ad un corpo collettivo, quello della nazione intesa come comunità di stirpe. Il dispositivo ideologico che sovraintendeva all’Azione T4 era solo uno degli anelli terminali di un ampio processo di radicalizzazione dell’azione biopolitica, portata ai suoi estremi risultati. E ne costituiva quindi la vera essenza.
All’autore non interessa la denuncia morale in sé ma la ricostruzione dei meccanismi che facevano parte di una macchina sterminazionista nel quale l’omicidio di massa veniva presentato dalle autorità pubbliche in quanto atto di «misericordia», coniugato alla necessaria «selezione» dei caratteri positivi della collettività. In altre parole, la morte dell’impuro, e del degenerato, come garanzia di vita dei «migliori».
Aly ci restituisce uno spaccato sia del sistema criminale di Stato sia del mondo delle vittime, molto presenti all’interno delle pagine del suo libro. Si concentra invece sull’ideologia antiebraica il volume di Steven Beller dedicato a L’antisemitismo (il Mulino, pp. 150, euro 13,50). Lo studioso, già Fellow del Peterhouse College di Cambridge e culturalmente attivo nel mondo anglosassone, si cimenta nel lavoro di definire e circoscrivere la cogenza interpretativa, e la funzionalità analitica, delle riflessioni sull’antisemitismo in età contemporanea.
CIÒ FACENDO, davanti alla messe gigantesca di studi così come ai diversi indirizzi interpretativi, Beller cerca di trovare una linea di equilibrio che storicizzi il pregiudizio antisemitico. Il problema, per qualsiasi studioso, al giorno d’oggi, non è infatti il difetto ma, piuttosto, l’eccesso di stimoli euristici. Non di meno, una questione di fondo è se l’esito sterminazionista sia stato in qualche modo già configurato, o comunque implicato, dalle forme precedenti di avversione antigiudaica oppure costituisca una frattura a sé, in quanto tale propria del Novecento.
Le riflessioni dell’autore non offrono risposte conclusive, assestandosi semmai sul versante della rassegna dei diversi contributi. Al riguardo la silloge delle sue riflessioni si raccoglie nell’affermazione per cui: «l’antisemitismo non è più un fenomeno isolato ma piuttosto è sostanzialmente una forma estrema di pensiero esclusivista moderno, con una logica condivisa da fondamentalismi e nazionalismi ».
Per integrare queste e altre considerazioni è anche utile un non meno recente volume del sociologo francese Pierre-André Taguieff, anch’esso intitolato L’antisemitismo (Raffaello Cortina, pp. 139, euro 13). Infine, Luca Peloso, studioso di filosofia, con L’esperienza dell’estremo. Vita e pensiero nei campi di concentramento (ombre corte, pp. 172, euro 15), lavorando sulla comparazione tra Lager nazisti e Gulag staliniani cerca di coinvolgere la riflessione filosofica nell’indagine storica e sociologica.
PIÙ CHE UN INTENTO storiografico l’autore in questo caso cerca di soddisfare alcune esigenze che hanno ad oggetto la narrabilità della prigionia in quelle condizioni estreme, soprattutto se dalla sua memoria derivano esigenze sia di comunicazione pubblica che di pedagogia civile.
La sfida, che rimanda direttamente all’oggi, e quindi ai sistemi analogici che adottiamo nell’interpretare quei passati non meno che alle categorie di razionalizzazione alle quali facciamo ricorso per ricondurre a senso ciò che altrimenti rischia di rimanere un’infinita insensatezza, invita alla rilettura dell’esperienza concentrazionaria attraverso diverse angolazioni disciplinari. Dalle quali, ancora una volta, ne deriva per il lettore il senso della incompiutezza, trattandosi di una storia che letteralmente precipita nel vuoto.
 «Se davvero vuole sconfiggere il fenomeno del caporalato, e cancellare le immagini della manodopera sfruttata nei campi di pomodori o intorno agli alberi di arance, l’Italia deve mettere al bando le aste “al doppio ribasso».
«Se davvero vuole sconfiggere il fenomeno del caporalato, e cancellare le immagini della manodopera sfruttata nei campi di pomodori o intorno agli alberi di arance, l’Italia deve mettere al bando le aste “al doppio ribasso».
Altreconomia online, 27 marzo 2017 (c.m.c.)
Terra! e FLAI Cgil scrivono al ministro dell’Agricoltura per chiedere un intervento in grado di fermare le aste “al doppio ribasso”, attraverso le quali vengono stabiliti i prezzi offerti alla grande distribuzione organizzata. La ricerca di fornitori sempre più a buon mercato rende difficile, se non impossibile, la tutela dei diritti nei campi.Se davvero vuole sconfiggere il fenomeno del caporalato, e cancellare le immagini della manodopera sfruttata nei campi di pomodori o intorno agli alberi di arance, l’Italia deve mettere al bando le aste “al doppio ribasso”, uno dei meccanismi utilizzati dalla grande distribuzione organizzata per scegliere i proprio fornitori.
La dinamica è semplice: la GDO fa sedere attorno a una piattaforma virtuale i propri fornitori chiedendo loro di avanzare un’offerta per una grande quantità di un certo prodotto; sulla base dell’offerta più bassa la GDO convoca successivamente una seconda asta on line che in poche ore chiama i partecipanti a rilanciare, con un evidente paradosso, per ribassare ulteriormente il prezzo di vendita di quel prodotto.
Per questo, secondo Terra! e daSud -promotrici della campagna #filieraSporca- e il sindacato FLAI della Cgil, «sebbene si presuma che questi meccanismi consentano al distributore di mantenere bassi i prezzi al consumo, risulta evidente che un sistema simile produce delle sofferenze economiche, scaricate sui fornitori e da questi ultimi sul settore produttivo e conseguentemente sui lavoratori». Questo scrivono, in una lettera inviata il 22 marzo al ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, Ivana Galli -della FLAI- e Fabio Ciconte -direttore di Terra!-.
Lo stesso Martina, infatti, nelle ultime settimane ha mostrato apertura nei confronti delle criticità che la campagna #filierasporca ha fatto emergere, a partire dalla pubblicazione del suo ultimo rapporto sulla filiera del pomodoro. E così le organizzazioni chiedono al ministro, tra i promotori della legge contro il caporalato, uno sforzo in più, per intervenire con «misure legislative volte a cancellare la pratica delle aste elettroniche inverse (così si chiama tecnicamente il meccanismo del doppio ribasso, ndr) nell’acquisto dei prodotti alimentari».
«Meccanismi come il sottocosto e le aste on line distruggono l’intera filiera dell’agricoltura, perché alterano alla base i rapporti tra grande distribuzione e consumatore, facendo pagare il costo più elevato all’ambiente e ai produttori, oltre ad aggravare le condizioni di sfruttamento dei lavoratori e il caporalato» ha spiegato Fabio Ciconte di Terra!, nel lanciare la campagna #ASTEnetevi.
FLAI Cgil e Terra! hanno scritto anche ad Auchan Italia, Carrefour Italia, Conad, Coop Italia, Crai, Despar, Esselunga, Eurospin, Interdis, Lidl Italia, Gruppo Pam Panorama, Selex, Sigma, Sisa, Sma Italia.
Sono i principali marchi della grande distribuzione presenti nel nostro Paese, e in molti casi fanno parte anche di importanti «centrali d’acquisto internazionali», che hanno sede fuori dall’Italia e fanno uso del meccanismo delle aste al doppio ribasso.
Queste centrali d’acquisto rappresentano una forma di cooperazione tra soggetti apparentemente concorrenti -i giganti della GDO-, e hanno l’obiettivo principale di accrescere il potere esercitato dai compratori sul mercato.
Secondo un recente report pubblicato da SOMO -centro olandese di ricerca sulle multinazionali- le maggiori centrali d’acquisto sarebbero in grado di spuntare dai fornitori ribassi ulteriori fino al 10% rispetto a quelli che potrebbe contrattare il singolo gruppo. Tra i marchi italiani, fanno parte di una delle maggiori centrali d’acquisto Coop Italia (il “gruppo d’acquisto” si chiama Coopernic, ha sede in Germania ed opera in 21 Paesi), Conad (fa parte di Alidis, che ha sede in Svizzera ed opera in 8 Paesi), mentre BIGS è la centrale d’acquisto che agisce in 11 Paesi europei per i licenziatari del marchio SPAR (Despar, in Italia).
SOMO ha riscontrato l’assenza di codici etici -in merito tanto a variabili di carattere sociale che ambientale- da parte delle prime cinque centrali d’acquisto europee, che hanno come clienti circa 35 marchi, per un fatturato complessivo di 600 miliardi di euro. La forza di questi soggetti, poi, non è solo quella contrattuale: alcuni fornitori, intervistati da SOMO, preferirebbero non dover collaborare con le centrali d’acquisto internazionali, per non offrire informazioni “sensibili” (come quelle relative ai loro costi) che saranno sicuramente condivise anche con le catene della grande distribuzione.
 «Il cuore della presenza popolare ieri non era nella Roma blindata che ospitava i leader europei, ma era nella Milano dove centinaia di migliaia di persone accoglievano la visita di papa Bergoglio nel suo viaggio pastorale tra le periferie».
«Il cuore della presenza popolare ieri non era nella Roma blindata che ospitava i leader europei, ma era nella Milano dove centinaia di migliaia di persone accoglievano la visita di papa Bergoglio nel suo viaggio pastorale tra le periferie».
il manifesto, 26 marzo 2017
La cerimonia per celebrare i Trattati di Roma sarà ricordata nella storia dei posteri come quella dei nani sulle spalle dei giganti. L’Europa costruita sulle macerie della Seconda guerra mondiale oggi si è ritrovata nel salone degli Orazi e dei Curiazi del Campidoglio sommersa dalla retorica della pace mentre alle nostre frontiere il fenomeno migratorio ci ricorda ogni giorno che nuove macerie le stanno attraversando portando l’eco delle guerre.
Tante manifestazioni in programma, una partecipazione di migliaia di persone isolate per le piazze di una Roma spettrale, in un sabato pomeriggio che ha svuotato la città, con le strade deserte occupate da vigili urbani mai visti così numerosi a ogni angolo del centro storico. E naturalmente con uno spiegamento massiccio delle forze dell’ordine per i venti di guerriglia che giornali e televisioni annunciavano a tamburo, formidabile antidoto a una partecipazione più larga.
Così il cuore della presenza popolare ieri non era nella Roma blindata che ospitava i leader europei, ma era nella Milano dove centinaia di migliaia di persone accoglievano la visita di papa Bergoglio nel suo viaggio pastorale tra le periferie. A parlare di povertà, di lavoro, invitando la gente ad «abbracciare i confini».
Difficile del resto appassionarsi alla cerimonia del Campidoglio, ai discorsi ufficiali dei capi di stato e di governo. La scena mediatica, che avrebbe dovuto celebrare i fasti di un Renzi vittorioso al referendum del 4 dicembre, ha ricevuto la tranquilla accoglienza del suo successore. Che ha svolto diligentemente il suo compito. Come anche il presidente Mattarella che è tornato a insistere sulla necessità di una nuova Costituzione dopo averne già sottolineato l’urgenza nel discorso davanti alle Camere riunite, per una riforma dei trattati, per dare una nuova Costituzione all’Europa. Ma proprio ritrovarne le ragioni profonde non è semplice né scontato. Se a parole e nei riti della ricorrenza, con dosi di retorica pari alla mancanza di solennità, tutti hanno parlato dei problemi sociali, dell’economia che si nutre delle diseguaglianze, nei fatti le promesse e gli impegni di costruire un’Europa sociale sono contraddetti dalle vicende degli anni recenti come l’esempio della Grecia dimostra con le sue sofferenze. Per iniziare un processo costituente bisognerebbe battersi per quei valori che noi italiani abbiamo appena difeso con il referendum del 4 dicembre, quando abbiamo fatto scudo alla Costituzione che vorremmo vedere riflessa a fondamento di un’altra Europa, di un altro progetto politico. Quello schieramento che si è unito nel referendum era in piazza, con la destra e la sinistra presenti con parole d’ordine che hanno trovato espressione trasversalmente agli schieramenti, tra nazionalismi risorgenti e principi europeisti messi a dura prova dal grande sonno delle classi dirigenti. Più vicine agli Orazi e Curiazi che allo spirito di Ventotene.»La cerimonia per celebrare i Trattati di Roma sarà ricordata nella storia dei posteri come quella dei nani sulle spalle dei giganti. L’Europa costruita sulle macerie della Seconda guerra mondiale oggi si è ritrovata nel salone degli Orazi e dei Curiazi del Campidoglio sommersa dalla retorica della pace mentre alle nostre frontiere il fenomeno migratorio ci ricorda ogni giorno che nuove macerie le stanno attraversando portando l’eco delle guerre.
Tante manifestazioni in programma, una partecipazione di migliaia di persone isolate per le piazze di una Roma spettrale, in un sabato pomeriggio che ha svuotato la città, con le strade deserte occupate da vigili urbani mai visti così numerosi a ogni angolo del centro storico. E naturalmente con uno spiegamento massiccio delle forze dell’ordine per i venti di guerriglia che giornali e televisioni annunciavano a tamburo, formidabile antidoto a una partecipazione più larga.
Così il cuore della presenza popolare ieri non era nella Roma blindata che ospitava i leader europei, ma era nella Milano dove centinaia di migliaia di persone accoglievano la visita di papa Bergoglio nel suo viaggio pastorale tra le periferie. A parlare di povertà, di lavoro, invitando la gente ad «abbracciare i confini».
Difficile del resto appassionarsi alla cerimonia del Campidoglio, ai discorsi ufficiali dei capi di stato e di governo. La scena mediatica, che avrebbe dovuto celebrare i fasti di un Renzi vittorioso al referendum del 4 dicembre, ha ricevuto la tranquilla accoglienza del suo successore. Che ha svolto diligentemente il suo compito. Come anche il presidente Mattarella che è tornato a insistere sulla necessità di una nuova Costituzione dopo averne già sottolineato l’urgenza nel discorso davanti alle Camere riunite, per una riforma dei trattati, per dare una nuova Costituzione all’Europa. Ma proprio ritrovarne le ragioni profonde non è semplice né scontato.
Se a parole e nei riti della ricorrenza, con dosi di retorica pari alla mancanza di solennità, tutti hanno parlato dei problemi sociali, dell’economia che si nutre delle diseguaglianze, nei fatti le promesse e gli impegni di costruire un’Europa sociale sono contraddetti dalle vicende degli anni recenti come l’esempio della Grecia dimostra con le sue sofferenze. Per iniziare un processo costituente bisognerebbe battersi per quei valori che noi italiani abbiamo appena difeso con il referendum del 4 dicembre, quando abbiamo fatto scudo alla Costituzione che vorremmo vedere riflessa a fondamento di un’altra Europa, di un altro progetto politico. Quello schieramento che si è unito nel referendum era in piazza, con la destra e la sinistra presenti con parole d’ordine che hanno trovato espressione trasversalmente agli schieramenti, tra nazionalismi risorgenti e principi europeisti messi a dura prova dal grande sonno delle classi dirigenti. Più vicine agli Orazi e Curiazi che allo spirito di Ventotene.

a Repubblica online, 26 marzo 2016
E' la prima strage di civili iracheni addebitata agli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump. Responsabili iracheni hanno denunciato l'uccisione di centinaia di civili a Mosul nella notte fra venerdì e sabato nel corso dei raid aerei contro l'Isis: il Pentagono ha ammesso che la coalizione internazionale a guida Usa ha bombardato una zona dove ci sono stati morti tra la popolazione. Impossibile determinare con esattezza il numero dei morti, ma si parla di più di 200 persone.
La dinamica dell'accaduto non è chiara: secondo alcune fonti le bombe avrebbero colpito un camion carico di esplosivo che poi avrebbe provocato il crollo del palazzo. Altre sostengono che l'obiettivo del raid era l'edificio stesso, dove ci sarebbe stata una postazione dell'Isis.
L'offensiva per riprendere Mosul ovest è iniziata a febbraio. La parte orientale della città è ormai sotto il controllo del governo e dell'esercito iracheno, ma il centro storico e la zona occidentale ancora sono oggetto di combattimenti furibondi. E' in uno di questi combattimenti che l'intervento dell'aviazione americana e alleata avrebbe compiuto la strage. Bachar al-Kiki, capo della provincia di Ninive, ieri ha parlato di "decine di corpi ancora sepolti sotto le macerie" di alcune palazzine distrutte dalle bombe. Il governatore provinciale Nawfal Hammadi ha accusato la coalizione a guida Usa di avere condotto raid sul quartiere di al-Jadida uccidendo "più di 130 civili". Lo stesso governatore Hammadi in una dichiarazione all'Agence France Presse ha attribuito parte della responsabilità ai jihadisti dell'Isis: "Cercano di bloccare con tutti i mezzi l'avanzata dell'esercito iracheno su Mosul, rastrellano i civili e li usano come scudi umani".
Due testimoni locali scampati alla strage, sempre all'Afp hanno descritto la distruzione di un immobile con 170 abitanti. L'Onu ha espresso "profonda inquietudine" e la coordinatrice umanitaria per l'Iraq, Lise Grande, si è detta "sconvolta da queste terribili perdite umane". Proprio nel timore di nuove stragi, l'esercito iracheno ieri sera ha annunciato la momentanea sospensione dell'offensiva. A più di un mese dal lancio dell'attacco a Mosul ovest, oltre duecentomila abitanti sono fuggiti dalla zona dei combattimenti, ma ancora seicentomila abitano nei quartieri della città sotto il controllo dell'Isis.
 «Il Trattato di Roma ha messo al centro il diritto di movimento delle persone e delle merci; come nella tradizione settecentesca ha associato la libertà ai fattori economici o di produzione, la cittadinanza all’apertura dei mercati
«Il Trattato di Roma ha messo al centro il diritto di movimento delle persone e delle merci; come nella tradizione settecentesca ha associato la libertà ai fattori economici o di produzione, la cittadinanza all’apertura dei mercati
». Huffingto Post online, 25 Marzo 2017 (c.m.c.)
ùIl processo di unificazione Europea, di cui celebriamo il sessantesimo compleanno, ha aperto la strada a una nuova cittadinanza. Studiosi della politica e giuristi hanno abbondantemente illustrato il paradigma post-nazionale e sovranazionale della libertà politica che dissocia la cittadinanza dalla nazionalità. Si tratta di una rivoluzione non meno epocale di quella del 1789 che, per ripetere le parole di Hannah Arendt, inaugurò la «conquista dello stato da parte della nazione» e in questo modo l’inizio della democratizzazione.
La storia dell’Europa moderna conferma che mentre la formazione dello stato territoriale ha unificato il corpo dei sudditi della legge è stata la sovranità nazionale a rendere gli stati democratici. Il diritto che ha segnato questo mutamento epocale è quello di e/immigrazione, ovvero la libertà di movimento, delle persone e dei beni.
L’Unione europea nacque sulla libertà di movimento ma con un’ambiguità economica che non è scomparsa, nemmeno quando con il trattato di Lisbona la cittadinanza europea è stata consolidata da una famiglia di diritti costruiti attorno al “libero movimento” e alla “non discriminazione” tra gli Stati membri e all’interno di essi. Pur riconoscendo che l’immigrazione è un fatto fondamentale della vita umana, che riflette la ricerca di individui e collettività di migliorare la propria condizione di vita, ha scritto Ulrich Preuss, essa non mai ha di fatto tolto di mezzo le ragioni economiche per il diritto di movimento e il ruolo degli Stati membri. È vero che, comunque, le ragioni economiche non furono mai così preponderanti da bloccare lo sviluppo di decisioni riguardo la cittadinanza dell’Unione europea e da dare a quest’ultima uno status giuridico formale (il Trattato di Maastricht del 1993) e aumentarlo incrementalmente con i successivi trattati di Amsterdam (1999), Nizza (2003) e Lisbona (2009). Ma tutto questo è avvenuto prima della grande crisi finanziaria.
È stata sufficiente questa crisi a mostrare le ambiguità: il Trattato di Roma ha messo al centro il diritto di movimento delle persone e delle merci; come nella tradizione settecentesca ha associato la libertà ai fattori economici o di produzione, la cittadinanza all’apertura dei mercati.
All’inizio del processo europeo di unificazione, quell’ambiguità si applicava essenzialmente all’immigrazione interna (l’antica preoccupazione degli anni ’50 e ’60). Successivamente si è applicata all’immigrazione extracomunitaria, formando sia la politica di integrazione con gli immigrati irregolari (descritti come cittadini di Paesi terzi) sia quella della repressione con i migranti sans-papiers. Joseph Weiler ha così argomentato che «la cittadinanza europea equivale a poco più di un cinico esercizio di pubbliche relazioni e che anche il più sostanziale diritto (al libero movimento e alla residenza) non è concesso secondo uno status dell’individuo in quanto cittadino ma in ragione delle capacità dei singoli come fattori di produzione».
Se il diritto fondamentale di libertà di movimento è così direttamente connesso a ragioni economiche – la circolazione di una forza lavoro concorrenziale – ciò significa che i confini nazionali sono interpretati e utilizzati come meccanismi funzionali a una divisione internazionale del lavoro. Essi diventano il centro del conflitto tra opposti interessi, nel senso che i lavoratori stranieri (che minacciano la classe lavoratrice di una nazione accettando di lavorare senza la stessa protezione sociale e gli stessi salari della classe lavoratrice nazionale), incontrano gli interessi di quei settori economici la cui competitività si basa sul lavoro a basso costo. Questo è stato il ragionamento (populista ma non irrazionale) che ha guidato gli elettori nel referendum su Brexit.
Questo conflitto è il cuore di ciò che James Hollifiel ha chiamato il “paradosso liberale”, il fatto che una società democratica basata sul libero mercato e sulla libertà di movimento conserva un tratto di chiusura legale al fine di proteggere il contratto sociale tra lavoro e capitale, così riconoscendo che il proprio welfare presuppone una società chiusa e uniforme. Strategie di chiusura legale non sono necessariamente e brutalmente di tipo diretto (bloccando i confini, incarcerando e rimpatriando gli immigrati irregolari).
Di fatto, sono strategie per la maggior parte indirette, in modo particolare quando sono rivolte agli immigrati regolari, per esempio limitando i loro diritti civili e sociali, rendendo loro difficile la naturalizzazione, restringendo il loro accesso ai servizi sociali o impedendo i ricongiungimenti familiari. Dunque, per gli Stati europei, e ora anche per l’Unione europea, riguadagnare il controllo dei propri confini equivale ad ammettere che “il controllo dell’immigrazione può richiedere una riduzione dei diritti civili e dei diritti umani per i non cittadini”.
È sull’immigrazione che si gioca quindi il futuro dell’Unione: su questo diritto è sorta e su questo stesso diritto può cadere se lascerà che i singoli stati membri regolino le loro politiche delle frontiere in maniera nazionalistica (come del resto stanno già facendo ad Est). Non sembrano esserci altre soluzioni al problema europeo: perché l’Unione sopravviva deve farsi politica e avere un potere federale capace di imporsi ai governi degli stati membri. Una soluzione più utopistica oggi di sessant’anni fa, nonostante quell’Europa venisse da una carneficina mondiale e questa da sei decenni di pace.

«Scritto il manifesto
Sembrano passati secoli, eppure sono passati solo cinquant’anni dal 1967, quando è stata pubblicata l’enciclica Populorum progressio, scritta da Paolo VI.
Tempestosi e ricchi di speranze quegli anni sessanta del Novecento; si erano da poco conclusi i lavori del Concilio Vaticano II che aveva aperto al mondo le porte della chiesa cattolica; era ancora vivo il ricordo della crisi dei missili a Cuba, quando il confronto fra Stati uniti e Unione sovietica con le loro bombe termonucleari, aveva fatto sentire il mondo sull’orlo di una catastrofe; i paesi coloniali stavano lentamente e faticosamente procedendo sulla via dell’indipendenza, sempre sotto l’ombra delle multinazionali straniere attente a non mollare i loro privilegi di sfruttamento delle preziose materie prime; la miseria della crescente popolazione dei paesi del terzo mondo chiedeva giustizia davanti alla sfacciata opulenza consumistica dei paesi capitalistici del primo mondo; nel primo mondo studenti e operai chiedevano leggi per un ambiente migliore, per salari più equi, per il divieto degli esperimenti nucleari.
In questa atmosfera il malinconico Paolo VI aveva alzata la voce parlando di nuove strade per lo sviluppo. Progressio, ben diverso dalla crescita delle merci e del denaro, la divinità delle economie capitalistiche.
L’enciclica sullo sviluppo dei popoli diceva bene che «il fine ultimo e fondamentale dello sviluppo non consiste nel solo aumento dei beni prodotti né nella sola ricerca del profitto e del predominio economico; non basta promuovere la tecnica perché la Terra diventi più umana da abitare; economia e tecnica non hanno senso che in rapporto all’uomo che esse devono servire».
La Populorum progressio metteva in discussione lo stesso diritto umano al «possesso» dei campi, dei minerali, dell’acqua, degli alberi, degli animali, che non sono di una singola persona o di un singolo paese, ma «di Dio», beni comuni come ripete papa Francesco nella sua enciclica Laudato si’ e continuamente.
L’enciclica Populorum progressio indica diritti e doveri dei popoli della Terra divisi nelle due grandi «classi» dei ricchi e dei poveri, ben riconoscibili anche oggi: i ricchi, talvolta sfacciatamente ricchi, dei paesi industriali ma anche quelli che, nei paesi poveri, accumulano grandi ricchezze alle spese dei loro concittadini; i poveri che affollano i paesi arretrati, ma anche quelli, spesso invisibili, che affollano le strade delle dei paesi opulenti, all’ombra degli svettanti grattacieli e delle botteghe sfavillanti.
La Populorum progressio fu letta poco volentieri quando fu pubblicata e da allora è stata quasi dimenticata benché le sue analisi dei grandi problemi mondiali siano rimaste attualissime.
I popoli a cui l’enciclica si rivolge sono, allora come oggi, quelli che lottano per liberarsi dal giogo della fame, della miseria, delle malattie endemiche, dell’ignoranza; che cercano una partecipazione più larga ai frutti della civiltà, una più attiva valorizzazione delle loro qualità umane; che si muovono con decisione «verso la meta di un pieno rigoglio».
L’enciclica denuncia il malaugurato (dice proprio così) sistema che considera il profitto come motore essenziale del progresso economico, la concorrenza come legge suprema dell’economia, la proprietà privata dei mezzi di produzione come un diritto assoluto, senza limiti né obblighi sociali corrispondenti. E condanna l’abuso di un liberalismo che si manifesta come «imperialismo internazionale del denaro».
In quegli anni sessanta era vivace il dibattito sulla «esplosione» della popolazione, in rapida crescita specialmente nei paesi poveri, e la domanda di un controllo della popolazione, resa possibile dall’invenzione «della pillola», aveva posto i cattolici di fronte a contraddizioni. Paolo VI ricorda che spetta ai genitori di decidere, con piena cognizione di causa, sul numero dei loro figli, prendendo le loro «responsabilità davanti a Dio, davanti a se stessi, davanti ai figli che già hanno messo al mondo, e davanti alla comunità alla quale appartengono». Il tema della «paternità responsabile» sarebbe stato ripreso nel 1968 dallo stesso Paolo VI nella controversa enciclica Humanae vitae e, più recentemente, da papa Francesco che ha detto che per essere buoni cattolici non è necessario essere come conigli.
Il progresso dei popoli è ostacolato anche dallo «scandalo intollerabile di ogni estenuante corsa agli armamenti», una corsa che si è aggravata in tutto il mezzo secolo successivo con la diffusione di costosissime e sempre più devastanti armi nucleari, oggi nelle mani di ben nove paesi, oltre che di armi convenzionali.
In mezzo secolo è cambiata la geografia politica; un mondo capitalistico egoista e invecchiato deve fare i conti con vivaci e affollati paesi emergenti, pieni di contraddizioni, e con una folla di poverissimi.
I poveri di cui l’enciclica auspicava il progresso, nel frattempo cresciuti di numero, sono quelli che oggi si affacciano alle porte dell’Europa per sfuggire a miseria, guerre fratricide, oppressione imperialista, per sfuggire alla sete e alle alluvioni, alla fame e all’ignoranza, quelli che i paesi cristiani non esitano a rispedire in campi di concentramento africani pur di non incrinare il loro benessere, magari dopo avere strizzato la vita e salute degli immigrati nei nostri campi. I pontefici dicano pure quello che vogliono; le cose serie sono i propri interessi e commerci.
Eppure è fra i poveri disperati e arrabbiati che trova facile ascolto l’invito alla violenza e al terrorismo; noi crediamo che la sicurezza dei nostri negozi e affari si difenda con altre truppe super-armate, con sistemi elettronici che si rivelano fragili e violabili, e invece l’unica ricetta, anche se scomoda, per rendere la terra meno violenta e più «adatta da abitare», sarebbe la giustizia.
«Il problema dell’Unione europea non è il recupero della sovranità nazionale, ormai puramente mitica, ma il recupero della democrazia ». il manifesto, 25 marzo 2017 (c.m.c.)
Al momento delle sue ultime elezioni l’Olanda è stata irrisa da tutti perché si è saputo che concorrevano ben 28 partiti. In realtà non c’era niente da ridere: grazie al privilegio di una legge rigorosamente proporzionalista, senza trucchi maggioritari, gli olandesi, con quei loro 28 partiti, hanno potuto rendere esplicita la crisi di rappresentanza che ormai percorre l’Europa, sconvolgendo antiche e storiche costellazioni politiche, producendo una varietà di fenomeni sbrigativamente catalogati col termine di populismo. La crisi del sistema democratico appare ormai in tutta la sua evidenza.
Di questo sarebbe bene che i rappresentanti dei 28 stati europei riflettessero oggi a Roma. Perché larga parte delle responsabilità di questa ormai profonda crisi di fiducia stanno proprio nel modo come è stata gestita l’Unione in questi sessant’anni che oggi invece si festeggiano.
Non lo faranno, ne sono certa: ricorreranno, come sempre, alla più insipida retorica.
Nel parlare di questo anniversario ci sarebbero mille cose da dire. L’elenco dei problemi all’ordine del giorno è lungo e drammatico. Non vi accenno, perché sono noti a tutti e tutti i giorni ne parliamo.
Temo che dal vertice celebrativo di Roma non uscirà nulla di serio, casomai solo qualcosa di preoccupante, come la già sbandierata proposta di rafforzare la nostra comune potenza militare (peraltro già ragguardevole, contrariamente a quanto si pensa), come se il possesso di un numero maggiore di cannoni potesse darci maggiore sicurezza contro il pericolo terrorista. O più autonomia dagli Stati uniti.
In realtà per riavviare qualche interesse per l’Unione europea, in un momento in cui più scarso non potrebbe essere, ci vorrebbe proprio una riflessione sul perché le tradizionali forze europeiste – di sinistra ma anche di destra – hanno a tal punto perduto la fiducia dei loro elettori.
E’ accaduto per molte ragioni ma essenzialmente perché si è andato sempre più confondendo il progetto europeo con quello della globalizzazione: l’Europa anziché smarcarsene, riaffermando la sua positiva specificità (a cominciare dal welfare ma soprattutto dalla sua storica maggiore distanza dalla mercificazione di ogni aspetto della vita), vi si è piattamente sempre più allineata.
E allora, perché l’Europa? Che senso ha, se resta niente altro che un pezzetto anonimo del mercato mondiale?
Costruire una nuova entità supernazionale, dotata di una qualche omogeneità culturale, sociale, economica e dunque politica, non è obiettivo facile. Tanto più se si pensa che la storia dell’Europa è storia delle sue nazioni, diverse in tantissime cose, a cominciare dalla lingua che vi si parla. Ma proprio per questo bisognava aver cura della società e non impegnarsi tecnocraticamente a costruire una pletorica macchina burocratica totalmente anti-democratica.
Senza un soggetto europeo, un popolo europeo in grado di diventare protagonista, dotato di quei corpi intermedi che danno forza all’opinione pubblica – sindacati, partiti, media, associazioni – come si può pensare di chiedere redistribuzione di risorse, solidarietà anziché competizione, comune sentire? Il problema dell’Unione europea, insomma, non è il recupero della sovranità nazionale, ormai puramente mitica, ma il recupero della democrazia.
Torno a richiamare la riflessione su un ultimo esempio: un mese fa la Bayer ha comprato la Monsanto, un puro accordo commerciale privato internazionale. Che avrà però per tutti noi conseguenze pesantissime, molto più rilevanti di qualsiasi altra deliberazione parlamentare.
Crediamo davvero che un’ Italietta che riacquista la propria totale sovranità nazionale potrebbe esercitare un controllo su simili decisioni? Se c’è una speranza di recuperare qualche forma di de-privatizzazione delle decisioni ormai assunte dai colossi operanti sul mercato internazionale l’abbiamo se daremo più forza a una delle entità in cui la globalizzazione potrebbe articolarsi, l’Europa, per l’appunto. Ma non una Europa qualsiasi, non l’attuale, bensì solo a una entità politica che abbia ridisegnato un modello di vera democrazia adeguato alla nostra epoca. Che ha come premessa il diritto-potere del popolo di contribuire alla determinazione delle scelte che lo riguardano.
Un tempo si chiamava “sovranità popolare” ed era intesa come “nazionale”; ora dobbiamo coniugarla come “europea”, ma senza, per questo, perdere la sostanza del termine sovranità e popolare.
Per questo è importante l’iniziativa delle tante associazioni, a cominciare dalla “mia” Arci, che, con il titolo “La nostra Europa”, ha promosso seminari e incontri in questi due giorni e oggi la marcia che parte alle 11 da piazza Vittorio.
E’ diversa da tutte le altre in programma: perché vuole dire sì all’Europa ma insieme che deve cambiare profondamente. E anche che per dare consistenza a questo obiettivo bisogna cominciare a dare protagonismo ai cittadini europei, non come individui, ma come soggetto collettivo. “La nostra Europa” ne è l’embrione.
 « L'ex ministro greco, presenta un
« L'ex ministro greco, presenta un
New Deal europeo. Un piano in due tempi: subito proposte dirompenti per l’economia e il lavoro, poi una Costituzione che sostituisca i trattati». il manifesto, 25 marzo 2017 (c.m.c.)
Diem 25 (Democracy in Europe Movement), il movimento paneuropeo fondato dall’ex ministro greco dell’economia Yanis Varoufakis un anno fa a Berlino, oggi torna a Roma per presentare il suo programma economico. È il primo passo per approntare un’agenda «progressista» nella prospettiva delle elezioni europee del 2019. Entro il 2025, Diem intende «democratizzare l’Unione Europea», sempre che ne esisterà una tra otto anni. Nel frattempo propone un «dialogo» con le forze politiche esistenti per individuare una forma politica capace di dare vita a un «terzo spazio» oltre i liberismi, i sovranismi e i populismi «che vogliono recuperare un passato che non è mai esistito e vivono del rigetto dell’establishment» sostiene il co-fondatore italiano Lorenzo Marsili. Sul piatto Diem mette 60 mila iscritti in Europa, 8 mila in Italia. Oggi Varoufakis sarà alla manifestazione «La nostra Europa» che parte alle 11 da piazza Vittorio.
Dalla dichiarazione di Roma oggi non arriverà alcuna svolta per un’Europa agonizzante. Il futuro sarà l’Europa a due velocità sostenuta da Italia, Spagna, Francia e Germania, ma rifiutata dal blocco dell’Est?
Questa soluzione mi intristisce. Esiste già da molto tempo. È un revival della proposta Juncker sulle geometrie variabili dell’Unione Europea. Se questo è il futuro significa che questi politici si dichiarano già sconfitti e non sanno dove portare questo continente. Quella che stanno celebrando è la distruzione dell’Unione Europea e il suo approccio business as usual che alimenta populismo, xenofobia e reazione.
Cosa propone Diem 25 per uscire da questa impasse?
Una strategia in due tempi: ora un New Deal europeo, proposte economiche dirompenti, attuabili già da domani mattina, a trattati vigenti di cui non sono affatto orgoglioso. Dopo avere affrontato seriamente il problema della povertà di massa e della cronica mancanza di investimenti, promuovere un’assemblea costituente paneuropea che elabori una costituzione democratica e sostituisca tutti i trattati.
Un tentativo di costituzione europea è stato respinto nel 2005 dai referendum in Francia e in Olanda, soprattutto da sinistra che ha contestato la natura neoliberista di quel testo. Questo nuovo, eventuale, tentativo sarà diverso e in che modo?
Non può che essere diverso. La prospettiva è costruire una repubblica europea su base federalista e che coinvolga tanto i parlamenti quanto le autonomie locali, sempre a partire dai cittadini e dalle loro città. Questo non sarà possibile farlo finché l’Europa continuerà a disgregarsi. Non sarà possibile parlare di una simile prospettiva finché dalla Grecia alla stessa Germania ci sarà la paura di perdere il lavoro o di non trovarlo.
Cosa prevede il «New Deal europeo» che presenterà stasera alle 20 al teatro Italia di Roma?
Un piano di investimenti per la riconversione ecologica da finanziare con un nuovo uso del Quantitative Easing con il quale, oggi, la Bce di Draghi acquista titoli di stato e delle imprese. È basato su un rilancio della Banca Europea degli investimenti. La Bce dovrebbe acquistare i suoi bond per finanziare gli investimenti. Inoltre vanno assicurati i beni di prima necessità e il diritto a un alloggio degno da finanziare con i profitti delle banche centrali europee. I rendimenti del capitale e della finanza vanno socializzati.
Diem 25 si sta configurando come un movimento politico trans-europeo. Quali saranno i suoi prossimi passi?
Abbiamo rivolto un invito aperto, e non una lista di cose da fare, ai partiti, sindacati, movimenti, ai cittadini. Confrontiamoci nei prossimi due mesi. Il 25 maggio ci incontreremo alla Volksbühne di Berlino, a un anno dalla nostra fondazione, per avviare un processo politico elettorale in vista delle prossime europee. Il processo prenderà forme diverse in ogni paese per dare una declinazione nazionale dell’agenda che avremo discusso e condiviso.
Da De Magistris a numerosi esponenti delle associazioni e delle sinistre fino a D’Alema, sono numerosi i soggetti interessati a un discorso critico e rifondativo dell’Europa politica. Ma seguono opzioni non proprio convergenti. Quale spazio avrà Diem?
De Magistris ha aderito al nostro movimento, molti esponenti della sinistra italiana sono interessati. D’Alema ha iniziato a fare un discorso molto critico su quello che è diventata l’Europa. Sta a lui capire se vuole parlare con noi. Il nostro documento sul New Deal non è la bibbia, stabilisce i parametri per un confronto.
Quali sono i vostri obiettivi?
Creare un’infrastruttura che possa permettere alle sinistre, e a un’area politico-culturale più ampia, di avviare un dialogo diverso da quello che esiste oggi. È il nostro lavoro: aprire lo spazio affinché questo possa avvenire a livello continentale.
Cosa risponde a chi, da sinistra, vuole uscire dall’Euro e dall’Unione Europea?
L’Unione Europea, per com’è stata costruita, è una cattiva idea. Lo sostengo dal 1998. La Grecia non doveva entrarci. E questo non lo dico perché sono anti-europeo, ma perché era insostenibile la sua permanenza. Di questa realtà bisogna tuttavia fare un’analisi dinamica e non statica. Gli eventi sono determinati da una molteplicità di cause. Ora non basta dire che l’uscita ci porterà al punto dove l’Unione Europea non ci porterà mai. La nostra proposta è seria, modesta e internazionalista, basata su una disobbedienza costruttiva. A differenza dei left-exiters il nostro piano A non prevede l’uscita dall’Unione Europea, ma un meccanismo per gestire gli effetti negativi di una possibile disgregazione dell’Eurozona. Quando l’establishment metterà una pistola alla tempia, come ha fatto con me quando facevo il ministro dell’Economia della Grecia, allora sarà possibile dire: fallo. E ne pagherai le conseguenze. Dobbiamo condividere le responsabilità politiche e smetterla di accusarci a vicenda.
 «Una oligarchia sovranazionale sempre più lontana dalla vita reale della gente cerca una nuova legittimità presentandosi come protettrice necessaria e benefica, a prescindere dai contenuti e dagli effetti delle sue politiche».
«Una oligarchia sovranazionale sempre più lontana dalla vita reale della gente cerca una nuova legittimità presentandosi come protettrice necessaria e benefica, a prescindere dai contenuti e dagli effetti delle sue politiche».
il Fatto quotidiano, 23 marzo 2017
L’Unione europea si appresta a celebrare il 60esimo anniversario dei Trattati di Roma manifestandosi sotto forma di un immenso accumulo di spettacoli. Come nelle analisi di Guy Debord, tutto ciò che è direttamente vissuto dai cittadini è allontanato in una rappresentazione.
Le celebrazioni sono il luogo dell’inganno visivo e della falsa coscienza. Non mancheranno gli accenni ai padri fondatori, e perfino ai tempi duri che videro nascere l’idea di un’unità europea da opporre alle disuguaglianze sociali, ai nazionalismi, alle guerre che avevano distrutto il continente. Anche questi accenni sono inganni visivi. Lo spettacolo delle glorie passate si sostituisce al deserto del reale per dire: “Ciò che appare è buono, e ciò che è buono appare”.
La realtà dell’Unione va salvata da quest’operazione di camuffamento. Come ricorda il filosofo Slavoj Žižek, la domanda da porsi è simile a quella di Freud a proposito della sessualità femminile: “Cosa vuole l’Europa?”. Cosa vuole l’élite che oggi pretende di governare l’Unione presentandosi come erede dei fondatori, e quali sono i suoi strumenti privilegiati?
La prima cosa che vuole è risolvere a proprio favore la questione costituzionale della sovranità, legittimando l’oligarchia sovranazionale e prospettandola come una necessità tutelare e benefica, quali che siano i contenuti e gli effetti delle sue politiche. Il primo marzo, illustrando il Libro bianco della Commissione sul futuro dell’Ue, il Presidente Juncker è stato chiaro: “Non dobbiamo essere ostaggi dei periodi elettorali negli Stati”. In altre parole, il potere Ue deve sconnettersi da alcuni ingombranti punti fermi delle democrazie costituzionali: il suffragio universale in primis, lo scontento dei cittadini o dei Parlamenti, l’uguaglianza di tutti sia davanti alla legge, sia davanti agli infortuni sociali dei mercati globali. Scopo dell’Unione non è creare uno scudo che protegga i cittadini dalla mondializzazione, ma facilitare quest’ultima evitandole disturbi. Nel 1998 l’allora presidente della Bundesbank Hans Tietmeyer invitò ad affiancare il “suffragio permanente dei mercati globali” a quello delle urne. Il binomio, già a suo tempo osceno, salta. Determinante resta soltanto, perché non periodico bensì permanente, il plebiscito dei mercati.
In quanto potere relativamente nuovo, l’oligarchia dell’Unione ha bisogno di un nemico esterno, del barbaro. Oggi ne ha uno interno e uno esterno. Quello interno è il “populismo degli euroscettici”: un’invenzione semantica che permette di eludere i malcontenti popolari relegandoli tutti nella “non-Europa”, o di compiacersi di successi apparenti come il voto in Olanda (“È stato sconfitto il tipo sbagliato di populismo” ha decretato il conservatore Mark Rutte, vincitore anche perché si è appropriato in extremis dell’offensiva anti-turca di Wilders). Il nemico esterno è oggi la Russia, contro cui gran parte dell’Europa, su questo egemonizzata dai suoi avamposti a Est, intende coalizzarsi e riarmarsi.
La difesa europea e anche l’Europa a due velocità sono proposte a questi fini. Sono l’ennesimo tentativo di comunitarizzare tecnicamente le scelte politiche europee tramite un inganno visivo, senza analizzare i pericoli di tali scelte e ignorando le inasprite divisioni dentro l’Unione fra Nord e Sud, Est e Ovest, Stati forti e Stati succubi. Si fa la difesa europea tra pochi come a suo tempo si fece l’euro: siccome il dolce commercio globale è supposto generare provvidenzialmente pace e democrazia, si finge che anche la Difesa produrrà naturaliter unità politica, solidarietà, e pace alle frontiere e nel mondo. Da questo punto di vista è insufficiente reclamare più trasparenza dell’Ue. Il meccanismo non è meno sbagliato se trasparente.
All’indomani della crisi del 2007-2008, la Grecia è stata il terreno di collaudo economico e costituzionale di queste strategie. L’austerità e le riforme strutturali l’hanno impoverita come solo una guerra può fare, e l’esperimento è additato come lezione. La Grecia soffre ormai la sindrome del prigioniero, ed essendosi sottomessa al memorandum di austerità deve allinearsi in tutto: migrazione, politica estera, difesa. Deve perfino sottostare alla domanda di cambiare le proprie leggi in modo da permettere la detenzione dei rifugiati e le loro espulsioni verso Paesi terzi. Nel vertice di Malta del 3 febbraio si è evitato per pudore di menzionare l’obiettivo indicato nell’ordine del giorno: ridefinire il principio di non-respingimento iscritto nella Convenzione di Ginevra.
La politica su migrazione e rifugiati è strettamente connessa ai nuovi rapporti di forza che si vogliono consolidare. Il fallimento dell’Unione in questo campo è palese, e l’élite che la governa ne è cosciente. L’afflusso di migranti e rifugiati non è alto (appena lo 0,2 per cento della popolazione Ue), ma resta il fatto che la paura è diffusa e che a essa occorre dare risposte al tempo stesso pedagogiche e convincenti. Se non vengono date è perché sulle paure si fa leva per sconnettere scaltramente le due crisi: quella economica e sociale dovuta a riforme strutturali tuttora ritenute indispensabili, e quella migratoria. Basta ascoltare i municipi che temono i flussi migratori: come fare accoglienza, se i comuni sono costretti a liquidare i servizi pubblici e ad affrontare emergenze abitative? Questo nesso è ignorato sia dai fautori dell’austerità, sia dalle destre estreme che la avversano. Lo è anche dalle sinistre che si limitano a difendere i diritti umani dei migranti e non – in un unico pacchetto, con gli occhi aperti sui rischi di dumping sociale – i diritti sociali di tutti, connazionali e non.
Se decidesse di combattere la crisi con un New Deal, mettendosi in ascolto dei cittadini (della realtà), l’Unione potrebbe trasformarsi in una terra di immigrazione, così come la Germania si è con il tempo trasformata da terra di immigrati temporaneamente “ospiti” (Gastarbeiter) in terra di immigrati con diritti all’integrazione e alla cittadinanza. Il New Deal non c’è, e il legame tra le varie crisi è negato per meglio produrre un’Europa rimpicciolita, basata non già sulla condivisione di sovranità ma sul trasferimento delle sovranità deboli a quelle più forti (nazionali o sovranazionali).
Ultima realtà occultata dalla società dello spettacolo che si auto-incenserà a Roma: il Brexit. Per le élite dell’Unione è la grande occasione: adesso infine si può “fare l’Europa” osteggiata per decenni da Londra. Sia il compiacimento dell’Unione sia quello di Theresa May sono improvvidi: se non danno assoluta priorità al sociale i Ventisette perdono la scommessa del Brexit; se il Brexit serve per demolire ulteriormente il già sconquassato welfare britannico, Theresa May si troverà alle prese con chi ha votato l’exit per disperazione sociale. Anche in questo caso viene misconosciuta o negata la sequenza cruciale: quella che dal dramma ricattatorio del Grexit ha condotto al Brexit. È l’ultimo inganno visivo delle cerimonie romane.
 «Se si rimuove e cancella la guerra in corso, gli strumenti di analisi per comprendere gli attentati jihadisti come quello sanguinoso di Londra, è un grave danno non solo alla verità ma anche all’intelligenza».
«Se si rimuove e cancella la guerra in corso, gli strumenti di analisi per comprendere gli attentati jihadisti come quello sanguinoso di Londra, è un grave danno non solo alla verità ma anche all’intelligenza».
il manifesto, 24 marzo 2017
«Siria, 500 marine e milizie curde schierate verso Raqqa, raid aereo Usa fa strage di sfollati», così titolavamo una nostra pagina ieri. Ecco il punto. Se si rimuove e cancella la guerra in corso, gli strumenti di analisi per comprendere gli attentati jihadisti come quello sanguinoso di Londra, è un grave danno non solo alla verità ma anche all’intelligenza.
La scia di sangue, che è tornata fin nella recinzione del parlamento britannico e a un anno esatto dagli attacchi a Bruxelles, dura infatti da troppo tempo. È una seminagione che parte dall’11 settembre 2001 a New York, arriva in Europa, prima in Spagna, poi a Londra e di seguito a Parigi, prima Charlie Hebdo poi, con una vera azione di guerra imparagonabile al ponte di Westminster, al Bataclan.
Dietro, impossibile non vedere, la diaspora di Al Qaeda troppo presto data per liquidata dopo l’uccisione di Osama bin Laden e invece riattivata in tutto il Medio Oriente con nuovi gruppi affiliati; e altrettanto incredibile tacere la lunga stagione della guerra occidentale nella vasta aerea mediorientale, dall’Afghanistan, dove dura da 16 anni e che nel solo 2016 ha prodotto 11.400 vittime civili, all’Iraq che era «missione compiuta» nel 2003; alla Libia e alla Siria dove la coalizione ibrida di Paesi europei, Usa, Turchia e petromonarchie del Golfo tentava lo stesso colpo riuscito a Tripoli con Gheddafi.
Se si rimuove questa ombra feroce che pesa sulla democrazia occidentale, vale a dire l’adesione e la promozione di conflitti bellici almeno negli ultimi venti anni, ecco che il terrorismo jihadista diventa indecifrabile. E invece i suoi codici sono ben leggibili ai nostri occhi.
Eppure ci si richiama alla necessità del modello israeliano, dimenticando che anche per l’Onu Israele occupa militarmente i territori palestinesi.
Così si ricorre a topos narrativi, il lupo solitario, l’emulazione su web, la propaganda islamista, il terrorista della porta accanto.
E si richiama la figura dei foreign fighters, che non sono poche decine ma migliaia e migliaia, da 15 a 20mila denunciò Obama stesso. Tutti partiti in tour da Europa e Stati uniti, mentre le rispettive intelligence guardavano da un’altra parte. E tutti bene accolti dall’atlantica Turchia che, in stretti legami economici e militari con i jihadisti, poi li ha smistati sui campi di battaglia. Ora ci ritornano pericolosamente in casa. Proprio mentre si annunciano le battaglie «decisive» delle due o tre guerre mondial-mediorientali ancora di là da finire.
Si combatte in Siria anche per far fallire la tregua decisa dall’Onu e i negoziati di Astana.
Sul campo si fronteggiano almeno sette eserciti, degli Usa – ora schierati piedi a terra -, della Russia, della Turchia, di quel che resta della Siria di Assad, le milizie sciite hezbollah e iraniane e la miriade di jihadisti, qaedisti e dell’Isis.
Ma la scia non finirà, nemmeno se cadesse Raqqa e neanche se cade Mosul, dove la frantumazione è pressappoco eguale anche perché ogni giorno in Iraq è strage di civili proprio per reazione alla perdita di posizioni del jihadismo sunnita.
Tre sono gli Stati distrutti dai nostri conflitti, Iraq, Libia e Siria: il cuore del Medio Oriente non esiste più.
Si dirà che ormai la scia di sangue del terrorismo di ritorno è diventata endemica. Ma questa endemia deriva dalle alleanze strategiche dell’Occidente legate mani e piedi alle petromonarchie del Golfo e alla nuova Turchia del Sultano Erdogan, nonostante tutto. Deriva cioè dalle guerre che abbiamo promosso.
Testimoni soli e veridici i milioni di disperati in fuga dai conflitti, dal terrorismo e dalla miseria. Una umanità alternativa che, solo se si azzarda a venire da noi, la ricacciamo con i muri e le fosse comuni a mare, per rinchiuderla poi «democraticamente» in campi di concentramento.
 «Con quale coraggio si celebra l’anniversario di un’Europa ideale proprio quando gli stati membri dell’Unione e le istituzioni comunitarie attuano programmi che contraddicono i più elementari diritti di chi fugge da guerre, conflitti etnici, povertà estrema?».
«Con quale coraggio si celebra l’anniversario di un’Europa ideale proprio quando gli stati membri dell’Unione e le istituzioni comunitarie attuano programmi che contraddicono i più elementari diritti di chi fugge da guerre, conflitti etnici, povertà estrema?». il manifesto
, 24 marzo 2017 (c.m.c.)
Da tempo è palese la doppiezza politica dell’Unione europea sull’immigrazione. Da un lato è la stessa Commissione a scrivere nei suoi documenti (ad esempio Population Structure and Ageing, 2016) che a causa dell’invecchiamento della popolazione si sta determinando uno squilibrio sempre più insostenibile tra le persone in età lavorativa e quelle che hanno superato i 65 anni. Dall’altro si occulta il fatto che solo consistenti flussi migratori possono correggere tale squilibrio ed evitare le sue pesanti ricadute sulla spesa pubblica degli stati membri.
I dati evidenziati dalla Commissione sono eloquenti. Se agli anziani, sempre più numerosi, si aggiunge il numero, sia pure in calo, di bambini e ragazzi al disotto di 15 anni, il risultato è che ad oggi nei paesi dell’Unione ci sono solo meno di due persone in età lavorativa che devono supportare le spese d’istruzione, sanità, pensioni, oltre alle altre spese generali dello stato per ogni persona anziana o molto giovane. Nei prossimi anni la situazione è destinata ad aggravarsi giacché la dipendenza dei giovanissimi e soprattutto degli anziani graverà su una persona e mezza in età lavorativa (1,57 nel 2030). E ciò solo in termini fiscali.
Ancor più importante è il deficit in termini di Pil. La sproporzione crescente tra la popolazione complessiva e quella in età lavorativa (anche a non tener conto del tasso di disoccupazione, dei sottoccupati e inattivi) non promette nulla di buono. Infatti le proiezioni economiche e di bilancio della Commissione prevedono una crescita media del Pil dell’1,1% fino al 2020 e dell’1,4% nei decenni successivi (nell’Ue a 28, ora 27). I valori sono ancora più bassi per l’Ue a 15. Il che significa una perdurante stagnazione.
Stando così le cose, la prima conseguenza negativa è che per garantire gli attuali livelli di spese sociali non basta continuare a tagliare in nome di un “rigore” dalle cui strette si vuol uscire solo a parole. Come non bastano i vani e inutili propositi di riduzione della spesa pubblica complessiva.
Per modificare questi squilibri occorrerebbe una rapida crescita della popolazione in età lavorativa dell’ordine di decine di milioni in pochi anni. Il che sarebbe possibile solo mettendo in atto politiche di accoglienza e rapida regolarizzazione di immigrati decine di volte più numerosi di quelli che bussano attualmente alle nostre porte.
Ovviamente, ciò richiederebbe una decisa inversione di tendenza anche in politiche economiche capaci di promuovere un effettivo ampliamento delle basi produttive e del lavoro. Ma pure su questo piano bisognerebbe che gli slogan conclamati non fossero contraddetti dalle pratiche effettivamente adottate.Ed è proprio questa la contraddizione da cui emerge la doppiezza politica dell’Unione europea e dei paesi membri. Non v’è alcuna intenzione di riformare il sistema economico e innovare le politiche sociali.
Si preferisce far credere che sia possibile ed utile fermare i flussi migratori e ignorare la funzione riequilibratrice che essi avrebbero in termini demografici, economici e socio-culturali.
Anche chi pretende di distinguersi dalle politiche di partiti e governi apertamente nazionalisti e xenofobi poi elabora e sottoscrive programmi che pretendono di rispedire i migranti nei paesi dai quali fuggono. E sono disposti a stringere patti con governi spesso corresponsabili delle condizioni di conflitto e di miseria dai quali uomini, donne e bambini cercano scampo a costo di subire sofferenze e violenze d’ogni genere fino al rischio di morire.
Con quale coraggio si celebra l’anniversario di un’Europa ideale proprio quando gli stati membri dell’Unione e le istituzioni comunitarie attuano programmi che contraddicono i più elementari diritti di chi fugge da guerre, conflitti etnici, povertà estrema? Si finge di distinguere tra migranti che avrebbero diritto di accoglienza – salvo poi contingentarne il numero e richiuderli in campi di ritenzione in attesa di pochi permessi e molto probabili rimpatri – e i cosiddetti “irregolari”. Si tenta così di giustificare la negazione di qualsiasi accesso a chi cerca solo di sfuggire alla fame ed invoca l’elementare diritto di costruirsi una vita migliore.
Ma non basta. Non si esita ad alimentare sentimenti di paura ed ostilità nelle popolazioni dei paesi meta dei migranti del tutto strumentalmente, a fini di controllo e disciplinamento sociale o addirittura di mero calcolo elettorale. Tutto ciò non merita alcun sventolio di bandiere.
il manifesto, 23 marzo 2017
Aldo Bonomi mi propone di rimettere in gioco il mio
Non ti riconosco, dichiarazione di smarrimento espressa in forma affermativa. E di virarla, per così dire, in forma interrogativa: come provare a conoscere il nostro tempo, fattosi appunto irriconoscibile?
Ricostruisce anche, in quel suo articolo, il nostro “camminare domandando” fuori dalle mura sicure del fordismo verso i territori magmatici del post-fordismo. E racconta la fatica di Sisifo di seguire il movimento altalenante della scomposizione e della ricomposizione di quasi tutto, soggetti storici, equilibri territoriali, comparti produttivi e riproduttivi, forme della rappresentanza e della rappresentazione… Con in testa la consapevolezza (l’idea, l’utopia?) che lasciate alle spalle le fabbriche in rovina – gli antichi punti focali di un conflitto fondativo e in fondo costituente – si trattasse, per chi non volesse arrendersi, di “fare società”. Parla, infine, di “sociologia delle macerie”, per dare un nome, sintetico, al nostro “lavoro intellettuale”.
Mette in fila tutto questo, Aldo, e ogni passaggio non è solo un pezzo di un’autobiografia collettiva rivisitato. E’ anche una sfida al nostro dispositivo conoscitivo: un colpo di piccone, un tassello dopo l’altro, a un “paradigma” che forse non richiede solo di essere aggiornato, ma sostituito perché, appunto, “falsificato” (ossia, rivelato fallace alla prova dello sguardo).
Prendiamo la questione della scomposizione e della ricomposizione.
Forse quel ciclo non è affatto “eterno”. Forse alla scomposizione non segue più una ri-composizione, ma solo la decomposizione. Forse la distruzione creatrice di schumpeteriana memoria, creatrice non è più. Si limita a distruggere e basta. L’Italia, dobbiamo ben dircelo, ha mancato il passaggio dall’età industriale a quella successiva. Non ha più un vero apparato industriale (ce l’ha spiegato Gallino più di dieci anni fa), non ha ancora (e non avrà mai) una vera economia dei servizi, se non a microscopiche macchie di leopardo.
Quello che osserviamo scrutando “il sociale” sono appunto macerie. Ma il resto dell’Occidente, pur mascherandole meglio, non è un esempio di salute. L’Europa sta su nelle sue aree centrali ridistribuendo alla rovescia le risorse – dal basso verso l’alto, dalle periferie ai centri – ma non ne crea di nuove, portatrici di futuro… E negli Usa, l’abbiamo visto quale sia il peso delle macerie delle infinite heartlands rispetto alle sottili fasce a scorrimento veloce delle aree costiere, in occasione dell’elezione di Trump… Per questo concludevo l’introduzione del mio libro citando Libeskind secondo cui essere consapevoli di essere parte di una fine è già un inizio…
Oppure prendiamo il progetto sintetizzato nella formula “fare società”. Doveva segnare l’avvento della figura del “Volontario” come nuovo produttore di buone pratiche e di alternative all’esistente, in sostituzione dell’obsoleto “Militante” ottocentesco. Favorire forme ardite di Communitas virtuosa nel quadro di un umanesimo rigenerato.
Non è andata così. All’inverso.
Non voglio fare di ogni erba un fascio. Men che meno insistere sulle piaghe più evidenti di quel “mondo”: le “Misericordie” impiegate come polizia interna prima nei Cie e poi negli Hotspot, guardiani di un’umanità dolente e vessata, testimoni reticenti e a volte complici delle vessazioni; le cooperative sociali costituite a copertura di attività criminali dei nuovi schiavisti, a far mercato dei corpi migranti… Non voglio parlare di questi casi di aperto tradimento della mission del Volontariato.
Voglio parlare dei suoi settori “sani”, che lavorano non solo nella legalità ma per la legalità e la solidarietà, ridotti tuttavia a sbiadite controfigure. Tritati nel meccanismo del mercato, spesso sviliti nella logica degli appalti che li costringe alla concorrenza reciproca, al mors tua vita mea, alle scelte al ribasso pur di aggiudicarsi i servizi che in un paese civile spetterebbero all’ente pubblico. E comunque costretti all’irrilevanza nel campo delle decisioni che contano. Oggetti e ornamenti delle retoriche politiche.
In questo contesto, la nostra “sociologia delle macerie” non può che disvelare ciò che trova: macerie, appunto. Senza un punto archimedico su cui poggiare, la sociologia non può che rimanere meramente – inerzialmente – descrittiva. E quel punto archimedico non può che essere, per una sociologia che voglia essere anche performativa – che non rinunci cioè a essere, per dirla ancora con Gallino, pensiero critico -, il “conflitto”. L’apertura di linee di frattura mobilitanti. Forme della resistenza e del rifiuto d’obbedienza ai dispositivi della sottomissione e dell’espropriazione.
O meglio, la domanda (le domande) sul conflitto (sui conflitti): sul come, il dove, il chi e soprattutto il perché di esso (anzi di essi, al plurale). Perché, nonostante la moltiplicazione del disagio e del degrado sociale, questa assenza di protesta stabile e dispiegata, che non sia la forma delegante e sfregiata del voto cosiddetto “populista”? L’unico che sembra – sembra, appunto! – far paura ai nuovi padroni del vapore transnazionale o ai loro (provvisori) ceti politici.
E poi, dove puntare lo sguardo per tentare almeno d’intravvedere l’embrione di una linea di faglia che si allarga? Un tempo si disse “ai cancelli!”, perché era lì, sulle catene di montaggio, che il lavoro vivo resisteva al comando incorporato nella “tecnologia di concatenamento” che l’incatenava. Poi si disse “fuori!”, negli spazi prima periferici della fabbrica diffusa dove il produrre s’impastava col territorio e le sue reti di prossimità.
Ma oggi? dove ci si batte? per contendere brandelli di autonomia, individuale o di gruppo, al comando altrui (perché, continuo testardamente a pensarlo, è questa, dell’autonomia, la radice creatrice in ogni autentico conflitto sociale).
Chi lo fa? Gli ambulanti nei mercati rionale condannati all’estinzione dalla “direttiva Bolkenstein”? I taxisti in rivolta contro il grande fratello incistato nell’App di Uber? O i futuri schiavi del dispotismo di quello stesso algoritmo, destinatari delle contumelie dei taxisti? O i nuovi agricoltori impegnati nella difesa delle qualità organolettiche dei propri prodotti contro la standardizzazione uniformante e immiserente dell’agricoltura chimica? O i residenti-resistenti portatori di una coscienza di luogo nel tempo del predominio sradicante dei flussi (penso naturalmente ai valsusini, ma non solo)? O i pochi restanti e i sempre più numerosi ritornanti alle terre dell’abbandono…
Lo so, nessuno di questi ha la “bella centralità” del conflitto di un tempo. Tutti soffrono di una qualche ambiguità. Ma per chi come noi ha fatto dell’interrogazione sul sociale il proprio mestiere è lì che si deve guardare.
E’ quello il nostro “orto di Candide”, sapendo che rinchiudersi nel proprio orto non va bene, ma restare senza orto vorrebbe dire consegnarsi al mercato.

«
Annunciata indirettamente dal Segretario di stato Usa, Rex Tillerson, che ha esortato i Paesi alleati, durante l’incontro ieri con il premier iracheno Heider al Habadi, «a fare di più» contro l’Isis, l’operazione dietro le linee nemiche compiuta da 500 combattenti curdi appoggiati delle forze speciali Usa, ha colto di sorpresa i miliziani dello Stato islamico. Il blitz, con l’impiego di aerei Osprey capaci di atterrare in spazi ristretti come un elicottero, è avvenuto a Tabqa, una cittadina della provincia di Raqqa, la “capitale” dell’Isis in Siria. I curdi hanno strappato all’Isis il controllo di quattro villaggi e interrotto la strada che porta verso Aleppo, a ovest. Tuttavia Raqqa si trova a decine di chilometri a est del luogo dove sono intervenuti curdi e americani. L’obiettivo dell’operazione perciò è solo quello di mettere le mani su quell’area, in preparazione dell’assalto finale a Raqqa. L’operazione congiunta segna un nuovo passo verso un maggiore coinvolgimento militare in Siria della nuova Amministrazione Usa che, come ha ribadito ieri Tillerson, considera la guerra all’Isis la «priorità assoluta». A Mosul intanto gli uomini del Califfato resistono alla pressione dell’esercito iracheno e la liberazione della città appare ancora lontana.
Non lontano da quell’area, nella cittadina di Mansoura, decine di sfollati siriani sono stati uccisi da un bombardamento aereo della scuola dove erano ospitati. I morti sarebbero una quarantina e l’Osservatorio per i diritti umani in Siria, vicino all’opposizione, sostiene che è stato compiuto dalla Coalizione a guida americana. Silenzio da parte di Washington, responsabile appena qualche giorno fa di un altro attacco aereo contro presunti «leader di al Qaeda» che invece ha centrato in pieno una moschea facendo dozzine di vittime. Nella scuola di Mansoura avevano trovato alloggio temporaneo una cinquantina di famiglie fuggite dai combattimenti nella provincia di Raqqa e da quelle di Homs e Aleppo.
Nel frattempo è definitivamente crollata la tregua proclamata alla fine dello scorso anno e la Siria precipita in una nuova, ma non inattesa, escalation militare innescata da jihadisti e qaedisti, descritti come “ribelli” o “insorti” dai media occidentali. In qualche capitale del Golfo qualcuno ha deciso di silurare i negoziati avviati da russi e turchi ad Astana e dalle Nazioni Unite a Ginevra, considerati «favorevoli» al presidente siriano Bashar Assad. I miliziani della Hay’at Tahrir al Sham, la coalizione composta da al Qaeda e dai suoi numerosi alleati, proseguono l’offensiva alla periferia orientale di Damasco e a Hama. Qui i qaedisti e altri gruppi islamisti hanno raggiunto il villaggio di Khatab, 10 chilometri a nord ovest della Hama. A Damasco Hay’at Tahrir al Sham, che domenica aveva lanciato una prima offensiva respinta dai governativi, martedì è ritornata all’attacco e ha occupato una zona industriale della capitale. Per ora i qaedisti guidati da Abu Muhammad al Julani, luogotenente di Ayman Zawahri, il successore di Osama Bin Laden, resistono agli attacchi aerei e al fuoco dell’artiglieria governativa. E a loro volta, dal sobborgo di Jobar, lanciano razzi e colpi di mortaio verso la capitale. In linea d’area sono ad appena tre-quattro chilometri dal quartier generale di Assad e domenica erano riusciti a colpire anche un edificio dell’ambasciata russa. Decine di famiglie sono state costrette ad abbandonare le loro case per sfuggire ai combattimenti.
Alla vigilia di una nuova sessione di colloqui tra governo ed opposizione l’inviato speciale dell’Onu per la Siria Staffan De Mistura ha descritto questi sviluppi come “allarmanti”. Un po’ poco visto di fronte al negoziato che si sta sbriciolando. Tra i gruppi alleati di al Qaeda nell’assalto della capitale infatti ci sono anche Ahrar al Sham e Jaysh al Islam considerati “moderati” dall’Occidente e Mohammed Alloush, leader di Jaysh al-Islam – fazione finanziata e armata dall’Arabia saudita – è il capo negoziatore a Ginevra. E se nei mesi scorsi, dopo la liberazione di Aleppo da parte dell’esercito siriano, i “ribelli” si erano spaccati in due gruppi – i presunti “moderati” favorevoli a discutere una soluzione politica e i qaedisti considerati “terroristi” anche dagli Stati Uniti e non solo da Mosca – adesso la frattura si è ricomposta. E la direzione dell’orchestra jihadista “ribelle” appare saldamente nelle mani di al Qaeda contraria a qualsiasi ipotesi di compromesso con «l’apostata» Assad. Invece secondo l’editorialista Hussein Abdel Aziz, del quotidiano saudita al Hayat, l’offensiva di Hay’at Tahrir al Sham non sarebbe volta a far naufragare il negoziato bensì avrebbe solo lo scopo di rafforzare l’opposizione ai colloqui a Ginevra ed Astana.
 L'ultimo articolo di Alfredo e ricordi di Valentino Parlato, Eugenio Scalfari, Beppe Vacca, Paolo Franchi.
L'ultimo articolo di Alfredo e ricordi di Valentino Parlato, Eugenio Scalfari, Beppe Vacca, Paolo Franchi.
l'Unità, il manifesto, la Repubblica, Huffington post, Corriere della Sera, 22 e 23 marzo 2017
l'Unita, 14 marzo
UN LUNGO SILENZIO A SINISTRA
di Alfredo Reichlin
L'ultimo articolo, quando finalmente scrive: Matteo, ora basta
Sono afflitto da mesi da una malattia che mi rende faticoso perfino scrivere queste righe. Mi sento di dover dire che è necessario un vero e proprio cambio di passo per la sinistra e per l’intero campo democratico. Se non lo faremo non saremo credibili nell’indicare una strada nuova al paese. Non ci sono più rendite di posizione da sfruttare in una politica così screditata la quale si rivela impotente quando deve affrontare non i giochi di potere ma la cruda realtà delle ingiustizie sociali, quando deve garantire diritti, quando deve vigilare sul mercato affinché non prevalga la legge del più forte. Stiamo spazzando via una intera generazione.
Sono quindi arrivato alla conclusione che è arrivato il momento di ripensare gli equilibri fondamentali del paese, la sua architettura dopo l’unità, quando l’Italia non era una nazione. Fare in sostanza ciò che bene o male fece la destra storica e fece l’antifascismo con le grandi riforme come quella agraria o lo “statuto dei lavoratori”. Dedicammo metà della nostra vita al Mezzogiorno. Non bastarono le cosiddette riforme economiche. E’ l’Italia nel mondo con tutta la sua civiltà che va ripensata. Noi non facemmo questo al Lingotto. Con un magnifico discorso ci allineammo al liberismo allora imperante senza prevedere la grande crisi catastrofica mondiale cominciata solo qualche mese dopo.
Anch’io avverto il rischio di Weimar. Ma non dò la colpa alla legge elettorale né cerco la soluzione nell’ennesima ingegneria istituzionale: è ora di liberarsi dalle gabbie ideologiche della cosiddetta seconda Repubblica. Crisi sociale e crisi democratica si alimentano a vicenda e sono le fratture profonde nella società italiana a delegittimare le istituzioni rappresentative. Per spezzare questa spirale perversa occorre generare un nuovo equilibrio tra costituzione e popolo, tra etica ed economia, tra capacità diffuse e competitività del sistema. Non sarà una logica oligarchica a salvare l’Italia. E’ il popolo che dirà la parola decisiva. Questa è la riforma delle riforme che Renzi non sa fare.
La sinistra rischia di restare sotto le macerie. Non possiamo consentirlo. Non si tratta di un interesse di parte ma della tenuta del sistema democratico e della possibilità che questo resti aperto, agibile dalle nuove generazioni.
Quando parlai del Pd come di un “Partito della nazione” intendevo proprio questo, ma le mie parole sono state piegate nel loro contrario: il “Partito della nazione” è diventato uno strumento per l’occupazione del potere, un ombrello per trasformismi di ogni genere. Derubato del significato di ciò che dicevo, ho preferito tacere. Tuttavia oggi mi pare ancora più evidente il nesso tra la ricostruzione di un’idea di comunità e di paese e la costruzione di una soggettività politica in grado di accogliere, di organizzare la partecipazione popolare e insieme di dialogare, di comporre alleanze, di lottare per obiettivi concreti e ideali, rafforzando il patto costituzionale, quello cioè di una Repubblica fondata sul lavoro.
Sono convinto che questi sentimenti, questa cultura siano ancora vivi nel popolo del centro sinistra e mi pare che questi sentimenti non sono negati dal percorso nuovo avviato da chi ha invece deciso di uscire dal Pd. Costoro devono difendere le loro ragioni che sono grandi (la giustizia sociale) ma devono farlo in un percorso aperto intento ricostruttivo e in uno spirito inclusivo. Solo a questa condizione i miei vecchi compagni hanno come sempre la mia solidarietà.
Il manifesto, 23 marzo
LA MORTE DI ALFREDO REICHLIN.
RAGAZZI, PARTIGIANI, COMPAGNI FELICI IN MEZZO AL POPOLO
di Valentino Parlato
«Il ricordo. Nel libro
Il midollo del leone, il lungo sodalizio con Luigi Pintor, compagno di banco e di lotta».
Il compagno Alfredo Reichlin ci ha lasciato: è una seria perdita. E quando scrivo “compagno” ricordo l’epoca del protagonismo politico e culturale del Pci. Alfredo ne è stato uno dei migliori interpreti: uno straordinario compagno.
La sua vita è stata molto intrecciata a quella dei compagni che hanno fatto questo giornale. Innanzitutto a quella di Luigi Pintor. Erano compagni di banco, al liceo Tasso, ed è proprio grazie a Giaime che ambedue hanno preso la strada che poi li ha portati al Pci. Finirono la scuola nel ’43 ma nel grande edificio di via Sicilia tornarono assieme, armati di pistola, già universitari, per la loro prima azione temeraria: entrarono nella stanza del preside fascista, Amante, minacciandolo di rappresaglia se non avesse consentito lo sciopero degli studenti convocato per protestare per l’uccisione di Massimo Gizzio, studente antifascista in un altro liceo della capitale. Poi riuscirono a prendere contatto col Pci e furono arruolati, diciannovenni, nei Gap romani.
È sempre con Luigi che alla Liberazione decidono di fare il passo dell’iscrizione al Pci. «Eravamo comunisti?» – si è chiesto Alfredo nel bel libro scritto qualche anno fa (Il midollo del Leone, Laterza 2010). Lo siamo diventati dopo. E tuttavia se si vuole capire qualcosa della storia d’Italia e del perché il ruolo del Pci è stato così grande, tanti discorsi sul mito sovietico e sullo stalinismo servono ma fino a un certo punto. Non spiegano perché una generazione che dell’Urss non sapeva nulla (noi compresi) si gettava nella lotta. Non era Stalin ma la patria che ci chiamava. Può sembrare retorico, ma è la pura verità.
«Io non so se questo sentimento nazionale sarebbe scattato senza l’appello all’unità nazionale che ci arrivò da Napoli, dal capo dei comunisti, un certo Ercoli [nome di clandestinità di Palmiro Togliatti --n.d.r.] Dario Puccini, fratello del futuro regista Gianni, ci riunì a casa sua per spiegarci che l’obiettivo di questo Ercoli era la ’democrazia progressiva’.’Progressista’, cercai di correggerlo. No, ’progressiva’, mi rispose irritato, e mi spiegò il significato fondamentale di questa parola che alludeva a un processo in atto: a come, in certe condizioni, la democrazia poteva trasformarsi in socialismo.(Non ci sono barriere cinesi tra la democrazia portata fino in fondo e il socialismo). Lo aveva detto nientemeno che Lenin».
Fu di nuovo assieme a luigi che Alfredo approdò, già nel 1945, alla redazione dell’Unità. Togliatti, con grande coraggio, aveva capito che se voleva costruire un grande partito popolare doveva rendere protagonisti i giovani cresciuti nel paese durante il fascismo, non gli anziani, pur gloriosi compagni, tornati dall’esilio o usciti dalle carceri.
Di quel giornale – in cui io, più giovane di sei anni, entrai come correttore di bozze appena sbarcato dalla Libia – Alfredo divenne direttore, poco più che trentenne, succedendo a Pietro Ingrao. Ed è per “ingraismo” che ne fu allontanato nel ‘ 62 e spedito in Puglia dove era nato, ma non aveva mai vissuto (mentre Luigi per le stesse ragioni veniva spedito in Sardegna).
Segretario del partito in quella regione allora tutta bracciantile lo seguii poco dopo, perché anche io fui mandato «a conoscere l’Italia», e fui per alcuni anni il suo vice. Fu una straordinaria esperienza. Reichlin, sempre in quel libro in cui dà conto della sua vita, racconta il primo impatto con la Puglia, quando parla della felicità: l’immensa felicità della politica che si fa popolo, che riscrive la storia.
«La profonda emozione di riscoprire gli italiani, il paese vero:le borgate, le fabbriche, i braccianti. Ricordo quando arrivai a Bari da Roma una sera tanto tempo fa (erano i primi anni ’60) per assumere la direzione dei comunisti pugliesi. Non conoscevo nessuno. Cenai in una squallida trattoria con Tommaso Sicolo, il mio vice, un operaio di Giovinazzo di straordinaria intelligenza. Stazza 110 chili. Non avevo mai visto mangiare un piatto così grande di pastasciutta. Mi comunicò che il giorno dopo dovevo fare un comizio a Corato. Era la prima volta che parlavo in piazza. Non so quello che dissi. Ricordo solo una piazza immensa e un mare di coppole. Gli zappatori. In Puglia incontrai una umanità: i compagni. Mi trovai immerso nella vita di un partito che era anche una straordinaria comunità umana».
Quando io arrivai in Puglia Alfredo era riuscito ad aprire l’organizzazione anche a qualche giovane che bracciante non era. Stava crescendo un gruppo di intellettuali – Franco De Felice, Mario Santostasi, Giancarlo Aresta, Beppe Vacca, Felice Laudadio – formatisi fra l’università e la casa Editrice Laterza.
Vito Laterza, che ne era il direttore, divenne nostro amico e ci offrì la vecchia villa dove d’estate alloggiava Benedetto Croce, autore fondamentale della casa editrice. Lì andammo a vivere con Alfredo, l’abitazione era bellissima ma ormai a pezzi, in attesa di essere demolita, gelida d’inverno. Lì si svolsero discussioni infinite sulla questione meridionale, di cosa voleva dire – non in astratto, ma a partire da quel contesto concreto – una rivoluzione in occidente che non fosse una semplice variante del riformismo socialdemocratico né del marxismo-leninismo di tipo sovietico. Fu una bellissima stagione.
Anche dopo – per tutti gli anni ’60 – continuammo a incontrarci molto: a Roma, a dirigere la commissione culturale, era venuta Rossana, molto amica di Alfredo, e sebbene non sia mai diventata una corrente, visse in quegli anni pre-’68 un’area ingraiana che la pensava in modo analogo. Così come Ingrao anche Alfredo non ci seguì nell’avventura de Il Manifesto.
Le nostre strade politiche si separarono, non i rapporti umani, sebbene per un po’ di anni, i primi, le relazioni fra chi come Alfredo e Ingrao faceva parte del vertice del partito e chi come noi ne era stato radiato, furono anche tesi.
Alfredo accettò la scelta della maggioranza del Pci anche quando si arrivò allo scioglimento del partito nel gennaio ’91 e poi le successive trasformazioni in Pds, Ds, Pd.
Una rottura gli è sempre sembrata un arbitrio, quasi un atto di superbia. Fino all’ultimo ha continuato a riferirsi a quel che era restato come “il Partito”. Non riusciva nemmeno a immaginarsene un altro. Ma alla fine non ha più retto e ha scelto anche lui la strada del dissenso aperto: votando No al referendum e scrivendo, solo pochi giorni prima di morire, a commento del Lingotto, un feroce articolo contro il renzismo.
le ultime pagine de Il Midollo del Leone sono dedicate ai fratelli Pintor.
Si parte dalla foto della loro classe di liceo e Alfredo torna a guardare quei volti di loro ragazzi. «Sopratutto – scrive- il volto di Luigi, il mio compagno di banco e fratello di Giaime, insieme al quale scoprivo i libri, facevo i grandi pensieri, e poi combattei fianco a fianco tra i partigiani, e poi ancora ci ritrovammo nella redazione dell’Unità. Era un ragazzo davvero straordinario e ne parlo perché vorrei che lo avessero conosciuto i tanti simili a lui, che certamente esistono e che ormai devono decidersi a prendere la parola. Luigi era il nostro capo…..Passò solo un anno ed egli venne a casa da me in quella sera tristissima del dicembre 1943 per dirmi che Giaime era morto, dilaniato da una mina mentre attraversava la linea sui monti dell’Alto Volturno. Noi avevamo 18 anni, Giaime 4 o 5 di più. E Giaime resta per me il simbolo di una generazione».
Rispetto agli intellettuali antifascisti delle generazioni precedenti, questa non si è fatta affascinare dall’intimismo, ha «lasciato ai vecchi intellettuali delusi la confusione dei loro propositi. L’ultima generazione non ha avuto tempo di costruirsi il dramma interiore: ha trovato un dramma esteriore perfettamente costruito».
E poi ricorda le parole di Calvino su Giaime: «L’esempio di Pintor, una delle tempre umane più estranee al decadentismo che pure veniva da un’educazione letteraria che era quella del decadentismo europeo, ci testimonia come in ogni poesia vera esiste un midollo di leone, un nutrimento per una morale rigorosa, per una padronanza della storia».
il suo libro, Alfredo lo conclude con queste parole: «Di questo ’midollo del leone’ c’è un gran bisogno. Se Vittorio Foa fosse ancora vivo e mi rivolgesse di nuovo quella domanda – credevate nella rivoluzione? – io risponderei con questi pensieri».
la Repubblica, 23 marzo
ALFREDO REICHLIN
di Eugenio Scalfari
«Addio amico mio eri il più comunista e il più democratico».
L’avevamo battezzata, Alfredo ed io, la cena dei cretini, che da almeno tre anni aveva luogo in un ristorante romano di buon livello, non sempre lo stesso. I membri titolari di quella cena erano oltre noi due anche Fabiano Fabiani e Luigi Zanda ciascuno con le proprie mogli. Ognuno di noi naturalmente poteva invitare altri comuni amici o figli e questo secondo ciclo, figli a parte, erano cretini di complemento, la serie B: Andrea Manzella, Lorenzo Pallesi, Gianluigi Pellegrino e suo padre quando era a Roma.
Cretini. Ma perché c’era venuta in mente quella parola attribuita a noi stessi e perché mi viene in mente per prima, insieme a una montagna di ricordi questo che è il più cretino del mondo? Era la consapevole descrizione di persone fortemente interessate alla politica e alla propria professione: uomo politico, avvocato, magistrato, docente. Ma nessuno di loro (di noi) aveva mai pensato al proprio interesse. L’interesse generale, quello sì; lo Stato in quanto suo tutore. La distinzione era netta tra l’interesse generale e quello particolare, che doveva essere tutelato anch’esso, ma solo con le forze proprie e comunque doveva cedere di fronte agli ideali, ai valori ed anche alla eventuale conflittualità con quello dello Stato.
Si può conciliare il generale e il particolare, ma c’è chi lo fa con sagacia, nel senso cioè che quella conciliazione è furbesca e procura comunque qualche vantaggio, qualche influente amicizia che al bisogno una mano te la dà. Il cretino della nostra definizione invece è in questo caso ingenuo, sincero, leale con gli altri ed anche con se stesso. Insomma non si è posto un problema contraddittorio che per la sua natura non c’è. Ma per ironizzarlo e divertirmici sopra usiamo la parola cretini, anziché onestamente ingenui. Era anche onestà, non soltanto nella vita pratica ma anche in quella intellettuale. È probabile che questo mio racconto venga preso in giro e sia origine di sfottimenti di vario genere, più o meno diffamatori. Comunque a noi cretini la diffamazione ci sfiora ma non ci tocca. E tantomeno ci ferisce.
Quello che fin qui ho raccontato riguarda questi ultimi anni della mia amicizia con Alfredo, ma essa è molto più antica. Cominciò nei primi anni Cinquanta attraverso Luigi Pintor il quale era molto attivo, comunista politicamente e dotato di grande estro musicale e pianistico. Suonava con la stessa passione e grande tecnica strumentale il pianoforte. L’avevo conosciuto casualmente ed ero stato affascinato dal suo ruolo di pianista. Alfredo lo conosceva e frequentava in quanto compagno comunista ed anche lui gradiva le sue suonate e fu lì il nostro primo incontro.
Capii subito che Alfredo era un comunista “sui generis”, più di sinistra degli altri ma al tempo stesso democratico e costituzionale. Popolare. Amico del proletariato, ma contrario ad ogni rivoluzione che in nome dell’eguaglianza abbandoni la libertà dei singoli, del loro modo di pensare e di agire. Per lui il comunismo e l’eventuale sua rivoluzione potevano essere necessarie per completare le libertà borghesi con la libertà sostanziale del proletariato. Le libertà borghesi, cioè, erano indispensabili perché fanno competere e vanno scambiate per privilegi, ma dovevano essere comunque appaiate alla libertà proletaria e alla sua forza di accedere al potere. Un potere pieno ma democratico. Una democrazia che inventava la sua struttura iniziale: non erano i pochi che comandavano i molti, ma i molti che attraverso il potere ottenevano le finalità volute a favore del proletario, ma al tempo stesso tutelavano la libertà e la difesa dei propri legittimi interessi particolari, non di classe ma di persona e di famiglia.
Questa nel Pci era la tesi sostenuta da Pietro Ingrao e questa fu con chiarezza, ma anche con senso di appartenenza alla rivoluzione sovietica e alla sua potenza internazionale e quasi imperiale, la “doppiezza” di Togliatti, segretario (cioè capo) del Pci, ma anche membro del Comintern e poi del Cominform, organi internazionali del movimento comunista.
Togliatti era le due cose insieme. La sua doppiezza in quegli anni fu preziosa al Pci perché non lo chiuse nel ghetto di un partito che pensava e proponeva soltanto la rivoluzione. Del resto ripeteva quanto era stato stabilito al Congresso di Lione molti anni prima, dall’influenza del pensiero di Gramsci, e soprattutto quanto avevano detto e scritto Marx ed Engels nel 1948, quando le rivoluzioni borghesi scoppiarono nell’Europa intera contro le monarchie e i loro poteri assoluti. Insomma, un ritorno alla Rivoluzione francese dell’Ottantanove, poi sostituita dal “terrore” di Robespierre, dal potere assoluto del Direttorio e poi di Napoleone. Questa storia finisce con la restaurazione del potere monarchico assoluto che ritornò in pieno dopo il Congresso di Vienna gestito da Metternich.
«Marx – mi diceva Alfredo – non avrebbe mai voluto una rivoluzione comunista in Russia per il semplice fatto che la Russia non era una potenza industriale che produce oltre al profitto anche una massa di operai. Era invece un paese latifondista abitato soprattutto da contadini che non a caso alcuni grandi scrittori come Gogol chiamavano “anime morte”. In Russia le liberà borghesi non esistevano, quindi non esisteva la democrazia e non poteva evolversi con il comunismo marxista».
Così la pensava Reichlin e così la pensava Togliatti, ancor più in questa direzione si svolgeva il pensiero e la posizione politica di Terracini. Diversa era quella di Amendola, il più democratico di tutti in Italia, ma il più leninista e poi staliniano in Urss. Amendola cioè estremizzava la sua democrazia italiana compensandola con il suo stalinismo russofobo.
Alfredo era seguace della doppiezza di Togliatti e del popolarismo di Ingrao. Conoscendo i miei sentimenti verso il movimento di “Giustizia e Libertà” derivanti dal Partito d’Azione, mi esortava a votare comunista ora che il Partito d’Azione di fatto non esisteva più, anche se la sua cultura politica era molto diffusa. Di fatto io votavo per il Partito repubblicano finché Ugo La Malfa ne fu il capo, ma quando morì cominciai a votare comunista. Questo coincise con l’emergere di Berlinguer e dei suoi primi strappi contro il potere sovietico.
Ricordo ancora una cena a casa di Alfredo, una casa della cooperativa dei giornalisti, in una serata quasi estiva. Alfredo, che era un bel giovane alto, snello e forte, aveva da poco sposato Luciana Castellina, fisicamente bellissima e politicamente molto impegnata nelle associazioni universitarie di sinistra e poi nel Pci come partito rivoluzionario. Lei altre domande non se le poneva, rivoluzionaria, punto e basta. Infatti col passar degli anni ci fu una rottura e i rivoluzionari a cominciare da Luciana uscirono clamorosamente dal partito e ruppero anche con Ingrao che entro certi limiti era con loro, e fondarono il manifesto.
Tutto questo accadde dopo. La cena di cui parlo avvenne molto prima, esattamente nel giugno del 1957. Aggiungo che l’Espresso era già nato nell’ottobre del 1955 e nel gennaio del ’56 fece la sua comparsa il Partito radicale, fondato dal gruppo dirigente dell’Espresso e del Mondo di Mario Pannunzio. Di quel partito io ero stato nominato vicesegretario.
Queste le premesse che determinarono la nostra cena cui ho accennato. Era molto ristretta e, come mi aveva avvertito Alfredo, riservata. C’erano i padroni di casa (soprannominati da tempo “i due belli”) c’era Togliatti con la sua compagna Nilde Iotti e io con mia moglie Simonetta.
A tavola su domanda di Luciana che voleva sentire da Togliatti come e dove aveva trascorso gli anni di guerra, Togliatti rispose: a Mosca in un albergo. E da quel momento parlò e raccontò quei tre terribili anni, tra il 1939 e il ‘42 con le truppe tedesche a quaranta chilometri da Mosca, circondata con soltanto pochissimi varchi lungo il fiume. Ogni tanto gli facevamo qualche domanda e lui rispondeva, chiariva, completava. Insomma un racconto affascinante, personalizzato da un protagonista politico che lo stesso Stalin trattava per quello che era. Poi su sollecitazione di Alfredo, raccontò anche quando era uno dei comandanti degli armati comunisti a Barcellona durante la guerra di Spagna e ricordò, con un certo imbarazzo, la strage degli anarchici i cui volontari erano anch’essi a Barcellona per arginare le truppe di Franco che assediavano la città. I comunisti e gli anarchici convissero per qualche tempo ma poi scoppiò una vera guerra interna e gli uomini guidati da Togliatti, quando lui era tornato a Mosca, fecero strage degli avversari.
Alla fine, dopo aver brindato e mangiato il tradizionale dolce “montebianco” (lo ricordo ancora) ci trasferimmo nel piccolo salotto con le signore in un lato e i tre uomini dall’altro.
Io su indicazione di Alfredo sedetti in poltrona, lui su una sedia e Togliatti per parlarmi vicinissimo sedette su un pouf, posizionandolo quasi attaccato alla poltrona. Lì compresi finalmente la ragione di quella cena, quando Togliatti mi domandò che cosa fosse e che cosa si proponesse di fare il nostro Partito radicale. Debbo dire che mi sentii assai lusingato da questo suo interesse e risposi: eravamo dei liberali di sinistra, alcuni di noi volevano aprire verso i socialisti, altri, la maggioranza, si consideravano alleati di Ugo La Malfa e dei suoi repubblicani.
«Ho capito – commentò Togliatti – siete una specie di succursale intellettuale dei contadini romagnoli gestiti da La Malfa. L’alleanza con i socialisti è un po’ più anomala». Ma lei, gli dissi io, non è favorevole a questa spinta più a sinistra? «Certo certo», rispose lui. «Forse non hai capito bene», interloquì Alfredo. «A noi interessa che i radicali operino in quanto tali e La Malfa va benissimo come punto di congiunzione. I socialisti di Nenni hanno molto più seguito popolare e con essi non potete fare un’alleanza ma di fatto finirete dentro quel partito senza alcuna funzione autonoma da manifestare. Che vantaggio c’è non solo per voi ma per il Paese?». Intervenne Togliatti: «I socialisti sono nostri alleati, certamente rappresentano, sia pure in modo alquanto diverso, una sinistra marxista e nei momenti fondamentali siamo uniti a tutti gli effetti. Ma un partito liberale di sinistra in Italia non c’è e soltanto il vostro per piccolo che sia marca e sottolinea una posizione che interpreta la parte migliore della classe borghese, quelle famose libertà borghesi che in Italia già ci sono ma sono ancora deboli e fragili.
Chi è in grado di rafforzarle non tanto con i numeri degli elettori ma con il sostegno intellettuale e politico dei valori delle libertà borghesi è il benvenuto anche per noi. Spero di essermi spiegato ». Chiarissimo, risposi io. E la conversazione finì lì.
Di racconti analoghi ne potrei fare molti. Dirò soltanto che quando Berlinguer scomparve, gli subentrò Natta (e Tortorella) ma Natta durò poco e il Pci dovette porsi il problema del nuovo segretario. Era già nata Repubblica e io sostenni che a quel posto andasse Reichlin. Il quale mi telefonò per dirmi che stavo sbagliando. Lui sapeva già che il congresso votava Occhetto e che probabilmente lui avrebbe cambiato il nome del partito. Farà senz’altro bene, mi disse Alfredo, ma lui, Alfredo, non l’avrebbe mai fatto ancorché fosse persuaso che quella era la soluzione necessaria. Quindi la facesse qualcun altro ma lui quell’iniziativa non l’avrebbe mai presa pure approvandola.
Questo è stato Alfredo. Un politico bravo ed efficiente ma soprattutto un custode di valori e ideali a favore dei poveri, dei deboli, degli esclusi. La politica è stata la sua passione ma con difficoltà ad effettuare interventi a favore dei suoi ideali. A me talvolta ricorda in questi ultimi tempi papa Francesco e gliel’ho detto. «Ma che sei matto? » mi ha risposto Alfredo. Questo avvenne un paio di volte durante la cena dei cretini. Lì ci incontrammo l’ultima volta un mese e mezzo fa. Poi si ammalò e adesso ci ha lasciato soli, almeno me.
Huffington post, 22 marzo
LA SUA LEZIONE È QUELLA DI TOGLIATTI.
SU RENZI CI SIAMO DIVISI"
di Beppe Vacca
Beppe Vacca fa un tiro di sigaretta, quasi a trattenere l’emozione, comenello stile dei vecchi comunisti: “Ricordo che a uno dei primi incontri Alfredomi chiese: quante ore al giorno lavori? Io risposi: sei, sette… e lui: cosìpoco? Per fare grandi cose devi lavorare almeno dieci ore al giorno. Iniziò inquei tempi un grande sodalizio intellettuale e anche una grande amicizia”. È lafase della cosiddetta “ecole bariesienne”, il fecondo incontro tra il Pci e gliintellettuali in Puglia. Ricorda Beppe Vacca, storico direttore dell’IstitutoGramsci: “Alla fine del ’62 in preparazione del decimo congresso Alfredo assumela segreteria regionale. Il partito comunista dell’epoca è un partito insediatonelle campagne, tranne Taranto città operaia, e nel quale la forza urbana èmolto modesta e la presenza del ceto medio intellettuale è sparuta”. Reichlin èun giovane dirigente comunista, sguardo esigente e asciutto, cresciuto nel Pcitogliattiano, quello di Gramsci del suo “rovello” della storia d’Italia, cheinterpreta il marxismo come storicismo assoluto, la “politica come storia inatto”, come ricorderà lo stesso Reichlin commemorando Ingrao: “Io – prosegueVacca – avevo scoperto Togliatti, e in Reichlin vidi un dirigente esemplare,per più ragioni”.
Quali?
«Innanzitutto per come interpretava il centralismo democratico. Tornando dalleriunioni di direzione a Roma, non è che dava la linea, spiegava il processo diformazione della linea. Metteva i dirigenti nelle condizioni di poter ragionarenei termini della discussione per come si sviluppava ai vertici. In secondoluogo, per la grande attenzione ai processi urbani».
La politica delle alleanze.
Alleanze e gruppi intellettuali. Anche perché questo tipo di esercizio dinutrire culturalmente il perché la linea era quella e non un’altra stabilisceun allargamento della comunicazione tra i gruppi stretti e una base più larga.Il terzo elemento è che lui inizia subito a dare un nuovo orientamento almovimento operaio della puglia. Lavorando sui braccianti, sul sindacato, licolloca sul terreno più avanzato della lotta per la modernizzazionedell’agricoltura pugliese. È un approccio sviluppistico, non semplicementerivendicativo. E infatti inizia allora il dibattitto se il Mezzogiorno èquestione agraria o questione urbana»
Sentendola parlare avverto una nostalgia per un’epoca in cui la politicaè anche esercizio intellettuale?
«Per me è la politica è sempre questa e non può essere alta. Allorain determinate condizioni, oggi in altre».
Torniamo ai Dieci anni di politica meridionale, come si intitola suo illibro (Editori Riuniti, 1974).
«Il punto di arrivo di questa linea, quando lascia la Puglia, per andare adirigere la commissione meridionale, è che il Mezzogiorno non venga tagliatofuori, anzi è l’idea di un nuovo modello di sviluppo del Mezzogiorno. È unlavoro molto importante, che culmina con la conferenza di Crotone, basato sullasaldatura tra il ciclo contrattuale delle lotte operaie, i fenomeni modernidelle città e quello che si può muovere dalle campagne e dai fenomeni modernidelle città».
È la grande scuola togliattiana: l’analisi sociale, il campo, lapolitica delle alleanze, l’idea di una battaglia che porta all’approdo di unademocrazia che distribuisce ricchezza e potere. Più avanzata.
«La lezione di Alfredo è la lezione di Togliatti. Il fondamento della politica èl’analisi storica. La politica una grande chiave interpretativa dellamodernità, la politica organizzata.
In questa lezione c’è anche un partito non leaderistico. Reichlin èin segreteria con Berlinguer, il leader più popolare che ha avuto la sinistra,ma ha attorno una classe dirigente viva a critica, basti pensare alla vicendadella scala mobile.
«Nella politica come è stata negli anni Settanta, il grande partito era uncomplesso insediamento sociale e il grande partito aveva grandi leader. Poi,cambia la società e il mondo. E quindi cambiano i partiti e la natura dellaleadership».
Negli ultimi anni, lei e Reichlin, due togliattiani, avete fattoscelte diverse. Molto diverse. Vi ha diviso il giudizio su Renzi.
Io ho guardato al Pd nel suo farsi senza essere influenzato dall’alternarsidelle sue leadership. E ho riconosciuto Renzi come leader legittimo.
Però, scusi professore. C’è una differenza non da poco tra ilpartito della Nazione di cui ha parlato Reichlin, che è un partito incardinatosu una parte della società e si fa carico della funzione nazionale, e un magmasenza confini. È la differenza tra un partito che allarga il campo dellasinistra e quello che esce dal campo e rompe i confini.
Per me il Pd è un partito della nazione, già per il fatto che ha accumulatodieci anni di esistenza per una parte fondamentale di un pezzo dell’Italia,della nazione. Se io parlo della sinistra in Germania parlo della Spd, inFrancia del Pse, in Italia del Pd. E il Pd, anche questo Pd, è più modernodelle socialdemocrazie. Non è, come dice lei, un contenitore indistinto, ma uncampo di forze.
Nell’ultimo editoriale Reichlin sull’Unitàusa toni pessimisti sul futuro della sinistra: “Non lasciamo la sinistra sottole macerie”.
«Ha il merito di parlare a tutti. Ognuno mediti e si faccia l’esame dicoscienza».
Scrive Reichlin: “Anche io avverto il rischio Weimar. Crisi socialee crisi democratica si alimentano a vicenda e sono le fratture della societàitaliana a delegittimare le istituzioni !rappresentative”.
È dal 1975 che in Italia è aperta la questione Weimar. Uscì allora il libro lacrisi di Weimer di Gian Enrico Rusconi, pubblicato da Einaudi. Ripubblicatooggi sarebbe attualissimo».
Corriere della sera, 22 marzo
ALFREDO REICHLIN,
PERCHÉ CI MANCHERÀ
di Paolo Franchi
«Padre nobile di tutti i leader della sinistra, con l’eccezione di Renzi, un comunista italiano e un particolarissimo homo togliattianus»
Alfredo Reichlin è morto ieri sera. Aveva 91 anni. Era stato partigiano nelle Brigate Garibaldi, dirigente e deputato per il Pci, allievo di Togliatti, poi in sintonia con Ingrao e la collaborazione con Berlinguer. Fu anche direttore dell’Unità.
Con Alfredo Reichlin, scomparso nella notte all’età di 91 anni, se n’è andato uno degli ultimi grandi vecchi della sinistra. Persone che erano passate attraverso la Resistenza e si erano formate nel clima arroventato della Guerra fredda, ma avevano saputo smussarne le asprezze, pur rimanendo legate all’idea di un superamento del sistema capitalistico che si era rivelata illusoria. Reichlin aveva tuttavia accettato, dopo la caduta del Muro di Berlino, l’esaurimento degli ideali comunisti e le successive svolte che avevano visto la progressiva trasformazione del Pci, fino a svolgere il ruolo di presidente della commissione incaricata di stendere il Manifesto dei valori del Partito democratico. Insisteva però sulla necessità che l’eredità storica della sinistra non andasse dispersa.
Nato a Barletta il 26 maggio 1925, ma cresciuto a Roma fin dall’infanzia, figlio di un avvocato, apparteneva alla generazione che si era avvicinata alla politica con l’adesione alla lotta partigiana nelle file del Partito comunista. In particolare aveva partecipato nella capitale all’esperienza dei Gruppi d’azione patriottica, i nuclei armati che conducevano la guerriglia urbana contro gli occupanti tedeschi e i loro alleati fascisti. Durante la guerra era stato anche catturato dal nemico e poi liberato per un intervento provvidenziale di Arminio Savioli, futuro giornalista dell’«Unità».
Giovane di notevoli capacità, era tra coloro che si erano formati all’ombra di Palmiro Togliatti, che dopo la Liberazione, aveva scelto di aprire il Pci a tutte le energie esterne disposte a condividerne il programma, con l’intento di aggregare forze fresche in una società civile che andava abituandosi alla vita democratica.
Divenuto vicesegretario della Federazione giovanile comunista, Reichlin aveva poi proseguito la carriera politica in campo giornalistico, entrando nella redazione dell’«Unità», di cui era divenuto vicedirettore e poi, nel 1958, direttore. Ricordava con grande orgoglio il ruolo svolto all’epoca dal quotidiano del Pci nella capitale, in particolar modo nel denunciare il degrado delle periferie romane. Il compito che aveva affidato al giornale non era tanto seguire la politica istituzionale, diceva rievocando quegli anni, quanto piuttosto andare alla «scoperta dell’Italia vera, con le sue miserie, le sue tragedie, le sue violenze».
Negli anni Sessanta Reichlin, sulla spinta del cambiamento determinato dalla destalinizzazione, si era avvicinato alla sinistra di Pietro Ingrao e forse anche per questo nel 1963 era stato sostituito da Mario Alicata alla guida dell’«Unità». Ma aveva sempre mantenuto un ruolo di spicco nel partito. Era stato segretario del Pci in un regione importante come la Puglia e dal 1968 era stato eletto in Parlamento. Sposato in prime nozze con un’altra esponente comunista, Luciana Castellina (radiata dal partito nel 1969 con il gruppo del «manifesto»), aveva avuto da lei due figli, Lucrezia (firma del «Corriere») e Pietro, entrambi economisti. Dal 1982 era sposato con Roberta Carlotto.
Durante gli anni Settanta Reichlin era entrato nella direzione nazionale del Pci e aveva lavorato in stretto raccordo con Enrico Berlinguer, di cui aveva condiviso le scelte fondamentali che avevano condotto il partito prima a straordinari successi e poi a un progressivo declino. Interessato ai temi della politica economica e alla necessità di definire un nuovo modello di sviluppo, si era preoccupato anche di stabilire un rapporto con il mondo produttivo, compresa la piccola imprenditoria. Dal luglio del 1989 al 1992 era stato il ministro dell’Economia del «governo ombra» costituito dal Pci, poi divenuto Pds.
Dopo la fine del blocco sovietico aveva accettato di mettere in discussione la propria esperienza politica nel libro Il silenzio dei comunisti (Einaudi), scritto con Vittorio Foa e Miriam Mafai. Altre riflessioni importanti sull’identità e il futuro della sinistra sono contenute nei suoi saggi Ieri e domani (Passigli, 2002) e Il midollo del leone (Laterza 2010). Il suo ultimo intervento, significativamente intitolato Non lasciamo la sinistra sotto le macerie , era uscito il 14 marzo scorso sul sito Nuova Atlantide: «Non sarà una logica oligarchica — scriveva — a salvare l’Italia. È il popolo che dirà la parola decisiva».
 »
»
. il manifesto, 22 marzo 2017 (c.m.c.)
La crisi politica, che segna l’Europa a sessant’anni dalla firma dei Trattati di Roma, non è semplice da interpretare per la sua sovrapposizione di contraddizioni interne ed esterne.
Il contributo europeo alla popolazione e all’economia mondiali è in calo.
E l’Europa deve ridefinire il suo ruolo di fronte all’ascesa di nuove potenze e di fronte alla crisi climatica globale. L’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti e la Brexit forniscono un nuovo sistema di coordinate.
La crisi è anche interna. Dopo due decenni di riforme economiche neoliberiste e di austerità, che hanno distrutto le prospettive future di quasi un’intera generazione di giovani, soprattutto nell’Europa meridionale, sarebbe necessario un piano di ricostruzione sociale in Europa. Ma questa visione non si è fatta strada ai vertici dell’Unione Europea, come ad esempio lascia intendere il Libro Bianco sul futuro della Ue, pubblicato all’inizio di marzo.
Si è forse trattato, di fronte a molti e indistricabili problemi, di una mossa intelligente il fatto che il Presidente della Commissione europea, J.C. Juncker, non abbia presentato una proposta politica coerente, ma quattro scenari di una futura integrazione europea: «Business as usual», lo smantellamento della Ue in una zona di libero scambio, la concentrazione della Ue su alcune politiche chiave, una Ue fondata su specifici accordi o l’estensione dell Ue verso una completa unione economica, finanziaria e fiscale.
I popoli europei stanno voltando le spalle in misura preoccupante all’integrazione europea, come lo stesso Juncker è costretto ad ammettere. Tuttavia, ciò ha portato solo in casi eccezionali, in particolare nel Sud, a un rafforzamento della sinistra. La regola sembra piuttosto essere che le persone traducono la loro insoddisfazione e la paura del futuro in crescente razzismo e nazionalismo. Si può dunque interpretare il Libro Bianco anche come un tentativo della «grande coalizione» formata da democristiani, socialdemocratici e liberali, di assumere una posizione difensiva contro la destra populista. Può questa tener testa alla pressione del nazionalismo?
Althusser insegna a trovare l’essenziale in ciò che non viene dichiarato. La principale omissione nel Libro Bianco è l’assenza di qualsiasi riferimento ai Trattati esistenti della UE. Questa riluttanza potrebbe essere la – del tutto realistica – valutazione per cui, nel quadro degli attuali rapporti, non sia praticabile alcun cambiamento della struttura giuridica fondamentale. Ma ciò significa che per l’Unione Europea si prospetta più un «qualcosa in più del solito» che una «grande riforma». Più efficiente, più rapida, certo. Ma questo non è affatto sufficiente per trovare una via d’uscita dalla crisi.
Le società europee sono sbilanciate. Comprendere ciò significa riconoscere che il compromesso durato finora, che ha sostenuto le società europee e la Ue, con Welfare state, alta occupazione e miglioramento del tenore di vita per molti, è stato rotto dalle classi dominanti sotto il segno del neoliberismo. Il risultato consiste nella disoccupazione di massa che minaccia soprattutto l’Europa meridionale e orientale, nell’abbandono di una generazione perduta e nel mettere i popoli europei l’uno contro l’altro e contro il resto del mondo. La crescita delle destre radicali non è la causa della disintegrazione dell’Europa, bensì una delle sue conseguenze.
L’Unione Europea si è dimostrata negli ultimi decenni sorda alle preoccupazioni e alle sofferenze delle sue cittadine e dei suoi cittadini. Si è sentito dire molte volte che l’Europa deve cambiare rotta. Al cuore della crisi politica europea si trova la mancanza di una vera democrazia, che può contare su sempre meno persone in grado di influenzarne lo sviluppo in senso democratico. La seconda, stridente omissione nei futuri scenari della Commissione Europea, è la realistica definizione del principale deficit nella costruzione europea, la mancanza di una democrazia reale. Ma la prosecuzione e il rafforzamento del precedente federalismo autoritario non possono certo essere considerati la via d’uscita dalla crisi di fiducia tra cittadini e Unione europea.
Mai nella storia la democrazia è stata gentilmente concessa dalle élite dominanti. Essa è stata sempre conquistata da movimenti di massa in processi rivoluzionari. L’Europa ha bisogno di un movimento rivoluzionario di massa, democratico o la sua integrazione pacifica rischia di fallire una seconda volta.
Il Libro Bianco, pubblicato dalla Commissione europea per l’anniversario dei Trattati di Roma, ha deluso molti che attendevano un cambiamento economico e sociale della Ue introdotto «dall’alto». Esso non migliorerà le condizioni delle donne e degli uomini che vivono nell’Unione europea e dipendono dalla vendita del proprio lavoro. Ed esso non presenta ai popoli europei nessuno di quei cambiamenti istituzionali, che potrebbero combinare, in prospettiva, autodeterminazione e democrazia transnazionale.
Mossa intelligente o no, il dibattito sul futuro dell’Europa è aperto. Vi sarà qualche possibilità di successo se sarà un dibattito in cui le popolazioni europee, i sindacati, i movimenti sociali e le forze politiche assumeranno l’Europa come «comune».
* Walter Baier è direttore della rete transnazionale Transform!Europe.
Traduzione dal tedesco di Beppe Caccia
Milioni di bambini rischiano la morte per carestia in Yemen, Sud Sudan, Somalia e Nigeria: la peggiore crisi umanitaria da quando sono state istituite le Nazioni Unite,
nytimes.com, Sunday Review, 18 marzo 2017
Sintesi
Si calcola che, a partire dal 1990, grazie agli aiuti internazionali è stata salvata la vita di più di 120 milioni di bambini affamati. Ma oggi è in atto una tragedia che ha tutte le caratteristiche di un vero e proprio sterminio: in particolare nello Yemen dove, complice l’Arabia Saudita che è alleata degli USA, si impedisce l’accesso ai reporter, per nascondere una carestia apocalittica. La blanda tradizione umanitaria bipartisan dei governi degli Stati Uniti (meno di un quinto dell’1% del reddito nazionale è stato mediamente allocato nel corso del tempo agli aiuti umanitari: circa la metà delle donazioni degli altri paesi sviluppati) sarà cancellata da Trump. L’Amerika non vuole più occuparsene: priorità agli investimenti nel settore militare, costruzione del muro con il Messico, drastico taglio dei fondi per l’assistenza (sia agli strati più poveri della popolazione americana che alle crisi umanitarie internazionali). Sono queste le priorità sbandierate dal nuovo tiranno dell’Occidente» (m.c.g.)
First, a quiz: What is the most important crisis in the world today?
A.) President Trump’s false tweets that President Barack Obama wiretapped him.
B.) President Trump’s war on the news media.
C.) Looming famine that threatens 20 million people in four countries.
Kind of answers itself, doesn’t it?
«We are facing the largest humanitarian crisis since the creation of the United Nations,» warned Stephen O’Brien, the U.N.’s humanitarian chief. «Without collective and coordinated global efforts, people will simply starve to death.»
How is Trump responding to this crisis? By slashing humanitarian aid, increasing the risk that people starve in the four countries — Yemen, South Sudan, Somalia and Nigeria. The result is a perfect storm: Millions of children tumbling toward famine just as America abdicates leadership and cuts assistance.
«This is the worst possible time to make cuts,» David Miliband, president of the International Rescue Committee, told me. He said that “the great danger” is a domino effect — that the U.S. action encourages other countries to back away as well. The essence of the Trump budget released a few days ago is to cut aid to the needy, whether at home or abroad, and use the savings to build up the military and construct a wall on the border with Mexico.
(Yes, that’s the wall that Trump used to say Mexico would pay for. Instead, it seems it may actually be paid for by cutting meals for America’s elderly and by reducing aid to starving Yemeni children.)
It’s important to note that «all of these crises are fundamentally man-made, driven by conflict,» as Neal Keny-Guyer, C.E.O. of Mercy Corps, put it. And the U.S. bears some responsibility.
In particular, the catastrophe in Yemen — the country with the greatest number of people at risk of famine — should be an international scandal. A Saudi-led coalition, backed by the United States, has imposed a blockade on Yemen that has left two-thirds of the population in need of assistance. In Yemen, “to starve” is transitive.
The suffering there gets little attention, partly because Saudi Arabia mostly keeps reporters from getting to areas subject to its blockade. I’ve been trying to enter since the fall, but the Saudi coalition controls the air and sea and refuses to allow me in. In effect, the Saudis have managed to block coverage of the crimes against humanity they are perpetrating in Yemen, and the U.S. backs the Saudis. Shame on us.
Likewise, the government in South Sudan this month denied me a visa; it doesn’t want witnesses to its famine.
In the United States, humanitarian aid has been a bipartisan tradition, and the champion among recent presidents was George W. Bush, who started programs to fight AIDS and malaria that saved millions of lives. Bush and other presidents recognized that the reasons to help involve not only our values, but also our interests.
Think what the greatest security threat was that America faced in the last decade. I’d argue that it might have been Ebola, or some other pandemic — and we overcame Ebola not with aircraft carriers but with humanitarian assistance and medical research — both of which are slashed in the Trump budget.
Trump’s vision of a security threat is a Chinese submarine or perhaps an unauthorized immigrant, and that’s the vision his budget reflects. But in 2017 some of the gravest threats we face are from diseases or narcotics that can’t be flattened by a tank but that can be addressed with diplomacy, scientific research, and social programs inside and outside our borders.
It’s true that American foreign aid could be delivered more sensibly. It’s ridiculous that one of the largest recipients is a prosperous country, Israel. Trump’s budget stipulates that other aid should be cut, but not Israel’s. The U.S. contributes less than one-fifth of 1 percent of our national income to foreign aid, about half the proportion of other donor countries on average.
Humanitarian aid is one of the world’s great success stories, for the number of people living in extreme poverty has dropped by half since 1990, and more than 120 million children’s lives have been saved in that period.
Consider Thomas Awiapo, whose parents died when he was a child growing up in northern Ghana. Two of his younger brothers died, apparently of malnutrition. Then Thomas heard that a local school was offering meals for students, a “school feeding program” supported by U.S.A.I.D., the American aid agency, and Catholic Relief Services. Thomas went to the school and was offered daily meals — on the condition that he enroll.
«I kept going to that little village school, just for the food,» he told me. He became a brilliant student, went to college and earned a master’s degree in the U.S. Today he works for Catholic Relief Services in Ghana, having decided he wants to devote his life to giving back.
I asked him what he thought of the Trump budget cutting foreign assistance. «When I hear that aid has been cut, I’m so sad,» he answered. «That food saved my life.»
Link: 'ThatFood Saved My Life,' and Trump Wants to Cut It Off - The New ...
https://www.nytimes.com/.../that-food-saved-my-life-and-trump
 ».
».
la Repubblica, 21 marzo 2017 (c.m.c.)
I signori della paura segnano le generazioni. Dimmi chi ti ha spaventato e ti dirò quanti anni hai. Per gli italiani nati fino agli anni Settanta il terrorismo ha il volto mascherato dei rapitori di Aldo Moro in via Fani, la faccia dei brigatisti in gabbia che rivendicano gli omicidi durante i processi, i sacchi di sabbia con i nidi di mitragliatrice ai posti di blocco nei centri storici di Roma, Milano, Torino, Genova. Per gli europei più giovani il terrore è raccontato dai cadaveri ai tavolini dei bar, dalle stragi ai concerti e sui lungomare, dai volti esaltati dei giovani soldati del califfato che rivendicano su Youtube gli omicidi che stanno per compiere. Per gli abitanti di Aleppo e delle tante aree del mondo sotto le bombe il terrorismo ha la stessa faccia della guerra e per distinguere l’uno dall’altra bisogna attendere la fine del conflitto e il racconto del vincitore.
L’uscita di emergenza dal terrorismo italiano degli anni Settanta costò centinaia di morti, famiglie distrutte, ma fu trovata. La vera discussione di allora fu per molti aspetti la stessa di oggi: si deve sospendere la democrazia per difendersi da chi l’attacca? Nonostante le tentazioni di destra e di sinistra per varare leggi da stato di polizia, si può dire che l’Italia sconfisse il terrorismo seguendo il principio per cui la democrazia si difende con la democrazia, perché sospendere il nostro sistema di garanzie rappresenta la prima vittoria per chi lo sta attaccando.
L’Europa e, più in generale l’Occidente, possono sperare nel 2017 di seguire la stessa strada? Il terrorismo che dice di ispirarsi a una religione si può combattere con le stesse armi che funzionarono contro il terrorismo ideologico di quarant’anni fa?
Strenuo oppositore delle legislazioni eccezionali, il politologo francese Bernard Manin ne parlerà domenica 2 aprile a Biennale Democrazia, con il direttore di Repubblica Mario Calabresi. Essere contrari alle leggi eccezionali in un Paese che continua a rimanere nel mirino dei terroristi e che ha istituito lo stato di emergenza fin dal 2015 non è facile. Manin spiegherà il suo punto di vista. Il dilemma è quello tra sicurezza e libertà anche se è tutto da dimostrare l’assunto per cui alzando muri ai confini e aumentando i controlli di polizia si sia davvero più sicuri.
Di quel dilemma parlano i giuristi Mauro Barberis e Geminello Preterossi coordinati il 30 marzo da Pier Paolo Portinaro. Una terza via tra chiudersi nel castello e lasciare totale libertà anche ai nemici è probabilmente quella che a livello internazionale ha tradizionalmente perseguito l’Italia. Ma anche in questo campo, ha segnalato più volte il capo della Procura di Torino, Armando Spataro, manca un coordinamento europeo tra intelligence, lacuna drammaticamente emersa anche dopo i recenti attentati. Spataro ne parla con l’inviato del Corriere della Sera Giovanni Bianconi. «Non è solo una questione di sicurezza ma di cultura», dice Christiane Taubira, ex ministra della giustizia in Francia con i governi Ayrault e Valls. Proprio la sua opposizione alle misure antiterrorismo varate dopo le stragi l’ha indotta a dimettersi dall’incarico. Venerdì 31 marzo racconterà il suo scomodo punto di vista.
Per combattere il terrore dei nostri giorni è indispensabile capire da dove nasce. Ed è questo un altro dei punti di discussione nell’Occidente. Non è irrilevante sapere se tutto parte da una radicalizzazione delle correnti più estreme dell’Islam o se, al contrario, è stata la voglia di rivolte radicali a trovare nel Corano la scusa per darsi una struttura culturale e religiosa di sostegno.
La prima ipotesi, quella dell’Islam che si radicalizza e arriva a conquistare le nostre città, come ideale prosecuzione della guerra santa per estendere il Califfato oltre la penisola arabica, è forse la spiegazione più rassicurante per l’Occidente. E per questo suona incompleta. La storia sociale delle banlieues parigine racconta che, almeno in quei luoghi, la rivolta sociale ha preceduto e di molto la radicalizzazione islamista. Come se l’integralismo religioso rappresentasse l’ultima àncora a cui attaccare la rabbia sociale dopo che la politica francese di destra e di sinistra l’aveva catalogata come una rivolta marginale: «Racaille», plebaglia, aveva esclamato il ministro degli interni dell’epoca, Nicolas Sarkozy. Era il 26 ottobre 2005.
Oggi che la “racaille” alimenta i campi di addestramento per foreing fighters in Siria rispondere alla domanda: «Come si diventa terroristi?» è fondamentale. L’inviata di guerra Francesca Borri, il sociologo Stefano Allievi e lo scrittore Giuseppe Catozzella ne parlano il 31 marzo coordinati da Renzo Guolo. Sperando di trovare un’uscita di emergenza dalla logica dello scontro tra civiltà che ha ormai ruotato di novanta gradi il suo asse e oggi si combatte esplicitamente tra Nord e Sud del mondo.
 Tra le decine di notizie cattive in merito alla decenza degli italiani di oggi eccone due buone. A Venezia, migliaia alla Marcia per l’Umanità per chiedere un’Europa solidale. A Villanova il sindaco presenta ai residenti i 10 migranti accolti nel comune.
Tra le decine di notizie cattive in merito alla decenza degli italiani di oggi eccone due buone. A Venezia, migliaia alla Marcia per l’Umanità per chiedere un’Europa solidale. A Villanova il sindaco presenta ai residenti i 10 migranti accolti nel comune.
La Nuova Venezia, 20 marzo 2017 (m.p.r.)
CORTEO PER L'ACCOGLIENZA
«SIAMO TUTTI CITTADINI»
di Vera Mantengoli
Venezia. Il Veneto che vuole una società dove l’uguaglianza a prescindere dal colore della pelle e la parità dei diritti siano valori fondanti, si è mostrato ieri per le calli di Venezia con la Marcia per l’Umanità, al grido di «la nostra Europa non ha confini, siamo tutti cittadini». La Venezia città dei ponti, è diventata simbolo della richiesta di ponti umanitari e solidarietà sociale. La manifestazione, organizzata da Melting Pot, si inserisce nel più ampio movimento europeo #overthefrontress che monitora i percorsi dei migranti, denunciando le ingiustizie.
In migliaia (1.500 per la Questura, 4.000 per gli organizzatori) hanno sfilato dalla stazione di Santa Lucia a Campo Sant’Angelo, preceduti dall’artista Barbara Tagliapietra che, vestita da colomba della pace, ha guidato il corteo con i migranti che reggevano il manifesto «Side by Side». La marcia, pacifica, allegra e scandita da musiche ritmate, si è conclusa con il lancio di un doppio appuntamento: il 22 aprile a Pontida e il 20 giugno, per la Giornata del Rifugiato.
Durante il corteo e sul palco si sono susseguite testimonianze e discorsi (Laboratorio Sociale Morion di Venezia, don Bruno Baratto e don Luca Favarin, il coordinamento Padova accoglie, il cantautore Pierpaolo Capovilla che ha letto Home di Warshan Shire e molte altre su FB «Side by Side»). Il filo conduttore degli interventi è stato l’urgenza di un nuovo modello di accoglienza. Molti i rifugiati che hanno denunciato alcune situazioni disumane, come a Cona e a Treviso: «Finalmente adesso vado a scuola» ha detto uno dei migranti, ringraziando il Centro Sociale Django di Treviso. «Voglio diventare un insegnante di matematica, ma nella Caserma Serena ci sentiamo prigionieri, non ci sono medicine adeguate e spesso vengono usate parole offensive nei nostri confronti».
Tra gli speaker anche chi ormai è in Italia da anni («Ricordiamo che lavoriamo e paghiamo le tasse») e tra i manifestanti anche le seconde generazioni, come Arising Africa di Padova. «Si parla di migranti, ma mai con i migranti» spiegano Sara e Barbara, afrodiscendenti, «Purtroppo il colore della pelle provoca ancora razzismo. Siamo qui perché si riprenda il discorso sulla cittadinanza e sulla ius soli e per ribadire che per una nuova accoglienza serve che ci si conosca come cittadini». «Basta con le divisioni» ha detto Marco Sinotti di #overthefrontress «soprattutto tra profughi economici e di guerra, siamo tutti bisognosi l’uno dell’altro. Le persone che arrivano sono dei veri flussi di vita e noi dobbiamo riuscire a mettere insieme le comunità locali con chi arriva o transita».
I sindaci Alessandra Buzzo di S. Stefano di Cadore (Belluno) e Franco Balzi di Santorso (Vicenza) sono stati applauditi: «Un amministratore» ha detto Buzzo «ha un’enorme responsabilità non solo di asfaltare le buche, ma di insegnare la solidarietà. Il mio Comune ha sempre accolto e una di queste persone oggi è il mio quinto figlio». «Le migrazioni rappresentano la storia dell’umanità», ha detto Sergio Zulian di Adl Cobas, «Basta con la criminalizzazione paranoica del migrante e no ai Cie in ogni Regione». Si è parlato anche di leggi con l'avvocato di Padova Marco Paggi dell'Asgi. che ha criticato il decreto Minniti che prevede di togliere il secondo grado di appello: «Si dice che i migranti sono troppi, ma se guardassimo il nostro stato demografico saremmo noi a invitarli. Questo decreto porterà soltanto braccia per il caporalato e voce agli xenofobi».
I MIGRANTI SI PRESENTANO AI RESIDENTI
di Giusy Andreoli
Villanova, incontro per conoscere i dieci stranieri appena arrivati in paese
Villanova di Camposampiero. Sono stati presentati ieri mattina dal sindaco ai residenti i 10 migranti africani che hanno trovato accoglienza in due appartamenti di Murelle Vecchia affittati dai proprietari, privati cittadini, alla Cooperativa “Laris” di Torri di Quartesolo, in accordo con la Prefettura di Padova. I 10, che ieri erano alle scuole medie, provengono dall’hub di Bagnoli e sono in Italia da giugno; cinque sono cristiani e cinque musulmani. Tutti sono stati vaccinati e hanno fatto uno screening sanitario. Kone Wandan è della Costa d'Avorio, ha 25 anni e faceva il commerciante; Mballo Madou è del Senegal, ha 28 anni ed era agricoltore; Len Yamory arriva dalla Guinea, ha 20 anni, studiava e dava una mano ai genitori nei campi, anche Fofan Abdurahman è della Guinea, ha 18 anni, studiava e aiutava i genitori in campagna; Madjegue Keita è invece del Mali, ha 18 anni e lavorava in campagna; arriva dalla Nigeria Ewemad Yobo, 25 anni, elettrauto; Osaren Ikponmwosa è nigeriano e diplomato ragioniere; nigeriano è Lucky Omobude, di 27 anni, gestiva un negozio di vestiti. Gli ultimi due sono della Sierra Leone: Tajan Alhajiss, 19 anni, studente, muratore e Koemneh Vandi, 25 anni, studente.
Ha sorpreso il gesto di un anziano, Zenobio Gelasio, che è andato a stringere la mano a tutti i migranti. «Sono emozionato e orgoglioso del mio Paese perché ricordo che una ventina di anni fa arrivarono quattro albanesi e li misero nei campi sportivi di via Puotti, dormivano nelle brande messe a terra nei bagni». Il sindaco Cristian Bottaro ha ribadito che la sua amministrazione ha messo in chiaro di non voler aderire allo Sprar, il progetto di accoglienza dei migranti. «Una scelta non contro le persone», ha spiegato Bottaro, «ma non sono d’accordo con le modalità. Ho però apprezzato che la Prefettura mi abbia telefonato per informarmi, un gesto di accortezza e correttezza. La nostra comunità si impegnerà per il rispetto, ma altrettanto ci aspettiamo da loro altrimenti dovranno lasciare il nostro territorio. E posso farlo in quanto autorità di pubblica sicurezza».
Il Comune non stanzierà risorse, ma accetterà che i migranti facciano lavori socialmente utili, se addestrati. Bottaro ha spiegato anche la presentazione pubblica: «Avevo due opzioni, non interessarmi e far finta di niente oppure farveli conoscere. Perché le barricata non producono niente». I responsabili della coop, fra cui uno psicologo e un mediatore culturale, hanno spiegato il percorso di accoglienza, i tempi e le modalità di gestione. «Due andranno lunedì in Commissione prefettizia che valuta le motivazioni dell’arrivo in Italia e poi emana il relativo decreto, uno andrà nei prossimi giorni, gli altri sono stati già sentiti e sono in attesa del decreto. Se positivo, riceveranno un permesso a muoversi nel territorio che dura dai 2 ai 5 anni, se negativo potranno fare ricorso». Molte le domande dei presenti. Un cittadino ha chiesto ai migranti se vogliono andare in altri Paesi europei, tutti hanno risposto che vogliono restare in Italia, suscitando l'ironico applauso di un militante leghista.
 «Il concetto di giustizia – e ingiustizia – ambientale è entrato di recente, ed è stato sviluppato contestualmente alle proteste e alle rivolte di comunità urbane emarginate». il blog di Guido Viale, 16 marzo 2017 (c.m.c.)
«Il concetto di giustizia – e ingiustizia – ambientale è entrato di recente, ed è stato sviluppato contestualmente alle proteste e alle rivolte di comunità urbane emarginate». il blog di Guido Viale, 16 marzo 2017 (c.m.c.)
Il corpo umano ha la sua estensione naturale nell’ambiente, originario o artificiale, in cui è inserito, così come ogni essere umano è una efflorescenza particolare dell’ambiente in cui vive. La condizione umana, intesa come esistenza particolare di ogni singolo uomo o di ogni singola donna, o di ogni comunità territorialmente situata, e non di un astratto “essere umano”, è indissolubilmente legata alle condizioni in cui si svolge la sua esistenza.
Condizioni che possono essere determinate tanto dalle dinamiche che interessano un determinato territorio, quanto dalla mobilità che contraddistingue l’individuo, la comunità o il gruppo sociale a cui l’individuo appartiene. Quanto al primo punto, un determinato territorio può essere caratterizzato sia da una relativa invarianza – restare più o meno uguale a se stesso nei secoli o nei millenni – quanto da una elevata varietà che può essere provocata sia da eventi naturali che da interventi migliorativi o devastanti di origine antropica; interventi che possono a loro volta provocare sia progressi o regressi del benessere dei suoi abitanti, sia catastrofi che richiedono un radicale ri-orientamento di molti dei loro comportamenti, fino al completo abbandono di un territorio. Quanto alla mobilità, e innanzitutto alle migrazioni che dall’origine hanno accompagnato l’evoluzione della specie umana e la differenziazione delle sue culture, oggi è uno dei fattori più rilevanti della stratificazione sociale.
Grosso modo, nel mondo globalizzato di oggi, possiamo distinguere il vertice di una piramide, costituita da una élite internazionale (il famigerato 1 per cento; ma probabilmente molti meno), sempre meno legata a un territorio particolare perché impegnata in investimenti e operazioni che spaziano su tutto il globo, e quindi scarsamente interessata alla qualità di un ambiente particolare, perché in grado in ogni momento di scegliersene uno più gradevole.
Mentre al fondo della piramide sociale, intere comunità sono costrette ad abbandonare, tutti insieme o un po’ per volta, il territorio in cui sono nati e cresciuti sia loro che le loro famiglie, perché reso inospitale e inabitabile da qualche catastrofe naturale o, sempre più, dai cambiamenti climatici in corso; oppure da progetti di “sviluppo” o da accaparramenti di risorse locali, per lo più promossi e gestiti da chi quel territorio non lo abita e non lo frequenta mai.
In mezzo a questi estremi, c’è una folta schiera di abitanti di questo pianeta che vivono in ambienti (aria, acque, suolo e alimenti) sempre meno naturali e sempre più non solo antropizzati, ma anche e soprattutto inquinati; e che tentano, perché ne hanno la possibilità, di sottrarsi al loro impatto per brevi periodi, come il week-end o le vacanze, alla ricerca di aria, acque e paesaggi meno compromessi. Ma la maggioranza degli abitanti di questa terra questa possibilità non ce l’ha; come non ha la possibilità di scegliere gli alimenti, l’acqua o la casa e si deve accontentare di ciò che è, quando lo è, alla sua portata.
Le diseguaglianze mostruose che affliggono la popolazione mondiale e che pregiudicano il suo futuro non sono sicuramente riconducibili soltanto al fattore ambiente; ma l’ambiente incide su di esse, e sulle dinamiche che le caratterizzano, molto più di quanto ci abbia insegnato a individuarle l’approccio ai problemi sociali sganciato dall’analisi di quelli ambientali proprio della cultura affermatasi prima in occidente, e poi in tutto il mondo, fondata sulla contrapposizione, e non sulla integrazione, tra uomo e natura.
In questa cultura il concetto di giustizia – e ingiustizia – ambientale è entrato di recente, ed è stato sviluppato contestualmente alle proteste e alle rivolte di comunità urbane emarginate o discriminate per ragioni economiche o razziali, che vedevano i territori in cui erano state relegate dallo sviluppo urbano venir scelte come sede degli interventi più impattanti: fabbriche inquinanti, discariche, inceneritori, depuratori, autostrade urbane, ecc. Lì il contrasto tra l’ambiente curato e, per quanto possibile, salvaguardato in cui avevano la loro residenza i ceti più privilegiati, da un lato, e le aree elette a discariche tanto degli “scarti umani” che di quelli industriali, dall’altro, era evidente e diventava sempre più intollerabile.
Ma in altre culture, che avevano mantenuto per secoli o millenni un rapporto più stretto con l’ambiente naturale in cui e di cui vivevano, la convinzione che la convivenza sociale tra i membri di una comunità su basi paritarie, cioè la giustizia sociale, fosse indissolubilmente legata al rispetto della natura e dei suoi cicli non era mai venuta meno.
Questo approccio sta diventando oggi sentire comune tra un numero crescente di uomini e donne impegnate nelle battaglie più diverse contro le diseguaglianze sociali, lo sfruttamento e l’oppressione. E non a caso è il centro del più importante documento politico di questo inizio di secolo: l’enciclica Laudato sì di papa Francesco. La connessione tra giustizia ambientale (il rispetto della natura e dei suoi cicli) e giustizia sociale (la lotta contro le diseguaglianze, lo sfruttamento è l’oppressione) è un paradigma destinato a cambiare dalle radici la cultura sociale e il progetto di un mondo diverso.
Qualcosa di questi temi, il rapporto tra le diseguaglianze sociali e il degrado ambientale, la traduzione in iniziative e progetti concreti la lotta contro i cambiamenti climatici che a parole tutti condividono, il rispetto dell’ambiente di tutti, e soprattutto di quello degli ultimi sta ispirando l’agire politico dell’establishment economico, politico o mediatico europeo? Neanche parlarne.
 ». il manifesto, 18 marzo 2017 (c.m.c.)
». il manifesto, 18 marzo 2017 (c.m.c.)
Occorreranno studi approfonditi di psicologia per riuscire un giorno o l’altro finalmente a capire come mai, ogni volta che si parla di debito pubblico, al ministro dell’Economia di turno brillino gli occhi, si guardi furtivamente intorno e con riflesso pavloviano decida di mettere sul mercato un altro pezzo di ricchezza sociale.
Come fossimo agli albori della dottrina neoliberale, ci tocca ogni volta sentire la litania: «Servono le privatizzazioni per abbattere il debito pubblico».
Nel frattempo, ci siamo venduti quasi tutto e il debito pubblico ha continuato allegramente la sua irresistibile ascesa.
Poco importa. Ormai sappiamo che ogni volta che si «accende» lo «scontro» tra il nostro governo e e l’Unione Europea, dobbiamo controllare le nostre tasche perché è quasi automatica la soluzione: la sottrazione di un bene comune..
Per carità, questa volta siamo solo alla fase istruttoria, ma il fatto che sia già uscita sulla stampa appare una studiata strategia di sondaggio preventivo per vedere di nascosto l’effetto che fa.
Il ministero dell’Economia sta studiando un nuovo assetto della Cassa depositi e prestiti (Cdp), che prevede la cessione di una quota del 15%, che porterebbe la proprietà pubblica al 65% (essendo il 15,93% già in possesso delle Fondazioni bancarie. Essendo il patrimonio complessivo pari a 33 miliardi, nelle casse dello Stato entrebbero 5 miliardi che naturalmente sarebbero destinati all’abbattimento del debito pubblico.
Inutile sottolineare come la parola «abbattimento» nel dizionario italiano ha un preciso significato: demolizione, distruzione, abolizione. Può chiamarsi abbattimento un’operazione che porterà il nostro debito pubblico dagli attuali 2.217,7 miliardi (dicembre 2016) ai futuri 2.212,7 miliardi?
In compenso, se l’ultimo dividendo staccato da Cdp corrispondeva a 850 milioni di euro (dei quali, 680 milioni sono andati allo Stato), in futuro, su ogni dividendo simile, lo Stato ne incasserà solo 550. Non è neppure chiaro ad oggi a chi verrà ceduto il 15% se a investitori istituzionali, a fondi o banche estere.
La svendita di un ulteriore pezzo di Cdp si incrocia anche con le grandi manovre intorno alla privatizzazione di Poste: l’idea del ministero dell’Economia è quella di cedere entro l’anno il residuo 29,3% (dopo aver ceduto il 35% a Cdp e il 36,7% a investitori individuali e istituzionali).
Grandi manovre finanziarie, fatte all’oscuro di tutti i detentori della ricchezza di Cassa Depositi e Prestiti, ovvero quelle oltre 20 milioni di persone che vi depositano i risparmi (oltre 250 miliardi) e che sapranno sempre meno intorno alla loro tutela e utilizzo.
Forse è davvero giunto il momento di rilanciare una campagna di massa per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti, per il suo decentramento territoriale e per la gestione partecipativa dell’utilizzo del risparmio postale.
Hanno venduto tutti i beni comuni e ora scappano con la Cassa. È il momento di riprenderci la ricchezza sociale che rappresenta.
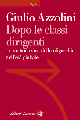 «Il saggio
«Il saggio
Dopo le classi dirigenti di Giulio Azzolini fa il punto sulla metamorfosi di oligarchie e classi dirigenti, svalutate dalla globalizzazione e dal web». la Repubblica, 18 marzo 2017 (c.m.c.)
Tempi di dannazione per “élite” ed “elitismo” e boati di disgusto per chi pronuncia quelle parole senza scherno e senza rendere omaggio alle “masse”. Questi sono gli anni della “casta” e della diffusa repulsione che essa raccoglie nel mondo. Eppure la risposta a questa melmosa crisi delle “classi dirigenti” (altro concetto ora infetto, un tempo glorioso) potrebbe anche vedere una rivincita delle teorie di Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto, italiani famosi nel mondo per le rispettive teorie, della “classe politica” e delle “élite”: una minoranza di governanti al comando di una maggioranza di governati.
Il paradosso è stravagante solo per chi non abbia fatto attenzione alla rilevanza che quelle teorie non hanno mai smesso di avere negli studi politici, da quando uscirono Elementi di scienza politica nel 1896 e Systèmes socialistes nel 1904. Nel primo si affermava il principio che in ogni società è sempre soltanto una ristretta cerchia di persone che detiene il potere politico; nel secondo a questa classe politica si dà il nome di “classe superiore” o di “élite”.
Parole che non erano neutrali e connotavano positivamente questa minoranza, mentre esprimevano un sentimento negativo verso il socialismo allora emergente. Tuttavia la storia non finiva lì perché la teoria successivamente sviluppata dagli stessi iniziatori, e poi da Roberto Michels, con la sua “legge di ferro dell’oligarchia” ha mostrato di valere ben oltre gli usi politici conservatori, quando si è manifestato il potenziale emancipativo dei regimi democratici.
Non sorprende dunque che un giovane ricercatore riproponga oggi la teoria delle élite per la forza esplicativa che ancora manifesta in un brillante e analitico volume di storia delle idee, ispirandosi ai successi che essa ha avuto in epoca democratica: Giulio Azzolini con Dopo le classi dirigenti. La metamorfosi delle oligarchie nell’età globale (Laterza).
Il principio organizzativo della vita sociale e istituzionale è implacabile: occorre una gerarchia e qualcuno che coordini e comandi, anche nelle forme più aperte di cooperazione. Michels usava il termine oligarchia, in maniera avalutativa, nell’analisi del partito socialdemocratico tedesco, e Azzolini tenta l’ardita impresa di riscattare la parola dal discredito in cui l’ha gettata la retorica corrente. Eppure è chiaro a tutti i realisti democratici, da Joseph Schumpeter a Robert Dahl, da Norberto Bobbio a Giovanni Sartori, passando per Lasswell, Aron, e arrivando fino alle generazioni successive dei Gianfranco Pasquino e Eva Etzioni Halevy, che anche la democrazia prevede una minoranza ben organizzata che esercita il potere su una maggioranza, che è, al confronto, sparsa e meno organizzata. L’atto stesso di votare è un gesto elitista che delega il potere a una minoranza (Nadia Urbinati, Democrazia rappresentativa, Donzelli).
L’idea di un governo diretto del popolo, attraverso le assemblee o i referendum, o addirittura il “cervello sociale” della rete (Casaleggio), non sono più che miti. Il “direttismo” (conio di Sartori) è una illusione perché suppone una competenza e una informazione dei cittadini, possibili solo in situazioni ideal-tipiche. Difficile oggi ripetere la formula elementare di Walter Bagehot, il classico ottocentesco della Costituzione inglese (1873), secondo cui quella che è «per abitudine o per scelta la maggioranza numerica della popolazione è contenta di delegare il potere a una minoranza scelta, di abdicare in favore di una élite educata e senza opposizioni». Rispetto ad allora non si vedono più gioiose abdicazioni; abbiamo riserve su quella “educazione” delle élite (Bagehot) o sulla qualità in generale dei quartieri alti della società (Schumpeter).
Il passaggio che ha creato lo sconquasso nelle relazioni tra governanti e governati è quello rappresentato dalla esplosione di un fattore che era rimasto implicito nella teoria delle élite: il nazionalismo metodologico, l’area nazionale statale in cui era concepito l’esercizio del potere. Lo sfondo era delimitato perché il potere aveva confini, era “cartografico”, mentre la globalizzazione ha prodotto una deterritorializzazione, denazionalizzazione, una fluidificazione del potere che lascia alle classi dirigenti “cartografiche” e alle loro campagne elettorali l’arduo compito di reggere la marea in condizioni di impotenza. Hanno qui le radici vari processi degenerativi di un’epoca in cui «ristabilire la visibilità delle frontiere serve a placare l’ansia». Muri ben radicati per terra sono la risposta, a volte politica, a volte solo retorica, di fronte al libero fluttuare di forze che appaiono minacciose e incontrollate.
Di questi confini presidiati Manlio Graziano racconta la storia geopolitica, dalla pace di Westfalia al confine americano col Messico ( Frontiere, Il Mulino). L’implicito nazionalista – la lacuna – della teoria delle élite produce oggi una affannosa ricerca di barriere scaccia ansia e di protezionismo. Una terapia – spiega Graziano – il cui vizio consiste nel voler curare il «rallentamento dell’economia con un ulteriore rallentamento dell’economia».
Gli “psicopatici delle linee di confine” sono sempre più numerosi nonostante la disconnessione delle ossessioni ideologiche dai fatti. Le espulsioni massicce di immigrati in difesa della purezza della nazione hanno storicamente provocato recessioni, accadde a Luigi XIV quando revocò l’editto di Nantes e cacciò dalla Francia duecentomila protestanti: erano buona parte dell’élite economica.
 «Decreto sicurezza. Dietro il provvedimento, l'idea che la marginalità sociale presente nello spazio pubblico deturpi il decoro».
«Decreto sicurezza. Dietro il provvedimento, l'idea che la marginalità sociale presente nello spazio pubblico deturpi il decoro». il manifesto
, 17 marzo 2017 (c.m.c.)
Il decreto Minniti, approvato ieri alla Camera e che di qui a breve sarà convertito in legge, propone un’idea di sicurezza secondo cui la marginalità sociale presente nello spazio pubblico deturpa il «decoro», disturba la «quiete pubblica» e attenta alla «moralità».
Di conseguenza, contro elemosinanti, clochard, venditori abusivi e consimili si decide di abbattere una scure di sanzioni molto aspre. Il provvedimento rilancia lo spirito del decreto Maroni del 2008, quando in nome di una guerra senza quartiere ai marginali d’ogni risma si tirarono fuori i sindaci sceriffi. Come già all’epoca, si agisce con decreto, ritenendo che sussistano i requisiti di necessità e urgenza. Al contempo però, con una certa schizofrenia governativa, lo stesso ministro Minniti, rispondendo al question time della Camera, dichiarava ieri un calo del 9,4% dei reati nel corso dell’ultimo anno. Tuttavia, aggiungeva il ministro, la percezione di insicurezza è aumentata. È alla percezione, ovvero alla pancia del paese, che risponde questo decreto. Il governo volta così le spalle al garantismo e prende la strada del populismo penale.
Come già per il decreto Maroni, è verosimile che la Corte Costituzionale dichiari illegittime numerose parti del provvedimento. Alcuni punti sono in effetti particolarmente critici: il potere dei sindaci, benché più contingentato di allora, appare ancora troppo ampio; e il cosiddetto Daspo cittadino prevede disuguaglianze nel trattamento. In sostanza il decreto dice, all’articolo 13, che il questore – il questore, si badi bene, e non il giudice – può vietare l’accesso a una serie di luoghi pubblici a chi negli ultimi tre anni è stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per spaccio; e si sa che spaccio è una categoria giuridica che nella realtà comprende molti semplici consumatori.
Qualora questo divieto fosse infranto, si potrebbero comminare multe che vanno dai 10 ai 40mila euro. Poi magari si verrà assolti in terzo grado, ma le sanzioni per essere andati laddove non si poteva e quando non si poteva resteranno sul groppone del malcapitato.
Tutto ciò avviene a pochi giorni di distanza da una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo, la sentenza Italia c. De Tommaso, che raccomanda al nostro paese di far uso un cauto delle cosiddette misure di prevenzione, essendo queste degli strumenti che limitano la libertà di movimento in assenza di un controllo giurisdizionale. Il governo invece, ne ha allargato il campo d’applicazione.
Il decreto, fra le tante cose, prevede che vengano multati e allontanati anche coloro che impediscono la libera fruizione delle stazioni, ovvero barboni e senzatetto, che proprio nelle stazioni usano chiedere l’elemosina e ripararsi dalle intemperie, poiché lì circola tanta gente e si può racimolare qualche soldo in più. Per questi si prevedono multe dai 100 ai 300 euro, che com’è noto non verranno mai pagate. Laddove poi queste persone non ottemperino all’ordine dell’autorità, come farebbe un barbone cacciato dalla stazione il giorno prima e tornatoci quello dopo, secondo l’articolo 650 del codice penale potrebbero essere portate in carcere.
Sulla scia di una cultura forcaiola propria della Lega, che infatti in commissione ha applaudito il decreto, il governo sembra mandare un messaggio alle forze dell’ordine, incoraggiandole ad adottare un approccio repressivo nei confronti di categorie già vulnerabili, ora anche indesiderabili.
Pochi giorni fa l’associazione Antigone ha incontrato nel carcere di Regina Coeli un detenuto ghanese che prima di finire dietro le sbarre dormiva all’addiaccio, anzi sotto il tetto della stazione. Due agenti delle forze dell’ordine sono andati a dirgli di andar via, e di fronte al suo rifiuto hanno buttato la sua coperta nel cestino; coperta che il ragazzo in questione è andato a prendere, e che gli agenti hanno nuovamente buttato via. Fino a quando, alla quarta volta, il ragazzo è stato portato in carcere per resistenza a pubblico ufficiale.
Ora, a nostro avviso, l’azione di chi sta al governo, e a volte si dice pure garantista e nemico dei populismi di ogni sorta, dovrebbe essere portatrice di messaggi d’altro tipo, e dar vita a provvedimenti motivati da ben altre urgenze, come ad esempio l’emergenza integrazione.
* Associazione Antigone

la Repubblica, ed.Bari online, 17 marzo 2017
Uno stabile destinato a ospitare migranti è stato occupato da una decina di famiglie del quartiere Salinella a Taranto. La zona di via Plinio è stata transennata e presidiata dalle forze di polizia. I circa 50 occupanti protestano: «Perché dare queste case ai migranti quando noi siamo senza casa e lavoro». Secondo il coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia Mimmo Lardiello, «i residenti della zona sono preoccupati perché si parla dell'arrivo di 400 immigrati. Il governo non può decidere da un giorno all'altro di trasformare un quartiere che ospita numerosi studi professionali in un ghetto». I poliziotti hanno poi proceduto alle operazioni di sgombero dell'immobile in seguito alla denuncia presentata la proprietario.
Da giorni circolava la voce che lo stabile al numero 16 di via Plinio, edificio di proprietà privata fino a due anni fa sede di uffici comunali, sarebbe stato preso in fitto da cooperative che si occupano dell'accoglienza e dell'assistenza ai migranti. L'allarme fra le famiglie della zona è scattato quando sul posto si è presentata una ditta di pulizie. In pochi minuti i manifestanti hanno allontanato i dipendenti della ditta e messo un guardiano all'ingresso dello stabile. La zona è stata subito presidiata dalla polizia. Poi sono arrivate mamme e bambini che hanno occupato gli alloggi.
La protesta ha un duplice volto: da un lato le famiglie della parte più popolare del quartiere che chiedono aiuto e alloggi al Comune, dall'altro professionisti e residenti della zona Bestat (Beni stabili), «preoccupati che l'arrivo di alcune centinaia di migranti peggiori ulteriormente la qualità della vita in un quartiere scarsamente illuminato e già teatro di atti vandalici contro portoni e auto in sosta», come spiega il consigliere comunale di Fi Giampaolo Vietri.
«L'accoglienza non può essere improvvisata e schizofrenica. Bisogna individuare razionalmente - aggiunge Lardiello - aree dove sono garantiti controlli di polizia e impatto sociale. Pochi mesi fa trenta migranti sono stati sistemati in un palazzo in pieno centro a Taranto ed hanno violato il regolamento condominiale creando scompiglio fra i residenti».

« esce rassicurata dal voto olandese. Ma non del tutto». la Repubblica,
La diga olandese ha funzionato. Ha tenuto. La temuta ondata populista, islamofoba ed euroscettica, non si è abbattuta sui Paesi Bassi, rimasti fedeli alla tradizione cosmopolita e permissiva. I partiti democratici hanno conquistato la stragrande maggioranza dei 150 seggi del Parlamento. Ma la viscerale avversione per lo straniero non è stata estirpata del tutto dal voto di ieri.
Serpeggia nelle vecchie Province Unite, come nel resto dell’Europa. Il sentimento xenofobo non ha prevalso, ma non è diminuito. Anzi è cresciuto, sia pure leggermente e non come sperava Geert Wilders. Il quale sarà deluso dopo le tante promesse dei sondaggi. Il tribuno xenofobo avrà più deputati, 19 invece di 15. Il suo partito (della Libertà) ne ha guadagnati un numero troppo sparuto per alimentare sogni di governo. Il suo avversario, il liberal-consevatore, Mark Rutte, lo ha sconfitto perché il suo partito sarà più presente in Parlamento. Ma dei 41 seggi che aveva nella precedente assemblea ne ha conservati soltanto 31. La distanza tra Rutte e Wilders si è accorciata.
Wilders non parteciperà comunque al futuro governo, poiché nessuno lo vuole come partner, dovrà accontentarsi di vantare un più consistente numero di elettori. Non un successo, dunque, ma una speranza rivelatasi un’illusione. Per l’Olanda europeista è invece un segno di stabilità, perché i partiti che la difendono possono creare un loro governo. L’avanzata della sinistra ecologista contrapposta al modesto risultato dell’estrema destra è stato un fatto rilevante per l’Olanda e per l’Europa. Come è stata importante la grande affluenza, l’82 per cento, che non ha favorito come si pensava l’estrema destra.
Il biondo Geert Wilders, che nasconde sotto la capigliatura tinta i lineamenti ereditati da un’ascendenza indonesiana (da cui non sono escluse tracce musulmane) ha conservato, anzi rafforzato una base da cui difendere quella che chiama l’identità europea e cristiana. I forse vaghi legami con l’Asia non appartengono più alla sua memoria. L’Olanda è ospitale con gli uomini e con le idee. Ha accolto la Ragione: quando era perseguitata altrove. Le eccentricità non la turbano. La posizione di Wilders andrebbe riconosciuta come una libertà, se chi l’incarna non volesse chiudere le moschee, proibire il Corano e non chiamasse “canaglie “ gli immigrati marocchini.
Sull’elezione di ieri ha pesato la controversia tra l’Aia e Ankara. Il presidente turco prepara per il sedici aprile un referendum che dovrebbe conferirgli più poteri, e per questo ha bisogno anche dei suffragi dei turchi residenti all’estero. A questo fine ha mandato dei suoi ministri a tenere comizi nelle comunità turche in Europa. Il premier Mark Rutte ha impedito agli inviati di Erdogan di adempiere alla loro missione. Gli ha chiuso la porta in faccia. E Ankara ha reagito con una collera tale da far apparire il governo olandese un difensore della inviolabilità nazionale di fronte alla prepotenza dei turchi. Rutte ha svolto un compito gradito agli elettori sensibili ai richiami islamofobi di Wilders. Ed è probabile che gli abbia sottratto dei consensi.
L’ Europa esce rassicurata dal voto olandese. Ma non del tutto. L’ elezione di ieri ha rinviato la partita ai prossimi appuntamenti. Il populismo non è dilagato nelle pettinate pianure strappate al mare per ospitarvi quanto di meglio la nostra civiltà europea abbia saputo dare. Ma l’elezione di metà marzo ha rivelato quanto esso sia radicato in un paese in cui tanti profughi hanno trovato una patria. L’affluenza alle urne, a Rotterdam, a Amsterdam, all’Aia, a Utrecht, nella ricamata Delft, doveva darci un segnale. Dopo un 2016 con forti accenti populisti, prima la Brexit e poi l’avvento di Donald Trump alla Casa Bianca, volevamo sapere quel che ci riserva l’anno in corso, durante il quale sono in programma elezioni sia in Francia sia in Germania. La Francia vota tra poco più di un mese e le elezioni olandesi dovevano servire per misurare il livello populista in Europa. Ma Parigi non è l’Aia. Né è Berlino. L’esperienza populista continua.


 «Se davvero vuole sconfiggere il fenomeno del caporalato, e cancellare le immagini della manodopera sfruttata nei campi di pomodori o intorno agli alberi di arance, l’Italia deve mettere al bando le aste “al doppio ribasso».
«Se davvero vuole sconfiggere il fenomeno del caporalato, e cancellare le immagini della manodopera sfruttata nei campi di pomodori o intorno agli alberi di arance, l’Italia deve mettere al bando le aste “al doppio ribasso». 

 «Il Trattato di Roma ha messo al centro il diritto di movimento delle persone e delle merci; come nella tradizione settecentesca ha associato la libertà ai fattori economici o di produzione, la cittadinanza all’apertura dei mercati
«Il Trattato di Roma ha messo al centro il diritto di movimento delle persone e delle merci; come nella tradizione settecentesca ha associato la libertà ai fattori economici o di produzione, la cittadinanza all’apertura dei mercati

 « L'ex ministro greco, presenta un
« L'ex ministro greco, presenta un 





 »
» ».
». 


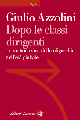 «Il saggio
«Il saggio 

