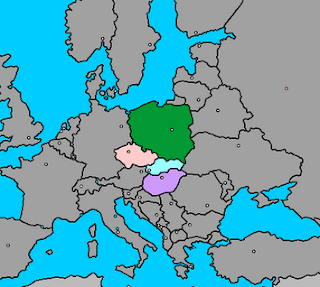Ancora ostacoli alle organizzazioni umanitarie che tentano di aiutare i fuggiaschi che tcercano rifugio in luoghi sicuri. Articolo di Carlo Lania e commento diLuigi Manconi.
Ancora ostacoli alle organizzazioni umanitarie che tentano di aiutare i fuggiaschi che tcercano rifugio in luoghi sicuri. Articolo di Carlo Lania e commento diLuigi Manconi.
Il manifesto, 1 agosto 2017
ONG DIVISE,
SOLO IN DUE FIRMANO
IL CODICE-SALVATAGGI
di Carlo Lania
«Codice a sbarre. Msf rifiuta le nuove regole: contrari alla presenza di agenti armati a bordo delle navi e al divieto di trasbordo dei migranti»
Alla fine solo due Ong – Save the Children e Moas – hanno accettato di firmare il codice di comportamento messo a punto dal Viminale per i salvataggi in mare. Medici senza frontiere ha scelto infatti di non accettare le nuove regole e lo stesso ha fatto la tedesca Jugen Rettet. Tutte le altre Ong, Sea-eye, Sea Watch e Sos Mediterranée, peraltro assenti alla riunione di ieri pomeriggio al ministero degli Interni, starebbero ancora valutando il da farsi, mentre disponibilità a firmare il Codice sarebbe stata dichiarata via mail in serata dalla spagnola Proactiva open arms.
L’accordo tra Ong e Viminale, che sembrava quasi raggiunto solo venerdì scorso, alla fine invece è saltato. E adesso le due parti si rimpallano la poca disponibilità a venirsi incontro. Due i punti principali di scontro, sempre gli stessi da quando la trattativa è cominciata: il divieto a effettuare i trasbordi dei migranti tratti in salvo e la presenza a bordo delle navi di agenti di polizia giudiziaria armati. Questioni dirimenti per le Ong, delle quali però l’ultima bozza inviata venerdì sera in visione dal ministero non avrebbe tenuto contro in maniera adeguata. «Ci preoccupa non aver ricevuto garanzie sul fatto che gli agenti salirebbero a bordo disarmati», spiega Tommaso Fabbri, capo missione di Msf Italia. «Se accettassimo, posso immaginare le ripercussioni che potremmo avere negli altri Stati in cui Msf opera e nei quali abbiamo mantenuto il principio di non avere con noi personale armato. Non dimentichiamo che siamo operatori umanitari».
Stessa cosa per quanto riguarda la possibilità di trasferire i migranti salvati a bordo di navi più grandi, come quelle della missione europea Sophia. Le Ong operano spesso su mezzi non particolarmente grandi, adatti per i soccorsi perché possono accostare i barconi senza creare situazioni di pericolo, ma del tutto inadatte a trasferirli in Italia. Un’ipotesi accordo si era trovata sulla possibilità di effettuare i trasbordi sotto controllo e autorizzazione della Guardia costiera italiana, ma alla fine non se ne è fatto nulla. «Nel codice questa possibilità viene prevista come un’eccezione, senza alcuna garanzia per le Ong di non essere costrette a dover tornare verso l’Italia con i migranti a bordo», prosegue Fabbri.
Cosa accadrà adesso è un’incognita per le organizzazioni umanitarie. Di sicuro a nessuna di loro verrà negato l’accesso ai porti, ma dal ministero degli Interni fanno capire che Moas e Save the Children, le due Ong che hanno accettato il Codice, diventeranno degli interlocutori privilegiati e entreranno di fatto nel sistema nel sistema istituzionale dei soccorso. Questo vuol dire che in caso di un barcone che si trovi in difficoltà la sala operativa della Guardia costiera chiamerà a intervenire prima di tutto loro. «Le altre – spiegano sempre al ministero – si assumeranno la responsabilità per quanto riguarda la sicurezza della navigazione e delle persone che si trovano a bordo».
Molto probabilmente verso le Ong che non hanno firmato verranno effettuati dei controlli più serrati per quanto riguarda la strumentazione di bordo, ma è chiaro che l’assenza delle Ong di fronte alle acque libiche, magari perché costrette a trasportare i migranti in un porto italiano, rischia di aumentare il numero dei naufragi.
Per Valerio Neri, direttore generale di Save the Children, Ong che invece ha accettato le nuove regole, «gran parte dei punti indicano cose che già facciamo e ci sono stati chiarimenti su un paio di punti che ci preoccupavano, quindi non abbiamo avuto problemi a firmare. Siamo convinti – ha aggiunto Neri – di aver fatto la cosa corretta e mi dispiace che altre Ong non ci abbiano seguito, ma evidentemente avevano altre sensibilità».
Il mancato accordo con le Ong ha scatenato le reazioni del centrodestra. Per il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta ha chiesto al ministro degli Interni Minniti «di chiudere i porti» alle Ong che non hanno sottoscritto le nuove regole, mentre Georgia Meloni, leader di FdI, ha chiesto al governo di sequestrare le loro navi.
ONG NEL MIRINO
PER SPORCARE TUTTO
di Luigi Manconi
La controversia tra le Ong e il governo italiano intorno al codice di regolamentazione dell’attività di salvataggio in mare è questione di grande importanza. Guai a pensare che in discussione sia la maggiore o minore severità dei controlli e la tassatività delle regole di ingaggio o la trasparenza di questo o quel finanziamento.
Fosse così, col buonsenso di tutti i soggetti, le contraddizioni si risolverebbero in breve. Ma non è affatto così: e il motivo è che la posta in gioco è rappresentata dalla stessa categoria di salvataggio.
Per questa ragione, il rifiuto da parte di un’organizzazione autorevole come Medici senza frontiere (premio Nobel per la Pace nel 1999) di sottoscrivere quel codice elaborato dal governo italiano, è un fatto estremamente serio. E male farebbe una persona esperta come il ministro dell’Interno Minniti a sottovalutarlo.
Ma come si è arrivati a questo esito?
Nei primi mesi del 2017, Frontex – agenzia europea della guardia di frontiera – solleva alcuni dubbi sull’operato delle organizzazioni non governative che partecipano all’attività di soccorso nel mare Mediterraneo. Si accende, così, una polemica sulle presunte relazioni tra le stesse Ong e le strutture criminali che gestiscono il traffico di migranti; e sui finanziamenti che alcune di quelle Ong riceverebbero da sostenitori sospetti perché interessati a «destabilizzare il quadro economico del nostro Paese».
Come affermato dal capo della Procura di Catania, Carmelo Zuccaro. La Commissione Difesa del Senato decide, in base a ciò, di avviare un’indagine conoscitiva, conclusa da un documento che deve riconoscere come tutte le accuse nei confronti delle Ong non reggano alla verifica dei fatti.
In quella sede, i più alti gradi della Marina militare, della Guardia costiera e della Guardia di finanza, escludono che siano mai emerse prove di rapporti tra Ong e trafficanti, sottolineando la piena collaborazione in quel tratto di mare tra organismi di coordinamento, imbarcazioni statuali e navi delle associazioni umanitarie. Anche la magistratura siciliana, nel corso delle audizioni, riconosce la sostanziale correttezza delle Ong.
Il procuratore capo di Catania, Zuccaro, sostiene di non disporre di «alcun fondamento probatorio» che suffraghi le proprie ipotesi accusatorie. E tuttavia, nonostante la fermezza della Guardia costiera nel ribadire di avere il pieno controllo di quanto avviene nelle operazioni Sar (Search And Rescue), le conclusioni della Commissione Difesa insistono sulla necessità di un «coordinamento permanente» per razionalizzare «l’attività disordinata» in quel tratto di mare, che sarebbe dovuta alla presenza delle Ong. Se ne conclude che sarebbe necessaria «una contestuale riduzione delle relative imbarcazioni nell’area».
Va detto che, nel corso di questa polemica, sono emersi umori assai pericolosi. In primo luogo, quella velenosa tendenza a «sporcare tutto», che è tanto più irresistibile quanto più il bersaglio del fango da gettare appare lindo, immune da brutture, privo di zone grigie e di ombre sospette. È l’antica pulsione a lordare ciò che è pulito (un muro, un’immagine, una reputazione), a degradare tutto e tutti al livello più basso, a omologare nell’infamia, a confondere nel disgusto universale. Se tutto è miserabile, la mia miseria risulta in qualche misura riscattata o, comunque, attenuata.
Ma c’è anche dell’altro. In quei meccanismi di degradazione, risultano sfigurate, e comunque intaccate, anche quelle categorie che potevano considerarsi intangibili. Indurre a sospettare che il bene possibile, rappresentato da un’attività umanitaria, possa rivelarsi un male contagioso – i soccorritori alleati ai carnefici – contribuisce potentemente a ridurre in macerie principi fondamentali. Le insinuazioni, e la diffidenza che ne consegue, non solo sfregiano le Ong e ne deturpano il prestigio, ma ottengono l’effetto di erodere i valori cui si ispirano. La violenta polemica, pur conclusasi con un pugno di mosche, ma con una persistente ombra di diffidenza da cui nasce anche questa proposta di codice di regolamentazione, mette in discussione quelle categorie di soccorso, salvataggio e aiuto umanitario che rappresentano il fondamento stesso dell’identità umana. Soccorso e salvataggio, infatti, costituiscono il cuore della vita nel momento essenziale in cui quella stessa vita è messa a repentaglio.
Gli uomini riconoscono di essere uniti da una obbligazione etica e sociale quando – innanzitutto quando – è dal rapporto di reciprocità che dipende la loro sopravvivenza. E il fatto che si evochi, in occasione dei salvataggi nel Mediterraneo, la cosiddetta legge del mare sottolinea l’ineludibilità di quel rapporto perché lo colloca geograficamente laddove lo spazio sembra raggiungere la sua assolutezza: il mare, appunto.
È questo che può spiegare i connotati perenni e imprescindibili di quell’obbligo-diritto-dovere al soccorso e al salvataggio come valore irrinunciabile. Non una vocazione utopica né una tentazione profetica nell’affermare tutto ciò. Piuttosto l’esatto contrario: la volontà umile e ostinata di ritrovare – nel fondamento materiale di una mutua necessità – il senso della qualità umana.
 «Gridiamo “Siamo tutti Charlie!” ad ogni nuova strage terroristica nella nostra Europa, ma ci facciamo passare sotto gli occhi i morti ammazzati a Kabul e Aleppo o annegati nelle acque del Mediterraneo».
«Gridiamo “Siamo tutti Charlie!” ad ogni nuova strage terroristica nella nostra Europa, ma ci facciamo passare sotto gli occhi i morti ammazzati a Kabul e Aleppo o annegati nelle acque del Mediterraneo».
il Fatto Quotidiano, 31 luglio 2017 (p.d.)
Una settimana fa un attacco terroristico ha ucciso 37 civili, e ne ha feriti più di 40. A Kabul. Alcuni ne avranno letto, ad altri, anche coscienziosi e ben informati, sarà sfuggito. Certo la reazione, in Italia come in Gran Bretagna e nel resto dell’occidente, è stata ben diversa rispetto all’angoscia e all’attenzione spasmodica riservata agli attacchi di Londra o Manchester. Ogni volta è lo stesso: siamo tutti Charlie, ma facciamo un po’più fatica ad essere Kabul, o Aleppo. Come se le vite non contassero tutte allo stesso modo.
Tra chi si è preso la briga di leggere il primo paragrafo di questo articolo, possiamo identificare due categorie. Da un lato quelli che annuiscono energicamente: due pesi e due misure, l’ipocrisia dell’occidente e via discorrendo. Dall’altro quelli che scuotono il capo con qualche impazienza: non capisci che è diverso se succede in Europa? che non ci si può far carico di tutti i problemi del mondo? che alla fine si ammazzano tra di loro? Eccetera eccetera. Questa seconda categoria coincide in parte con quelli che pensano che i morti nel Mediterraneo non siano affar nostro, e un suo nutrito sottogruppo sbraita che questa gente viene qui per rubare o per farsi saltar per aria (semplifico).
La prima categoria la pensa in modo radicalmente opposto, naturalmente, e tuttavia, anche tra questi, la maggioranza ha dedicato ai fatti di Kabul (o di Aleppo, o del Sudan) una frazione dell’attenzione e del cordoglio dedicato a Manchester, a Nizza o a Parigi. Persuasione politica, analisi geopolitica, credo religioso, convincimenti morali fanno una qualche differenza, ma non tutta la differenza.
Non è un fenomeno nuovo. Se n’era già accorto Aristotele, che notava nella Retorica che la compassione (così come l’invidia) la si prova per chi conosciamo, o per chi è simile a noi per età, carattere, costumi e cultura, nascita o condizione sociale. Perché la compassione è legata alla paura – alla paura che possa succedere a noi. Per questo si prova compassione per ciò che è vicino, mentre ciò che è lontano – ciò che è alieno – non ha lo stesso effetto. Aristotele descrive, non giudica: così stanno le cose, e basta.
In un magnifico saggio del 1994, Carlo Ginzburg esplorava queste dinamiche tracciando la genealogia culturale di una figura immaginaria, quella di un ipotetico mandarino cinese. Questo povero mandarino, in vari scritti di Diderot, di Adam Smith, di Chateaubriand e di Balzac, veniva introdotto soltanto per morire nell’indifferenza, o per volontà, di un altrettanto ipotetico europeo desensibilizzato dalla distanza. Nella versione più catastrofica, Adam Smith immagina che la Cina “con i suoi abitanti, venga improvvisamente inghiottito da un terremoto”. Per Smith, ogni europeo compassionevole ne sarebbe certo rimasto scosso, ma “se dovesse perdere un mignolo, stanotte non dormirebbe; mentre ronferà pacificamente sulla rovina di un centinaio di milioni di fratelli, purché non li abbia mai visti”.
E non si tratta certo solo di distanza effettiva. Per lo stesso principio, notava Diderot, “proviamo compassione per un cavallo che soffre, e schiacciamo una formica senza farci scrupolo alcuno”. In alcune versioni lo sventurato mandarino viene addirittura ucciso a distanza da un francese, con un solo cenno del capo. La domanda è se la distanza attenui la compassione e il senso di responsabilità morale a tal punto da rendere contemplabile anche l’omicidio.
Ginzburg, da storico (e a differenza di tanta filosofia morale), non pare giudicare. Nota piuttosto quanto queste dinamiche siano rilevanti oggi: “Sappiamo che il guadagno di alcuni può provocare, più o meno direttamente, le sofferenze di altri esseri umani lontanissimi, costretti alla miseria, alla denutrizione o addirittura alla morte… il mandarino cinese può essere ucciso semplicemente pigiando un bottone”. Osserva poi che “il progresso burocratico [ha creato] la possibilità di trattare grandi quantità di individui come se fossero puri numeri: un altro modo molto efficace di considerarli a distanza”, come le formiche di Diderot.
Assolviamoci pure per la nostra indifferenza verso chi è diverso e lontano, constatiamo pure, realisticamente, che non può essere altrimenti, che le nostre responsabilità di italiani, di europei non possono estendersi egualmente all’intero globo terraqueo, per quanto interconnesso. Nel mentre, però, è forse il caso di tenere a mente che nel nostro mondo di oscene diseguaglianze i mandarini, o le formiche, non sono solo gli altri – gli immigrati sui barconi, i richiedenti asilo visualizzati per cifre, i poveracci laggiù in Africa o in Afghanistan.
Sempre più spesso mandarini (o formiche) siamo anche noi. Perché la nostra vita non ha davvero nulla in comune con le esistenze dorate di quella micro-élite finanziaria che, complice la politica, decide per tutti noi, senza identificazione, senza compassione. Mandarini sono allora non solo le vittime di Kabul, o i migranti che affogano nel Mediterraneo. Sono anche quei 35 milioni di americani a cui Trump vuole togliere l’assistenza. Mandarini sono i disoccupati italiani senza futuro nascosti nelle tabelle ministeriali. Mandarini sono quei britannici che i tagli targati Tories hanno fatto sprofondare sotto la soglia di povertà. In questo non siamo poi così lontani nell’essere alla mercé di chi, simpatia per noi,davvero non ne prova alcuna.

il manifesto 30 luglio 2017 (c.m.c.)
Sarebbe un errore considerare lo scontro tra Francia e Italia sul controllo dei cantieri navali di Saint-Nazaire solo come una manifestazione della grandeur d’Oltralpe.
Quest’ultima, sia chiaro, è ben presente e rinvigorita dall’energica figura di Macron, che vuole reincarnare i tradizionali miti patriottardi, espansivi e (neo)coloniali da Napoleone Bonaparte a De Gaulle.Senza scordare che anche Mitterand non scherzava quando affermava “La France c’est l’Europe”. La vittima più prossima è spesso l’Italia, al netto della vittoria di Bartali al Tour de France del lontano ’48 (e Paolo Conte ne registrò il sempiterno risentimento francese).
L’Italia: surclassata nella geopolitica, e sul terreno del militarismo, nel Mediterraneo e in Africa. Ultimo esempio, la vicenda libica. Sbeffeggiata sul tema dei migranti, vittime predestinate di ogni litigio tra i potenti. Oggetto di shopping da parte francese in ogni campo, da quello agroalimentare a quello della grande distribuzione commerciale, da quello finanziario – bancario a quello delle telecomunicazioni. Campi strategici per il nostro interesse nazionale inclusi, come si può notare. Non desta quindi sorpresa – casomai necessità di approfondimento critico – se l’iniziativa di una minacciata nazionalizzazione, seppure temporanea, dei cantieri Stx, per bloccare il take over di Fincantieri, da parte di Macron, in spregio agli accordi fatti con Hollande (ma non sarebbe questa la novità), incontri immediatamente il plauso di Force Ouvriere e di Jean Luc Melenchon.
In realtà la vicenda va inquadrata in un contesto più ampio che vede la crisi della globalizzazione, come fin qui l’abbiamo conosciuta, con consistenti segnali di contrazione della medesima , ovvero di deglobalizzazione, sia in campo commerciale – anche in questo modo si spiega la di per sé positiva marcia indietro francese sulla Torino – Lione – sia in quello industriale, come in quello finanziario. Questo non significa che l’impresa capitalistica abbia smesso di espandersi spazialmente. Solo che vengono avanti nuovi protagonisti che cambiano il volto del capitalismo moderno. Come il cosiddetto platform capitalism che esige investimenti fissi enormemente inferiori e sfrutta il lavoro precario o addirittura servile. Su questo movimento di fondo dell’economia, fioriscono – si può dire a destra come a sinistra – varie forme di protezionismo e di nazionalismo. Trump ed epigoni ne sono il prodotto più che la causa.
Le conseguenze in Europa sono ormai evidenti. Proprio i ministri dell’economia di Italia, Francia e Germania avevano chiesto alla Commissione di Bruxelles di rivedere le regole per gli investimenti stranieri nell’Unione, soprattutto per osteggiare l’aggressività della imprenditoria asiatica. L’altro elemento che, determinando uno spostamento del baricentro economico da Ovest ad Est su scala globale, mette in crisi i precedenti presupposti della globalizzazione. Solo che così facendo la Ue ha introiettato il protezionismo. In Spagna l’acquisto di Abertis da parte di Atlantia è messo in forse.
Nella patria dell’ordoliberismo, la Germania, viene varata una legge per limitare le scalate a società e infrastrutture strategiche per evitare che la tecnologia venga catturata dal Dragone cinese.
Mentre si vuole addirittura cambiare la geografia, spostando ad esempio i confini dell’Italia fino a quelli tra Niger e Libia per bloccare i migranti, in Europa si riaprono conflitti antichi attorno agli assetti proprietari e di comando di grandi società. Nel caso in questione di Stx l’incidenza del militare nella partita industriale, complica le cose, ma non ne costituisce la motivazione esclusiva.
Per queste ragioni appare inadeguato un semplice sussulto d’orgoglio italiano, ad esempio contro il controllo francese di Vivendi su Telecom, se non è già troppo tardi. Intendiamoci, meglio di un’inerte sottomissione, visto l’effettivo carattere strategico del settore delle telecomunicazioni.
L’incontro di martedì a Roma con il ministro dell’economia francese e il bilaterale di fine settembre a Lione fra Francia e Italia servirà a poco. Il vero problema è invertire la direzione verso un’Europa a due velocità, impedire che si rafforzi dopo le urne tedesche del 24 settembre e affrontare di petto la questione delle politiche economiche, delle diseguaglianze e dei rapporti ineguali fra i paesi. In sostanza il cambiamento radicale dei Trattati.
 dimentica che chi fugge oggi lo fa perché, per raggiungere il nostro benessere, abbiamo razziato le loro risorse, creando i deserti dove vogliamo respingerli.
dimentica che chi fugge oggi lo fa perché, per raggiungere il nostro benessere, abbiamo razziato le loro risorse, creando i deserti dove vogliamo respingerli.
il manifesto, 29 luglio 2017
«Aiutiamoli a casa loro». E dopo averli "aiutati» per secoli a casa loro, in Africa, schiavizzandoli e depredando le loro risorse, una generazione "ingrata" vuole venire a casa nostra. Deportiamoli, si dice anche a sinistra»
Adesso sono tutti d’accordo, compreso il segretario del Pd che ha sposato in pieno questo slogan che coniò per primo Salvini. Per la verità, la prima volta che ho sentito dire con convinzione «aiutiamoli a casa loro» è stato nel giugno del 2001.
Durante una conversazione con il presidente del Parco delle Cinque Terre, allora attivista del Pds e poi europarlamentare. Un presidente di Parco molto capace che ha trovato un modo intelligente per recuperare i vigneti ed i terrazzamenti nelle stupende colline delle Cinque Terre, cercando di promuovere un turismo sostenibile in un ambiente molto fragile.
Un uomo innamorato della sua terra e convinto oppositore della globalizzazione capitalistica. Ad un certo punto della discussione venne fuori la questione dell’immigrazione e lui mi raccontò di cinque albanesi che avevano accolto con entusiasmo alle Cinque Terre ed erano stati ricambiati con furti e violenze varie. Da qui la sua profonda avversione al fenomeno migratorio e il suo profondo convincimento: «Aiutiamoli a casa loro».
Poco tempo fa mentre attraversavo lo Stretto ho incontrato un amico magistrato, un democratico convinto e conseguente, cattolico socialmente impegnato, da sempre persona sensibile ai temi sociali.
Mentre l’aliscafo saltellava sulle onde, in una giornata da montagne russe, sono sbalzato via dalla poltrona, non per il mal di mare ma quando gli ho sentito dire: «Aiutiamoli a casa loro…qui non possiamo continuare ad accoglierli…anzi dovremmo far star male quelli che ci sono in modo tale che quando telefonano a casa sconsiglino altri a partire…» .
Me lo diceva con sofferenza, vera, con rammarico ma anche con la convinzione che se non vogliamo far vincere Salvini dobbiamo porre un argine a questi flussi migratori. Se li lasciamo a bighellonare tutto il giorno, ospiti di buoni alberghi- sosteneva- questi giovanissimi africani che hanno tutti un telefonino manderanno a casa delle belle immagini e il flusso diventerà una valanga e saremo sommersi.
Come ha lucidamente ribadito ribadito Guido Viale su questo giornale con 180mila profughi o 200mila non si dovrebbe parlare di invasione in un paese con 60 milioni di abitanti.
Cosa avrebbe dovuto dire il popolo libanese quando sono arrivati un milione e mezzo di siriani in un paese di cinque milioni di abitanti? Inoltre, e spesso lo dimentichiamo, abbiamo un saldo demografico negativo di circa 50mila unità l’anno e un saldo migratorio nazionale negativo per oltre 100 mila unità (soprattutto dovuto a giovani italiani studenti e laureati che emigrano in vari paesi del mondo).
Inoltre, negli ultimi anni per via della crisi economica del nostro paese gli stranieri che ritornano nel loro paese sono superiori a quelli che arrivano, in particolare gli albanesi, i marocchini, rumeni, filippini, ecc.
Quindi non c’è nessuna esplosione demografica e non c’è nessun pericolo di invasione se gli immigrati sono ancora oggi l’8,5% della popolazione a fronte di percentuali ben maggiori in diversi paesi europei, dall’Austria all’Irlanda per non parlare della Svizzera.
Malgrado queste evidenze statistiche è entrato nella pelle italica questo virus dell’invasione che porta ogni giorno persone insospettabili a chiedere di respingere i barconi e magari affondarli. Uno degli ultimi casi riguarda un noto intellettuale siciliano, Antonio Presti, l’ideatore di «Fiumara d’arte» famosa a livello internazionale, organizzatore di eventi artistici di assoluto rilievo.
Ebbene proprio lui, in una conferenza stampa che annunciava a Taormina il progetto di riqualificazione del Villaggio Le Rocce di Mazzarò, ad un certo punto denuncia l’arrivo nel paese di una trentina di migranti dicendo testualmente : «Meno italiani più immigrati, è iniziata la sostituzione di popolo»». Ed aggiungendo che «« non è razzismo, ci opponiamo all’invasione di altre culture e alla perdita della nostra identità».
Ho voluto citare questi casi concreti di intellettuali, di persone che hanno operato bene in diversi campi, non di operai disoccupati che temono la concorrenza di chi è costretto a lavorare a salari da fame – come avviene nell’edilizia e in agricoltura – né di persone ideologicamente di destra.
Ho voluto citarli perché dovremmo prendere atto che viviamo in un paese che sta diventando profondamente razzista nella sua stragrande maggioranza. A differenza degli anni ’30 del secolo scorso, oggi nessuno si dichiara apertamente razzista, o parla di razze superiori, ma di diritto a difendersi da una invasione distruttiva, sia sul piano culturale che su quello economico (i soldi ai migranti anziché ai nostri poveri!!).
E sono tutti convinti che «non possiamo accoglierli tutti» e quindi dobbiamo fermarli con ogni mezzo. E, siccome siamo buoni, l’unica cosa che possiamo fare è di «aiutarli a casa loro»». Come? Semplice: con lo sviluppo economico. Se i popoli dell’Africa subsahariana si svilupperanno come abbiamo fatto noi si fermerà l’emigrazione.
Peccato che abbiamo dimenticato o non vogliamo fare i conti con la storia. Le prime grandi ondate migratorie dall’Europa verso altri continenti sono iniziate nei paesi in cui avveniva la rivoluzione industriale, a cominciare dall’Inghilterra, ovvero iniziava quello che chiamiamo sviluppo economico capitalista.
Anche in Italia, nell’ultimo quarto del XIX secolo, le prime ondate migratorie hanno interessato il Piemonte, la Liguria e la Lombardia, cioè le regioni dove è nata la prima rivoluzione industriale italiana. Prima che lo sviluppo economico porti ad un blocco dell’emigrazione possono passare decenni o secoli, come dimostra, tra l’altro il caso emblematico del nostro Mezzogiorno.
E noi italiani che non siamo riusciti in centocinquanta anni a risolvere la questione meridionale, che abbiamo milioni di giovani meridionali precari e/o disoccupati malgrado le politiche di sviluppo adottate nel corso di decenni, gli investimenti a valanga, i poli di sviluppo industriale, il sostegno alle start-up, vorremmo risolvere la «questione africana» esportando il nostro modello di sviluppo?!
E quale aiuto a casa loro vorremmo portare dopo che abbiamo tagliato le poche risorse che c’erano per la cooperazione popolare, quelle delle ong, che in qualche caso aveva dato buoni frutti quando non era caduta nella logica dell’economicismo o dello sviluppismo esasperato.
La cooperazione per garantire un minimo di welfare come scuole, sanità, case, questo sì che serve. Ma, se volessimo veramente «aiutarli a casa loro» ci sarebbe un mezzo immediato: un reddito minimo vitale per tutte le famiglie povere africane.
Si potrebbe cominciare dai paesi dove in questo momento partono il maggior numero di migranti come la Nigeria, Niger, Etiopia, Eritrea, ecc. Ipotizziamo che si riuscisse a dare a tutti i giovani tra i 16 ed i 32 anni un minimo vitale di 200 euro al mese, che mediamente in Africa consentono ad una famiglia di sopravvivere. E ipotizziamo sempre che un primo bacino di utenza sia di circa 100 milioni di giovani.
Il costo mensile sarebbe di 20 miliardi di euro al mese, un terzo di quello che Draghi ha elargito mensilmente al sistema creditizio europeo oberato da titoli spazzatura e crediti inesigibili. Immaginiamo che a Bruxelles passi una decisione del genere, quale sarebbe la reazione? Scandalo! Aiutiamo i giovani africani mentre i nostri sono precari, disoccupati e impoveriti? Morale della favola: quando diciamo «aiutiamoli a casa loro» vogliamo dire ben altro.
Basa un breve excursus storico per rendercene conto. Sono secoli che come europei ««aiutiamo a casa loro»» i popoli africani , latino-americani ed asiatici. Soprattutto gli africani sono stati oggetto delle nostre attenzioni, premure, affetto. Prima di tutto portandogli la civiltà e facendoli uscire da una condizione di uomini semiselvaggi, animisti e antropofagi, trasportandoli a nostre spese nel mondo civile (quello che i comunisti un tempo chiamavano «tratta degli schiavi»).
Poi con l’installazione delle nostre tecniche agricole, delle monoculture più moderne che hanno prodotto un notevole flusso di esportazioni, nonché la valorizzazione delle loro miniere che erano state ignorate per secoli come fonte di ricchezza. Ed ancora gli abbiamo insegnato l’uso delle moderne tecniche militari, li abbiamo fatti passare dall’arco e le lance ai carri armati e agli aerei, li abbiamo aiutati a combattersi nel modo più moderno ed avanzato possibile offrendogli consiglieri militari e le armi più sofisticate.
Infine gli abbiamo insegnato l’uso del denaro e come sia facile prenderlo in prestito e poi doverlo restituire con buoni tassi di interesse, ovvero quella che è la nostra libertà più grande e bella: la libertà di indebitarsi fino al collo.
E dopo aver operato per secoli a casa loro, per il loro benessere, adesso questa generazione ingrata vuole venire a casa nostra con tutti i problemi che già abbiamo… Non è possibile…riportiamoli a casa loro , anzi deportiamoli.

«e»
. Internazionale online, 29
Come si misura la malvagità umana? A volte è fin troppo facile. Quest’estate le città britanniche devono fare i conti con le conseguenze di diversi attentati terroristici ed episodi di razzismo. L’attentato di Manchester. Gli omicidi sul ponte di Westminster. L’orrore del London Bridge. L’attentato contro le persone che si trovavano fuori dalla moschea di Finsbury Park nella parte nord di Londra e in altre moschee. O gli uomini non identificati che sono ancora a piede libero nella capitale dopo aver spruzzato acido sui visi dei passanti, sfigurandoli.
Nel Regno Unito la resilienza che mostriamo di fronte a questi episodi è encomiabile. Tornando a Londra dopo aver passato un po’ di tempo fuori, mi sono sentita rinfrancata da un numero del magazine del London Evening Standard che celebrava le persone comuni che si erano fatte avanti per dare il loro aiuto dopo queste atrocità. I paramedici che hanno lavorato per tutta la notte. Il cuoco romeno che ha nascosto le persone nella sua panetteria. Il tifoso di calcio che si è scagliato sui terroristi del London Bridge urlando: “Fottetevi, forza Milwall!”. Lo studente che ha ospitato il coordinatore che organizzava l’assistenza alle vittime dell’inferno scatenatosi alla Grenfell Tower e alle loro famiglie.
Fermi tutti. Aspettate un secondo. Uno di questi episodi non è uguali agli altri. Il disastro della Grenfell Tower, nel quale sono morte almeno ottanta persone, non è stato un attacco terroristico o un atto doloso. È semmai il risultato di anni di decisioni sciagurate prese dagli amministratori di condominio e di investimenti inesistenti per le case popolari.
Il 14 giugno intere famiglie sono bruciate vive nelle loro case, in parte perché, a quanto pare, il Royal Borough of Kensington and Chelsea non ha voluto pagare le cinquemila sterline necessarie per i rivestimenti antincendio. Né è stato in grado di trovare i soldi, nonostante il bilancio positivo, per installare un efficace sistema di valvole antincendio all’interno di un edificio che stava andando in malora.
Kensington and Chelsea è un municipio governato dai conservatori che, per quanto riguarda il denaro investito, s’interessa poco o nulla ai cittadini più poveri che difficilmente voteranno per loro. Nel 2014, mentre ai residenti della Grenfell Tower erano negate semplici operazioni di manutenzione, gli amministratori hanno concesso delle riduzioni di cento sterline ai contribuenti più ricchi, sbandierando i risultati ottenuti nel “garantire costantemente una maggiore efficienza migliorando i servizi”. Questa efficienza aveva dei nomi, dei genitori e dei figli.
Si tratta di una stortura morale assoluta. Una stortura che nega le proprie responsabilità, fino a quando questa negazione finisce per prendere fuoco. Prendendo a prestito un’espressione di Friedrich Engels, John McDonnell ha descritto il disastro della Grenfell Tower come un “omicidio sociale”. Il cancelliere ombra ed ex voce critica della sinistra parlamentare non è mai stato famoso per la cautela delle sue dichiarazioni.
Naturalmente la stampa conservatrice ha fatto a gara per condannare McDonell, non perché avesse torto ma per la sua mancanza di discrezione. “In questo paese c’è una lunga tradizione di omicidi sociali”, ha detto, “nei quali le decisioni vengono prese senza curarsi delle conseguenze… E per questo motivo molte persone hanno sofferto”.
“È difficile negare la realtà di queste sofferenze quando non è ancora stato concluso il conto dei morti in questo cimitero a forma di torre che appare oggi come una ferita nello skyline londinese”. Come ha scritto la filosofa Hannah Arendt, “la triste verità è che le azioni peggiori sono commesse da persone che non si decidono mai a essere buone o cattive”.
L’austerità di mercato non è meno brutale per il fatto che non produce vittime. Si tratta di un’ideologia calcolatrice, che misura il valore umano in denaro ed effettua tagli che colpiscono, anche se indirettamente, la vita delle persone. Redistribuire grandi somme di denaro dai poveri ai ricchi non è solo un’infrazione morale astratta: è qualcosa che uccide. Accorcia vite umane e ne peggiora milioni di altre.
Solitamente lo fa in una maniera mostruosamente flemmatica: il pensionato che muore prima per una malattia curabile, gli adolescenti che smettono di studiare, i disabili che vengono abbandonati mentre soffrono per le loro malattie fisiche e mentali senza avere qualcuno che si occupi di loro, le migliaia di persone morte mentre erano nelle liste d’attesa di sussidi che avevano pieno diritto di ricevere, i genitori il cui orgoglio va in frantumi nel vedere i loro bambini andare a scuola affamati.
Noi cittadini non siamo spinti a misurare il costo umano dell’austerità in questo modo, anche se esistono molte persone in oscuri uffici che fanno esattamente questo genere di calcoli. Quest’anno, quando i ricercatori del Journal of the Royal Society of Medicine hanno affermato che i costanti tagli al servizio sanitario potrebbero essere all’origine di quasi trentamila “morti supplementari” in Inghilterra e in Galles nel 2015, il governo ha denunciato un “trionfo dei pregiudizi personali sulla ricerca”. Comunque la si voglia vedere, si tratta di una risposta odiosa e arrogante di fronte a trentamila nuove morti.
La malvagità del mercato
Esiste un tipo di malvagità per cui un individuo permette agli angoli più oscuri della sua mente di fargli conficcare una lama nel ventre di un passante o di mettere una bomba in mezzo a una folla di ragazze adolescenti. Questa forma di mostruosità è tanto facilmente individuabile quanto fortunatamente rara, anche se meno rara di quanto fosse in periodi meno febbrili di quello attuale.
Ma esiste un’altra forma di malvagità di cui raramente parla la stampa. È quella che emerge quando qualcuno si siede con una calcolatrice in mano e calcola quanto costerebbe proteggere e nutrire la vita umana, deduce questa cifra dal costo di una riduzione fiscale per dei proprietari immobiliari o di una bella serata all’opera, e poi stabilisce una cifra. È una forma di malvagità ordinaria, diventata ormai di routine e automatizzata negli anni dell’austerità. È una forma di malvagità che, secondo le parole dello scrittore Terry Pratchett, “comincia quando cominci a trattare le persone come cose”.
Il disastro della Grenfell Tower è l’infernale prova delle conseguenza di questa spietatezza fiscale, che nessuno può ignorare. Chi dice che la cosa non era prevedibile è stato smentito dalle vittime.
L’associazione dei residenti aveva scritto sul proprio sito web, dopo aver implorato per anni i direttori di condominio di migliorare le loro condizioni di vita: “È un pensiero davvero terrificante ma il Grenfell Action Group crede fermamente che solo un evento catastrofico sia in grado di mostrare pubblicamente l’inettitudine e l’incompetenza dei nostri padroni di casa”.
Questo catastrofico evento è arrivato. La consueta risposta dei britannici alla tragedia, una dignità coraggiosa e composta, è stavolta inappropriata. Quando cominceranno le indagini sulla Grenfell Tower, ad agosto, è importante che ogni cittadino esiga delle risposte e che chiami questa farsa con il suo nome: omicidio organizzato.
(Traduzione di Federico Ferrone)
Questo articolo è apparso sulla rivista britannica New Statesman.
 C'è poco da meravigliarsi. Con la vittoria nel neoliberismo i pilastri della difesa del lavoro sono stati sgretolati. Gli anziani li ricordano: potere dei lavoratori, lotta, contrattazione, solidarietà. Chi pagherà saranno i giovani, se non comprenderanno e si ribelleranno.
C'è poco da meravigliarsi. Con la vittoria nel neoliberismo i pilastri della difesa del lavoro sono stati sgretolati. Gli anziani li ricordano: potere dei lavoratori, lotta, contrattazione, solidarietà. Chi pagherà saranno i giovani, se non comprenderanno e si ribelleranno.
Micromega online, 24 luglio 2017
Due proposte di legge
La Commissione Affari costituzionali della Camera ha da poco iniziato l’esame di due proposte di modifica dell’articolo 38 della Costituzione, nella parte in cui menziona il diritto alla pensione e precisa che alla sua attuazione “provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”. Con la prima proposta, sottoscritta da parlamentari di maggioranza e opposizione, dal Pd ai Fratelli d’Italia, si vuole puntualizzare che il diritto alla pensione si attua “secondo principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione tra le generazioni”1. La seconda proposta è stata presentata da deputati del Pd e ha un contenuto simile: vuole precisare che “il sistema previdenziale è improntato ad assicurare l’adeguatezza dei trattamenti, la solidarietà e l’equità tra le generazioni nonché la sostenibilità finanziaria”2.
Molti hanno accolto con entusiasmo il richiamo alla solidarietà tra generazioni, considerato una novità positiva per i pensionati di domani. Proprio su questo aspetto deve avere insistito una velina a cui evidentemente si deve un titolo molto gettonato dalle testate, che hanno sbrigativamente parlato di “norma salva-giovani”. Sono però mancate analisi più approfondite su una vicenda di notevole portata e impatto, tutto sommato passata sotto silenzio.
Basta però leggere le relazioni introduttive alle proposte di modifica della Costituzione per rendersi conto della loro portata eversiva: l’obiettivo è la “rimodulazione della spesa pensionistica nella direzione di una maggiore sostenibilità”, ovvero, tanto per incominciare, il taglio delle pensioni di oggi, estorto con la promessa di una garanzia delle pensioni di domani (evidentemente contenute per rendere possibili quelle di dopodomani).
A irritare sono le motivazioni per cui occorrerebbe rimodulare la spesa pensionistica, che pure muovono da una premessa incontestabile, seguita però da conclusioni surreali. Si dice infatti che “non si può considerare equo un Paese nel quale il sistema pensionistico discrimina fra pensionati di generazioni diverse”3, ma questo non porta a immaginare politiche tese a incidere positivamente sulle pensioni future: politiche per il lavoro di qualità, che contrastino la precarietà e l’abbattimento dei salari, unite a un piano di investimenti per affrontare la piaga della disoccupazione giovanile. Tutto il contrario: non si mettono in discussione la cancellazione dei diritti dei lavoratori e l’austerità, che anzi una retorica truffaldina presenta, contro ogni evidenza, come il presupposto per una ripresa economica e dell’occupazione. Si giunge così alla conclusione che, se non si vuole discriminare tra chi ha di più e chi avrà di meno, non resta che lasciare le cose come stanno per chi ha di meno, e nel contempo togliere a chi ha di più.
E si badi che non si tratta qui di colpire i cosiddetti pensionati d’oro, ma semplicemente chi ha ottenuto il dovuto con sistemi di calcolo che i fautori della riforma costituzionale reputano ora “abbastanza generosi”4. Sistemi che da molti anni a questa parte hanno però consentito la sopravvivenza a tanti giovani e meno giovani, che sono stati costretti a ricorrere alle pensioni dei genitori per far fronte alla disoccupazione, a salari da fame, e soprattutto a uno Stato sociale oramai in disarmo.
Analisi economica del diritto costituzionale
Le proposte di riforma appena viste vanno lette in un tutt’uno con altre riforme o proposte di riforma che si sono succedute nel tempo e che hanno inteso mutare profondamente i caratteri della Costituzione.
Quest’ultima si fonda sull’idea che l’uguaglianza deve essere promossa contro il funzionamento del mercato: solo se controllata e indirizzata dai pubblici poteri l’iniziativa economica privata persegue “fini sociali” (art. 41), mentre se viene lasciata libera si trasforma in uno strumento di sopraffazione e sfruttamento. Tutto l’opposto di quanto sostiene l’ortodossia neoliberale, ovvero che l’iniziativa privata persegue fini sociali in quanto viene lasciata libera, se i pubblici poteri rinunciano a indirizzarla. Come si sa è in quest’ultimo senso che spinge l’Unione europea, che chiede ai Paesi membri di disciplinare i mercati non per contrastarli, ma per assecondarli: per assicurare il funzionamento della concorrenza, ovvero per tradurre le leggi del mercato in leggi dello Stato. Con il risultato che l’inclusione sociale viene ridotta a inclusione nel mercato, ritenuto lo strumento più adatto a redistribuire risorse, molto più della regolamentazione pubblica, fonte di inefficienza.
Queste convinzioni, un punto fermo dell’ortodossia neoliberale, si devono in particolare alla teoria della scelta pubblica, per cui la politica, prima ancora della democrazia, è fonte di corruzione e deve pertanto ritirarsi dall’arena economica. Non è un caso se proprio in tale ambito si è elabora l’analisi economica del diritto costituzionale (constitutional economics), una disciplina complessivamente tesa a rendere resistenti le regole destinate a riservare ai pubblici poteri il ruolo di meri custodi del principio di concorrenza. Il che avviene nel momento in cui si conferisce rango costituzionale a quelle regole, ovvero se si inseriscono nelle Carte fondamentali disposizioni ricavate dal principio per cui lo Stato deve assecondare il mercato5. Magari, per quanto riguarda il tema delle pensioni, limitando la spesa pubblica per favorire così la privatizzazione del sistema, affermando oltretutto che lo si fa per i giovani.
Non stupisce allora se, tra le proposte elaborate dai cultori di questa disciplina, spicca l’inserimento a livello costituzionale del principio del pareggio di bilancio, o sue varianti, che in area europea è stato sponsorizzato dal noto Fiscal compact, e in Italia realizzato con la riforma dell’art. 81 della Carta fondamentale: dove si dice ora che “lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio”. Il che equivale a mettere fuori legge i tentativi di tenere insieme crescita economica e piena occupazione, l’unica vera ricetta “salva-giovani”, e più in generale rovesciare il principio fondativo della cultura costituzionale italiana: quello per cui l’economia viene sottomessa alla politica, e quindi il mercato viene subordinato alla partecipazione democratica.
Solidarietà tra generazioni, neoliberalismo e beni comuni
Per molti aspetti l’inserimento in Costituzione del principio dell’equilibrio di bilancio ha già determinato un forte snaturamento della Carta fondamentale, mettendo oltretutto in luce come non vi sia un significativo scarto politico tra l’equilibrio e il pareggio di bilancio. È quanto si ricava da alcune sentenze della Corte costituzionale che si sono misurate con il principio, e hanno nel contempo affrontato il tema della solidarietà tra le generazione.
In particolare una decisione ha salvato alcune previsioni contenute in una legge attuativa “del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81 della Costituzione” (si badi pareggio e non equilibrio)6, affermando che il principio vincola i cittadini meno giovani, chiamati a sacrificarsi per i cittadini più giovani: “sostenibilità del debito pubblico implica una responsabilità” che “non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future”7. In un’altra decisone, che ha salvato i limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione concepiti come misure di austerità, il fine del ricambio generazionale viene invocato come movente per gli sforzi volti a perseguire l’equilibrio di bilancio8. Più recentemente si sono precisati i fondamenti per la “mutualità intergenerazionale” in materia pensionistica, e si è tra l’altro menzionata la disposizione costituzionale in cui si chiede di adempiere ai “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2)9.
A ben vedere non tutte le decisioni della Corte ricalcano questo schema, ovvero utilizzano la solidarietà tra generazioni come espediente buono a promuovere l’osservanza dell’ortodossia neoliberale imposta da Bruxelles: per giustificare, nel nome di una parità di trattamento incentrata su un minimo comun denominatore, la compressione certa di diritti alle generazioni presenti a beneficio ipotetico delle generazioni future. Una decisione ha ad esempio dichiarato l’incostituzionalità del blocco della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore ai 1200 Euro, deciso come misura di austerità in linea con le richieste europee. Il blocco contrasta infatti con il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia (art. 38 Cost.) e, posto che la pensione costituisce una retribuzione differita, con il diritto a una retribuzione sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.)10. Più recentemente, a proposito del diritto all’educazione e all’avviamento professionale dei disabili, diritto menzionato nella medesima disposizione in cui si parla di diritto alla pensione, si è affermato che il bilancio deve piegarsi ai diritti e non viceversa: “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”11.
Ciò detto, la solidarietà tra generazioni non costituisce necessariamente un principio tipico dell’ortodossia neoliberale. Questa non ne ha la paternità: se ne è appropriata snaturando la valenza riconosciuta al principio nei contesti in cui ha una tradizione più nobile.
In particolare la cultura dei beni comuni si fonda esattamente su questa forma di solidarietà, in nome della quale si definiscono i limiti allo sfruttamento del bene: questo deve essere utilizzato in modo tale che siano conservate intatte tutte le sue funzioni. È ad esempio la possibilità per le generazioni future di fruire di un ambiente salubre a indicare per il tempo presente i limiti allo sfruttamento ambientale. Giacché è il suo valore d’uso che occorre conservare, e anzi proteggere da chi vede solo il suo valore di scambio: da chi esclude per appropriarsi del bene, per tutelare invece chi esclude per favorire i libero accesso al bene.
Competizione fiscale
I progetti di riforma della disciplina costituzionale del diritto alla pensione non hanno evidentemente nulla che vedere con tutto questo. Il fine ultimo non è tanto la sostenibilità del diritto in un contesto di risorse complessivamente calanti, bensì in una situazione nella quale si sceglie deliberatamente di diminuire la spesa sociale in omaggio a un progetto politico ben preciso. Il progetto neoliberale, che vuole affossare i diritti sociali sul presupposto che occorra riconoscerli solo se vi è sostenibilità finanziaria. Come se solo i diritti sociali avessero un costo, e non lo avessero invece le libertà indispensabili a far funzionare il mercato concorrenziale: idea tanto diffusa quanto infondata, dal momento che quelle libertà presuppongo quantomeno l’esistenza di un oneroso apparato di pubblica sicurezza e un sistema di tribunali altrettanto oneroso.
Non solo. Tra le libertà valorizzate dall’ortodossia neoliberale svetta quella relativa alla circolazione dei capitali, che costringe gli Stati a ingaggiare una drammatica competizione per attrarre o trattenere il maggior numero di investitori. Se i capitali circolano liberamente gli Stati sono cioè portati a comprimere i salari e i diritti dei lavoratori, e ovviamente ad abbattere la pressione fiscale sulle imprese: come da ultimo con la riduzione dell’aliquota proporzionale Ires dal 27,5% al 24% realizzata dalla legge di stabilità 201612. Il tutto alla base di una spirale perversa: la diminuzione del gettito fiscale, sempre crescente per effetto della competizione tra Stati, impone di limitare la spesa sociale, che avrebbe però bisogno di crescere anch’essa a causa della compressione dei salari e dei diritti dei lavoratori. Di qui una serie di scelte obbligate come, per tornare al nostro tema, la diminuzione della spesa pensionistica, che come si vede costituisce il frutto di scelte politiche e non un accidente determinato da fattori naturali: come vogliono far credere coloro i quali si concentrano sul prolungamento della vita media (peraltro ora insidiato dalla diffusione della povertà).
È però questo il ruolo che l’ortodossia neoliberale affida allo Stato. Non tanto di arretrare per lasciare spazio ai mercati, ma di attivarsi per sostenere i mercati, per prevenire il loro fallimento e soprattutto per socializzare le perdite che ne derivano. Se del caso sacrificando la democrazia e persino la politica, per sterilizzare così il conflitto sociale e renderlo incapace di condizionare l’ordine costituito. Anche questa è una finalità riconducibile alla proposta di costituzionalizzare la solidarietà tra generazioni come limite al diritto alla pensione, che se approvata infliggerebbe il colpo di grazia a quella che da tempo non è più “la Costituzione più bella del mondo”.
NOTE
1 Proposta di legge costituzionale n. 3478 Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità intergenerazionale nei trattamenti previdenziali e assistenziali.
2 Proposta di legge costituzionale n. 3858 Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità e la sostenibilità dei trattamenti previdenziali.
3 Proposta di legge costituzionale n. 3478, www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050960.pdf.
4 Relazione alla proposta di legge costituzionale n. 3858, www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0048830.pdf.
5 Cfr. J.M. Buchanam, Constitutional Economics, in J. Eatwell, M. Milgate e P. Newman (a cura di), The World of Economics, London e Basingstoke, Macmillan Press Limited, 1991, p. 134 ss.
6 Legge 24 dicembre 2012 n. 243.
7 Sentenza 10 aprile 2014 n. 88
8 Sentenza 28 marzo 2014 n. 60.
9 Sentenza 13 luglio 2016 n. 173.
10 Sentenza 10 marzo 2015 n. 70.
11 Sentenza 16 dicembre 2016 n. 275.
12 Art. 1 comma 61 Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).

Italia e Francia in rissa concorrenziale per vincere il primato di chi è più dtupido nel comprendere che cos'è l'Esodo del XXI secolo. il manifesto, 29 luglio 2017 (p.d.)
Quello che succede tra Francia e Italia è un groviglio grottesco di velleità geopolitiche, interventismo militare da due soldi, rivalità industriali e diplomatiche. Ma tutto questo contro le azioni umanitarie delle Ong e sulla pelle di migliaia di esseri umani, i migranti che si imbarcano in Libia alla volta dell’Europa. Ma andiamo con ordine.
La nazionalizzazione dei cantieri di Saint Nazaire, da cui escono navi da crociera e militari, è solo un aspetto della politica francese di piccola grandeur nel Mediterraneo e in Africa. La Francia, che nel 2011 aveva lanciato la demenziale guerra in Libia, che ha portato al caos attuale, non poteva tollerare che Fincantieri mettesse le mani su un settore strategico così importante. Alla stessa logica appartiene l’incontro di “pacificazione” promosso da Macron tra Serraj e Haftar, un colloquio che, come ha notato Angelo Del Boca intervistato da Tommaso Di Francesco sul manifesto di giovedì, non cambia nulla dal punto di vista del conflitto di potere in Libia, ma è un affronto evidente all’Italia e alla sua pretesa di rappresentare gli interessi d’Europa nel tratto di mare delicatissimo tra Sicilia e Africa.
Ma sottolineare una volta di più il nazionalismo francese non significa assolvere quello italiano, con la semplice differenza che l’apparato militare gestito dal ministro Pinotti non è paragonabile a quello francese, che già opera in Niger, Ciad e altre zone dell’Africa sub-sahariana. La proposta, da parte di Gentiloni, di inviare le nostre navi nelle acque della Libia contro i «trafficanti», ha il significato di una risposta alla Francia, sia per la questione Fincantieri, sia per il ruolo che Macron vorrebbe in Libia. Come dire: «Macron, stai attento, ci siamo anche noi!». La mossa italiana si situa nel solco delle iniziative di Minniti per far gestire ai libici il controllo dei migranti. E come quelle, creerà solo nuova confusione e sofferenze. Insomma, ruggiti di un topo.
La verità è che la Libia è in mano ai signori della guerra, che Serraj conta sempre meno e che Haftar, il suo rivale in Cirenaica, sostenuto dai francesi (nonché da egiziani e russi) è sempre più potente. Di conseguenza, giorno dopo giorno, si scopre che l’Italia ha puntato sui cavalli perdenti, soprattutto per quanto riguarda il controllo delle risorse petrolifere. La debolezza strategica si somma in questo caso all’incapacità politica (tra l’altro, che fine ha fatto in tutto questo il ministro Alfano?).
La smentita-conferma di Serraj - che, tornato a Tripoli ha prima negato di aver richiesto l’intervento italiano per poi confermare ma precisando che avrà solo una funzione di «supporto» - getta una coltre di ridicolo sull’intera vicenda. È possibile che Serraj si sia accorto che Macron è un po’ più potente di Gentiloni e ora ci abbia ripensato. O magari che tema di sbilanciarsi troppo dalla parte dell’Italia. E comunque di rivelarsi alle fazioni libiche come troppo subalterno all’occidente. Ma, in ogni caso, la faccenda delle navi italiane è un segnale gravissimo per le Ong, a cui si vuole già imporre un insensato codice di comportamento. Se la storia della guerra ai «trafficanti» si tramutasse in un blocco di gommoni e carrette del mare, i costi umani sarebbero enormi. Non solo perché le navi delle Ong sarebbero spinte a diradare o annullare gli interventi, ma perché i migranti sopravvissuti a possibili naufragi sarebbero ricacciati nell’inferno libico.
Ecco un altro risultato dell’ottusità europea e del ruolo delle destre nel condizionare le politiche migratorie. I migranti continueranno ad arrivare in Libia. Ma troveranno un mare pullulante di navi militari pronte a respingerli. Un lavoro sporco che l’Italia, potenza di terz’ordine, vuole svolgere per un’Europa, Francia compresa, incapace di affrontare la questione delle migrazioni. In questi giochi di guerra e di petrolio tutti hanno qualcosa da guadagnare, tranne l’umanità.
 «L' Unione ancora più indebolita, sciolta in una sorta di Europa “liquida” in cui ognuno pensa al vantaggio individuale. Preoccupati solo di curare il proprio giardino nell’incapacità di amministrare l’intero parco».
«L' Unione ancora più indebolita, sciolta in una sorta di Europa “liquida” in cui ognuno pensa al vantaggio individuale. Preoccupati solo di curare il proprio giardino nell’incapacità di amministrare l’intero parco».
la Repubblica, 28 luglio 2017 (c.m.c.)
Ci sono due parole che descrivono bene la crisi che sta vivendo l’Unione europea: interesse nazionale. Lo scontro tra Francia e Italia sull’acquisizione di Stx da parte di Fincantieri ha rispolverato un concetto che negli ultimi quindici anni era stato emarginato. O almeno la classe dirigente del Vecchio continente aveva iniziato a utilizzare con pudore, se non con un vero e proprio senso di vergogna.
Ecco, quel muro, anche solo psicologico, è stato abbattuto. E le macerie si riverseranno su un futuro che rischia di essere ben più appannato del presente che stiamo vivendo. Con un’Unione ancora più indebolita, sciolta in una sorta di Europa “liquida” in cui ognuno pensa al vantaggio individuale. Preoccupati solo di curare il proprio giardino nell’incapacità di amministrare l’intero parco.
Il presidente francese Macron ha vinto le elezioni presentandosi anche come il “campione” di un nuovo europeismo. Ha marcato la campagna elettorale affrontando a viso aperto il populismo di Le Pen. Ha persino organizzato la sua cerimonia di insediamento facendo suonare l’Inno alla Gioia di Beethoven, ossia l’inno ufficiale della Ue.
Eppure molti degli atti concreti realizzati in questi mesi costituiscono una vera e propria inversione di tendenza. Del resto si tratta di una retromarcia che non è stata innestata solo da Parigi. È ormai chiaro che l’interesse nazionale sta prevalendo in quasi tutta Europa. Se l’Eliseo annuncia la nazionalizzazione dei cantieri Stx con il ministro dell’Economia Le Maire che dichiara pubblicamente « difendiamo i nostri interessi», in Spagna le procedure di acquisto di Abertis da parte di Atlantia sono costellate da una serie di ostacoli e condizioni che fanno perno proprio su una sorta di neoprotezionismo. Tutto a dispetto dei principi comunitari che consentono di vietare le acquisizioni straniere solo in caso di minaccia per «la sicurezza pubblica o l’ordine pubblico». E certo non sembrano i casi trattati in questi giorni.
Il punto, ormai, è che si sta mettendo sullo stesso piano la difesa della specificità europea e quella dei singoli partner dell’Ue. All’inizio dell’anno i ministri dell’Economia di Italia, Francia e Germania avevano chiesto alla Commissione di Bruxelles di rivedere le regole per gli investimenti stranieri nell’Unione. Un tentativo di difendersi soprattutto dall’aggressività imprenditoriale asiatica. Un modo per tutelare il nostro know how. E per porre il tema della reciprocità a paesi che concepiscono il capitalismo solo senza regole. Ma quella preoccupazione adesso si sta trasformando in una malattia endogena capace di infettare le radici dell’Unione europea. Soprattutto di minare alla base gli ideali sui quali è stata edificata l’Ue. Non è infatti un caso che la sfida intrapresa da questo egoismo nazionalista 2.0 non si concentri solo sulle partite industriali e finanziarie. Ormai si sta trasferendo anche sui grandi temi che assillano tutti i paesi. Basti pensare all’enorme questione dei migranti.
La soluzione adottata nell’ultimo anno è stata sostanzialmente solo quella di sigillare i confini a nord di Italia a Grecia. Senza alcuna effettiva cooperazione. Come se una volta chiuse le frontiere, il problema potesse essere risolto solo da uno o da un paio di Paesi direttamente toccati dall’ondata migratoria. Chiudendo così gli occhi e facendo finta di non vedere. Riservandosi magari la possibilità di intervenire unilateralmente nel caso in cui si offrisse l’occasione di mettere la mano su qualche interesse economico come può essere il petrolio libico.
È lo stesso spirito e lo stesso sentimento che ha portato la Gran Bretagna a votare a favore della Brexit. Sono due facce della stessa medaglia. Che, però, può rapidamente rivelarsi una patacca. Il prezzo di queste scelte, infatti, le paga solo la costruzione dell’Ue. L’Unione ha già segnato il passo sul completamento del suo percorso. Non esiste una politica di difesa comune, non esiste un fisco comune, non si condividono i rischi né le opportunità. Resta solo la moneta unica. Ma è ormai evidente che un’Europa solo monetaria non è più sufficiente.
La rincorsa verso gli slogan del populismo demagogico che ancora vengono urlati nel Vecchio Continente può sortire un solo effetto: assestare un ulteriore colpo a un’Europa già malata. Macron probabilmente volge lo sguardo al passato quando pensa alla “grandeur” francese. Picasso diceva: « Dipingo ciò che penso, non ciò che vedo». Era però un artista. Chi ha responsabilità istituzionali deve essere consapevole della realtà. E anche Parigi è troppo piccola per affrontare in solitudine le sfide globali. Il leader francese non può nemmeno pensare, come diceva De Gaulle, che « l’intendenza seguirà ». In questa Europa nessuno da solo ha la forza di farsi seguire. Tutti, semmai, hanno la possibilità di far pericolosamente tornare indietro le lancette dell’orologio.
 La vittoria del referendum del 4 dicembre ha bloccato solo una delle strade tentate per stravolgere la Costituzione. Altre manovre sono in corso, a partire dalla legge elettorale.
La vittoria del referendum del 4 dicembre ha bloccato solo una delle strade tentate per stravolgere la Costituzione. Altre manovre sono in corso, a partire dalla legge elettorale.
il Fatto quotidiano, 27 luglio 2017, con postilla
La vittoria del No non basta ad impedire nuovi tentativi di stravolgimento della Costituzione. Abbassare la guardia sarebbe un errore, come sottovalutare la forza e la determinazione delle potenti forze che in Italia e all’estero hanno spinto Renzi a tentare di deformare la Costituzione. La proposta di Renzi – bocciata il 4 dicembre 2016 – è solo la forma che ha assunto in Italia una scelta politica e istituzionale autoritaria e accentratrice. Panebianco ha proposto che le future modifiche debbano riguardare tutta la Costituzione, principi compresi, non più solo la parte istituzionale. Del resto il tentativo di modificare il patto costituzionale uscito dalla Resistenza e dall’intesa tra le forze fondamentali dell’epoca ha radici antiche.
Né è casuale che l’Istituto Leoni rilanci la flat tax, con il conseguente stravolgimento della progressività e dell’universalità dei diritti sociali, cambiando di fatto la prima parte della Costituzione. Le dichiarazioni fatte durante la campagna referendaria che la prima parte della Costituzione non era in discussione celavano in realtà il boccone più ambito, da affrontare una volta risolto il problema dei meccanismi decisionali in senso autoritario. Del resto nel mondo ci sono tendenze autoritarie: dalla simpatia delle grandi corporation per i regimi non democratici, fino alle derive autoritarie in Turchia, in Ungheria con il bavaglio alla stampa, in Polonia con l’attacco all’autonomia della magistratura. La pressione è contro le procedure democratiche, viste come inutili pastoie che ritardano le decisioni delle corporation e dei gruppi di potere. Il pensiero stesso è semplificato e primordiale e la società che prefigura è autoritaria, anzitutto sotto il profilo culturale. È già accaduto negli Usa, la destra ha preparato gli stravolgimenti partendo dal piano culturale, con l’obiettivo di trasformare un nuovo pensiero dominante in unico, talora in un dogma di Stato. Qualcosa del genere sta accadendo anche in Italia, la destra è all’attacco di principi fondamentali, la reazione è debolissima. La responsabilità politica e culturale del gruppo dirigente a trazione renziana è di avere buttato alle ortiche i valori della sinistra, una rottamazione dei principi. Pensiamo al fisco: la progressività del prelievo è stata abbandonata e sulla casa sono state tolte le tasse ai ricchi; sono stati approvati condoni a raffica, ora in proroga, con le stesse motivazioni di Tremonti. Sinistra e destra hanno sempre avuto un confine: il no, di principio, ai condoni. Questo argine è stato fatto saltare. Dove stanno ora le differenze? Ora è in preparazione un altro stravolgimento costituzionale e questa volta l’attacco riguarderà insieme meccanismi decisionali e principi, cioè i diritti fondamentali delle persone: lavoro, diritti, sanità, stato sociale. Per respingere questo tentativo il primo appuntamento è la legge elettorale, che non a caso nel disegno renziano era tutt’uno con le modifiche costituzionali. Il prossimo parlamento avrà un ruolo importante per respingere questi tentativi. Non si può che concordare con Onida: “Rinnegare i principi non vorrebbe dire rivedere la Costituzione ma stravolgerne i principi supremi… un salto indietro di due secoli”. Un parlamento eletto con i residui di Porcellum e Italicum, composto da nominati dai capipartito e non da eletti dai cittadini sarebbe subalterno ai poteri dominanti. Un parlamento rappresentativo, che risponde agli elettori, potrebbe impedire lo stravolgimento dell’assetto costituzionale, perfino imporne l’attuazione.
La nuova legge elettorale sarà uno spartiacque. Questo è drammaticamente sottovalutato. Troppi continuano a credere che una modalità elettorale vale l’altra. Non è così. Una legge elettorale che consenta di eleggere un parlamento rappresentativo, consapevole del suo ruolo, sarà decisiva per garantire la Costituzione. Altrimenti la destra rilancerà il presidenzialismo.
Il comitato per il No ha il merito di avere dato legittimità culturale e politica al No contro la deformazione costituzionale, impedendo il monopolio della destra. Ma anche a sinistra occorre chiarezza. Il No non è una linea del passato. Il 4 dicembre non basta ad impedire nuovi tentativi e la legge elettorale ancora non c’è. Sì e No non sono sullo stesso piano. Il Sì avrebbe fornito al gruppo di potere renziano le credenziali presso le forze che vogliono il cambiamento ad ogni costo della nostra Costituzione in modo che una minoranza di elettori diventi maggioranza comunque. Il No ha bloccato questo percorso.
Ora il tentativo riparte.
Il 2 ottobre, come l’11 gennaio 2016, lanceremo un’iniziativa per avviare una campagna nel Paese per impedire che la legge elettorale venga sequestrata dai capi partito, come hanno già fatto con il Porcellum e poi con l’Italicum, con l’obiettivo di consentire agli elettori di decidere chi li deve rappresentare.
postilla
Il potente gruppo finanziario JP Morgan, leader indiscusso del capitalismo globalizzato, minacciò l'allora presidente della Repubblica di sfracelli se la de-costituzione di Renzi non fosse passata. Vedi in proposito, su eddyburg: Il giudizio universale di JP Morgan, di Barbara Spinelli, Eddytoriale n 171, di EddyburgIo dico No ai ladri di sovranità, di Tomaso Montanari

manifesto, 27 luglio 2017
Ancora una volta per capire la crisi libica e dintorni, ricorriamo ad Angelo Del Boca, storico del colonialismo italiano e della Libia.
Gentiloni ha ricevuto Fajez al Sarraj di ritorno dal vertice con Haftar promosso da Macron a e ha comunicato che il leader di Tripoli «ha chiesto aiuto navale italiano in acque libiche contro i trafficanti di esseri umani»; ora la proposta «viene valutata con il ministro della Difesa». Che significa?
«Sembra un nuovo intervento militare, una nuova avventura italiana. Comunicato appena dopo il vertice voluto da Macron. Una specie di guerra d’immagine. Ma pericolosa, Non a caso è stato subito apprezzato dalla destra italiana che da tempo vuole schierare le cannoniere. Certo non è chiaro: si tratta di una sorta di blocco navale in acque libiche, solo della Tripolitania, quasi una sostituzione italiana dell’inutile e corrotta guardia costiera libica? Oppure in acque internazionali? Comunque sulla pelle dei profughi che a quel punto sarebbero sequestrati, dopo l’eventuale cattura dei “trafficanti” e rispediti nelle prigioni libiche o nella disperazione africana. Senza escludere il rischio di come avviene un blocco navale: dovremmo ricordarcelo come Italia: nel 1997 affondammo la barcarola albanese Kater I Rades con una corvetta della Marina e morirono 108 persone».
Qual è il suo giudizio sul vertice di Parigi promosso dal presidente francese?
«È come se Macron avesse voluto ricucire, ma solo recitandolo, l’affronto di Sarkozy che, nel marzo 2011 guidò la guerra a Gheddafi forzando la mano a tutti, a cominciare dall’Italia fino agli Stati uniti, un fatto che almeno Obama ha riconosciuto come un tragico errore. Uno strappo tra l’altro costato 30 mila miliardi di dollari in distruzioni di città, fabbriche, infrastrutture, secondo la valutazione fatta dalle Nazioni unite.
«Attenzione, si tratta di una svolta d’immagine. Macron si muove con l’atteggiamento da piccolo Napoleone, sopravanza l’Italia con un summit realizzato quasi di nascosto e sfotte perfino quando si sente in obbligo di ringraziare «il mio amico Gentiloni». La sua riparazione serve in sostanza ad imporre il primato della Total in terra libica.
«Se avesse voluto riabilitare davvero la Francia perlomeno doveva annunciarsi come un giovane convinto europeista che ammette gli errori francesi in Africa. Invece paradossalmente si fa forte dei disastri compiuti dai presidenti francesi precedenti e ancora una volta del controllo assoluto che Parigi ha dei paesi della fascia del Sahel, tra cui Niger, Mali, Ciad dei quali controlla economia e valuta con il franco locale Cfa, l’acronimo vuol dire che quei Paesi appartengono alla Communauté Financière Africaine. Il colonialismo sta sempre lì. Ora per il ministro Minniti, il Niger diventa la frontiera sud, il muro da difendere, dell’Europa».
Eppure Sarraj e Haftar si sono stretti la mano per un cessate il fuoco, l’ipotesi di un governo unitario di transizione, elezioni nella primavera del 2018…
«Ma se si legge bene, sono gli stessi contenuti dell’incontro tra i due di Abu Dhabi nel maggio scorso. Sui quali Macron ha messo il cappello. Un vertice quello la la mediazione degli Emirati, in realtà schierati con il generale Khalifa Haftar che fa il lavoro sporco per la stessa Francia, l’Egitto e la Russia. Dietro Fajez al Sarraj c’è il riconoscimento dell’Onu e l’Italia, che lo ha insediato con la Marina militare – e quello nemmeno c’informa che va da Macron. Ma il «nostro» leader vive sotto assedio, non controlla a pieno nemmeno la città di Tripoli; tanto meno la Tripolitania divisa tra milizie in parte schierate con Tripoli, come quelle di Misurata che ricattano costantemente Sarraj, in parte con il precedente governo islamista di Khalifa al-Ghweil; ci sono poi l’enclave armata di Zintane che ha detenuto e liberato Seif Al Islam, il figlio di Gheddafi; il Fezzan delle tribù e dei clan e la Cirenaica di Haftar, ancora alle prese con il tentativo di ricostituzione delle milizie jihadiste, a Derna e Bani Walid dopo la sconfitta di Sirte. Dappertutto centinaia di milizie armate.
«Questo elenco per dire che proprio l’ultimo capitolo dell’accordo di Abu Dhabi – «risolvere il nodo delle milizie» – è fallito facendo fallire tutto il resto. Perché parliamo di controllo del territorio che non c’è. Lo sa bene il generale Haftar che avanza e occupa i decisivi pozzi petroliferi. Non a caso su di lui si spostano ormai le simpatie internazionali, comprese quelle dell’Italia. La pace nella Libia somalizzata dall’intervento militare occidentale, che ha mandato in frantumi un lavorìo di 42 anni per tenerla insieme, non può avere come interlocutori soltanto due protagonisti. Le forze in campo sono molte di più. A cominciare da quelle internazionali, perché la Libia è diventata il cuore del neocolonialismo mondiale.

«». L'Espresso, 23 luglio 2017 (c.m.c.)
Una società multietnica multiculturale, multirazziale, pluralista... È solo un ritornello, una giaculatoria rassicurante, o dietro questa formula sta nascendo davvero la cultura necessaria per affrontare un problema grandissimo, forse il più impegnativo e decisivo tra i molti che, oggi, si affollano e annunciano ovunque un cambiamento d'epoca?
La manifestazione più appariscente, e drammatica, è sicuramente quella che definiamo razzismo, che riappare in molti luoghi. Se però il razzismo è il fenomeno più noto, l'orizzonte da contemplare è ormai quello di società nelle quali la difficile ricerca di valori comuni e la necessaria coesistenza tra valori diversi rompono la trama degli abituali criteri di riferimento. Le nostre società non sono abbastanza forti né per assimilare l'"altro", né per respingerlo.
Respingerlo non possono, quando si tratti di un profugo o, più semplicemente di un lavoratore indispensabile a colmare vuoti. Assimilarlo non vogliono, non ne hanno i mezzi e la forza: o, spesso, è proprio l' "altro" che chiede un riconoscimento, non l'assimilazione. Chiede di violare il santuario della scuola laica portando il suo chador. Conserva magari l'antropologica propensione a fissare violentemente il rapporto tra i sessi, si porta dietro pratiche antiche e tremende, come l'infibulazione. E malgrado ciò (o proprio per ciò), esige poi diritti e eguaglianze che non stanno nei vecchi schemi, anzi ne rivelano le crepe, le debolezze.
Sono così proprio i nostri modelli più abituali e rassicuranti - la tolleranza, l'eguaglianza, il "melting pot" - ad apparirci bisognosi di ripensamento. È indispensabile vedere se essi sono in grado di comprendere una dinamica dei conflitti che va ben al di là della discriminazione più o meno violenta. Un esempio per tutti. Oggi si propone, giustamente, l'estensione agli immigrati di una serie di diritti civili, sociali, politici. Questa è una via sacrosanta, l'unica a poter impedire almeno le forme più brutali e formali di discriminazione. Ma, superato questo conflitto, se ne profila uno più difficile da risolvere. L'esperienza di molti paesi ci dice che proprio il riconoscimento di una pari cittadinanza agli immigrati scatena reazioni nei gruppi sociali che, socialmente o culturalmente, si sentono minacciati da questa maggior vicinanza di gruppi che escono da qualcuno dei ghetti in cui erano stati confinati. La parità - dovremmo saperlo - spesso annuncia nuovi conflitti.
Ma è la stessa nozione di eguaglianza a esser messa in discussione. La rinuncia alle identità irriducibili al modello prevalente appare la condizione stessa dell'eguaglianza, che si configura così in forme che ammettono un vero pluralismo solo in occasioni e casi determinati. È lo stile dell'America del "melting pot", dove l'essere riconosciuto come eguale dipendeva proprio dalla capacità di omologarsi. Ma è pure uno stile che, in nome di valori dominanti ed esclusivi, ha negato o ritardato il riconoscimento dei diritti delle minoranze.
Da qui il paradosso di una concezione dell'eguaglianza che custodisce il germe della discriminazione. Da qui la necessità di muoversi verso una concezione dell'eguaglianza fondata sul riconoscimento pieno delle identità diverse, che diviene così il fondamento del diritto alla identità, del diritto alla differenza. Da qui lo scolorirsi dell'immagine del "melting pot", sostituita da quella del "salad bowl". Non il crogiuolo nel quale ogni elemento si fonde, perde la sua identità e diviene irriconoscibile. Al suo posto, una "insalatiera" nella quale la mescolanza è possibile, in cui i diversi elementi rimangono riconoscibili.
Lungo questa strada c'è un rischio che viene reso esplicito da chi dice che il riconoscimento del pluralismo non può portare con sé la legittimazione delle idee più arretrate, di simboli di barbarie, di violazione di valori essenziali della civiltà. Ecco, allora, la domanda più generale: la regola del pluralismo è incondizionata o ammette eccezioni? E, se sì, secondo quali criteri? Le risposte sono difficili, e sono il segno della vera difficoltà che s'incontra quando si cerca di convertire l'antirazzismo in accettazione convinta di una prospettiva sociale segnata dalla presenza di diverse culture.
Questo non significa negare o mettere tra parentesi il fatto che sono stati faticosamente costruiti grandi valori comuni, quelli in cui s'identifica (o dovrebbe identificarsi) la nostra civiltà. Quel che si mette in discussione è l'esistenza di una cultura dominante, da accettare senza alcun preventivo confronto e senza ammettere la possibilità che questo confronto possa arricchire lo stesso quadro di valori e di criteri di riferimento nei quali ci siamo finora riconosciuti. In ciò sta la differenza tra assimilazione e integrazione. E quello che oggi ci appare un arduo ostacolo da superare può divenire l'occasione per la nascita di una organizzazione sociale dove proprio la fatica del confronto può far rinascere il senso della comunità. Non è un processo facile. Richiede un apprendimento collettivo, non esclude conflitti.
Né può essere affidato soltanto al fluire delle cose, alla buone volontà. Esige le sue regole, istituzioni, scelte, le sue "forzature". Servono politiche capaci di incidere sulla sostanza della loro condizione, e quindi investimenti in informazione, formazione, strutture, "azioni positive". Integrazione e costruzione di valori comunitari camminano insieme. E il senso di appartenenza a una comunità nasce e si sviluppa solo se si partecipa effettivamente alla sua vita, ai momenti nei quali la comunità si costruisce.
Il vedere l'"altro" insediarsi stabilmente nel proprio territorio produrrà spaesamenti, rifiuti, conflitti. Non c'è dunque una via rapida di pacificazione. Ma non ce n'è una diversa.
 «Nel cuore della miglior tradizione europea non c’è nessuna millanteria delle origini, c’è la ricerca della verità, l’incessante indagine conoscitiva. C’è il dubbio ed è da questo cuore che partono le istanze di dignità umana e di giustizia che percorrono la storia europea».
«Nel cuore della miglior tradizione europea non c’è nessuna millanteria delle origini, c’è la ricerca della verità, l’incessante indagine conoscitiva. C’è il dubbio ed è da questo cuore che partono le istanze di dignità umana e di giustizia che percorrono la storia europea».
Il Fatto Quotidiano online, 26 luglio 2017 (c.m.c.)
L’Europa sta cercando la propria anima, e non sa bene dove trovarla. Ha senso girare la domanda a chi pratica le scienze storiche? Dipende. Troppo spesso gli intellettuali sbandierano slogan improbabili, come la pretesa continuità della storia europea da Omero ai nostri giorni; troppo spesso la retorica corrente fa leva su parole logore e vacue come “radici” o “identità”.
Alla base di queste prediche a vuoto c’è un colossale equivoco, l’idea che un’immagine monolitica dell’Europa sempre uguale a se stessa la rafforzi sulla scena “globale” del mondo di oggi. È vero il contrario: per secoli abbiamo coltivato un’idea di Europa eterna e immutabile, bandiera di un eurocentrismo che rivendicando la superiorità su ogni altra civiltà mirasse a legittimare ieri il più brutale colonialismo, oggi l’egemonia dell’Occidente. Quel tempo è finito per sempre, quell’idea di Europa ha generato formidabili anticorpi che l’hanno ridotta in polvere. Per non dire delle “radici cristiane”, formula che vuol chiudere l’Europa entro un muro. Ma se neghiamo tali artificiose continuità, che cosa resta dell’Europa?
Un netto bivio tra continuità e discontinuità non ha senso. Nel cuore della miglior tradizione europea non c’è nessuna millanteria delle origini, c’è la ricerca della verità, l’incessante indagine conoscitiva. C’è il dubbio, l’ideale socratico della “vita esaminata” (al fine di intendere da quali motivazioni sia mosso il nostro agire), ed è da questo cuore che partono le istanze di dignità umana e di giustizia che percorrono la storia europea. Perciò dobbiamo concentrare lo sguardo sui termini di passaggio, sulle fratture interne alla storia d’Europa.
Fratture che sono anche cerniere, ponti di comunicazione fra culture diverse. Leggere la storia culturale europea come perpetuo alternarsi di continuità e discontinuità, mescolarsi di civiltà, lingue, religioni. Incontri e scontri, anche violenti, che hanno costruito nei secoli il nostro Dna. Il suo vanto non è nella “radice unica”, ma nella sua ramificatissima, feconda pluralità. Nella sola Italia contiamo etruschi e greci, fenici e celti, sardi e italici, romani e liguri, longobardi e arabi, francesi e catalani, slavi e veneti, austriaci e spagnoli, “pagani” e cristiani, musulmani, ebrei. E molto altro ancora. È nelle pieghe, nelle suture e nei conflitti fra l’una e l’altra di queste componenti che dobbiamo cercare un’idea di Europa che sia vincente sulla scena globale del mondo.
Due concetti-chiave della storia culturale europea, quello di “classico” e quello di “Rinascimento”, mostrano quanto essa sia ricca e feconda, se solo rinuncia a una concezione angustamente identitaria. Il Rinascimento fu lo sforzo di far rinascere l’antichità classica, cioè di sanare una ferita, di gettare un ponte su una discontinuità. Ma di rinascimenti ce n’è stato solo uno, o tanti? Le molte ‘rinascenze’ al tempo di Carlo Magno o di Federico II, a Reims o a Padova o a Bisanzio, rivelano una sequenza segmentata e sofferta, non una pacifica continuità.
Ed è possibile, anzi necessario, chiederci se altre civiltà lontane dall’Europa non abbiano avuto un qualche loro rinascimento (lo ha fatto un grande antropologo, Jack Goody, nel suo Rinascimenti: uno o molti?, pubblicato in Italia da Donzelli). Quanto alla classicità greco-romana, essa non coincide affatto con l’Europa, anzi il suo spazio culturale ha avuto un orizzonte mediterraneo, esteso verso Sud e verso Oriente più che verso Nord. La stessa categoria di “classico” ha un ambito di applicazione enormemente più vasto dell’Europa, perché si presta a orientare lo sguardo e i comportamenti, a costruire sistemi di valori, gerarchie, preferenze, gusti, anche nella cultura araba, cinese, persiana, indiana.
Dobbiamo ripensare la classicità greco-romana attraverso il filtro di un’assidua comparazione con elaborazioni culturali affini, anche in orizzonti assai lontani dall’Europa. Non dobbiamo considerare i “nostri” Antichi come provvidenzialmente identici a noi stessi, ma anzi riconoscere la loro radicale alterità; e quando vi troviamo frammenti di un’identità che è ancora la nostra (per esempio in una moltitudine di parole greche, da ‘nostalgia’ a ‘democrazia’), dobbiamo guardarle più da vicino : quanto diversa dalla nostra la democrazia ateniese, dove le donne non votavano e non si metteva in discussione la schiavitù!
Eppure, abbiamo ancora molto da imparare dall’idea di cittadinanza come fu elaborata nella polis antica. Se consideriamo il classico come spola tra l’identico e il diverso, come esercizio della mente e della moralità che ci spinge al confronto con altre culture, anche la civiltà greco-romana potrà valere come chiave d’accesso alla molteplicità culturale del mondo contemporaneo: una piattaforma conoscitiva efficace solo se spogliata di ogni pretesa di unicità, e fecondata dalla comparazione.
Ogni tempo ha la sua Europa. Ma l’Europa di oggi conserva l’impulso a cercare la verità delle cose, la memoria di sé che induca al confronto, l’incessante interrogarsi sulla natura della nostra memoria culturale? C’è da dubitarne. Nelle istituzioni europee non regna la cultura, non regna il dubbio, non regna la dignità umana né la giustizia sociale. Regna un riduzionismo tecnocratico, di natura sostanzialmente autoritaria e antidemocratica, secondo cui al mercato, e ad esso solo, spetta regolare la società in tutti i suoi aspetti. Sembra esaurito il notevolissimo impulso ideale che fra le rovine della seconda guerra mondiale innescò il processo che avrebbe portato alla nascita dell’Unione Europea. Essa avrebbe dovuto partire dalla coscienza di sé per costruire un modello di convivenza che segnasse un suo nuovo ruolo nel mondo.
Quegli ideali si sono inariditi, e l’Europa a cui si pensa oggi non è quella dei suoi cittadini, della sua storia, della sua cultura, ma quella dei Trattati, dove il ruolo della memoria storica è marginale, come lo è l’equità sociale; è l’Europa dei mercati, prona a una logica di globalizzazione che implica la metamorfosi del cittadino in consumatore. In un tal contesto non vi sarà mai un vero patriottismo europeo: perché la patria ha un’anima, il mercato no. Rispetto all’Europa dei mercati, l’Europa della cultura è (per usare una metafora cara a Benjamin) come il mendicante che bussa alla porta. Avrà con sé un messaggio, o forse addirittura l’anima dell’Europa che andiamo cercando? Non lo sapremo mai, se quella porta non verrà aperta. Ma perché si apra, dobbiamo bussare più forte, dobbiamo alzare la voce.
 Un resoconto sul rastrellamento degli immigrati "illegali'"nell’era Trump. Storie di ordinaria persecuzione quotidiana: ma la California non è d'accordo,
Un resoconto sul rastrellamento degli immigrati "illegali'"nell’era Trump. Storie di ordinaria persecuzione quotidiana: ma la California non è d'accordo,
The New York Times, 21 luglio 2017 (m.c.g.)
“Criminals off the street, that’s our goal”: è stata questa la parola d’ordine, persecutoria e razzista nei confronti della popolazione immigrata, che ha risuonato martellante della campagna elettorale di Trump. Al di là della minacciata costruzione del muro alla frontiera con il Messico, l’amministrazione Trump si è messa immediatamente all’opera: in tutto il paese gli uffici locali dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) dall’alba alla notte stanno rastrellando le strade e le abitazioni dove risiedono gli immigrati: con ‘successo’, se si considera che, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, i rimpatri forzati sono aumentati del 40%. Ma in California siamo molto al di sotto della media.
L’articolo è firmato da due giornaliste del NYT che hanno accompagnato gli agenti dell’ICE durante un rastrellamento notturno nella California del Sud. Si raccontano (e vengono accompagnate da un filmato) le storie disperate di migranti accolti in uno Stato, la California, che ne ospita (con grandi vantaggi economici, poiché si tratta di manodopera a basso costo che si adatta ai lavori più faticosi e meno remunerati) più di 2 milioni e che continua a dichiararsi fermamente contrario alle deportazioni di massa volute da Trump. Molti sceriffi californiani infatti, malgrado le segnalazioni dell’ICI, non confermano l’espulsione.
Più in generale, sono le amministrazioni delle grandi città americane che continuano a opporsi, malgrado le incessanti minacce di ritorsione presidenziale nei confronti delle “sanctuary cities”, al pensiero unico trumpiano secondo il quale tutti i migranti sono delinquenti.
Ma vi sono alcuni punti di debolezza nelle politiche di accoglienza messe in atto prima dell’arrivo di Trump nelle maggiori città santuario. Virtuosamente destinate a favorire l’emersione, queste politiche potrebbero invece risultare molto utili ai ‘persecutori’: all’ICE appunto. Infatti, le procedure di identificazione e registrazione dei migranti, avviate negli anni passati per far emergere i residenti illegali e riconoscere loro un diritto di cittadinanza e l’accesso ai servizi, costituiscono una banca dati preziosa per chi vuole individuare e ‘deportare’ i cittadini indesiderabili.
A San Francisco si è già corso ai ripari, distruggendo tutti i file del Municipal Identification Program, istituito nel 2009 per dare riconoscibilità e aiuto ai migranti illegali. Ma per le altre grandi città che non l’hanno ancora fatto (ad esempio New York) potrebbe aprirsi un ulteriore contenzioso legale, ancora più pericoloso per gli immigrati, fra Washington e i governi locali.
(scelto e presentato da Maria Cristina Gibelli)
The New York Times
A BROADER SWEEP
byJennifer Medina and Miriam Jordan
RIVERSIDE, Calif. — Just after dawn, a line of officers marched to the gate outside Fidel Delgado’s home here with guns drawn, one holding a rifle. Mr. Delgado emerged barechested from his home and with a look of confusion.
“Qué necesita” he asked: What do you need? About 20 minutes later and 10 miles away, Anselmo Morán Lucero sensed exactly why officers had come. He spotted them as he was returning from a night out, and turned his truck around. But an unmarked S.U.V. pulled in front of him and another flashed its lights behind him, blocking his escape.
They asked his name. They asked if he knew why he was being arrested. Mr. Lucero nodded. Every day around the United States, from before sunrise until late into the night, people like Mr. Delgado and Mr. Lucero are being picked up by Immigration and Customs Enforcement officers, the front-line soldiers in President Trump’s crackdown on illegal immigration.
More than 65,000 people have been arrested by the agency since Mr. Trump took office, a nearly 40 percent increase over the same period last year and as sure a sign as any that the United States is a tougher place today to be an undocumented immigrant.
But I.C.E. is in some ways operating in enemy territory in California, home to more than two million undocumented immigrants and hostile to the idea of mass deportations. Because local law enforcement often will not turn over undocumented immigrants in their custody, I.C.E. must make most of their arrests at homes, at workplaces and out on the street, which is more complicated than simply picking people up from jails — and potentially more dangerous.
So when a team of immigration agents gathered at 4:30 on one already warm morning in June, their chief, David Marin, warned them to stay away from any sign of danger.
After going over notes on each of the men they were after, the team pulled out in their unmarked S.U.V.s. Eight hours later, five men would be in custody, awaiting the start of deportation proceedings.
The New York Times followed the team for a day as it navigated the streets and politics of Southern California, and spoke with some of the men it arrested and the families they may soon be leaving behind.
An Unplanned Arrest
As the sun crept above the horizon, the officers gathered on a hill just a few yards away from Mr. Delgado’s home. But it was not Mr. Delgado they had come for; it was his son Mariano.
Mariano Delgado, 24, had returned to Mexico in 2011 after he was convicted of drunken driving. Since illegally re-entering the United States, he has been arrested four times for assault with a deadly weapon.
Immigrants like him are called “criminal aliens,” and there are so many of them in Southern California that Mr. Marin says it is effectively impossible to go after anyone else. But under President Trump, agents are encouraged to also arrest undocumented immigrants without serious criminal records, a break from the Obama administration’s policy of mostly leaving those immigrants alone. So here and across the country, agents now make more “collateral” arrests — undocumented people they come across while looking for someone else. That was about to happen.
When officers, guns out, approached the chain-link fence surrounding the home, the dogs began barking loudly, joining the squawking chickens. Fidel Delgado emerged.The elder Mr. Delgado, 46, and his wife, María Rocha, told the officers that their son had moved to Texas months ago. They readily admitted to being in the country illegally, but added that they worked. Their youngest son, 16, is an American-born citizen. When the agents shook him out of bed, he began to sob.
After taking Mr. Delgado’s fingerprints, they ran them through a database. Within minutes, they learned that he had once crossed the border illegally, twice in the same day, and had been sent back to Mexico.
A couple of officers debated what to do: Should they take both parents and call Child Protective Services for the boy? Did they believe that Mariano Delgado was no longer living there, even though they thought he was home as recently as the week before? “If he doesn’t give up the son, we’re going to take him,” one officer said.
They left the wife behind and led Mr. Delgado to a van, where he was soon shackled. The handcuffs would leave marks.
Later that morning, Ms. Rocha, 50, leaned against the chain-link fence that surrounds their home, bleary-eyed and in shock. “My husband, they had no reason to take him,” she said. “They weren’t searching for him.”
The family has lived in the three-bedroom white house in a blue-collar, semirural enclave of Riverside for three years, paying $1,300 a month in rent. Ms. Rocha, who cleans offices in nearby Corona, a more upscale community, said she brought home about $1,200 a month. Her husband, who milks cows at a dairy, earns about $12 an hour.
The couple married in Mexico 24 years ago, just before heading north. “We came here for a better life,” she said. In all her years in the United States, she said, she had never had problems with “la migra,” as the immigration agency is known. By the afternoon, Mr. Delgado had been released by the immigration agents, who decided that he was not a threat to public safety. He was given a notice that he must comply with any orders from immigration agents and returned to work the next day.
Agency Under a Microscope
Before heading out to their targets for the day, the I.C.E. team gathered in the darkness in the parking lot of a small hardware store. Mr. Marin, the enforcement supervisor, quizzed his officers:
What time will this man start to leave his home? Which way will that one turn when he pulls out of his driveway? When will the other one arrive back from his night shift? The officers had been watching the men they were after for days, learning their habits so they could capture them easily.
Mr. Marin, 48, has worked in immigration enforcement for more than two decades, starting when the agency was called Immigration and Naturalization Services. In the 1990s, he said, officers would spend much of their time rounding up immigrants in front of home repair stores, routinely arresting people so many times that they would know them by sight. Within hours of a bus ride returning them to Mexico, Mr. Marin said, they would be on their way to the United States again.
Like roughly half of the other officers, Mr. Marin began his career in the military, serving as a Marine. He amassed tattoos the way others collect shot glasses: On his left forearm is the first letter of the word “Christian” written in Arabic, commemorating his work collecting intelligence on the Taliban in Pakistan.
Though he had to pass a basic Spanish course early in his career, today Mr. Marin hardly speaks a word of it. But many officers do. Nearly 40 percent of Mr. Marin’s officers are Latino, he said, and many of them hear refrains of “How can you do this to your own people?” They do not apologize.But the agency is under a microscope here. Arrests in the Los Angeles region are up only 17 percent since Mr. Trump took office, far less than in the rest of the country, according to I.C.E. statistics.
Members of Congress and local officials routinely call Mr. Marin’s cellphone when they hear of arrests in their area.
“People want to know if we’ve gone into schools, if we’re standing in the market, but that’s not what we do,” Mr. Marin said, driving before dawn. “We know an arrest is a traumatic event for a family. We know the impact it has, and we take it very seriously.”
Luck Runs Out
While Mr. Delgado was being questioned, other members of the team were waiting for Mr. Lucero, who had already been deported once. Mr. Lucero, 51, and his wife, Jamie, 47, arrived from a small village in the Mexican state of Puebla more than three decades ago. He had built a thriving landscaping business, tending to yards of homes in upscale Orange County.
In 2006, Mr. Lucero was convicted in a domestic violence case and spent several months in jail, then was deported. But he had reconciled with his wife and was eager to return to her and their six children, two of them born in the United States. So he crossed the border illegally again.
Immigration officials had tried to get the Orange County sheriff’s office to hold Mr. Lucero for them when he was in jail for a day on a new domestic violence charge in 2014. But the sheriff declined, according to I.C.E. Many California sheriff and police departments do not cooperate with immigration officials, saying it erodes trust in law enforcement among immigrant populations. Mr. Trump has threated to punish these so-called sanctuary cities and counties, saying they harbor lawbreakers. For several nights before the I.C.E. team showed up, Mr. Lucero said, he had dreams of immigration agents coming to get him. The night before, he and his wife tried their luck at a nearby casino, playing the slot machines until daybreak. They had won a couple of hundred dollars and left just before 6 a.m.
When they began driving home, Ms. Lucero’s brother, with whom the family lives, warned them that immigration officers were near. But Mr. Lucero was unable to evade them.Hours after his arrest, Jamie Lucero, her eyes red with tears, pulled out a blue folder with Mr. Lucero’s papers neatly organized, including documents showing he had completed an anger-management program and followed the rules of probation from his domestic violence case. She was planning to take the folder with her when she visited him in detention, though the papers are unlikely to have a bearing on his new deportation case.
Their 29-year-old son, Urie, said that the week before, four officers had come to the door holding a picture of a bald man they said they were after. They never mentioned the man’s name, and Urie Lucero said he did not recognize the man. But the officers came inside the home and looked around. The family is convinced that the visit and the picture of the bald man were ruses to try to scope out Anselmo Lucero’s whereabouts. “That’s how they are getting people,” Urie Lucero said.
Jamie Lucero said the officers had told her not to bother paying for a lawyer because he faced certain deportation.
By lunchtime, the agents had five immigrants in custody: three of their six targets of the day, as well as Mr. Delgado and another man they found in the home of a target. Typically, officers successfully arrest about half the people they are looking for, Mr. Marin said, so this was a good day. “Criminals off the street, that’s our goal,” he said while standing inside the San Bernardino processing center, where immigrants from the region are taken each day.
The men they had arrested sat inside a small holding cell clutching their brown-bag lunch of a turkey sandwich and apple. Mr. Marin and one of his deputies headed for lunch at a small Mexican taqueria.
A broader sweep. A day in the field with immigration enforcers in California, a state hostile to President Trump’s efforts to step up deportation - The New York Times
https://www.nytimes.com/.../immigration-enforcement-california...
 «La tentazione autoritaria sarà sconfitta se quei popoli vedranno nel progetto europeo un modello di società dinamica e attrattiva».
«La tentazione autoritaria sarà sconfitta se quei popoli vedranno nel progetto europeo un modello di società dinamica e attrattiva».
Internazionale online 26 luglio 2017 (c.m.c.)
Dopo la Brexit si parlerà di una “Polexit” per la Polonia, o direttamente di una “Estexit” per l’eventuale scissione tra i vecchi paesi membri dell’Unione europea e quelli nuovi dell’Europa centrale e orientale?
La decisione presa il 24 luglio dal presidente polacco Andrzej Duda di apporre il veto su due delle tre riforme del sistema giudiziario proposte dal governo di Varsavia e adottate dal parlamento, allontana per il momento questa minaccia. Si tratta però soltanto di una tregua, una battaglia vinta nella guerra dell’autoritarismo combattuta in seno stesso all’Unione europea.
Il presidente Duda, al quale fino a oggi nessuno aveva attribuito una simile forza di carattere, ha detto di essere stato colpito dalle parole di Irena Zofia Romaszewska, 77 anni, anziana intellettuale associata all’epopea di Solidarność nell’era comunista. Essendo già vissuta in un’epoca in cui tutti i poteri erano nelle mani dei procuratori, gli avrebbe detto, non aveva voglia di riviverla. Ed era proprio questo il punto della riforma della giustizia: la fine di una separazione dei poteri e il controllo della politica sulla nomina dei giudici.
Il capo di stato polacco non è stato influenzato soltanto da questa figura storica della dissidenza, ma anche e soprattutto dalla mobilitazione dei giovani che hanno invaso le strade e le piazze di Varsavia per difendere lo stato di diritto e i valori europei.
Se lunedì scorso, con il colpo di scena che ha costretto il potere a fare un passo indietro, c’è stata una vittoria, questa va attribuita soprattutto alla mobilitazione di massa in piena estate della società civile polacca e soprattutto dei più giovani che, secondo tutti i sondaggi, sono in maggioranza legati ai valori europei e hanno una maggiore apertura mentale.
Sarebbe tuttavia bene non farsi illusioni: non per questo in Europa centrale si fermerà l’ondata illiberale partita dall’Ungheria di Viktor Orbán e ripresa dalla Polonia di Jarosław Kaczyński. Corrisponde a una visione del mondo nazionalista, sciovinista ed esclusivista che ha trovato un’ampia eco in una fase di sconvolgimenti e incertezze e che ha fatto della figura del migrante il capro espiatorio di tutti i mali e del liberalismo politico dell’Europa occidentale un simbolo di debolezza e di rinuncia.
Tanto la Polonia quanto l’Ungheria non sono del tutto convertite a questa visione, e lo testimonia il sussulto di resistenza messo in campo dalla società civile a ogni tappa di questa erosione democratica attuata metodicamente dai due governi.
La questione, aperta da tempo e ancora senza una risposta davvero convincente, riguarda la reazione della stessa Unione europea. Per la prima volta la Commissione europea ha messo in guardia la Polonia dopo il voto di tre riforme della giustizia e ha di certo tirato un gran sospiro di sollievo all’annuncio del veto presidenziale su due di esse.
Bruxelles temeva di dover passare alla fase successiva in caso di approvazione delle riforme. Il famoso articolo 7 del trattato di Lisbona, la “bomba atomica” degli statuti dell’Unione europea, prevede la sospensione dei diritti di voto di uno stato membro in caso di violazione flagrante dei suoi princìpi fondatori. Per sanzionare uno stato serve però l’unanimità, di fatto impossibile dato il sostegno evidente dell’Ungheria alla Polonia di oggi.
Per screditare una minaccia non c’è niente di meglio che agitarla senza avere gli strumenti per applicarla. Tanto più che alcuni dirigenti del Pis, il partito di Jarosław Kaczyński, hanno ammesso di volere usare le minacce europee per scatenare un’ondata di reazioni nazionaliste e non hanno esitato a paragonare la Bruxelles di oggi alla Mosca di ieri.
I principali attori dell’Ue hanno l’imperativo di ridefinire il loro comportamento, la loro strategia e i loro discorsi di fronte alle tentazioni autoritarie di alcuni stati. Non possono restare in silenzio né continuare ad agitare minacce senza futuro. L’urgenza riguarda in particolare la cancelliera tedesca Angela Merkel, la personalità più forte del Partito popolare europeo (Ppe), l’alleanza di partiti di destra nel parlamento europeo che annovera tra i suoi membri il partito Fidesz di Viktor Orbán. Una parte della destra tedesca è compiacente nei riguardi del presidente ungherese, ma la cancelliera non può permetterselo.
È però soprattutto alle società civili dei “Peco”, i paesi dell’Europa centrale e orientale nel gergo di Bruxelles, che l’Unione deve parlare. Si è vista la bandiera blu stellata dell’Europa fungere da elemento di convergenza per i manifestanti anticorruzione di Bucarest e per gli oppositori del controllo politico sulla giustizia in Polonia.
È in corso una battaglia sorda nel settore dell’informazione. In Polonia come in Ungheria, i poteri politici continuano a rafforzare il controllo sui mezzi di informazione, ovviamente su quelli pubblici, e questo emerge dal tono dei telegiornali, ma anche su quelli privati, con la partecipazione di “amici” del potere o il soffocamento di mezzi di comunicazione indipendenti, privati degli introiti pubblicitari.
L’obiettivo, come in tutti i paesi autoritari che si rispettino (per esempio la Turchia di Erdoğan oggi) è quello di limitare il più possibile le voci critiche e dissidenti per dare libero sfogo alla propaganda governativa. Così le opinioni pubbliche finiranno per trovare “normali” i provvedimenti arbitrari antimigranti, gli ostacoli allo stato di diritto, i limiti imposti alla libertà di espressione, di riunione, di manifestazione.
La visione del mondo espressa dai leader di questa “tentazione autoritaria” è rafforzata dalle influenze extraeuropee. Nelle ultime settimane abbiamo visto Donald Trump interrogarsi, in un discorso magniloquente pronunciato a Varsavia, sulla “volontà di sopravvivere” dell’Europa; e Benyamin Netanyahu incitare i leader del “gruppo di Visegrad” (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia) riuniti a Budapest a ribellarsi a Bruxelles, rievocando in un discorso a porte chiuse ritrasmesso da un microfono malauguratamente rimasto aperto la figura del “barbaro” alle nostre porte.
Questa tentazione può e deve essere contenuta. A farlo però saranno innanzitutto i popoli di quegli stessi paesi, se vedranno nel progetto europeo un modello di società dinamica e attrattiva, l’antitesi del mostro burocratico, intrusivo e accentratore descritto dai loro leader.
È soprattutto ridando vita al progetto europeo che si eviterà una Estexit, che non è desiderabile né oggi né in futuro, perché condannerebbe i popoli dell’Europa centrale e orientale a restare in un vicolo cieco senza futuro sotto il controllo di leader populisti. Il tempo non è molto, ma i giovani polacchi che hanno fatto arretrare la minaccia illiberale in questi ultimi giorni hanno mostrato di crederci: tocca al resto dell’Europa non deluderli.
(Traduzione di Giusy Muzzopappa)
Questo articolo è stato pubblicato dal settimanale francese L’Obs.
 Roberto Ceccarelli intervista Andrea Fumagalli, economista all'università di Pavia, sul senso antropologico del lavoro, una merce sempre più disprezzata dal capitalismo.
Roberto Ceccarelli intervista Andrea Fumagalli, economista all'università di Pavia, sul senso antropologico del lavoro, una merce sempre più disprezzata dal capitalismo.
il manifesto, 26 luglio 2017
«Indagine Ue su occupazione e sviluppi sociali 2017. "Il lavoro va considerato come un esercizio di libertà e auto-determinazione. Conta più il diritto alla scelta del lavoro che il diritto al lavoro qualunque sia. Il reddito di base e senza condizioni è la premessa di questa libertà"»
A cosa è dovuta questa crescita?
«All’aumento dell’età pensionabile, del lavoro degli over 50, del part-time involontario e della precarietà. Il dato complessivo di 234 milioni di persone al lavoro va analizzato in dettaglio. Se guardiano i dati relativi alle unità di lavoro equivalenti, ovvero la quantità di lavoro richiesta dalle imprese, questa cresce a un saggio inferiore rispetto alla crescita degli addetti. Il che significa che la quantità di lavoro resta ancora stagnante, ma aumenta la quota dei precari a scapito dei posti fissi si ha un aumento delle persone occupate ma con un livello reddituale peggiorato. In pratica il lavoro stabile viene sostituito dal lavoro precario.
Mentre in Europa la quota dei Neet diminuisce, in Italia continuano a crescere. Come si spiega questa differenza?
«In Italia il numero dei Neet (Not Engaged Education Employenent Training) è sempre stato del 60-70 per cento superiore alla media Ue, intorno a un livello del 20% rispetto alla forza lavoro complessiva. La media europea è dell’11%. In Italia la quota dei cosiddetti scoraggiati, cioè coloro che non fanno nessuna ricerca di lavoro nel periodo della rilevazione, e quindi non vengono contabilizzati nei disoccupati veri e propri, è di gran lunga superiore alla media europea. Teniamo presente che gli scoraggiati sono sopratutto giovani che hanno bisogno di lavorare perché hanno bisogno di reddito. Non sono quindi disoccupati volontari, ma non rientrano nemmeno tra i disoccupati. I Neet sono il bacino degli scoraggiati, oltre che del lavoro nero e grigio. Una recente ricerca del progetto europeo «Pie news-commonsfare.net» ha evidenziato che i giovani precari sotto i 25-26 anni non cercano effettivamente lavoro. Sono quelli che possiamo chiamare precari di seconda generazione che vivono di «lavoretti» nella «gig economy». Non vedono più nel lavoro la principale forma di realizzazione. Il loro è un rifiuto individuale del lavoro che non assume una dimensione collettiva.
Nel nostro paese si registra anche un aumento record del lavoro autonomo. Per tradizione, siamo sempre stati un paese con tante partite Iva. Oggi la partita iva è un modo per sfuggire alla precarietà o di essere diversamente precari?
«In Italia la quota di lavoratori non subordinati, detti autonomi, è pari al 23%. Buona parte è composta da partita Iva, in parte sono lavoratori individuali per conto terzi che svolgono prevalentemente un lavoro eterodiretto che spesso è l’unica possibilità immediata per avere un minimo di reddito intermittente. Quest’ultima è una forma di precarietà che ha una storia strutturale nel nostro paese.
Cosa dire ai giovani che non avranno una pensione degna?
«Le riforme pensionistiche in Italia con il passaggio al sistema contributivo hanno risolto il problema della sostenibilità economica della spesa previdenziale, ma hanno innescato una bomba sociale. In presenza di elevata precarietà lavorativa, i contributi versati non permetteranno a molti di godere di un livello di pensione superiore alla povertà relativa. Saranno costretti a lavorare finché moriranno, oppure a sperare di morire prima di andare in pensione. Questo obbligherà, a partire dal 2030, quando il sistema contributivo andrà a regime, a un intervento di sostegno al reddito per coloro che si troveranno in una situazione di povertà.
Come si spiega il boom della povertà nel nostro paese, unico caso in Europa con Romania e Estonia?
«La povertà non riguarda più solo coloro che sono fuori dal mercato del lavoro: i disoccupati e i pensionati con basso reddito. Riguarda sempre più anche coloro che sono all’interno del mercato del lavoro. Questa è la quota di poveri che aumenta di più. Per l’Istat il dato preoccupante è quello degli «operai e assimilati» che hanno un rapporto di lavoro continuato. L’incidenza della povertà sfiora il 20%, uno su cinque, contro il 33% dei disoccupati. Ciò vuol dire che il lieve incremento occupazionale in corso si coniuga con l’ampliamento della «trappola della precarietà» i cui effetti sulla dinamica della domanda e della polarizzazione dei redditi sono ormai evidenti.
Basterà il reddito di inclusione contro la povertà voluto dal governo?
«Assolutamente no. Il reddito di inclusione, finanziato con 700 milioni che saliranno a 1 miliardo e 400 nel 2018 è sottoposto a tali vincoli di accesso da far sì che solo meno del 20 per cento delle famiglie in povertà assoluta potranno goderne.
Il governo promette di aumentare i fondi…
«È difficile che tale promessa possa essere mantenuta nei vincoli di bilancio se il governo decide in modo prioritario di spendere quasi 10 miliardi di euro per vari salvataggi bancari. Bankitalia stima che tale decisione farà aumentare dell’1 per cento il rapporto debito/Pil.
La commissaria Ue all’occupazione Thyssen sostiene che l’Europa è per il reddito minimo, ma lascia ai singoli paesi la possibilità di adottare il reddito di cittadinanza. Qual è la soluzione migliore?
«La discussione sulla scelta tra reddito minimo e di cittadinanza è malposta. Il vero discrimine non è l’universalità ma l’incondizionalità: un reddito dato senza nessuna contropartita. Sarebbe più utile erogare un reddito di base pari alla soglia di povertà relativa di 780 euro al mese partendo da coloro che si trovano al di sotto di questa soglia a livello individuale con un esborso di 15 miliardi netti annui più i 9 miliardi già stanziati per gli ammortizzatori sociali. Con l’accortezza di specificare che tale reddito dev’essere il più incondizionato possibile.
In Italia non c’è né l’uno, né l’altro…
«Nel nostro paese qualsiasi proposta di legge sul reddito minimo, o di base, dev’essere accompagnata da una proposta di salario minimo orario per i non contrattualizzati. Per evitare il rischio di un effetto sostituzione tra il salario e il reddito.
Stefano Rodotà e Luigi Ferrajoli sostengono che le ragioni del reddito e del salario minimo sono affermate negli articoli 36 e 38 della Costituzione e non contraddicono l’articolo 1 sulla “repubblica fondata sul lavoro”. Ritiene che questa impostazione permetta di superare la contrapposizione tra reddito e lavoro?
«La trovo corretta. Nell’attuale contesto capitalistico, che non è quello del secondo Dopoguerra, il lavoro remunerato andrà a diminuire con l’automazione tecnologica, soprattutto nel comparto dei servizi. Il lavoro va considerato come un esercizio di libertà e auto-determinazione. Conta più il diritto alla scelta del lavoro che il diritto al lavoro qualunque sia. Il reddito di base e senza condizioni è la premessa di questa libertà.
 L'interesse dell'Europa a utilizzare le persone che fuggono dai loro deserti è simmetrico rispetto all'interesse dei migranti di trovare un'occupazione. Ma per trovare la sintesi occorre un'Europa profondamente diversa dall'UE.
L'interesse dell'Europa a utilizzare le persone che fuggono dai loro deserti è simmetrico rispetto all'interesse dei migranti di trovare un'occupazione. Ma per trovare la sintesi occorre un'Europa profondamente diversa dall'UE. il manifesto
, 26 luglio 2017
Il terrore e il furore con cui l’Unione Europea e il governo italiano affrontano l’arrivo dei profughi nascono dall’oblio del passato e dall’incapacità di guardare al futuro. I profughi che hanno raggiunto l’Europa nel 2015 (l’anno di maggior afflusso) sono meno dei migranti economici arrivati o legalizzati ogni anno prima del 2008. Con quei migranti l’Europa aveva realizzato la sua ricostruzione postbellica, il miracolo economico e conquistato la posizione di rilievo mondiale che oggi sta perdendo. Ma quel milione e mezzo è solo la metà degli abitanti che un’Europa sempre più vecchia perde ogni anno.
Così tra non molto i governi europei dovranno richiamare nei loro paesi i fratelli e i figli di quegli esseri umani che oggi cercano di far annegare nel Mediterraneo, far morire di sete nel Sahara, far schiavizzare dalle bande che controllano la Libia, far azzannare dai cani e bastonare dalle guardie alle barriere di filo spinato dei Balcani. Perché in un’Europa sempre più vecchia non sarà solo impossibile pagarsi le pensioni; un paese con pochi giovani, pochi bambini, senza gioia, senza creatività, senza iniziativa, senza capacità di confrontarsi con l’altro da sé è condannato a chiudersi e morire.
Chiusura di cui l’Italia è stata destinata a far le spese per prima: mentre il suo governo cerca di spostare i confini dell’Europa al di sotto della Libia, per non farvi entrare chi scappa da dittature, guerre o disastri ambientali, gli altri governi dell’Unione europea hanno invece spostato da tempo quei confini alle Alpi: di lì non si passa; i profughi, se proprio si devono salvare, se li tenga l’Italia.
Stanno facendo del nostro paese quello che il Governo italiano vorrebbe fare della Libia: un deposito di esseri umani a perdere, con tutto il caos che ne consegue. I rimpatri sono costosi e per lo più impraticabili; i respingimenti non ottengono altro effetto che alzare il numero dei morti. Ma se i profughi si sa solo trattenerli per un anno o sei mesi in degradanti contenitori per poi mettere per strada sia coloro a cui viene denegato che coloro a cui viene riconosciuto l’asilo, consegnandoli al lavoro nero, alla criminalità, alla prostituzione, a una clandestinità imposta per legge, allora sì, questo renderà invivibile il paese. I 180 mila profughi del 2016 non sono un gran numero per un paese di 60 milioni di abitanti. Ma con i 200 mila di quest’anno raddoppiano e l’anno prossimo saranno 600 mila o forse più, e così via; non c’è alternativa di destra – respingimenti e rimpatri – che valga: quelle alternative sono state già tutte tentate senza risultati.
Nessun dubbio che un’Unione europea come questa, dove ciascuno va per conto suo, sia destinata a crollare: messe ai margini Italia e Grecia, perso il Regno unito, sarà comunque difficile tener dentro paesi come Ungheria, Polonia e compagnia. D’altronde, un’Europa assediata dalle guerre, dall’Ucraina al Sahrawi, passando per Siria, Iraq, Afghanistan, Israele, Yemen, Sud Sudan, Libia, Ciad, Mali, Nigeria, Repubblica Centroafricana, e altro ancora, si sta trasformando in una fortezza: in cui forse non si entra più (ma c’è già abbondanza di materiale umano esplosivo al suo interno); ma da cui non si potrà neanche più uscire. O solo con le armi: a combattere contro quelle che stiamo vendendo a piene mani in quegli stessi paesi.
Nel mondo d’oggi non si può più stare da soli e per questo l’Europa va ricostituita; ma dalle fondamenta; le sue classi dirigenti non sono in grado di farlo, e nemmeno di concepirlo: hanno smesso da tempo di pensare, non vedono né passato né futuro, vivono in un eterno presente; tutt’altro che innocente. La questione dei profughi andava affrontata dall’inizio, ben prima del semestre di presidenza italiana, come una questione di tutta l’Unione, da mettere davanti a tutto il resto, come aveva cercato di prospettare, tra i tanti, Barbara Spinelli subito dopo la sua elezione al Parlamento europeo. Invece si sono persi tre anni. «Davanti a tutto il resto» non vuol dir solo corridoi umanitari ragionevolmente selettivi invece del massacro in corso, che procura guadagni e poteri immensi a scafisti, aguzzini del deserto e affiliati all’Isis.
Vuol dire rovesciare il tavolo dell’austerità. L’Europa ha bisogno di quei migranti; per integrarli deve innanzitutto offrire a loro e, insieme, ai 25 milioni di disoccupati creati con la crisi, un lavoro. Per mettere tutte quelle persone al lavoro ci vuole un grande piano di investimenti diffusi.
Quel piano è la conversione ecologica, come prescritto dagli impegni presi al vertice di Parigi. Ma è un piano che non può riguardare solo l’Europa: deve coinvolgere anche i paesi di origine dei nuovi arrivati: non si tratta di «aiutarli a casa loro», bensì di aiutarli qui in Europa (che non è casa nostra) ad aver voce e a rendersi parte attiva della pacificazione dei loro paesi in guerra; e, quando potranno tornarvi (e molti non aspettano altro), della loro ricostruzione, del loro risanamento ambientale e sociale, della loro conversione ecologica, con progetti e interventi analoghi a quelli da sviluppare qui.
E’ inutile vaneggiare di piani Marshall per l’Africa senza dir a chi sono diretti: protagonisti della rinascita di quei paesi non possono essere né le multinazionali che la stanno devastando, né i suoi governi corrotti e sanguinari che costringono a fuggire la parte migliore dei loro concittadini, ma solo una nuova grande leva di migranti e di cooperanti europei impegnati a costruire insieme non solo una nuova Europa qui, ma anche una grande comunità euro-afro-mediterranea là; aperta alla libera circolazione non dei capitali, ma delle persone e delle loro aspirazioni.

«. MicroMega, 24 luglio 2017 (c.m.c)
L’analisi di Massimo Giannini sulla sinistra divisa e minoritaria è, come sempre, impietosamente lucida. Eppure credo che non sia l’unica lettura possibile.
Essa appare, ed è, realistica, se diamo per scontato, come sempre si fa, un dato di fondo: e cioè che i rapporti di forza tra destra, sinistra e pentastellati siano, sul breve periodo, stabili. Ma se proviamo a pensare che cambi la base elettorale attiva, anche questo scenario può cambiare. In altre parole, Giannini fa quello che fanno i leaders di tutti i partiti: dà per scontato che continuerà a votare circa la metà del Paese. E che l’altra metà sia sostanzialmente perduta alla vita della democrazia italiana.
Quello che Anna Falcone ed io abbiamo provato a proporre è di cambiare occhiali: e di provare a svegliare quest’altra metà del Paese. Perché noi due, che non siamo politici, né tantomeno leaders? Perché durante la campagna referendaria del No abbiamo visto con i nostri occhi questa altra Italia, quella che non vota: l’abbiamo vista partecipare a riunioni e assemblee. E poi il 4 dicembre l’abbiamo ritrovata nelle urne.
Ovviamente non tutta la valanga dei No era di sinistra: ma una parte lo era, eccome. Voti di giovani senza più fiducia. Voti di sommersi che sentono di non avere alcun interesse a sommarsi a quelli, ben più pesanti, dei salvati. Un elettorato potenzialmente di sinistra comprese allora che si combatteva una battaglia decisiva per la partecipazione e la rappresentanza degli ultimi: un elettorato che, se tornasse a votare, potrebbe sconvolgere gli equilibri. E, allora, perché non pensare che accanto al realismo dello stato delle cose possa esserci anche un altro realismo, quello di chi vuole provare a modificarla, la realtà? Antonio Gramsci ha scritto che l’idolo più difficile da abbattere è la credenza che tutto ciò che esiste, sia naturale che esista così.
La proposta del Brancaccio è provare ad abbattere quell’idolo, costruendo una lista unitaria della Sinistra non intesa come somma dei pezzetti già noti, ma come una realtà nuova, capace di coinvolgere e rendere protagonista quest’altro mondo. Per questo non ha molto senso parlare – come fa Giannini – di ‘montanariani’ o ‘falconiani’: non abbiamo alcuna intenzione di costruire l’ennesima listina da zero virgola, e non lo faremo. Se sarà evidente che non ci sono le condizioni per una lista unica davvero profondamente innovativa (che è l’obiettivo esplicito che abbiamo indicato), il percorso continuerà come costruzione (lenta, paziente e speriamo feconda) di uno spazio politico nuovo, ma non contribuirà ad aumentare la frammentazione elettorale.
Se l’obiettivo è questo, allora forse si capisce che le categorie da usare non sono più la ‘purezza’, l’‘identità’, o il ‘rancore’. La questione è molto più pragmatica: bisogna parlare un’altra lingua, cercare altri interlocutori, abbattere le pareti della stanza chiusa dove si gioca l’asfittica partita autoreferenziale che tiene lontana dalla politica metà del Paese. Giuliano Pisapia dice di sentirsi a casa nel Pd, e Giannini scrive che egli abbraccia la Boschi perché sa di appartenere alla stessa famiglia politica della sottosegretaria. Io, invece, credo che sia un errore: non perché il Pd o la Boschi siano il male, ma perché credo che chi vuole costruire la sinistra nuova debba stare da un’altra parte.
La casa dei sommersi non può essere la stessa casa di chi ha contribuito a sommergerli. Il Pd ha avuto un ruolo decisivo nella costruzione di un Paese terribilmente diseguale e ingiusto: se vogliamo parlare alle vittime di questa diseguaglianza, di questa ingiustizia, dobbiamo cercare un’altra casa. E un’altra famiglia: perché difficilmente i milioni di giovani che hanno votato No, e che ora probabilmente si asterranno, si sentono della stessa famiglia della Boschi. Essi, insieme ad altri milioni di elettori, quando vedono la Boschi, pensano invece a un intreccio, appunto familistico, tra potere e banche: lontano mille miglia da ogni idea di giustizia o inclusione.
Insomma, accanto al realismo un po’ cinico che spinge alle alleanze dentro l’eterno recinto, c’è anche un realismo (forse più lungimirante) che spinge a uscire dal recinto. Una via che non porta subito al governo. Ma l’unica via per costruire una sinistra capace di cambiare lo stato delle cose.
 L'Italia ripudia la guerra, solo sulla Carta, ma non i lauti profitti che essa genera.
L'Italia ripudia la guerra, solo sulla Carta, ma non i lauti profitti che essa genera.
ytali, 24 luglio 2017 (p.d.)
E due. Appena pochi mesi dopo l’incontro a Riyadh della ministra della difesa italiana, Roberta Pinotti, con il suo omologo saudita, ora è stata la volta del ministro degli esteri della stessa Arabia Saudita, Adel al-Jubeir, che è stato ricevuto con tutti gli onori alla Farnesina dal suo omologo italiano, Angelino Alfano. Perché così frequenti incontri? Qual è la materia tanto interessante (e riservata: i comunicati dei due vis-à-vis si sono limitati all’annuncio e alla ovvia “cordialità”) da motivare questi insistiti rapporti? ytali un sospetto ce l’ha, e lo già manifestato più volte ancora prima della visita di Pinotti nella capitale saudita. E cioè che tanto reciproco interessamento possa avere per tema non solo i pur intensi rapporti economici (l’Italia è tra i maggiori esportatori nel paese mediorientale) ma, specificamente, gli enormi quantitativi di micidiali bombe MK82 che, con impressionante e sempre maggiore frequenza, partono dalla Sardegna, via navi-container, e sbarcano nei porti dell’Arabia.
Da qui i carichi vengono trasferiti negli aeroporti militari da dove i bombardieri della Royal Saudi Air Force partono per i raid sullo Yemen, dov’è sempre in corso una terribile guerra civile alimentata dalla coalizione a guida saudita impegnata a restaurare il governo di Hadi, deposto da una fazione avversa. Così vengono seminati morte e distruzioni che, secondo l’Alto commissariato per le Nazioni Unite per i diritti umani, i sauditi&alleati “hanno causato il doppio delle vittime civili rispetto a tutte le altre forze messe insieme, e quasi tutte in conseguenza degli attacchi aerei” partiti da Riyadh. (In uno dei bombardamenti del settembre scorso è stata anche colpita “per errore” una fabbrica italiana: “Utilizzano bomba italiane per bombardare italiani”, com’è stato detto nel successivo ottobre quando per l’unica volta la ministra Pinotti ha risposto alla Camera a un nugolo di interrogazioni sul vergognoso traffico di queste armi micidiali).
Si è detto che sono bombe italiane. Già, perché – lo ripetiamo per l’ennesima volta – le MK82 recano alcuni codici chiarissimi tra cui quelli delle due aziende italiane che le hanno prodotte: la Ims spa di Vicenza (che fabbrica gli involucri) e la Rwm-Italia spa di Domusnovas, in Sardegna, che fornisce gli esplosivi e gli inneschi per rendere “attivi” gli ordigni. E questa Rwm-Italia altra non è che una “figlia” (pur formalmente italiana) del gruppo tedesco Rwm. Ma il governo tedesco si guarda bene da intestarsi la fabbricazione delle bombe, e rispetta almeno formalmente i dettati dell’Onu e della Ue: tant’è che delega il lavoro sporco ma assai redditizio all’Italia, e così non compromette il proprio nome in un’operazione che viola le solenni raccomandazioni internazionali di non fornire armamenti di alcun genere alle parti in conflitto nello Yemen.
E Pinotti aveva confermato tutto questo. Primo: “La Rwm ha esportato [bombe] in Arabia Saudita in forza di una licenza rilasciata in base alla normativa vigente”. Secondo: “Le richieste [di esportazione] delle imprese italiane sono gestite dall’Unità per le autorizzazioni di materiale di armamento, Uama”, organo interministeriale Difesa-Esteri. Alt, per un momento. L’Uama è gestita in accordo tra Difesa ed Esteri? Ecco un punto-chiave, ecco come e perché viene avvalorato il sospetto (non solo di ytali ma, sin dall’inizio di questa storiaccia, da Famiglia Cristiana che per prima aveva pubblicato nell’autunno scorso la foto inequivocabile di uno di questi ordigni) sul motivo, almeno parallelo ad altri, dell’incontro dei governanti sauditi prima con la ministra della difesa e poi con il ministro degli esteri. Quale coincidenza, proprio i responsabili dei due dicasteri impegnati nell’Uama… Né solo questa, di coincidenza. La più grave è che proprio alla vigilia del cordiale incontro alla Farnesina, era avvenuta un’altra, ennesima spedizione delle solite MK82 – la settima o l’ottava spedizione? Se ne è perso il conto, anche perché non di tutte queste spedizioni si ha notizia dai portuali, dalle soffiate “anonime”, dalle indagini di un parlamentare sardo – dalla Sardegna verso Riyadh.
Questa volta tre tir anonimi, senza cioè intestazione della ditta di trasporto, e con l’insolita scorta di gipponi dei carabinieri e dei vigili del fuoco (quindi non bombe “inerti” come quella volta alla Camera volle sostenere la ministra Pinotti, ma bombe di cui era ammessa la pericolosità dallo stesso tipo di scorta), sono partiti da Domusnovas, all’estremo sud dell’isola, hanno percorso ben 270 chilometri lungo la statale 131 e la diramazione centrale nuorese sino a raggiungere, all’estremo nord della Sardegna, il porto industriale di Olbia per scaricare su di un cargo civile, italiano (della Moby), centinaia e centinaia di ordigni. Il cargo ha quindi attraversato il braccio tirrenico sino a Piombino dove le bombe sono state trasferite su altro mercantile, battente bandiera non italiana, che si è diretto a Riyadh.
Attenzione, per cercare di tacitare l’operazione, e a differenza di quanto era sin qui accaduto, il trasbordo del micidiale carico non è stato effettuato nel porto-canale di Cagliari (cioè vicino al Sulcis, sede della Rwm-Italia, e quindi sotto gli occhi e gli obiettivi fotografici di molti testimoni) ma all’altro capo dell’isola: quasi un agire da clandestini, in un angolo del porto più marginale della Sardegna, e questo per realizzare l’ennesima vendita di bombe ad uno stato in guerra guerreggiata con una fazione dello Yemen. Questa volta l’on. Mauro Pili, gruppo misto, ex presidente della regione Sardegna, ha segnalato alla Procura di Tempio tutta la dinamica dell’operazione, sottolineandone non solo tutta la sospetta irritualità ma soprattutto la sin troppo manifesta copertura di forze dello Stato: carabinieri, e quindi con l’ovvia autorizzazione della Difesa; e vigili del fuoco, corpo che dipende degli Interni che non possono non essere stati allertati e consenzienti.
E dire che il Parlamento europeo ha approvato qualche mese fa a larga maggioranza un emendamento (di socialisti, sinistra, verdi e liberali) ad una risoluzione che sottolinea la necessità e l’urgenza di porre fine alla guerra nello Yemen. Questo emendamento impegna l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Federica Mogherini, a lanciare una iniziativa volta a imporre a tutti i paesi comunitari un “severissimo” (l’aggettivo è testuale) embargo di armi nei confronti dell’Arabia Saudita. Nessun dubbio che l’iniziativa sia stata lanciata. Ma nessun dubbio anche, sul fatto che, per quanto riguarda l’Italia, tanto la ministra della Difesa quanto il ministro degli Esteri – nella loro qualità di corresponsabili dell’Unità per le autorizzazioni di materiale di armamento – non abbiamo raccolto il “severissimo” richiamo di Mogherini.
 Un ficcante articolo scritto per chi ritiene che «l’obiettivo fondamentale sia ricompattare il centrosinistra: discutere sui contenuti, ma per tornare uniti al governo del Paese» come ai bei tempi di Monti e Prodi.
Un ficcante articolo scritto per chi ritiene che «l’obiettivo fondamentale sia ricompattare il centrosinistra: discutere sui contenuti, ma per tornare uniti al governo del Paese» come ai bei tempi di Monti e Prodi.
La Repubblica, 24 luglio 2017
È DAVVERO una sinistra morente, quella che considera “mortale” l’abbraccio tra Giuliano Pisapia e Maria Elena Boschi. Come se quella foto scattata alla festa dell’Unità non fosse un semplice gesto di cortesia tra due personalità che pur sapendo di avere idee diverse su tante cose, sanno anche di appartenere a una stessa famiglia politica. Ma fosse invece la prova di un tradimento identitario da parte del leader destinato a guidare il Campo Progressista, che ha l’ardore e l’ardire di cingere la spalla della madrina della riforma costituzionale del governo Renzi. L’immagine di una contaminazione non solo culturale, ma addirittura antropologica, che la purezza della sinistra non può tollerare. Oggi nella lotta irriducibile contro il renzismo, come ieri nella battaglia irrinunciabile contro il berlusconismo.
Bisogna dirlo, con onestà. Renzi fa poco o nulla, per trovare un terreno comune con tutto quello che si muove a sinistra del Pd. Il manifesto macroniano del segretario appena uscito in libreria non ha certo alzato il livello del dibattito, ma semmai ha solo sparso nuovo sale sulle vecchie ferite, tra bordate contro Bersani e strali contro D’Alema, ironie contro Prodi e veleni contro Letta. La disfatta referendaria non ha prodotto nessun cambiamento di linea nel partito, che in un contesto neo-proporzionale si crogiola nel mito ostinato dell’autosufficienza. La conferenza programmatica a ottobre offerta a Orlando e un paio di poltrone in segreteria concesse a Emiliano sono solo un beffardo “brodino” propinato a una minoranza malaticcia e sempre più sofferente.
Ma la sinistra del Pd cosa sta facendo, per ricomporre questa frattura profonda e soprattutto giustificare la sua esistenza presente e futura? Poco o nulla, a sua volta. Gli scissionisti di Mdp, i reduci di Rifondazione, gli epigoni di Sinistra italiana, i civatiani, i montanariani e i falconiani: a guardare le schegge impazzite di questa infinita diaspora torna in mente la leggendaria parodia televisiva che Corrado Guzzanti fece di Bertinotti. Fausto il Rosso, che teorizzava le virtù della “sinistra pulviscolare”, capace di ridursi in polvere e così diventare inafferrabile per il nemico. La sinistra giocosa, innocente e irresponsabile, capace di cullarsi nell’eterna sindrome di Peter Pan, di trascorrere i decenni a suonare ai citofoni e poi di ricomparire dopo qualche era geologica per chiedere «mi ha cercato qualcuno?».
Pisapia, l’uomo che dovrebbe provare a federare le schegge, sarà anche un “leader riluttante”: troppo morbido, un po’ timido, quasi ambiguo. Ma sembra impresa sovrumana mettere ordine in questo caos entropico, in cui si sommano nobili ragioni ideali e indicibili ambizioni personali. Pare che nella galassia rossa si scontrino due o tre linee linee. C’è la linea di Bersani e Speranza, che criticano il Pd ma riconoscono i comuni avversari, Grillo e Berlusconi, e dunque cercano un terreno non conflittuale con la prospettiva che sia ancora possibile ricostruire una parvenza di centro-sinistra. C’è la linea di Pisapia, che teme la nascita di due liste, anche se ne vorrebbe tanto una sola, larga, estesa dai progressisti ai centristi, dai cattolici ai civici, da Zingaretti a Tabacci. Insomma, come cantava Jovanotti, “una grande chiesa / da Che Guevara a Madre Teresa”.
Poi c’è la linea di D’Alema, che è speculare a quella di Renzi: lista unica, “Izquierda unida”, da Articolo Uno a Nicola Fratoianni, magari guidata da Anna Falcone. Una lista radicalmente alternativa al Pd, che lo attacca a viso aperto in campagna elettorale, e dopo il voto si vede com’è finita. In questa lista ci sono quelli che si indignano per i “casti connubi” con Boschi. Quelli che considerano il Pd un partito di destra, da avversare come si avversava Forza Italia. Quelli che riconoscono la leadership di Pisapia solo se chiede scusa per aver votato sì al referendum. Quelli che pongono come conditio sine qua non di una ripresa del dialogo a sinistra l’eliminazione di Renzi dalla scena politica.
Nessuno sa immaginare quale linea prevarrà. Ma al di là di questa guerriglia tattica, e di fronte all’analoga impasse causata dal confuso e rissoso movimentismo di Renzi, è purtroppo evidente che sul piano della strategia questa “accozzaglia del forse” non ha ancora prodotto nulla di qualificante. Non una proposta organica, non una piattaforma programmatica, se si eccettuano le pur sacrosante ma al fondo generiche contestazioni alla buona scuola o al Jobs Act. E allora, tra il Pd che respinge con sdegno il Vinavil messo a disposizione da Prodi e i suoi carnefici che gli oppongono l’antica “diversità” da preservare, la sola colla che tiene insieme le polveri del Campo progressista rischia davvero di essere l’anti-renzismo.
Troppo, perché anche il segretario è palesemente a corto di idee e di orizzonti. Troppo poco, perché così si smarrisce l’obiettivo fondamentale che invece dovrebbe ricompattare il centrosinistra: discutere sui contenuti, ma per tornare uniti al governo del Paese. A prescindere dalle inutili nostalgie, questa è stata la virtù dell’Ulivo del ‘96 e persino dell’Unione del 2006. E questa è oggi la virtù che il Pd e i dieci piccoli indiani che si agitano alla sua sinistra stanno smarrendo. Per ragioni uguali e contrarie, e ripescando una formula coniata da Arturo Parisi dopo la caduta del primo governo Prodi, tutti gridano «meglio perdere che perdersi». Non hanno capito che stavolta, andando avanti così, riusciranno a fare tutte e due le cose.
 «Le celebrazioni Rai dei 20 anni e quella per i 25 anni della strage di via D’Amelio raccontano storie diverse. Nell’ultima versione si sfuma il ruolo della trattativa tra Stato e Cosa Nostra, depistaggi ed errori non hanno responsabili chiari».
«Le celebrazioni Rai dei 20 anni e quella per i 25 anni della strage di via D’Amelio raccontano storie diverse. Nell’ultima versione si sfuma il ruolo della trattativa tra Stato e Cosa Nostra, depistaggi ed errori non hanno responsabili chiari».
il Fatto Quotidiano, 24 luglio 2017 (p.d.)
Più ci si allontana nel tempo da un evento, più cresce la responsabilità di chi lo racconta a generazioni che non ne hanno diretta memoria. Per i 25 anni dalla strage di via d'Amelio la Rai ha creato e proposto in prima serata sulla rete ammiraglia una docufiction dal titolo Adesso tocca a me (regia di Francesco Miccichè), che combina filmati d’archivio, interviste ai protagonisti superstiti, e ricostruzioni cinematografiche di 57 giorni intercorsi fra la strage di Capaci e quella del 19 luglio 1992. Si tratta di un'iniziativa in sé degna di ogni lode; appare tuttavia istruttivo il confronto tra questa nuova produzione e l'analoga fiction Rai di cinque anni fa (I 57 giorni, regia di Alberto Negrin), che vedeva come protagonista Luca Zingaretti.
Non importa rilevare qui che la mancanza di un filo narrativo unitario rende la docufiction di oggi più desultoria e farraginosa, tanto più in quanto la commovente testimonianza dell’agente superstite Antonio Vullo, che parla in prima persona, si sovrappone a“tagli” e punti di vista diversi, nonché ai commenti fuori campo e alle interviste a posteriori dei fratelli e dei colleghi del giudice, tra cui l’attuale presidente del Senato Piero Grasso. Quel che importa è che le differenze tra le due produzioni tv sono una spia della poco confortante virata culturale intervenuta dal 2012 a oggi. In Adesso tocca a me la parola “trattativa” compare una volta sola, in bocca al procuratore Sergio Lari, senza che sia nemmeno ben chiaro a cosa si riferisca; ne I 57 giorni, invece, si tratta di una realtà evocata a più riprese, che è al centro delle preoccupazioni di Borsellino nelle ultime settimane di vita, in quanto sembra proprio l'opposizione del giudice ai contatti (non episodici) tra la mafia e pezzi dello Stato a risultargli fatale. Non a caso, nel 2012 a fianco di Borsellino si vede per lo più il giovane sostituto procuratore Antonio Ingroia (futuro artefice proprio del processo sulla trattativa insieme a Nino di Matteo e ad altri), mentre nel 2017 in quel ruolo incontriamo l’eroico poliziotto Rino Germanà (egli stesso oggetto di un attentato nel ‘92), che discute col giudice della strategia degli appalti di Cosa Nostra.
Nel 2012 i contrasti di Borsellino con il procuratore di Palermo Giammanco vengono drammatizzati in una serie di scontri violenti che rendono plasticamente gli ostacoli incontrati dal magistrato nel suo ambiente di lavoro; nel 2017 questi alterchi sono ridotti a un unico episodio, e si insiste sul peraltro indubbio favore popolare di cui il giudice godeva dopo la morte di Giovanni Falcone; la complessa partita della neonata Direzione Nazionale Antimafia, alla cui direzione, dopo Capaci, molti volevano fosse nominato proprio Borsellino, è liquidata in una sola battuta. Nel 2017 l’interrogatorio-clou condotto da Borsellino a Roma è quello del pentito Leonardo Messina, e verte sulla dinamica degli appalti mafiosi, mentre ai colloqui col pentito Gaspare Mutolo è riservato un breve per quanto intenso cameo. Nel 2012, invece, è proprio l’interrogatorio di Mutolo del 1 luglio 1992 a svelare a Borsellino dei retroscena insospettati sui legami tra mafia, politica e servizi segreti, e tramite un semplice espediente (la “mano offesa”) si fa capire che Mutolo indica a Borsellino come agente infedele dei servizi il medesimo personaggio che in quello stesso giorno egli incontra poi al ministero degli Interni è la scena madre in cui Borsellino intuisce che un pezzo dello Stato lo controlla e lavora contro di lui. Interessante caso di simmetria: nel 2012 si identificava l'agente, ma non se ne diceva il nome; nel 2017 si menziona bensì il nome dell’agente, ma non si precisa che è lo stesso che il pentito accusa così pesantemente: per le future generazioni bisognerà mettere insieme i pezzi e spiegare che si tratta di Bruno Contrada, poi condannato a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa (la recente revoca della condanna in Cassazione non interviene sul merito degli addebiti ma sulla codificazione giuridica del reato all'epoca dei fatti).
Infine, nel 2012 tutto si chiudeva con il furto misterioso dell’agenda rossa e i drammatici funerali; nel 2017 si ha il coraggio di parlare dell’infame depistaggio che per anni ha addossato la strage all'improbabile pentito Vincenzo Scarantino, finalmente assolto con tutti i co-imputati. Ma non viene chiarito il ruolo di chi a Scarantino per primo credette (o lo creò?), come il collerico questore Arnaldo La Barbera, o il procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra: quest'ultimo anzi nella fiction di oggi non compare affatto, mentre in quella del 2012 in pieno Palazzo di Giustizia veniva mandato a quel paese da Borsellino, il quale pochi giorni prima di morire reclamava invano di essere ascoltato come testimone nell’indagine su Capaci, condotta proprio da Tinebra. Né poi in Adesso tocca a me il loquace presidente del Senato Grasso, che dispensa perle di saggezza, giunge a spiegare come mai nulla accadde dopo il suo interrogatorio segreto al pentito Gaspare Spatuzza del lontano giugno 1998, nel quale - come ha mostrato Enrico Deaglio sulla base di un controverso verbale - Scarantino veniva già totalmente scagionato.
Una trattativa inesistente, un Contrada al più ambiguo, un depistaggio messo in atto da ignoti. Viene da chiedersi se la fiction del trentennale, nel 2022, partirà da queste premesse, o da altre.

. la Repubblica, 23 luglio 2017
In questo torrido e arido mese di luglio, i capi di stato del gruppo di Visegrad — la città ungherese dove nel 1991 si sono riuniti per la prima volta i rappresentanti dei paesi del centro ed est Europa — si sono incontrati a Budapest e hanno indirizzato una lettera-documento in tema di immigrazione al nostro governo. L’Italia, che si trova a presidiare molti chilometri di confini del territorio europeo, si è vista calare per bocca del leader ungherese Viktor Orbán, questo suggerimento che ha l’arroganza del comando: chiudere i porti e accettare le proposte dei paesi frondisti, che prevedono la gestione, con il sostegno dell’Ue, della politica di “protezione” dei confini europei, l’addestramento della guardia costiera libica, e nuovi codici di condotta delle Ong.
Il gruppo di Visegrad si prende una grande libertà di manovra rispetto sia a Bruxelles che a Roma. Al di là dell’insopportabile arroganza di questa lettera, alla quale Gentiloni ha risposto con giusta fermezza, è interessante comprendere il milieu ideologico nel quale è maturata. Una vecchia storia che torna attuale, come del resto le ideologie xenofobe e nazionaliste (per non dire fasciste).
L’Europa sta progressivamente acquistando due facce, riadattando un’antica divisione tra due concezioni della politica e dello spazio politico: una cooperativa e cosmopolita; una etnica e fondata su un’immaginaria identità nazionale pre-politica. Certo, questa distinzione non è così semplice perché ciascuna di esse ha avuto al proprio interno differenze non piccole, per cui anche le visioni cosmopolite si sono fatte strumento di politiche imperialistiche; e infine, nella dimensione nazionale vanno contemplate anche ispirazioni democratiche e repubblicane, come quella che aveva in mente il nostro Mazzini. Non quindi bianco e nero.
Tuttavia, le similitudini di famiglia ci sono; e riusciamo a riconoscere le fisionomie di un percorso di ispirazione cosmopolita e di un percorso nazionalista. Fino alla costruzione dell’Unione europea, quest’ultima è stata predominante e più familiare; quell’altra è restata dal Settecento quasi un sogno di visionari, associata all’illuminismo di Kant; il quale però non era un utopista, e aveva elaborato una teoria realistica su come fosse possibile coniugare pace e libertà: la nascita di governi costituzionali e di una politica limitata dai diritti (tra cui quello di uscire dal proprio paese e quindi di entrare in un altro) avrebbe mostrato l’utilità della pace anche a coloro che ragionavano solo per interessi e non per principi.
I trattati che da quello di Roma del 1957 si sono succeduti, hanno fatto dell’Europa un terreno di sperimentazione giuridica e politica della pace perpetua: i contraenti di quei patti hanno accettato di tenere i loro confini porosi, aperti ai beni e alle persone, distinguendo tra il principio della libertà di movimento e di lavoro dei cittadini dei paesi europei e il principio di accoglienza (che è principio di rispetto e aiuto non di inclusione politica) degli stranieri. Il patto di cooperazione, e poi via via di unione, ha cercato di tenere insieme questi due principi secondo criteri di convenienza e di umanità.
La condizione perché il compromesso tra interessi e principi regga nel tempo è che tutti coloro che accettano di sottoscrivere i trattati ne rispettino le ragioni e le norme. La condizione è che interessi e principi si limitino a vicenda, senza lasciare campo esclusivo a nessuno dei due, perché se il dispotismo della virtù distrugge la libertà, il dispotismo dell’interesse distrugge la cooperazione. Questo dosaggio è la condizione per la persistenza del patto tra interessi nazionali diversi e Paesi intenzionati a cooperare. La soluzione del problema europeo (che è il rischio di conflitti e guerre) si è mostrata possibile, e non utopistica, a questa condizione. Tale è il paradigma dell’Unione europea.
La divaricazione tra le due traiettorie che sta avvenendo sotto i nostri occhi, se non contrastata, può avere la forza di rovesciare la soluzione al problema europeo e di riportare al centro gli interessi nazionali come interessi divergenti e poco collaborativi. L’Europa degli ex imperi centrali e dell’ex impero comunista, di cui il populista Orbán si è fatto leader, è protagonista del risveglio della politica del filo spinato. Ma attenzione, non si tratta di una soluzione che mira a riportare le lancette dell’orologio a prima del 1957: questo nazionalismo populista è nato nell’Unione europea e si propone come una visione dell’Ue, alternativa a quella che aveva ispirato i fondatori.
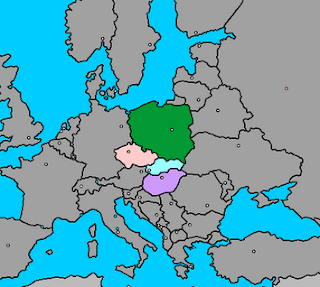 |
| Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia |
I nuovi nazionalisti non sono così anacronistici da rivendicare nazioni isolazioniste. E per questo, Orbán, il primo leader di una democrazia populista sul territorio europeo, si candida a paladino dell’Europa: i confini dell’Ungheria sono, lo ha più volte detto, i sacri confini dell’Europa cristiana.
Così la pensano anche la Polonia e l’Austria, il paese che ha visto, trent’anni fa, il primo partito di destra xenofoba adottare una strategia populista per conquistare consensi e penetrare l’opinione pubblica. La lunga strada verso l’Europa nazionalista è cominciata proprio allora, insieme alla fine della Guerra fredda. Quella di oggi non è una scaramuccia orchestrata da alcuni leader scalpitanti, ma il segno di una sterzata verso una visione del continente che ha l’ambizione di essere nazionalista e xenofoba. In questa contingenza populista, l’Italia si trova a difendere i confini di un modello di Europa contro un altro, non semplicemente del territorio nazionale ed europeo.

“
“Non c’è niente di più misterioso o di più bello di un muro. Già me lo vedo; laggiù nel prato, che si erge come un’immane barriera contro il tempo”, La musica del caso, 1990, Paul Auster.
1. Nel recente incontro tra Papa Francesco e Angela Merkel è emersa “sintonia sulla necessità di abbattere i muri”. Non è stato detto a quali, dei tanti muri già eretti o in corso di costruzione, l’auspicio si riferisca, ma è poco probabile si tratti di quello tra la Turchia e la Siria, ormai quasi completato. La gigantesca opera, che si estende lungo cinquecento cinquanta sei dei novecento undici chilometri della linea di confine, consiste in una serie di blocchi di calcestruzzo alti tre metri, larghi due e del peso di quattordici tonnellate ciascuno, sovrastati da sessanta centimetri di filo spinato e con sessanta sette torri di avvistamento.
I lavori sono iniziati nel 2014, in seguito alle pressanti richieste degli Stati Uniti e dell’Europa di chiudere la “frontiera porosa” e impedire il passaggio di estremisti e terroristi. L’allora presidente Obama aveva più volte ammonito la Turchia a fare di più per “sigillare” il confine ed ora, a sancire la complicità con l’occidente, il governo turco orgoglioso per lo stato di avanzamento del muro può dichiarare “siamo nella stessa barca con i nostri alleati, stiamo facendo del nostro meglio”. E del loro meglio si accingono a fare anche lungo i confini con l’Iran e con l’Iraq dove è stata avviata la costruzione di altri due muri, rispettivamente di settanta e novantadue chilometri.
2. I muri, che provocano sofferenza e morte per migliaia di esseri umani, sono anche grandi infrastrutture e, come tutte le grandi opere, procurano enormi profitti alle imprese che le costruiscono. I progetti dei muri turchi, coordinati dai ministeri della difesa e delle finanze, sono stati affidati a TOKI, la società di proprietà dello stato, fondata trent’anni fa per costruire case popolari e che si è espansa fino a controllare l’intero settore dell’edilizia e dell’urbanistica. Presieduta da Ergun Turan, fedelissimo di Erdogan, e posta sotto il personale controllo del primo ministro, è diventata uno dei cardini su cui si regge il regime. Ufficialmente è un ente senza scopo di lucro ma, avendo la facoltà di espropriare terreni e proprietà pubbliche e private e di cambiarne le destinazioni, ad esempio trasformando un parco in centro commerciale (come è successo a Gezi park) o distruggendo le città abitate dai curdi per rinnovarle e renderle “attraenti al turismo internazionale” (come ha fatto a Diyarbakir) il suo potere è enorme. Secondo gli oppositori, l’intoccabilità di Toki, che non è stata scalfita nemmeno dai pur numerosi scandali e accuse di corruzione, deriva dal fatto che gira i suoi profitti al governo e ai suoi amici.

3. Un muro non è una linea sulla carta, un segno topografico come dicono gli architetti, ma un manufatto tridimensionale che riconfigurando i rapporti tra chi sta da una parte e dall’altra e le loro condizioni di vita, cambia la geografia e la storia del territorio al quale viene imposto. L’intenzione della Turchia di occupare la parte settentrionale della Siria è nota da tempo e, secondo molti osservatori, di fatto il muro ha già spostato il confine. Meno attenzione, invece, è stata data ai progetti di sviluppo immobiliare di Erdogan, la cui visione per la regione, una volta “ripulita dai terroristi jihadisti e curdi”, è di costruirvi una città nuova. “Possiamo farlo in meno di un anno”, ha detto, “siamo esperti in costruzioni e infrastrutture, quello di cui abbiamo bisogno è solo un flusso costante di investimenti”. … Con un linguaggio che abilmente maschera con la retorica dell’intervento umanitario il furto della terra e i relativi grandi affari, ha concluso “oltre a case adatte alla locale tradizione architettonica, costruiremo scuole ed ospedali e così elimineremo il trauma psicologico della popolazione….. bisogna avviare una campagna internazionale per la raccolta dei fondi e poi noi siamo
 Ridurre le tasse e appiattirle non significa solo tradire il principio costituzionale della proporzionalità tra reddito e contributo alla spesa pubblica, ma provocherebbe riduzione della spesa sociale e indebolimento del potere pubblico di influire sulla direzione degli investimenti.
Ridurre le tasse e appiattirle non significa solo tradire il principio costituzionale della proporzionalità tra reddito e contributo alla spesa pubblica, ma provocherebbe riduzione della spesa sociale e indebolimento del potere pubblico di influire sulla direzione degli investimenti.
il manifesto, 22 luglio 2017
In barba a tutte le nuovistiche pretese rottamatrici, ormai è chiaro che nella politica italiana a difettare sono proprio i progetti e che la prossima campagna elettorale sarà dominata da una idea vecchia come il cucco, quale il mantra della riduzione indiscriminata delle tasse.
Riproposto nelle forme più demagogiche anche sotto le vesti di ricorso alla flat tax, un’idea che nasce dal cuore della destra ma a cui ha occhieggiato lo stesso Renzi. Questo deficit di pensiero e di ideazione è tanto più grave a sinistra, dove esso spiega ciò che altrimenti rimarrebbe inspiegabile: il cinismo con cui da tutte le parti – sia nel Pd di Renzi, sia nei fuoriusciti di Mdp, sia nella sinistra estrema – si rinunzia a costruire una coalizione larga di centrosinistra e si punta solo a strappare qualche voto all’immediato vicino dando per scontato che le elezioni siano già perse, bastonandosi di santa ragione tra più affini invece di combattere soprattutto sul piano ideale e programmatico la destra e il movimento 5Stelle (non a caso sostenente una bandiera – il «reddito di cittadinanza», che è un sussidio flat – speculare a quella della destra).
Eppure non è in alcun modo sottovalutabile la pericolosità di una proposta come la flat tax, nell’ipotesi dell’Istituto Bruno Leoni un’aliquota unica del 25% per Irpef, Ires, Iva, sostitutive ecc, associata a un trasferimento monetario agli incapienti. Perseguire una simile ipotesi porta a due esiti entrambi estremamente negativi. Il primo è una drammatica alterazione della distribuzione del reddito, già tanto disegualitaria e squilibrata, a ulteriore favore dei ricchi e a danno dei ceti medi: Baldini e Giannini su Info La voce segnalano che una coppia di dipendenti del Nord con due figli con 40 mila euro di reddito guadagnerebbe 268 euro, mentre la stessa famiglia con reddito più che doppio (80 mila) ne guadagnerebbe quasi 9 mila.
Il secondo esito negativo è una perdita di gettito (le entrate pubbliche complessive si ridurrebbero di più di 95 miliardi di euro l’anno, lo spazio di quattro-cinque finanziarie!) di tale entità da restituire attualità al motto starving the beast, «affamare la bestia governativa», sottraendogli le risorse necessarie a finanziare servizi pubblici e prestazioni sociali. Non si deve dimenticare che l’espressione entrò in auge all’epoca di Reagan, quando nella cerchia dei consiglieri repubblicani nessuno credeva che i tagli fiscali del 1981 potessero essere finanziariamente sostenibili (e in effetti non lo furono), ma si consideravano i tagli stessi come mezzi per formare disavanzi tali da affamare il bilancio pubblico, utilizzando l’«affamamento» come leva per abbattere la spesa. Il tutto nella più classica logica ostile all’esercizio della responsabilità collettiva incarnata dalle istituzioni pubbliche: «meno tasse, meno regole, meno stato, più mercato», associando l’idea che la tassazione sia intrinsecamente dannosa alla volontà di ridurre al «minimo» il ruolo degli stati e dei governi (nella proposta dell’Istituto Leoni la perdita di gettito sarebbe finanziata per due terzi con l’abolizione delle prestazioni assistenziali esistenti – assegni familiari, indennità di accompagnamento, integrazione al minimo, pensione sociale, ecc. -, per un terzo con altri tagli di funzioni pubbliche).
Dunque, le critiche che dipingono la flat tax come «ambiziosissima» ma irrealistica o intempestiva, perché troppo costosa, sono assolutamente insufficienti e non colgono nel segno. Perché non è solo questione di promesse demagogiche irrealizzabili, né è solo questione delle risorse mancanti con cui finanziare le politiche di tagli fiscali. In gioco c’è molto di più: queste politiche sono profondamente sbagliate e tali rimarrebbero anche se ci fossero le risorse per realizzarle, sia sotto il profilo redistributivo, sia sotto il profilo dell’impatto ipotizzabile sull’economia e sulla società. In primo luogo per il disorientamento culturale che ne scaturisce: le visioni neoliberiste, di cui è figlia la flat tax, infatti, hanno fatto sì che un dibattito meditato sulla tassazione scomparisse dalla scena pubblica. L’inerzia di una riflessione pubblica sulla tassazione ha prodotto quel fenomeno generalizzato per cui le scelte di politica fiscale non sembrano più appartenere alla discriminante destra/sinistra: da entrambi i lati appare dominante un unico slogan, diminuire le tasse. Così si perde di vista che il significato e il ruolo della tassazione non sono valutabili in se stessi, ma si commisurano anche e soprattutto al livello e alla qualità dei servizi di cui una società desidera disporre, i quali a loro volta, esprimono la qualità e la natura dei «beni collettivi» e dei «legami di cittadinanza» propri di quella stessa società.
Poiché, però, il dibattito sul livello e la struttura della tassazione è centrale per il processo democratico, l’accettazione della ridefinizione della questione fiscale nei termini angusti imposti dai conservatori è particolarmente dannosa per le forze di centro-sinistra. Esse, infatti, hanno bisogno per definizione di politiche attive e di offrire servizi di alta qualità e basano la loro forza sull’estensione della cittadinanza e sull’approfondimento dei legami coesivi tra cittadini e dei legami di fiducia tra cittadini e stato, l’indebolimento dei quali è, invece, provocato dalla delegittimazione della tassazione. Se ne vedono le conseguenze, in vari paesi europei, nello scatenamento di populismi che trovano impreparate le forze di sinistra e di centrosinistra.
Queste ultimi confermano la loro vitale necessità di essere e di essere percepite, agli occhi del loro elettorato, al tempo stesso più efficienti, più eque e più capaci di sollecitare il potenziale dinamico e coesivo di una società. In definitiva, Renzi non va criticato per aver conquistato «margini di flessibilità« e voler oggi rimettere in discussione il Fiscal Compact. Va criticato per aver dissipato quei margini di flessibilità (che concretamente vogliono dire finanziamento in deficit) finanziando non spesa in investimenti produttivi ma spesa corrente, fatta di tagli fiscali, decontribuzione, regalie varie. Al contrario, quello che oggi urge è un rovesciamento di lessico, di paradigma culturale, di etica pubblica che sposti il focus – dagli incentivi indiretti, i bonus, i trasferimenti monetari quali sono anche i benefici fiscali – a un grande Piano di investimenti pubblici per un nuovo modello di sviluppo di elevata qualità e ad alta intensità di lavoro, soprattutto per i giovani la cui disoccupazione rimane scandalosamente vicina al 40%.
 Benvenuta Legambiente tra gli avversari del Ceta. Ma l'accordo della globalizzazione capitalista monaccia ben più che l'agricoltura: i diritti del lavoro, la salute, la tutela dell'ambiente. La regola che vogliono è: se c'è un conflitto tra un diritto e un maggior profitto è questo che va difeso.
Benvenuta Legambiente tra gli avversari del Ceta. Ma l'accordo della globalizzazione capitalista monaccia ben più che l'agricoltura: i diritti del lavoro, la salute, la tutela dell'ambiente. La regola che vogliono è: se c'è un conflitto tra un diritto e un maggior profitto è questo che va difeso.
il manifesto, 23 luglio 2017, con riferimenti
Attenzione a sottovalutare la portata politica e le conseguenze dell’approvazione del trattato commerciale tra Canada e Unione Europea, il cosiddetto Ceta, in votazione nei prossimi giorni al Senato.
Lo dimostra, ad esempio, il modo in cui il Pd sta organizzando il voto dei suoi parlamentari, per evitare sorprese, dopo che diversi presidenti regionali, a partire da Zingaretti, Emiliano e Zaia hanno scelto di esprimere pubblicamente il loro dissenso.
Ma lo si può leggere anche dal modo con cui il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, sta rispondendo alle critiche e provando a rilanciare un dibattito sul tema della globalizzazione e contro l’isolamento e il protezionismo. Secondo il Ministro quanto raggiunto rappresenterebbe un enorme passo avanti in termini di riduzione dei dazi sulle merci scambiate e, in ogni caso, l’essenza di un negoziato sta nel raggiungimento di un compromesso.
Il non detto è però che il compromesso è stato trovato sacrificando sul tavolo negoziale l’agricoltura italiana.
Come per il Ttip – il trattato commerciale «gemello» con gli Stati Uniti, che aveva avuto prima uno stop da parte di Francia e Germania e poi uno definitivo con l’elezione di Trump – per i negoziatori nord americani due condizioni erano pregiudiziali: l’apertura dei mercati europei ai prodotti agricoli nordamericani e la garanzia sugli investimenti delle imprese attraverso arbitrati extragiudiziali. Ha un bel dire Calenda che bisogna fidarsi della controparte, in particolare quando ha il viso rassicurante di Justin Trudeau, e di chi fa la trattativa. Perché è proprio qui l’errore, nell’idea che si possa scambiare l’azzeramento dei dazi di cui beneficeranno le Pmi italiane, di per se positivo, con l’invasione di grano che ha avuto trattamenti intensivi con glifosate, vietato in Italia, di formaggi e salumi dai nomi fintamente italiani, di carni sottoposte a trattamenti con ormoni per l’accrescimento vietati da noi.
Proprio per queste ragioni si può essere contro questo accordo. I prodotti italiani sono infatti apprezzati dal Canada alla Cina per una qualità che ha dietro la forza di un modello economico e di biodiversità, fatto da migliaia di piccole imprese dell’agroalimentare che tutelano le proprie produzioni tipiche e si stanno sempre più riconvertendo al biologico. Non capire questo e rivendicare che 41 Dop italiane (su 289) saranno garantite, è davvero miope.
Anche perché questo trattato crea un precedente in termini di dumping ambientale e indirettamente sociale, oltre che di giurisdizioni speciali per le imprese che potrà essere copiato in tutti i futuri accordi con altri Paesi.
Invece di militarizzare i propri parlamentari, per evitare sorprese nel voto, il Pd dovrebbe riconoscere il grave errore politico che ha commesso nel lasciare la trattativa in mano a Calenda. Il quale, va riconosciuto, ha svolto anche in questo caso benissimo il ruolo di avvocato di Confindustria.
Ma per dirla con le parole di Michael J. Sandel, non tutto è in vendita, ha un prezzo o può essere oggetto di trattativa. Se i nostri amici Canadesi non sono disponibili a rivedere i trattati commerciali per aumentare gli scambi con l’Europa, se non a fronte di concessioni inderogabili, chi fa politica deve saper dire dei no. Ed è anche dallo stop a trattati di questo tipo che può nascere un confronto che guardi al mondo di domani, alle regole per il movimento delle merci ma anche ai diritti delle persone, evitando di dare spago a chi soffia su venti razzisti e isolazionisti.
Riferimenti
Vedi su eddyburg, tra i numerosi articoli dedicati al tema, quelli di Marco Bersani e di Alex Zanotelli
 L'interesse dell'Europa a utilizzare le persone che fuggono dai loro deserti è simmetrico rispetto all'interesse dei migranti di trovare un'occupazione. Ma per trovare la sintesi occorre un'Europa profondamente diversa dall'UE. il manifesto, 26 luglio 2017
L'interesse dell'Europa a utilizzare le persone che fuggono dai loro deserti è simmetrico rispetto all'interesse dei migranti di trovare un'occupazione. Ma per trovare la sintesi occorre un'Europa profondamente diversa dall'UE. il manifesto, 26 luglio 2017

 Ancora ostacoli alle organizzazioni umanitarie che tentano di aiutare i fuggiaschi che tcercano rifugio in luoghi sicuri. Articolo di Carlo Lania e commento diLuigi Manconi.
Ancora ostacoli alle organizzazioni umanitarie che tentano di aiutare i fuggiaschi che tcercano rifugio in luoghi sicuri. Articolo di Carlo Lania e commento diLuigi Manconi. 





 «L' Unione ancora più indebolita, sciolta in una sorta di Europa “liquida” in cui ognuno pensa al vantaggio individuale. Preoccupati solo di curare il proprio giardino nell’incapacità di amministrare l’intero parco».
«L' Unione ancora più indebolita, sciolta in una sorta di Europa “liquida” in cui ognuno pensa al vantaggio individuale. Preoccupati solo di curare il proprio giardino nell’incapacità di amministrare l’intero parco». 


 «Nel cuore della miglior tradizione europea non c’è nessuna millanteria delle origini, c’è la ricerca della verità, l’incessante indagine conoscitiva. C’è il dubbio ed è da questo cuore che partono le istanze di dignità umana e di giustizia che percorrono la storia europea».
«Nel cuore della miglior tradizione europea non c’è nessuna millanteria delle origini, c’è la ricerca della verità, l’incessante indagine conoscitiva. C’è il dubbio ed è da questo cuore che partono le istanze di dignità umana e di giustizia che percorrono la storia europea».  Un resoconto sul rastrellamento degli immigrati "illegali'"nell’era Trump. Storie di ordinaria persecuzione quotidiana: ma la California non è d'accordo,
Un resoconto sul rastrellamento degli immigrati "illegali'"nell’era Trump. Storie di ordinaria persecuzione quotidiana: ma la California non è d'accordo,