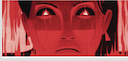il Fatto Quotidiano,
Nel 2014, per la prima volta, la Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge elettorale. In nome del principio della continuità dello Stato la sentenza non ha travolto deputati e senatori eletti l’anno precedente, ma ha comunque sancito espressamente la rottura del rapporto di rappresentanza tra i parlamentari e il corpo elettorale. In poche parole, ha sancito la non rappresentatività del Parlamento attualmente in carica.
Ciononostante, la maggioranza parlamentare non si è fatta scrupolo di abusare dei numeri che l’avevano incostituzionalmente resa tale, riscrivendo a proprio vantaggio le regole del sistema istituzionale. Un tentativo vanificato da un doppio fallimento: la bocciatura referendaria della riforma costituzionale e l’incostituzionalità anche della nuova legge elettorale.
Oggi, incredibilmente, ci risiamo. Ancora una volta una maggioranza parlamentare non rappresentativa degli italiani prova a imporre una legge elettorale segnata da astuzie e forzature: mancanza di un chiaro principio ispiratore, divieto del voto disgiunto, ripartizione pro-quota del voto maggioritario tra i partiti della coalizione nel proporzionale, ritorno delle liste-civetta, candidature plurime, liste bloccate… Alla base, un patto apertamente rivolto a danneggiare le forze politiche lasciate escluse e a privare i cittadini del potere di determinare la composizione del futuro Parlamento. Il risultato che si va costruendo sotto i nostri occhi è talmente artificioso e incomprensibile che gli stessi fautori della legge non hanno potuto evitare il ridicolo di prevedere l’inserimento nella scheda elettorale di istruzioni per l’uso agli elettori!
Da più di dieci anni i partiti elaborano leggi elettorali rivolte non ai cittadini, ma esclusivamente a se stessi. Non mirano a valorizzare la volontà popolare, ma a distorcerla a loro favore. Non si interrogano su quale strumento sia più adeguato alle esigenze sociali, ma su quello più utile ai loro regolamenti di conti. È ora di dire basta.
I vertici istituzionali hanno il dovere di garantire il corretto rispetto delle regole della competizione politica. Vogliamo credere che questa volta le presidenze delle Camere sapranno difendere il dettato costituzionale respingendo l’inammissibile pretesa del governo di apporre la fiducia sulla legge elettorale. E vogliamo credere che questa volta il Presidente della Repubblica non accetterà di farsi coinvolgere in un’operazione finalizzata, a pochi mesi dal voto, a predefinire incostituzionalmente il risultato delle elezioni a discapito della volontà degli elettori.

il Fatto quotidianola Repubblicail manifesto, 11 ottobre 2017. Tre opinioni sulla nuova legge elettorale che voglionopropinarci: Marco Travaglio, Enzo Mauro, Andrea Fabozzi. In calce un link da utilizzare per esprimere il vostro dissenso
il Fatto Quotidiano
UN NUOVO 4 DICEMBRE
di Marco Travaglio
Un governo illegittimo, sostenuto da una maggioranza fittizia figlia di una legge elettorale incostituzionale e spalleggiato da un capo dello Stato eletto da quella falsa maggioranza e già firmatario di una legge elettorale incostituzionale, impone la fiducia a se stesso su una nuova legge elettorale incostituzionale senza averne il potere (la legge non è di iniziativa governativa, ma parlamentare) per impedire al Parlamento di discutere, emendare ed eventualmente bocciare una norma studiata a tavolino da quattro partiti per favorire se stessi e far perdere le elezioni alla prima forza politica del Paese (il M5S) e alla sinistra non allineata, e per consentire a un pugno di capi-partito di nominarsi i due terzi delle prossime Camere, truccando le regole del gioco a pochi mesi dalle urne in barba alla raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2003 (citata anche da sentenze della Corte di Strasburgo) di non modificare le leggi elettorali nell’ultimo anno prima delle elezioni. Stiamo parlando della legge “nostra” per antonomasia: quella che regola il diritto di voto, la sovranità popolare sancita dall’articolo 1 della Carta e ora confiscata dai partiti come “cosa loro”.
I precedenti di un voto di fiducia sulla legge elettorale sono, nell’ultimo secolo, appena tre e tutti poco rassicuranti: il primo sulla legge Acerbo del 1923, che assicurò a Benito Mussolini una maggioranza in Parlamento che non aveva nel Paese; il secondo sulla cosiddetta “legge truffa” del 1953 (un modello di democrazia al confronto degli ultimi obbrobri: assegnava un piccolo premio di governabilità a chi si aggiudicava il 50% dei voti più uno); il terzo nel 2015 sull’Italicum, poi dichiarato incostituzionale dalla Corte. Infatti ieri è inorridito persino Napolitano, il che è tutto dire. Nemmeno B. aveva osato tanto nel 2005, quando impose il Porcellum, anche lui alla vigilia del voto. E dire che la legge Calderoli, portando la firma del ministro delle Riforme, era di iniziativa governativa, così come l’Italicum firmato dieci anni dopo dalla ministra Boschi: dunque in quei casi, per quanto forzata, la fiducia un senso poteva averlo. Stavolta il governo Gentiloni si era volutamente e dichiaratamente tenuto fuori dalla legge elettorale, infatti il Rosatellum-1, il Tedeschellum e il Rosatellum-2 sono stati tutti di iniziativa parlamentare. Il Rosatellum prende il nome dal capogruppo del Pd alla Camera, previo accordo con Pd, Ap, FI e Lega: due forze di maggioranza e due di opposizione. Che c’entra il governo Gentiloni?
E perché mai chi del Rosatellum non condivide il metodo (l’accordo con B. e Salvini) o il merito (coalizioni finte e solubili, nominati à gogo, niente voto disgiunto, 6 pluricandidature) dovrebbe affossare il governo? E quali cause di forza maggiore giustificano la fiducia per approvarlo in blocco, senza emendamenti né dibattiti, visto che il Parlamento ha il tempo e i numeri per votarlo con le normali procedure? E che fine hanno fatto i moniti del Quirinale contro gli abusi di fiducia anti-Parlamento?
Dinanzi a questo sterminio della democrazia parlamentare e della legalità costituzionale, ci sarebbe da attendersi una reazione delle istituzioni di garanzia, a cominciare dal presidente della Repubblica, che invece tace e acconsente (a parte i fervorini ai giudici che osano ancora aprire bocca). E dai presidenti di Camera e Senato, che già avallarono la fiducia all’Italicum, ma che ora – visto quel che stabilì la Consulta – dovrebbero pensarci bene prima di perseverare. I loro poteri – lo sostiene un gruppo di giuristi interpellati da Libertà e Giustizia – consentono di rifiutare la messa in votazione della fiducia. Se invece ignoreranno un’altra volta la legge dello Stato per piegarsi alla legge del più forte, passeranno alla storia come i complici di una stagione incostituzionale senza fine. Si leggano il presidente emerito della Consulta Gustavo Zagrebelsky, nell’ultima intervista a Silvia Truzzi sul Fatto: “Immaginiamo che si approvi una nuova legge elettorale in prossimità del voto e che questa legge sia incostituzionalissima, addirittura per contrasto evidente con i precedenti della Corte. Le procedure non consentirebbero di rivolgersi a essa in tempo utile. Si voterebbe con quella legge e le nuove Camere resterebbero in carica tranquillamente, ma incostituzionalmente, in virtù del principio di continuità… I politici eletti avevano tutto l’interesse a terminare il mandato parlamentare. Con la conseguenza aberrante che le sentenze della Corte non hanno sortito effetto e il gioco può essere ripetuto all’infinito: basta votare la legge quando non è più possibile ricorrere contro i suoi vizi”. Chiamatelo regime, o fascismo 2.0, o come volete. Ma una cosa è certa: la democrazia parlamentare è un’altra cosa, anzi è l’opposto. E pensare che questi impuniti hanno appena approvato la legge Fiano per rivietare il fascismo e magari abbattere qualche obelisco del Duce, salvo poi calcarne le orme con lo stesso Fiano relatore.
Chi condivide la nostra denuncia può fare molto in queste ore decisive. Aderire sul sito del all’appello anti-Rosatellum (80 mila firme in 10 giorni). Tempestare di email e messaggi sui social Laura Boldrini perché blocchi la fiducia e i parlamentari del Pd perché abbiano il coraggio di opporsi. Scendere in piazza Montecitorio oggi alle 13 con i 5Stelle e poi sempre a Roma in piazza del Pantheon alle 17.30 con Bersani (Mdp), Anna Falcone e le altre sinistre, per dire No alla deriva autoritaria e Sì alla sovranità popolare. Come al referendum del 4 dicembre 2016: anche un anno fa ci credevano pochi e rassegnati, invece fummo 19.420.271. E stravincemmo.
la Repubblica
UN COLPO DI MANO
di Ezio Mauro
NON è un colpo di Stato, come urlano i grillini in piazza, ma questa decisione del governo di mettere la fiducia sulla legge elettorale è un colpo di mano: gravissimo per la materia delicata di cui tratta (una materia di garanzia per tutti) e per il momento in cui avviene, a pochi mesi dalle elezioni politiche.
Giunge così a compimento nel modo peggiore una vicenda emblematica dell’impotenza dell’intero sistema politico, e della vacuità della legislatura tutta intera, e cioè l’incapacità del Parlamento e dei partiti di trovare un’intesa alla luce del sole che doti il Paese di una regola elettorale non basata su furbizie contingenti e vantaggi di parte, ma su un meccanismo in grado di restituire ai cittadini la piena potestà di scegliere i loro rappresentanti, con una regola riconoscibile dagli elettori e riconosciuta dall’intero sistema, capace di durare nel tempo al di là dei calcoli miopi di breve periodo. Restituendo così al meccanismo della rappresentanza quella stabilità e quella neutralità che sono parte indispensabile della fiducia nella politica e nelle istituzioni, oggi perduta.
C’è una contraddizione logica nel chiamare indecentemente in causa nell’atto finale il governo che non è intervenuto nel percorso della riforma - Gentiloni lo aveva sempre escluso, dunque deve spiegare cosa l’ha convinto a cambiare idea - perché faccia scattare il lucchetto della fiducia, troncando il confronto parlamentare per paura delle imboscate nascoste nel voto segreto.
PROPRIO lo spettro dichiarato dei franchi tiratori, che agita questa legge elettorale come i fantasmi abitano i castelli d’Inghilterra, è la prova patente di quanto poco i partiti-padri di questa legge si fidino della sua capacità di convincere e coinvolgere i loro parlamentari, come capita ad ogni confisca di sovranità politica da parte dei vertici più ristretti.
C’è poi una contraddizione tutta politica, clamorosa e sotto gli occhi di tutti: cosa c’entra un patto di maggioranza (riconfermato e blindato a forza con il voto di fiducia) con un provvedimento che nasce trasversale, a cavallo tra gran parte dell’area di governo e una certa opposizione, anzi per dirla tutta da un’intesa tra il Pd e Forza Italia con il concorso interessato della Lega e del partitino di Alfano? In questo modo si svilisce anche l’istituto parlamentare e lo stesso voto di fiducia, uno dei momenti più significativi del rapporto tra il governo e le Camere: qui invece ridotto a puro espediente tecnico, dove non è in gioco la fiducia e nemmeno il governo, ma entrambi diventano puri strumenti servili di un consenso indotto e forzato, con la destra che esce dall’aula per far passare in un giorno pari la fiducia ad un governo a cui si oppone nei giorni dispari.
L’ultima contraddizione - in realtà la prima - è del Pd, il partito che regge la maggioranza, il governo e ha chiesto la fiducia. In epoca di crisi conclamata della rappresentanza, queste operazioni servono solo a testimoniare un arrocco di forze politiche spaventate per un’autotutela ad ogni costo, dando fiato ai partiti antisistema che quanto più sono incapaci di produrre politica in proprio, tanto più ricevono forza dagli errori altrui. Avevamo sempre chiesto una legge elettorale: ma non a qualsiasi costo. Non con il capolavoro di un voto che sembra costruito apposta per creare sfiducia.
TRE FIDUCIE, POI ALTRE TRE
di Andrea Fabozzi
«Legge elettorale. Cambia la maggioranza, a chiedere la fiducia sul Rosatellum sono il Pd con Forza Italia, Lega e Ap. Gentiloni "non era entusiasta" ma si adegua grazie alla copertura del Quirinale. Mattarella preoccupato soprattutto di andare al voto con le attuali leggi non omogenee. Renzi vuole andarci presto e per questo la forzatura, sulla quale potrebbe essere chiamata presto la Corte costituzionale, si ripeterà al senato»
Non si sente niente. Quando la presidente della camera Boldrini dà la parola alla ministra Finocchiaro per consentirle di porre la questione di fiducia sulla legge elettorale, dai banchi M5S si urla «venduta» e si lanciano fascicoli e rose rosse («per simboleggiare la morte della democrazia»), dai banchi di Sinistra italiana e Mdp si grida «vergogna». La ministra fa la sua comunicazione resistendo a un tentativo di placcaggio di La Russa, poi quasi scappa via. Si vede che non è contenta, nei giorni scorsi aveva lasciato intendere che la fiducia non era necessaria, appartiene alla corrente del ministro Orlando che è l’unico ad aver sollevato dubbi nel governo.
Gentiloni, che per mesi ha ripetuto di voler solo «seguire» e «spronare» il lavoro del parlamento sulla legge elettorale, «non era affatto entusiasta» della richiesta di mettere la fiducia arrivata dal Pd, per conto anche di Forza Italia, Lega e Ap. Il racconto è del capogruppo democratico Rosato e l’auto-retroscena fa parte dell’accordo con il capo del governo: il Pd mette in scena con il massimo della teatralità una richiesta prevedibile, perché già sperimentata con l’Italicum. Da Mattarella, oggi come allora, arriva il via libera, con una nota in cui si liquida la questione fiducia come «attinente al rapporto parlamento governo» ma si insiste sul valore positivo della riforma elettorale.
Il comunicato del Colle è identico a quello con cui due anni fa Mattarella non si oppose alla fiducia sull’Italicum, deludendo le opposizioni (anche, all’epoca, Forza Italia e Lega). In più adesso c’è la preoccupazione del presidente della Repubblica per un risultato elettorale affidato alle due leggi «non omogenee» consegnate dalla Consulta (risultato che toccherà a lui gestire) e la considerazione che ancora più pesante, perché senza reali precedenti, sarebbe stato un decreto elettorale. Sotto l’ombrello del Quirinale si posiziona anche la presidente Boldrini – «la fiducia è una prerogativa del governo» – che due anni fa aveva riconosciuto «una logica» a chi faceva notare come per il regolamento della camera non si possono chiedere fiducie quando è prescritto il voto segreto, che è sempre possibile sulle leggi elettorali.
Non mancano altri argomenti, visto che l’articolo 72 della Costituzione impone «la procedura normale di esame e approvazione» per le leggi elettorali. In questo caso gli unici due precedenti contrari precedenti all’Italicum non fanno testo, perché uno risale al fascismo (legge Acerbo) e l’altro alla legge «truffa» quando l’ostruzionismo bloccava l’aula e il presidente del senato si dimise. È infatti il precedente dell’Italicum a consentire la nuova fiducia. Allora Napolitano non era più al Quirinale, ma caldeggiò la fiducia malgrado anche quella legge contenesse l’indicazione del «capo della forza politica» che, adesso il presidente emerito ha chiesto di correggere. Fuori tempo massimo e invano.
Perché non ci sarà nessuna discussione sugli emendamenti, soprattutto quelli a voto segreto (un centinaio) che avrebbero potuto fermare il Rosatellum. Oggi le prime due fiducie, domani quella sull’articolo tre – una delega che in pratica il governo dà a se stesso per ridisegnare i collegi – e i voti sugli ultimi due articoli (senza rischi, contengono norme favorevoli a Mdp sulla raccolta delle firme). Poi, forse venerdì, il voto finale. Inevitabilmente segreto, ma che preoccupa meno il Pd rispetto agli emendamenti. Il margine di vantaggio è ampio, circa duecento voti.
Proprio l’inevitabilità alla camera dell’ultimo voto segreto, dove i franchi tiratori potrebbero conquistare il bottino pieno, abbattendo la legge, aveva alimentato gli scetticismi sulla fiducia. La giornata di ieri ha chiarito che la vera ragione di questa mossa è quella di fare presto, per ripetere lo stesso aut aut ai senatori. Dai primi di novembre – orientativamente dalla settimana che comincia il 6, ma anche in questo caso è il governo che dà le carte – il senato sarà in sessione di bilancio; l’obiettivo del Pd è di far approvare definitivamente la legge, ancora con la fiducia, entro quella data. Servirà un’altra corsa, una settimana di lavoro in commissione e una in aula.
I numeri con cui ieri a palazzo Madama è passata la legge europea (solo 118 sì) testimoniano la difficoltà. Se alla camera i berlusconiani non hanno dovuto votare la fiducia, al senato l’assenza al momento della chiama potrebbe non dare sufficienti garanzie.
Ma è un altro il rischio che governo e maggioranza accettano di correre, approvando ancora una legge elettorale con la fiducia. È vero che la precedente, l’Italicum, non è stata sanzionata dalla Corte costituzionale per questa ragione (lo è stata com’è noto per altre) ma solo perché nessun tribunale aveva sollevato il problema davanti ai giudici delle leggi. Che anzi, rifiutando di auto assegnarsi il quesito, nulla avevano detto sulla pertinenza di questo genere di dubbi di costituzionalità. Accade adesso che già venerdì (a Messina) e poi per tutto il mese di ottobre, quattro tribunali (gli altri sono Lecce, Venezia e Perugia) potrebbero accogliere queste nuove osservazioni sollecitate dall’avvocato Besostri. Il problema della fiducia sulle leggi elettorali, allora, può arrivare comunque alla Consulta. A ridosso delle prossime elezioni
Il Fatto Quotidiano ha lanciato una petizione per chiedere che gli elettori possano scegliere i parlamentari: finora le firme raccolte sono 79mila (clicca qui per firmare).

il manifesto,
La storia è nota: l’Africa è povera e ha bisogno dell’aiuto dei paesi ricchi. E se le potenze occidentali hanno sfruttato il continente con la schiavitù, il colonialismo e il saccheggio delle risorse naturali, è stato in passato. Oggi sono generose, determinate a eliminare la povertà e a promuovere lo sviluppo sostenibile. Ma questa favoletta, che i paesi ricchi ripetono fino alla nausea, è piuttosto ingenua. Sappiamo da un pezzo che l’Africa è «creditrice netta» rispetto al resto del mondo. L’ammontare di risorse finanziarie accumulate all’estero grazie alla fuga di capitali negli ultimi decenni supera di molto le risorse che vanno nell’altra direzione, compresi gli aiuti e il debito. Ogni anno si prelevano dal continente fra i 30 e i 60 miliardi di dollari, secondo un rapporto diffuso nel 2015 dal Gruppo di alto livello sui flussi finanziari illeciti (High Level Panel on Illicit Financial Flows) creato dalla Commissione economica dell’Onu per l’Africa (Uneca), presieduto da Thabo Mbeki, ex presidente del Sudafrica. E si tratta di stime al ribasso.
In cosa consiste questa emorragia che gli specialisti chiamano «flussi finanziari illeciti»? Intanto, ovviamente, si compone di attività criminali di ogni tipo (droghe, traffico di armi, ecc.), alle quali si aggiunge il riciclaggio di denaro legato alla corruzione. Inoltre le compagnie multinazionali facilitano flussi finanziari illeciti in uscita manipolando transazioni commerciali. Fatture false,
transfer pricing, pagamenti fra case madri e loro sussidiarie, meccanismi di elusione fiscale allo scopo di nascondere redditi sono pratiche comuni da parte delle compagnie, nel loro sforzo di massimizzare i profitti. È comune il ricorso sia all’evasione fiscale (che è illegale) che all’elusione fiscale, grazie alle scappatoie legali offerte dal sistema di tassazione internazionale.
La fuga di capitali è un fenomeno globale. Per anni, i paesi sviluppati hanno ritenuto che il problema dei flussi finanziari illegali fosse prima di tutto una faccenda di lotta contro il terrorismo, il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari. Ma di recente, in un periodo di grande pressione sui bilanci nazionali, i governi delle economie avanzate hanno moltiplicato gli sforzi per combattere anche l’evasione da parte delle aziende. Questo in parte spiega per esempio la battaglia in corso in Europa: paesi come la Francia e la Germania sono stanchi di vedere i colossi del digitale come Google, Apple, Facebook e Amazon aggirare gli obblighi fiscali spostando i profitti in Irlanda o Lussemburgo.
Ma l’impatto della fuga di capitali sui paesi in via di sviluppo, in particolare sull’Africa, è di gran lunga più devastante. Nel continente africano le entrate fiscali sono già molto basse: in media il 17% del Prodotto interno lordo (Pil), rispetto al 35% dei paesi ricchi. E le autorità fiscali non hanno risorse sufficienti per contrastare le strategie sempre più sofisticate, sempre più aggressive messe in atto dalle multinazionali per evadere le tasse; per non parlare dei meccanismi di corruzione che coinvolgono i politici locali. Il costo umano e sociale degli abusi relativi alle imposte societarie è gigantesco. Significa infatti meno risorse per infrastrutture, istruzione, salute, alimentazione, protezione dei diritti delle donne, programmi ambientali. Non per nulla le Nazioni unite hanno dichiarato che i flussi finanziari illeciti sono un grave ostacolo al finanziamento dello sviluppo e dunque al raggiungimento degli Obiettivi dello sviluppo sostenibile.
In questo contesto, la Commissione indipendente per la riforma della tassazione delle imprese multinazionali (Icrict) ha chiesto alle Nazioni unite uno sforzo per combattere l’evasione fiscale da parte delle transnazionali come parte di una più ampia strategia di lotta contro i flussi finanziari illeciti. È una lotta che richiede l’impegno da parte degli Stati e della comunità globale per migliorare la trasparenza dei sistemi finanziari e del commercio internazionale, e per consolidare le capacità delle amministrazioni fiscali nazionali. Questo significa, fra l’altro, obbligare le imprese a rendere pubblici i dettagli delle loro attività in ognuno dei paesi dove operano, per far sì che tutti i profitti siano debitamente tassati nel paese dove si svolgono effettivamente le attività produttive e commerciali. E significa anche monitorare tutti i fattori e gli attori che rendono possibile la fuga dei capitali, in particolare le banche che aiutano a nascondere le risorse finanziarie illegalmente succhiate via, a danno dell’Africa.
Léonce Ndikumana è docente di economia e direttore del Programma per la politica di sviluppo dell’Africa presso l’Istituto di ricerca di economia politica all’università del Massachusetts. È commissario della Commissione indipendente per la riforma della tassazione delle imprese multinazionali (Icrict).
Questo articolo esce oggi in una dozzina di paesi diversi in occasione dell’inizio a Nairobi della conferenza sui flussi finanziari illeciti e il loro impatto sullo sviluppo dell’Africa.

la Repubblica
Guai a considerare il latino una lingua morta. Il primo striscione che gli operai dell’Ilva stringono fra le loro mani recita “Pacta servanda sunt”. E mica latino maccheronico, ma addirittura una perifrastica (passiva) per ricordare che i patti firmati a suo tempo vanno rispettati.
La rabbia di Genova si sveglia all’alba. Alle cinque del mattino sono già in mille dentro la fabbrica di Cornigliano, la stessa che a fine maggio ha ospitato Papa Francesco in vista pastorale, che qui aveva parlato di “dignità del lavoro”. «Eccola la risposta alle parole del Papa, quattromila esuberi e diecimila riassunti con il Jobs Act» spiega Ivan. «Ivan di nome, incazzato di cognome» aggiunge quando i mille dalla fabbrica sono già usciti in strada e iniziano a marciare verso il centro, destinazione finale la Prefettura.
I numeri degli tagli sono minori di quelli di Taranto, ma non la voglia di urlare tutto il proprio no a un piano che qui, a Cornigliano, cancella seicento operai su millecinquecento, il 40% della forza lavoro e, di fatto, azzera l’accordo di programma. Eccolo “il patto”, o meglio “i patti” dello striscione latino. Qui l’accordo di programma si ripete come un mantra, mentre gli operai camminano lenti dal ponente operaio fino al centro borghese della città. Con loro ci sono i camalli del porto, ma anche i vigili del fuoco, e tanti altri.
E poi c’è la chiesa, con i cappellani del lavoro che ogni settimana si chiudono in fabbrica a parlare con gli operai. La linea l’ha data per primo il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, che ha chiesto di “trattare fino allo strenuo”. Gli operai parlano di lui e delle sue parole. «È uno di noi quando c’è da parlare di lavoro» spiega Luca che si è fermato a bere un caffé con un amico. Davanti a tutti cammina un “Hyster”, gigantesco mezzo meccanico da 65 tonnellate usato per spostare i rotoli d’acciaio che a Cornigliano arrivano da Taranto a Genova via treno o via mare per essere lavorati e trasformati in prodotti finiti.
Un tempo anche qui a Cornigliano si produceva l’acciaio, ma nel 2005 l’altoforno, dopo anni di battaglie fra ambiente e lavoro, è stato chiuso. È allora che è nato l’accordo di programma, un’intesa fra governo, azienda e sindacati che scrivendo la parola fine alla “colata continua” manteneva però i posti di lavoro in attività “a freddo”, di laminazione dell’acciaio. All’epoca il padrone delle ferriere si chiamava Emilio Riva. I conti li faceva ancora con il “lapis”, lui che si era diplomato in ragioneria alle serali e che aveva iniziato nel dopoguerra vendendo rottami. L’Emilio con i lavoratori si scontrava, ma poi li portava in trattoria al Sassello e tornava la pace. In quel 2005 si sancì che nessuno sarebbe più uscito dalla fabbrica, se non di sua volontà.
All’epoca i dipendenti erano 2.200, oggi sono 1.500 e la differenza l’hanno fatta prepensionamenti ed esodi agevolati. Di quei millecinquecento, quattrocento sono in cassa integrazione, ma la speranza era che una nuova proprietà interessata a investire su Cornigliano per aumentare la produzione desse anche a chi era fuori la possibilità di rientrare. Certo, nessuno si aspettava una passeggiata, ma all’annuncio dei 600 esuberi Cornigliano non ha atteso un secondo per far esplodere la sua rabbia. «Più che una lettera, quella di AmInvestCo è una provocazione – spiega Ivano Bosco, segretario della Camera del Lavoro di Genova, sindacalista-operaio che ha iniziato poco più che ragazzo a difendere i suoi colleghi ai bacini di carenaggio del porto – Seicento fuori, tutti gli altri licenziati e riassunti senza scatti d’anzianità e integrativi. Si può considerare una proposta?».
Ora il governo ha dato un colpo di freno, in attesa di un piano più dettagliato, che tenga conto degli accordi stabiliti a suo tempo. Davanti alla Prefettura, più d’uno ricorda di quando, chiuso l’altoforno, Emilio Riva avesse proposto la costruzione di un forno elettrico, per rifare l’acciaio senza più inquinare l’ambiente. Ma non se ne fece nulla.

il Fatto quotidiano, 10 ottobre 2017.
Esce Pisapia, entra la “sinistra del Brancaccio”. All’indomani della rottura con l’ex sindaco di Milano, lo scenario si aggiorna: Tomaso Montanari e Anna Falcone presentano la loro iniziativa con una conferenza nella sede di Stampa Romana. “Vogliamo la sinistra che non c’è”, dicono. Ovvero: una lista civica, nata dalla battaglia in difesa della Costituzione e costruita dal basso. Da fare anche insieme ai partiti – da Mdp fino a Rifondazione comunista – purché non siano i partiti a guidarla. Stelle polari: gli spagnoli di Podemos e i laburisti di Jeremy Corbyn.
Falcone e Montanari, insomma, vogliono contribuire alla nascita della lista unitaria – di cui si parla ormai da mesi – ma solo alle loro condizioni. Lo storico dell’arte lo spiega con una battuta. Neanche a dirlo, su Massimo D’Alema: “Abbiamo perso tanti mesi a discutere su chi dovesse guidare l’autobus (Pisapia, ndr), non è il caso di perdere tempo anche sui passeggeri”. Un messaggio feroce: se qualcosa può nascere a sinistra, i partiti non devono guidare un bel niente. D’Alema e Bersani sarebbero “passeggeri” e non conducenti. “Chi ha già avuto a lungo incarichi politici – spiega – potrebbe fare un passo di lato”. Montanari (forse involontariamente) utilizza la stessa, identica espressione di Pisapia su D’Alema. Ieri, per inciso, l’ex premier è stato omaggiato anche da uno dei suoi nemici storici: Achille Occhetto, l’uomo della svolta dal Pci al Pds, era di passaggio alla Camera. Interpellato su D’Alema, ha sibilato: “L’Italia è ancora nelle mani di un serial killer”… La replica del lider Maximo a Montanari arriva nel pomeriggio, da Milano.
Con la proverbiale ironia: “C’è chi mi chiede un passo in avanti, chi indietro e chi di lato. Sembra di essere alla scuola di tango”. D’Alema è in versione battutista: “Pisapia ha detto di volersi accordare con Renzi. Se non ci riesce ci siamo noi. Ma tra noi e il Pd, Giuliano rischia di stare stretto: non vorrei che alla fine sia lui a fare un partitino, che magari prende il 3%…”. Poi però si fa più serio: per l’ex sindaco, dice, le porte sono ancora apertissime. Viste le cronache di questi giorni, è una notizia: “Pisapia rimane il primo interlocutore”. E aggiunge: “Il nostro è un processo aperto. Speriamo possa starci anche Campo progressista”.
Quella che è stata raccontata come una rottura, dunque, potrebbe non essere ancora tale. Al massimo un’accelerazione: “Non si poteva continuare a tergiversare – spiega D’Alema – perché le elezioni sono vicine e andare avanti senza avere né un nome né un simbolo non sarebbe stato giusto. Così ci ha pensato Roberto Speranza”. Lo stesso Speranza che D’Alema definisce “leader” della nuova sinistra.
La confusione, nell’universo al di là del Pd, continua a regnare. Ricapitolando: c’è la proposta civica di Falcone e Montanari, la rottura (o presunta tale) con Pisapia, le ondeggianti posizioni dei padri nobili di Mdp, le richieste di Pippo Civati e Nicola Fratoianni. Il famoso “campo largo” per adesso è ancora un campo di battaglia.
Se ne capirà qualcosa in più in vista del 19 novembre, la data indicata da Speranza per l’assemblea fondativa. Fondativa di cosa, non si sa: sarà la costituente di Mdp o l’atto di nascita di una nuova lista unitaria? Risponde Speranza: “Sarà aperta a tutti coloro che vogliono costruire un’alternativa progressista alle politiche sbagliate di Renzi”. Chi vivrà, vedrà.
postilla
Difficile immaginare che si possa essere così vecchi come dimostra di esserlo la vecchia sinistra. Pensare che D'Alema, Bersani e Pisapia possano vincere contro la lista che scaturirà dall'"Alleanza popolare democrazia e giustizia" rientra nel campo delle possibilità, pensare invece che possano stare insieme di fronte agli elettori significa non aver compreso nulla. Se non lo hai letto, scorri l'articolo Una tesi sulla sinistra.

la Repubblicaevoca «un lungo passato di servaggio femminile di cui solo di recente abbiamo recuperato la consapevolezza, ma ci costringe ugualmente a ricordare che per molte donne il Medioevo non accenna a finire».
Maria Serena Mazzi, Donne in fuga. Vite ribelli nel Medioevo, ( Il Mulino, pagg. 180, euro 14)
«Io t’amaçerò se tu non stai cheta e ferma, e lascimi usare techo a qualunque modo io voglio», ripeteva, tra una percossa e l’altra, un maestro muratore lombardo alla moglie Leonarda, colpevole di non lasciarsi sodomizzare. La frase figura negli atti del processo tenutosi nel 1477 a Firenze, città natale della malcapitata che, dopo tre mesi di matrimonio, aveva cercato rifugio nella casa paterna, sporgendo denunzia contro il marito. Il suo coraggio fu premiato, e i giudici le concessero lo scioglimento del matrimonio: sebbene, sul piano giuridico, l’autorità del marito fosse legge, la sodomia era condannata dalla Chiesa ed era inconciliabile con la procreazione, fine primario dei coniugi. Ma se quella di Leonarda può sembrarci una storia a lieto fine, rimane pur sempre un’eccezione, come ci ricorda Maria Serena Mazzi nelle sue Donne in fuga. Vite ribelli nel Medioevo (Il Mulino, pagg. 180, euro 14).
Dopo avere contribuito con Prostitute e lenoni nella Firenze del Quattrocento (Il Saggiatore, 1991) allo sviluppo di quegli studi sulla condizione femminile di cui la Storia delle donne in Occidente (Laterza 1990), diretta da Georges Duby e Michel Perrot, costituisce in Europa una consacrazione, Mazzi riprende in mano una tematica che le è cara proponendocene una sintesi eloquente. Per fare uscire dal loro lungo silenzio le donne vissute, tra il XII e il XVI secolo, in una società dove i soli ad avere diritto alla parola erano gli uomini, la studiosa ha infatti raccolto un campionario di storie esemplari che non lascia dubbi sulla durezza della loro condizione subalterna.
Sono storie di ribellione, di fuga, di sconfitte, di punizioni atroci, suddivise in base all’appartenenza sociale – aristocratica, borghese, popolare – e alla diversità dei ruoli – figlie, mogli, madri, religiose. In parte la studiosa ripercorre storie già note, come quella di Cristina di Markyate, figlia di un ricco mercante inglese del XII secolo, che si sottrae a un matrimonio imposto, consacrandosi a Dio, o della sua contemporanea, la belga Juette, che vedova di un marito ripugnante, pur di non risposarsi si fa murare viva. Oppure quella della francese Dhuoda, secondo Gerda Lerner ( The Creation of Feminist Consciusness, Oxford University Press, 1993) la prima scrittrice in Europa a prendere la penna in mano per parlare di sé.
Andata sposa nell’824 a Bernardino di Settimania, un grande signore della Linguadoca, e relegata nel castello di Uzès mentre il marito era ciambellano alla corte imperiale, Dhuoda si vide portar via i due figli ancora bambini e scrisse per il primogenito, che non avrebbe mai più rivisto, un manuale di comportamento. «Quest’opera quando ti sarà giunta inviata dalla mia mano – ella gli scrive, forte della sua autorità materna – io voglio che tu la stringa con amore». Altre, invece, sono testimonianze riemerse di recente dal fondo degli archivi e che, riportando alla luce brevi frammenti di esistenze dimenticate, vengono così ad arricchire l’appassionante casistica di Donne in fuga. Unendo all’autorità della studiosa uno stile elegante e scorrevole, Maria Serena Mazzi sa infatti evocare con efficacia un lungo passato di servaggio femminile di cui solo di recente abbiamo recuperato la consapevolezza, ma ci costringe ugualmente a ricordare che per molte donne il Medioevo non accenna a finire e la fuga continua.
Nell'icona: miniatura medievale raffigurante un marito che picchia la moglie (Zurigo, Zentralbibliothek)

il Fatto Quotidiano,
Sette miliardi e mezzo in sedici anni, cioè quasi mezzo miliardo l’anno, un milione e trecentomila euro al giorno. Questo – a fronte di 260 milioni per la cooperazione civile – è il costo della partecipazione dell’Italia alla campagna militare afgana, la più lunga della nostra storia, secondo il rapporto “Afghanistan, sedici anni dopo” pubblicato dall’Osservatorio Milex sulle spese militari italiane, che traccia un bilancio di questa guerra, iniziata il 7 ottobre 2001. In realtà l’onere finanziario complessivo della missione italiana è assi più pesante considerando i suoi costi indiretti, difficilmente quantificabili: l’acquisto ad hoc di armi, munizioni, mezzi da combattimento ed equipaggiamenti, il loro continuo aggiornamento a seconda delle esigenze operative e il ripristino delle scorte, l’addestramento specifico del personale e, non da ultimo, i costi sanitari delle cure per le centinaia di reduci feriti e mutilati.
In sedici anni la guerra in Afghanistan è costata complessivamente 900 miliardi di dollari: 28mila dollari per ogni cittadino afgano (che mediamente ha un reddito di 600 dollari l’anno). In termini umani è costata la vita di 3.500 soldati occidentali (53 italiani) e di 140mila afgani tra combattenti (oltre 100mila, un terzo governativi e due terzi talebani) e civili (35mila, in aumento negli ultimi anni, quelle registrate dall’Onu: dato molto sottostimato che non tiene conto delle tante vittime civili non riportate). Senza considerare i civili afgani morti a causa dell’emergenza umanitaria provocata dal conflitto: 360mila secondo i ricercatori americani della Brown University.
Chi sostiene la necessità di portare avanti questa guerra si appella alla difesa dei progressi ottenuti. Quali? A parte un lieve calo del tasso di analfabetismo (dal 68% del 2001 al 62% di oggi) e un modestissimo miglioramento della condizione femminile (limitato alle aree urbane e imputabile al lavoro di organizzazioni internazionali e Ong, non certo alla Nato), l’Afganistan ha ancora oggi il tasso più elevato al mondo di mortalità infantile (113 decessi su mille nati), tra le più basse aspettative di vita del pianeta (51 anni, terzultimo prima di Ciad e Guinea Bissau) ed è ancora uno dei Paesi più poveri del mondo (207° su 230 per ricchezza procapite). Politicamente, il regime integralista islamico afgano (fondato sulla sharìa e guidato da ex signori della guerra della minoranza tagica) è tra i più inefficienti e corrotti al mondo e ben lontano dall’essere uno Stato di diritto democratico: censura, repressione del dissenso e tortura sono la norma. Per non parlare del problema del narcotraffico (si veda articolo accanto). La cartina al tornasole dei progressi portati dalla presenza occidentale è il crescente numero di afgani che cerca rifugio all’estero: tra i richiedenti asilo in Europa negli ultimi anni, gli afgani sono i più numerosi dopo i siriani.
Anche dal punto di vista militare i risultati sono deludenti. Dopo sedici anni di guerra, i talebani controllano o contendono il controllo di quasi metà Paese. Una situazione imbarazzante che ha spinto il presidente americano Donald Trump a riprendere i raid aerei e rispedire truppe combattenti al fronte, e la Nato a spostare i consiglieri militari dalle retrovie alla prima linea per gestire meglio le operazioni e intervenire in caso di bisogno. Sul fronte occidentale sotto comando italiano dove, per fronteggiare l’avanzata talebana, dall’inizio dell’anno i nostri soldati (un migliaio di uomini, il secondo contingente dopo quello Usa: alpini della brigata Taurinense e forze speciali del 4° reggimento alpini paracadutisti) sono tornati in prima linea a pianificare e coordinare le offensive dei soldati afgani.
Gli esperti militari dubitano del successo di questa strategia: perché mai poche migliaia di truppe che combattono a fianco dell’inaffidabile esercito locale dovrebbero riuscire laddove gli anni passati hanno fallito 150mila soldati occidentali armati fino ai denti? Secondo esperti e diplomatici, l’unica via d’uscita è il dialogo con i talebani e la loro inclusione in un governo federale e multietnico, il ritiro delle truppe Usa e Nato e la riconversione della cessata spesa militare in ricostruzione e cooperazione.
È opportuno ricordare che i talebani, fortemente sostenuti dalla maggioranza pashtun degli afgani, non rappresentano una minaccia per l’Occidente poiché la loro agenda è la liberazione nazionale, non la jihad internazionale: combattono i jihadisti stranieri dell’Isis-Khorasan infiltratisi in Afghanistan e non hanno mai organizzato attentati in Occidente (né hanno avuto alcun ruolo negli attacchi dell’11 settembre, che avevano apertamente condannato). L’alternativa è il prolungamento indefinito di una guerra sanguinosa che nessuno ha la forza di vincere e che sprofonderà l’Afghanistan in una situazione di caos e instabilità crescenti, facendone un rifugio ideale per formazioni terroristiche transnazionali come ISis-Khorasan.
Una prospettiva pericolosa ma utile da un punto di vista geostrategico, poiché uno stato di guerra permanente giustificherebbe un’altrettanto permanente presenza militare occidentale che, seppur minima, basterebbe a scoraggiare interferenze da parte di potenze regionali avverse (Russia, Cina, Iran, Pakistan) desiderose di estendere la loro influenza strategica, stroncare il narcotraffico afgano che le colpisce e, non ultimo, mettere le mani sulle ricchezze minerarie afgane (in particolare le ‘terre rare’ indispensabili per l’industria hi-tech) valutate tra i mille e i tremila miliardi di dollari.
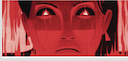
La Repubblica
Un bollore intorno al cuore. La migliore definizione della rabbia si deve ad Aristotele, ma c’è anche chi sente un grande battito nelle tempie o un dolore dietro il collo. La rabbia può essere un’emozione pubblica o privata, può riguardare una comunità intera o una relazione personale. Se dovessimo affidarci al celebre marziano di Eric J. Hobsbawm che annusa per la prima volta l’aria del nostro pianeta, potremmo ricavarne che la nostra è l’età della rabbia. Come spiegargli altrimenti Trump alla Casa Bianca, la scelta dirompente di Brexit, l’infuriare dei venti populisti in Europa? E gli attentati, lo scontro di civiltà, la Terza guerra mondiale stigmatizzata da papa Francesco? Non è un caso che proprio nella rabbia si sia imbattuta la più grande esploratrice morale delle emozioni, Martha Nussbaum, che le ha dedicato il libro Anger and Forgiveness, ora tradotto dal Mulino (Rabbia e perdono). Un saggio che attraversa la politica e i codici più intimi, toccando anche la “sfera di mezzo”, i contatti con le persone estranee. E come accade con i libri della Nussbaum — settant’anni, professoressa di Law and Ethics all’Università di Chicago — ogni pagina comporta un dilemma morale, e dunque una sorta di autoanalisi da cui si esce più ricchi e con qualche certezza in meno.
Professoressa Nussbaum, il suo saggio è stato messo in cantiere quattro anni fa ma sembra scritto oggi. Qual è stata la spinta iniziale?
«Sì, ora il mio libro sembra ancora più attuale. La politica della rabbia ha alterato il corso della storia di tante nazioni, inclusi gli Stati Uniti. E anche il futuro dell’Europa dipenderà dal richiamo della rabbia o dal prevalere di altri sentimenti. Io ho cominciato a riflettervi anni fa, quando cercavo un buon tema per le John Locke Lectures a Oxford. Fino a quel momento avevo scritto libri sull’amore, sul dolore, sulla compassione e sulla vergogna. L’idea mi è venuta dopo aver consegnato all’Indian Express un commento sul massacro dei musulmani avvenuto a Gujarat nel 2002. Non potevo sapere allora quale sarebbe stato l’approdo della mia ricerca, ossia che la rabbia è sempre un sentimento velenoso e controproducente».
Dai suoi studi emerge che la rabbia oltre a essere pulsione istintiva è il risultato di una costruzione culturale. Lei fa l’esempio delle civiltà greca e romana dove questo sentimento veniva accettato solo nelle creature ritenute inferiori, donne e bambini. In questi anni la rabbia ha acquisito una sorta di legittimazione culturale. Come è stato possibile?
«Tutte le civiltà incubano tantissima rabbia. Probabilmente si tratta di un fenomeno universale che ha radici nell’evoluzione. Quel che distingue greci e romani è che la consideravano un problema, i cui effetti dovevano essere contenuti. Perché le culture moderne sono così diverse? Penso che questo abbia a che fare con i modi in cui la mascolinità è stata interpretata. L’immagine dell’America è quella dei pionieri in lotta contro forze nemiche. Anche se alcuni dei nostri eroi letterari più amati oggi incarnano compassione più che rabbia, come l’avvocato Finch ne Il buio oltre la siepe.
Nella vostra cultura Verdi è il compositore che più ha colto il senso di questo sentimento».
In che modo?
«Mostrandone gli aspetti distruttivi. Rigoletto uccide sua figlia, Iago annienta sia Otello che Desdemona. Un momento interessante nel Rigoletto è il duetto “ Sì, vendetta, tremenda vendetta” che il protagonista e Gilda intonano dopo che lei viene portata via dal Duca. La musica è felice: mia figlia a tre anni la voleva ascoltare di continuo perché le dava allegria. Rigoletto crede di aver trovato il segreto della gioia. Ma ha trovato solo distruzione: di sé stesso e della figlia».
Potrebbe essere la colonna sonora del suo libro. Lei sostiene che la rabbia può essere uno strumento utile quanto pericoloso nella sfera morale.
«La rabbia può servire come segnale che qualcosa non va. E può scuotere le persone dall’inerzia verso le cose sbagliate. Martin Luther King intravide nella rabbia una motivazione essenziale al lavoro di correzione di un’ingiustizia sociale. Ma ne rintracciava anche un aspetto pericoloso nel desiderio di rivalsa: non appena la rabbia spinge il popolo a muoversi — diceva King — il sentimento deve essere “purificato”, così il popolo conserva la protesta ma senza anelito a rivalse».
Lei la definisce “rabbia di transizione”, ossia un’emozione rivolta a un bene futuro.
« La rabbia di transizione è quella che ti induce a esclamare: “ È terribile: non deve succedere più!”. Si denuncia una ingiustizia, ma concentrandosi sul futuro, non sulla rivalsa. Non è certo facile costruire su queste basi un movimento di massa, ma abbiamo esempi storici fortunati come quello di Gandhi, di Mandela e dello stesso King. Anche il movimento delle donne per larga parte si è tenuto su questi binari. E lo stesso potrei dire per il movimento dei diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender, che impostano le loro campagne sul potere dell’amore».
Un aspetto interessante del suo lavoro riguarda l’inutilità del perdono, che presuppone sempre una gerarchia morale. E questo non aiuta a ricomporre i rapporti.
«Nella cultura cristiana ed ebraica i racconti del perdono sono esplicitamente gerarchici: i peccatori devono umiliarsi e chiedere perdono a un superiore. Anche il perdono incondizionato spesso assume una sgradevole sfumatura di superiorità morale. San Paolo dice che devi perdonare i tuoi nemici perché così facendo “ammasserai carboni ardenti sui loro capi”. Io preferisco l’amore generoso esemplificato nella parabola del figliol prodigo. E nella carriera di Nelson Mandela».
Posso chiederle quanto conta il suo personale vissuto nelle sue riflessioni filosofiche?
«Cerco sempre un riscontro nella mia vita, e nella vita di molte persone. Soprattutto leggo libri di letteratura e di storia, seguo l’attualità. So bene di non essere una persona rappresentativa per molti motivi: ho una vita felice, un lavoro ideale, amici fantastici e una figlia meravigliosa».
Ma lei non si arrabbia mai?
«Non mi arrabbio mai con le persone che amo, mentre tendo a farlo nella “sfera di mezzo”, con commessi maleducati e tecnici incompetenti. Ora non sopporto chi ha atteggiamenti discriminatori verso il genere e l’età. Detesto quell’omone che afferra la mia valigia senza chiedermi il permesso e la spinge nella cappelliera dell’aereo. Anche perché godo di ottima forma fisica».
Nel libro lei accenna a comportamenti provocatori che gli uomini assumono verso le donne intellettuali. A cosa si riferisce?
«Gli uomini hanno l’abitudine di interrompere le donne, come se fossero sempre capaci di spiegare le cose meglio. Nella lingua inglese si dice mansplaining, ed è già una conquista che ci sia un nome. Il mio migliore amico una volta ha osservato che tutte le donne autorevoli di sua conoscenza parlano con un tono di voce piuttosto alto. Pensava che dipendesse dalla loro esperienza di donne che non erano state ascoltate. A me piace essere la prima a fare una domanda in un seminario: sento che altrimenti non prenderei la parola. Come dice Catharine MacKinnon: “Togli il tuo piede dalle nostre gole e allora potrai sentire con quale voce le donne parlano”».
Nella sua vita personale è riuscita a trasformare la rabbia in un sentimento positivo?
« Essere rifiutata da Harvard è per me qualcosa di molto personale, fonte di grande rabbia. È accaduto nel 1993: si trattava di un’ingiustizia provocata da un atteggiamento sessista. Sedici anni più tardi avrei ricevuto l’offerta di un incarico da parte di quella università. C’erano ancora alcuni dei vecchi professori del Dipartimento di studi classici che avevano votato contro di me. E uno in particolare, Albert Henrichs, mi disse che l’esclusione era stata un’ingiustizia. Non ho accettato l’offerta, ma sono rimasta colpita dalla sua grandezza d’animo. Albert è morto quest’anno, poco prima che tenessi una lecture che ho voluto dedicargli pubblicamente. Alla fine di ottobre andrò a Boston per commemorarlo. È tutto quello che posso dire sul superamento della rabbia». ?

il Fatto quotidiano
Quando qualcuno urla “morte agli arabi” cosa intende? Chi deve ucciderli esattamente? Se tocca a lui, che fa, suona i campanelli del suo condominio e se chi apre è un arabo lo sgozza?
Insomma, come si cura un fanatico? Partire dall’inseguimento di un gruppo di esaltati armati sulle montagne dell’Afghanistan, nel deserto dell’Iraq o nelle città della Siria è una cosa. Combattere contro il fanatismo in sé è tutt’altra.
L’attacco alle Torri gemelle di New York, l’11 settembre 2001, così come altre decine di attentati in centri urbani e luoghi affollati in diverse parti del mondo, non è il frutto della rabbia che i poveri nutrono contro i ricchi. Questa guerra si gioca tra i fanatici, convinti che il loro fine giustifichi qualunque mezzo, e tutti gli altri, per i quali la vita è un fine, non un mezzo. È una battaglia fra chi ritiene che, a prescindere da quello che intenda per “giusto”, il giusto sia più importante della vita stessa, e gli altri, secondo i quali la vita viene prima di quasi tutti gli altri valori.
Molti dimenticano che l’islam estremista non ha affatto il monopolio del fanatismo violento. Il fanatismo è molto più antico dell’islam. Più antico del cristianesimo e dell’ebraismo. Chi tira bombe contro gli studi medici in cui si praticano aborti, chi uccide immigrati in Europa, chi assassina donne e bambini ebrei in Israele, chi brucia una casa con dentro un’intera famiglia palestinese nei Territori occupati da Israele, chi profana sinagoghe, chiese, moschee e cimiteri, tutti costoro sono diversi da al Qaeda e dall’Isis per quello che fanno e per la misura del loro operato, ma non nella natura dei loro misfatti. Oggi si parla di “crimini d’odio”, ma forse sarebbe meglio dire “crimini di fanatismo”.
Un importante scrittore israeliano, Sami Michael, raccontò un giorno di un lungo viaggio in macchina insieme a un autista. A un certo punto questi cominciò a spiegargli quanto importante, e pure urgente, fosse per noi ebrei “uccidere tutti gli arabi!”. Sami Michael ascoltò educatamente finché l’autista non ebbe finito la sua concione e, invece di scandalizzarsi, gli fece una domanda ingenua: “E chi, secondo lei, dovrebbe uccidere tutti gli arabi?”. “Noi! Gli ebrei! Bisogna farlo! O noi o loro! Non vede cosa ci fanno continuamente?” “Ma chi di preciso dovrebbe uccidere tutti gli arabi? L’esercito? La polizia? O i pompieri? O i medici in camice bianco, con delle iniezioni?”. L’autista si grattò il capo, tacque, rifletté sulla domanda e alla fine rispose: “Bisogna dividerci il compito fra noi. Ogni maschio ebreo dovrà uccidere alcuni arabi”.
Sami Michael non si arrese: “Va bene. Diciamo che lei, in quanto cittadino di Haifa, ha in carica un condominio della sua città. Passa di porta in porta, suona il campanello, domanda educatamente agli inquilini: ‘Scusi, siete per caso arabi?’. Se rispondono di sì lei 31 spara e li uccide. Finito di uccidere tutti gli arabi del condominio che le è stato assegnato, scende e se ne va a casa e allora, prima di allontanarsi, sente improvvisamente da un piano alto il pianto di un neonato. Che fa? Torna indietro? Sale su per le scale e spara al neonato? Sì o no?”. Lungo intervallo di silenzio. L’autista meditò. Alla fine rispose al suo passeggero: “Senta, signore, lei è una persona veramente crudele!”. Questa storia fa uscire allo scoperto qualcosa del guazzabuglio che si trova talora nell’animo del fanatico: un insieme di ottusità, sentimentalismo e scarsa fantasia. Grazie a quel neonato Sami Michael ha costretto il fanatico seduto al volante a mettere in funzione la propria fantasia, facendo con ciò vibrare le sue corde emotive. L’autista, che amava i bambini, è rimasto interdetto, si è offeso, si è riempito di rabbia per quel passeggero che lo ha costretto a materializzare in una terribile immagine l’astratto slogan “Morte agli arabi!”. Ed ecco che proprio nella rabbia di quell’autista è forse riposto un barlume di speranza, per quanto timida e parziale: quando il fanatico si trova nella condizione di dare concretezza allo slogan, di configurare i tratti dell’orrore e di mettersi nei panni dell’assassino di un neonato, forse a volte – solo a volte – si risveglia in lui un certo disagio. Una lieve esitazione. Compare tutt’a un tratto una crepa nell’ottusa muraglia del fanatismo.
Certo, non si tratta di una medicina miracolosa. Ciononostante, forse ogni tanto l’attivarsi dell’immaginazione, la costrizione a osservare molto più da vicino la sofferenza delle vittime, forse tutto ciò ogni tanto può fare da contraltare all’astratta crudeltà di formule quali “Morte agli arabi!” o “Morte agli ebrei!” o “Morte ai fanatici!”. Uccidere tutti gli arabi è molto più facile che uccidere un solo neonato arabo.
La storia di Sami Michael, che riuscì a mettere in imbarazzo o a confondere per un attimo l’autista che invocava l’uccisione di tutti gli arabi, dimostra che al fanatico non piace immaginare i dettagli del gesto al quale si vota con ardore. Gli piace lo slogan, il proclama, sempre che non si trovi costretto a tradurlo in urla, suppliche, gemiti di agonia, pozze di sangue, cervelli spappolati sul marciapiede. È vero che il mondo è pieno di sadici ma gran parte dei fanatici non è fanatica per sadismo, anzi, lo è per ideali astratti, desiderio di redenzione e riscatto universale in nome dei quali “ci si deve liberare dei malvagi”. Chissà se ad alcuni fanatici, nel momento in cui traducessero lo slogan “Dobbiamo annientare tutti i malvagi” in una descrizione delle sofferenze che ciò necessariamente implica – sofferenze terribili e strazianti – tremerebbe la mano… Almeno a quelli che non sono anche dei sadici patologici…
Immaginare il mondo interiore, le idee e anche le emozioni dell’altro da sé: farlo pure nel momento dello scontro. Farlo anche – anzi: soprattutto – mentre dentro di noi monta quel miscuglio febbrile di rabbia, umiliazione, obbrobrio, tracotanza e incrollabile convinzione di aver subìto un torto, di essere dalla parte del giusto. Forse anche chiederci di tanto in tanto, “E se io fossi stato lei? O lui? O loro?”, mettendosi per un attimo nei panni del prossimo e persino nella sua pelle non per attraversare il fiume o “rinascere”, ma soltanto per capire e anche sentire quel che c’è laggiù: cosa ’è oltre il fiume? Che cosa hanno in testa? Come si sentono laggiù? E che aspetto abbiamo noi, da laggiù?
Questa curiosità non ci conduce necessariamente a un relativismo etico onnicomprensivo e neanche alla negazione di sé in nome dell’affermazione dell’altro. Ci conduce, ogni tanto, a una scoperta sensazionale, la scoperta che esistono molti fiumi, che da ogni sponda di quei fiumi si vede un paesaggio diverso, affascinante e sorprendente; che sono affascinanti anche se non si attagliano a noi, sorprendenti anche se non ci conquistano. Forse la curiosità ha davvero un potenziale di apertura, di tolleranza.

il manifesto,
Una marea bianca di decine di migliaia di persone ha invaso ieri le piazze centrali delle principali città spagnole, come Madrid, Barcellona, Valencia, Saragozza, Santiago, Siviglia e molte altre. Alle 12, convocate dall’associazione appena costituita chiamata «Hablemos/Parlem?», senza bandiere e indossando magliette bianche, hanno chiesto a gran voce che il dialogo torni a prevalere.
Una richiesta sensata, dato che né una dichiarazione di indipendenza, né una repressione selvaggia sembrano strade promettenti per stabilizzare una situazione che è arrivata a preoccupare persino i mercati e i grandi poteri finanziari che finora erano stati poco sensibili al dibattito catalano. Non c’erano partiti fra gli organizzatori di questa protesta gentile, ma alcuni membri di partiti e sindacati hanno partecipato a titolo individuale a queste manifestazioni auto organizzate in pochi giorni attraverso le reti sociali (soprattutto via twitter).
A Madrid si sono sentiti slogan come «meno odio, più conversazione», o «meno bandiere e più dialogo». Bandiere che invece non sono mancate a poche centinaia di metri dove un’altra manifestazione, assai più numerosa (si parla di 50mila persone contro le 1.500 di «bianchi» nella capitale) e decisamente schierata a destra (non a caso vi partecipava il vice segretario popolare Pablo Casado), di bandiere spagnole rojigualdas ce ’’erano una marea, in mezzo a grida da stadio «Yo soy español, español», «¡Viva España!» o l’ormai classico belligerante «Coi golpisti non si parla». La polizia ha tenuto separate le due manifestazioni.
A Barcellona per la manifestazione in favore del dialogo c’erano anche Ada Colau e Miquel Iceta, leader dei socialisti catalani, che hanno chiesto «dialogo, negoziato e patto. Si tratta di parlare e risolvere». Oltre ai palloncini bianchi liberati nel cielo, fra gli slogan che invitavano a parlare, anche quelli rivolti al presidente della Generalitat come quelli che dicevano «La Catalogna non è vostra, è di tutti» e «Fate il vostro lavoro».
La manifestazione di oggi, sempre alle 12, ma solo a Barcellona, sarà certamente molto più controversa. Organizzata dall’associazione filo-unionista «Società Civile catalana», è appoggiata entusiasticamente da Pp e Ciudadanos. Il Pp, per bocca del portavoce Fernando Martínez Maillo, ha chiesto alla «maggioranza silenziosa», che di solito non scende in piazza, di manifestare avvolta da bandiere spagnole, catalane (ma non quella indipendentista, ça va sans dir) ed europea. Soprattutto per chiedere a Puigdemont «che si fermi e riconduca la situazione e smetta di far male alla Catalogna».
Il segretario del Psoe Pedro Sánchez ha parlato invece a Valencia, dove ha detto che lo Stato spagnolo attraversa un momento «traumatico» e che secondo lui «noi cittadini viviamo e dormiamo pensando all’integrità territoriale del nostro paese». Ha appoggiato la marcia dei bianchi giacché «il Psoe è per il dialogo», in cui, ha detto, «c’entra tutto meno l’intransigenza, l’unilateralità e l’illegalità».
La Cup invece ribadisce che martedì la sessione plenaria del Parlament catalano sarà «un’opportunità storica e un momento chiave per esercitare l’autodeterminazione» e che la loro volontà «è che effettivamente si produca una dichiarazione unilaterale di indipendenza», anche se ha riconosciuto che la Catalogna non avrà capacità per rendere effettiva la legge di transitorietà giuridica, per cose come il controllo delle frontiere, degli aeroporti, dell’economia.
Secondo gli anticapitalisti il processo costituente dovrebbe iniziare immediatamente. La Cup chiede anche che sia i cittadini, sia le istituzioni boicottino banche come Sabadell, La Caixa e il Bbva, che hanno deciso di trasferire le sedi sociali fuori dalla Catalogna per esercitare pressione sul Govern di Barcellona. I Mossos, secondo la Candidatura unitaria popolare, dovrebbero al più presto «smettere di essere la polizia della Giustizia spagnola».
Mossos che rimangono al centro di 16 indagini giudiziarie aperte in Catalogna per «disobbedienza per inattività» non essendo intervenuti domenica nelle operazioni di ritiro delle urne o di allontanamento dei votanti.

il manifest
IL SINDACO DI RIACE INDAGATO:
«SONO POVERO E SERENO,
FORSE DO FASTIDIO»
intervista di Silvio Messinetti
Intervista a Mimmo Lucano. Il primo cittadino: Non posso farci nulla se il modello di accoglienza che stiamo sperimentando è visto come un’anomalia burocratica. Funziona. Ben vengano i controlli, io non ho conti segreti
Sindaco Lucano, dalle contestazioni avanzate dagli inquirenti pare che lei in concorso con altri abbia architettato «la grande truffa dei migranti». Come si sente? Sta vivendo un incubo?
«L’inchiesta parte da una vecchia ispezione prefettizia venuta a verificare presunte anomalie burocratiche nella gestione dell’accoglienza. Sono sconcertato e senza parole, ma per certi versi mi viene quasi da ridere perché non ho nessun bene nascosto. Non possiedo niente, non ho nessun conto segreto, percepisco una modesta indennità di 1.050 euro, non ho mai praticato familismo e nepotismo, la mia famiglia vive fuori da Riace, a mille km da qui, in Toscana. Non ho mai approfittato della mia posizione. Ma una cosa voglio ribadirla proprio al . Io sono un comunista nel senso ideale più ampio. Se un cittadino viene a Riace per me ha gli stessi miei diritti. Per questo oggi Riace non è più solo un comune calabrese. È un comune del mondo. E io accolgo tutti. Io vivo di ideali. Se questa la chiamano “anomalia burocratica” io non posso farci niente. Allora ben vengano i controlli su di me e che siano i più approfonditi possibili».
In effetti, dopo questi primi controlli lei stesso ha sollecitato ulteriori verifiche, poi effettuate. Adesso questo avviso di garanzia inaspettato. Lei si sente perseguitato perché scomodo?
«Non voglio fare del vittimismo. Ma è chiaro che vogliono colpire un modo diverso, e in controtendenza, di approccio ai flussi migratori. Noi non alziamo muri ma costruiamo ponti. Conservo sempre presente l’insegnamento di Dino Frisullo, la sua utopia di fratellanza tra popoli. Il nuovo conflitto di classe è l’immigrazione e io sto con gli immigrati, con i subalterni di questo secolo».
Nelle scorse settimane si era detto indignato e sfiduciato con lo Stato e con il Viminale dopo la sospensione dei fondi e dopo il rischio di abolizione dei bonus e delle borse-lavoro. Che rapporti ha con il Viminale?
«Diciamo altalenanti. Dopo questi dubbi sollevati dal ministero mi sono recato personalmente a Roma in questi giorni e mi hanno assicurato che sbloccheranno i fondi, anzi pensano anche di aumentarli. Ma di sicuro tutte queste voci che periodicamente si rincorrono contro i pilastri del nostro modello possono penalizzarci. Perché i bonus tutelano la dignità del rifugiato, spesso umiliato nella consegna di alimenti. Grazie ai buoni-moneta queste persone hanno immediatamente autonomia economica e libertà di scelta dei beni di prima necessità, entrano subito in contatto con i riacesi e si integrano. È questo il succo del modello Riace: costruire processi rigenerativi e perenni della società. Perché i migranti non devono essere dei pacchi depositati per sei mesi e poi recapitati altrove. Da noi costituiscono la linfa vitale e rigenerativa del territorio. Ed è così che siamo sopravvissuti alle lungaggini burocratiche di trasferimento delle risorse dallo Stato agli enti territoriali, grazie ai bonus. Ma negli ultimi due anni ci hanno costretto a un calvario, due anni di falsità e di congetture sulla base di verifiche effettuate in modo superficiale e approssimativo, senza sentire i soggetti beneficiari dei progetti, veri testimoni in grado di attestare la qualità dei servizi a loro erogati. Nessuna audizione con gli operatori, nessun colloquio con la popolazione, nessun contatto con i commercianti. la verifica è stata solo sulla documentazione e con toni ostili e punitivi. Forse vogliono costringerci a chiudere. Ma se manca la fiducia sono io il primo a volerlo».
Bergoglio ha sempre espresso gratitudine e ammirazione per il suo operato. «Le porte della mia casa saranno sempre aperte per lei», ha dichiarato in sua presenza. Magari se fosse respinto dallo Stato italiano, lei potrà chiedere asilo in Vaticano?
«È una buona idea. Anche perché a volte rifletto e mi dico che il papa argentino è l’ultimo uomo a dire cose di sinistra nel mondo».
IL POLVERONE DI RIACE
«La scheda. Le tappe di ispezioni e accuse contro Mimmo Lucano, sindaco calabrese amato da Wenders e da Bergoglio»
Prima la relazione del prefetto di Reggio, Michele Di Bari, che annotava «criticità estremamente preoccupanti, sia per gli aspetti amministrativi e organizzativi che per gli aspetti di merito, riguardanti i servizi rivolti agli stranieri, assolutamente carenti e privi di effettiva pianificazione».
A fine 2016 un video su Youtube, pubblicato da un nick name anonimo, che voleva far credere che il sindaco avesse pilotato un appalto con i fondi regionali per il dissesto idrogeologico. Da qui le sue dimissioni, poi revocate a furor di popolo. Poco tempo fa la visita degli ispettori del ministero chiamati a giudicare il modello dell’accoglienza che anni fa ha colpito anche il regista tedesco Wim Wenders. Infine la circolare del Viminale e della prefettura reggina che decretava la sospensione dell’erogazione dei fondi per presunte irregolarità.
Nell’attacco concentrico contro Mimmo Lucano, sindaco di Riace mancava solo quel tassello: un’indagine che dipingesse «la grande truffa dei migranti». E puntualmente, l’indagine della procura di Locri è arrivata. Insieme a un avviso di garanzia con un capo d’accusa pesante che sembra fatto apposta per sollevare un polverone: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato e dell’Ue, concussione e abuso d’ufficio, in concorso. Poco importa che in realtà si tratta nient’altro che del supplemento di una vecchia indagine del gennaio scorso per le contestazioni sollevate dagli ispettori prefettizi per verificare l’eventuale fondatezza delle accuse.
Per questo è stato eseguito anche un decreto di perquisizione e sequestro per acquisire tutta la documentazione sui progetti. Tra i destinatari dell’avviso anche Fernando Capone, presidente di Città futura-don Puglisi, l’associazione che oggi coordina tutti i progetti in corso. Lucano dopo la prima ispezione- con risultati negativi – non solo ha presentato puntuali controdeduzioni, ma ha sollecitato ulteriori controlli, poi effettuati, dei quali tuttavia non è mai riuscito a conoscere l’esito.

il manifesto, 6 ottobre 2017. Ancora una volta, nel mondo secolare solo un quotidiano comunista è capace di pubblicare un libro di un Papa che a sua volta è uno dei pochissimi che sanno pronunciare le parole di verità sul mondo di oggi: quello che malauguratamente è e quello che potrebbe e dovrebbe essere
Per Francesco la terra è innanzitutto il campo: la sede in cui si svolge e da cui dipende la vita di quei contadini di quei braccianti che, insieme ai recuperatori di rifiuti e di strutture abbandonate, costituiscono la base sociale principale dei movimenti popolari.
Quei movimenti radunati dal papa per offrire loro una sede dove coordinarsi, definire i propri obiettivi, far sentire la propria voce. A loro sono infatti rivolti tre dei principali discorsi che hanno caratterizzato la svolta che Francesco ha cercato di imprimere al ruolo della chiesa con il suo pontificato. Ma campo è inseparabile dal lavoro che lo rende fertile; e lavoro è un diritto di tutti, che va rivendicato con forza ed a cui va restituita la dignità negata dallo sfruttamento di un sistema fondato sul dominio incontrastato del dio denaro. Ed è inseparabile anche da tetto, il diritto a una casa, che fin dal suo primo discorso rivolto ai movimenti popolari Francesco declina nel senso di comunità, di vicinato, mutuo aiuto: il “fuori” senza il quale il “dentro” della casa si risolve in una prigione.
Ma Terra – questa volta con la maiuscola – è anche il pianeta in cui si svolge e da cui dipende la vita di noi tutti: un ambiente indissolubilmente trasformato dallo sviluppo storico, dalle opere, dai manufatti e dalle produzioni in cui si è concretizzata l’attività del genere umano, che è anche e soprattutto lavoro; come è inseparabile dal concetto di dimora: il luogo in cui le facoltà umane di ciascuno si possono sviluppare attraverso la convivenza e l’interscambio con il territorio e gli altri esseri umani che lo abitano.
In questa connessione tra il locale e il globale, tra il mondo del vissuto quotidiano e le prospettive dello sviluppo storico, tra il comportamento di ciascuno – analizzato fin nei minimi e apparentemente insignificanti particolari – e le scelte politiche da cui dipende il futuro dell’umanità e del pianeta sta la grandezza del pensiero di Francesco, che non ha eguali in nessuno dei leader politici e del personale di governo che oggi opprimono la popolazione del pianeta.
Francesco è un papa: si ritiene, e viene da molti considerato, il vicario di dio in terra; il suo pensiero è indissolubilmente legato al suo ruolo; e non potrebbe essere altrimenti. Per lui la Terra è parte del “creato”. Ma anche così, o proprio per questo, la Terra assume nel suo pensiero una propria autonomia e, attraverso i suoi cicli e i suoi equilibri, un ruolo regolativo nel definire che cosa è lecito e che cosa non è lecito nei comportamenti umani: non si può distruggere o sottrarre agli esseri umani campo, lavoro e tetto, ossia un ambiente sano, la possibilità di agire nella storia e le condizioni di una convivenza fondata sulla giustizia – che certo non esclude, ma anzi impone, il conflitto, e su questo Francesco è perentorio – senza far venir meno le possibilità di sopravvivenza per tutto il genere umano.
L’essere umano è per lui parte della Terra; non può contrapporsi più di tanto ai meccanismi che ne regolano cicli ed equilibri e ad essi si deve conformare. Non, quindi, la ubris del dominio sulla natura e sugli altri esseri, come per secoli è stato interpretato il messaggio biblico, bensì una consonanza con essi che fa del genere umano il custode, o uno dei custodi del, creato. Sono sanciti così sia l’abbandono di una concezione antropocentrica, prevalsa soprattutto con l’avvento dell’era moderna, sia l’adesione alla visione propria di quell’ecologia profonda che sta affermandosi, pur con grandi difficoltà, in molti campi della cultura e in gran parte dei movimenti autorganizzati del nostro tempo: una visione che Francesco abbraccia senza remore nell’enciclica Laudato sì.
È solo così, infatti, che si può riportare il lavoro, insieme alle sue finalità, ai suoi prodotti, ai suoi effetti sull’ambiente e sugli esseri umani, entro i limiti della sostenibilità, restituendo agli emarginati della Terra dignità e qualità della vita. Perché le vittime dell’aggressione alle risorse del pianeta sono soprattutto i poveri e sono loro, per forza di cose, quelli maggiormente interessati alla salvaguardia e al risanamento di tutto l’ambiente in cui vivono: dal “campo” al pianeta Terra; dall’aria che respiriamo e dal cibo che mangiamo – o che vorremmo mangiare – agli equilibri climatici globali. Per questo la giustizia sociale non è perseguibile al di fuori della giustizia ambientale, del rispetto della Terra, della salvaguardia dei suoi cicli e di tutto il vivente.
È in questo contesto che si situa l’impegno di Francesco a favore dell’accoglienza e dell’inclusione di tutti i migranti, che considera la conseguenza più evidente degli squilibri ambientali e sociali del mondo d’oggi: quelli che costringono milioni di esseri umani a fuggire da paesi che al momento, e forse per un lungo periodo, e forse anche per sempre, non danno loro più alcun accesso a un campo, a un tetto e a un lavoro, spingendoli a cercare queste cose in paesi lontani e sempre più ostili.
È un impegno non privo di ondeggiamenti e contraddizioni, come quelli testimoniati dagli scarti tra il discorso di Francesco in vista della giornata mondiale del migrante del 2018, e quel “primo, quanti posti ho?” pronunciato in aereo, di ritorno dall’America Latina, che ha dato modo a una parte della gerarchia ecclesiastica di fornire un assist immediato agli obbrobriosi respingimenti del ministro Minniti; per poi contraddirsi ancora nell’invito ad accogliere tutti i migranti “a braccia aperte”; aperte come il colonnato di san Pietro: quello sotto cui Francesco aveva invitato a trovar rifugio i senzatetto di Roma prima che le gerarchie vaticane li cacciassero di nuovo per non turbarne il decoro. Sono segni evidenti del fatto che quando dalle enunciazioni di principio si scende ai fatti, si aprono conflitti a tutto campo che non risparmiano nessuno, costringendo a continui ondeggiamenti.
Ma l’approccio che unisce giustizia sociale a giustizia ambientale resta comunque il tema di fondo che attraversa e domina tutta l’enciclica Laudato sì: un testo che riposiziona radicalmente le priorità e le prospettive della politica, della cultura e dell’agire quotidiano. Per i cattolici, nel solco di una continuità, che Francesco rivendica, con encicliche di precedenti pontefici; per i non credenti, in piena sintonia sia con il pensiero ecologista più radicale sia con le culture indigene, soprattutto quelle dell’America Latina, che hanno giocato un ruolo fondamentale in questa elaborazione.
La pubblicazione, per iniziativa del manifesto, di questo libro – che contiene, oltre ad alcune note di commento e di contestualizzazione, il testo integrale dei tre discorsi che Francesco ha rivolto al mondo in occasione degli incontri mondiali con i movimenti popolari – è anch’esso il segno di una volontà di rinnovare il proprio repertorio politico attingendo a fonti ed ambiti fino a pochi anni fa quasi impensabili.

il Fatto Quotidiano,
Ripubblichiamo parte dell’intervento che la professoressa Carlassare ha tenuto a Roma al convegno dei Comitati del No lunedì 2 ottobre
Da anni siamo costretti a parlare di leggi elettorali: i vertici politici, che non si rassegnano all’idea di doversi misurare continuamente con le istanze del corpo sociale, cercano di soffocarle con ogni artificio, contro l’ art. 1 “La sovranità appartiene al popolo” dove il verbo “appartiene” non è scelto a caso. I Costituenti dopo attenta discussione, lo sostituirono a “emana”, proposto inizialmente, per evitare il rischio che venisse interpretato nel senso che il popolo, attraverso il voto, trasferisce la sua sovranità. Era loro fermissimo intento affermare, senza equivoci, che la sovranità è del popolo e nel popolo continua a rimanere. Non è legittimo recidere i canali di trasmissione delle domande sociali alle istituzioni: alla legge elettorale non è consentito.
La Costituzione del 1948 è frutto dell’impegno collettivo di persone animate da grandi speranze e profondi ideali, unite nell’intento di dar vita a un sistema nuovo fondato sui valori di libertà e democrazia appena ritrovati, che si volevano salvaguardare in futuro. In una straordinaria stagione ricca di fermenti vitali ogni scoria del cupo passato era allontanata, così come ogni artificio antidemocratico di cui si era avvalso il regime: maggioranze truccate, premi per dominare schiacciando gli avversari politici, liste bloccate imposte agli elettori . L’obiettivo era la partecipazione “la partecipazione di tutti” come dice l’art. 3; e lo conferma l’art. 49: i cittadini, “Tutti i cittadini” – precisa la norma – hanno il diritto associarsi in partiti “per concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale”. Nessuno escluso.
Nello spirito del 1948 non poteva esserci che un sistema proporzionale con una modalità di voto in grado di tener saldo il rapporto fra elettori ed eletti: “La sovranità spetta tutta al popolo che è l’organo essenziale della nuova costituzione… l’elemento decisivo, che dice sempre la prima e l’ultima parola”. E dunque, il fulcro dell’organizzazione costituzionale è nel Parlamento “che non è sovrano di per se stesso; ma è l’organo di più immediata derivazione dal popolo”, si legge nella Relazione di Meuccio Ruini all’Assemblea costituente.
E il popolo è costituito da tutti i cittadini, altrimenti si ha una democrazia dimezzata. Secondo “la definizione minima” di Norberto Bobbio, per “regime democratico s’intende primariamente un insieme di regole e di procedura per la formazione di decisioni collettive, in cui è prevista e facilitata la partecipazione più ampia possibile degli interessati”. Era questo il pensiero dei Costituenti.
Durante i lavori della Commissione dei 75 (Seconda Sottocommissione, 7 novembre 1946), il grande costituzionalista Costantino Mortati propose di inserire in Costituzione il principio della rappresentanza proporzionale “perché costituisce un freno allo strapotere della maggioranza e influisce anche, in senso positivo alla stabilità governativa”. Prevalse invece l’idea di lasciare la materia elettorale alla legge ordinaria anche più tardi, quando se ne discusse in aula; un emendamento presentato dall’on. Giolitti non fu approvato.
Ma il suo contenuto, è importante ricordarlo, trasformato in ordine del giorno, venne invece approvato: “L’Assemblea costituente ritiene che l’elezione alla Camera dei deputati debba avvenire secondo il sistema proporzionale” (23 settembre 1947). È un impegno solenne. Non si può dunque affermare, come di recente Fusaro, che la Costituzione “nulla dice… su come trasformare i voti in seggi. Nulla. Ma proprio nulla di nulla”. Se la Costituzione non ne parla espressamente, il principio della rappresentanza proporzionale è implicito nel sistema complessivo oltre che in precise disposizioni: articolo 72 – le Commissioni in sede legislativa devono essere composte “in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari”; articolo 82 – ciascuna Camera, esercitando il potere parlamentare d’inchiesta, nomina “fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione fra i vari gruppi”; art. 83 – all’elezione del presidente della Repubblica “partecipano tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze”. Un sicuro “plurale” che non ha nulla di generico.
Il modello dei Costituenti, sottolineava Livio Paladin, è quello delle “democrazie di stampo liberale e dunque pluralistico che vuole temperare il principio maggioritario sia attraverso la rigidità della Costituzione e il controllo di costituzionalità sulle leggi, sia garantendo le libertà fondamentali, a cominciare dalla libertà di associazione e di manifestazione del pensiero”.
Le minoranze sono l’essenza del costituzionalismo liberale e sulla possibilità di far sentire la loro voce sono basati gli istituti giuridici posti a tutela dei diritti costituzionali , dai diritti di libertà ai diritti sociali. Per garantirli le Costituzioni esigono che la loro disciplina sia riservata alla legge, approvata dal Parlamento dove hanno voce anche le minoranze e non da fonti del governo dove la sola maggioranza è presente.
La distorsione della rappresentanza – dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale – alterando la composizione delle Camere si ripercuote pesantemente sulla vita dei cittadini: in assenza di voci in grado di difenderli i diritti sono gravemente incisi, il pensiero minoritario sacrificato. Ormai, che la norma sia fatta dal governo o dal Parlamento dove la maggioranza domina incontrastata, è la stessa cosa. Soffocate le minoranze, a nulla vale la rigidità della Costituzione; a tutelarla non bastano le garanzie giuridiche: se non sono accompagnate dalle garanzie politiche assicurate dal pluralismo risultano del tutto inefficaci. Una maggioranza artificialmente creata non trova più i limiti politici consueti in democrazia; le altre forze, ridotte all’irrilevanza, come possono svolgere un’opposizione efficace?
Qualche idea per le prossime elezioni politiche, nella speranza che siano elezioni vere e non una nuova truffa
Le elezioni politichesi avvicinano. Non sappiamo ancora con quale strumento quelli che comandanooggi ci obbligheranno a ridar loro il potere. Meno che meno sappiamo seriusciremo a sconfiggerli.
Comunque, poiché abbiamoimparato che le idee hanno mani e piedi, vogliamo contribuire alla campagnaelettorale con alcune idee che ci sembrano ancora valide. Esse partono da unassunto, da cui prende avvio il documento Democrazia e uguaglianza di Anna Falcone e Tomaso Montanari”: «La scandalosa realtà di questo mondo è un’economia che uccide. Èpensabile trasporre questa verità in un programma politico coraggioso einnovativo? Noi pensiamo che non ci sia altra scelta»
UNA TESI sulla “Sinistra”
di Edoardo Salzano
Quando si parla di “sinistra ci si riferisce generalmente,in Italia, quella sinistra politica le cui vicende hanno contrassegnato il XIXe XX secolo. Una vicenda che in Italia ha visto i primi passi nella“predicazione” socialista di Camillo Prampolini e Filippo Turati, poi haproseguito con la fondazione del Partito comunista d’Italia e la partecipazionedeterminante alla Resistenza, ed ha avuto a mio parere il momento più alto nelPCI, il “partito di Gramsci, Togliatti, Longo e Berlinguer”.
Quella vicenda è proseguita poi sempre più stancamente neglianni successivi: quando il rosso, scolorandosi in un rosa sempre più pallido,si è mescolato con colori sempre più scuri. Riassumerò quella vicendautilizzando quattro parole chiave: globalizzazionecapitalista, sviluppismo, migrazioni, disoccupazione
1.Globalizzazione capitalista
La sinistra, nell’assumere come compito storico la difesadelle classi sociali direttamente sfruttate dal capitalismo, ha anche accompagnatole varie fasi della nascita e dell’affermazione di quel sistema contrattando leforme e i limiti dello sfruttamento riuscendo, a al tempo stesso, in gran partedel mondo, i principi della Rivoluzione liberale dove essi consentivano ilmaggior peso del potere antagonista delle classi lavoratrici.
Il momento culminante del ruolo salvifico della sinistra si manifestònegli anni delle Seconda guerra mondiale. Il potere del proletariato e delle altreclassi subalterne si era affermata come prima forma di un ordinamento nuovo (il“socialismo”, predicato e praticato come prima tappa del percorso verso il “comunismo”).Esso tuttavia non aveva “rotto la catena del potere capitalista nel suo “puntopiù alto” (l’Europa e gli Usa, permeati da principi liberali), ma nel “puntopiù basso” (là dove erano falliti i tentativi di introdurre forme diverse dall’autocraziazarista e dalla servitù della gleba).
In quegli anni, emerse il mostro covato nelle viscere delcapitalismo, il Nazismo. La sua presa del potere in uno dei paesi chiave delcapitalismo, la Germania, fu immediatamente seguita dalla tigre asiatica, ilGiappone, e dal vassallo mediterraneo, l’Italia. Seguì. Sperimentazione dinuovi strumenti di guerra in Ispagna. Poi qualcosa cambiò.
Dopo una fase di tentennamenti, si costituì l’alleanza antifascistadegli stati e delle aree politico-culturali e sociali che storicamente esprimevanole due facce del capitalismo reale, quello “di Stato”, in Urss e quello“privato a sostegno statale” nel resto del mondo permeato dai principi delliberalismo. Quell’alleanza sconfisse la peggiore catastrofe che minacciava l’umanità:la vittoria dell’Asse nazifasciata nel mondo.
Ma all’indomani dello scioglimento di quell’alleanza nacquela nuova risposta strategica alle “velleità” di superare il capitalismo: laDottrina Truman. Nel frattempo le difficoltà interne e gli impegni militari avevanocondotto all’interruzione del sostegno da parte dell’Urss all’indipendenza dimolti stati dell’Africa.
Dal “socialismo reale” non si avanzò mai verso il “comunismo”.
2.Sviluppismo
Quella stessa sinistra che ha accompagnato e “servito”l’evoluzione storica del sistema capitalistico aveva collaborato con esso (oppureaveva subìto senza comprendere né reagire) in alcune operazioni che hannoradicalmente mutato il quadro delle ideologie, dei valori, delle strategie edelle pratiche di quel sistema, preparando il terreno per quell’assetto deipoteri che caratterizza oggi il mondo “globalizzato”, e viene diversamente definitodai diversi analisti: da “Neoliberalism”(David Harvey) a “Finanzcapitalismo” Luciano Gallino).
Mi riferisco a una serie di operazioni di vario genere eoperanti su vari piani, che hanno coinvolto e stravolto la persona umana inmolte sue dimensioni. Mi riferisco all’aver accettato, da parte delle sinistredel passato, la “esportazione delle contraddizioni del capitalismo”, effettuataquando la riduzione dei profitti conseguente alle conquiste delle classilavoratici aveva spinto le classi dominanti a compensarla con un aggravamene eun ampliamento dello sfruttamento dei popoli via via colonizzati (vedi ladenuncia di Lenin in L’imperalismo fasesuprema del capitalismo).
E mi riferisco soprattutto a quella che è stata definita “lacredenza dello sviluppo” (Gilbert Rist, Losviluppo, Storia di una credenza occidentale) Qualcosa che è molto più che unaideologia o una convinzione razionale, ma è unafede quasi fanatica per la possibilità dell’indefinito aumento dellacapacità della produzione di merci, e dell’applicazione di sempre più evolutetecnologie, per affrontare e risolvere tutti i mali del mondo.
La cecità di questa credenza è risultata evidente quando leragioni dell’ecologia hanno iniziato ad apparire: quando i “limiti dellosviluppo”, l’impossibilità di conservare il pianeta Terra continuando a consumarloin dosi sempre più massicce, hanno fatto emergere una “consapevolezza ecologica”. E quando poi i fenomeni planetariconnessi a queste cause sono apparsi nella vita quotidiana (l’effetto serra, ilsurriscaldamento dell’atmosfera, la desertificazione di vaste aree, lo scioglimentodei ghiacci).
Eppure, anche laddove e quando questa realtà ha cominciato adiventare evidente a gran parte della “vecchia sinistra” questa è rimastaincollata alla sua credenza. Lungi dall’abbandonarla ha inventato a slogan,strumenti e proposte presentati come capaci di guarirne gli effetti.
È nata così la “green economy”: un aggiustamento marginaledel sistema economico dato, e da parte questo “sostenibile”, cioè “sopportabile.Il camuffamento operato dalla Commissione Bruntland, che ha fornito così oltretuttouna parola, “sostenibilità”, da pronunciare orerotundo da tutti gli sviluppisti mascherati, nonché un nuovo campo d’affariall’altra creatura della cecità della “vecchia sinistra: il Neoliberalism.
3. Migrazioni
Un ragionamento altrettanto severo è necessario se siesamina il ruolo svolto dalla “sinistra” nei confronti dell’altra grandetragedia dei nostri tempi: quella delle migrazioni. Come non seppe comprenderel’avvento della globalizzazione capitalista, come cascò nella trappola dellosviluppismo, così non comprese che l’imperialismo analizzato da Lenin erasopravvissuto alla fase del colonialismo: era divenuto “imperialismo puro”, poteredominatore molto al di là dello sfruttamento economico: potere capace diplasmare i molteplici dispositivi mediante i quali pochi uomini riescono adasservire tutti gli uomini. Non è certamente un caso se le ultime grandimanifestazioni per la pace – un campo peculiare alla sinistra mondiale – si sianospente dopo la ventata del 1968. come se la sinistra si fosse ormai rassegnataalla vittoria definitiva del capitalismo.
Si tratta, in sostanza, di un’altra faccia dello“sviluppismo” Si tratta di non aver compreso che per eliminare tutte le causedel dolorante esodo dal Sud ai Nord del mondo occorreva rovesciarecompletamente le ideologie le strategie, i modelli specifici da applicare pereliminare le cause dalle migrazioni provocate da guerre e persecuzioni,carestia, siccità, sfratti. Occorreva, in altri termini, abbattere etrasformare dalle radici il capitalismo.
4. Disoccupazione
Dimenticare l’errore originario del capitalismo (aver ridottoogni cosa a merce, a partire dal lavoro) ha condotto la sinistra a balbettare difronte al crescente dramma dalla disoccupazione.
Karl Marx ha dato una definizione della forza lavoro e dellavoro da un punto di vista generale, antropologico, esterno quindi alcapitalismo: «Perforza-lavoro o capacità di lavoro intendiamo l'insieme delle attitudini fisichee intellettuali che esistono nella corporeità, ossia nella personalità vivented'un uomo, e che egli mette in movimento ogni volta che produce valori d'uso diqualsiasi genere. (Capitale, libro Primo, sezione III); «In primo luogo il lavoro è unprocesso che si svolge fra l'uomo e la natura, nel quale l'uomo, per mezzodella propria azione, media, regola e controlla il ricambio organico fra sestesso e la natura: contrappone se stesso, quale una fra le potenze dellanatura, alla materialità della natura. Egli mette in moto le forze naturaliappartenenti alla sua corporeità, braccia e gambe, mani e testa, perappropriarsi dei materiali della natura in forma usabile per la propria vita (Capitale, libro Primo, sezione IV).
Partendo da questa premessa e sviluppandola grazieal lavoro di Claudio Napoleoni ho sostenuto che il lavoro può (vedi l’eddytorialen. 144) e quindi deve, essere utilizzato dall’uomo nonsolo in relazione alla sua propria sussistenza e riproduzione, ma a qualsiasifine socialmente utile e produttore di valor d’uso a cui egli ritenga utileapplicarlo, comprendendo tra tali attività tutte quelle finalizzate allaricerca della verità, della bellezza, della comunicazione di se stesso e allacomprensione degli altri, mediante l’impiego di tutti gli strumenti espressiviimpiegabili.
Naturalmente, ciascuno di tali impieghi del lavoro dovrebbeessere retribuito nella misura necessaria per continuare a svolgerlo. Èl’economia, in altri termini, che deve essere subordinata al lavoro, non illavoro all’economia. Il contrario di ciò che avviene nel sistema capitalistico.
Possiamo parlare di “comunismo”? non so. Soche si tratta di una tensione per la fuoriuscita dal capitalismo, ma mi sembral’unica capace di dare una speranza alle crescenti vittime di questosistema.
5. Una Sinistra inutile?
La “sinistra” di cui disponiamo non ha compreso, enon è stata quindi capace di combattere, le quattro tragedie dominanti di oggi:la globalizzazione capitalistica, lo sviluppismo, le migrazioni, ladisoccupazione. Agli occhi di molti ne è stata anzi complice. Com’è possibileallora che abbia credito chi si propone un’aggregazione di tutti quelli chehanno sbagliato (e continuano a sbagliare?).
L’errore di fondo della sinistra è stato quello dinon aver compreso che per contrastare quelle tragedie con qualche efficacia, e conquel tanto di fiducia nell’avvenire che è necessario per alimentare la speranza,era necessario fare esattamente l’opposto di quello che si stava facendo. Occorrevariprendere la lotta per il superamento integrale del capitalismo, e nonconsumarsi in qualche guerriglia contro l’una o l’altra delle sue incarnazioni.Lottare per un’altra economia in un’altra società. Una prospettiva comunista?Forse, ma non solo parolaia.
Nessuno può pensare che sia possibile camminare in questadirezione con i protagonisti, e con le residue o restaurate sigle, dellasinistra inutile che popola i palazzi e i palazzetti del potere.
Non so quanta parte dell’elettorato che si àallontanato dalle urne negli ultimi anni sia insoddisfatto delle risposte, odelle mancate risposte della sinistra a quelle tragedie. E non è neppure certoche l’offerta politica di Anna Falcone e Tomaso Montanari, "Alleanza popolare per la democrazia e l'uguaglianza" sia immediatamente percepita nella suaconsistenza rinnovatrice. Così come, del resto. sono abbastanza sicuro chequella proposta abbia bisogno di tempo per maturare e dar luogo a risultatisignificativi nei risultati elettorali. È una proposta strategica, ma senza unastrategia affidabile per i suoi obiettivi e i suoi metodi non esistono tattichevalide. Perciò è probabile che nell’immediato, si dovrà scegliere, ancora unavolta, di votare per una delle offerte politiche che saranno meno lontane dallastrategia preferita, nella speranza che sia l’ultima volta.

lasinistraquotidiana,
Sono molteplici i fattori che stanno alla base della gravissima crisi che sta attraversando l’unità nazionale spagnola (ovvero dell’indipendenza della Catalogna): elementi di natura storica, politica, istituzionale, economica.
La crisi spagnola (ovvero dell’indipendenza della Catalogna), così come tante altre situazioni sparse principalmente sullo “storico” territorio europeo (ma anche fuori, come nel caso del Kurdistan e di diverse situazioni africane), rappresenta anche (e forse soprattutto) il nuovo punto di espressione di quell’arretramento dell’entità politica denominata “Stato – Nazione” che, in relazione al processo di globalizzazione economica, molti pensavano potesse essere risolto all’intero di nuove dimensioni denominante appunto “sovranazionali”.
In questo momento alcuni pensano che questa crisi esplosa violentemente in uno dei maggiori paesi dell’Unione Europea potrebbe essere vista proprio dal lato dell’indipendenza catalana per costruire, più facilmente, un’Europa di “piccole patrie” non vincolate alla rigidità dei grandi Stati (questa è l’opinione anche del Ministro degli Esteri della Generalitat catalana, Raul Romeva).
Sorprende (ma non troppo) l’utilizzo “a sinistra” della teoria delle due “tigri di carta”, utilizzata per esprimere una pilatesca equidistanza.In realtà l’analisi sulla quale si potrebbe lavorare è quella che ci troviamo di fronte ad una situazione creata per certi versi da un intreccio di contraddizioni del tutto inedite mai affrontate nel tempo recente, almeno dalla fase post – caduta del muro di Berlino.
Si sono connessi, infatti, a questo punto sia l’arretramento del fenomeno che è stato definito come “globalizzazione” e che ha provocato l’arresto o almeno il rallentamento nel processo di disfacimento dello “Stato – Nazione” e, insieme, quella che è stata definita “fine della società liquida”.Quella “società liquida” che Bauman aveva teorizzato a suo tempo (“Modernità liquida”, Laterza 2000).
A sostegno della tesi sulla”fine della società liquida” il filosofo docente alla Normale Roberto Esposito in un suo saggio utilizza molti autori: da Kenichi Omae (Il mondo senza confini, il Sole 24 ore), Carlo Bordoni (Fine del mondo liquido, il Saggiatore) a Daniele Giglioli (Stato di minorità, Laterza).
La tesi che si sostiene nell’intervento di Esposito, è quella che la già definita “geniale metafora” mostra il suo tempo, non solo perché troppo indeterminata, ma perché incapace di dar conto di un ulteriore passaggio che sembra spingerci del tutto fuori dalla modernità così come questa è stata concepita facendola coincidere con il trionfo del “pensiero unico” e la “fine della storia”. Due punti questi ultimi sui quali sarà il caso di ritornare.
Secondo Esposito infatti: «Gli stati sovrani dichiarati anzi tempo finiti rialzano la testa, mentre la geopolitica ridisegna vecchie e nuove zone d’influenza. Nel linguaggio dell’inclusione torna a lavorare la macchina dell’esclusione. I confini che sembravano dissolti riprendono a suddividere quanto si era immaginato di unire. Non solo ma fuori da ogni metafora liquida, si solidificano muri di cemento, in barriere di filo spinato, in blocchi stradali. Un mondo terribilmente solido, striato di frontiere materiali, subentra a quello liscio, promesso dai teorici dell’età globale»..
Riemergerebbe, in sostanza, un forte richiamo identitario che troverebbe la sua espressione non tanto e soltanto in richieste di tipo economico, ma anche e proprio (come accade nel caso ispano/catalano) da una molteplicità di elementi fra i quali reciterebbe un ruolo fondamentale quello della “identità storica” ( riassumibile nel caso in questione della Spagna/Catalogna nelle “fratture” ancora in atto dalle vicende della guerra civile e dalla contrapposizione Monarchia/Repubblica).
Nel caso ispano/catalano si nota, infatti, l’elemento del confronto tra monarchia accentratrice (come si è visto nell’uso della forza nel giorno del referendum) versus repubblica popolare: ed è questo un elemento che sul piano politico ha dimostrato comunque di mantenere un peso molto rilevante.
Il richiamo identitario si sviluppa proprio a livello di grandi masse sul terreno storicamente e culturalmente più prossimo, quella della propria immediata dimensione territoriale: quella della riconoscibilità della “propria patria” in questo caso fieramente repubblicana.Tanto è vero che l’UE (costruita mille miglia lontano da questo tipo di tensioni) e le cancellerie europee si sono palesate quanto mai perplesse nell’assumere posizione al riguardo se non con espressioni di mera circostanza.
Torniamo però al tema più generale: quello della fine della “società liquida” e, insieme, dell’inaspettato ritorno sulla scena dello “Stato – Nazione” (fattore alimentato anche dalla vicenda dei migranti) e della “geopolitica” (con accenti, in questo caso, addirittura da “nuova guerra fredda”).
Nel corso di questi ultimi anni abbiamo verificato l’evolversi di nuove dimensioni dell’agire politico sviluppatesi in particolare in Occidente e poste in relazione a profondi mutamenti avvenuti sul piano dell’innovazione tecnologica nel campo della comunicazione di massa, della struttura della società e della modificazione nel rapporto tra forme di gestione del potere da parte delle classi dominanti e il concetto stesso di rappresentatività politica.
E’ stato analizzato il fenomeno di una globalizzazione economica velocizzata al massimo dall’uso di nuove tecnologie e sono sorti movimenti testi a contrastarne gli effetti più dirompenti al riguardo delle stridenti diseguaglianze sociali che – a livello planetario – il fenomeno definito come “globalizzazione” ha provocato.
Nel frattempo hanno acquistato grande peso quelle contraddizioni definite post –materialiste “in primis” quelle ambientale e di genere; si è sviluppato fortemente il processo di finanziarizzazione nel ciclo di gestione capitalistica; la “politica” è stata sempre più esercitata nel segno del “comando” e dell’interventismo sulle sfere della vita quotidiana ( è questo l’elemento di maggiore difficoltà della cosiddetta “democrazia liberale”, nella dimostrazione di una sempre più crescente incompatibilità tra di essa e il capitalismo iperfinanziarizzato che non lascia margini al pluralismo politico e al welfare ma si intende come totalizzante nell’accentramento della gestione del potere).
Addirittura, sulla spinta della fine dell’esperienza sovietica si parlò, da parte di politologi conservatori come Fukuyama e Huntington di “fine della storia” e addirittura di unico confronto possibile quello dello “scontro di civiltà” tra l’Occidente e l’Islam.Del resto questo esito della “fine della storia” non coincideva altro che con il trionfo dell’ideologia capitalista travestita da non-ideologia era apparso possibile grazie all’egemonia assunta dal concetto neo-liberista insito nella ventata conservatrice propiziata dall’offensiva di Reagan negli USA e di Margaret Tachter in Gran Bretagna: USA e Gran Bretagna.
USA e Gran Bretagna si dimostravano ancora una volta dopo la fine della seconda guerra mondiale i paesi-guida nell’economia e anche nella riflessione politica, campo nel quale il sociologismo di marca USA pareva ormai sopravanzare l’idealismo del modello renano.
Insomma: era il tema del “pensiero unico” sul piano economico, politico e soprattutto filosofico:Una sola strada sembrava tracciata e l’unico scontro possibile era dunque quello “di civiltà” versus i “nuovi barbari” dell’islamismo terrorista (salvo, ovviamente, gli affari con i sauditi, ecc.).
Ora la fine della società liquida sta mandando in una difficoltà forse definitiva il “pensiero” ed il “mercato” unico, con grande fastidio di coloro che detengono il potere in quella “plutocrazia” ancora così definita da Noam Chomsky nel suo fondamentale “Le dieci leggi del potere” recentemente apparso anche in Italia.
Oggi, nel relativamente “piccolo” della crisi spagnola (ovvero dell’indipendenza catalana) è proprio questo punto del pensiero e del mercato unico che va in discussione.
In questo quadro di visione complessiva schematicamente riassunto , sul piano più strettamente politico, emergono alcuni fenomeni molto importanti : quello della già richiamata evidente crisi di quella già classicamente definita come “democrazia liberale” e, di conseguenza, in Occidente della completa dismissione di identità da parte dei partiti socialisti e socialdemocratici (compreso il PDS, poi DS italiano, che proveniva da una storia affatto diversa).
In questo quadro emergono evidenti :Il passaggio degli ex- socialisti e socialdemocratici nel campo liberista attraverso la scorciatoia del blairismo e dell’ulivismo (certo con contraddizioni, ma nella sostanza della schematicità di un intervento di questo tipo il giudizio di fondo non può che essere quello appena pronunciato);la marginalizzazione, non solo elettorale ma soprattutto di radicamento sociale, delle forze rimaste antagoniste, soprattutto di quelle di matrice comunista costrette a nascondersi, in pratica, in Francia, in Spagna, in Italia, in Grecia all’interno di generiche alleanze “di sinistra” e prive della capacità di affrontare, a livello di masse, il nuovo quadro di contraddizioni che si sta presentando.
Due punti di riassunto per concludere:la globalizzazione, così com’era stata intesa negli ultimi 20 anni si è arrestata;così come ha sicuramente rallentato, rispetto alle previsioni, quel processo di cessione di sovranità dello “Stato – Nazione” che pure era stata considerato alla base di ipotesi politiche di grande portata come quella della costruzione dell’Unione Europea. Concetto di “Stato – Nazione” attaccato dunque non in dimensione sovranazionale ma all’opposto dall’emergere di specificità territoriali di tipo economiche e culturale sbrigativamente definite nel linguaggio giornalistico corrente come “regionaliste”.
Si è così dimostrato che, in sintesi, il laissez-faire e la tecnocrazia internazionale non forniscono una valida alternativa allo Stato-nazione eppure i popoli premono per affermare una più diretta vocazione alla piena espressione della loro volontà.
Forse ci sarebbe da riflettere su di una frase dell’economista e premio Nobel Amartya Sen che parla infatti di “identità multiple” (etnica, religiosa, nazionale, locale, professionale e politica), molte delle quali oltrepassano i confini nazionali o stanno dentro a quei confini forzatamente tracciati nell’epoca dei nazionalismi e degli imperialismi, in quel secolo definito “breve” da Eric Hobsbawm.
“Identità multiple” che l’internazionalismo marxista risolveva declinando come l’avversario dell’internazionalismo fosse il nazionalismo borghese e considerando la divisione del mondo in classi il vero ostacolo allo sviluppo della società umana. Ci troviamo di fronte a contraddizioni evidentemente stridenti non affrontate dal punto di vista del pensiero politico.Un pensiero politico quello corrente mai apparso, come in questa fase, legato esclusivamente nelle sue espressioni maggioritarie a esigenze contingenti di sopravvivenza per ceti privilegiati. Forse è proprio quest’ultimo il punto, quello della sopravvivenza dei ceti privilegiati: come sempre il punto riguardante l’egoismo, la conservazione, lo sfruttamento, la disuguaglianza .
Una situazione che reclama urgentemente una proposta di modello alternativo naturalmente rivolta non solo alla Catalogna.

Left
«La Libia è diventata una prigione a cielo aperto, lontano dagli occhi e lontano dal cuore… Oggi non è più possibile nemmeno onorare la morte o curare e alleviare le sofferenze di chi affronta questi viaggi della speranza». Parole dettate dall’esperienza, parole che suonano come un possente atto d’accusa rivolto ai “securisti” di casa nostra, in primis al ministro dell’Interno, plenipotenziario per il Mediterraneo, Marco Minniti.
A pronunciarle, nel corso di un dibattito al Festival d’Internazionale a Ferrara, è Stefano Argenziano, coordinatore dei progetti di migrazione e delle operazioni di Medici senza frontiere in Libia. Occorre tenerle bene in mente, queste parole, quando oggi, 3 ottobre, assisteremo alla solita parata di dolore e lacrime di coccodrillo in ricordo della più grave strage di innocenti avvenuta nel “mar della morte”: il Mediterraneo (3 ottobre 2013, la strage di Lampedusa, il terribile naufragio vicino all’isola dei conigli, costato la vita a 368 persone, quasi tutte eritree).
Tenere a mente quanto denunciato da Nancy Porsia, reporter coraggiosa che ha documentato sul campo gli orrori dell’inferno libico: «Al momento – spiega – la Libia non è un partner per la risoluzione di un problema europeo di consenso elettorale», gli fa eco Porsia, che anzi rincara la dose: «la politica migratoria europea è un sistema criminogeno», non è il traffico ad alimentare i flussi, ma al contrario esso è la risposta a una domanda crescente. Per questo la soluzione sarebbe «una politica più aperta di rilascio di visti presso le ambasciate». Ai securisti che blaterano di un rischio per la nostra democrazia determinato da una inesistente “invasione” di migranti, andrebbe risposto con le parole di Khalifa Abo Khraisse, sceneggiatore trentenne libico, autore delle “Cartoline da Tripoli”, che fa la spola fra Sud e Nord del Mediterraneo.
«Voi qui leggete e ascoltate termini che in Libia non hanno significato. Leggete che il governo italiano ha fatto un accordo con il governo libico, ma quelle sono semplicemente persone alle quali le milizie hanno permesso di insediarsi come governo. E lo stesso vale per la guardia costiera libica: non esiste. Anche ‘centri di detenzione’ è una definizione molto aleatoria: come si fa a stabilire quanti sono, quando a volte sono semplici punti di raccolta in mezzo al deserto? Non c’è possibilità di monitorare questi centri». Occorre prestare attenzione, e dare risalto, alle denunce di quanti praticano solidarietà verso i più indifesi tra gli indifesi, e per questo considerati testimoni scomodi, presenze ingombranti da chi, per una manciata di voti, a quel mondo – Ong, gruppi di base, volontari – ha dichiarato guerra.
Così come non può considerarsi un elemento marginale, a sinistra, nella discussione di ipotetiche alleanze elettorali con il Partito democratico, oggi al Governo, quello della politica estera. Quel mondo solidale chiede tre atti concreti: la chiusura dei lager libici e la fine del sostegno ai signori della guerra, milizie e tribù, in affari con i trafficanti di esseri umani, che l’Italia sta pagando per fare da aguzzini di migranti; la fine della vendita di armi all’Arabia Saudita, armi (bombe) con cui l’”Isis bianco” (il regno Saud), massacra il popolo yemenita; il riconoscimento unilaterale dello Stato di Palestina a fronte della forsennata politica di colonizzazione portata avanti da Israele in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Sono richieste che richiamano coerenza, determinazione, rispetto di quei principi spesso evocati ma quasi mai praticati. E i principi, i valori, non sono negoziabili.

il manifesto, 4 ottobre 2017. «Rivoluzione in Vaticano (e al manifesto)? No, ma per la Chiesa certamente una discontinuità forte. Il comunismo non c’entra ma il focus delle parole del papa ha a che fare con i movimenti rivoluzionari».
Le parole del Papa veicolate da il manifesto: uno scandalo? Saranno in molti a gridarlo. Già parecchi hanno cominciato minacciosamente a chiamare Bergoglio «comunista in tonaca bianca», figurarsi quando scopriranno che i suoi discorsi agli Incontri Mondiali dei Movimenti Popolari (EMMP) – Roma 2014; Santa Cruz in Bolivia 2015; di nuovo Roma 2016 (il prossimo era ipotizzato nientemeno che a Caracas) – vengono addirittura distribuiti in abbinamento al quotidiano dei comunisti senza tonache quali siamo noi.
Di comunisti (o simili) in effetti agli incontri ce ne sono stati e anche importanti: all’ultimo Pepe Mujica, guerrigliero coi Tupamaros e quindi presidente dell’Uruguay, calorosamente salutato da Papa Francesco; con Evo Morales, presidente indio della Bolivia, c’era stata quasi una cogestione della conferenza. E poi, con i movimenti, provenienti da 68 paesi diversi, ce ne sono stati molti altri, ancorché non presidenti, ma a capo di assai importanti organizzazioni di sinistra: João Pedro Stedìle, leader dei Sem terra brasiliani e il coordinatore della rete internazionale Via campesina tanto per fare un esempio, ambedue – fra l’altro – membri del comitato internazionale del Forum Sociale Mondiale, con cui la EMMP ha molti tratti comuni nonostante qualche dissenso. Era stato peraltro invitato anche Bernie Sanders che poi non è potuto venire e a seguire i lavori ci sono stati Indignados, Confederazioni sindacali, persino il Leoncavallo.
Rivoluzione in Vaticano, dunque (e al manifesto)? No, ma per la Chiesa certamente una discontinuità forte, pratica e teorica. Il comunismo non c’entra ma il focus significante delle parole del papa ha certo a che fare con i movimenti rivoluzionari: per via dell’insistente richiamo alla soggettività, al protagonismo delle vittime, che debbono prendere la parola e non solo subìre. Perciò occorre dar valore alla politica con la P maiuscola, di cui «non bisogna avere paura, perché è anzi la forma più alta della carità cristiana». Non politica «per» i poveri, però – che «è carro mascherato per contenere gli scarti del sistema» (Francesco parlava dei «bonus»?), ma politica «dei» poveri, e cioè praticata direttamente da loro. Questo significa «rifondare la democrazia», che è oggi recinto dai «confini ristretti», è solo quella èlitaria, ufficiale, inservibile.
Alla denuncia dell’ingiustizia da parte della Chiesa – espressa sia pure con maggiore prudenza di quanto accade oggi che si condanna senza mezzi termini la globalizzazione neoliberista, la corruzione della finanza, il terrorismo del danaro – qualche papa ci aveva già abituati. In questo senso il Concilio Vaticano II è stato una straordinaria porta spalancata su un pensiero cristiano fino ad allora per i più inimmaginabile. Colpì anche noi comunisti che del Vaticano, e non senza ragioni, eravamo abituati a sospettare.
Nelle tesi per il IX congresso del PCI fu inserita una affermazione significativa: la religione sentitamente vissuta può essere un contributo importante alla critica anticapitalista. Un concetto su cui Togliatti tornò in modo più netto nel discorso, diventato famoso, tenuto al primo convegno su cattolici e comunisti promosso da una organizzazione comunista: dalla federazione della «bianchissima» Bergamo (di cui mi piace ricordare che era segretario uno dei fondatori de Il Manifesto, Eliseo Milani). E poi c’erano stati in America Latina, negli anni ’70, Puebla e la Liturgia della Liberazione.
Ma la grande innovazione di cui Papa Bergoglio si fa ora paladino sta nel dire che i poveri bisogna amarli e aiutarli e che poi andranno in paradiso, ma che devono alzare la testa e combattere qui e oggi, su questa terra e in questo tempo. E nel chiedere ai movimenti, e cioè alla politica, di farsi carico di generare i processi necessari. Se il manifesto veicola i discorsi di papa Francesco, non è per ospitalità, o per strumentale ammiccamento. È perché questo suo messaggio lo sentiamo nostro. Utile anche ai nostri lettori. Molti generosamente impegnati nella solidarietà, e però spesso, per disillusione, ormai scettici verso la politica.
Da domani, 5 ottobre, in edicola con il manifesto «Terra, casa, lavoro. Discorsi ai movimenti popolari» di papa Francesco. Un libro edito da Ponte alle Grazie curato da una delle nostre firme Alessandro Santagata. Introduzione di Gianni La Bella.

il Fatto quotidiano
«Pubblichiamo parte dell’intervento che il professor Azzariti ha tenuto nel convegno dei Comitati del No lunedì 2 ottobre 2017»
La discussione sulla riforma del sistema elettorale è diventata insopportabilmente confusa, anzi del tutto indecifrabile, almeno per chi vuole ragionare in base a valori e non solo per perseguire i propri interessi di partito, se non direttamente quelli strettamente personali. Ci vengono proposti sistemi elettorali, sempre più complessi, che sembrano fondarsi sul mistero della cabala, con il solo scopo di acquisire prima del voto un risultato politico desiderato ovvero con il fine di esorcizzare esiti non graditi.
Così è per l’ultima proposta, elaborata dagli stessi protagonisti che pochi mesi addietro si erano accordati per introdurre un sistema del tutto diverso, che ora immaginano di poter escogitare un meccanismo grazie al quale - secondo le parole dei commentatori più accreditati e dei più scaltri esponenti politici - si garantisca a Berlusconi di ottenere la leadership nel centrodestra, a Salvini di fare il pieno nei collegi del nord, ad Alfano di provare a non scomparire, a Renzi di tacitare gli avversari interni e orchestrare un trappolone per Pisapia, a quest’ultimo di affrancarsi dall’ingombrante D’Alema e abbandonare la sinistra soi-disant radicale.
È questo un terreno di discussione inaccettabile. L’espressione unicamente del livello di assoluta autoreferenzialità della politica, un’ostentazione della politica che si allontana sempre più dal mondo reale. Allora, il nostro primo sforzo credo debba essere quello di riportare con i piedi per terra il confronto sulla legge elettorale. Ricordare, che questa non serve per assicurare il risultato ai giocatori, bensì a permettere al popolo sovrano di esprimere e scegliere i propri rappresentanti.
Sulla riforma della legge elettorale mi limito qui a due considerazioni. In primo luogo, ricordo che entrambe le decisioni della Consulta sui sistemi elettorali hanno rilevato che le ragioni della governabilità - obiettivo politico legittimo - devono però essere perseguite “con il minore sacrificio possibile per la rappresentanza politica nazionale”, la quale “si pone al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo prefigurati dalla Costituzione”.
A me sembra chiaro il senso di un tale rilievo: l’ansia di governabilità che ha dominato la politica in Italia nell’ultimo quarto di secolo è andata troppo oltre ed è giunta a comprimere eccessivamente il valore supremo della rappresentatività dell’assemblea parlamentare. Dopo queste sentenze, il buon legislatore non perderebbe un attimo del suo tempo e - ringraziata la Corte per averla avvertita del pericolo incorso - rimedierebbe al mal fatto, riscoprendo le virtualità della rappresentanza politica che si pone alla base della nostra democrazia costituzionale.
V’è, poi, una seconda ragione che dovrebbe sollecitare a invertire la rotta. Ed è la constatazione dello stato in cui ci troviamo. Dopo venticinque anni di democrazia maggioritaria nessun risultato auspicato è stato conseguito: non la promessa semplificazione del sistema politico, che è invece esploso e s’è frammentato al suo interno; non la reclamata stabilità dei governi, costantemente ostaggio di maggioranze sempre più litigiose; non l’illusione della scelta del governo rimessa al corpo elettorale, che non decide ormai più nulla, non solo non sceglie il governo, ma neppure i propri rappresentanti, neppure l’ultimo dei peones.
Non solo non si sono raggiunti gli obiettivi perseguiti ma si sono pericolosamente inaridite le fonti che alimentano la democrazia costituzionale. Il Parlamento in primo luogo. Quest’ultimo io credo sia stato il peccato più grande.
Se vi è un organo sacrificato dal lungo regresso che ha accompagnato il progressivo, apparentemente inarrestabile, declino del paese questo è stato l’organo della rappresentanza popolare. Oggi il Parlamento italiano non conta più nulla, schiacciato dal governo che ne domina i lavori, impedito al confronto da regolamenti fatti apposta per poter decidere senza discutere. Il Parlamento sembra aver perduto ogni autonomia di organo costituzionale, posto ai margini della nostra forma di governo, che pure si vuole ancora qualificare come “parlamentare”. Questa “riduzione al nulla” del Parlamento è il più grave dei peccati e la più imperdonabile delle leggerezze perché - come scriveva Kelsen - “alla sorte del parlamentarismo è legata la sorte della stessa democrazia”.
In verità, il Parlamento oggi non è stato solo abbandonato dalla classe politica, che discute altrove, ma anche dal popolo che si indigna, ma non va più a votare, che non si riconosce più nelle istituzioni democratiche. Ed è questo il lato più preoccupante perché non c’è democrazia senza consenso. Invero, non c’è neppure un governo democratico senza consenso. Eppure le ultime leggi elettorali sembrano essere state pensate proprio per governare senza popolo, con l’unico scopo di avere un governo la sera stessa delle elezioni, anche se queste fossero andate deserte e comunque a prescindere dalla rappresentanza effettiva, dal peso reale delle forze in campo.
Oggi abbiamo l’occasione di rimettere al centro della nostra riflessione la questione della rappresentanza reale, cercando di ridurre il terribile gap tra rappresentanti e rappresentati; provando a recuperare un po’ di popolo alle ragioni della democrazia e del parlamentarismo.
Per far questo è necessario sfatare un po’ di luoghi comuni. Mai stati veri, sebbene ostinatamente ripetuti. Non è vero, ad esempio, che si vota per “scegliere” il governo: si votano i membri dell’organo legislativo, i rappresentanti della nazione, che poi svolgeranno le proprie funzioni senza vincolo di mandato. La democrazia parlamentare è cosa ben diversa dalla democrazia del capo. Poi, dei parlamentari autorevoli, perché realmente rappresentativi della nazione, potranno assicurare un sostegno duraturo e responsabile ai governi, i quali - dopo le elezioni, in base all’esito di esse, e dopo la nomina effettuata dal presidente della Repubblica - si presenteranno di fronte ad essi per esporre un programma di governo. Sono dunque i parlamentari a dover conferire - con mozione motivata - la fiducia al governo e non viceversa. Dunque il parlamento viene prima del governo.
Un Parlamento davvero rappresentativo non può essere il frutto esclusivo di torsioni maggioritarie, premi, sbarramenti e altre diavolerie immaginate solo per giungere ad un esito voluto. La richiesta di una legge elettorale di tipo proporzionale vuole preservare l’essenza e il valore del parlamento di una democrazia realmente pluralista.

il manifesto
Stavolta non si trattava di fanatici delle armi, come Adam Lanza, il responsabile del massacro nella scuola elementare di Sandy Hook, in Connecticut, nel 2012 e Dylann Roof, l’autore della strage in una chiesa di Charleston nel 2015. Non c’entra la paranoia di due studenti mentalmente disturbati, come accadde a Columbine, nel 1999. E, nonostante la rivendicazione, neppure si può dare la colpa allo Stato Islamico e alle guerre in medio oriente, come nel caso degli attacchi di San Bernardino, in California nel 2015, e di Orlando, in Florida, nel 2016. No, domenica a Las Vegas l’autore della strage è un pensionato, per di più milionario, due categorie finora mai incontrate nel quadro degli atti di terrorismo.
Stephen Paddock, 64 anni, era un giocatore, apparentemente fortunato, che passava gran parte del suo tempo a Las Vegas al casinò, oppure partecipava ai tornei di poker on line da casa sua, in un quartiere residenziale di Mesquite, sempre in Nevada. Della sua vita lavorativa si sa solo che era finita molti anni fa, da decenni si occupava solo delle sue proprietà immobiliari, anche in questo caso con successo. Al contrario di altri terroristi americani non era un cacciatore, non aveva una passione per le armi da fuoco, non era un reduce dal servizio militare, com’era stato, per esempio, Timothy McVeigh, l’autore dell’attentato di Oklahoma City nel 1995.
Paddock non era un emarginato o un lupo solitario: aveva due fratelli, una madre ancora viva con la quale era in contatto, una compagna che al momento della sparatoria era all’estero. Non aveva mai dato segni di squilibrio mentale o manifestato desideri di vendetta, non era in contatto con organizzazioni criminali o gruppi neonazisti anche se, per la gioia dei giornali, suo padre era stato un rapinatore di banche tra i dieci più ricercati dall’Fbi negli anni Settanta.
No, Stephen Paddock era un normale americano agiato, di quelli che fanno le crociere nei Caraibi o nel Mediterraneo, vengono in Italia per vedere Firenze e Venezia, affollano i parchi di Yellowstone e Yosemite e, naturalmente, vanno a Las Vegas per provare il brivido della roulette, dei dadi, delle slot-machine. Paddock, dopo aver fatto tutte queste cose, ha deciso di farne un’altra più emozionante e spettacolare: sparare sulla folla di un concerto. Ha affittato una suite al 32° piano in un albergo che dominava l’area del festival, l’ha riempita di armi semiautomatiche, ha sfondato i vetri delle finestre e ha iniziato la strage, che avrebbe potuto essere anche peggiore di quello che è stata, come testimonia l’incredibile numero di feriti, 527, che si aggiungono ai 59 morti confermati.
Com’era prevedibile, il presidente Donald Trump e i repubblicani in Congresso si sono limitati a delle frasi di circostanza, deputati e senatori rimangono ostaggi della potente National Rifle Association, che con i suoi cinque milioni di iscritti costituisce uno dei pilastri del blocco di potere oggi dominante. La Nra, nata come club di appassionati di tiro a segno a fine Ottocento, ha cambiato pelle nella seconda metà degli anni Settanta, riuscendo a imporre un allargamento progressivo del diritto di portare armi, fino ad ottenere una storica vittoria nel 2008 con la sentenza della Corte suprema District of Columbia versus Heller, che sostanzialmente apriva la via a una deregolamentazione totale basata su una lettura fino ad allora ultraminoritaria del II Emendamento della costituzione.
Nell’interpretazione di Antonin Scalia a nome della maggioranza dei giudici, quello di armarsi è un diritto individuale di ogni cittadino americano, legato all’autodifesa, non connesso al servizio militare in una milizia o una riserva dell’esercito. Naturalmente, i cinque giudici repubblicani non affrontarono il problema della difesa dei normali cittadini da chi volesse acquistare armi da guerra (Paddock aveva 23 armi da fuoco nella sua stanza, tra i quali vari AR-15, i fucili d’assalto in dotazione alle forze armate americane).
Il fatto che le stragi sostanzialmente immotivate siano diventate, insieme agli omicidi, il problema di salute pubblica n. 1 negli Stati Uniti è evidente a tutti ma il sistema politico sembra totalmente paralizzato e incapace di affrontarlo. Neppure proposte parziali e modeste, come vietare l’acquisto di armi ai potenziali terroristi o alle persone mentalmente instabili, sono state approvate negli ultimi anni, nonostante un’escalation di violenza impensabile in qualsiasi altro paese.
Nel 2014 c’erano stati 12.571 omicidi con armi da fuoco, nel 2015 ce n’erano stati 13.500, nel 2016 il totale è balzato a oltre 15.000. A questi, occorre aggiungere i circa 22.000 suicidi l’anno, sempre con armi da fuoco. Per avere un’idea migliore di cosa significhino queste cifre basterà ricordare che gli Stati Uniti hanno un tasso di omicidi per 100.000 abitanti che è circa 4 mentre in tutti i paesi europei tranne l’Ungheria questo tasso è inferiore a 2, e nei paesi industrializzati come Germania, Francia, e Gran Bretagna è inferiore a 1. L’Italia, nonostante mafia e camorra, ha circa 450 omicidi l’anno, cioè un tasso di 0,81 ogni 100.000 abitanti. In Giappone, il tasso è 0,3, cioè ci sono meno di 400 omicidi l’anno nonostante sia un paese di 120 milioni di abitanti.
Ci sono speranze per gli Stati Uniti? Nonostante il dibattito sulle armi da fuoco venga puntualmente riaperto ad ogni nuova strage, l’emozione sembra durare pochi giorni o settimane e, soprattutto, sembra incapace di scalfire l’indifferenza del sistema politico. In otto anni di presidenza, neppure Barack Obama, un coraggioso e carismatico sostenitore di maggiori restrizioni e controlli, riuscì a far approvare a Congresso un qualsiasi modesto provvedimento utile a limitare i danni. Dopo Las Vegas non c’è che da aspettare il prossimo massacro.
il manifesto, «Una prospettiva, quella dello storico inglese Stephen A. Smith, che mentre descrive "Un impero in crisi 1890-1928" estende gli effetti dei "dieci giorni che sconvolsero il mondo" fino alle attuali tensioni nazionaliste»
Un centenario in sordina quello della rivoluzione d’ottobre del 1917: certo, sono moltissime le iniziative commemorative e le occasioni di studio preparate in Russia e nel mondo, ma nessun festeggiamento commensurabile a quelli che segnarono, ad esempio, i duecento anni della rivoluzione francese. Nella nostra editoria ad alcune pubblicazioni di indubbio interesse e novità, per esempio il volume in uscita da Jaca Book, La rivoluzione russa di Pier Paolo Poggio, Giovanni Codevilla e Stefano Caprio, va ad aggiungersi da Carocci un importante contributo dello storico inglese, Stephen A. Smith, La rivoluzione russa Un impero in crisi 1890-1928 (pp. 464,euro 34,00) nella introduzione al quale si chiarisce subito che scrivere di questi eventi è per forza di cose «un’impresa di carattere peculiarmente politico», ciò che fa scegliere all’autore di attenersi a una trattazione il più possibile obiettiva.
Questo stesso intento porta Smith ad ampliare la trattazione storica della rivoluzione russa, partendo dagli anni del regno di Alessandro III, e a dedicare ampio spazio anche ai fatti di inizio secolo, dalla guerra giapponese alla rivoluzione del 1905 fino alla Grande Guerra. Allo stesso tempo, la sua trattazione si estende a tutti gli anni venti, al periodo della Nep, e giunge alla Grande Svolta staliniana alla vigilia della collettivizzazione, della grande industrializzazione e degli anni del Terrore.
Una particolare attenzione, dunque, viene prestata a temi e questioni che nella storiografia precedente al 1991 avevano suscitato minore interesse e, in concreto, al problema della dimensione imperiale e nazionale della rivoluzione, questione ancora molto viva ai giorni nostri, e che nei confronti della rivoluzione è stata a suo tempo acutamente trattata da Vittorio Strada nel suo volume Rivoluzione e impero (Marsilio).
Tutti i dettagli della storia
Proprio la questione dell’impero spinge Smith ad affrontare le implicazioni etniche e nazionali della rivoluzione e della guerra civile. Dalla rassegna di quegli eventi si ottiene un quadro di riferimenti assai utile anche per indagare le questioni nazionali nel mondo post-sovietico dei nostri giorni, dall’annoso problema del nazionalismo grande russo, dell’antisemitismo, ma anche della russofobia, a quello dei nazionalismi degli altri popoli dell’impero (dal Baltico, al Caucaso, all’Ucraina, all’Asia Centrale) e oltre. Sono tutti aspetti dei conflitti interni alla rivoluzione che Smith giustamente confronta e contrappone agli intenti dichiarati del nascente potere proletario: affermare una prospettiva internazionalista e universale, che avrebbe dovuto realizzarsi nella vittoria del socialismo in tutto il pianeta.
Lo storico inglese ripercorre la storia dei rapporti e delle contrapposizioni tra i bolscevichi e gli altri movimenti politici di orientamento socialista, caratterizza i dissidi anche all’interno dello stesso partito comunista, traccia tendenze e conflitti che risultano significativi anche per comprendere la storia più recente di quelle nazioni e di quei popoli che vennero inglobati nelle varie repubbliche socialiste dell’Urss. Sempre con un occhio attento alla storia più recente, Smith affronta il tema delle persecuzioni contro la Chiesa e la politica antireligiosa sviluppata fin dal successo del colpo di stato dell’Ottobre.
Centrale, poi, l’analisi dei tratti sociali, culturali, politici del variegato mondo contadino russo e del suo rapporto con il nuovo potere dei Soviet. Allo stesso tempo, Smith sviluppa anche un fruttuoso confronto con la storia della cultura russa e sovietica, tra tradizione, innovazione, pragmatismo e aspettative catartiche, negli anni che precedettero la piena affermazione dello stalinismo. E affronta in modo assai vivace il tema della violenza rivoluzionaria, rifiutando molti degli stereotipi interpretativi fin qui accettati e mettendo a confronto il periodo dell’autocrazia con quello del nascente stato sovietico, quello della guerra civile e quello del terrore rosso della Ceka.
Approda così a constatare la «ubiquità della violenza» nella rivoluzione: nel mettere ovviamente in evidenza la tendenza del potere sovietico a «plasmare il corpo sociale» con pratiche di schedatura, carcerazione, deportazione e così via, non minimizza il carattere violento e repressivo dell’ancien régime enumerandone i numerosi antecedenti e stabilendo interessanti analogie. Di grande rilievo è anche l’analisi offerta dallo storico inglese del rapporto tra azione rivoluzionaria, gestione del potere e ideologia, e, allo stesso tempo, del passaggio dalla rivoluzione di popolo a quella «dall’alto» attuata da Stalin fino al recupero di molti tratti dell’autocrazia.
I
nterpretazioni precedenti
In questa prospettiva, Smith tiene conto, pur tendendo a superarle, delle varie letture precedentemente offerte della rivoluzione russa, da quella di Martin Malia, che parla di «ideocrazia», attribuendo grande importanza all’ideologia anche nelle scelte pratiche e contingenti della gestione del potere, a quella di Richard Pipes che vede la persistente influenza dello zarismo nel definirsi del nuovo stato sovietico e della stessa concezione della dittatura del proletariato che si realizza poi nell’incontrastata autorità di Stalin.
Il quadro che se ne ottiene è pacatamente obiettivo: qualcuno lo leggerà come «distaccato e disilluso», ma Smith offre l’opportunità unica di poter ripercorrere le diverse fasi della storia russa con un occhio al loro significato più propriamente universale, all’opposizione tra socialismo e capitalismo anche in una prospettiva che conduce alla contemporaneità e alle nuove situazioni conflittuali del nostro tempo tra Russia e Occidente.
Certo è che lontano dai trionfalismi e dalle aspettative che parvero dischiudere i «dieci giorni che sconvolsero il mondo», accettata la fine «della spinta propulsiva dell’Ottobre» e lontano da qualsiasi posizione di parte, sottolinea l’importanza della rivoluzione nell’edificare uno stato che non solo seppe tener testa a lungo al capitalismo, ma soprattutto fornì un alto tributo di sangue come decisivo baluardo contro la vittoria del fascismo.
In questi tempi di dilagante russofobia e riabilitazione di movimenti nazionalistici a suo tempo alleati del nazismo quella di Smith è una presa di posizione decisa e niente affatto scontata.
Nell'immagine: Aleksandr Deyneka, La difesa di Pietrogrado
il Fatto Quotidiano,
HANNO DISTRUTTO
I NOSTRI VALORI
di Tomaso Montanari
Antonio Padellaro scrive che se la sinistra non sarà rappresentata nel prossimo Parlamento, i responsabili faranno “bene a espatriare”. Sono d’accordo: è per questo che, il 18 giugno scorso, ho lanciato – al Teatro Brancaccio, con Anna Falcone e quasi duemila persone – un appello per “una sola lista a sinistra”.
Ma non parliamo della stessa “sinistra”. Padellaro è convinto che il Partito democratico ne faccia parte, e che le divisioni dentro e fuori quel partito siano tutte imputabili alle “inimicizie personali” di Matteo Renzi e ai simmetrici personalismi dei troppi leader che si contendono il “comando”. Ma se c’è una cosa che appare chiara proprio leggendo il Fatto Quotidiano è che il Pd è un partito che da tempo non ha nulla a che fare con la sinistra: esso ha invece preso il posto della vecchia Democrazia cristiana, senza averne tuttavia la cultura né una sinistra interna altrettanto efficace e preparata. È il partito del potere: perché ha inteso il potere come un fine. L’unico.
L’Italia così com’è (segnata dalla massima crescita europea della diseguaglianza, Regno Unito escluso) è un prodotto del Pd, che – insieme ai partiti di cui è erede, nella formula del centrosinistra – ha governato più a lungo di Berlusconi. Lo smontaggio dello Stato, la distruzione del pubblico e la negazione sistematica di pressoché tutti i principi fondamentali della Costituzione sono da imputare al Pd almeno quanto a Forza Italia.
Arrivati a Renzi, il problema non è stato il “personalismo” (pure odiosamente pervasivo): ma la definitiva distruzione dei diritti dei lavoratori (Jobs act), la spallata finale alla scuola pubblica (la Buona scuola), la mazzata inflitta all’ambiente (lo Sblocca Italia di Maurizio Lupi), la mercificazione completa del patrimonio culturale e la fine della tutela (la “riforma” Franceschini) e via elencando. Con Minniti, poi, siamo arrivati all’eradicazione dell’articolo 10 dalla Costituzione e a una politica securitaria per la quale i militanti di Fratelli d’Italia e Lega si spellano le mani. Un partito che blocca lo Ius soli mentre approva un maxi-condono per l’abusivismo edilizio: è questo il Pd.
A “espatriare” farebbe bene una sinistra pronta a sostenere e prolungare tutto ciò. Votare Pd per fermare la destra vuol dire ripetere l’errore di chi era convinto che la visione di Sanders fosse utopica e minoritaria e ha imposto la Clinton in nome del “realismo”: sappiamo com’è finita. Fermare la destra facendo la politica della destra serve solo a rinviare lo schianto finale, rendendolo ancora più devastante.
In tutta Europa sono nati movimenti radicali di sinistra (che usino o meno questa parola nel loro nome), che contestano alla radice lo stato delle cose e le politiche di centrosinistra degli ultimi vent’anni, rigettano il dominio della finanza sulla politica e rivendicano il diritto di governare puntando al “pieno sviluppo della persona umana” e non obbedendo al mercato. Tutti partiti meno “a sinistra” di papa Francesco, sia chiaro: tanto per dire quanto sia insensato parlare oggi di “centrosinistra” sul piano culturale.
Manca quasi solo l’Italia, e spero che il percorso del Brancaccio possa – con il tempo che ci vorrà – generare qualcosa di simile. Ma un simile progetto non può certo iniziare sostenendo gli alfieri dello stato delle cose. Alle prossime elezioni ci saranno tre, diverse, destre: quella padrona del marchio, i 5stelle di Di Maio e il Pd di Renzi. Una sinistra che voglia rovesciare il tavolo dello stato delle cose non può allearsi con nessuna delle tre.
E i numeri? Si può decidere di rivolgersi solo al 50% che vota, o decidersi finalmente a parlare all’altra metà del Paese, con un linguaggio nuovo e radicale. È la metà riemersa il 4 dicembre, determinando la vittoria del No: laddove i flussi elettorali dimostrano che l’85% dei votanti Pd ha scelto il Sì.
Siamo, dunque, a una scelta di campo. L’oracolare Giuliano Pisapia ha infine detto che sarà al fianco del Pd, mentre MdP deve ancora decidere: tutti gli altri vogliono un quarto polo. Non so come finirà: ma se ci si divide tra chi vuole lasciare tutto così com’è, e chi vuole invertire la rotta non è uno scandalo, è onestà intellettuale. Lo scandalo è non averlo fatto prima: oggi saremmo al 20 per cento. O al governo.
MA NON TUTTI
SONO COME RENZI
di Antonio Padellaro
Sulla sinistra (ancora) possibile, Tomaso Montanari riesce a dire e a scrivere cose che restituiscono speranza. Poi però esiste la dura realtà quotidiana che la buona politica può certo trasformare, non prima però di aver compreso. Mi limito al dato citato a proposito del Referendum costituzionale: pur avendo la riforma imposta da Matteo Renzi “straperso” nel Paese, l’85% dei votanti Pd ha scelto il Sì.
Dunque la domanda è: assodato che per tutte le ragioni esposte da Montanari il renzismo è il degno erede del berlusconismo, come mai pur avendo perso per strada larghe fette di consenso quel Pd continua a ricevere i voti di tanti milioni di italiani? Eredi del berlusconismo anch’essi? Tutti democristiani di ritorno? Tutti che, come le famose scimmiette, preferiscono non vedere e non sentire pur di continuare a subire gli effetti delle diseguaglianze e della distruzione progressiva della cosa pubblica? Come cronista del Corriere della Sera, poi come direttore dell’Unità ho conosciuto quel mondo: anche se qualche anno è trascorso sono convinto che, al di là di un ceto politico spesso impresentabile, nella base di iscritti ed elettori esso resti una realtà largamente ancorata ai valori fondanti della sinistra. Paradossalmente anche a quelli che il renzismo non ha fatto altro che rinnegare. Allora perché diavolo restano nel Pd invece di procedere a quella “scelta di campo” che nel loro stesso interesse sembrerebbe inevitabile? Non lo fanno, caro Montanari, perché non si fidano. Né dei Cinque Stelle, per molte delle ragioni su cui sicuramente concordiamo. Ma neppure intendono dare ascolto a coloro che a nome della sinistra dicono di parlare dando tuttavia di quella stessa sinistra un’immagine fumosa, rissosa e alla fine politicamente ininfluente. E allora, in mancanza di meglio prendono quello che c’è. “Parlare all’altra metà del Paese con un linguaggio nuovo e radicale” è un progetto entusiasmante a cui auguro di cuore le migliori fortune.
Nel frattempo, per affrontare quella dura realtà quotidiana sempre più stretta tra il ritorno della destra e l’incognita pentastellata suggerirei di compattare “quello che c’è”. Magari dialogando con chi nel Pd pensa di rappresentare molte delle cose di sinistra di cui tu parli, per nulla rassegnato a lasciare le cose come stanno. Non provarci, considerare il Pd un partito perduto alla causa, significa fare soltanto il gioco di Renzi. Ne vale davvero la pena?
Quello che a Padellaro sfugge è che il mutamento non sta solo nel fatto che un berlusconcino come Matteo Renzi si sia impadronito di ciò che restava del Pci, ma che è cambiato il carattere antropologico degli ex militanti della sinistra italiana, e che contemporaneamente è cambiato il mondo nel quale la vecchia sinistra combatteva. Il personale che è rimasto nel PD di Renzi e che continua a votare per lui è costituito da schegge della sinistra del millennio scorso, ma il significato di quella sinistra non ha più alcuna rilevanza di fronte ai problemi dei nostri giorni (vedi il nostro La parola "Sinistra". Da qui anche la profonda disaffezione verso i partiti di quell'epoca scomparsa, e il fenomeno dell'astensione dal voto.. L'intelligenza politica di Anna e Tom è di aver compreso questo cambiamento e di avere di conseguenza proposto una piattaforma politica radicalmente diversa da quelle delle tradizionali sinistre Per quello che so di loro, non verranno mai a patti: non si metteranno nella situazione in cui "le mort saisit le vif"("il morto afferra il vivo", e lo trascina con se).

integrazionemigranti.gov.it.

la cittàinvisibile,. «
Fritjof Capra – Ugo Mattei, Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni, Aboca, Arezzo 2017.
Questo è il terzo libro dell’insieme proposto come documentazione sulla “ecologia politica”. ( i primi due sono .: Déborah Danowski – Eduardo Viveiros de Castro, Esiste un mondo a venire? Saggio sulle Paure della fine, Nottetempo, Milano 2017; Philippe Pignarre – Isabelle Stengers, Stregoneria capitalista. Pratiche di uscita dal sortilegio, Ipoc, Milano 2016).
Come potete vedere, siamo ancora di fronte a una coppia di autori: Fritjof Capra e Ugo Mattei. Il primo (fisico e teorico dei sistemi) è, tra le altre cose, il direttore e fondatore del Centro per L’Ecoalfabetizzazione di Berkeley; in Italia è conosciuto per essere l’autore del testo “Il Tao della fisica” edito da Adelphi. Ugo Mattei è professore ordinario di Diritto civile all’’Università di Torino e ricopre la cattedra Alfred and Hanna Fromm di International and Comparative Law allo Hasting College of the Law dell’Università della California. È stato Vicepresidente della Commissione Rodotà presso il Ministero della Giustizia; Presidente dell’acquedotto di Napoli (Arin SPA poi trasformata in ABC); Consigliere di Amministrazione del Manifesto dal 2011 al 2013. Dal 2014 al 2015, Vicesindaco di Chieri presso Torino dove ha organizzato la prima edizione di AREA, Festival Internazionale dei Beni Comuni.
Il senso di questo connubio risiede in una constatazione: se nel campo scientifico si è assistito ad un cambio di paradigma passando da uno di tipo meccanicistico ad uno di tipo sistemico, nell’economia e nel diritto facciamo invece ancora riferimento al primo e cioè a quello meccanicistico con una serie di conseguenze divenute sempre più disastrose dal punto di vista dell’ecologia della terra.
Occorre cambiare la visione del mondo: si dovrebbe cioè passare da un mondo interpretato come una macchina a un mondo inteso come rete di comunità ecologiche in quanto la natura sostiene la rete della vita attraverso dei principi generativi e non estrattivi. Il nodo fondamentale da dover mettere in discussione è dunque quello di una visione della natura dalla quale possiamo prelevare (predare) all’infinito, una natura che ci è perciò totalmente esterna.
Un paradigma che propugna il dominio dell’uomo sulla natura postulando il concetto di “leggi della natura” che sarebbero quindi perfettamente oggettive e stabili nel tempo, postulando anche un approccio di tipo razionalistico e atomistico non solo della realtà, ma della società stessa. Tutto questo diviene, dal punto di vista giuridico, una definizione della società come un aggregato di individui distinti e la proprietà un diritto individuale garantito dallo stato. Secondo gli autori, proprietà e sovranità sono i due concetti intorno ai quali si organizza tutta la visione moderna del diritto.
In questo senso il modo di produzione capitalista ha provocato una deriva storica fondamentale per la quale si è passati da una situazione di abbondanza dei beni comuni e scarsità di capitali a quella odierna per la quale si ha un eccesso di capitale e una carenza di beni comuni, situazione questa che si specchia in una società nella quale si muovono comunità a bassissimo grado di coesione. Tutto questo è un fatto di tipo culturale anche se, all’opposto, viene letto come naturale anche se priva del potere le persone. I punti fermi del paradigma attuale sono quelli che ruotano intorno a pochi concetti: «sulla sovranità dello stato e sulla proprietà privata alimentata dal denaro (in sé un’astrazione giuridica concentrata nelle mani di grandi gruppi bancari)». Situazione questa che ha provocato guadagni enormi per pochi a scapito dell’ambiente e delle comunità locali.
L’auspicato cambio di paradigma giuridico dovrà insistere sull’impellenza di una visione relazionale da dover essere istituzionalizzata in coerenza con i principi che sostengono la vita in questo pianeta. Il presupposto che la natura disponga di risorse infinite è giunto al capolinea, facendo emergere domande sempre più stringenti sui modi di rapportarsi con la natura stessa mettendo in campo un atteggiamento che sia totalmente sostenibile.
Gli autori affrontano la problematica di una documentazione storica delle trasformazioni ideologiche che hanno portato ad abbracciare una chiave di lettura della realtà di tipo meccanicistico a partire prima dalla scienza per la quale con Galileo Galilei si è privilegiata la quantificazione spesso a scapito di elementi qualitativi; con Cartesio una visione del mondo materiale funzionante in modo simile ad una macchina per di più esterna alla mente – con il diritto che diviene una infrastruttura “oggettiva” separata dall’individuo – sino alla visione atomistica messa in campo da Locke.
E se sovranità dello stato e proprietà privata individuale furono i pilastri della modernità giuridica il merito andrebbe di nuovo a Locke questa volta in compagnia di Hobbes, in una operazione parallela che accompagna, portando a compimento, una delle principali fasi di accumulo del capitale. Intorno ai secoli XVI e XVII si attua così la piena convergenza tra scienza, diritto e economia intorno appunto ad alcuni concetti di cui abbiamo appena parlato.
Siamo di fronte a un mondo caratterizzato da abbondanti risorse comuni come foreste o risorse ittiche, alle quali fanno riscontro altrettante istituzioni comunitarie quali, per esempio, le gilde professionali. «Istituti quali la proprietà privata individuale, le società per azioni e gli stati sovrani, nonché la libertà contrattuale in generale e la responsabilità per colpa, furono creati per trasformare alcuni beni comuni in concentrazioni di capitale. […] Il diritto è divenuto uno strumento del dominio dell’uomo sulla natura» (p. 31). Il meccanismo sotteso a tutta questa serie di operazioni era connesso ad una lettura per la quale le altre creature sarebbero vissute in uno “stato di Natura”, cosa che non competeva agli umani che non facevano parte della stessa categoria.
È in questo contesto che si afferma il concetto della libertà di mercato che si articola con la costituzione dello stato che funziona come elemento regolatore in una equazione a somma zero tra i due fattori. Questa contingenza è, addirittura, ritenuta una legge di natura. Da ora in poi la visione economica sarà una visione distorta, di breve termine, lineare, riduzionistica e quantitativa. L’idea stessa di sviluppo è di tipo quantitativo e fa riferimento al concetto di “miglioramento” che risale anch’esso al XVII secolo. Stato e mercato sono elementi derivati del diritto creato dagli uomini (la specie umana), ma appaiono come elementi naturali.
Negli ultimi trentanni, in ambito scientifico, si è cominciato a imporre un paradigma completamente diverso di tipo olistico e relazionale. Il mondo non si interpreta né si rappresenta come una macchina bensì come una rete. In questo ambito la comprensione della vita avviene tramite relazioni e modelli: occorre pensare per sistemi, occorre un approccio di tipo sistemico attraverso i quali la vita è sostenuta attraverso processi di tipo generativo e non estrattivo. L’intero pianeta è un sistema complesso in grado però di autoregolarsi e di comportarsi di fatto come un essere vivente. Il meccanicismo applicato all’evoluzione ci aveva restituito una natura in perenne lotta competitiva per l’esistenza, nascondendo così quegli elementi dimostratisi trainanti, quali la creatività e il costante emergere della novità.
Anche se il pensiero sistemico è in questo momento la punta più avanzata della ricerca scientifica, l’ambito economico giuridico è invece solidamente ancorato al pensiero meccanicistico che ci restituisce una visione della realtà a corto raggio «incentrata sull’individuo, proprietario astratto e atomizzato. Questo “atomo” può godere del diritto individuale di proprietà della Terra, estraendo valore dai beni comuni a scapito degli altri» (p. 37). Il diritto non è un corpo avulso e preesistente dai comportamenti che esso regola, il diritto dovrebbe essere sempre un processo di “commoning”.
Gli elementi costitutivi del diritto saranno allora i beni comuni all’interno di una rete relazionale e non i singoli individui. Se la scienza di avanguardia ha ormai abbracciato un modo di pensare sistemico, il modo di pensare “meccanico” è ancora, nel pensiero comune, il modo giusto di pensare, dimenticandosi che la scienza tutta, opera per modelli cambiandoli e adeguandoli, costruendoli cioè intorno a ipotesi interpretative dei fenomeni, spesso pensando che detti fenomeni si manifestino in termini puri e non comunicanti. In realtà tutti i fenomeni naturali sono interconnessi e le loro proprietà non sono loro intrinseche, ma derivano dal rapporto dei singoli fenomeni con gli altri. Anche parlare di singolo fenomeno sarebbe in definitiva una astrazione.
Il pensiero occidentale, in termini scientifici, evolve da una visione per la quale tutte le parti della natura interagivano tra di loro in vista di una finalità immanente alle stesse (teleologia), a una per la quale occorre occuparsi soltanto delle cose quantificabili, con l’obiettivo di un sapere utile per dominare e controllare la natura dalla quale si estraggono oltre che alle risorse le cosiddette “leggi naturali” che sono oggettive e persistenti e non dipendono dall’osservatore. Credenza assoluta era che un qualsiasi fenomeno complesso potesse essere spiegato riducendolo alle più piccole parti che lo compongono. Percorso questo che, nello stesso tempo, fa anche il pensiero giuridico che si sposta da un terreno consuetudinario ad uno promulgato e codificato, creando di pari passo gli esperti ai quali viene delegato lo sviluppo e l’interpretazione delle leggi che si sovrappongono al sapere frutto dei comportamenti reciproci che la comunità aveva intessuto. Relazioni per le quali le decisioni venivano prese in vista di quelle ulteriori che si potevano intraprendere in un ipotetico futuro e proiettate verso il bene comune.
Qui la connessione con la proprietà privata individuale diventa pregnante con un procedimento apparentemente sottile. Privata poteva essere quella proprietà che non apparteneva a nessuno (res nullius) – tutto quanto poteva appartenere a qualcuno, ma non lo era – da non confondersi con le cose appartenenti a tutti (res communes) come l’acqua, l’aria, oppure il mare; e con le cose appartenenti alla città (res publicae). Ma tutto questo non era ben distinto, in maniera tale che le terre bene comune intorno alle città poterono essere progressivamente privatizzate da grandi aziende agricole schiavistiche. Il concetto di res nullius distinto da res communes permette questa appropriazione. In questo gioco delle parti, «al fine di legittimare l’appropriazione di terreni, schiavi e risorse, ben presto si affermò l’idea che la terra senza un privato proprietario non appartenesse a nessuno, piuttosto che essere di tutti» (p. 108). In questo contesto si innestano le polemiche sulle enclosures che segneranno la trasformazione del paesaggio agrario dell’Europa, e dell’Inghilterra in particolare, dove il bisogno di recintare i pascoli per la produzione di lana da lavorare nelle prime fabbriche, sottrae ai contadini le terre comuni, convertendo gli stessi a lavoratori salariati o a esercito di riserva della forza lavoro in favore del capitale nascente.
Rivoluzione completata e totale sincronia tra concezione scientifica e diritto e economia. Ma lungo il percorso dello sviluppo dei modelli scientifici di descrizione dei fenomeni fisici ed organici, ad un certo punto, si presenta un paradosso. Per il secondo principio della termodinamica, in un sistema isolato l’entropia (la misura del disordine) non decresce nel tempo. I processi fisici, cioè, si svolgono in una sola direzione, dall’ordine al disordine. Questo presuppone un universo che si muove verso un disordine crescente, mentre le osservazioni evoluzionistiche nell’ambito della biologia ci restituivano sistemi sempre più ordinati e complessi.
Ilya Prigogine si rese conto che la seconda legge si riferiva a sistemi chiusi mentre i sistemi biologici sono sempre aperti a flussi di energia e materia. Nel mondo vivente ordine e disordine si creano nello stesso tempo. Si crea allora una prima scollatura con la visione meccanicistica della realtà che trova il suo compimento in alcuni elementi della meccanica quantistica in cui compaiono elementi di relazione e di relazione di relazioni. In biologia si afferma che gli organismi viventi sono realtà complesse non comprensibili tramite il solo studio delle loro parti e derivano il loro comportamento dalle interazioni e relazioni tra le parti stesse. Si va dunque dagli oggetti alle relazioni sconvolgendo così il paradigma dominante. Proseguendo nella ricerca emergono concetti quali reti e flussi, sistemi non lineari. Sempre Prigogine parla poi di “strutture dissipative”, un apparente ossimoro che comunque sottolinea che stabilità e mutamento di fatto coesistono tanto che «la creatività – cioè la generazione di nuove forme – è una proprietà chiave di tutti i sistemi viventi» (p. 131).
Ci si aspetterebbe, a questo punto, un adeguamento paradigmatico del diritto alla nuova visione sistemica e reticolare, ma l’impostazione meccanicistica è di fatto profondamente correlata al modo di produzione capitalista al quale rende un servizio prezioso. Il diritto si professionalizza eliminando così ogni possibile residuo che faccia riferimento a elementi consuetudinari provenienti dal basso, producendo l’esproprio di un “bene comune” importante, quello del proprio ordine giuridico. Questo ha fatto sì che l’accessibilità al diritto stesso è diventata una prerogativa di quegli stessi professionisti, tanto che, per assurdo, non possiamo sapere «veramente dove si trovi il diritto in un momento dato, se non quando lo cogliamo mediante una decisione [nel momento in cui una delle persone addette ai lavori lo coglie]» (p. 164). L’assurdo sta nel fatto che l’esito di un conflitto legale non è così determinabile con certezza come afferma la visione meccanicistica.
Cosa si dovrebbe fare? I nostri autori cercano e propongono delle risposte: «separare il diritto dal potere e dalla violenza, far diventare le comunità sovrane e rendere la proprietà generativa» (p. 167). Il diritto dovrebbe essere, per esempio, considerato un processo continuamente negoziato di creazione di connessioni culturali. Fare poi resistenza con il boicottaggio e l’elaborazione di nuove dottrine della responsabilità. Lottare contro la proprietà intellettuale. Recupero dei beni in degrado anche tramite strutture giuridiche quali i community land trust: «Il diritto di proprietà può essere strutturato in maniera tale per cui i proprietari assenteisti perdano i propri diritti a favore di occupanti che coltivino attivamente la terra» (p. 176). Invertire certi assunti dichiarando che lo stato è una istituzione legittima nella misura per la quale è in grado di proteggere la comunità dall’uso estrattivo della proprietà privata. La comunità dovrebbe essere sovrana ed essa potrà riconoscere anche la proprietà privata purché essa sia di tipo generativo come il permettere l’uso individuale di una abitazione a persone a basso reddito.
È in gioco di nuovo un dispositivo del consenso basato su crescita, innovazione, modernizzazione e, non ultimo, se non correlato, che la ricchezza è misurabile soltanto attraverso il denaro. Per questo si accetta di lavorare “sodo” e vendere il proprio tempo per ottenere un salario con il quale partecipare ai processi di accumulo e di consumo. «Secondo tale concezione, per esempio, il lavoro domestico di cura dei bambini e degli anziani o la produzione del proprio cibo, la realizzazione artigianale dell’abbigliamento o la costruzione del proprio tetto non contano come produzione, non creano ricchezza né contribuiscono al prodotto interno lordo, poiché si verificano al di fuori di una transazione di mercato» (p. 212). Tradotto in altri termini si ha che anche il lavoro di riproduzione fa parte dell’appropriazione capitalistica la cui eventuale carenza (di detto lavoro), derivata dallo smantellamento di beni comuni quali gli elementi di relazione e solidarietà comunitaria, diventa un’occasione in più per il capitale per poterlo mettere sul mercato come servizio dal quale riuscire ad estrarre ancora profitto.
La natura si è evoluta secondo principi volti a sostenere la rete della vita ed erano queste le leggi di natura. Tali principi, formulati oggi in termini di modelli e processi sono «altrettanto rigorosi quanto le newtoniane leggi di gravità» (p. 220). Il diritto derivato da questo cambio di paradigma potrà allora, per esempio, mettere in discussione la stipula di alcune tipologie di contratti «quali molti degli attuali accordi di project financing […] [che] saranno considerati illegali e dichiarati privi di forza esecutiva dai tribunali» (p. 231).