

 La lettera con la quale il leader della sinistra europea, Alexis Tsipras, accetta la candidatura e le tre sagge condizioni che pone alla sua formazione.
La lettera con la quale il leader della sinistra europea, Alexis Tsipras, accetta la candidatura e le tre sagge condizioni che pone alla sua formazione.
Il manifesto, 25 gennaio 2014. In calce i promotori e della lista italiana e le adesioni finora pervenute.
In Grecia, in Italia e nell’Europa del Sud in genere siamo testimoni di una crisi senza precedenti, che è stata imposta attraverso una dura austerità che ha fatto esplodere a livelli storici la disoccupazione, ha dissolto lo stato sociale e annullato i diritti politici, economici, sociali e sindacali conquistati. Questa crisi distrugge ogni cosa che tocca: la società, l’economia, l’ambiente, gli uomini.
“L’Europa è stata il regno della fantasia e della creatività. Il regno dell’arte”, ci ha insegnato Andrea Camilleri, per finire in “un colpo di stato di banchieri e governi”, come ha aggiunto Luciano Gallino. Questa Europa siamo chiamati a rovesciare partendo dalle urne il 25 di maggio nelle elezioni per il Parlamento Europeo. Scommettendo sulla ricostruzione di una Europa democratica, sociale e solidale.
La vostra proposta per l’unità, aperta e senza esclusioni, della sinistra sociale e politica anche in Italia rappresenta un prezioso strumento per cambiare gli equilibri nell’Europa del Sud e in modo più generale in Europa. Syriza ed io personalmente sosteniamo che l’unità della sinistra con i movimenti ed i cittadini che colpisce la crisi rappresenta il migliore lievito per il rovesciamento. È la condizione necessaria per cambiare le cose.
La vostra proposta per la creazione di una lista aperta, democratica e partecipativa della sinistra italiana, dei movimenti e della società civile in Italia per le elezioni europarlamentari di maggio, con l’obiettivo di appoggiare la mia candidatura per la Presidenza della Commissione Europea, può rappresentare con queste condizioni un tentativo di aprire una nuova speranza con successo.
La prima condizione è che questa lista si costituisca dal basso, con l’iniziativa dei movimenti, degli intellettuali, della società civile. La seconda condizione è di non escludere nessuno. Si deve chiamare a parteciparvi e a sostenerla prima di tutto i semplici cittadini, ma anche tutte le associazioni e le forze organizzate che lo vogliono. La terza condizione è di avere come speciale e unico scopo quello di rafforzare i nostri sforzi in queste elezioni europee per cambiare gli equilibri in Europa a favore delle forze del lavoro contro le forze del capitale e dei mercati. Di difendere l’Europa dei popoli, di mettere freno all’austerità che distrugge la coesione sociale. Di rivendicare di nuovo la democrazia.
L’esperienza di Syriza in Grecia ci ha insegnato che in tempi di crisi e di catastrofe sociale, come oggi, è di sinistra, radicale, progressista, ogni cosa che unisce e non divide.Solo se facciamo tutti insieme un passo indietro, per fare tutti insieme molti passi in avanti, potremmo cambiare la vita degli uomini. In un quadro del genere anche il mio contributo potrà essere utile a tutti noi, ma prima di tutto ai popoli d’Italia e d’Europa.
Alexis Tsipras è Presidente di Syriza e Vicepresidente del Partito della Sinistra Europea
Qui su eddyburg l'appello e le prime adesioni. Qui per sottoscrivere l'appello
 A proposito del congresso di SEL. «Non sappiamo dire perché pur partendo da analisi profonde e condivise della grave malattia che rischia di inghiottire l’Europa nel destino weimariano, le sinistre plurali non riescano a unirsi in una lista comune a sostegno della candidatura di un leader europeo come Alexis Tsipras».
A proposito del congresso di SEL. «Non sappiamo dire perché pur partendo da analisi profonde e condivise della grave malattia che rischia di inghiottire l’Europa nel destino weimariano, le sinistre plurali non riescano a unirsi in una lista comune a sostegno della candidatura di un leader europeo come Alexis Tsipras».
Il manifesto, 25 gennaio 2014
Non sappiamo dire perché pur partendo da analisi profonde e condivise della grave malattia che rischia di inghiottire l’Europa nel destino weimariano, le sinistre plurali non riescano a unirsi in una lista comune a sostegno della candidatura di un leader europeo come Alexis Tsipras. Né dire perché un sindacato italiano come la Cgil, presente nelle assise di Sinistra ecologia e libertà con Camusso e Landini, pur invocando una risposta keynesiana ai vincoli catastrofici dell’austerità non sappia offrire una risposta unitaria al dramma del lavoro ormai ridotto a merce. Ma è questo quadro di spaccature e divisioni che ci viene restituito dalla tribuna congressuale di Sel.
Il partito di Nichi Vendola ieri lo ha ascoltato nella lunga e appassionata relazione che appunto si concludeva con il no all’adesione alla lista italiana per Tsipras e il sì alla presentazione del proprio simbolo con l’indicazione di sposare la scelta del Pse e di conseguenza di Martin Schulz come candidato alla presidenza della Commissione europea. Con una fortissima probabilità di non superare, né gli uni né gli altri, quella soglia del 4 per cento necessaria per entrare nel parlamento europeo. Uno scenario che abbiamo purtroppo conosciuto esattamente quattro anni fa, alle elezioni europee del 2009 quando l’astensionismo superò il 7 per cento, le destre avanzarono, la sinistra arretrò, lasciando Rifondazione e Sel fuori da Strasburgo. Anche allora il manifesto provò a indicare la via di una lista unitaria fuori dalle litigiosità partitiche, l’appello restò inascoltato e fummo facili profeti dello sventurato risultato. Oggi, con la maturità del giovane leader di Syriza, sarebbe stato possibile (e speriamo ancora possa essere) arrivare uniti alla meta delle elezioni.
Naturalmente non è semplice operare nel vivo delle storie personali e collettive che in questi anni hanno separato il nostro campo. Vendola ha ragione quando ricorda che una nuova sinistra pretende un discorso di verità, che la sconfitta perdura, che arrendersi alla fatalità delle larghe intese anche in Europa significa considerare Schulz come un avversario anziché come un alleato. Più difficile da questo dedurne che allora «Sel non deve avere paura di andare con il suo simbolo alle europee».
La scelta di alzare le bandiere di partito viene replicata quando si atterra nello scenario italiano. L’attacco al Pd di Renzi è netto. Il segretario-sindaco «ignora proprio il senso delle primarie», ha sostituito la «procedura democratica con la velocità del comando», la sua polemica contro i piccoli partiti «nasconde la bulimia dei grandi», la legge elettorale concepita in profonda sintonia con Berlusconi è «un’intesa opaca con il berlusconismo». Il Pd resta un interlocutore, ma l’alleanza «non è una condanna».
La botta, elettorale e personale, che ha colpito un partito e un leader, ambiziosi e fragili, si fa sentire e c’è voglia di «toglierci il lutto». Vale la lezione di Calamandrei e dei piccoli numeri del partito d’Azione, o quella di due grandi sconfitti, Ingrao e Gramsci, figure dell’album citato da Vendola. Per dire, come scrive Corrado Stajano concludendo il viaggio nella “Stanza dei fantasmi”, che la speranza nella speranza è sì difficile, ma anche doverosa
Cio’ che sarebbe avvenuto se non potessimo giovarci d’ una magistratura autonoma rispetto ai partiti, e ciò che invece, per fortuna, è accaduto. Ma “del diman non v’è certezza”.
La Repubblica, 25 gennaio 2014
Nelle riflessioni sul da farsi vengono utili storie virtuali, ossia come staremmo se anziché X, fosse avvenuto Y.
Invertiamo la freccia del tempo rivivendo giovedì 1 agosto 2013: da sette ore, cinque ermellini deliberano in camera di consiglio sul ricorso contro la condanna a 4 anni, inflitta dalla Corte d’appello milanese all’ex premier; rispondeva d’una lunga frode fiscale consumata negli Usa, essendo già “statista”; il grosso della condotta delittuosa svaniva, estinto dalla prescrizione, tanto utile agli acrobati illegalisti. Corrono previsioni d’annullamento con rinvio, nel qual caso tutto finirebbe nel solito poco onorevole proscioglimento: il delitto c’era ma non è più punibile; se li mangia il tempo. Stiamo supponendo che la Corte esaudisca l’augurio: Deo gratias, esclamano molti eletti (li nominava il partito, come nella mussoliniana Camera dei Fasci e Corporazioni): temevano una fine abortiva della legislatura; questo rassicurante evento blinda le “larghe intese”. La posta era terribile: vedi l’allarme lanciato dal Corriere, 24 luglio 2013; povera Italia, in preda ai mercati se cadesse il governo.
La questione è chi abbia vinto. Ovvio, Berlusco Magnus, più forte della legge: da vent’anni combattevano due poteri e soccombe la compagnia in toga; siamo liberi, plaudono gli addetti al culto d’Arcore. Vanno in soffitta antiche massime giacobine, che vigano regole uniformi. Nossignori, è tempo d’una versatile empiria, attenta alle persone. Qualche politologo dai pochi scrupoli la chiama «moderna democrazia». Il redivivo aveva sfiorato la vittoria con una strepitosa rimonta: grazie al Porcellum sarebbe padrone nella Camera bassa solo che la campagna elettorale fosse durata ancora qualche giorno; i Pd calavano a vista d’occhio. Ormai egemone, terrà in piedi questa larva d’un governo finché gli conviene, logorando i consorti, nelle cui file impianta colonie.
Tale sarebbe il quadro se le sentenze corrispondessero ai calcoli nei luoghi del potere politico. Che il Pd sia timido davanti all’uomo forte, consta da precedenti indecorosi: non era eleggibile alle Camere, finché fosse in atto una concessione amministrativa economicamente rilevante (art. 10, c. 1, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), ma oligarchi ex comunisti gli garantivano le aziende; Montecitorio chiude gli occhi, intendendo l’incompatibilità nel senso ridicolo che tocchi solo Fedele Confalonieri, titolare della concessione, senza effetti rispetto al padrone, irresistibile autocrate. Fosse meno visibile, lo diremmo imprenditore occulto.
Era storia virtuale. La sera del 1° agosto le cose vanno diversamente. Gli ermellini rientrano e avviene tutto in pochi minuti, nemmeno fosse un caso qualunque, risolubile in equazioni legali: cade la pena accessoria (sarà rideterminata dalla Corte milanese); respinti i 47 motivi del ricorso; passa in giudicato la condanna a 4 anni (3 coperti da indulto). Inorridiscono i sedicenti moderati.
Qui la commedia prende ritmi indiavolati. L’alto stratega delle “larghe intese” appare stupito: una sua fulminea nota contiene lodi al condannato, degno homme d’État, e calcando la mano sull’altro piatto, raccomanda riforme della giustizia (cospicua gaffe, sia permesso dirlo). Furibondo, lui sbraita da Porta a porta: è atto «irresponsabile» condannarlo in primo, secondo, terzo grado; da vent’anni serve l’ingrata Italia (arricchendosi a dismisura e l’ha lasciata in bolletta); abitiamo un paese guasto ma lo ripulirà cominciando dai tribunali. Ai bei tempi esibiva una volgarità sorridente. Adesso ringhia, torvo e nero. Secondo recenti norme, votate anche dai suoi (d.P.R. 31 dicembre 2012 n. 235), e se ne vantavano qualificandosi «partito degli onesti», l’ormai irrevocabile condanna gli toglie il seggio al Senato, dove sedeva immune da eventuali misure cautelari o investigative: non è più candidabile; e a parte l’effetto morale, l’anno da scontare causa intuibili disturbi. Era sua l’idea d’un secondo settennio dell’uscente dal Quirinale: adombrando misteriosi accordi, vuol estorcere interventi che lo riqualifichino, come niente fosse; e nella retorica d’Arcore questo bagno catartico diventa «pacificazione », invocata dal «popolo della libertà». Gli riaprano i palchi dello spettacolo politico o cade il governo: esige la grazia, subito, motu Praesidentis, doveroso rimedio alla lesa maestà (cinque «impiegati » s’erano permessi d’applicargli uno stupido comma), e non basta perché pendono altre accuse; noncurante dell’elementare grammatica giuridica, chiede d’essere garantito da ogni rischio penale, né più, né meno. Nelle dicerie d’amnistia mettono becco ministro della difesa, uomo dai vari colori, e madama guardasigilli, mano quirinalesca.
Imperversa tre mesi la battaglia in Senato: l’esclusione dall’assemblea, cantano i suoi a piena gola, è una pena, quindi irrogabile solo ai fatti post 5 gennaio 2013 (entrata in vigore della relativa legge); decida in proposito la Consulta; e se ne riparla tra un anno; chi vivrà, vedrà. Pronta, la guardasigilli interloquisce ad adiuvandum: il diritto è «materia d’approfondimento», no?; e volano ciarle da portineria. Il voto segreto in assemblea lascerebbe più d’uno spiraglio all’inamovibile, dato l’umore malsicuro nel gruppo Pd, ma gli elettori incutono paura. Voto palese, quindi, e come Dio vuole, mercoledì 27 novembre, Re Lanterna perde il laticlavio: mese infausto; sabato 12 novembre 2011 usciva da Palazzo Chigi. La fase seguente, prossima al punto climaterico, pone gravi questioni.
 Non fu un Presidente del consiglio, partner autorevole del PD di Napolitano ed Epifani e sodale "in profonda sintonia" del PD di Renzi e Renzi a proclamare che non è giusto pagare le tasse, e a darne il buon esempio tanto da essere condannato da tre tribunali per frode fiscale? Il manifesto, 24 gennaio 2014
Non fu un Presidente del consiglio, partner autorevole del PD di Napolitano ed Epifani e sodale "in profonda sintonia" del PD di Renzi e Renzi a proclamare che non è giusto pagare le tasse, e a darne il buon esempio tanto da essere condannato da tre tribunali per frode fiscale? Il manifesto, 24 gennaio 2014
L’evasione fiscale accertata dalla guardia di Finanza nel 2013 è di 52 miliardi di euro, pari ad almeno tre leggi di stabilità di importo pari a quella licenziata dal governo Letta a fine dicembre: poco più di 14 miliardi di euro. Nel rapporto annuale diffuso ieri, le Fiamme Gialle sostengono di avere individuato 12.726 responsabili di reati fiscali e 8.315 evasori totali che hanno occultato al fisco redditi per 16,1 miliardi di euro. Si stima che i ricavi non contabilizzati e i costi non deducibili rilevati agli altri tipi di evasione siano pari a 20,7 miliardi di euro. L’Iva è stata evasa per 4,9 miliardi di euro. Almeno due sono riconducibili alle cosiddette «frodi carosello», cioè quelle operazioni illegali basate su fittizie transazioni commerciali con l’estero. L’importo dell’evasione fiscale internazionale ammonterebbe a 15,1 miliardi di euro.
Sugli oltre 12 mila denunciati per reati fiscali, 202 sono stati arrestati per falsa fatturazione fatture (pari a 5.776 violazioni); 534 sono i casi di chi non ha versato l’Iva (534 casi); 2903 le violazioni di chi ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi; 1.967 i casi di chi ha nascosto la contabilità. Sono state inoltre avviate procedure di sequestro pari a 4,6 miliardi di euro nei confronti di chi è stato riconosciuto responsabile di frodi fiscali, di beni mobili, immobili, valuta e conti correnti pari per 4,6 miliardi. Nel corso del 2013 sono stati eseguiti provvedimenti che hanno permesso di riportare 1,4 miliardi, al patrimonio dello Stato. Magra consolazione, visto che complessivamente si tratta di 5,6 miliardi, un decimo dell’importo che si ritiene sia stato nascosto.
Quanto al controllo degli scontrini e ricevute fiscali negli esercizi commerciali, la Guardia di Finanza sostiene di avere effettuato 400 mila controlli. Nel 32% dei casi sono stati rilasciati in maniera irregolare, poco più di uno su tre. Sono stati intercettati oltre 298 milioni in contanti e titoli illecitamente trasportati attraverso i confini nazionali. Rispetto al 2012 queste operazioni sono quasi triplicate. Nel 2013 ne sono state individuate il 140% in più rispetto all’anno precedente, pari ad oltre 258 milioni. Le Fiamme Gialle sostengono che questo aumento sia stato dovuto alla severità della entrata in vigore nel 2012.
Un’altra parte dell’attività dei militari si è rivolta al contrasto del lavoro nell’economia sommersa. Sono stati scoperti 14.220 lavoratori totalmente in nero, 13.385 sono gli irregolari. I datori di lavoro che li hanno sfruttati sono 5.338. Anche il capitolo delle violazioni fiscali è quello rappresentato dal settore economico dei giochi e delle scommesse, in espansione e da tempo al centro delle attenzioni della finanza pubblica. Nel 2013 la Gdf ha effettuato oltre 9mila interventi e ha denunciato 3.500 casi di violazione a carico di 10 mila responsabili. Le scommesse «al nero», cioè non soggette alle imposte previste in questi casi, sono state pari a 123 milioni di euro.
Commentando i dati il segretario confederale della Cisl, Maurizio Petriccioli ha chiesto «un impegno suppletivo e straordinario da parte del Governo e del Parlamento». Il deputato Pd Michele Pelillo, segretario della commissione Finanze, ha suggerito usare la delega fiscale, approvata alla Camera e ora al vaglio del Senato, per il contrasto dell’evasione. «I numeri che ci dà oggi la GdF sull’evasione fiscale sono impressionanti. Dobbiamo dunque prendere atto che questi sforzi sono stati insufficienti e che dobbiamo fare di più».
In un documento approvato dalla commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria nella XVI legislatura (2008–2012) aveva quantificato l’entità dell’economia sommersa tra i 230 e 250 miliardi di euro. In una audizione alla commissione Finanze del Senato nel 2012 il presidente della Corte dei Conti ha indicato una cifra più contenuta pari a 180 miliardi di euro annui, citando una stima basata sui dati Ocse. È stata anche realizzata una simulazione della distribuzione territoriale dell’evasione.
Nell’aprile 2012 all’Unità di informazione finanziaria (UiF), un ufficio della Banca d’Italia, risultava che la media dell’evasione è di 38,19 euro su 100 euro di imposte pagate. Questa media cresce in regioni come il Molise, la Basilicata e la Puglia (64 su 100), poi c’è la Campania con il 59 e la Sicilia con il 56, a seguire tutte le altre. Un’altra caratteristica determinante di questa massa monetaria è quella di stimolare o di favorire la crescita delle economie criminali e i sistemi di riciclaggio del denaro sporco. Due facce della stessa medaglia, sostiene l’Ocse dal 2012. Se a questa cifra aggiungiamo quella dell’elusione fiscale, pari a 150 miliardi di euro all’ano, si comprende facilmente le dimensioni finanziarie di un fenomeno che è anche alla base di un’economia parallela che finanzia attività criminali o quelle apparentemente legali. Secondo la Corte dei Conti l’Italia è primo in Europa per evasione fiscale. Nel mondo ci sono solo Turchia e Messico
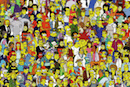 È incredibile pensare che siamo da tempo schiavi di un paradosso. La colpa è di chi è tanto bue da scegliere "democraticamente" i padroni che da trent'anni ci comandano.
È incredibile pensare che siamo da tempo schiavi di un paradosso. La colpa è di chi è tanto bue da scegliere "democraticamente" i padroni che da trent'anni ci comandano.
La Repubblica, 24 gennaio 2014
Un terremoto fa aumentare il Pil perché crea nuove attività e occupazione: questo paradosso sintetizza meglio di qualsiasi discorso l’assurdità dell’indicatore che condiziona tutte le decisioni di politica economica. Il Prodotto Interno Lordo rappresenta la misura delle transazioni monetarie e la sua variazione indica se un’economia si sta arricchendo oppure no. Ma se venisse lanciato un piano di trasporti volto ad incentivare l’uso della bicicletta e dei mezzi pubblici al posto dei veicoli privati, l’effetto contabile sarebbe quello di una drastica diminuzione dei consumi di energia e quindi del Pil e del gettito fiscale. Tutto ciò farebbe peggiorare i conti pubblici e il rapporto tra debito e reddito spingendo il governo a varare delle pesanti manovre per contenere la spesa ed innalzare le tasse. Il miglioramento della qualità della vita e la salvaguardia dell’ambiente che potrebbero derivare da una riduzione del trasporto privato avrebbero dunque effetti negativi sulla politica economica.
Se prendiamo il caso italiano, possiamo osservare che l’attenzione è concentrata sulla crescita del prodotto interno – automobili, case, beni di consumo – mentre la qualità delle infrastrutture e del capitale come il territorio, l’acqua, l’aria, il patrimonio artistico e l’istruzione, è completamente ignorata. Il settore privato non ha alcun incentivo ad investire per valorizzare lo stock di capitale, mentre lo Stato non ha i soldi per farlo. Se, invece, la qualità del capitale fosse calcolata nel Prodotto Interno Lordo, il risultato sarebbe ben diverso perché in tal modo ne risulterebbe accresciuta la ricchezza nazionale riducendo il peso del debito. Il nostro Paese diventerebbe migliore sia sotto il profilo della qualità della vita che per l’affidabilità di fronte ai famigerati mercati finanziari.
Le critiche al Pil sono ormai contenute in una letteratura sterminata eppure non si è ancora riusciti a fare il passo decisivo: abbandonare il Pil per utilizzare altri indicatori in grado di orientare in modo più intelligente le decisioni di politica economica. Siamo convinti che bisognerebbe seguire un criterio diverso: fissare gli obiettivi sucuimisurarel’efficaciadellepolitiche economiche. Ciò significa che un presunto criterio di misurazione oggettiva andrebbe sostituito con un approccio squisitamente normativo epolitico:lacontabilitàdovrebbeavere il compito di misurare gli impegni e gli obiettivi stabiliti in sede politica. Si tratta dunque di individuare una serie di indicatori che siano in grado di fornire informazioni sulla direzione in cui il sistema intende procedere e sul futuro che vogliamo costruire.
Siamo ben consapevoli che il principale ostacolo ad una tale impostazione è rappresentato dal problema dei confronti: come adottare degli standard omogenei e quindi delle politiche coordinate tra i vari Paesi? L’indicatore che in questa fase di crisi dovrebbe essere assunto come stella polare per misurare l’efficacia delle politiche economiche è il tasso di disoccupazione. L’obiettivofondamentale della politica economica dunque dovrebbe essere quello di creare occupazione equamente retribuita per tutta la forza lavoro attiva sul territorio europeo.Ilmodopercrearenuovaoccupazione dipende in primo luogo dall’espansione della domanda sia pubblica che privata. A sua volta, l’espansione della domanda ha bisogno di risorse finanziarie per aumentare la spesa e l’occupazione nel settore pubblico, per diminuire le tasse sul lavoro e sulle imprese e per garantire finanziamenti adeguati agli investimenti delle imprese.
Quando l’obiettivo della piena occupazione sarà raggiunto, allora la politica economica potrà individuare altri traguardi e altre sfide utilizzando nuovi indicatori.
Riferimenti
Ricordate la definizione che Robert Kennedy diede del mitico Prodotto Interno Lordo?
 L'unica speranza du impedire che vinca questa proposta renzusconiana è che ciò che resta di sinistra nel PD lo faccia esplodere, anzichè limitarsi a tentar di depeggiorarne i prodotti.
L'unica speranza du impedire che vinca questa proposta renzusconiana è che ciò che resta di sinistra nel PD lo faccia esplodere, anzichè limitarsi a tentar di depeggiorarne i prodotti.
il manifesto, 23 gennaio 2014
Due soli articoli, lunghissimi. Il relatore che è anche il presidente della prima commissione della camera, il berlusconiano Francesco Paolo Sisto, ha attratto a sé l’attenzione per tutta la giornata. Prima ha mostrato le occhiaie ai giornalisti, frutto ha detto di una notte di lavoro. Poi ha annunciato a più riprese che stava limando gli ultimi commi. Nel frattempo Verdini per Berlusconi e Bressa per Renzi facevano sul serio. Recapitando il testo definitivo con gran ritardo, e costringendo così Sisto a presentarsi in commissione solo alle otto di sera. Con quella che formalmente è la 23esima proposta di legge di riforma del sistema di voto, ma che con buona pace del regolamento è stata immediatamente proposta come testo base (si voterà oggi). Del resto, secondo il presidente Sisto, i tempi per la presentazione degli emendamenti sono cominciati a decorrere prima che fosse noto il testo da emendare. Dopo la pausa del fine settimana si vuole chiudere in due, tre giorni di discussione. Per licenziare la legge per l’aula entro fine gennaio.
Il ritardo di ieri è dovuto alla Lega. Verdini si è ricordato degli alleati troppo tardi. E ha provato a inserire nel testo una modifica per salvarli, visto che nei sondaggi viaggiano abbondantemente sotto il 5%. La soluzione sarebbe stata quella di introdurre una nuova soglia di sbarramento, magari lo stesso 8% già previsto per le forze non coalizzate, da raccogliere in almeno tre regioni (ipotesi che avrebbe tentato anche i centristi che mantengono un consenso concentrato al sud). Il Pd aveva anche detto di sì. È stato il Nuovo centrodestra di Alfano a fermare il «salva Lega» che nel frattempo Bossi aveva giudicato indispensabile. Più che altro per fare un dispetto al nuovo segretario leghista Salvini che, informato del fallimento della trattativa, stava già dichiarando che al Carroccio non servono aiutini.
Nel testo è confermato il conteggio dei seggi su base nazionale e sono confermate le tre soglie di sbarramento: 5% per i partiti coalizzati, 8% per i non coalizzati e 12% per le coalizioni. La soglia per aver diritto al premio di maggioranza del 18% resta fissata al 35%. Altrimenti ballottaggio, e chi vince (vietati apparentamenti) guadagna automaticamente 327 seggi, che è anche più del 51% annunciato (quasi il 52%). La novità è che all’interno della coalizione che supera lo sbarramento (12%), dev’esserci almeno un partito che supera il 5% per concorrere al premio di maggioranza. Secondo l’ultimo sondaggio dell’istituto di fiducia di Berlusconi (Euromedia, due giorni fa) né il centrodestra né il centrosinistra sono in questa condizione. Anche nel caso in cui uno dei due contendenti dovesse afferrare il 35% (Berlusconi sarebbe adesso al 34%) si dovrebbe andare al ballottaggio. Al termine del quale, quindi, anche un partito votato al primo turno solo dal 22% degli elettori (come Forza Italia, sempre secondo il sondaggio Datamedia), esclusi tutti i suoi alleati rimasti sotto la soglia, conquisterebbe tutti per sé il 52% dei seggi. Premio di maggioranza «reale»: 52–32=30%.
Resta ancora da fare il lavoro sulle circoscrizioni, tutte da ridefinire attorno alle 110 provincie e alle dieci città metropolitane. Avranno da tre a sei candidati e almeno la legge esclude le candidature in più circoscrizioni. Ma resta il fatto che con il riparto nazionale il voto di un elettore palermitano alla sua lista, corta quanto si vuole, può far eleggere un candidato veneto della stessa lista, ma a lui sconosciuto. Con il primo voto di stasera, quando sarà adottato come testo base, l’Italicum di Renzi comincia la sua corsa. Lo attende al varco quella decina di deputati del Pd non renziani che in commissione affari costituzionali sono la maggioranza, o quasi, della delegazione del partito. Presenteranno emendamenti per introdurre le preferenze e alzare la quota sopra la quale si ha diritto al premio di maggioranza. Sul primo punto troveranno gli alfaniani, sul secondo i montiani. La corsa è a ostacoli
L’interrogativo seguente è d’obbligo: quindi c’è il rischio che la futura legge elettorale,quell’Italicum frutto dell’incontro Renzi-Berlusconi, possa finire di nuovo davanti alla Consulta per un vizio di costituzionalità almeno sulla questione delle preferenze? Qui si raccolgono affermazioni convinte. E preoccupanti. Sulle quali riflettere. Del tipo: «La Corte ha aperto una porta importante per porre subito la questione di costituzionalità. Se il ricorrente Bozzi è dovuto arrivare in Cassazione per veder recepita la sua istanza, adesso la faccenda è cambiata. Un nuovo ricorso potrebbe arrivare sui nostri tavoli anche subito». Come andrebbe a finire? Anche in questo caso la risposta è assai pregnante: «La Corte, sta scritto nelle carte, non ha sdoganato un sistema senza preferenza».È settimana “bianca” alla Consulta. Ma i giudici lavorano ugualmente. È troppo fresca la bocciatura del Porcellum per non interrogarsi su che sta succedendo adesso. Anche se la premessa è necessaria: «La Corte non dà patenti di costituzionalità sulle leggi in itinere o approvate nella loro interezza. I giudici valutano il singolo punto. Su quello si pronunciano. Proprio com’è avvenuto per il Porcellum». Già, sul premio di maggioranza e sulle preferenze, giusto i due fantasmi di potenziale incostituzionalità che cominciano ad agitarsi in queste ore. La preferenza che non c’è. La soglia minima per il premio di maggioranza, quel 35%, valutato come «ancora troppo basso».
Ma è la preferenza il vero scoglio. Perché, come dicono alla Corte, il passaggio che riguarda la necessità che ce ne sia almeno una viene considerato del tutto inequivoco. Anzi, chiarissimo. Ovviamente i giudici sono stati attenti, nelle motivazioni, a non “sposare” un sistema elettorale, né avrebbero potuto farlo. Ma hanno valutato il diritto costituzionale di un cittadino ad esprimere un suo pieno voto e quindi una sua scelta. Per questo, alla Corte, ci si meraviglia sulla convinzione del palazzo della Politica che, sin dal primo momento, ha ritenuto che i giudici avessero sponsorizzato il sistema spagnolo e dato il via libera a quelle liste corte, da 3 a 6 candidati, che adesso fanno bella mostra di sé nel nuovo testo della legge elettorale. Ma questo via libera invece non c’è. «Quello era solo un esempio di un sistema diverso da quello previsto dal Porcellum». Tutto qui. «Ma non significava affatto che un sistema senza le preferenze sia costituzionale».
«La battaglia contro il nuovismo non si combatte con la vecchia logica correntizia o con le trappole parlamentari, la competizione con una leadership plebiscitaria non si sviluppa in appartate riunioni di gruppi dirigenti».
Il manifesto, 22 gennaio 2014
Irrefrenabile è scattato l’applausometro per la nuova legge elettorale, infelice fin dal nome (l’hanno battezzata Italicum), un concentrato che, tra premio di maggioranza e soglie di sbarramento, tiene stretta la camicia di forza alla nostra asfittica democrazia (in quale paese se prendi il 35% dei voti hai il 60% dei seggi?). Tutto in nome di un bipolarismo coatto, già sperimentato nel 2008 da Veltroni, che recuperò un po’ di voti al Pd, fece tabula rasa alla sua sinistra e perse, con un distacco, quello sì storico, con Berlusconi.
Al pregiudicato miracolato dal rottamatore non sembra vero di essere tornato al centro della scena. Ne dà testimonianza inviando attestati di stima al leader della parte avversa mentre intanto si prepara a replicare il sorpasso, puntando a vincere le elezioni al primo turno grazie alla lunga filiera delle formazioni di destra.
Del resto una legge elettorale di questa natura è lo specchio fedele del renzismo, di una politica che va per le spicce, che mal sopporta quel che resta del partito e dei partiti, che vorrebbe fare piazza pulita delle residue resistenze e vedersela nella sfida con il vecchio leone. Nella riunione della direzione del Pd, Renzi ha difeso la profonda sintonia col Cavaliere, e rafforzato il concetto: «Esprimo la mia gratitudine a Berlusconi per aver accettato di discutere». Ma se a discutere è il presidente del Pd, se Gianni Cuperlo non si inchina alla grande svolta e polemizza, allora il segretario lo zittisce in malo modo, e l’altro anziché tenere il campo e replicare, stizzito getta la spugna e dà le dimissioni.
Che lo stile del sindaco di Firenze sia un po’ bullesco, che usi, verso chi lo critica, argomenti tipicamente berlusconiani (io rispondo solo ai milioni che mi votano) non c’è chi non lo veda. Ma che l’opposizione interna sia messa male è altrettanto evidente. Invece di dare battaglia sui contenuti, Fassina prima e Cuperlo a ruota, con le dimissioni a catena sono evidentemente lontanissimi dall’intercettare la sfida all’altezza in cui Renzi gliela lancia.
La battaglia contro il nuovismo non si combatte con la vecchia logica correntizia o con le trappole parlamentari, la competizione con una leadership plebiscitaria non si sviluppa in appartate riunioni di gruppi dirigenti. Qui l’asticella è molto più alta, è tra chi sa parlare alla gente attraverso la televisione e i cinguettii e chi si attarda nelle liturgie dell’organizzazione. Tra il berlusconiano e il dalemiano, tra l’uomo nuovo e il chierico, non è difficile prevedere chi è che si condanna alla definitiva irrilevanza
... e la Costituzione violata una volta ancora. Sarà l'ultima, perchè il Porcellum n.2 è costruito per cancellarla del tutto.
Il manifesto, 21 gennaio 2014
Fu vera e profonda sintonia tra Renzi e Berlusconi? Vorremmo dubitarne, anche se la proposta approvata dalla direzione del Pd ha subito avuto il «sincero e pieno apprezzamento» di Berlusconi. Ma poco importa. Conta invece capire se la proposta è compatibile con la Costituzione.
Dobbiamo anzitutto considerare che con la sentenza 1/2014 la Corte costituzionale ha trasformato il tema elettorale da questione sostanzialmente rimessa alla decisione legislativa e delle forze politiche in una questione di diritti fondamentali giustiziabili davanti alla stessa Corte.
Quei diritti — in specie gli artt. 48, 49, 51 — qualificano la Repubblica come democratica, e assicurano la rappresentatività delle sue istituzioni. Dopo la sentenza, l’intervento del legislatore deve trovare giustificazione in un obiettivo costituzionalmente accettabile (principio di necessità) e raggiungere l’obiettivo con il minimo di non arbitrario sacrificio (principio di ragionevolezza e proporzionalità). In ogni caso, senza ledere il nucleo prescrittivo incomprimibile del diritto stesso. Non bastano più a sostenere una proposta i mantra del bipolarismo e della governabilità.
Veniamo alla proposta: tre soglie di accesso al 5, 8 e 12%; premio di maggioranza del 18% con soglia del 35%, e fino a concorrenza del 55% dei seggi; doppio turno per il premio se nessuno raggiunge il 35% dei voti; minicollegi e liste bloccate brevi, con primarie per la scelta dei candidati. Si direbbe un sistema a metà strada tra il Porcellum e il sindaco d’Italia, con soglie per l’accesso e per il premio accortamente costruite sui sondaggi secondo le convenienze dei due partiti maggiori.
Due le domande: se la proposta è costituzionalmente compatibile, e se funziona. Sul primo punto il dubbio di incostituzionalità è forte. Il mix tra alti sbarramenti, forte premio di maggioranza e doppio turno rende l’accesso alle istituzioni rappresentative un percorso minato per tutti, salvo i due maggiori partiti destinati a confrontarsi nell’eventuale ballottaggio. E non sembra un obiettivo costituzionalmente accettabile che una legge elettorale sia volta a favorire decisivamente questo o quel partito, conducendo alla sterilizzazione di consensi ricevuti da altri partiti. Né sembra necessaria, ragionevole e proporzionata la compressione dei diritti — pur sempre diritti fondamentali della persona — in funzione dell’interesse dei partiti maggiori.
Anche sulle liste bloccate brevi pesa l’ombra della incostituzionalità. Comunque sottraggono — sommandosi — l’intera rappresentanza politica alla scelta dell’elettore. Che inoltre, non volendo sostenere una presenza sgradita tra i componenti di una lista, deve cambiare il voto, o non votare affatto. Effetti negativi per niente corretti dalla previsione di primarie. Non essendoci identità di platea tra votanti nelle primarie ed elettori, il problema della preclusione di ogni scelta per l’elettore rimane tal quale.
Ma, almeno, funziona? Probabilmente no. L’esperienza del doppio turno per i sindaci ha evidenziato come il premio di maggioranza esalti la frammentazione e spinga ad anticipare già al primo turno la formazione di coalizioni. Le schede elettorali sembrano lenzuoli. Gli effetti negativi rimangono, incluso in specie il ricatto dei partitini. Mentre la distorsione sulla rappresentatività dei consigli comunali può essere fortissima.
Sono da tempo convinto che la vera risposta è abbandonare l’opzione di un sistema elettorale che conceda decisivi e artificiosi vantaggi a questo o quel partito. Ripristinare una rappresentanza che in principio riconosca a ciascun soggetto politico una presenza nelle istituzioni commisurata al consenso. E dare voce, non negare la parola, soprattutto quando la politica è chiamata a scelte difficili e dolorose, come oggi accade in tempi di grave crisi. La governabilità è un bene importante, che va però riferito non solo alle istituzioni, quanto al paese.
Renzi ha anche offerto un contentino a Letta, con una riforma del senato che può dare al governo l’agognato anno di vita. Peccato che sia una proposta pessima. Un senato non elettivo: che differenza c’è con una camera di nominati? Meglio chiuderlo. O, forse, meglio aprire le teste a qualche pensiero veramente innovativo. Questa sì che sarebbe una riforma.
 l nuovo leader del PD non è confrontabile con Massimo D'Alema: l'inciucio avvenne quando Berlusconi era in maggioranza, Renzi lo ha resuscitato quando era ormai fuori dal gioco perché condannato per frode fiscale. Dal blog
l nuovo leader del PD non è confrontabile con Massimo D'Alema: l'inciucio avvenne quando Berlusconi era in maggioranza, Renzi lo ha resuscitato quando era ormai fuori dal gioco perché condannato per frode fiscale. Dal blog
idomini, 19 gennaio 2014
Basta leggere i giornali di centrodestra di oggi, e meglio ancora il ‘mattinale’ di Forza Italia, per fare al volo il conto dei vantaggi e degli svantaggi innescati dall’incontro di ieri fra Renzi e Berlusconi. Fanno sorridere in verità le accorte profezie sulla durata del governo Letta, da ieri ”ancorato” a un programma di riforme istituzionali che dovrebbe tenerlo in vita per almeno un anno. La verità è che d’un balzo i pesi dei giocatori in campo sono stati completamente redistribuiti. Letta (nipote) avrà pure più tempo davanti (e poi chissà, vatti a fidare), ma dipende in tutto e per tutto da Renzi e dal patto di Renzi con Berlusconi (e con Letta zio), non più da Giorgio Napolitano il quale esce a sua volta a dir poco ridimensionato, se non strategicamente sconfitto, dallo storico incontro. Angelino Alfano ha praticamente un cappio alla gola, e se aveva fatto conto, per sopravvivere, su una svolta proporzionalista adesso deve cominciare a meditare i termini di un rientro nella casa bipolare del Capo. Silvio Berlusconi è di nuovo al centro della scena (qualcuno aveva davvero creduto che ne restasse fuori solo perché giuridicamente decaduto?). Il Pd, che solo domani discuterà la proposta di legge elettorale messa a punto dal suo segretario col Cavaliere, è ridotto a quello cui ha voluto ridursi, un’appendice del leader (ricorda qualcosa?). La legge elettorale infine, posta in gioco solo apparente dello storico incontro, è più che mai in alto mare, perché è tutta da verificare la congruenza fra il disegno di R-B e le indicazioni della Corte costituzionale: e dunque, alla fine, anche il come e il quando delle prossime elezioni è tutto da vedere.
Fine del conto al volo. Il quale spazza via in un batter d’occhio l’isterica caciara formalistica fra antirenziani e antiberlusconiani da un lato e filorenziani e filoberlusconiani dall’altro sull’opportunità o meno dell’incontro che ha tenuto banco nelle quarantotto ore precedenti. Dimostrando l’ovvio, e cioè che se è lecito, e perfino dovuto, consultare sulla legge elettorale il leader (decaduto per frode fiscale) del secondo partito, che quest’ultimo ne esca più o meno rilegittimato dipende dal ”come” della consultazione stessa. E il ”come” non si riduce affatto al luogo dell’incontro, alla soglia simbolica del Nazareno o alle (poche) uova marce lanciate contro il Cavaliere. Il come è sostanza, e sta nelle due paroline magiche che Renzi ha scelto per siglare la serata: ”profonda sintonia”. Una sintonia che non va riferita purtroppo solo al risultato dell’incontro, ma alle sue premesse.
Giova fare in proposito un esercizio – impopolare – di confronto col passato. Non sono pochi coloro, a partire da Marco Travaglio, che oggi derubricano le responsabilità di Renzi riconducendole alle ventennali responsabilità dei leader del Pds-Ds-Pd, in primis Massimo D’Alema, nel ”legittimare” Berlusconi. Il rottamatore non avrebbe fatto altro, in sostanza, che allinearsi con i rottamati. Peccato che il paragone fra Renzi e D’Alema non stia in piedi. Nel ’96, quando prese inizio l’avventura spericolata della Bicamerale che avrebbe dovuto riscrivere con Berlusconi mezza Costituzione, Berlusconi aveva la maggioranza assoluta dei voti: aveva stravinto le elezioni nel ’94, le aveva perse nel 96 ma d’un soffio, e non per un calo di voti. L’impatto revisionista della sua ”nuova destra” – che agitava, va ricordato e non lo si ricorda mai, la minaccia di un’assemblea costituente in cui sarebbe stata maggioranza – era enorme, e il tentativo di ”imbrigliarlo” nella riscrittura delle regole era volto non a legittimarlo, ma a contenerlo. Fu un tentativo perdente, perché il progetto di Berlusconi era un progetto eversivo, irriducibile alla legalità e al galateo costituzionale: e questa è storia del ventennio passato. Ma oggi, Berlusconi non ha la stessa forza elettorale di allora, e il suo progetto eversivo nemmeno: la sua irriducibilità alla legalità, com’è noto, gli si è rivoltata contro, il suo declino è stato sancito giuridicamente, le sue ricette neoliberiste non hanno retto alla prova tragica della crisi degli ultimi anni, la sua riforma della Costituzione, approvata senza l’apporto del centrosinistra, è stata sconfitta dal referendum del 2006. Oggi sì, dunque, richiamarlo in campo significa ri-legittimarlo ben al di là della sua legittimazione effettiva. E significa soprattutto un’altra cosa: che questa rilegittimazione è possibile perché implica una completa interiorizzazione della sua agenda. ”Profonda sintonia”, appunto: non solo – si badi – sulla legge elettorale, ma sulla revisione della Costituzione, della forma di Stato (la riforma del federalismo) e di governo (il combinato disposto far legge elettorale e riforma del bicameralismo).
Il tema dunque va spostato: dalla ”resurrezione” di Berlusconi – che per quanto sia stupefacente non è una novità, data la pervicacia del centrosinistra nell’ucciderlo giudiziariamente senza seppellirlo politicamente – all’intronamento a furor di media e di primarie di Matteo Renzi. Spiace per quanti, a partire da Repubblica, avevano salutato nel giovane segretario del Pd l’avvento del tempo nuovo e oggi si ritrovano risospinti improvvisamente nel vecchio: ma per chi avesse occhi per vedere, la ”profonda sintonia” fra l’agenda di Renzi e quella di Berlusconi era chiara, chiarissima, ben prima dello storico incontro. Paradossalmente non ha tutti i torti il cinismo dei giovani dirigenti più vicini al segretario, quando dicono che Renzi può ricevere il Cavaliere senza temerne l’impatto personale. In gioco infatti non c’è solo né tanto la rilegittimazione della persona Berlusconi, quanto la legittimazione da sinistra della sua eredità. Ovvero l’ammissione, da sinistra, che tutto sommato aveva ragione lui su tutto, e che basta fare meglio di lui le cose che voleva fare lui per ”cambiare verso” al paese. Questo e non altro è il senso della ”profonda sintonia”.
L’Unità, 19 gennaio 2014
Una lista con Tsipras alla Commissione Europea, l’appello degli intellettuali. La promuovono Andrea Camilleri, Paolo Flores d’Arcais, Luciano Gallino, Marco Revelli, Barbara Spinelli, Guido Viale. L'appello (i
l fatto quotidiano) e lr prime adesioni (il manifesto), 18 e 19 gennaio 2014
Il Fatto quotidiano, 18 gennaio 2014
La lista per le elezioni europee a cui proponiamo di dar vita con questo documento sarà una lista di cittadinanza assolutamente autonoma, promossa da personalità della cultura, dell’arte e della scienza e da esponenti di comitati, associazioni, movimenti e organismi della società civile che ne condividono gli obiettivi e i contenuti, e che non verrà “negoziata” con alcun partito. Questo sia per segnare una netta discontinuità con il passato, sia per sottolineare la novità di questa proposta: l’adesione a questa lista elettorale non deve essere confusa con l’affiliazione ad alcuno dei partiti esistenti o in fieri e non ha alcuna pretesa identitaria.
Questa lista avrà un comitato di garanti formato tra i firmatari dell’appello, che non si candideranno. Avrà un comitato promotore, con compiti operativi.
Su questa base le realtà organizzate come i partiti, o loro strutture, le associazioni politiche o culturali, i centri sociali – che vorranno sostenere questo progetto sono le benvenute e possono contribuire al suo successo anche presentando proposte di candidatura di propri iscritti, purché rispondenti alle caratteristiche indicate nell’appello. E potranno sostenere la lista, la raccolta delle firme e le attività connesse alla campagna elettorale, costituendosi in uno o più comitati di sostegno dotati della più ampia autonomia, seguendo il modello già adottato nella campagna per i referendum contro la privatizzazione dell’acqua e dei sevizi pubblici locali, modalità che ha garantito il successo in quella iniziativa referendaria.
L'APPELLO
Per questo facciamo nostre le proposte di Alexis Tsipras, leader del partito unitario greco Syriza, e nelle elezioni europee del 25 maggio lo indichiamo come nostro candidato alla presidenza della Commissione Europea. Il suo paese, la Grecia, è stato utilizzato come cavia durante la crisi ed è stato messo a terra: in quanto tale è nostro portabandiera. Tsipras ha detto che l’Europa, se vuol sopravvivere, deve cambiare fondamentalmente. Deve darsi i mezzi finanziari per un piano Marshall dell’Unione, che crei posti di lavoro con comuni piani di investimento e colmi il divario tra l’Europa che ce la fa e l’Europa che non ce la fa, offrendo sostegno a quest’ultima. Deve divenire unione politica, dunque darsi una nuova Costituzione: scritta non più dai governi ma dal suo Parlamento, dopo un’ampia consultazione di tutte le organizzazioni associative e di base presenti nei paesi europei.
Deve respingere il fiscal compact che oggi punisce il Sud Europa considerandolo peccatore e addestrandolo alla sudditanza, e che domani punirà, probabilmente, anche i paesi che si sentono più forti. Al centro di tutto, deve mettere il superamento della disuguaglianza, lo stato di diritto, la comune difesa di un patrimonio culturale e artistico che l’Italia ha malridotto e maltrattato per troppo tempo. La Banca centrale europea dovrà avere poteri simili a quelli esercitati dalla Banca d’Inghilterra o dalla FED, garantendo non solo prezzi stabili ma lo sviluppo del reddito e dell’occupazione, la salvaguardia dell’ambiente, della cultura, delle autonomie locali e dei servizi sociali, e divenendo prestatrice di ultima istanza in tempi di recessione. Non dimentichiamo che la Comunità nacque per debellare le dittature e la povertà. Le due cose andavano insieme allora, e di nuovo oggi.
Oggi abbiamo di fronte una grande questione ambientale di dimensioni planetarie, che può travolgere tutti i popoli, e un insieme di politiche tese a svalutare il lavoro, mentre una corretta politica ambientale può essere fonte di nuova occupazione, di redditi adeguati, di maggiore benessere e di riappropriazione dei beni comuni. È il motivo per cui contesteremo duramente il mito della crescita economica così come l’abbiamo fin qui conosciuta. Esigeremo investimenti su ricerca, energie rinnovabili, formazione, trasporti comuni, difesa del patrimonio culturale. Sappiamo che per una riconversione così vasta avremo bisogno di più, non di meno Europa.
Proprio come Tsipras dice riferendosi alla Grecia, in Italia tutto questo significa rimettere in questione due patti-capestro. Primo, il fiscal compact: il pareggio di bilancio che esso prescrive è entrato proditoriamente nella nostra costituzione, l’Europa non ce lo chiedeva, limitandosi a indicare sue «preferenze». Secondo, il patto di complicità che lega il nostro sistema politico cleptocratico alle domande dei mercati: chiediamo una politica di contrasto contro le mafie, il riciclaggio, l’evasione fiscale, la protezione e l’anonimato di capitali grigi, la corruzione, in un’Europa dove non sia più consentito opporre il segreto bancario alle indagini della magistratura. Significa infine difendere la Costituzione nata dalla Resistenza, e non violarne i principi base come suggerito dalla JP Morgan in un rapporto del 28 maggio 2013, cui i governanti italiani hanno assentito col loro silenzio. Significa metter fine ai morti nel Mediterraneo: i migranti non sono un peso ma il sale della crescita diversa che vogliamo. Significa darsi una politica estera, non più al rimorchio di un paese– gli Stati Uniti– che perde potenza ma non prepotenza. La pax americana produce guerre, caos, stati di sorveglianza. È ora di fondare una pax europea.
Le larghe intese, le rifiutiamo in Italia e in Europa: sono fatte per conservare l’esistente. Per questo diciamo no alla grande coalizione parlamentare che si prepara fra socialisti e democristiani europei, presentandoci alle elezioni di maggio con una piattaforma di sinistra alternativa e di rottura. Nostro scopo: un Parlamento costituente, che si divida fra immobilisti e innovatori. Siamo sicuri fin d’ora che gran parte dei cittadini voglia proprio questo: non l’Unione mal ricucita, non la fuga dall’Euro, ma un’altra Europa, rifatta alle radici. La chiediamo subito: il tempo è scaduto e la casa di tutti noi è in fiamme, anche se ognuno cercasse rifugio nella sua tana minuscola e illusoria.
L’Italia al bivio
Questo è l’orizzonte. A partire da qui avanziamo la proposta di dare vita in Italia a una lista che alle prossime elezioni europee faccia valere i principi e i programmi delineati.
Una lista promossa da movimenti e personalità della società civile, autonoma dagli apparati partitici, che sia una risposta radicale alla debolezza italiana. Una lista composta in coerenza con il programma, che candidi persone, anche con appartenenze partitiche, che non abbiano avuto incarichi elettivi e responsabilità di rilievo nell’ultimo decennio.
Una lista che sostiene Tsipras ma non fa parte del Partito della Sinistra Europea che lo ha espresso come candidato. I nostri eletti siederanno nell’europarlamento nel gruppo con Tsipras (GUE-Sinistra Unitaria europea). Una lista che potrà essere sostenuta, come nel referendum acqua, dal più grande insieme di realtà organizzate e che non si manterrà con i rimborsi elettorali.
Una lista che con Tsipras candidato mobiliti cittadine e cittadini verso un’Altra Europa.
Sono numerose le adesioni all’appello «A sinistra, una lista per Tsipras» lanciato ieri da Andrea Camilleri, Paolo Flores d’Arcais, Luciano Gallino, Marco Revelli, Barbara Spinelli e Guido Viale. In questa pagina rendiamo note le prime, ma la pubblicazione continuerà nei prossimi giorni.
Questa lista avrà un comitato di garanti formato tra i firmatari dell’appello, che non si candideranno.
Avrà un comitato promotore, con compiti operativi. Su questa base le realtà organizzate — e i partiti, o loro strutture, le associazioni politiche o culturali, i centri sociali — che vorranno sostenere questo progetto sono le benvenute e possono contribuire al suo successo anche presentando proposte di candidatura di propri iscritti, purché rispondenti alle caratteristiche indicate nell’appello. E potranno sostenere la lista, la raccolta delle firme e le attività connesse alla campagna elettorale, costituendosi in uno o più comitati di sostegno dotati della più ampia autonomia, seguendo il modello già adottato nella campagna per i referendum contro la privatizzazione dell’acqua e dei sevizi pubblici locali, modalità che ha garantito il successo in quella iniziativa referendaria.
Di seguito il primo nucleo di adesioni:
Mario Agostinelli, Andreina Albano, Gaetano Azzariti, Giuliana Beltrame, Alberto Burgio, Loris Campetti, Luca Casarini, Franco Chiarello,Giovanni Carrosio, Furio Colombo, Gildo Claps, Emmanuele Curti, Giorgio Dal Fiume, Marco D’Eramo, Tommaso Di Francesco, Monica Di Sisto, Andrea Di Stefano, Gianni Ferrara, Carlo Freccero, Francesco Garibaldo, Domenico Gattuso, Alfonso Gianni, Alessandro Gilioli, Paul Ginsborg, Fabio Grossi, Leo Gullotta, Monica Lanfranco, Teresa Masciopinto, Katia Mastantuono, Valerio Mastrandrea, Antonio Mazzeo, Sandro Medici, Tomaso Montanari, Roberto Musacchio, Maso Notarianni, Giovanni Orlandini, Moni Ovadia, Giovanni Palombarini, Giorgio Parisi, Angela Pascucci, Antonello Patti, Fulvio Perini, Tonino Perna, Paolo Pietrangeli, Nicoletta Pirotta, Felice Roberto Pizzuti, Gabriele Polo, Gianni Rinaldini, Tiziano Rinaldini, Umberto Romagnoli, Riccardo Rossi, Edoardo Salzano, Antonia Sani, Andrea Segre, Patrizia Sentinelli, Stefano Sylos Labini, Anna Simone, Massimo Torelli, Giolì Vidigni.
Secondo il fondatore di Repubblica Matteo Renzi ha riportato Berlusconi al centro della politica italiana, gli concedendo al colpevole di furto allo Stato l'atto di clemenza che Giorgio Napolitano gli ha negato, e tuttavia va bene così. Viviamo in un mondo di poeti, se è vero che “è del poeta il fin la meraviglia”. La Repubblica, 19 gennaio 2014
La vera — e formidabile — bravura di Silvio è sempre stata quella d’incantare la gente, ma è la stessa bravura di Matteo che sa incantare la gente come Silvio e anche di più ora che Silvio è vecchio e fisicamente un po’ provato. Matteo è un Silvio giovane dal punto di vista dell’incantamento e quindi più efficace.
Adesso il suo problema sarà quello di convincere Alfano a contentarsi. Gli ha offerto uno stock di seggi basati sul proporzionale ma corretti da un maggioritario assicurato dal premio di maggioranza che le liste dei partiti maggiori otterranno. Alfano avrà meno di quanto sperasse col doppio turno continuando tuttavia ad esistere, ma con Silvio l’Ispanico restituito al suo ruolo di salvatore della Patria. È terribilmente scomoda per Alfano una convivenza di questo genere. O si oppone al compromesso che gli viene proposto o il suo movimento finirà di nuovo nelle braccia di Berlusconi. Questo è il dilemma che dovrà sciogliere nelle prossime quarantott’ore.
C’è tuttavia un aspetto di questa situazione politica: è interesse della democrazia italiana l’esistenza d’una destra moderata, repubblicana ed europeista, che restauri l’alternanza tra le due ali dello schieramento nell’ambito di quei principi sui quali è nata la democrazia europea simboleggiata dalla bandiera tricolore: libertà, giustizia, fraternità. In Italia ci fu la destra storica dopo la quale cominciò il gioco malandrino del trasformismo con interruzioni di governi autoritari comunque mascherati. Alfano può non piacere, non è certo un personaggio attraente, carisma zero, intelligenza politica dubitabile, ma non c’è solo lui in questa prima esperienza di destra moderata, ci sono Lupi, Cicchitto, Quagliariello. Siamo comunque ad un primo esperimento, ma merita di non essere schiacciato e ributtato indietro. È una mossa intelligente quella di Renzi di avergli offerto una ciambella di salvataggio, ma la ciambella funziona se il mare è calmo e la costa è vicina. Con Berlusconi risuscitato la costa è assai lontana e il mare in tempesta. Questo è il punto che Alfano e i suoi dovranno valutare con la massima attenzione.
Nel frattempo la recessione economica sembra aver toccato il fondo cominciando a risalire. I dati per la prima volta registrano un aumento dei fatturati; la speranza è che i consumi riprendano e il «credit crunch» delle banche abbia finalmente una fine. La Commissione della Ue, si spera ed è probabile, darà un giudizio favorevole sulla politica economica italiana, specialmente per quanto riguarda le privatizzazioni e la revisione delle spese superflue. Le privatizzazioni consentiranno una diminuzione consistente del debito pubblico, la riduzione della spesa e l’appoggio dell’Europa potrebbero liberare risorse per incentivare la domanda interna ed anche quella estera. Il trattato con la Svizzera sui capitali italiani depositati nelle banche di quel Paese è vicino alla sua conclusione e ci darà una congrua disponibilità di nuove risorse.
Insomma tra un anno il rilancio dello sviluppo potrebbe essere consolidato e i riflessi su investimenti e occupazione potrebbero essere consistenti. Non siamo certo in grado di giudicare se Renzi sarà lieto di questo risultato, ma tutti gli italiani ne saranno confortati e la rabbia sociale sarà confinata in piccole minoranze. Il Silvio Ispanico si attribuirà tutti i meriti. È sempre avvenuto e sarà ancora una volta così. Speriamo soltanto che gli italiani che credono nelle favole siano meno numerosi di oggi e i partiti più idonei a capire le differenze tra cultura politica e improvvisazione. Ci vogliono tutte e due queste capacità, una sola è una sciagura.
 Che altro dire! Se non che ha ragione chi dice che il fomdo dell'abisso è sempre più in basso di quanto si potesse pensare.
Che altro dire! Se non che ha ragione chi dice che il fomdo dell'abisso è sempre più in basso di quanto si potesse pensare.
Il manifesto, 18 gennaio 2014
E' sbocciato un amore, una «profonda sintonia» fra il Pd e Forza italia. O meglio, fra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Forse non è ancora un accordo, i dettagli sono tutti da definire, e potrebbero essere la buccia di banana su cui far scivolare il governo verso le elezioni. Ma quando una sintonia è «profonda» risulta molto difficile per chiunque — soprattutto nella maggioranza di governo — disturbarla facendo «la voce grossa». Specialmente quando si hanno percentuali elettorali a una cifra («non permetteremo il ricatto dei piccoli partiti», è l’avvertimento di Renzi).
Dopo più di due ore di faccia a faccia e una breve dichiarazione ai giornalisti, il segretario del Pd ha dato appuntamento a lunedì quando nella direzione del partito arriverà la proposta di legge elettorale e di riforma costituzionale. Dunque manca qualche ora per cercare un «patto» nella maggioranza. Tuttavia dentro la partita politica ieri se ne è giocata un’altra, fortemente simbolica.
Nessuna telecamera ha mostrato immagini dell’incontro (per pudore residuo, per vergogna, per paura dell’impopolarità?), che nessuno poteva immaginare qualche settimana fa, soprattutto dopo la cacciata di un pregiudicato dal Parlamento: la scelta di Renzi ha di fatto riabilitato un leader dimezzato dai guai giudiziari.
Forse il segretario del Pd voleva cancellare la sua profonda incoerenza, facendo dimenticare certe frasi roboanti che appena qualche mese fa era diventate titoli di prima pagina. Dopo la sentenza della Cassazione «per Berlusconi la partita è finita, game over», disse compiaciuto per aver azzeccato la battuta giusta. Ma per i politici la coerenza non è una virtù e il giovane Renzi contraddice clamorosamente la sua liquidatoria battuta ricevendo il leader di Forza Italia addirittura nella sede del Partito democratico. Un atto di arroganza dunque verso il suo stesso partito, anche se non verso la storia, basti ricordare i rapporti con D’Alema e con Veltroni.
Ma ora la situazione è diversa: in nessun paese normale può accadere che a decidere le riforme (elettorali e costituzionali) venga chiamato un personaggio che i magistrati stanno per assegnare ai servizi sociali o agli arresti domiciliari. E siccome la forma è sostanza questa sfida simbolica dice molto dell’invulnerabilità da cui Renzi si sente protetto. Un uomo solo al comando dopo il plebiscito delle primarie. Che umilia almeno una parte dell’elettorato del Pd.
Il braccio di ferro tra il segretario, il presidente del consiglio e la maggioranza di governo è arrivato al punto di massima tensione, moltiplicatore di un conflitto nel Partito democratico ancora frastornato dal cambio dei vertici e dalla geografia mobile delle correnti. Per certi versi sembra di assistere ai vecchi riti democristiani quando il segretario Dc attaccava il governo Dc le cui sorti erano alla fine decise dal gioco delle correnti di piazza del Gesù.
Perché somiglia molto ad un gioco democristiano questa triangolazione tra Letta, Renzi e Alfano che cercano di farsi lo sgambetto per poi meglio accordarsi e chiudere la partita della legge elettorale in modo che soddisfi le esigenze di tutti. Però quando al tavolo è seduto anche Berlusconi c’è sempre il rischio che decida di ribaltarlo. E a pensarci bene, che a decidere sul futuro del nostro Paese sia un pregiudicato non è umiliante solo per un partito, ma per tutti.
 Intervista all’intellettuale americano che spiega le sue teorie e le sue radicali opinioni politiche «Ci sono due ombre scure che incombono su ogni considerazione riguardo al futuro: la catastrofe ambientale e la guerra nucleare. La prima è già tristemente una realtà; l’altra è un rischio sempre presente che non accenna a dissolversi».
Intervista all’intellettuale americano che spiega le sue teorie e le sue radicali opinioni politiche «Ci sono due ombre scure che incombono su ogni considerazione riguardo al futuro: la catastrofe ambientale e la guerra nucleare. La prima è già tristemente una realtà; l’altra è un rischio sempre presente che non accenna a dissolversi».
La Repubblica, 18 gennaio 2014
«Non penso che ci sia un politico che abbia mai prestato una qualche attenzione a ciò che scrivo, dico o faccio». A 85 anni, Noam Chomsky si rende bene conto che pure essere uno degli intellettuali più ascoltati del pianeta, non cambia la direzione che il mondo ha preso. Il grande linguista americano, a partire dagli anni Settanta, ha scelto seriamente la strada del pensiero e dell’attivismo politico che lo ha portato oggi a essere l’interlocutore privilegiato nei dialoghi sui problemi di ordine mondiale. Una raccolta dei suoi saggi politici, I padroni dell’umanità (Ponte alle Grazie, in libreria il 23), mette ora in fila tutte le sue risposte, generalmente volte a condannare i sistemi neoliberisti e neocolonialisti. Nel frattempo la sua idea di una grammatica universale (facoltà mentale comune a tutti gli individui) e la teoria della grammatica generativa (l’insieme, finito, delle regole che danno luogo alle potenzialmente infinite formulazioni delle frasi) hanno iniziato a camminare da sole: «La grammatica generativa è ormai una scienza, – dice – e come tale raccoglie i risultati prodotti dalla partecipazione collettiva di tanti studiosi». Il 25 gennaio a Roma, all’interno del Festival delle Scienze, Chomsky terrà una lezione magistrale in cui parlerà del linguaggio e della mente. Ma il pubblico italiano potrà incontrarlo anche la sera prima in un curioso spettacolo musicale, Conversazioni con Chomsky,
una talk-opera multimediale del compositore Emanuele Casale, ove il linguista parteciperà a «una sessione di domande sugli argomenti della linguistica, dell’economia e della politica, anche italiana»…
Professor Chomsky, lei parteciperà a un’opera musicale. Si dice spesso che la musica sia un linguaggio universale. Ma, innanzi tutto, la musica è un linguaggio?
«Il concetto di linguaggio nell’uso comune è vago e informale. È comunque possibile formulare almeno alcune chiare domande. Per esempio quali relazioni ci sono tra musica e linguaggio umano? Ci sono studi su questo e molte idee interessanti ma la domanda generale non ha risposta. È come domandarsi se gli aeroplani volino (certo, ma non come le aquile) o se i sottomarini nuotino (non proprio come delfini). Sono faccende che hanno a che fare con le metafore che scegliamo di accettare, non sono questioni fattuali».
Cosa differenzia il linguaggio verbale dagli altri sistemi di segni (suoni, figure, gesti)?
«È importante ricordare che il linguaggio umano non è necessariamente verbale. Può essere espresso attraverso suoni, il modo più comune, o segni grafici. Come abbiamo scoperto in anni recenti, molti linguaggi simbolici che sono nati nel mondo sono particolarmente simili ai linguaggi orali. A ogni modo il linguaggio umano differisce da altri sistemi di segni in alcuni importanti aspetti: struttura, uso, rappresentazione neuronale. È stato anche scoperto che lo stesso gesto può funzionare in maniera diversa se viene usato in un sistema di segni o se in un contesto non linguistico. Le proprietà fondamentali del linguaggio umano appaiono uniche e sono probabilmente emerse relativamente di recente rispetto al processo evolutivo. La facoltà del linguaggio sembra essere ampiamente dissociata da altri sistemi cognitivi umani e completamente differente dai sistemi di comunicazione animali».
Se il linguaggio è generato dalla grammatica e la grammatica fondata su strutture foniche, si potrebbe dire che il linguaggio si origina più probabilmente dal suono che dal segno?
«Quello che possiamo dire è che il suono è solo una delle forme di esternalizzazione del linguaggio e non sembra essere essenziale della sua natura. Concordo con la tradizione che tende a considerare il linguaggio primariamente uno strumento del pensiero e la sua esternalizzazione, in una o un’altra modalità, un processo secondario. È tuttavia vero che i segni grafici sono cosa piuttosto recente nella storia dell’uomo, tra l’altro solo in certe culture, e che non possano essere collegati all’origine del linguaggio».
Cosa pensa delle recenti ricerche neurolinguistiche? I risultati scientifici mettono a tacere la lunga diatriba tra “innatismo” e “comportamentismo”?
«Nonostante io abbia sempre trovato fuorviante parlare di dibattito tra “comportamentismo” e “innatismo” (e soprattutto su questa parola bisognerebbe accordarsi, perché non ha un significato ben definito), non si può seriamente dubitare che ci sia un alto numero di fattori innati che entrano in ogni aspetto della funzione cognitiva. L’unica alternativa è la magia. Il lavoro scientifico è determinare questi fattori: per esempio, qual è la dote biologica che rende il bambino, e non un altro organismo, in grado di sviluppare le capacità che io e lei stiamo usando ora? E così domande simili sulle facoltà mentali e non. Anche i comportamentisti ormai credono a fattori innati».
Se il linguaggio dà forma all’esperienza, quanto i problemi del mondo dipendono dal linguaggio?
«Difficile pensare che esista un’attività umana in cui il linguaggio non sia direttamente coinvolto. Dire che ci sia una dipendenza dal linguaggio è plausibile ma è una questione davvero troppo seria e indefinita per esaminarla».
Il suo ultimo libro si intitola I padroni dell’umanità. Chi sono costoro?
«I centri corporativi delle società industriali avanzate vogliono farsi ricordare come i padroni dell’umanità. Il termine è preso in prestito da una frase di Adam Smith: “la vile massima dei padroni dell’umanità: tutto per noi, niente per gli altri”. È esattamente la proprietà istituzionale delle società capitaliste ».
Lei scrive che potere e verità sono in conflitto e che gli intellettuali o ricercano la verità o comandano. È dunque impossibile il governo dei filosofi sognato da Platone?
«Bakunin predisse che il governo dalla classe emergente della scientific intelligentsia avrebbe portato alle peggiori e brutali autocrazie della storia umana. È risultata un’osservazione lungimirante. Non c’è dunque ragione per aspettarsi che il governo dei filosofi, o quello di una qualsiasi altra élite, sia migliore».
Tra i temi che le stanno più a cuore c’è l’ambiente. Quali rischi dobbiamo temere maggiormente?
«Ci sono due ombre scure che incombono su ogni considerazione riguardo al futuro: la catastrofe ambientale e la guerra nucleare. La prima è già tristemente una realtà; l’altra è un rischio sempre presente che non accenna a dissolversi, è quasi un miracolo che siamo scappati a un disastro nucleare non così tanto tempo fa. Pessimismo e ottimismo sono questioni soggettive, non sono importanti: qualunque sia il proprio stato d’animo, le azioni da intraprendere sono essenzialmente le stesse».
idadominijanni, 16 gennaio 2014
Fu durante un convegno sul quarantennale del Sessantotto, più di cinque anni fa, che Margarethe Von Trotta mi anticipò che stava lavorando a un film sulla vita di Hannah Arendt. Ardua scommessa, pensai e le risposi provando a immaginare come si potesse restituire la complessità della vita, del pensiero e della persona di Arendt in un film di due ore. Ma Margarethe le scommesse, se non sono ardue, non le prende nemmeno in considerazione; e fino a quel momento le aveva vinte tutte: con Anni di piombo (Leone d’oro a Venezia 1981), con Rosa Luxemburg (1986), con Rosenstrasse (20013).
Ha vinto anche questa. Presentato al festival di Toronto del 2012, Hannah Arendt( coproduzione Germania-Lussemburgo-Francia-Israele) è uscito nel frattempo con acclamazione di critica e di pubblico negli Stati uniti (uno dei dieci film migliori del 2013 secondo il ) e in tutta Europa salvo che in Italia, dove pare che le sale non ritengano commestibile la storia di una ignota filosofa: un bel sintomo dello stato dell’arte nel nostro paese. La distribuzione (Ripley’s film e Nexo Digital) approfitta dunque della Giornata della memoria per mandarlo in 70 sale e 19 città il 27 e 28 febbraio prossimi, e della ripubblicazione per Feltrinelli de La banalità del male per diffonderlo in formato digitale. Il resto lo faranno scuole, università e circuiti culturali interessati.
In coppia con la cosceneggiatrice americana Pam Katz (ma sono donne anche la produttrice Bettina Brokemper, la direttrice della fotografia Caroline Champetier, la montatrice Bettina Böler), Von Trotta sceglie gli anni fra il 1960 e il 1964 per condensare vita e pensiero di una delle protagoniste assolute del Novecento. Reincarnata in una strepitosa Barbara Sukowa, Hannah vive a New York dal 1941, dopo la fuga in Francia dalla Germania di Hitler nel ’33, l’internamento nel campo di detenzione di Gurs e l’esodo oltreoceano con la madre e il secondo marito, Heinrich Blücher, il comunista tedesco autodidatta incontrato a Parigi e sposato nel ’40.
Sfondando – giustamente – il confine fra privato e pubblico che Arendt mantenne come un punto fermo della sua filosofia, il film restituisce assieme la dimensione personale e politica di Hannah, le amicizie e l’insegnamento, gli amori e il pensiero, incastonati fra la decisione di andare a Gerusalemme per seguire il processo a Eichmann e il discorso tagliente tenuto alla New School per rispondere agli attacchi suscitati dal suo reportage del processo sul New Yorker, con le tesi esplosive sulla ”banalità del male” perpetrato da Eichmann nonché sulla ”cooperazione” dei vertici della comunità ebraica tedesca con le deportazioni.
Esplosive allora e dopo (Von Trotta: «io stessa ho potuto recepirle appieno solo dopo la caduta del Muro di Berlino»), perché insopportabili tanto per la cultura antinazista, rassicurata dall’idea della mostruosità eccezionale di quel male di cui Arendt svelava invece la banale normalità, tanto per la comunità ebraica, rassicurata dalla certezza dell’innocenza assoluta delle vittime. Non solo la comunità intellettuale newyorkese ma tutto il mondo affettivo di Hannah ne resta terremotato: i colleghi che la invitano a dimettersi dall’insegnamento, gli amici ebrei che le voltano le spalle, Hans Jonas, il più antico fra loro, che l’accusa di far prevalere in lei l’arroganza dell’intelligenza tedesca sulle radici ebraiche.
E’ il nocciolo anti-identitario e ”non allineato” del pensiero di Arendt che ci convoca e ci parla tutt’ora, ogni giorno e in ogni circostanza in cui la certezza dell’appartenenza va a discapito della comprensione dei fatti. Così come tutt’ora ci parla la battaglia di Hannah per non rinunciare alla pubblicazione del suo reportage sul New Yorker: allora come oggi, c’è sempre un caporedattore o una caporedattrice zelante (per inciso, uno dei personaggi più vivi del film) che ti dice che pensi troppo liberamente per vendere, o che sei troppo filosofa per fare del buon giornalismo.
C’è nel film questo nocciolo, che si forma nella testa di Hannah durante il processo al criminale nazista che «siede nella gabbia di vetro come un fantasma e non è per niente terribile»; ma non c’è solo questo. C’è l’amicizia di Hannah con Mary Mc Carthy (Janet McTeer) e Lotte Köhler (fonte diretta della sceneggiatura), quell’amicizia femminile che fu un filo d’acciaio della «non femminista» Arendt ed è un filo d’acciaio della filmografia di Von Trotta, da Sorelle a Anni di piombo a Rosenstrasse. C’è il controverso rapporto d’amore fra Hannah e il suo maestro Martin Heidegger, una sorta di passato che non passa e che non cessa di tornare, fra la gratitudine e l’incubo, nei ricordi e nel sonno, irrinunciabile malgrado e contro l’adesione di Heidegger al nazismo.
C’è, ancor più irrinunciabile, il rapporto con la lingua materna, che s’impone negli esuli contro l’inglese ogni volta che c’è da discutere di qualcosa in cui ne va di se stessi (il film alterna infatti le due lingue, e per fortuna non sarà doppiato in italiano). C’è infine e soprattutto, come ha notato il NYT, non solo il pensiero ma il pensare di Arendt, quella sua peculiare capacità di fare la spola fra i fatti e la teoria, fra l’evento e il concetto, che ne ha fatto la grandezza e che Barbara Sukova lascia srotolare fra una sigaretta e l’altra, fra una nottata alla macchina da scrivere e un riposino diurno sul divano, vita activasenza soste e missione senza tempo. Erano i favolosi anni Sessanta, quando a New York si poteva ancora fumare perfino in un’aula della New School, e chissà se pure per questo il pensiero volava più libero.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale la legge elettorale c'é e non produce "frantumazione parlamentare". In realtà vogliono che la maggioranza relativa diventi maggioranza assoluta e domini indisturbata: come fece Mussolini nel 1924 e tentò Scelba nel 1953 con la "legge truffa". L'Unità, 17 gennaio 2014
Caro Direttore, ora che la Consulta ha depositato le motivazioni della sentenza ed il «premio di maggioranza» è stato archiviato come «incostituzionale», le conseguenze di questo passaggio d’epoca che chiude il ventennio «maggioritario» meritano di essere messe in chiaro.
1) Ormai la legge elettorale c’è; è falso che sia urgente inventarne una, quasi a colmare un vuoto. Non c’è un vuoto legislativo. In forza della sentenza, perfezionata a tutti gli effetti con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è attualmente in vigore un sistema proporzionale con sbarramento al 4%. Infatti lo sbarramento attualmente vigente non era compreso nella materia sottoposta al vaglio della Corte: e dunque resta in piedi.
2) È deplorevole che questo specifico dato venga nascosto ai cittadini dai mezzi di comunicazione. Se lo si scrivesse a chiare lettere, i cittadini si chiederebbero che senso abbia l’attuale frenesia alla ricerca di una legge elettorale visto che non solo ce n’è già una, ma c’è anche l’agognato «sbarramento» atto a tranquillizzare chi finge di preoccuparsi della «frantumazione» partitica additata di norma (in discreta malafede) come patologia tipica proporzionale. Frantumazione non ci può dunque essere perché comunque è in vigore lo «sbarramento» al 4%.
Dunque cosa vogliono? Vogliono una legge che consenta ad una maggioranza relativa di diventare, in sede parlamentare, maggioranza assoluta: nel che risiedeva il nucleo fondamentale della legge Acerbo voluta da Mussolini nel 1923 e messa in atto alle elezioni mortifere del 1924. Veicolo di tale miracolo (una minoranza di elettori che produce una maggioranza di eletti) è il famigerato «premio di maggioranza». Per lo meno, la improvvida «legge truffa», bocciata dagli elettori il 7 giugno del 1953, dava il «premio» alla lista (o coalizione) che avesse superato, sia pure di un solo voto, il 50% dei suffragi!
Fingere che si debba escogitare una nuova legge elettorale perché in questo momento ne siamo privi è anche un sopruso: è quasi circonvenzione, come di incapaci, della gran parte dei cittadini-elettori. Il ruolo di stampa, radio, tv può risultare di vera e consapevole complicità.
L’argomento che si ode più spesso ripetere al fine di esorcizzare la legge elettorale proporzionale (con sbarramento) attualmente vigente è che si avrebbe daccapo un Parlamento ingovernabile dato l’arroccamento semi-aventiniano e fatuamente sterile dei «cinquestellanti». Ma già oggi, con un Parlamento eletto con un sistema ultramaggioritario («Porcellum»), il risultato è uguale: l’impossibilità di dar vita ad una maggioranza politica definibile come tale! Dunque si dovrebbe inventare addirittura qualcosa di più mostruoso, di più aberrante del «Porcellum», per superare una siffatta difficoltà.
Essa è dovuta alla scelta di un partito (al quale si accredita un terzo dell’elettorato) di tirarsi fuori da ogni alleanza: tecnica adoperata già dal movimento hitleriano negli ultimi anni di Weimar. Ma una tale scelta non la si sconfigge a colpi di trucchi elettorali, bensì politicamente. Se si è capaci di ciò. E invece su questo terreno per ora nessuno seriamente si cimenta.
Bisogna dunque smetterla di escogitare leggi elettorali più o meno alchemiche fondate sul presupposto seguente: siccome prevedo il risultato, devo provvedere a truccarlo!
Un'intervista alla coraggiosa combattente per la difesa di una Repubblica che rispetti la propria Costituzione e i più elementari diritti umani.
Il manifesto, 16 gennaio 2013
Forse la Lega di Matteo Salvini che va a braccetto con Marine Le Pen ha passato il segno. La ministra per l’Integrazione Cécile Kyenge, non fosse altro che per una questione di toni, questa volta sembra decisa a pretendere un’azione più decisa contro il razzismo. Non per una questione personale, “non sono solo io il bersaglio di certi attacchi razzisti, è la democrazia stessa ad essere in pericolo”. Se tanta determinazione avrà un seguito, allora forse ci dovremo abituare a una ministra che non si limiterà a glissare con classe, o con ironia, alle provocazioni cui viene sottoposta ogni volta che partecipa a un dibattito pubblico. Kyenge è arrabbiata.
Ministra, gli insulti razzisti e le frasi imbecilli continuano. Siamo arrivati al punto che la polizia deve blindare i luoghi che lei frequenta. Lei ha detto che devono essere fermati. In che modo? Pensa che ci siano gli estremi per impedire l’assedio dei leghisti?
A questo punto penso che sia necessario e urgente mettere in campo un’azione politica forte, dico questo non solo per difendere la mia persona ma soprattutto per tutelare ogni tipo di diversità da questi attacchi intollerabili. La ministra Kyenge è solo un pretesto, io vengo attaccata e strumentalizzata per colpire un simbolo che va ben al di là della mia persona: il vero obiettivo è la democrazia. Ricopro un ruolo politico con una carica importante, sono un ministro della Repubblica italiana, e vengo colpita per portare avanti un discorso pericolosissimo che genera paura e intolleranza. E’ questo un tentativo che bisogna assolutamente fermare in ogni modo. Dobbiamo ritrovare l’orgoglio delle nostre istituzioni.
Per Roberto Maroni anche gli insulti sono solo critiche legittime e nessun leghista sembra pentito per il basso livello di certi attacchi.
Prima di tutto vorrei ricordargli che lui è un leader di un gruppo politico e recentemente ha anche ricoperto un ruolo importante e delicato come ministro degli Interni, per questo dovrebbe cogliere l’opportunità di dire cose diverse a questo proposito. Questi sono fatti gravi che non riguardano solo la mia persona e un politico serio li deve sempre condannare.
Cosa intende quando dice che serve una reazione politica forte? In Italia esiste già una legge che punisce il reato di istigazione all’odio razziale.
Sì certo, esiste, ma io credo che ci siano delle modalità di intervento ancora più incisive per sensibilizzare la popolazione sul tema del razzismo. E’ in atto una campagna mediatica elettorale molto violenta, la stanno facendo sulla pelle di qualcuno per colpire i valori della democrazia e della convivenza. Tutti devono comprendere la gravità della situazione. Quando un deputato arriva a tingersi di nero la faccia in parlamento, allora significa che siamo andati oltre e che abbiamo passato il segno.
Appunto, e quindi?
Dobbiamo arrivare ad escludere programmi politici che istigano al razzismo. Sia in Italia che in Europa.
Il paragone forse non è così azzardato: in Francia hanno vietato gli spettacoli razzisti del comico Dieudonné. Hanno fatto bene?
Si tratta di una questione molto delicata e controversa. Serve una discussione approfondita a livello europeo. Il mio ministero sta portando avanti un patto per l’Europa, si tratta di un documento programmatico che invita tutti i paesi a rafforzare i percorsi culturali necessari per fare argine al razzismo. Lo presenteremo tra poco. Ciò non esclude, per tornare in Italia, anche un rafforzamento della legge Mancino, lo ritengo necessario, ma personalmente ci tengo a sottolineare soprattutto l’utilità dei percorsi di formazione e di sensibilizzazione.
Un’incursione nella politica. In parlamento ci sono i numeri per abolire il reato di clandestinità, un reato odioso per cui nessuno però va in galera (è prevista solo un’ammenda). Il punto vero è capire se ci sono i margini per abolire la Bossi-Fini. Pensa che il Pd sia maturo al punto di rischiare una crisi di governo per abrogare questa legge?
Il mio partito su questi temi ha indicato degli obiettivi ben precisi, è chiaro che nell’ambito del patto di coalizione adesso si aprirà una discussione importante anche sulla Bossi-Fini.
Ma è evidente che il ministro Alfano non ci sta.
Il nostro obiettivo è riuscire ad avere un governo diverso e forte anche su questi temi, ci impegneremo per questo.
Che ne dice dell’esito del referendum online del M5S sull’abolizione del reato di clandestinità? Se lo aspettava?
La società evidentemente è cambiata. Non ho mai avuto dubbi sul fatto che quel reato sia totalmente privo di senso. Anche l’esito di quella consultazione dice che bisogna avere il coraggio di affrontare la realtà
La vergogna gettata sul nostro paese da una manciata di farneticanti. Il timore è che siano la punta di un iceberg. La Repubblica, 16 gennaio 2014
UNA duplice, speciale vigliaccheria contraddistingue la campagna orchestrata dalla Lega contro Cécile Kyenge.
Vigliaccheria numero uno: prima ancora che la linea politica, viene presa di mira la persona in quanto tale, accusata perfino di «favorire la negritudine ». Così ieri a Montecitorio il deputato Gianluca Buonanno è giunto a tingersi il volto per insinuare che per ottenere vantaggi in Italia bisognerebbe farsi «un po’ più scuri». Vigliaccheria numero due: i leghisti agiscono surrettiziamente, pubblicando l’agenda della Kyenge sul giornale di partito senza neanche avere il coraggio di scrivere a che scopo lo fanno. Dico e non dico, lancio il sasso e ritiro la mano. Vigliacchi, appunto.
Un’ipocrisia evidenziata dal segretario Salvini che sogghigna rifugiandosi dietro al diritto alla libertà d’informazione: che male c’è a divulgare degli appuntamenti pubblici? Mentre Roberto Maroni, che pure sarebbe il presidente di una grande regione europea come la Lombardia, finge di cascare dalle nuvole: «Non capisco perché contestare il ministro Kyenge sia un atto di razzismo». Non capisce, poverino?
Per carità, la Lega non è razzista. Con gli africani è dispostissima a stringere affari. Lo ha rivelato un’inchiesta di Claudio Gatti su “Il Sole 24 Ore”: subito dopo l’accordo italo-libico del 2008 per il respingimento in mare dei migranti, il suo tesoriere Belsito — che guarda caso la Lega aveva inserito nel cda della Fincantieri — si diede da fare per vendere al regime di Gheddafi pattugliatori e corvette sulle cui commesse tentò di lucrare col meccanismo dei retropagamenti. Un po’ a te e un po’ a me. La magistratura sta ancora indagando. Se invece una cittadina italiana nata in Congo viene incaricata dal governo di operare per l’integrazione degli immigrati, allora si grida allo scandalo. La si addita al pubblico ludibrio.
La Lega si protende nel disperato tentativo di recuperare uno spazio elettorale all’estrema destra. Ieri Salvini ha stretto alleanza a Strasburgo con Marine Le Pen, leader ultranazionalista d’oltralpe, e chi se ne importa della coerenza federalista. Le stesse camicie verdi che un mese fa al Lingotto di Torino scandivano in coro “Italia vaffa…” non esitano a scendere in piazza coi Forconi che sventolano il tricolore. E quando si fa la posta alla Kyenge gli va benissimo di ritrovarsi fianco a fianco coi fascisti di Forza Nuova.
Resta da chiedersi quale possa essere l’esito di questa offensiva razzista. L’intenzione è evidentemente quella di far dimenticare l’onta del partito arraffapoltrone, funestato dalle ruberie, marginalizzato a Roma ma tuttora bene inserito in tutte le postazioni di sottogoverno nel Nord. Salvini confida nella memoria corta degli esasperati e degli incattiviti dalla crisi che morde. Intuisce che a destra oggi c’è il vuoto e che l’Italia impoverita rimane territorio aperto per le scorrerie dell’antipolitica.
Si tratta di un’operazione non solo cinica, ma pericolosissima. Il classico caso dell’apprendista stregone. Perché è molto improbabile che l’agitazione delle tematiche xenofobe e antieuropee possa resuscitare un movimento screditato innanzitutto fra la gente che per un quarto di secolo aveva illuso, traendone un potere esercitato maldestramente. Assai più probabile, purtroppo, è che la crisi del forzaleghismo su cui s’innesta una tale velenosa campagna di diseducazione di massa, favorisca l’avvento di una nuova destra estrema in grado di rivendicare la sua verginità politica. Fa paura anche solo evocarla, perché il suo biglietto da visita è una violenza che da verbale, “futurista”, fa in fretta a diventare squadrismo.
L’odio diffuso contro Cécile Kyenge — se non verrà rintuzzato al più presto — piuttosto che beneficiare i suoi propalatori leghisti è più facile che generi fenomeni marginali ma devastanti di militarizzazione. L’exploit greco di Alba Dorata sta lì a dimostrarlo.
Il ritornello che già si sente ripetere perfino dai megafoni televisivi, è un’accusa dal sapore beffardo: l’aver nominato ministro una donna con la pelle nera viene additato come episodio di un non meglio precisato «razzismo all’incontrario ». Anche Buonanno, il deputato che si è tinto la faccia a Montecitorio, ha adoperato questa espressione che non significa nulla, «razzismo all’incontrario». Quasi che la ovvia parità di diritti naturalmente assegnata dalla cittadinanza italiana fosse un privilegio insopportabile, un torto inflitto alla maggioranza dei “bianchi”.
Il razzismo ipocrita della Lega non è dissimile, nelle sue modalità espressive, dall’antisemitismo del comico francese Dieudonné. Fermiamoli finché siamo in tempo.
Una intelligente analisi del renzismo, con una conclusione molti "politicistica" secondo il suo stesso audace autore.
Il manifesto, 16 gennaio 2014
Prima di entrare nel merito della delicata materia politica, cui questo articolo intende fare riferimento, devo confessare una mia personale difficoltà, o storico disagio, che potrebbe rendere quanto segue altamente opinabile. E cioè: quando il dissenso politico diventa abissale, si trasforma in una differenza antropologica, che lo fonda e giustifica. Per quanto mi riguarda è così che io guardo Matteo Renzi, il nuovo e brillante leader della sinistra italiana. E’ come se lui ed io appartenessimo a mondi diversi, incomunicabili. Perciò dicevo della mia difficoltà di costruirci un discorso ragionevole sopra. Sarebbe come se al marziano di Flaiano si fosse chiesto di formulare un oculato giudizio politico sui frequentatori dei caffè di Via Veneto, o anche viceversa (ai tempi suoi, s’intende: adesso anche lì è tutt’altra cosa).
Tutto ciò — lo dico senza ironia e senza nessuna autocondiscendenza affabulatoria — pende gravemente a mio sfavore. Lui è il nuovo che avanza, con tutta la forza dirompente della sua totale (anche anagrafica) ignoranza del passato. Io sono il passato che guarda con sbigottimento al presente, con la pretesa, oggi totalmente, anzi comicamente vana, che la conoscenza del passato, e il tenerne conto, come si faceva una volta, possano portare ancora qualche piccolo elemento di previsione, e di azione, per il presente. Ma allora, se della politica abbiamo due nozioni e credenze nettamente opposte, perché presumere di giudicare una delle due politiche dalla specola di osservazione di una concezione della politica che le è esattamente opposta? Sappia perciò il lettore — lo dico per onestà intellettuale — che questo articolo sarà marcato negativamente da questa forte pregiudiziale .
Ridurrò il resto ad alcune considerazioni basilari, anzi, a questa sparsa “lettura del testo”, che illumini (forse) il punto in cui siamo.
1. L’ho già detto in altre occasioni, ma in esordio voglio tornare e ricordarlo. Renzi, e il renzismo, il quale già gli è nato e anzi prospera vigorosamente accanto, rappresenta l’approdo finale della lunga parabola iniziata venticinque anni fa con la Bolognina di Achille Occhetto. Qual è l’essenza di questa parabola? L’essenza di questa parabola è la cancellazione, oggi ormai totale e irreversibile, della tanto vituperata “diversità comunista” (cioè della pretesa, abominevole agli occhi di molti, di fare politica in modo diverso per obiettivi diversi).
Questa cancellazione incide tanto più pesantemente sul panorama politico italiano in quanto non ha dato luogo, come si poteva pensare e sperare, alla nascita di un’opzione socialista. Il crollo del vecchio socialismo, in ragione fondamentale (ma non solo) della campagna giudiziaria di Mani pulite, e il rifiuto, da studiare ancora fino in fondo, della dirigenza post-comunista di subentrargli in quel ruolo, hanno prodotto questo unicum nella storia europea degli ultimi due secoli: l’Italia è l’unico paese in Europa in cui non esiste un partito socialista.
Il continuo decalage autodefinitorio — Pci, Pds, Ds, Pd… — e cioè in buona sostanza l’incertezza profonda su cosa si è e soprattutto su cosa si vuole essere o diventare, ha prodotto la perdita di qualsiasi identità culturale e ideale. Il renzismo replica: che bisogno ce n’è? La politica ne prescinde. Intanto andiamo avanti a tutta birra. Poi, eventualmente, si vedrà.
2. Come già accennavo, la chiave di tutta questa storia sta nell’incredibile serie di errori commessi dalla vecchia dirigenza post comunista (che non abbiamo né spazio né voglia di approfondire in questa sede, ma diamo ormai per storicamente appurati). L’ultimo soprassalto identitario si verifica quando Bersani sconfigge nettamente Renzi alle primarie del 2012. Il genio del renzismo consiste nell’avere colto il momento in cui lo sfinimento del vecchio gruppo dirigente lascia aperte le porte al più drastico dei rovesciamenti. Tale rovesciamento consiste essenzialmente di tre aspetti:
a) Renzi sostituisce la forza plebiscitaria del consenso alla gerarchia organizzata e scalare (e talvolta un po’ omertosa) del Partito. Cioè, in sostanza, nega l’utilità e l’opportunità in re del Partito, il quale resta come un puro guscio, la bandiera da sventolare (ma neanche troppo, spesso quasi per niente) nelle occasioni ufficiali. Cioè: cambia la nozione stessa di democrazia, che questo paese bene o male ha praticato dal ’45 a oggi (tutelata, se non erro, da certi aspetti non irrilevanti della nostra Costituzione);
b) Insieme con l’utilità e l’opportunità del proprio Partito (e, più in generale, della forma partito in quanto tale), nega l’utilità e l’opportunità della rappresentanza parlamentare. Infatti, tradizionalmente, fra il corpo degli eletti, i quali, almeno teoricamente, dovrebbero rappresentare l’autentica volontà popolare, e la direzione del Partito corrispondente c’è sempre stata (almeno dopo la chiusura, per il Pci, della fase staliniana) una dialettica di confronto e di scambio. Oggi la rappresentanza parlamentare viene trattata alla stregua di una semplice esecutrice dei diktat provenienti dalla direzione renziana;
c) La politica si dispiega, per il verbo renziano, come la serie di atti che servono a raggiungere il più rapidamente ed efficacemente possibile quel determinato risultato. La direzione di marcia dell’intero processo, e i suoi riflessi sulla situazione sociale, culturale ed etico-politica del paese, restano nell’ombra. Probabilmente ci sono, ma meno si vedono e meglio è (o forse, se si vedessero, sarebbe molto peggio). Come si dice a Roma “famo a fidasse”.
3. Se le osservazioni precedenti sono minimamente fondate, salta all’occhio che le caratteristiche “nuove” del renzismo (cioè la velocissima rivoluzione accaduta negli ultimi due anni nel campo della sinistra moderata) sono enormemente simili a quelle già verificatesi nel corso degli anni precedenti nel centro-destra e nella realtà politica del dissenso e dell’opposizione popolari.
Per vincere Silvio Berlusconi e Beppe Grillo — cosa che non era stabilmente accaduta mai alla vecchia dirigenza post-comunista e post-democristiana — occorreva seguirli sul loro stesso terreno. Questo mi pare davvero inconfutabile: leaderismo assoluto, populismo plebiscitario, discreto disprezzo dei meccanismi istituzionali e costituzionali, rifiuto del sistema-partito e del sistema-partiti, rottura degli schemi della vecchia, logora e consunta immagine del politico ancien régime, sono i punti di forza del “nuovo politico” al di là e al di qua dei tradizionali, anch’essi terribilmente obsoleti, limiti politico-ideali, destra, sinistra, e quant’altro ci viene dal passato. Il “nuovo politico” non ha avversari: ha solo concorrenti, da battere più o meno sul loro stesso terreno. Fra loro potrebbero persino intendersi: e non è detto che almeno su certi terreni, per esempio la nuova legge elettorale, questo non accada.
4. Il dato forse più significativo di tale processo è che esso ha acquisito rapidamente un vasto consenso popolare. Il “popolo” (insomma, più esattamente, un quoziente piuttosto vasto dell’elettorato del Pd, con ramificazioni significative negli altri elettorati) segue Renzi su questa strada. Da più parti si sente ripetere: «Con Renzi si vince». Importa meno sapere “cosa si vince”, purché sia raggiunta una ragionevole sicurezza che “con Renzi si vince”. Dunque, leaderismo, populismo plebiscitario, liquidazione dei partiti, un discreto disprezzo per il gioco parlamentare e per le istituzioni che lo garantiscono, hanno fatto breccia in profondità. Media — organi di stampa, televisioni, opinion makers — si allineano sempre più entusiasticamente. Uomini inequivocabilmente di sinistra (Vendola, Landini) sembrano guardare con simpatia alle possibilità di manovra, che il “nuovismo” renziano consente loro (per forza, meglio che star fermi, oppure restare per sempre marginali!).
5. Dunque, c’è stato, come sempre accade in questi casi, un processo di reciproco riconoscimento tra il leader nascente e le masse mutanti (ne hanno discorso recentemente Eugenio Scalfari ed Ernesto Galli della Loggia rispettivamente su la Repubblica e il Corriere della Sera: tornerò prossimamente su tale argomento). Si potrebbe ragionare a lungo su tali processi. Quel che conta è però che siano avvenuti. Constatarlo non significa però sapere come contrapporvisi. Anzi: è difficile interporsi soprattutto nel momento stesso in cui, come accade ora, tale congiungimento avviene. E tuttavia, il momento in cui il congiungimento avviene è però anche quello in cui una possibile interposizione va elaborata e presentata; altrimenti la partita è chiusa come minimo per un decennio. Ma qui conciano i dolenti lai. Non si tratta infatti di contrapporre soltanto un’ipotesi politica a un’altra, per ora prevalente. Si tratta, per riesumare una vecchia, detestatissima terminologia, di ricreare una cultura politica della sinistra, ancorata alla tradizione (tutto quel che c’è di buono al mondo ha un passato e una storia) e al tempo stesso moderna, modernissima, più dell’altra che, tutto sommato, non vede molto più al di là della punta del proprio naso. Ossia. cominciare a dire ragionevolmente quel che si vuole e prima di dire come lo si vuole. Resta dunque qualcosa del passato: diversi. Ma nuovi: non più comunisti. Questa è la scommessa. Resta tutto sommato credibile dal fatto che in Italia di così ce ne sono tanti, li conosco e ci lavoro insieme. Difficile è stendere la rete fra le loro non sempre facilmente assimilabili diversità. ma se si deve fare, si farà. In tempi di durissima carestia è esattamente quello che bisogna tornare a fare.
6. Prima di chiudere vorrei esibirmi nell’ultima farneticazione politica, anzi politicistica. Se le cose stanno come il passatista dice, bisognerebbe evitare a ogni costo che il governo Letta cada e si vada, come gli homines novi più o meno concordemente auspicano, al voto.
Per tre motivi (almeno): a) bisogna evitare che la destra si ricompatti; b) bisogna elaborare una buona legge elettorale che senza equivoci assicuri in questo paese l’alternanza: il doppio turno e le preferenze (possibilmente più di una), sono l’unico sistema in grado di farlo, e per ottenerlo ci vorrà più tempo di quanto si pensi; c) abbiamo bisogno di tempo per elaborare, proporre e imporre una nuova cultura politica, della sinistra, con le conseguenze che un tale processo potrebbe avere sull’intero assetto politico e civile del paese.
Sono argomentazioni paradossali per uno che invita a resuscitare la vecchio-nuova sinistra? Sì, è vero. Ma il paradosso è la nostra attuale condizione di vita — persino della vita pubblica e civile (talvolta personale), oltre che politica. Fare a meno del paradosso oggi non si può. Perciò è necessario astutamente governarlo
«Il dogma del laissez-faire, dell’economia lasciata libera di farsi e disfarsi, dello Stato che deve sottomettersi a questa benevola legge naturale e restringere al massimo la sua presenza, regolarmente s’è infranto contro il muro, smentito dai fatti».
La Repubblica, 15 gennaio 2014
QUANDO le crisi sono devastanti non si può fare a meno dello Stato, perché solo quest’ultimo è in grado di metter fine alla devastazione, solo il pubblico sa scommettere sul futuro senza pretendere l’immediato profitto cercato da cerchie sempre più ristrette di privati. Parlando con Ezio Mauro, nell’intervista del 10 gennaio, Sergio Marchionne dice questo, in sostanza, e l’ammissione è importante. Lo dice raccontando una storia di successo - la fusione tra Fiat e Chrysler - e tutte le fiabe sul mercato che guarisce senza Stato si Sbriciolano.
Senza quasi accorgersene, l’amministratore delegato ridipinge anche l’immagine di se stesso: la figura thatcheriana dell’imprenditore che sfianca i sindacati più resistenti, promettendo un capitalismo che distruggendo crea, e poco importa se la società si disintegra. Si sbriciola anche quest’illusione, se c’è stata. Le Grandi Depressioni non sono redentrici; la Fabbrica Italia su cui giurò nell’estate 2012 è fallita.
La frase chiave nella narrazione di Marchionne mi è parsa la seguente: «La nostra fortuna è stata di poter trattare direttamente con il Tesoro (americano), con la task force del Presidente Obama: non con i creditori di Chrysler, come voleva la vecchia logica. Se no, oggi non saremmo qui». L’idea era di far rinascere Fiat «in forma completamente diversa », e solo lo Stato federale Usa poteva fronteggiare — mettendoci la faccia, e i soldi — una crisi depressiva che Marchionne definisce «spaventosa » («I manager uscivano per strada con gli scatoloni perché le aziende chiudevano (...) non so se mi spiego»). In ogni grande svolta, specialmente quando spavento e cupidigia divorano i mercati, solo la forza pubblica possiede lo sguardo lungo, il dovere solidale, la temerarietà, di cui son sprovviste le vecchie logiche. L’amministratore delegato non lo dice espressamente ma la vecchia logica è quella, tuttora spadroneggiante, del mercato che crolla e si rialza come Lazzaro, senza però che nessuno lo richiami in vita. Si rialza spontaneamente, come Marchionne forse immaginò per un certo tempo: tagliando i costi del lavoro, secernendo guerre tra poveri, e tra poveri e sindacati. La redenzione è mancata: non poteva venire dagli investitori, né dal «sistema digestivo delle banche che si era bloccato».
La crisi iniziata nel 2007-2008 ha mostrato quel che pure era evidente, dopo i disastri degli ultimi secoli e in particolare dopo la Depressione del ’29. Il dogma del laissez-faire, dell’economia lasciata libera di farsi e disfarsi senza obblighi speciali, dello Stato che deve sottomettersi a questa benevola legge naturale e restringere al massimo la sua presenza, regolarmente s’è infranto contro il muro, smentito dai fatti. Obama ha «creduto» al progetto Fiat, e a un certo punto ha scavalcato gli spiriti animali del mercato (creditori, banche), incapaci di credere e digerire alcunché.
Il porcellum è stato un veleno scientificamente inoculato nelle vene della nazione. Ha intossicato il parlamento, riempiendolo di “nominati” al servizio delle segreterie. Ha innescato una micidiale crisi di rigetto nella società civile, spingendo moltitudini di elettori a cercare l’antidoto nell’anti-politica. Il dramma è che con questo “mostro” concepito dalla resistibile armata del cavaliere abbiamo già votato due volte, eleggendo due parlamenti. È vero che la consulta si premura di chiarire ora che il principio di «continuità dello stato» è comunque assicurato, e che la sua pronuncia non inficia le ultime tornate elettorali né delegittima le camere appena elette.
Ma questo non è balsamo. Semmai è altro sale sulla ferita. Dal 2005, grazie alla “cura” berlusconiana, l’italia è una democrazia violata. La legge elettorale, cioè la “regola” fondamentale che disciplina l’esercizio di un diritto inalienabile dei cittadini, ha violato palesemente la costituzione. Ci sono voluti quasi dieci anni per certificare quello che era già chiaro allora. Meglio tardi che mai. Ma il rammarico resta, insieme all’indignazione.
Le motivazioni della corte erano importanti non solo per comprendere le ragioni dell’incostituzionalità del porcellum. Ma anche e soprattutto per capire quali paletti avrebbe fissato, nella prospettiva della riforma elettorale. I giudici hanno adottato una soluzione “aperta”, che di fatto non preclude nessuno dei modelli possibili, né il proporzionale né il maggioritario, variamente corretti e integrati. Purché il premio di maggioranza abbia una soglia minima, e a condizione che l’elettore abbia il diritto di scegliere. Riaffermati questi principi irrinunciabili, le motivazioni della corte non sbarrano la strada a nessuna delle ipotesi messe in campo da Matteo Renzi. Il modello spagnolo può funzionare (purché le liste prevedano circoscrizioni ridotte e con pochi candidati), così come il mattarellum corretto (purché si gradui adeguatamente il premio della parte proporzionale) o il doppio turno di lista (ribattezzato impropriamente il “sindaco d’Italia”, e purché sia introdotto il voto di preferenza o il listino “corto”).
Questa exit strategy indicata dalla consulta è da un lato un’opportunità. Ma dall’altro lato un problema. Chi pensava (o sperava) che la corte togliesse le castagne dal fuoco alla politica rimane deluso. La palla torna interamente nella metà campo dei partiti. E questo costringe il leader del pd ad accelerare i tempi, e a rompere gli indugi. Renzi deve portare a casa un risultato entro il 20 gennaio, quando il dibattito approderà in commissione alla camera, e poi una settimana dopo in aula. Il leader, da solo, non ha i voti per fare una qualunque riforma. Ha bisogno di alleati. E ferma restando l’indisponibilità di Grillo, ha solo due forni ai quali rivolgersi. Quello di Berlusconi e quello di Alfano. Ma l’uno, per ora, è alternativo all’altro. E l’uno e l’altro sono pericolosi.
Berlusconi può discutere forse solo di modello spagnolo, che è tendenzialmente bipartitico, ma non vuole né il mattarellum corretto né il doppio turno di lista (gli elettori di destra storicamente non vanno a votare due volte in due settimane). Alfano può discutere del “sindaco d’Italia”, ma non vuole né il mattarellum corretto (con i collegi uninominali sarebbe costretto a tornare nelle braccia del cavaliere) né il modello spagnolo (con uno sbarramento al 15% rischierebbe di star fuori dal parlamento). Renzi ha avuto il merito di forzare il modulo, e di mettere tutti di fronte alle proprie responsabilità, offrendo tre ipotesi di intesa possibile.
Ma ora, nell’indecisione altrui, è costretto a scegliere. Se tratta con alfano, deve smettere di bastonare quotidianamente il nuovo centrodestra, e appiattirsi su un governo letta dal quale invece si vuole sistematicamente e ostinatamente distinguere. Se tratta con berlusconi, deve accettare l’idea dell’eventuale «patto col diavolo». Ma sapendo bene cosa l’aspetta. Non solo una probabile crisi di governo (eventualità cui alfano sarebbe costretto per la rottura del patto di coalizione). Ma anche una possibile imboscata (“specialità” nella quale il cavaliere è maestro indiscusso). Berlusconi potrebbe portare il sindaco di Firenze a un passo dall’accordo sul modello spagnolo, per poi far saltare il tavolo all’ultimo minuto, incassando in un colpo solo la caduta del governo delle strette intese e le elezioni anticipate con il proporzionale puro (cioè la morte politica di Renzi).
È un rischio concreto e non fantapolitica. Per convincersene, basta chiedere al D’Alema della bicamerale e al Veltroni del 2008. Una “lezione” che non possiamo e non dobbiamo dimenticare.