

 «Non un’opinione europea, ma somma di opinioni nazionali non comunicanti. Solo sulla carta partiti, sindacati, media europei (meglio i movimenti). Ogni parlamentare o commissario risponde al suo frammento, non all’Europa».
«Non un’opinione europea, ma somma di opinioni nazionali non comunicanti. Solo sulla carta partiti, sindacati, media europei (meglio i movimenti). Ogni parlamentare o commissario risponde al suo frammento, non all’Europa».
Il manifesto, “Sbilanciamo l’Europa”, 7 marzo 2014.
Che adesso, attraverso il voto, sia possibile indicare chi dovrà essere presidente della Commissione europea è un passo in avanti nella democratizzazione dell’Unione. Che tale elezione sia ora il frutto di una maggioranza parlamentare politicizza la scelta, finalmente sottratta al rito falsamente neutrale secondo cui fino ad oggi i governi, pur diversi fra loro, si accordavano sul nome più adatto. Un meccanismo che esasperava ulteriormente la presunzione su cui si basa la costruzione comunitaria, secondo cui quanto muove ogni decisione sarebbe procedimento puramente tecnico. E tuttavia che sia sufficiente accrescere i poteri del Parlamento per democratizzare la Ue è ipotesi francamente un po’ semplicista. Ci vuole ben altro.
Innanzitutto per la buona ragione che sin dalla sua nascita, nel ’57, ma in modo più evidente con l’introduzione dell’art. 102 del Trattato di Maastricht del ’93 (nella sua sostanza pienamente recepito dagli atti fondamentali successivi), si è tolto alla politica il potere di regolare gran parte della vita della Comunità (e dunque valore a ogni decisione parlamentare). Quell’articolo costituzionalizza infatti il primato della competitività nel mercato su ogni altra considerazione, e taglia così fuori l’economia dalla sfera delle decisioni politiche. La sovranità su questo decisivo settore, che determina ogni altra scelta, è stata così trasferita direttamente alle mani (invisibili) del mercato, non alle istituzioni europee. Il compito affidato agli esecutivi, e sottoposto al controllo del parlamento, è dunque solo quello di montare la guardia, attraverso una quantità di regole e sorveglianze, affinché il mercato venga liberato da ogni intrusione intesa a garantire alla politica - e cioè agli umani - il governo della società. Fin quando il principio ispiratore dell’Unione resterà la competitività costi quel che costi, possiamo dotare il Parlamento di tutti i poteri che vogliamo ma la politica, dunque la democrazia, non sarà reintrodotta.
Sarebbe bene riflettere sul fatto che a ingoiare quell’articolo 102 e la filosofia che lo accompagna sono stati parlamenti nazionali pur dotati di ogni potere e che pure non l’hanno esercitato per cancellare l’ispirazione di un Trattato che pure comportava la scelta suicida di non poter più legiferare se non al servizio della massima competitività e dunque solo su dettagli marginali, la scelta di fondo essendo stata fatta una volta per tutte con la costituzionalizzazione dell’obbligo di adottare una linea iperliberista. Ci si dovrebbe interrogare su come poté accadere che a questo siano addivenuti parlamenti di paesi dove pur forte era la tradizione di politiche fondate su un incisivo intervento pubblico in funzione regolamentatrice dell’economia. È accaduto anche in Italia, dove quel Trattato è stato votato da una schiacciante maggioranza contro solo gli antieuropeisti del Msi e gli europeisti di Rifondazione comunista che pure, tuttavia, ha accettato che tutto si risolvesse in una sbrigativa seduta e senza che l’opinione pubblica fosse minimamente allertata. E informata.
Tutto questo naturalmente si può cambiare ed è quello che in molti cerchiamo di fare. Ma avendo chiaro cosa serve per democratizzare l’Europa. E per cominciare qualcosa che dipende direttamente da noi. Se fino ad ora l’opinione pubblica italiana così come degli altri paese è stata così disattenta (e dunque inefficace) rispetto alle pur gravi scelte adottate a livello europeo (liberalizzazione del movimento dei capitali senza contemporanea creazione di uno spazio unico sociale e fiscale, tanto per fare l’esempio più macroscopico) è perché non esiste un’opinione pubblica europea, ma una somma di opinioni nazionali che non comunicano, perché solo sulla carta esistono partiti, sindacati, media realmente europei (un po’ meglio i movimenti). Ogni parlamentare e ogni commissario risponde al suo frammento, non a tutta l’Europa. E perciò a nessuno. Né, di conseguenza, una decisione assunta a Bruxelles acquista la stessa legittimazione di una legge nazionale. Senza questi corpi intermedi fra società civile e istituzioni - aveva acutamente notato la sentenza della Corte Costituzionale tedesca all’epoca del varo del Trattato di Maastricht - la democrazia (per non parlare di solidarietà) non esiste. Costruirli dipende anche da noi.
Una replica a Rodotà: «L’obiettivo della lista è quello di portare nelle istituzioni europee, e non solo, una posizione aspramente critica nei confronti della Ue, per modificare radicalmente i trattati e cambiare il segno delle politiche economiche e sociali, senza essere antieuropea».
Il manifesto7 marzo 2014
In effetti il ragionamento di Rodotà è ben più ampio. Egli prende atto dei significativi cambiamenti intervenuti nelle dinamiche del quadro politico italiano e vuole «gettare lo sguardo sull’intera fase che abbiamo alle spalle». Per questo smonta puntualmente la costruzione renziana, evidenziando come il tentativo di ritorno ad un sistema bipolare – che passa anche attraverso l’Italicum e il più recente mostruoso compromesso della riforma elettorale in una camera sola — si riduca semplicemente alla rilegittimazione di Berlusconi, pienamente rientrato in campo come deuteragonista, se non addirittura come deus ex machina. Questo comporta una insensibilità, quando non aperta ostilità, da parte di Renzi verso ciò che si muove alla sua sinistra, malgrado le speranze da più d’uno coltivate da quelle parti. Ecco dunque, secondo Rodotà, aprirsi una prateria per le forze di una potenziale sinistra che egli definisce, restringendola, come formata da «Sel, il gruppo di Pippo Civati, la lista Tsipras e i parlamentari (e non solo) che si allontanano dal Movimento 5Stelle».
Tale restrizione è del tutto indebita. Non tanto perché lascia fuori qualche pezzo della nomenclatura della tradizionale sinistra radicale, ma soprattutto perché non tiene conto della sinistra diffusa e del protagonismo dei movimenti. Di quelle stesse forze, insomma, che hanno animato le tante lotte sociali, locali e nazionali, sviluppatesi in questi anni, che hanno dato vita alle manifestazioni del 12 e del 19 ottobre 2013 — scelleratamente ma non obbligatoriamente contrapposte tra loro – e alle ultime vittoriose battaglie referendarie. Tutti questi movimenti e queste coscienze diffuse non entrano in un processo di ricostruzione di uno spazio politico di sinistra in modo passivo, ma o ne sono protagonisti da subito o questo spazio e questo processo non si aprono né si realizzano.
Rodotà afferma esplicitamente che tale processo dovrebbe e potrebbe essere finalizzato alla costruzione di un Nuovo Centro Sinistra, basato sulla liberazione del Pd dall’abbraccio con il Nuovo Centro Destra (le maiuscole sono sue). Qui le distanze sono ancora maggiori. Legare il processo di ricostruzione di una sinistra alla riconquista del Pd, inchiodarlo nel letto di Procuste di un eterno centrosinistra, cui l’aggettivo nuovo sta come il prezzemolo, è esattamente il motivo per il quale tale processo non è mai potuto sorgere. Anche quando ve ne sarebbero state le possibilità, sia oggettive che soggettive — come all’inizio della formazione di Sel — è stata precisamente quella mancanza di autonomia ideale e progettuale a soffocare il bimbo nella culla. La verità è che continua ad essere assente una sincera e approfondita discussione sulla natura del Pd (spunti ve ne sono, manca l’affondo), che vada al di là dell’esame delle volatili dichiarazioni dei suoi dirigenti e che invece si ponga in relazione ai nuovi assetti interni e internazionali del capitalismo e di un sistema istituzionale deprivato di una vera democrazia.
La lista Tsipras da un lato poggia proprio su quella sinistra diffusa e sulle migliori esperienze di quei movimenti (le candidature scelte vanno lette e giudicate in questa luce, fermo restando che la perfezione in questo campo non esiste e strascichi polemici sono inevitabili) e dall’altro dichiaratamente non ha la presunzione di guidare un processo di ricostruzione di un nuovo soggetto di sinistra. Bene lo ha compreso Marco Bascetta, rispondendo su questo giornale a un’antipatizzante lettera di Carlo Formenti. L’obiettivo della lista, questo sì alla sua portata, è quello di portare nelle istituzioni europee, e non solo, una posizione aspramente critica nei confronti della Ue, per modificare radicalmente i trattati e cambiare il segno delle politiche economiche e sociali, senza essere antieuropea. Se avrà successo potrà anche avere un effetto collaterale, ovviamente desiderabile e desiderato, ma che non può essere scambiato per il suo target: quello di invertire la tendenza alla frantumazione della sinistra, di spostare l’elaborazione e l’azione della medesima in una dimensione internazionale, di battersi per la ricostruzione dell’Europa avviando una campagna costituente tra i cittadini europei e non come somma di vittorie in ambito nazionale. Scusate se è poco.
 «In campo. Presentate a Roma le candidature dell’Altra Europa con Tsipras: 37 uomini, 36 donne; 59 candidati espressi da movimenti, associazioni e «società civile», 14 dai partiti. Nel programma: riscrivere lo statuto della Bce, investimenti pubblici e tutele sociali, un’Europa che non cede al neoliberismo e ai nazionalismi».
«In campo. Presentate a Roma le candidature dell’Altra Europa con Tsipras: 37 uomini, 36 donne; 59 candidati espressi da movimenti, associazioni e «società civile», 14 dai partiti. Nel programma: riscrivere lo statuto della Bce, investimenti pubblici e tutele sociali, un’Europa che non cede al neoliberismo e ai nazionalismi».
Il manifesto, 6 marzo 2014
La lista «L’Altra Europa con Tsipras» ha presentato 73 candidature per le elezioni europee di maggio. Ci sono 37 uomini, 36 sono le donne; 59 candidati sono stati espressi da movimenti, associazioni e «società civile», 14 dai partiti che sostengono la lista: Sel e Rifondazione comunista. Sono state raccolte oltre 200 proposte, ciascuna delle quali sottoscritta da associazioni, comitati, gruppi o partiti che hanno aderito alla lista. Oltre 7 mila sono state le firme a sostegno delle candidature, un dato che conferma l’interesse per un esperimento in controtendenza con i recenti e disastrosi fallimenti della «sinistra radicale». L’obiettivo è raggiungere un risultato a due cifre, anche se il 6–7% dei voti che i primi sondaggi attribuiscono alla lista «ci rendono molto contenti».
Lo ha detto ieri Barbara Spinelli, capolista in tre circoscrizioni su 5. «Io di mestiere scrivo – ha detto – Ho pensato che queste capacità dovevo comunicarle diversamente per metterle a disposizione degli invisibili, testimoniando per chi non ha voce, per farli diventare combattenti per un’Europa radicalmente diversa da quella che ci hanno consegnato i conservatori e da quella che vuole ritornare alle sovranità nazionali. Queste forze oggi sono complici e vogliono garantire lo status quo». Per Spinelli questo ragionamento traccia la linea degli «euroinsubordinati». Un traiettoria che parte da sinistra con la candidatura di Tsipras, designato alla presidenza della Commissione europea dalla sinistra europea nel congresso tenuto a Madrid e rivendicato da Rifondazione Comunista, e che ambisce a conquistarsi una posizione autonoma rispetto ai socialisti e democratici europei (dove si trova il Pd di Matteo Renzi), ai conservatori e ai liberali. Con Verhostadt, candidato dell’Alde, come con lo stesso Schultz candidato dei socialisti, Spinelli non ha tuttavia escluso contatti.
I primi due mesi di vita dell’«Altra Europa» sono stati intensi. 30 mila firme raccolte da un appello dei «garanti» della lista: Andrea Camilleri, Paolo Flores d’Arcais, Luciano Gallino, Marco Revelli, Guido Viale, Spinelli oltre allo stesso Tsipras. Poi ci sono state le polemiche prima sull’esclusione dal logo della lista (il restyling ora è completo) tra i «garanti» e Rifondazione Comunista; poi quelle tra i garanti stessi a proposito dell’esclusione della candidatura dell’eurodeputata Idv Sonia Alfano (incandidabile secondo una delle regole proposte: non avere avuto incarichi politici negli ultimi 10 anni) e Luca Casarini, la cui candidatura è stata invece confermata con voto a maggioranza nella circoscrizione del Centro-Italia.
Sul ritiro della candidatura di Camilleri, le spiegazioni sono state forse poco convincenti. Averla comunicata il 2 marzo, per poi smentirla subito dopo, è attribuito alla «gioia che si candidava». Mentre in realtà quella decisione non era stata ancora presa. Spinelli si è scusata per l’«intempestività» e assicura che Camilleri continuerà a sostenere la lista. Spinelli ha infine spiegato la sua decisione di ritirarsi dopo l’eventuale elezione. Di solito questo avviene a urne chiuse quando i politici nazionali cedono il posto alle seconde file. Averlo annunciato prima, ha detto Spinelli, «permette di eleggere i più votati e competenti. Lo permette il metodo delle preferenze».
Agli «euroinsubordinati» la giornalista e scrittrice, figlia di Altiero Spinelli, propone un ragionamento politico complesso, ma che rientra nelle corde della sinistra europea. Dimostrare che esiste, oggi, la possibilità di essere contro l’austerità senza cedere ai populismi che con ogni probabilità mieteranno successi alle prossime elezioni. Il movimento 5 Stelle di Grillo e Casaleggio, considerato ad oggi il depositario delle posizioni anti-austerità, viene dato in una forbice tra il 20–25%. Su questa base sono riemerse ieri parole che non ascoltavamo da almeno un decennio in una sede politica italiana: l’idea dell’Europa non prigioniera del neoliberismo e del suo determinismo economicista. Un’Europa dove la perdita della sovranità degli Stati-nazione non è preliminare all’esproprio della decisione politica dei popoli, come degli individui, bensì ad una redistribuzione della ricchezza e dei poteri a livello sovranazionale e in maniera democratica.
Un’Europa, infine, politica, che sappia cioè rivedere di sana pianta i suoi trattati; rovesciare i mandati costitutivi della Bce di Mario Draghi; avviare un piano neo-keynesiano di investimenti pubblici; applicare le tutele sociali minime a partire da un salario e da un reddito minimo per 19 milioni di disoccupati e perlomeno il doppio di precari e lavoratori autonomi. Tsipras ha proposto una conferenza europea sul debito per i paesi dell’Europa del Sud, simile a quella che nel 1953 alleviò il peso che gravava sulla Germania del Dopoguerra. Una proposta ripresa dalla lista italiana, potenzialmente capace di rompere ogni schema di politica economica adottata in Italia.
Un altro mondo, inconcepibile. Sapendo che il vero banco di prova sarà il dopo-elezioni. Nascerà una prospettiva costituente, e uno spazio politico, tra le compagini che stanno dando vita a questa esperienza, ma soprattutto oltre
Un titolo strumentalmente forzato per un’analisi a tutto campo del sistema politico italiano, da Renzi Berlusconi e Letta, a Civati e alla lista Tsipras. I timori, e le speranze e le scommesse.
La Repubblica, 6 marzo 2014
DINAMICHE forti attraversano il sistema politico italiano, e lo stanno cambiando profondamente. Ma, se pure questo processo è stato accelerato dalle iniziative di Renzi, per comprenderlo bisogna andare oltre la stretta attualità, gettare lo sguardo sull’intera fase che abbiamo allespalle.
Altrimenti si rimane prigionieri di formule ingannevoli — «Aspettiamo Renzi alla prova dei fatti», «Se fallisce, è la fine» — che rivelano non tanto una deriva personalistica, quanto piuttosto una sfiducia nella possibilità stessa di condurre analisi politiche. E invece proprio dalla politica bisogna ripartire, registrando che siamo alla fine di un ciclo che si è dipanato attraverso l’emergenza montiana, le larghe intese e le piccole intese, senza offrire né soluzioni a breve né prospettive, sì che Renzi finisce con l’apparire come una sorta di curatore fallimentare. Il suo obiettivo è visibilmente quello di strutturare il sistema politico intorno a due poli, non due partiti, e proprio qui scatta l’impossibilità di liberarsi con una mossa tutta volontaristica dell’eredità del passato. “Padrone”, almeno nelle apparenze, di un partito che aveva conquistato senza combattere, Renzi ha poi rivolto lo sguardo dall’altra parte e, muovendo da una sottovalutazione del suo partner di governo, il Nuovo Centro Destra, si è lanciato verso la rilegittimazione di Berlusconi, impigliandosi però nei prevedibili conflitti determinati dall’affidarsi all’astuzia della “doppia maggioranza”.
Ora la nuova “intesa” intorno alla legge elettorale mostra come egli non debba solo fare i conti con i fallimenti del passato, ma pure con l’esito infelice del suo stesso azzardo. Indicata come un passaggio necessario per un chiarimento del quadro politico, la nuova fase della riforma elettorale produce, al contrario, una inquietante confusione istituzionale, destinata a sfociare in conflitti (ricatti?) incrociati, rendendo più soggetta a condizionamenti l’azione di governo e più esposta la nuova soluzione a chiari vizi di incostituzionalità. Frutto evidente di pure strumentalità partitiche, dissolve la logica, già precaria, della doppia maggioranza, spinge tanto Berlusconi quanto Alfano a perseguire le proprie convenienze, a rafforzare la propria identità, aprendo la via a conflitti inevitabilmente destinati ad influire su tempi e scelte del governo. L’apertura a Berlusconi era stata, nei fatti, una evidente sfida ad Alfano, così come la precedente apertura su lavoro e diritti civili lo era stata nei confronti di Letta. Cambiati i ruoli, mutato Renzi da sostanziale sfidante ad alleato obbligato di Alfano, quale sarà in concreto la linea della maggioranza ora rinsaldata?
Bisogna tornare, a questo punto, alla questione dei due poli, in vista dei quali è stata confezionata la nuova legge elettorale, con chiusure conservatrici a favore di chi già è insediato all’interno del sistema, introducendo così una ulteriore rigidità di cui, prigionieri di una poco riflessiva furia “riformatrice”, non sembra siano stati adeguatamente valutati tutti gli effetti. Sul versante berlusconiano, è evidente l’intenzione di costruire una coalizione nella quale sarà obbligato ad entrare tutto il pulviscolo dei gruppi e gruppetti che si agitano a destra in questo momento per dare l’impressione di una autonomia del tutto finta, poiché sanno benissimo che la nuova legge elettorale, quali che siano le soglie fissate, precluderà loro ogni possibilità di accesso al Parlamento. Si creano così le premesse per negoziati opachi, per contropartite d’ogni genere, mantenendo le condizioni che hanno in passato inquinato il nostro sistema politico e anticipando alla fase preelettorale il potere dei gruppi marginali, ma indispensabili per assicurare il successo della coalizione. Inoltre, l’alta soglia dell’8%, imposta alle liste autonome, diventa un potente disincentivo per avventure solitarie del Nuovo Centro Destra.
Diversa si presenta la situazione nel centrosinistra, dove Renzi sembra aver ripreso la logica della “vocazione maggioritaria” e, fidando sul proprio appeal, non manifesta aperture verso le diverse realtà esistenti, mostrandosi piuttosto interessato al recupero di una parte dell’elettorato del Movimento 5Stelle (strategia peraltro analoga a quella di Silvio Berlusconi). Peraltro, la sua sbrigativa rilettura di quel che oggi sarebbe la sinistra, unita ai quotidiani slittamenti ai quali lo obbliga la convivenza con gli alfaniani, ha creato condizioni propizie all’apertura di un processo che oggi, sia pure in forme ancora da chiarire, vede coinvolti Sel e il gruppo di Pippo Civati, la lista Tsipras e i parlamentari (e non solo) che si allontanano dal Movimento 5Stelle.
Sono realtà diverse, ciascuna delle quali meriterebbe una analisi specifica, ma di cui qui può essere indicato quello che appare un possibile terreno comune. Civati, con quella che non è soltanto una battuta, ha parlato di Nuovo Centro Sinistra, ponendo così un problema: è possibile un processo, tutt’altro che semplice e breve, che abbia come primo obiettivo quello di liberare il Pd dal legame pericoloso con il Nuovo Centro Destra e, in prospettiva, consenta di lavorare intorno ad una ipotesi di sinistra nuova e non velleitaria? Di questo si dovrebbe tener conto, senza rifugiarsi nelle troppo comode obiezioni “realistiche” che, negli ultimi tempi, hanno privato il centrosinistra di ogni capacità di creare le condizioni pur minime per non essere sempre succube di stati di necessità, veri o costruiti. La politica è anche, talora soprattutto, capacità di assumersi rischi, senza la quale nessuna vera innovazione è possibile. Forse è qui che il proclamato “coraggio” di Renzi dovrebbe esercitarsi pure in questa direzione. E si potrebbe anche cominciare a ragionare fuori da un’altra pesante ambiguità, l’indicazione della durata del governo fino al 2018, che sembra un artificio per tener buono Alfano. Qualora al Senato si creassero le condizioni per liberarsi da questa ingombrante tutela, si potrebbe ragionevolmente discutere di un programma limitato e di un ritorno alle urne secondo una logica politica, e non puramente strumentale, anche se ora contro questa possibilità si leva il pasticcio dell’eventuale elezione differenziata di Camera e Senato.
Ripeto. È un processo non facile, che tuttavia può permettere di avviare un cammino che faccia uscire dal deserto politico nel quale continuiamo ad aggirarci. In questa prospettiva si presenta come assai impegnativa l’iniziativa della lista Tsipras perché, in particolare, la partecipazione alle elezioni europee significherà sottoporsi ad un vero confronto pubblico. È una impresa rischiosa e, proprio per questo, vorrebbe dai suoi promotori un rigore estremo. Dal passato vengono esempi che ammoniscono sul rischio legato a logiche autoreferenziali (il fallimento nelle ultime due elezioni politiche dalla Sinistra arcobaleno e della lista Ingroia). Dal presente viene l’obbligo a riflettere su che cosa significhi, al di là del fatto simbolico, il riferimento a Tsipras e al suo partito, Syriza. Si tratta di una esperienza maturata attraverso un lavoro politico non breve e che si è consolidato grazie ad una intensa presenza sociale. Condizioni, queste, che non trovano corrispondenza nella lista italiana e nella variegata coalizione che la sostiene, che peraltro non ha dato una esaltante prova di sé proprio nella scelta delle candidature, come attestano le cronache di ieri. Per tutti quelli che vogliano andare oltre la semplice critica al governo Renzi, si apre una stagione assai impegnativa. Ma proprio con queste difficoltà bisognerà misurarsi.
 Finalmente parole chiare sull’Ucraina, la Russia, i Rapporti con gli Usa e l’Europa. E sui numerosi errori compiuti nel vecchio Continente che si dibatte nelle sue incertezze.
Finalmente parole chiare sull’Ucraina, la Russia, i Rapporti con gli Usa e l’Europa. E sui numerosi errori compiuti nel vecchio Continente che si dibatte nelle sue incertezze.
La Repubblica, 5 marzo 2014
IN PARTE per monotonia abitudinaria, in parte per insipienza e immobilità mentale, continuiamo a parlare dell’intrico ucraino come di un tragico ritorno della guerra fredda. Ritorno tragico ma segretamente euforizzante.Perché la routine è sempre di conforto per chi ha poche idee e conoscenza. Le parole sono le stesse, e così i duelli e comportamenti: come se solo la strada di ieri spiegasse l’oggi, e fornisse soluzioni.
È una strada fuorviante tuttavia: non aiuta a capire, a agire. Cancella la realtà e la storia ucraina e di Crimea, coprendole con un manto di frasi fuori posto. È sbagliato dire che metà dell’Ucraina — quella insorta in piazza a Kiev - vuole «entrare in Europa». Quale Europa? Nei tumulti hanno svolto un ruolo cruciale - non denunciato a Occidente - forze nazionaliste e neonaziste (un loro leader è nel nuovo governo: il vice Premier). Il mito di queste forze è Stepan Bandera, che nel ’39 collaborò con Hitler.
È sbagliato chiamare l’Est ucraino regioni secessioniste perché «abitate da filorussi». Non sono filo- russi ma russi, semplicemente. In Crimea il 60% della popolazione è russa, e il 77% usa il russo come lingua madre (solo il 10% parla ucraino).
È mistificante accomunare Nato e Europa: se tanti sognano l’Unione, solo una minoranza aspira alla Nato (una minaccia, per il 40%).
Sbagliato è infine il lessico della guerra fredda applicato ai rapporti euro-americani con Mosca, accompagnato dal refrain: è «nostra» vittoria, se Mosca è sconfitta. Dal presente dramma bellicoso si uscirà con altri linguaggi, altre dicotomie. Con una politica - non ancora tentata - che cessi di identificare i successi democratici con la disfatta della Russia. Che integri quest’ultima senza trattarla come immutabile Stato ostile: con una diplomazia intransigente su punti nodali ma che «rispetti l’onore e la dignità dei singoli Stati, Mosca compresa», come scrive lo studioso russo-americano Andrej Tsygankov.
L’Ucraina è una regione più vitale per Mosca che per l’Occidente, e i suoi abitanti russi vanno rassicurati a ogni costo. È il solo modo per esser severi con Mosca e insieme rispettarla, coinvolgerla. Siamo lontani dunque dalla guerra fredda. Che era complicata, ma aveva due elementi oggi assenti: una certa prevedibilità, garantita dalla dissuasione atomica; e la natura ideologica (oggi si usa l’orrendo aggettivo valoriale) di un conflitto tra Est sovietizzato e liberal-democrazie. Grazie allo spauracchio dell’Urss, Europa e Usa formavano un «occidente » senza pecche, qualsiasi cosa facesse. L’Urss era nemico esistenziale: letteralmente, ci faceva esistere come blocco di idee oltre che di armi.
Questo schema è saltato, finita l’Urss, e l’Est è entrato nell’Unione. Mentre l’Urss crollava un alto dirigente sovietico, Georgij Arbatov, disse: «Vi faremo, a voi occidentali, la cosa peggiore che si possa fare a un avversario: vi toglieremo il nemico». Non aveva torto, se ancora viviamo quel lutto come orfani riottosi. Ma non è più l’antagonismo ideologico a spingerci. La Russia aspira a Riconquiste come la Nato e Washington. Fa guerre espansive in Cecenia mentre gli Usa, passivamente seguiti dall’Europa, fanno guerre illegali cominciando dall’Iraq e proseguendo con le uccisioni mirate tramite i droni.
«Oggi la Russia di Putin e “l’Occidente” condividono un’identica visione basata sulla ricerca di profitto e di potere: in tutto tranne su un punto, e cioè a chi debbano andare profitto e potere», scrive Marco D’Eramo su Pagina 99 (25-2-14). Questo significa che non la guerra fredda torna, ma il vecchio equilibrio tra potenze ( balance of power) che regnava in Europa fino al ’45: i Grandi Giochi dell’800, in Asia centrale o Balcani. Qui è la perversione odierna, obnubilata. Washington ha giocato per anni con l’idea di spostare la Nato a Est, fino ai confini russi. Più per mantenere in piedi l’ostilità del Cremlino che per aiutare davvero nazioni divenute indipendenti.
L’Europa avrebbe potuto essere primo attore, perso il «nemico esistenziale». Non lo è diventata. È un corpo con tante piccole teste, alcune delle quali (Germania per prima) curano propri interessi economico-strategici da soli. Lo scandalo è che nel continente c’è ancora una pax americana opposta alla russa. Una pax europea neppure è pensata. Eppure una pax simile potrebbe esistere. L’unità europea fu inventata proprio in risposta all’equilibrio delle potenze, per una pace che non fosse una tregua ma un ordine nuovo.
L’ombrello Usa ha protetto un pezzo del continente, consentendogli di edificare l’Unione, ma ha viziato gli europei, abituandoli all’indolenza passiva, all’inattività irresponsabile, al mutismo. Finite le guerre fratricide, l’Europa occidentale s’è occupata di economia, pensando che pace-guerra non fosse più di attualità. Lo è invece, atrocemente. Priva di visioni su una pace attiva, l’Europa cade in errori successivi fin dai tempi dell’allargamento. Allargamento che non definì la pax europea: i paesi dell’Est si liberarono, senza apprendere la libertà.
Tra Russia e Usa il rapporto è antagonistico, ma a parole. Nei fatti è un rapporto di rivalità mimetica, di somiglianza inconfessata. L’Ucraina è una nazione dalle molte etnie, con una storia terribile. Storia di russificazioni forzate, che in Crimea risalgono al ’700: ma oggi i russi che sono lì vanno protetti. Storia di deportazioni in massa di tatari dalla Crimea, che pagarono la collaborazione col nazismo e tornarono negli anni ’90. Storia di una carestia orchestrata da Stalin, e di patti con Hitler su cui non è iniziata alcuna autocritica (il collaborazionista Bandera è un mito, per le destre estreme che hanno pesato nei recenti tumulti).
Uno dei più nefasti fallimenti della rivoluzione a Kiev è stata la decisione di abolire la tutela della lingua russa a Est: cosa che ha attizzato paure e risentimenti antichissimi dei cittadini russi, timorosi di trasformarsi in paria inascoltati dal mondo. Tutte queste etnie convivevano, quando in Europa c’erano gli imperi. Pogrom e Shoah son figli dei nazionalismi.
Oggi regnano due potenze dal comportamento imperialista (Usa, Russia), che però non sono imperi multietnici ma nazioni-Stato distruttivi come in passato. Se l’Europa non trova in sé la vocazione di essere impero senza imperialismo, via d’uscita non c’è. Se non trova il coraggio di dire che mai considererà «filo-europei» neonazisti che si gloriano di un passato russofobo che combatté i liberatori dell’Urss, le guerre nel continente son destinate a ripetersi. Le tante chiese ucraine lo hanno capito meglio degli Stati.
«L’insieme di draconiane misure nei confronti degli enti locali ha un unico scopo: metterli con le spalle al muro dal punto di vista economico per persuaderli/obbligarli ad un gigantesco percorso di espropriazione e di privatizzazione, consegnandone beni e patrimonio alle lobby bancarie e finanziarie». I
l manifesto, 5 marzo 2014
1. La querelle nata in questi mesi – e divenuta drammatica in questi giorni- intorno al decreto cosiddetto “Salva Roma”, dimostra come uno dei nodi cruciali della guerra alla società, dichiarata dalle lobby finanziarie con la trappola della crisi del debito pubblico, veda da subito al centro gli enti locali, i loro beni e servizi, il loro ruolo. Infatti, poiché l’enorme massa di ricchezza privata prodotta dalle speculazioni finanziarie, che ha portato alla crisi globale di questi anni, ha stringente necessità di trovare nuovi asset sui quali investire, è intorno ai beni degli enti locali che le mire sono ogni giorno più che manifeste.
2. Già nel rapporto “Guadagni, concorrenza e crescita”, presentato da Deutsche Bank nel dicembre 2011 alla Commissione Europea, si scriveva a proposito del nostro Paese : “ (..) I Comuni offrono il maggior potenziale di privatizzazione. In una relazione presentata alla fine di settembre 2011 dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze si stima che le rimanenti imprese a capitale pubblico abbiano un valore complessivo di 80 miliardi di euro (pari a circa il 5,2% del PIL). Inoltre, il piano di concessioni potrebbe generare circa 70 miliardi di entrate. E questa operazione potrebbe rafforzare la concorrenza. (..) Particolare attenzione deve essere prestata agli edifici pubblici. La Cassa Depositi e Prestiti dice che il loro valore totale corrente arriva a 421 miliardi e che una parte corrispondente a 42 miliardi non è attualmente in uso. Per questa ragione potrebbe probabilmente essere messa in vendita con relativamente poco sforzo o spesa. Dal momento che il settore immobiliare appartiene in gran parte ai Comuni, il governo dovrebbe impostare un processo ben strutturato in anticipo. (..) Quindi, secondo le informazioni ufficiali, il patrimonio pubblico potrebbe raggiungere in valore complessivo di 571 miliardi, vicino al 37% del PIL. Naturalmente, il potenziale può anche essere ampliato.”
3. La spoliazione degli enti locali è naturalmente avviata da almeno un quindicennio e vi hanno concorso diversi fattori. Il primo è stato il Patto di Stabilità e Crescita interno, ovvero le diverse misure, annualmente stabilite, per far concorrere gli enti locali agli obiettivi di stabilità finanziaria decisi dallo Stato in accordo con l’Unione Europea. Quel patto ha visto in una prima fase una durissima contrazione delle possibilità di assunzione del personale da parte degli enti locali, riducendone drasticamente la qualità del servizio e contribuendo in questo modo a costruire una campagna ideologica sull’inefficienza del “pubblico”; in un secondo momento è finita sotto attacco la possibilità e la capacità di investimento da parte degli enti locali che, con l’alibi di non doversi indebitare, sono stati costretti e ridurre al lumicino le opere da realizzare; infine, nell’attualità, perfino la capacità di spesa corrente trova draconiane limitazioni, mettendo definitivamente a rischio il funzionamento stesso degli enti locali. Classificati da ora in avanti in “virtuosi” e “non virtuosi”, gli enti locali saranno costretti, per entrare nella prima categoria, ad aumentare le tasse locali e le tariffe, a ridurre ulteriormente l’occupazione, a dismettere il patrimonio pubblico e a privatizzare i servizi pubblici locali.
4. Il secondo fattore è dovuto alla spending review, ovvero i drastici tagli lineari che, anziché riorganizzare la spesa eliminando gli sprechi e le corruttele, comportano un’automatica riduzione di tutti i servizi erogabili senza alcuna scala di priorità e senza la benché minima programmazione. Il terzo fattore è stata l’approvazione del Fiscal Compact, ovvero l’obiettivo sottoscritto in sede europea di portare entro venti anni al 60% il rapporto debito/pil che oggi è pari al 133% . Ciò significa annualmente una riduzione secca di tale rapporto del 3,3% , con un costo di oltre 50 miliardi/anno. Se a questo si aggiunge l’introduzione del pareggio di bilancio nella Costituzione –di fatto, la costituzionalizzazione della dottrina liberista- il quadro è decisamente chiaro.
5. La tesi qui sostenuta è che l’attacco agli enti locali sia sistemico e abbia come ultimo obiettivo la scomparsa della funzione pubblica e sociale dell’ente locale, come sin qui lo abbiamo conosciuto, trasformandone il ruolo da erogatore di servizi per la collettività a facilitatore dell’espansione della sfera di influenza dei capitali finanziari e da garante dell’interesse collettivo a sentinella del controllo sociale delle comunità. Una trasformazione autoritaria necessaria per permettere, attraverso la drastica riduzione della democrazia di prossimità, la totale spoliazione dei beni comuni delle comunità locali. Per queste ragioni, l’ente locale è destinato a diventare uno dei luoghi fondamentali dello scontro sociale nei prossimi mesi.
6. L’insieme di draconiane misure nei confronti degli enti locali ha un unico scopo: metterli con le spalle al muro dal punto di vista economico per persuaderli/obbligarli ad un gigantesco percorso di espropriazione e di privatizzazione, consegnandone beni e patrimonio alle lobby bancarie e finanziarie Un processo che avviene attraverso diversi ma convergenti percorsi. Cosa posseggono infatti gli enti locali? Territorio, patrimonio e servizi, ed è su questi che si sta giocando, e sempre più lo si farà nel prossimo periodo, la guerra contro la società.
7. Il territorio è da tempo strumento di valorizzazione finanziaria, in due diverse modalità di scala. La prima attraverso la continua cementificazione del suolo, favorita da una norma, da anni reiterata in Parlamento, che consente di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente dei Comuni : in pratica, anche solo per garantire l’ordinario funzionamento dell’ente locale, gli amministratori sono invogliati a consegnare porzioni di territorio alla speculazione immobiliare, arrivando al paradosso che, mentre fino a qualche anno fa erano i costruttori a fare la questua negli uffici comunali per ottenere cambi di destinazione d’uso di terreni, oggi sono i sindaci a inseguire i costruttori per poter firmare convenzioni che consentano di mettere in cassa i relativi oneri. La seconda è quella dei grandi eventi e delle grandi opere : che siano basi militari (Muos di Catania, Dal Molin di Vicenza), che siano mega-progetti infrastrutturali (Tav, Ponte sullo stretto, 35 nuovi progetti autostradali) o “eventi” (Giubileo di Roma, Expo di Milano), l’unico obiettivo è la consegna del territorio alla valorizzazione finanziaria e alla speculazione immobiliare.
8. Il patrimonio pubblico in mano agli enti locali ha, come abbiamo visto, dimensioni enormi (421 miliardi). La sua svendita, cominciata da tempo, è oggi considerata da Governo e Sindaci un vero e proprio piano strategico e, attraverso l’alibi della crisi del debito pubblico, sono ormai in adozione in tutti i Comuni piani di dismissione all’unico scopo di fare cassa. Anche i servizi pubblici locali sono da molto tempo sotto attacco e a rischio privatizzazione. Su questo terreno, come anche Deutsche Bank nel suo rapporto citato all’inizio ha dovuto riconoscere, la straordinaria vittoria referendaria del movimento per l’acqua nel giugno 2011 ha complicato molto i piani, senza tuttavia far desistere le grandi lobby finanziarie.
9. Cassa Depositi e Prestiti, ovvero l’ente (ora SpA, con all’interno le fondazioni bancarie) che raccoglie il risparmio postale (240 miliardi) di quasi 24 milioni di persone, è il vero e proprio braccio operativo di questo processo. Cassa Depositi e Prestiti interviene infatti sulla valorizzazione finanziaria del territorio, finanziando direttamente, o attraverso F2i (Fondo per le infrastrutture, partecipato al 16% da Cdp), molte delle grandi opere, in particolare autostradali, in corso o in progetto nel nostro Paese; così come, attraverso FIV(Fondo Investimenti per le Valorizzazioni) di CDPI sgr si propone agli enti locali come partner ideale per la valorizzazione degli immobili da immettere sul mercato, fissandone un prezzo ed impegnandosi ad acquisirli, qualora dopo bando l’ente locale non riesca a venderli (FIV comparto Plus) o acquisendoli direttamente (FIV comparto Extra); altrettanto determinante è il ruolo assunto da Cdp nei processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali, essendo da tempo impegnata attraverso F2i (Fondo per le infrastrutture) da una parte e FSI (Fondo strategico Italiano, interamente controllato da Cdp), in operazioni di ingresso nel capitale sociale delle aziende di gestione del servizio idrico e dei servizi pubblici locali per favorirne fusioni societarie e il rilancio in Borsa.
10. Se il luogo dello scontro sociale del prossimo periodo sarà dunque l’ente locale, il nodo intorno al quale si dipanerà sarà quello del ruolo di Cassa Depositi e Prestiti. Se sotto attacco è la stessa funzione sociale degli enti locali come luoghi di prossimità degli abitanti di un territorio, altrettanto sotto scacco è l’utilizzo della ricchezza sociale prodotta nel Paese, in particolare quella del risparmio postale dei cittadini, che invece di essere utilizzata per gli investimenti volti al soddisfacimento dei bisogni sociali e ambientali delle comunità locali, viene interamente indirizzata come leva per l’espansione dei mercati finanziari e finalizzata all’espropriazione dei beni comuni. Si comprende meglio, a questo punto, anche il senso profondo della progressiva riduzione degli spazi di democrazia, che vede nell’accentramento istituzionale da una parte e in una furbesca campagna contro la “casta” e relativa riduzione della rappresentanza dall’altra, il progressivo distanziamento dei luoghi della decisionalità collettiva dalla vita concreta delle persone. L’obiettivo è chiaro : se ciò che è in atto è un mastodontico processo di spoliazione delle comunità locali, diviene necessario rendere loro sempre più ardua qualsiasi forma di organizzazione e di protesta, trasformando in rassegnata solitudine quella che potrebbe altrimenti divenire lotta per la riappropriazione sociale.
11. Oggi sindaci e amministratori sono posti di fronte ad un bivio senza zone d’ombra : devono decidere se essere gli esecutori ultimi di un processo di privatizzazione che dalla Troika discende verso i governi e scivola giù fino agli enti locali o se riconoscersi come i primi rappresentanti degli abitanti di un determinato territorio e porsi in diretto contrasto con quei processi. Ma, indipendentemente dalla consapevolezza dei propri sindaci e amministratori, le donne e gli uomini di ogni comunità locale di questo Paese devono sapere che la lotta collettiva e generalizzata contro la trappola del debito, per una nuova finanza pubblica e sociale, per la riappropriazione sociale dei beni comuni, è interamente nelle loro mani. E che da essa dipende il destino della democrazia reale.
- See more at: http://altracitta.org/2014/03/05//#sthash.tUyn2one.dpuf
 Una valutazione sintetica ma esauriente del gioco delle tre carte con la quale stanno per concludere la dissoluzione della democrazia nella triste penisola. E gli eredi della sinistra, quando non guidano la truffa, tacendo acconsentono.
Una valutazione sintetica ma esauriente del gioco delle tre carte con la quale stanno per concludere la dissoluzione della democrazia nella triste penisola. E gli eredi della sinistra, quando non guidano la truffa, tacendo acconsentono.
Il Fatto quotidiano, 5 marzo 2014L’accordo truffaldino tra un premier diventato tale con una manovra di Palazzo (privo com’è di consenso elettorale) con un partitino di scissionisti nominati dal precedente padrone realizza l’abusivismo perfetto in una democrazia ormai per modo di dire: ci prendiamo il governo e vi sequestriamo il voto, tiè. Non lo chiameremo golpe perché non c’è dramma, trattandosi di un misero gioco delle tre carte. Si strombazza l’Italicum per la Camera, ma da usare solo quando il Senato sarà abolito, forse tra 18 mesi o forse mai. Un obbrobrio mai visto, incostituzionale col botto.
Del resto, è il sogno a lungo cullato lassù sul Colle che pur di non far esprimere gli italiani ha preferito affidarsi a maggioranze artificiali (Monti, Letta) che infatti si sono autodissolte con imperdonabile spreco di tempo e di energie. Adesso tocca al fenomeno Renzi inventarsi un sistema elettorale ad personam che scandalizza perfino uno specialista come Berlusconi. Il turbo fiorentino ha la mania dei record. Cinque riforme in cinque mesi (se sono tutte così…). Due maggioranze, una per le riforme e una per i giorni feriali.
E a ben guardare, nel suo governo di governi ce ne sono tre, uno dentro l’altro come le matrioske. Il primo è quello della bella presenza: il più giovane, il più snello, il più rosa, buono per i titoli sui giornali. Il secondo è quello che conta e fa di conto. Guidato dal ministro dell’Economia Padoan, presidia via XX Settembre con un blocco di tecnici che dovranno piacere a Bruxelles e a Berlino. Il terzo è il sottogoverno degli affari e degli inciuci, quello dei sottosegretari così impresentabili che perfino Alfano è costretto a cacciarne uno (il prode Gentile). A Renzi avevamo creduto quando aveva letto il successo alle primarie del Pd come l’ultima spiaggia di un Paese giunto allo stremo. In molti abbiamo pensato: questo fa sul serio. Ora si sta giocando tutto il capitale tra pasticci e imbrogli vari. Non si dura nascondendo le elezioni in un cassetto. E per governare non basta qualche tweet.
 La follia istituzionale di un parlamento eletto con una legge incostituzionale che cambia la Costituzione accogliendo l'iniziativa di «due personaggi ambedue sprovvisti di potere propositivo legale, uno perché condannato per truffa a danno dello stato e interdetto dai pubblici uffici, l’altro perché era titolare di una carica che lo rendeva incompatibile col mandato parlamentare».
La follia istituzionale di un parlamento eletto con una legge incostituzionale che cambia la Costituzione accogliendo l'iniziativa di «due personaggi ambedue sprovvisti di potere propositivo legale, uno perché condannato per truffa a danno dello stato e interdetto dai pubblici uffici, l’altro perché era titolare di una carica che lo rendeva incompatibile col mandato parlamentare».
Il manifesto, 4 marzo 2014
In un Paese civile, un evento senza precedenti nella storia degli stati, come la declaratoria di incostituzionalità del sistema di elezione del Parlamento – cioè della legge che sancisce la forma di stato e inerisce alla forma di governo — avrebbe determinato, immediatamente e senza alcuna esitazione, lo scioglimento immediato delle assemblee elette con quel sistema. Con l’assoluta sicurezza della legittimità del sistema elettorale col quale sarebbero state elette le nuove Camere, stante la fortuna di disporre di un meccanismo elettorale di risulta costituzionalmente corretto e immediatamente utilizzabile, depurato com’è delle disposizioni illegittime.
Siamo, invece, in Italia. Ci tocca quindi constatare che le due Camere del Parlamento restano, spavaldamente, in carica. Per giunta si apprestano a riformare addirittura la Costituzione e intanto a provvedersi di un altro sistema elettorale. A proporlo sono stati due personaggi ambedue sprovvisti di potere propositivo legale. Uno perché condannato per truffa a danno dello stato e interdetto dai pubblici uffici, l’altro perché era titolare di una carica che lo rendeva incompatibile col mandato parlamentare. Ambedue in preda all’ossessione di acquisire, esercitare e incrementare potere personale, anche calpestando norme e principi. Ma non basta. Ad integrare la devastazione giuridica, politica e morale che sta attraversando la nostra Repubblica, si aggiunge il tipo di sistema elettorale che propugnano i due usurpatori dei diritti dei componenti delle due Camere. Sistema che riproduce sfacciatamente le incostituzionalità già accertate dalla Corte, le riveste e le imbelletta con sguaiata volgarità.
Chi scrive, tuttavia, resta imperterrito difensore del parlamentarismo. Al punto da sognare un’estrema improbabilità. Pur se nominati e non eletti, è dal voto alle liste che contenevano i loro nome che i deputati e i senatori in carica derivano i poteri che spettano ai membri del Parlamento. È dal voto delle elettrici e degli elettori, pur se con sistema truffaldino, è dal corpo elettorale, pur se compresso e resecato, è in nome di quel poco che forse resta ancora della sovranità popolare che i deputati e i senatori seggono sugli scanni delle Aule delle due Camere. Potrebbero perciò riscattarsi dall’essere stati nominati e non eletti, potrebbero, per una volta, liberarsi dal dovere di ubbidire a chi li ha inclusi nelle liste e sentirsi obbligati invece a rappresentare «la Nazione senza vincolo di mandato» rifiutando di approvare una legge elettorale progettata da chi ha usurpato il loro potere fondamentale di proposta oltre che di approvazione delle leggi.
Una legge elettorale che si basa su due negazioni, due violazioni dei principi elementari dello stato rappresentativo e della democrazia. Uno è il principio della libertà di voto, quindi di scegliersi chi votare come proprio rappresentante. È menzogna volgare asserire che si è liberi di scegliere in caso di lista bloccata. Lo si sarebbe soltanto… votando per una lista avversaria a quella preferita con il candidato preferito collocato però in una posizione di assoluta improbabilità di elezione.
L’altra negazione è quella occultata dalla idolatria della governabilità, della stabilità, della personalizzazione del potere, tutto a un uomo solo, e di altre mistificazioni della politologia dominante e distruttiva del principio di eguaglianza. Si denomina «premio di maggioranza». Ne va smascherata la verità con forza e continuità per combattere il capovolgimento indotto nel senso comune di una verità elementare. È falso nel nome, nella sostanza e nell’effetto. Non premia affatto una maggioranza, vanifica quella vera. Il principio di maggioranza, come tutti sanno, presuppone il raggiungimento della metà più uno dei voti espressi. Il «premio di maggioranza» non lo si conferisce a chi questi voti li ha acquisiti (che oltretutto non avrebbe bisogno) ma a chi non li ha acquisiti. Lo si conferisce , quindi, a una minoranza, quella che ottiene un solo voto in più di ciascuna altra minoranza. Il «premio» si traduce quindi in un privilegio per una delle minoranze rispetto a tutte le altre. Privilegio che comporta compressione di voti e sottrazione di seggi a quella che risulterà essere la maggioranza reale, vera, perché composta dalla somma delle liste votate, esclusa la minoranza privilegiata. Col renzusconum una lista che ottiene il 37% dei voti, raggiunto magari con altre liste della coalizione che non hanno raggiunto la soglia del 5% dei voti, un<CW-26>a lista quindi che potrebbe aver conseguito solo il 30% dei voti o anche meno, otterrebbe il 53% dei seggi sottraendoli alla rappresentanza dei due terzi degli elettori. Non è l’unica violazione di ogni logica elementare del renzusconum. Ce ne sono altre come le «soglie» di entità esorbitante che perciò vanificano i voti di milioni di elettori che non si riconoscono in nessuna delle due aggregazioni supposte come maggiori. Soglie che operano selettivamente al primo scrutinio, ma scompaiono nel ballottaggio per riservarlo all’esclusivo dominio di tali aggregazioni.
Si sostiene che queste illogicità plateali, queste storture aberranti, si rendono necessarie per assicurare la governabilità anche se sacrificano l’eguaglianza. Un principio fondante (il massimo secondo Costituzione) dovrebbe recedere a fronte di un obiettivo che, al di là del costo altissimo in termini della stessa tollerabilità democratica, è tutt’altro che certo e comunque non sicuramente virtuoso. Lo dimostra l’esperienza disastrosa del governo Berlusconi, che dal 2008 al 2011 disponeva di una maggioranza enorme e ha portato l’Italia sull’orlo del default. Si sostiene anche che la sera dell’elezione gli elettori e le elettrici devono «sapere chi li governa». Mai idiozia così truffaldina fu congegnata. Averla prima inventata e poi diffusa ha determinato il rovesciamento tragico del senso dell’elezione trasmutandola in scelta di colui dal quale si sarà governati, come dire, se … da Francia o da Spagna si otterrà il «magnare». L’elezione non sarà più diretta alla scelta del rappresentante delle domande, dei bisogni, dei progetti di chi compone il corpo elettorale cui spetterebbe la sovranità. La sovranità sarà capovolta, diverrà sudditanza a un capo assoluto. La tragedia della democrazia si rappresenterà con la farsa dell’elezione.
Prima di approvare questa legge ci pensino i parlamentari della Repubblica. Chissà. Potrebbero cogliere l’occasione per rivelarsi tali.
 Sapide annotazioni e suggestive rimembranze storiche suscitate dalla mimica del figlio del Cavaliere.
Sapide annotazioni e suggestive rimembranze storiche suscitate dalla mimica del figlio del Cavaliere.
La Repubblica, 4 marzo 2014
Nell’eloquio del premier esordiente ricorrono i gesti esclamativi, abilmente usati. Definiamolo in greco: anziché dal nóos, organo intellettivo, sale dal thumós, sede degli spiriti vitali; volano parole esca cariche d’effetto; e talvolta catturano l’uditorio. Ad esempio, «rottame», da cui il verbo «rottamare»; o «mettere la faccia»; «se questo governo fallisce, la colpa è mia»; annunciava «una riforma al mese». Manca ancora la trama razionale: come stiano effettivamente le cose; quid agendum ossia la scelta del fine e i motivi; fin dove sia conseguibile; con quali risorse; come spenderle ecc.
Perdurando lacune sintattiche, siamo nella sfera del grido o segno mimico: N. batte pugni sul tavolo; solleva un sopracciglio; sta mani in tasca; dà manate sul palmo della mano altrui anziché stringerla. La politica, materia ibrida, ha testa e viscere: gestire l’interesse pubblico richiede mente fredda, acume percettivo, fantasia intellettuale, calcoli esatti; è una scienza ma chi comanda dura finché i sudditi non se lo scrollino, essendosi spenti i carismi che irradiava; e lì siamo sul terreno sensitivo.
La caduta dell’ex premier è caso classico: poco carismatico, teneva banco da 10 mesi, covato dal Quirinale; i punti deboli erano visibili da quando è emerso, sotto pesante parentela, ma pareva inamovibile, così protetto, avendo dalla sua l’inerzia d’una legislatura i cui reddituari, nominati dai partiti, mirano al quinquennio; e d’un colpo risulta fuori gioco.
Quanto influiscano gli sfondi emotivi, spesso determinanti, lo dicono quattro esempi. Nicola nasce nella Roma ancora semigotica, primavera 1313, tra i mulini del Tevere, sotto la Sinagoga, figlio dell’oste Lorenzo (Cola di Rienzo) e impara benissimo l’arte notarile. L’anonimo autore d’una Cronica romanesca lo descrive ferrato latinista: «deh, como e quanto era veloce lettore»; «tutta die» studia epigrafi delle quali pullula l’Urbe; decifra «li antiqui pataffii», interpreta figure, evoca tempi gloriosi. Le lapidi gli servono da scala: ha estro politicante; non ancora trentenne, sale ad Avignone, speaker del governo popolare; e torna con un buono stipendio, notaio del Tesoro comunale. Era posto strategico: in tale veste sferra «luculente » arringhe» contro i magnati, talmente stupidi da subire inerti un colpo di Stato (20 maggio 1347); nominatosi tribuno, governa a mano dura, col favore popolare, ma ha l’Io gonfio. L’inflazione megalomaniaca culmina nella fantasmagoria 31 luglio-1 agosto: cita Sua Santità, l’Imperatore, gli Elettori, i pretendenti; declina titoli immaginari («Candidatus Spiriti Sancti miles, Nicolaus Severus et Clemens, liberator Urbis, zelator Italiae, amator Orbis, Tribunus Augustus »). Ha dei soprassalti. Venerdì 14 settembre convoca i baroni, li imprigiona e condanna a morte ma l’indomani mattina cambia idea, convitandoli in Campidoglio. S’è candidato all’Impero. Chiama il popolo a parlamento e racconta dei sogni. Se ne stava sgomento quando i baroni vengono alla Porta Tiberina, 29 novembre, avendo complici tra le mura, ma il tentativo fallisce, allora. canta vittoria, sfila, arringa, nega la sepoltura ai tre Colonna morti. In fondo labile, dopo 15 giorni abdica rifugiandosi nel Castello, indi s’imbosca tra Napoli e Roma, ospite dei francescani spirituali sulla Maiella, poi in blanda prigionia boema dall’estate 1350, finché emissari papali lo riconducono ad Avignone (estate 1352). Morto Clemente VI, offre servizi nei domini italiani al successore Innocenzo (stesso numerale) e torna al seguito del cardinale legato. Era capolavoro d’arte ipnotica il modo in cui affascina i due fratelli del terribile e ricchissimo condottiero fra’ Moriale, con i soldi dei quali affitta una compagnia, accolto trionfalmente, ma ormai lo vedono deforme, malfermo, beone. La guerra contro i baroni ristagna. A tradimento cattura fra’ Moriale, decapitato sotto il Campidoglio, sulle cui scale mercoledì mattina 8 ottobre 1354 cade miserabilmente (tentava la fuga, travestito da rivoltoso).
L’impetuoso Francesco Crispi (1818-1901), due volte presidente del Consiglio, va soggetto a lampi allucinatori: teme attacchi dalla flotta francese; crede d’avere acquisito l’Impero etiopico con un imbroglio diplomatico, fallito il quale, manda al macello quattro brigate italiane nella giornata d’Adua, domenica 1 marzo 1896; e trova un culto postumo, quale precursore del Duce.
Il quale rifonda l’Impero e ne sogna uno mediterraneo-atlantico, guadagnato con mille o duemila morti nella scia delle vittorie hitleriane, a spese d’Inghilterra e Francia, paesi capitalisti. Dopo vent’anni d’una sbornia epica all’Italia «proletaria» (già Pascoli la chiamava così) restano gli occhi per piangere, ma gl’irriducibili rimpiangono l’uomo forte, taumaturgo, mago delle vie brevi, finito orribilmente appeso come Cola di Rienzo, perché dove gl’impulsi viscerali prevalgano sulle idee, ci vuol poco a convertirli nel contrario, dall’entusiasmo adorante al ludibrio del cadavere. Rimane costante un’acuta idiosincrasia: non piace chi parli poco, attento ai nessi, contando sul raziocinio; il difetto d’enfasi è piuttosto raro e chi vi cade lo paga.
Vedi Giolitti, aborrito in chiavi multiple: emette prosa secca, mentre gli antagonisti declamano (l’unica volta che cita Dante, molto a proposito, Montecitorio scoppia in una risata); tiene d’occhio i fatti, anziché cantare meraviglie; disegnando un socialismo riformista nell’area governativa, offende oligarchi e piccoli borghesi rampanti, consumatori d’erba retorica dannunziana; e colpa imperdonabile, non vede perché l’Italia debba giocarsi la testa saltando gratuitamente addosso a due potenti paesi dei quali è alleata da trent’anni.
Eravamo partiti dalla lingua politica italiana. Il premier in carica gioca d’effetto innestandovi locuzioni estranee alla parlata ufficiale. L’idem storico non esiste, irripetibile essendo ogni contesto, ma l’analogia aiuta a capire quel che avviene. Il punto interessante è cosa sia pronosticabile sul governo misteriosamente nato dai patti tra mercoledì 12 febbraio e l’indomani.
Lo strumento essenziale della democrazia rappresentativa continua a essere trattato come se il Palazzo si fosse trasformato in un mercato delle vacche (pardon, delle cacche) Il manifesto, 4 marzo 2014
L’intreccio è apparentemente senza soluzione, salvo che una soluzione c’è sempre: prendere un po’ di tempo. La corsa di Renzi sulla legge elettorale — quando era solo il segretario del Pd voleva approvarla in prima lettura entro febbraio, scadenza poi spostata di un mese causa più alto incarico — sbatte contro l’equivoco fondativo del suo governo. I garanti del patto sulle riforme, Berlusconi e Renzi medesimo, hanno interessi opposti a quello del partito che con i suoi 32 senatori tiene in piedi l’esecutivo, il Nuovo centrodestra di Alfano. Al presidente del Consiglio e al Cavaliere interessa tenere sulla corda i partiti con la minaccia di elezioni nel 2015, al ministro dell’interno sta a cuore prolungare la legislatura fino a quando Berlusconi sarà politicamente tramontato (per raccogliere la leadership che non può contendere). I primi hanno fretta, il secondo rallenta. Con Alfano sta la minoranza Pd che vuole mettere in crisi l’asse tra Firenze ed Arcore, oltre che una straordinaria ragione di buonsenso: l’Italicum applicato al bicameralismo paritario peggiora i suoi già numerosi difetti. Ecco spiegati gli emendamenti dei bersaniani Lauricella e D’Attorre, che rinviano l’operatività della nuova legge elettorale all’entrata in vigore della riforma del senato. Altra promessa, o minaccia, renziana.
L’aula della camera affronterà l’argomento oggi pomeriggio, partendo dal voto degli emendamenti al testo del relatore Sisto (Fi) che rispecchia il vecchio accordo Pd-Fi-Ncd. Ci sono i tempi contingentati e Renzi spera ancora di chiudere il discorso entro fine settimana. Stamattina il comitato dei nove della commissione affari costituzionali deciderà sull’ammissibilità dei nuovi emendamenti che andranno ad aggiungerci agli oltre duecento da votare. Tra questi nuovi quello D’Attorre che trasforma l’Italicum in una legge elettorale valida solo per la camera dei deputati. Dal punto di vista costituzionale nulla impedisce, ne ha impedito, di avere due sistemi diversi per le due camere — anche se la Consulta nella recente sentenza ha sottolineato i rischi per la governabilità. In teoria (ma non si è mai fatto) la Costituzione consentirebbe di sciogliere in anticipo anche una sola camera.
Con l’emendamento D’Attorre in caso di elezioni anticipate a prima della riforma del senato, per palazzo Madama si voterebbe con il sistema uscito dalla sentenza della Consulta, con soglia di sbarramento per le coalizioni persino più alta dell’Italicum (20%) ma più bassa per i partiti coalizzati (3%). E senza premio di maggioranza, quindi il vincitore della camera non avrebbe la garanzia di poter governare senza alleanze successive al voto. Per Renzi questa eventualità appare comunque preferibile rispetto alla proposta Lauricella, che rinvia l’entrata in vigore dell’Italicum alla riforma del senato, per la quale è decisivo ogni singolo voto del Ncd. In ogni caso potrebbe minacciare le elezioni anticipate, accada quel che accada. Il presidente del Consiglio non è però riuscito ancora a convincere il berlusconiano Verdini. Ha ancora qualche ora, perché gli emendamenti in questione, sui quali è possibile un pericoloso voto segreto, sono all’articolo due della legge e dunque non sarebbero stati in ogni caso votati oggi.
Nel frattempo è completamente uscita dai radar la proposta di riforma del senato, che il segretario Pd aveva promesso per metà febbraio. Si sa che persino il presidente della Repubblica ha fatto conoscere i suoi dubbi per la progettata «camera dei sindaci», e che Renzi sta immaginando correzioni. Ha fretta ma non riesce a correre.
Tre incantatori di serpenti raccolgono il 75% dei voti: come mai «folle sterminate di esseri umani preferiscono essere schiavi di un tiranno piuttosto che uomini liberi? Forse la libertà non è altrettanto conveniente quanto la schiavitù». Il manifesto, 4 marzo 2014
La sinistra è scomparsa. A metterla definitivamente fuori combattimento è stata la crisi economica che ha fatto emergere in maniera ancora più clamorosa che in passato la sua vacuità e inadeguatezza a rappresentare gli interessi dei ceti colpiti, la sua vocazione alla sudditanza e al compromesso. Lo spettacolo stringe il cuore. Tanto più che, mentre nelle piazze televisive trionfa una pletora di unti dal Signore (se Renzi è il figlio, Grillo è lo spirito santo), la sinistra non riesce a intonare neppure un mea culpa, a elaborare neanche uno straccio di riflessione autocritica. Come se nessuno fosse responsabile di niente, tutto fosse avvenuto per sentenza celeste e ormai non ci restasse che piangere.
A guardarsi intorno, si direbbe che il fascino perverso del catastrofismo ci abbia presi tutti al laccio: la piovra finanziaria, l’Europa dei forti, i nuovi schiavisti della mondializzazione produttiva sembrano aver eretto, tutti assieme, un muro impossibile da oltrepassare.
Ho partecipato alcune sere fa a una riunione di persone aventi alle spalle un onorevole passato di lotte democratiche, insomma di forte impegno politico. Non ho sentito echeggiare una sola parola di tipo propositivo, e ancor meno relativa agli errori commessi, ai comportamenti sbagliati, alle debolezze anche di tipo etico mostrate, si badi, non soltanto da questa o da quella organizzazione politica ma dai singoli, da tutti noi. Avrei voluto prendere la parola ma non ho osato, intimidito a mia volta dalla cupa atmosfera generale determinatasi, credo, in forza del prevalente sentire pessimistico dei presenti.
Le parole, lo sappiamo tutti, sono importanti, scalfiscono le nostre coscienze. Soprattutto quando vengono ossessivamente reiterate come fanno i giornali ogni mattina con questo lemma abusivo, come fa la televisione, come fanno i politici, i cittadini e come facciamo inconsapevolmente noi stessi attribuendo in tal modo, senza ritegno, quarti di nobiltà a politiche che meriterebbero ben altre definizioni.
Le parole devono corrispondere esattamente alle cose: guai se ciò non accade. Mi vengono a mente alcuni straordinari versi di Juan Ramon Jimenez: Intelligenza, dammi/ il nome esatto delle cose!/ … che la mia parola sia/ la cosa stessa…
Per noi infatti era «la cosa stessa», soprattutto se ci si riferisce al contenuto etico della parola «austerità», che da sempre si contrappone a «dissolutezza» e «corruzione» ed è metafora di costumi irreprensibili. Apparteneva insomma al nostro vocabolario (chi più di noi può amare e praticare l’austerità?): abbiamo lasciato senza colpo ferire che diventasse l’altrui foglia di fico. Anzi peggio: che diventasse la nostra parola «nemica», la bandiera da abbattere.
 Diceva Andreotti: a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. Ecco perchè B. preferisce governare così.
Diceva Andreotti: a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. Ecco perchè B. preferisce governare così.
Il Fatto quotidiano, 2 marzo 2014
A gennaio, quando Renzi incontrò il pregiudicato interdetto decaduto Berlusconi nella sede Pd per discutere la nuova legge elettorale e le riforme collegate (Senato e Regioni), scrivemmo pur fra mille dubbi che non era proprio uno scandalo. Le leggi elettorali appartengono agli elettori, non agli eletti, dunque era impensabile tagliar fuori il maggior partito di centrodestra.
Inoltre, stante lindisponibilità dei 5Stelle persi nella Rete, per sbloccare l'impasse non restava che rivolgersi al terzo partito, Forza Italia: l'unico che poteva assicurare una maggioranza in Parlamento. Renzi, appena plebiscitato segretario del Pd, giurava che l'accordo con B. era per una legge che ci mettesse al riparo da altri governi con B.
Intanto, mentre lui e B. si occu-pavano delle riforme, Letta poteva governare sereno. Non restava che prenderne atto e aspettarlo al varco, cioè alla prova dei fatti: per quanto inedita, lipotesi che un politico italiano dicesse la verità non andava scartata a priori. Ora, meno di due mesi dopo e alla luce dei fatti, possiamo tranquillamente affermare che Renzi mentiva.
L'accordo con B., quasi sempre intermediato dal comune amico Denis Verdini, è ben più vasto e stringente di unintesa tecnica per quelle tre riforme. È un patto d'acciaio le cui clausole restano occulte, anche se i risultati si manifestano ogni giorno più chiari.
Il Caimano sa che il 10 aprile si riunisce il Tribunale di sorveglianza per decidere dove sconterà i 7 mesi di pena (quel che resta della condanna a 4 anni, detratti i 3 anni di indulto e i 5 mesi di liberazione anticipata extralarge sancita dallo svuotacarceri Cancellieri): in galera, o ai domiciliari, o ai servizi sociali. Forse, per non alimentare il suo vittimismo durante la campagna elettorale per le Europee, il verdetto slitterà di un paio di mesi. In ogni caso il pregiudicato sarà politicamente fuori gioco sino a fine anno: guiderà il partito per interposto Toti. Intanto tenterà il colpaccio: candidarsi ugualmente alle Europee in barba alla legge Severino e sfidare gli uffici elettorali della Corte dappello a depennarlo, con una prova muscolare che mira a resuscitare il vecchio nemico, le toghe rosse; a incendiare una spenta campagna elettorale; e a mettere in difficoltà l’amico Matteo.
Per portare a termine il piano, B. ha bisogno di un governo che regga almeno un anno, dandogli modo di tornare come nuovo a Natale e di organizzare l’unica campagna che gli sta a cuore: quella delle politiche, che non fa mistero di auspicare per il 2015. Il governo Letta questa garanzia non gliel’assicurava: stava insieme con lo sputo, passava di gaffe in scandalo, non aveva più l’appoggio del Pd, poteva sfasciarsi da un momento all'altro. E, se anche fosse durato fino al 2015, avrebbe costretto il quasi ottantenne Caimano a sfidare un giovane come Renzi, che ha la metà dei suoi anni, per giunta intonso da esperienze governative e dunque molto più fresco e popolare di lui. Una partita persa in partenza.
L'ideale era che Renzi subentrasse a Letta sputtanandosi con un colpo di palazzo senza passare dal voto, risputtanandosi con estenuanti trattative con i partiti e i partitini di una maggioranza Brancaleone, arcisputtanandosi con un governicchio impresentabile e ultrasputtanandosi con grandi promesse e pochi fatti. Lamico Matteo,con ammirevole abnegazione, lha puntualmen-te accontentato. Missione compiuta. Già che ce-ra, gli ha pure regalato il controllo militare sui ministeri della Giustizia (con i berlusconiani Costa & Ferri), delle Infrastrutture (con i diversamente berlusconiani Lupi & Gentile) e delle Attività produttive (con la berlusconiana Guidi che veglia anche sulle Comunicazioni).
Così B. potrà seguitare a governare sui propri interessi e “gratis”, senza nemmeno il fastidio di entrare nella maggioranza, metterci la faccia e sporcarsi le mani.
 Finalmente una proposta sensata e concreta per uscire dalla crisi, ispirata da Luciano Gallino e proposta dai parlamentari di SEL. Non solo le cose da fare ma anche le risorse da impiegare. Sarebbe l'inizio di un'inversione di tendenza, possibile se il PD fosse diverso.
Finalmente una proposta sensata e concreta per uscire dalla crisi, ispirata da Luciano Gallino e proposta dai parlamentari di SEL. Non solo le cose da fare ma anche le risorse da impiegare. Sarebbe l'inizio di un'inversione di tendenza, possibile se il PD fosse diverso.
Greenreport, 27 febbraio 2014, con postilla
Dall’opposizione Sinistra ecologia libertà prova a inserirsi in grande stile nel dibattito sulle prime misure economiche annunciate dal nuovo presidente del consiglio Matteo Renzi. Ieri Giorgio Airaudo ha presentato la proposta di legge per la «istituzione di un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici denominato «Green New Deal italiano» contro la recessione e la disoccupazione», da attuare tramite l’istituzione di una Agenzia nazionale per gli anni 2014-2016.
Airaudo, presentando la proposta, ha ricordato i dati sconvolgenti pubblicati dall’Istat nell’ottobre 2013, quando i disoccupati erano arrivati a 3.189.000 e ha evidenziato che con queste cifre, anche «se il quadro economico mutasse e vi fosse un boom, occorrerebbero non meno di 15 anni per riportare l’occupazione a livelli che si possano considerare fisiologici e non si riuscirebbe comunque a tornare ai livelli precedenti (ad esempio al dato del 2005, che ha costituito l’anno migliore del nuovo secolo per l’occupazione nei Paesi Ue), tenendo presente che la maggior parte delle imprese stanno provvedendo a sostituire in misura e rapidità crescente il lavoro umano con varie forme di automazione».
Sel parte da una convinzione che è l’esatto contrario della ricetta neoliberista: «È l’occupazione che genera sviluppo, non il contrario. I dati relativi al tasso di disoccupazione nel nostro Paese mostrano un quadro di assoluta gravità che continua a peggiorare. Si tratta di una vera e propria emorragia di posti di lavoro, che colpisce gli under 30, ma non di meno tutte le altre fasce di età. Quello che più turba è l’enorme crescita di quanti si dicono “scoraggiati”, che hanno smesso di cercare lavoro perché ritengono di non trovarlo. La disoccupazione continua a crescere anche nell’ambito del lavoro precario, a riprova del fatto che la scelta di favorire contratti non a tempo indeterminato ha poco o scarso impatto sul problema occupazionale, mentre priva i lavoratori di molti diritti fondamentali».
Airaudo, in una conferenza stampa con Luciano Gallino, vero ispiratore del Green New Deal, ha detto che l’obiettivo della proposta di legge è quello di «creare 1 milione e mezzo di posti di lavoro in tre anni, impegnando circa 17 miliardi, con lo Stato che diventa datore di lavoro di ultima istanza». Si tratta della trasposizione in proposta legislativa di quell’Agenzia per l’occupazione ipotizzata da tempo dal sociologo torinese, che ha descritto più di un anno fa anche sulle pagine di greenreport.it.
Gallino ha dunque sottolineato che «la priorità di questo Paese è il lavoro, che è una cosa molto concreta che richiede risposte precise. Se ci si affida al mercato e agli incentivi è impossibile risolvere il problema della disoccupazione». Per Gennaro Migliore, capogruppo di Sel alla Camera, il Green New Deal italiano sarebbe «uno choc positivo per l’economia che però dovrà avere effetti benefici anche sull’ambiente e non devastarlo. Anche la competitività delle imprese italiane non verrebbe intaccata dall’impegno pubblico. Non si può affidare al mercato quello che il mercato non vuole e non può fare».
Ma dove prendere i soldi? 17 miliardi di euro non sono così pochi, di questi tempi. Airaudo ha però puntualizzato subito che «la copertura dell’investimento triennale dovrebbe venire dall’uso dei fondi della Cassa depositi e prestiti, anche attraverso l’emissione di obbligazioni, e dai Fondi strutturali europei. Con una responsabilizzazione degli enti locali, attraverso l’allentamento del patto di stabilità interno. Ma attenzione, con una clausola sull’occupazione netta: chi vincesse a livello locale questi appalti dovrebbe non aver licenziato nei 24 mesi precedenti e impegnarsi a non licenziare nei 24 mesi successivi». Un punto controverso, questo. Se da una parte si tratta di una strategia per evitare escamotage da parte dei soliti furbi, dall’altra rischia di penalizzare anche quelle imprese che negli ultimi due anni hanno giocoforza dovuto affrontare licenziamenti per poter sopravvivere.
Il piano straordinario per il lavoro di Sel è in ogni caso una potente sfida politica al Pd, visto che dovrà essere discusso nel percorso parlamentare del Jobs Act di Matteo Renzi. «Serve un New Deal ispirato a quello rooseveltiano, e noi pensiamo che lo Stato possa diventare datore di lavoro di ultima istanza»: per far questo, secondo Gallino, «gli interventi vanno concentrati nei settori ad alta intensità di lavoro», che per Sel sono «il risanamento delle scuole, la ristrutturazione degli ospedali e la manutenzione del territorio per contrastare il dissesto idrogeologico». Si tratta di un tipo di occupazione in gran parte immune ai rischi da quell’informatizzazione e automatizzazione che attualmente spingono verso la disoccupazione tecnologica e, cosa non meno importante, si tratta di posti di lavoro che per loro natura non possono essere delocalizzati, come ha sottolineato proprio Gallino.
Gallino ha spiegato le differenze tra questo Green New Deal dal Jobs Act di Renzi: «La proposta di Sel è una proposta concreta, precisa, si potrebbe approvarla in una settimana e farla partire in 15 giorni. Si tratta di una proposta argomentata in 40 pagine di dati e statistiche. Da Renzi, sul lavoro, vorrei vedere qualcosa di più sostanzioso perché finora siamo sul piano dei discorsi. Il Jobs Act che ho scaricato dal sito di Renzi è soltanto un dossier di poche pagine che contiene alcune idee interessanti e altre a dire il vero mirabolanti. Ad esempio è mirabolante l’idea di cambiare per intero la legislazione sul lavoro in 8 mesi. In Italia, la legislazione sul lavoro ha cominciato a evolversi il 1 gennaio 1948, quando è nata la Costituzione. Otto mesi sono pochi date queste premesse di contenuto. Quelle del Jobs Act sono poche paginette che volano per aria. Aspetto che le paginette di Renzi diventino qualcosa di più concreto».
A Gallino – che nel suo ultimo libro parla, fin dal titolo de “Il colpo di Stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa” – gli è stato chiesto come questo ragionamento faccia da premessa alla necessità di un Green New Deal e lui ha risposto: «Tra il novembre 2011 e il febbraio 2012 la Bce ha prestato alle banche europee più di un trilione di euro, ovvero più di 1000 miliardi. Le banche italiane ne hanno approfittato per 300 miliardi. Una frazione minima di questi miliardi sono finiti alle imprese e per creare occupazione; gli altri sono stati depositati come collaterali alla Bce per impieghi prevalentemente bancari e finanziari privi di impatto sull’economia reale».
Postilla
 Nel libro del sapiente costituzionalista Paolo Maddalena riemerge il tema nodale dell’urbanistica – l’appartenenza pubblica della facoltà di edificare - colpevolmente trascurato per troppi decenni dagli addetti ai lavori e dai decisori nazionali, regionali e comunali
Nel libro del sapiente costituzionalista Paolo Maddalena riemerge il tema nodale dell’urbanistica – l’appartenenza pubblica della facoltà di edificare - colpevolmente trascurato per troppi decenni dagli addetti ai lavori e dai decisori nazionali, regionali e comunali
Paolo Maddalena, Il territorio bene comune degli italiani, Donzelli, pp. 210, € 18
La partita del territorio italiano, del paesaggio e della loro tutela, si gioca tutta intorno a un’espressione latina, ius aedificandi.
Secondo Paolo Maddalena, professore di Diritto romano, poi giudice della Corte dei Conti e, per un decennio, della Corte Costituzionale, se si chiarisse per bene, senza ambiguità, che una cosa è essere proprietari di un suolo altra cosa è aver diritto a farci quel che si vuole, forse per territorio e paesaggio italiano si può immaginare un futuro più sereno. Ma che cosa c’entra lo ius aedificandi?
C’entra, spiega Maddalena in questo saggio di lettura agile (con introduzione di Salvatore Settis), nonostante la mole di sapienza giuridica che vi è riversata, perché un presunto diritto a costruire si ritiene sia connaturato al diritto di proprietà. È una convinzione molto diffusa in Italia: ne è prova il successo di uno degli slogan simbolicamente più efficaci del berlusconismo, “padroni in casa propria”, che ha fatto proseliti sia fra i grandi che fra i piccoli possessori di aree, a dimostrazione che esiste nel nostro paese un nutrito, multiforme “blocco edilizio” tenuto insieme da una smodata intolleranza verso le regole. Ma uno ius aedificandi così inteso, baluardo di un oltranzismo privatistico, è uno sgorbio giuridico, insiste Maddalena, senza riscontri nelle fonti del diritto romano, anzi ampiamente smentito da questo, e soprattutto in patente contrasto con la nostra Costituzione. Ciò nonostante sul diritto a costruire vige una specie di consuetudine, avallata da alcune norme del codice civile e da qualche sentenza della Corte Costituzionale (risalente a prima che Maddalena vi facesse parte) e poi da un sentire diffuso che autorizza sia abusi edilizi sia piani casa.
E invece possedere un suolo non è come possedere un tavolo. Non lo si può trasformare o manipolare a piacimento. L’edificazione, scrive Maddalena, «produce effetti non solo sui beni in proprietà del privato, ma anche sui beni che sono in proprietà collettiva di tutti, come il paesaggio, che, essendo un aspetto del territorio, è in proprietà collettiva del popolo, a titolo di sovranità».
Stendere un velo di cemento anche solo su duecento metri quadrati di suolo sottrae irreversibilmente a questo alcune funzioni che sono di interesse della collettività. Quella porzione di suolo sarà impermeabilizzata, con un acquazzone la pioggia vi scivolerà e non sarà assorbita ricaricando le falde. Il suolo non potrà più essere coltivato. Non immagazzinerà più carbonio. Se sopra il velo si innalzerà un edificio, questo altererà la prospettiva esistente, attirerà più persone, produrrà più scarichi. Se invece che uno, gli edifici sono tanti, tutti questi effetti si moltiplicheranno. Non può essere solo il proprietario a decidere che cosa fare del suo suolo.
La proprietà privata non dà diritti illimitati. Diritti che, per fare un esempio, un costruttore ritiene di poter esercitare quando va a contrattare la trasformazione di un area con un’autorità pubblica troppo spesso soggiogata politicamente. Ma – ed è qui uno dei punti cruciali del saggio di Maddalena – non è la proprietà privata limitata dagli interessi pubblici. La prospettiva va ribaltata. È il territorio nel suo complesso un bene appartenente alla collettività (come sostenevano già i romani), essendo il territorio il luogo nel quale si esercita la sovranità popolare. E ciò determina, scrive Maddalena, una prevalenza giuridica dell’interesse pubblico su quello privato. Detto in altri termini (sperabilmente non troppo elementari): se in qualunque modo si tocca il territorio sono gli interessi pubblici che vanno considerati più di quelli privati.
Il libro di Maddalena ripercorre in modo assai coinvolgente la storia di come il territorio sia stato considerato un bene collettivo ed enumera le norme giuridiche che hanno supportato questa concezione. Dall’età classica alla nostra Costituzione. Inoltre il libro è percorso dall’idea di quanto sia necessario riferirsi a questi principi nella pratica legislativa, in quella politica e in quella amministrativa. Qui non è possibile neanche sintetizzare tale ricchezza di documentazione, salvo sottolineare come il saggio di Maddalena segni un punto fermo nella saggistica dedicata al territorio e al paesaggio. E nelle battaglie per la loro tutela.
suo partito. Ma la sinistra è un'altra cosa. Il manifesto, 2 marzo 2014
Chissà se al compagno Renzi sarà andato di traverso il pop-corn quando Martin Schulz, a conclusione del congresso-convenscion del Pse, ha esordito con «Cari compagni…», rivolgendosi naturalmente anche alla folta delegazione di un partito, che ha cancellato la parola sinistra dal suo nome. Il libraio di Wurselen è da ieri il candidato alla presidenza della Commissione europea. Lo ha designato l’assise di Roma, alla fine delle tre giornate convocate per accendere i motori di una campagna elettorale difficile, decisiva, con una posta altissima per la sinistra e per le sorti stesse dell’Europa.
Nella sala del palazzo dei congressi quello di Schulz è risuonato come un discorso d’altri tempi, più vicino alle corde di un socialismo lombardiano d’altri tempi che a quelle di un liberismo blairiano, ispiratore del nuovo corso renziano. Contro una crisi che ha fatto «i ricchi sempre più ricchi», che ha prodotto «120 milioni di poveri, 27 milioni di disoccupati», Schulz ha chiesto ai rappresentanti del socialismo europeo se erano «ancora in grado di sentire il dolore di chi con la crisi ha perso il lavoro, la casa, la certezza di poter sfamare i propri figli», perché «solo se saremo in grado di condividere questo dolore — ha avvertito il leader socialdemocratico — potremo meritare di vincere le elezioni».
Questo socialista che milita nell’Spd dall’età di diciannove anni, ha parlato del bisogno di ricostruire un’Europa sociale e democratica, aperta nelle sue frontiere, dove «nessun paese dovrà imporsi agli altri», dove «al centro dovrà esserci la parola uguaglianza», contro la “mano invisibile” del mercato che tutto regola, contro una politica che «pensa solo a salvare le banche», contro «i cinici sempre in agguato, e sempre pronti a dire che il voto non conta perché sono gli accordi nascosti», a dettare legge. Dunque il prossimo 25 maggio la sinistra «che si è persa deve ritornare a casa».
Ma Schulz è anche un bravo equilibrista, molto attento a non nominare la revisione dei Trattati, a non citare mai la Bce, a glissare sulle larghe intese che in Germania e in Italia continuano a parlare la lingua del fiscal compact. Una lacuna tempestivamente colmata da Renzi quando, nel suo breve intervento, ha assicurato che prima di tutto l’Italia «deve adempiere ai propri obblighi tenendo i conti in ordine». Tutto il contrario di quel che ispira il candidato della sinistra Alexis Tsipras, simbolo di una battaglia e di una coalizione che mette al centro la critica alla politica economica delle istituzioni monetarie e dei governi che se ne sono arcigni guardiani. E che, dalla Grecia, indica la rotta per un’altra Europa.
 Bisogna finanziare la scuola privata perché la scuola pubblica è migliore: le paradossali argomentazioni della nuova ministra del governo Renzi, “giovane” e “rosa” nell’apparenza ma vecchio e nero nella sostanza. L
Bisogna finanziare la scuola privata perché la scuola pubblica è migliore: le paradossali argomentazioni della nuova ministra del governo Renzi, “giovane” e “rosa” nell’apparenza ma vecchio e nero nella sostanza. L
a Repubblica, 2 marzo 2014
Cambiano i governi non la politica scolastica, che promette di andare verso la graduale eguaglianza delle scuole private a quelle pubbliche. Alcuni governi sono più energici di altri; questo parte con una straordinaria determinazione. Le prime dichiarazioni della nuova ministra della Pubblica istruzione, Stefania Giannini, sono improntate al merito e al bisogno, per usare una fortunata coppia di valori, molto frequentati negli anni ’80. Il merito dovrebbe guidare la diversificazione remunerativa degli insegnati delle scuole pubbliche: coloro che producono di più dovrebbero essere meglio retribuiti, come i dipendenti di una qualunque azienda.
Il criterio per stabilire il merito nell’insegnamento medio e superiore non sarà facile da individuare, a meno che non si adottino criteri discutibili come il numero dei promossi, le ore di servizio alla scuola, o il buon gradimento da parte dei genitori o del dirigente scolastico. Ma è doveroso attendere le proposte prima di giudicare, riservandoci un angolino di scetticismo per le pratiche che vogliono applicare la logica degli incentivi economici a tutte le funzioni indifferentemente, non tenendo conto che ci sono beni di cittadinanza (come la scuola) che non possono essere giudicati con gli stessi criteri della produzione di beni destinati al mercato.
Le dichiarazioni di Stefania Giannini sono invece più esplicite nella parte relativa ai rapporti dello Stato con le scuole private paritarie. Qui la ministra invoca il bisogno. E le posizioni che emergono sono molto preoccupanti benché non nuove. Nuovo è l’armamentario argomentativo, perché pensato non per convincere che le scuole private parificate meritino più finanziamenti, ma per sostenere che esse hanno bisogno dei soldi pubblici e, infine, che il sollievo dal bisogno sarà garantito dal percorso del governo che va verso l’affermazione dell’eguaglianza piena, non più della parità, delle scuole private con quelle pubbliche. Il fine è far cadere ogni barriera che distingue i due ordini di scuola allo scopo di non dover più giustificare i finanziamenti pubblici, che a quel punto sarebbero dovuti. In questa cornice si iscrive la proposta della ministra di rilanciare le scuole private paritarie.
Veniamo alla giustificazione di questa marcia accelerata verso la scuola privata, che come si è detto è basata sul bisogno: in pochi anni le scuole private hanno perso studenti (in cinque anni uno su cinque), e per fermare questa emorragia lo Stato dovrebbe intervenire. E così è. I soldi pubblici sono infatti già stati accreditati alle Regioni, come ha comunicato la Compagnia delle opere (ben rappresentata nel governo): 223 milioni di euro stanziati per l’anno scolastico 2013/2014, in aggiunta a 260 milioni già previsti per lo stesso anno. In tutto, 483 milioni che tengono in piedi un settore in estrema difficoltà. Il pubblico, dunque, “tiene in piedi” la scuola privata in difficoltà. I vescovi e la ministra Giannini all’unisono chiamano questa una politica di «libertà effettiva di scelta educativa dei genitori».
Ma se c’è emorragia di studenti dalle private alle pubbliche, logica vorrebbe che si diano più risorse alle pubbliche, sia perché ne hanno presumibilmente più bisogno sia perché se lo meritano, avendo attratto più studenti, nonostante le “classi pollaio” esito della riforma Gelmini. Se è solo per bisogno che le scuole private devono ricevere i soldi pubblici, ciò significa che lo Stato fa dell’assistenza vera e propria. Non è dunque chiaro con quale logica la ministra applica la coppia merito/ bisogno, perché qui sembra di capire che le pubbliche siano punite proprio per ricevere gli studenti che abbandonano le private, le quali per non saper trattenere gli studenti ricevono invece i finanziamenti. È chiaro che i soldi pubblici servono a tenere queste scuole in vita, non a premiare il merito o il buon rendimento.
Tenerle in vita, si sostiene, perché sono il luogo dove si concretizza la «libertà educativa dei genitori». Ma perché i genitori scelgono di iscrivere i figli alla scuola pubblica? Presumibilmente questa loro scelta libera è dettata da ragioni di merito: la scuola pubblica è, nonostante tutto, migliore e vince sul mercato della libertà educativa. Ma a seguire le parole del ministro sembra di capire che lo Stato interverrebbe quando la scelta è già stata fatta, ovvero per finanziarne il residuo (cioè il risultato di quella scelta) non per garantirla. Qui vediamo in azione l’opposto del criterio del merito e del bisogno legato al merito, e inoltre una stridente contraddizione con il principio della libera scelta.
Un argomento insidioso per giustificare il tampone di emorragia con i soldi pubblici è che un alunno delle scuole private costa meno di un alunno delle scuole pubbliche. Nel contesto di razionalizzazione mercatista della spesa pubblica nella quale ci troviamo, non si fatica a intuire quale sarà il passo successivo: meglio finanziare le scuole private che quelle pubbliche perché costano meno all’erario. Questo sarebbe un epilogo fatale per la scuola pubblica. A giudicare da queste prime dichiarazioni della ministra Giannini, nel settore dell’istruzione il governo promette di essere un governo della restaurazione, ovvero di voler chiudere la disputa tenuta aperta dalla nostra Costituzione, decretando che tutte le scuole sono pubbliche, quelle dello Stato e quelle private parificate, che tutte devono essere “eguali”. La maggioranza parlamentare ha il potere di farlo. Ma l’opinione pubblica e politica ha il dovere di criticare questa scelta e di operare per fermarla o cambiarla.


giuliarodano.eu, 24 febbraio 2014
| Nel governo la metà dei ministri sono donne. Ma io non sto serena. Rimane qualcosa che non mi convince, anzi, per dirla tutta, che mi irrita, un sassolino nella scarpa o una briciola tra le lenzuola. Non sto serena perché solo qualche settimana fa una giovane donna in gamba è rimasta fuori dal Consiglio regionale della Sardegna, nonostante avesse raccolto oltre il 10% dei consensi. E non ho sentito una sola parola di condanna su una legge elettorale così infame, Anzi la Tavola della parità ha ribadito la richiesta di modifiche corporative all’ Italicum, che tanto somiglia alla legge sarda. Non sto serena perché delle donne ministro una è portatrice di clamorosi conflitti di interesse, un’altra intende governare la scuola applicando invece che rovesciando le ricette devastanti dei suoi predecessori e perché della terza non ho sentito una sola parola conto gli F35. E siamo solo alle prime battute. Mi si dirà, ma potrebbero fare altrettanto gli uomini. E vero. E quindi non basta che ci siano le donne per farmi essere serena. Non è questa presenza che fa la novità del governo. Possibile che in un governo con otto ministre non ci sia una parola nel programma per la lotta alle dimissioni in bianco, non vengano pronunciata dal presidente del Consiglio le parole giustizia sociale, o il temine evasione fiscale o la parola precariato o al a disoccupazione intellettuale. Che non ci sia una parola per le ragazze che devono rinunciare alla maternità perché la partita Iva o il contratto a termine non le garantiscono più. Non sto serena. A me avevano insegnato, le tante che mi hanno preceduto e che hanno aperto la strada, che le donne, lottando per la loro liberta, avrebbero contribuito alla liberta di tutte e di tutti. Avrebbero cambiato la politica, le sue forme e i suoi contenuti, avrebbero rovesciato il punto di vista sulle cose, affermando quello di genere. Avrebbe preteso un mondo in cui dove ogni volta che si pensa o di dice uno non può che dirsi e intendersi due. Invece sembra bastarci che ci sia un numero di ministre pari a quello dei ministri, chiunque siano, qualunque cosa facciano e dicano. Sembra bastarci – esattamente come agli uomini - che ci vengano assicurati dei posticini sicuri in una brutta legge elettorale. Non ci interessa che più della metà delle donne sarde siano fuori della rappresentanza. Non ci viene in mente che una legge che esclude i cittadini, escluderà le donne e le escluderà di più. Ma quello che sembra interessarci è essere il 50% dei non esclusi. Le donne non devono salvare il mondo, mi si dice. Ma milioni di donne non sono libere, in Italia. A che pro il 50/50 se loro sempre non libere rimangono? |
 «Il Pd non sarà più un partito di centrosinistra, tanto meno di sinistra, quale mai è stato. Sarà sempre più quello che in parte è già oggi: un partito personale, anzi una agenzia di marketing elettorale, nuova fiammante come una Ferrari». Che fare allora? una risposta c'è.
«Il Pd non sarà più un partito di centrosinistra, tanto meno di sinistra, quale mai è stato. Sarà sempre più quello che in parte è già oggi: un partito personale, anzi una agenzia di marketing elettorale, nuova fiammante come una Ferrari». Che fare allora? una risposta c'è.
Il manifesto, 1 marzo 2014
«Il tunnel in cui siamo rinchiusi è cementato dal potere lasciato alla finanza e dall’ideologia del mercato, traccia il trentennio liberista che ci ha portato alla depressione. Se ne può uscire soltanto con un cambiamento profondo del modello economico e dell’orizzonte politico».
Sbilanciamoci.info, 28 febbraio 2014
Una moneta senza Stato, la Bce che protegge la finanza dall'inflazione, salva le banche fallite e non protegge dalla recessione. Ma cosa accadrebbe se si tornasse alle valute nazionali?
Se guardiamo indietro, abbiamo venticinque anni di politiche monetarie sbagliate, che hanno fondato su mercato e moneta unica l’intera costruzione europea, abbandonando via via occupazione, modello sociale, diritti, democrazia. Appena dietro di noi abbiamo la più grave crisi del capitalismo dal 1929, da cui nasce la depressione attuale. I paesi che hanno provato a uscirne – Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone – l’hanno fatto creando nuove bolle speculative per la finanza, alimentate dall’introduzione di un’enorme liquidità nell’economia mondiale. Se guardiamo avanti, il buio è fitto. Le promesse di ripresa dell’economia sono state finora illusorie e riguardano soprattutto pochi paesi del nord Europa. A Bruxelles, Berlino e Francoforte la politica resta immutabile: per la periferia d’Europa austerità fiscale, un debito insostenibile anche se gli spread calano, politica monetaria rigida, mano libera per la finanza. Ci muoviamo in un lunghissimo tunnel da cui sembra impossibile uscire.
È il tunnel dell’euro, di una moneta senza stato, di una Banca centrale che protegge la finanza dall’inflazione ma non sa affrontare la recessione, che salva le banche fallite ma rifiuta di sostenere il debito degli stati. È il tunnel di un’Europa asimmetrica nelle forze produttive e nel potere politico, che produce squilibri e ne scarica i costi sulle periferie, costrette a imitare l’impossibile modello d’esportazione della Germania. Il tunnel di una politica – anche quella del nuovo governo di Matteo Renzi, al centro dello speciale della settimana scorsa – che ripete annunci illusori sulla fine della crisi e sui tagli alle tasse, ossessionata dall’austerità quando la disoccupazione giovanile arriva al 40%, una politica che di fronte alle reazioni anti-europee sceglie di cavalcare anch’essa le pulsioni populiste.
Guardando fuori d’Europa il buio è ancora più vasto. L’inizio della restrizione monetaria negli Usa ha già provocato in molti paesi emergenti fughe di capitali, recessione, svalutazioni. Nei confronti del dollaro, nell’ultimo anno la valuta del Brasile si è svalutata del 17%, quelle di India, Indonesia, Russia e Sudafrica di circa il 20%, la lira turca del 22%, il peso argentino del 60%. Sono tutti paesi inondati di capitali dai paesi ricchi che ora si trovano indebitati con l’estero, debiti da rimborsare in valute più costose e a tassi d’interesse crescenti: si direbbe che si prepara una nuova versione della crisi del debito del Terzo mondo degli anni ’80. Facile immaginare che se in Italia avessimo nuovamente la lira, anch’essa sarebbe in balìa della speculazione, con i prezzi delle importazioni gonfiati dalla svalutazione, l’export depresso dalla crisi internazionale, i capitali in fuga da un paese che non cresce da vent’anni.
Non ci sono scorciatoie – come la nostalgia per la lira per uscire dal tunnel. Al di là degli errori commessi sull’euro – che Sbilanciamoci! denunciava già nel suo Rapporto 2002 – il tunnel in cui siamo rinchiusi è cementato dal potere lasciato alla finanza e dall’ideologia del mercato, traccia il trentennio liberista che ci ha portato alla depressione. Se ne può uscire soltanto con un cambiamento profondo del modello economico e dell’orizzonte politico.
È nel mezzo di questo tunnel che andremo al voto alle elezioni europee. Un tentativo di procedere a piccoli passi è quello che propone nell’intervista a pagina due di questo speciale Martin Schultz, candidato socialdemocratico alla presidenza della Commissione europea. Troppo poco e troppo tardi, a sei anni dall’inizio della crisi. L’alternativa di Sbilanciamoci! e della Rete europea degli economisti progressisti (Euro-pen) è presentata a pagina tre: un’unione monetaria da ricostruire con nuove regole per la Banca centrale europea, una garanzia comune sul debito pubblico con l’emissione di eurobond e forme di controllo sui movimenti di capitali, limitando la libertà d’azione della finanza. E, naturalmente, meno poteri ai banchieri e a Berlino, e più democrazia nelle scelte economiche, aprendo la strada alla fine dell’austerità e a politiche industriali e del lavoro disegnate per uno sviluppo sostenibile sul piano sociale e ambientale.
Sono le proposte di cambio di rotta che saranno discusse il 19 marzo al Forum "Un’altra strada per l’Europa" al Parlamento europeo, che qui presentiamo. A discuterne – con esperti, movimenti e sindacati – ci saranno europarlamentari e politici della sinistra – Syriza compresa – verdi e socialdemocratici. Un’occasione per risvegliare la politica, a Bruxelles come a Roma, dare contenuti al dibattito sul voto europeo, e cercare davvero l’uscita dall’euro-tunnel.
 «Un libro assai utile quello di Alessandro Arienzo su
«Un libro assai utile quello di Alessandro Arienzo su
La governance (Ediesse, pp. 205, euro 12). Nell’ultimo decennio è uscita sconfitta l’ipotesi di una «governance politica dell’economia». Questo studio permette di indagare una formula confusa ed abusata, nell’oramai quarantennale dominio neo-liberista del capitalismo finanziario». Il manifesto, 28 febbraio 2014
Il volume fa parte di una collana di recente creazione. È quella dei «fondamenti», che un gruppo di giovani curatori promuove, con l’editore Ediesse, «per un vasto pubblico di lettori curiosi e appassionati», incrociando il «taglio monografico» con «l’alta divulgazione». Una sfida notevole, di questi tempi, quella di unire approfondimento della ricerca e diffusione del sapere. Sembra scomodare i celebri Libri di base diretti da Tullio De Mauro, che Editori Riuniti pensò in tutt’altra fase culturale. Ad ogni modo l’impostazione grafica di questi volumi è caratterizzata dalla presenza di schemi esemplificativi, glossari, bibliografie commentate e sunti chiarificatori posti alla fine di ciascun capitolo, «per riassumere» il contenuto di quanto detto in precedenza. Il tutto senza perdere il taglio analitico critico che vorrebbe contraddistinguere la collana. Sicuramente così succede con il volume di Alessandro Arienzo, ricercatore appartenente alla scuola filosofica napoletana e attento studioso di governamentalità e biopolitica che dagli studi sulla ragion di Stato è da tempo approdato a scandagliare i meandri delle tecniche di governance contemporanea.
Un generico termine
Ma che cos’è la governance? Questo l’interrogativo che apre il libro. Seguono tre capitoli riguardanti la governance europea, quella internazionale, tra sicurezza e sviluppo, per finire con una riflessione sulla portata della governance tra Stato e mercato.
Arienzo chiarisce subito che il lemma governance può essere inteso come «espressione generica del governare»: «qualsiasi forma di organizzazione dell’azione collettiva». Qui la memoria risale alle formule utilizzate nella Francia medievale, piuttosto che nell’Inghilterra del Seicento. Ma l’opposizione tra governance e government si afferma nel lessico pubblicistico e scientifico con le riforme delle istituzioni di governo locale e metropolitano negli Stati Uniti degli anni Sessanta e Settanta del Novecento. Poi arriva la corporate governance delle imprese finanziarie, che diviene parametro di comportamento delle istituzioni della globalizzazione: dal Fondo monetario internazionale alla Banca mondiale. Da una parte quindi il governo gerarchico-piramidale che si fonda sull’autorità sovrana dello Stato. Dall’altra la governance dei meccanismi informali, di processi aperti e diffusi, tendenzialmente orizzontali e non-gerarchici, che includono reti decisionali miste, pubbliche e private.
Ecco che qui Arienzo si concentra giustamente sulla tendenza oramai quarantennale dell’attuale concetto e pratica di governance: «un percorso di messa in discussione delle procedure del governo rappresentativo negli Stati democratici e parlamentari», non per aprire spazi di orizzontalità partecipativa, ma per obbedire al dogma della «governabilità». È un mantra che giunge fino agli epigoni del compromesso storico, tuttora ai vertici istituzionali, ma che prende le mosse dal celebre Rapporto alla Commissione Trilaterale, tradotto in Italia nel 1977 con prefazione di Giovanni Agnelli: non è certo una strana combinazione. Piuttosto un manuale che impone il verbo della governabilità per arginare sommovimenti sociali che rivendicano giustizia sociale, democrazia, diritti, redistribuzione del reddito. È l’inizio di un processo di spoliticizzazione dell’orizzonte democratico e di incubazione di una retorica sulla governance, intesa esclusivamente come processo di «forme organizzative e politiche di diretta espressione del contemporaneo neoliberalismo», piuttosto che come occasione di redistribuzione dei processi decisionali verso il basso, in favore di soggetti non appartenenti alla struttura gerarchica dei poteri economico-politici esistenti. Sono Margaret Thatcher e Ronald Reagan che si affacciano, in compagnia dei Chicago boys, fino all’ortodossa austerità tedesca.
Così Arienzo sintetizza perfettamente lo stato dell’arte. Nell’ultimo decennio è uscita sconfitta l’ipotesi di una «governance politica dell’economia» che la Commissione europea aveva descritto nel Libro bianco del 2001, insistendo particolarmente sui princìpi di «apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza». Nella bibliografia commentata è ricordato un volume collettivo che provò a confrontarsi a viso aperto con quell’opzione, insistendo sugli spazi di azione dei movimenti sociali europei e globali: Governance, società civile e movimenti sociali. Rivendicare il comune (Ediesse, 2009). Nello stesso decennio ha preso sempre più corpo una «governance economica della politica e della società», fautrice di uno Stato regolatore minimo, imbevuta di neocorporativismo, capace di conservare i rapporti di potere esistenti e al contempo di colonizzare l’immaginario collettivo.
Una partita ancora aperta
È la nuova ragione dell’ordine neo-liberale (per dirla con Dardot-Laval, da poco tradotti per DeriveApprodi) che diventa «governance commissaria di mercato», in grado di «commissariare le politiche economiche degli Stati» e governare le forme di vita degli individui, nel «gestire e amministrare il loro capitale umano», così come gli spazi dei «processi aggregativi», tanto reali, quanto virtuali. Eppure Alessandro Arienzo ci invita a non considerare conclusa la partita. Tra i «vuoti e gli scarti della democrazia» (riprendendo un lavoro curato dallo stesso Arienzo e da Diego Lazzarich, Esi, 2012) si apre l’urgenza di riconoscere il carattere politico e conflittuale che la governance inscrive nei rapporti di potere. È quello il terreno dove sfidare le derive neo-oligarchiche e tecnocratiche. Magari con il protagonismo di soggetti collettivi consapevoli del fatto che gli spazi politici di azione sono quelli locali – per un nuovo diritto alla città – insieme con quello continentale – per un’Europa politica e sociale.
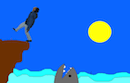 Misera e morte per i popoli d’Europa, cominciando dai bambini, le donne, gli anziani, se non cambia la politica che comanda le scelte., Se l’Europa non cambia, in fondo all’abisso andiamo tutti.
Misera e morte per i popoli d’Europa, cominciando dai bambini, le donne, gli anziani, se non cambia la politica che comanda le scelte., Se l’Europa non cambia, in fondo all’abisso andiamo tutti.
La Repubblica, 26 febbraio 2014
IL DOLORE sta producendo risultati»: fa impressione, proprio ora che è divenuto ministro dell’Economia, rileggere quel che Pier Carlo Padoan disse il 29 aprile 2013 al Wall Street Journal, quando era vice segretario generale dell’Ocse. Già allora i dati sull’economia reale smentivano una così impudente glorificazione dell’austerità - e addirittura dei patimenti sociali che infliggeva - ma l’ultimo numero di Lancet, dedicato alla sanità pubblica in Grecia dopo sei anni di Grande Depressione, va oltre la semplice smentita. Più che correggersi, il ministro farebbe bene a scusarsi di una frase atroce che irresistibilmente ricorda Pangloss, quando imperterrito rassicura Candide mentre Lisbona è inghiottita dal terremoto raccontato da Voltaire: «Queste cose sono il meglio che possa accadere. La caduta dell’uomo e la maledizione entrano necessariamente nel migliore dei mondi possibili».
Lancet non è un giornale di parte: è tra le prime cinque riviste mediche mondiali. Il suo giudizio sulla situazione ellenica, pubblicato sabato in un ampio dossier (lo ha ripreso Andrea Tarquini sul sito di Repubblica), è funesto: la smisurata contrazione dei redditi e i tagli ai servizi pubblici hanno squassato la salute dei cittadini greci, incrementando il numero di morti specialmente tra i bambini, tra gli anziani, nelle zone rurali. Nella provincia di Acaia, il 70 per cento degli abitanti non ha soldi per comprare le medicine prescritte. Emergency denuncia la catastrofe dal giugno 2012. Numerose le famiglie che vivono senza luce e acqua: perché o mangi, o paghi le bollette. Nel cuore d’Europa e della sua cultura, s’aggira la morte e la chiamano dolore produttivo. «Siamo di fronte a una tragedia della sanità pubblica», constata la rivista, «ma nonostante l’evidenza dei fatti le autorità responsabili insistono nella strategia negazionista».
Qualcuno deve spiegare a chi agonizza come sia possibile che il dolore e la morte siano «efficaci», e salvifiche per questo le riforme strutturali fin qui adottate. Né è solo «questione di comunicazione » sbagliata, come sosteneva nell’intervista Padoan: sottolineare gli esiti promettenti del consolidamento fiscale, ammorbidendo magari qualche dettaglio tecnico, non toglie la vittoria al pungiglione della morte. Trasforma solo un’improvvida teoria economica in legge naturale, perfino divina. Moriremo, certo, ma in cambio il Paradiso ci aspetta. Soprattutto ci aspetta se non cadremo nel vizio disinvoltamente rinfacciato agli indebitati impoveriti: la «fatica delle riforme » ( reform fatigue), peccato sempre in agguato quando i governi «sono alle prese con resistenze sociali molto forti». Quando siamo ingrati, come Atene, alle iniezioni di liquidità che l’Unione offre a chi fa bancarotta: nel caso greco, due bailout tardivi, legati a pacchetti deflazionistici monitorati dalla trojka. I contribuenti tedeschi hanno già dato troppo, dicono in Germania. Non è vero, i contribuenti non hanno pagato alcunché perché di prestiti si tratta, anche se a tassi agevolati e destinati in primis alle banche. Difficile dar torto alle «forti resistenze sociali», se solo guardiamo le cifre fornite su Lancet dai ricercatori delle università britanniche di Cambridge, Oxford e Londra. A causa della malnutrizione, della riduzione redditi, della disoccupazione, della scarsità di medicine negli ospedali, dell’accesso sempre più arduo ai servizi sanitari (specie per le madri prima del parto) le morti bianche dei lattanti sono aumentate fra il 2008 e il 2010 del 43%. Il numero di bambini nati sottopeso è cresciuto del 19 %, quello dei nati morti del 20. Al tempo stesso muoiono i vecchi, più frequentemente. Fra il 2008 e il 2012, l’incremento è del 12,5 fra gli 80-84 anni e del 24,3 dopo gli 85. E s’estende l’Aids, perché la distribuzione di siringhe monouso e profilattici è bloccata. Malattie rare o estinte ricompaiono, come la Tbc e la malaria (quest’ultima assente da 40 anni. Mancano soldi per debellare le zanzare infette). La rivista inglese accusa governi e autorità europee, ed elogia i paesi, come Islanda e Finlandia, che hanno respinto i diktat del Fondo Monetario o dell’Unione. Dopo la crisi acuta del 2008, Reykjavik disse no alle misure che insidiavano sanità pubblica e servizi sociali, tagliando altre spese scelte col consenso popolare. Non solo: capì che la crisi minacciava la sovranità del popolo, e nel 2010-2011 ridiscusse la propria Costituzione mescolando alla democrazia rappresentativa una vasta sperimentazione di democrazia diretta. Non così in Grecia. L’Unione l’ha usata come cavia: sviluppi islandesi non li avrebbe tollerati. Proprio nel paese dove Euroto. pa nacque come mito, assistiamo a un’ecatombe senza pari: una macchia che resterà, se non cambiano radicalmente politiche e filosofie ma solo questo o quel parametro. Il popolo sopravvive grazie all’eroismo di Ong e medici volontari (tra cui Médecins du Monde, fin qui attivi tra gli immigrati): i greci che cercano soccorso negli ospedali «di strada» son passati dal 3-4% al 30%.
S’aggiungono poi i suicidi, in crescita come in Italia: fra il 2007 e il 2011 l’aumento è del 45%. In principio s’ammazzavano gli uomini. Dal 2011 anche le donne. Lancet non è ottimista sugli altri paesi in crisi. La Spagna, cui andrebbe assommata l’Italia, è vicina all’inferno greco. Alexander Kentikelenis, sociologo dell’università di Cambridge che con cinque esperti scrive per la rivista il rapporto più duro, spiega come il negazionismo sia diffuso, e non esiti a screditare le più serie ricerche scientifiche (un po’ come avviene per il clima). L’unica istituzione che si salva è il Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie, operativo dal 2005 a Stoccolma. La Grecia prefigura il nostro futuro prossimo, se le politiche del debito non mutano; se scende ancora la spesa per i servizi sociali. Anche in Italia esistono ospedali di volontari, come Emergency. La luce in fondo al tunnel è menzogna impudente. Senza denunciarla, Renzi ha intronizzato ieri la banalità: «L’Europa non dà speranza se fatta solo di virgole e percentuali » — «l’Italia non va a prendere la linea per sapere che fare, ma dà un contributo fondamentale ». Nessuno sa quale contributo dia. Scrive l’economista Emiliano Brancaccio che i nostri governi «interpretano il risanamento come fattore di disciplinamento sociale». Ma forse le cose stanno messe peggio: il risanamento riduce malthusianamente le popolazioni, cominciando da bambini e anziani.
Regna l’oblio storico di quel che è stata l’Europa, del perché s’è unita. Dimentica anche la Germania, che pure vive di memoria. Dopo il ‘14-18 fu trattata come oggi la Grecia: sconfitto, il paese doveva soffrire per redimersi. Solo Keynes insorse, indignato. Nel 1919 scrisse: «Se diamo per scontata la convinzione che la Germania debba esser tenuta in miseria, i suoi figli rimanere nella fame e nell’indigenza […], se miriamo deliberatamente all’umiliazione dell’Europa centrale, oso farmi profeta, la vendetta non tarderà ». La vendetta non tardò a farsi viva, ed è il motivo per cui ben diversa e più saggia fu la risposta nel secondo dopoguerra. Quella via andrebbe ripercorsa e potrebbe sfociare in una Conferenza europea sul debito, che condoni ai paesi in difficoltà parte dei debiti, connetta i rimborsi alla crescita, dia all’Unione poteri politici e risorse per lanciare un New Deal di ripresa collettiva e ecosostenibile. È già accaduto, in una conferenza a Londra che nel 1953 ridusse quasi a zero i debiti di guerra della Germania. I risultati non produssero morte, ma vita. Fecero rinascere la democrazia tedesca. Non c’era spazio, a quei tempi, per i Pangloss che oggi tornano ad affollare le scene
 L’ideologia del nuovo nècentro-nèsinistra. Da inserire nello stupidario, se l’autore non avesse un peso smisurato nel presente. Lo scritto rivela che non certo dalle sue idee nasce il peso che si è conquistato. Grazie alle debolezze altrui, o anche da più forti e oscuri poteri?
L’ideologia del nuovo nècentro-nèsinistra. Da inserire nello stupidario, se l’autore non avesse un peso smisurato nel presente. Lo scritto rivela che non certo dalle sue idee nasce il peso che si è conquistato. Grazie alle debolezze altrui, o anche da più forti e oscuri poteri?
La Repubblica, 23 febbraio 2014
Vent'anni dopo l'uscita di "Destra e sinistra", il bestseller di Norberto Bobbio, l'editore Donzelli ripubblica una nuova edizione con una introduzione di Massimo L. Salvadori e due commenti di Daniel Cohn-Bendit e Matteo Renzi. Pubblichiamo l'intervento del presidente del Consiglio. Un vero e proprio manifesto del capo del nuovo governo
la parola "sinistra" era una parolaccia. Sacrificata al galateo della coalizione di centrosinistra, tanto da giustificare dibattiti estenuanti e buffi sul trattino, ricordate?
"Centro-sinistra" o "centrosinistra" era la nuova disputa guelfi-ghibellini, tra chi pensava il campo progressista come un litigioso condominio, caseggiato rumoroso di partiti gelosi delle proprie convenienze e confini e chi, invece, vagheggiava il Partito-Coalizione, area politica aperta, il cui orizzonte schiudeva l'universo del campo progressista.
In questo incrocio, che ha opposto due linee in parte intente a far baruffa ancora adesso, c'è il Partito democratico, la parola "sinistra" come un laboratorio, sempre in trasformazione, sempre ineludibile.
Una frontiera, non un museo. Curiosità, non nostalgia. Coraggio, non paura. Erano quelli gli anni dell'Ulivo, il progetto di Romano Prodi di abbattere gli steccati che separavano gli eredi del Partito comunista da quelli della Democrazia cristiana, di una forza che raccogliesse istanze liberal-democratiche, ambientaliste, in una nuova unità, una nuova cultura politica semplicemente, finalmente potremmo dire, "democratica".
Erano, nel mondo, gli anni della "terza via", di Bill Clinton e Tony Blair, una rotta per evitare Scilla e Cariddi, tra gli estremismi della sinistra irriducibile e la destra diventata, dopo Reagan e Thatcher, una maschera di durezze. Qualcuno pensò allora perfino che la sinistra fosse ormai uno strumento inservibile, non più adeguato a un mondo nuovo, sulla spinta di quella che si chiamava globalizzazione, dove finiva il XX secolo della guerra fredda e cominciava il XXI, tutto individuale e personal, dalla tecnologia alla politica.
A fare da sentinella, non per custodire e conservare, ma per richiamare alla sostanza delle cose, alla loro forza, il filosofo Norberto Bobbio - or sono venti anni esatti - pensò di tirare una linea, per segnalare dove la divisione tra destra e sinistra ancora teneva e tiene. Suggerendo che la scelta cruciale resti sempre la stessa, storica, radicale, un referendum tra eguaglianza e diseguaglianza, come dal XVIII secolo in avanti. Mi chiedo se oggi che la seduzione della "terza via" - che pure nel socialismo liberale, nell'utopia azionista di Bobbio, ha trovato più che un riflesso - si è sublimata perdendo slancio, la coppia eguaglianza/diseguaglianza non riesca a riassorbire integralmente la distinzione destra/sinistra. Basti pensare, a livello europeo, all'insorgere dei populismi e dei movimenti xenofobi contro i quali è chiamato a ridefinirsi il progetto dell'Unione europea, così in crisi. Un magma impossibile da ridurre alla vecchia contraddizione eguali/diseguali a lungo così nitida.[sic]
Dal punto di vista del sistema politico, infatti, sono e rimango un convinto bipolarista. Credo che un modello bipartitico, all'americana per intenderci, sia un orizzonte auspicabile, sia pur nel rispetto della storia, delle culture, delle sensibilità e della pluralità che da sempre contraddistinguono il panorama italiano. Ma riflettendo sulla teoria, sui principi fondamentali, non so se, invece, non sia più utile oggi declinare quella diade nei termini temporali di conservazione/ innovazione.
Tiene ancora, dunque, lo schema basato sull'eguaglianza come stella polare a sinistra? In una società sempre più individualizzata, sotto la spinta anche delle nuove tecnologie, dei social network, delle reti che connettono ma anche atomizzano, creando e distruggendo comunità e identità? Come recuperare, dopo anni di diffidenza, anche tra i progressisti, idee come "merito" o "ambizione"? Come evitare che, in un paesaggio sociale tanto mutato, la sinistra perda contatto con gli "ultimi", legata alle fruste teorie anni sessanta e settanta, mentre papa Francesco con calore riesce a parlare la lingua della solidarietà? Certo, l'eguaglianza - non l'egualitarismo - resta la frontiera per i democratici, in un mondo interdipendente, dilaniato da disparità di diritti, reddito, cittadinanza. Eppure era stato lo stesso Bobbio, proprio mentre scandiva quella sua storica dicotomia, a rendersi conto che forse la sua argomentazione aveva bisogno di un'ulteriore dimensione, un diverso respiro temporale, un'altra profondità. "Nel linguaggio politico - scrive Bobbio - occupa un posto molto rilevante, oltre alla metafora spaziale, quella temporale, che permette di distinguere gli innovatori dai conservatori, i progressisti dai tradizionalisti, coloro che guardano al sole dell'avvenire da coloro che procedono guidati dalla inestinguibile luce che vien dal passato. Non è detto che la metafora spaziale, che ha dato origine alla coppia destra-sinistra non possa coincidere, in uno dei significati più frequenti, con quella temporale".
Ecco perché, venti anni dopo il monito di Bobbio, è maturo il tempo per superare i suoi confini, modificati e resi frastagliati dal mondo globale, come insegnano Ulrich Beck e Amartya Sen. Serve una narrazione temporale, dinamica, più ricca. Che non dimentichi radici e origini, sempre da mettere in questione, da problematizzare, ma che, soprattutto, faccia i conti con i tempi nuovi che ci troviamo a vivere, ad attraversare. Aperto/chiuso, dice oggi Blair. Avanti/indietro, chissà, innovazione/conservazione.
E, perché no, movimento/stagnazione. Se la sinistra deve ancora interessarsi degli ultimi, perché è questo interesse specifico che la definisce idealmente come tale, oggi essa deve avere lo sguardo più lungo. Le sicurezze ideologiche del Novecento, elaborate sull'analisi di un mondo organizzato in maniera assai meno complessa di quello contemporaneo, rendevano più semplice il compito della rappresentanza delle istanze degli ultimi e degli esclusi, e del governo del loro desiderio di riscatto. A blocchi sociali definiti e compatti bisognava dare cittadinanza, affinché condizionassero le decisioni sul futuro delle comunità nazionali di cui erano parte. Per la sinistra che, dopo Bad Godesberg, si organizzava in Europa in partiti socialdemocratici postmarxisti (e anticomunisti) era un compito certo faticoso, ma lineare nel suo meccanismo di funzione politica.
Oggi quei blocchi sociali non esistono più ed è un bene che sia così! In fondo tutta la fatica quotidiana del lavoro della sinistra socialdemocratica, cara a Bobbio, era stato quello di scardinare quei blocchi. Allo scopo di offrire agli uomini e alle donne, che erano in quei blocchi costretti, l'opportunità di una vita materiale meno disagevole e di un'esistenza più ricca di esperienze. Con l'invenzione del welfare quella sinistra aveva provveduto a sfamare le bocche e gli animi degli ultimi e degli esclusi, liberandoli dal bisogno materiale - libertà fondamentale anche per la sinistra liberaldemocratica americana di Franklin D. Roosevelt - e fornendo loro l'occasione di realizzare se stessi. L'invenzione socialdemocratica del welfare aveva così conseguito due obiettivi storici. Da un lato, difatti, il welfare aveva soddisfatto la sacrosanta richiesta di maggiore giustizia sociale. Dall'altro, tuttavia, il miglioramento delle condizioni oggettive di vita degli ultimi aveva determinato un beneficio generale per tutte quelle comunità democratiche che non avevano avuto timore di rispondere "Sì!" alla loro domanda di cambiamento.
La sinistra cara a Bobbio, quella socialdemocratica e anticomunista, ha insomma vinto la sua partita. Ma oggi ne stiamo giocando un'altra. Quei blocchi sociali che prima rendevano tutto più semplice non ci sono più. Gli stessi confini nazionali che erano il perimetro entro cui si giocava la partita dell'innovazione del welfare sono ormai messi in discussione. Più che con blocchi sociologicamente definiti entro Stati nazionali storicamente determinati, oggi la nuova partita si svolge con attori e campi da gioco inediti. Quei blocchi sono stati sostituiti da dinamiche sociali irrequiete. I confini nazionali non delimitano più gli spazi entro i quali le nuove dinamiche giocano la loro partita.
Di fronte a questo potente mutamento di prospettiva sociale ed economica, culturale e politica, la sinistra deve mostrare di avere coraggio e non tradire se stessa. Deve accettare di vivere il costante movimento dei tempi presenti e accoglierlo come una benedizione e non come un intralcio. È questo straordinario, irrefrenabile movimento che sfonda la vecchia bidimensionalità della diade destra/sinistra e le dà temporalità e nuova forza. E invece spesso, in Italia e in Europa, la sinistra ne ha paura. Sembra non rendersi conto che il nuovo mondo in cui tutti viviamo è anche il frutto del successo delle proprie politiche, dei cambiamenti occorsi nel Novecento grazie alla sua iniziativa. Perché l'innovazione, quando ha successo, produce un ambiente diverso da quello da cui si è mosso. Un ambiente mutato che chiama al mutamento gli stessi che più hanno concorso a mutarlo. Cambiare se stessi è l'incarico più gravoso di tutti. Eppure non cambiare se stessi, in una realtà che si è contribuito a cambiare, condanna all'incapacità di distinguere i nuovi ultimi e i nuovi esclusi, e all'ignavia di non mettersi subito al loro servizio. Che è proprio quanto successo alla sinistra di tradizione socialdemocratica al cospetto delle sfide del secolo nuovo.
La sinistra è oggi chiamata a riconoscere e a conoscere il movimento continuo delle nuove dinamiche sociali, contro chi vorrebbe vanamente fare appello a blocchi che non esistono più e che è un bene non esistano più! In Italia, più che altrove, la capacità della politica di saper distinguere le dinamiche sociali che interessano gli ultimi e gli esclusi, di saperle intrecciare per dare loro rappresentanza e, infine, di saperne governare il costante movimento per costruire per loro, e per tutti, un paese migliore, è il compito del Partito democratico. È la missione storica della sinistra.

Affermare – come ha fatto Matteo Renzi nell'introduzione alla nuova edizione di "Destra e sinistra" di Norberto Bobbio – che il Pd non intende più collocarsi a sinistra conclude l'ultimo giro di boa del partito democratico. Simbolico, ma fa impressione che questo arrivi proprio quando in Italia si superano i 4 milioni di senza lavoro
Lo fa prendendosi qualche licenza culturale, come citare Norberto Bobbio contro Bobbio esempio di chi, se aveva ragione in passato, non l’avrebbe più oggi, quando la distinzione tra destra e sinistra non avrebbe più senso. Pazienza, oggi ne vediamo di ben altre. Fra le innovazioni trionfanti c’è che ciascuno riveste o spoglia dei panni che più gli aggrada il defunto scelto come ispiratore. Più significativo è che il concetto archiviato indicava il peso assegnato da ogni partito alla questione sociale e dichiararla superata proprio mentre si sfiorano e forse si superano i quattro milioni di senza lavoro, fa impressione. Forse per questo l’ex sindaco di Firenze si era scordato di informarci su quel job act che doveva presentare entro gennaio; ma in primo luogo non risulta che durante le consultazioni qualcuno glielo abbia ricordato, in secondo luogo nel governo se ne occuperà la ministra Guidi, donna imprenditrice esperta in quanto allevata dal padre confindustriale.
Sappiamo dunque che dobbiamo attenderci con il nuovo esecutivo e dobbiamo al Pd tutto il peso, visto che né la sua presidenza né la sua minoranza gli hanno opposto il proprio corpo, al contrario hanno sgombrato il campo sussurrando come il melvilliano Bartleby “preferirei di no”. Della stessa pasta la stampa, affaccendata dal sottolineare lo storico approdo delle donne a metà del governo sottolineando il colore delle giacche e il livello dei tacchi, cosa che dovrebbe far riflettere le leader di “Se non ora quando”. Eccola qui l’Ora, ragazze, non si vede dove stia la differenza.
Il nuovo che avanza ha rilanciato anche Berlusconi, primo interpellato da Renzi per incardinare tutta l’operazione. Condannato da mesi per squallidi reati contro la cosa pubblica ad astenersi dalla politica è stato ricevuto non già dai giudici di sorveglianza, bensì dal capo dello stato per illustrargli quello che pensa e intende fare sul futuro del paese. Per ora appoggia Renzi, rassicurando i suoi che non è un comunista.
La postfazione alla riedizione di un libro sul quale è utile ricominciare a riflettere, prima che il “pensiero unico” del neoliberalismo si sia impadronito di tutte le teste.
La Repubblica, 24 febbraio 2014
Sono passati vent’anni dalla pubblicazione di Destra e sinistra. Due decenni segnati da sommovimenti profondi. L’Unione europea si dibatte in una crisi pluridimensionale di portata eccezionale. «Per la prima volta nella loro storia, gli europei sperimentano la finitezza dell’Europa». Così si esprime il sociologo Ulrich Beck nel suo ultimo libro, Europa tedesca.
Cambiamenti di eguale portata si sono prodotti sulla scena internazionale. Tra questi ultimi, le rivoluzioni inauguratesi nel 2010 contro l’autoritarismo e la corruzione delle classi dirigenti del mondo arabo. Insieme con esse, sono letteralmente andate in pezzi le strategie opportunistiche dell’Occidente a sostegno di regimi non-democratici – strategie promosse dalla sinistra come dalla destra, in nome della stabilità. Questa messa in scacco del cinismo politico dei partiti al potere – in Occidente, in Africa e in Medio Oriente – ha contemporaneamente messo in rilievo un altro fenomeno. Quello di un “progresso civile” irreversibile, anche se “non necessitato”, per riprendere i termini di Bobbio. Se la transizione resta altamente problematica per i paesi della “primavera araba”, ciò non impedisce che queste rivolte abbiano per orizzonte comune la democrazia. È in nome della dignità umana che la resistenza è continuata nonostante la violenza della repressione. È in ragione dei valori democratici che la spartizione diseguale delle ricchezze è diventata sempre più intollerabile per queste società oppresse.
Detto in altro modo, le rivolte emancipatrici che scoppiano nelle più diverse parti del mondo mostrano tutte le volte che la democrazia non è un’avventura qualsiasi. Il suo manifestarsi, e i valori su cui si fonda, anche se storicamente e geograficamente definiti, hanno una portata universale. I diritti dell’uomo e lo Stato di diritto democratico fanno ormai parte del “patrimonio comune dell’umanità”. La logica democratica è una “logica di libertà”.
Detto altrimenti, anche se non risponde a una logica di causa- effetto – caratterizzata com’è dalla sua fragilità intrinseca e dalla possibilità di regressione – la sua messa in moto introduce una coerenza nella storia umana tale per cui le sue sequenze non sono intercambiabili. Il nostro patrimonio democratico trae la sua forza dalla possibilità di essere riattivato in ogni istante, in qualunque parte del mondo, da un qualunque individuo appartenente alla comunità umana.
Questa idea di progresso e di una crescente consapevolezza di una eguale dignità umana si ritrova a più riprese, sotto la penna di Bobbio. La si trova, in particolare, in un passaggio come questo: «La spinta verso una sempre maggiore eguaglianza tra gli uomini è irresistibile. Ogni superamento di questa o quella discriminazione rappresenta una tappa, certo non necessaria, ma almeno possibile, del processo di incivilimento. Mai come nella nostra epoca sono state messe in discussione le tre fonti principali di diseguaglianza: la classe, la razza e il sesso. La graduale parificazione delle donne agli uomini è uno dei segni più certi dell’inarrestabile cammino del genere umano verso l’eguaglianza». (...) Di fatto, la battaglia democratica è lungi dall’essere conclusa. Non soltanto perché la democrazia non è il solo tipo di regime che esista al mondo, ma anche perché i nostri Stati di diritto democratici sono lontani dal garantire l’effettivo rispetto dei diritti dell’uomo, persino all’interno dell’Unione europea. Alcuni pretendono che il progetto democratico europeo si sarebbe esaurito. Le aspirazioni degli uni e le disillusioni degli altri ci dicono il contrario. E se si è insediata la stanchezza europea, ciò dipende forse innanzitutto dal fatto che la classe politica europea – di destra e di sinistra – non è stata all’altezza dell’esigenza democratica che caratterizza il progetto politico dell’Unione europea. Invece di assumere come indispensabile la mutazione del loro patrimonio politico, i leader delle nazioni europee si sono votati all’impotenza, in un mondo in cui l’economia, la finanza, i media… funzionano ormai a scala planetaria.
Un’impotenza che certe nazioni, nei loro sogni più folli, immaginano di poter combattere da sole. A forza di rifiutare di impegnarsi insieme nella democratizzazione della globalizzazione, e nella realizzazione della democrazia europea, i leader degli Stati si sono assuefatti a una tolleranza di fronte all’ingiustizia, all’interno dell’Unione europea e ancor più al di fuori delle sue frontiere. I malfunzionamenti democratici, non solo al livello istituzionale, ma soprattutto nella realtà quotidiana, costituiscono senza alcun dubbio un ingrediente fondamentale della crisi simbolica acuta che incancrenisce il nostro continente. Questa crisi attiene al registro specificamente identitario e deve essere presa molto sul serio. Io sono convinto che la sua risoluzione passa tra le altre cose attraverso la spiegazione del significato del “politico”. E ciò impone di esporsi pubblicamente attraverso un progetto impegnativo per le società e per gli individui che le compongono. Il progetto politico si determina senza alcun dubbio a partire da una visione del mondo. Ma esso è anche un qualche cosa in cui ciascuno deve potersi riconoscere per appropriarsene veramente. In questo senso, esso funziona come uno “stabilizzatore identitario” che non necessariamente è sinonimo di particolarismo o di regresso. Quella che si suole chiamare la «crisi di legittimità» che investe l’ordine politico delle nostre democrazie liberali ha dei legami evidenti con la crisi identitaria europea.
Ed è assai spiacevole che i partiti politici, quale che sia il loro orientamento, abbiano preso l’abitudine di puntare il dito sulla crisi di legittimità europea, quando quest’ultima è in qualche modo null’altro che un’amplificazione della crisi di legittimità che già da tempo ha eroso l’ordine politico nazionale. Si tratta di una rottura socio-politica che concerne i sistemi politici moderni in generale. Detto in altro modo, la sfida si situa su un terreno più grande: quello del valore della politica e della fiducia nei confronti delle istituzioni democratiche rappresentative, vale a dire della classe politica tout court. Ora, questa fiducia si basa sulla qualità della performance del processo di identificazione in generale. È così che le chiusure identitarie – le quali possono raggiungere proporzioni deliranti – si possono interpretare come altrettante lacune nel processo di identificazione, considerato nel suo insieme.
Se questo libro di Bobbio rimane attuale, non è tanto in ragione degli argomenti che sviluppa, ma soprattutto per ciò che esprime: un bisogno di ritrovare il senso della politica.