

 Democrack. Come nello scontro sulla «riforma» del Senato, anche sul lavoro la minoranza inghiotte il rospo.
Democrack. Come nello scontro sulla «riforma» del Senato, anche sul lavoro la minoranza inghiotte il rospo.
Il manifesto, 12 ottobre 2014
Insomma, è proprio il caso di dirlo: molto rumore per nulla.
Dopo lo scontro sulla «riforma» del Senato, ora di nuovo, sul lavoro, la minoranza Pd inghiotte il rospo. La sinistra interna (3 eccezioni su 26 confermano la regola) si è piegata al ricatto della fiducia. Come se un ricatto costituisse un alibi, come se la debolezza fosse una ragione. Ma se lo scorso agosto si trattò forse di un imprevisto, adesso siamo a un copione sperimentato, del resto conforme alla sortita di Bersani di qualche giorno fa. L’avviso sulla lealtà alla «ditta» – peraltro ribadito anche da ultimo – non fu dunque una voce dal sen fuggita, ma il previdente annuncio di quanto era già intuito, assunto, metabolizzato.
È stata una scelta grave in un passaggio strategico. Renzi ha aperto la guerra interna nel Pd su materie cruciali. La modifica della Camera Alta stravolge l’architettura costituzionale e mina alle fondamenta la rappresentanza democratica, alterando la natura dello Stato. L’attacco ai diritti essenziali del lavoro subordinato colpisce il cardine della Repubblica antifascista, oltre che la ragion d’essere di una sinistra che possa legittimamente dirsi tale. Non si tratta di scelte improvvisate, e non è casuale che su questi terreni il «capo del governo» abbia deciso di giocarsi la partita. Sfondando sulla divisione dei poteri e sui diritti del lavoro, mortificando il dissenso e sfottendo le organizzazioni sindacali, Renzi intende mostrarsi in grado di guidare il «cambiamento»: di svuotare la Costituzione del ’48 e di varare una nuova forma di governo funzionale alla sovranità del capitale privato.
Solo chi avesse perso qualsiasi capacità di giudizio potrebbe sottovalutare la gravità di quanto accade. Nel giro di pochi mesi viene prendendo vita un regime autoritario nel quale il capo della fazione prevalente potrà controllare tutti gli snodi della decisione politica. E si viene regredendo verso un’oligarchia neofeudale in cui il lavoro è senza garanzie, precarizzato nella radice del rapporto contrattuale, quindi ricattabile in ogni momento e destinato a salari sempre più bassi. Nemmeno manca, per i palati più esigenti, il grazioso sarcasmo delle «tutele crescenti».
In tale scenario non incombe sui parlamentari democratici alcun vincolo politico o morale di lealtà verso il partito e il gruppo, né, tanto meno, verso l’esecutivo.
Non solo perché – anche grazie alla comprovata obbedienza dei dissidenti – il Pd è diventato un partito personale, comandato col ricatto, il dileggio, l’insulto. Non solo perché ogni vincolo viene meno quando sono travolti principi fondamentali della Carta e perché, chiedendo la fiducia su una delega in bianco («indefinita e sfuggente nei criteri», nota la Cgil), il governo ha violato la Costituzione (e di ciò il presidente della Repubblica dovrebbe tener conto, invece di lasciarsi andare a impropri apprezzamenti del Jobs Act). Ciascun parlamentare del Pd ha il diritto e il dovere di decidere in piena autonomia anche perché il governo procede rovesciando di sana pianta il programma in base al quale i parlamentari democratici sono stati eletti. Un tale governo non va preservato. Va contrastato e fatto cadere al più presto, impegnandosi affinché il paese imbocchi la strada della riscossa democratica.
Dire, com’è stato detto, che negare la fiducia sarebbe stato «irresponsabile» perché la scelta sarebbe tra Renzi e la Troika è soltanto un modo per nascondere la realtà. Non solo questo governo si attiene in toto ai dettami di Washington, Bruxelles e Francoforte (o qualcuno si meraviglia per la soddisfazione di Draghi e della Merkel?). Lo fa, per di più, impedendo alla gente di capire e di sottrarsi alla morsa del nuovo regime che soffoca il paese. Se una politica di destra è fatta da un partito che si dichiara, almeno in parte, di sinistra, che senso hanno ancora queste vetuste parole, e come si può pensare di poter cambiare rotta?
Ma allora perché, ancora una volta, questo cedimento, che, come ognuno vede, demolisce la credibilità della sinistra democratica? Perché questa obbedienza che rischia di ridurre il dissenso interno a una farsa; che induce a parlare di tradimento del mandato parlamentare (questo ha detto in sostanza il senatore Tocci intervenendo in aula); che rende la minoranza complice del nuovo padrone del Pd, al quale non solo è offerta una preziosa sanzione di onnipotenza (delle sue sprezzanti risposte alle timide richieste di modifica della delega resterà memoria), ma è anche concessa gratis l’opportunità di esibire, quando serve, una patente contraffatta di sinistra? Si può tergiversare e predicare cautela, pur di sottrarsi al giudizio. Si può tacere, augurandosi di limitare il danno o di propiziare sviluppi positivi. Ci si illude. Da sé le cose non cambieranno certo in meglio. Noi stiamo piuttosto con il segretario generale della Fiom che arrischia un giudizio durissimo (votare la fiducia serve a «difendere le poltrone») e ne trae le dovute conclusioni («di un parlamento così non sappiamo che farci»).
Nondimeno, siamo tra i testardi che pensano che in politica non si è mai all’ultima spiaggia e che nessun frangente, per quanto grave, è irreparabile e definitivo. Anche in questo caso, nonostante tutto, staremo a vedere come andrà avanti questa storia e come si concluderà. Sentiamo che alcuni dissidenti saranno il piazza con la Cgil il 25 ottobre. E che un esponente della minoranza del Pd, l’onorevole D’Attorre, annuncia battaglia sul Jobs Act alla Camera, definendo «inaccettabile» che anche in quella sede il governo ponga la fiducia. Ne prendiamo atto. Osservando che, se le parole hanno ancora un valore, queste equivalgono a promettere che, in tale non improbabile evenienza, la sinistra del Pd arriverà finalmente a quella rottura che non ha sin qui nemmeno ventilato. Vedremo.
Intanto resta che viviamo giorni cupi, gravidi di pericoli, forieri di nuove violenze e di più gravi ingiustizie. Giorni che gettano nuove inquietanti ombre sul futuro di questa Repubblica.
 Organizzati, comunicativi e con una nuova leadership. Questo occorre oggi per costruire una nuova sinistra e scongiurare il disastro dell'Italia. Un ragionamento basato sulla valutazione critica dell'esperienza "movimentista".
Organizzati, comunicativi e con una nuova leadership. Questo occorre oggi per costruire una nuova sinistra e scongiurare il disastro dell'Italia. Un ragionamento basato sulla valutazione critica dell'esperienza "movimentista".
Il manifesto, 11 ottobre, con postilla
All’indomani del «patto degli Apostoli» e dell’invito di Norma Rangeri a una nuova unità a sinistra, Tonino Perna invita alla prudenza e sollecita «una grande tessitura sociale e culturale di parole in grado di costruire la visione del futuro desiderabile e credibile». Ha ragione: il disastro renziano ha radici antiche e l’alternativa non può certo stare in una rivincita (seppur la cercasse) dell’establishment del Pd di ieri, che di quel disastro ha posto le premesse politiche e culturali (a cominciare dall’elevazione a stelle polari «delle leggi di mercato e della crescita economica senza se e senza ma»).
Ma questa necessaria tessitura deve accompagnarsi a una iniziativa politica immediata: perché il rischio di una desertificazione del tessuto sociale e istituzionale è sempre più forte e sul deserto è difficile anche ricostruire. Nello stesso tempo, non siamo all’anno zero ché i tentativi degli ultimi tempi, seppur improduttivi sul piano elettorale, non sono stati avari di elaborazione culturale. Una rinnovata iniziativa politica, che abbia l’ambizione di diventare egemone (e non solo di superare il quorum delle prossime elezioni, sperando che non sia troppo alto…), deve, peraltro, misurarsi con alcune questioni, troppo spesso eluse o esorcizzate e che stanno alla base degli insuccessi degli ultimi anni. Provo a indicarne alcune.
Primo. In tutte le recenti esperienze alternative e innovative ci si è mossi, talora teorizzandolo e comunque nei fatti, sul presupposto che le buone idee sono di per se sole, proprio perché buone, capaci di produrre in modo automatico l’organizzazione necessaria (e sufficiente). Non è così. Lo dico pur consapevole, da vecchio movimentista, delle degenerazioni burocratiche e autoritarie che spesso si annidano negli apparati. Contro queste derive va tenuta alta la guardia ma la sottovalutazione del momento organizzativo (e della sua legittimazione) è stata una delle cause principali della rissosità e della inconcludenza di molte aggregazioni politiche ed elettorali dell’ultimo periodo. Posso dirlo per esperienza diretta con riferimento a “Cambiare si può” (paralizzato dalla mancanza di luoghi di decisione e, per questo, facile preda di una nefasta e alienante occupazione). Ma lo stesso dimostrano le difficoltà in cui si dibatte la lista Tsipras.
Secondo. La bontà delle idee non ne garantisce, di per se sola, neppure la capacità di autoaffermarsi e di aggregare consensi. Il fatto nuovo della società dell’immagine – affermato da tutti ma non ancora compiutamente metabolizzato – è il primato della comunicazione sui valori. Sempre più persino chi è subalterno o marginale combatte battaglie non proprie, mobilitandosi e votando su parole d’ordine altrui più che a sostegno dei propri bisogni e interessi. Si spiegano così i successi di Berlusconi e di Renzi, che – modernizzando un copione antico – hanno attinto consenso e voti in maniera massiccia in strati popolari. La comunicazione, poi, ha oggi regole e modalità semplificatorie, assertive, spesso demagogiche. Non ci piacciono (o non piacciono a me). Ma da esse non si può prescindere, almeno oggi. Meglio, in ogni caso, adottarle – con il necessario distacco critico – per veicolare buoni progetti piuttosto che subirle con il loro carico di cattivi progetti… Nella odierna comunicazione fast food le parole contano più della realtà che rappresentano: occorre cambiare questa spirale perversa, ma per farlo bisogna saper usare le parole.
Terzo. Se questo è vero lo sbocco è conseguente. Abbiamo buone idee e buoni progetti ma continueremo, ciononostante, ad essere sconfitti e saremo ridotti all’irrilevanza (non solo alla minorità) se non sapremo esprimere nuovi linguaggi, semplificati e ripetitivi, ma capaci di dare concretezza a una prospettiva di eguaglianza e di emancipazione (la mancanza di una promessa attendibile di reddito decente per tutti ha fatto vincere chi ha dato a molti una mancia di 80 euro, pur sottratta con l’altra mano).
E lo stesso accadrà se non sapremo esprimere un personale politico radicalmente diverso da un ceto responsabile di sconfitte seriali (non scopro l’acqua calda se dico che nella resistibile ascesa di Renzi è stato determinante il contributo, miope quanto comprensibile, di chi lo ha votato «perché è il solo che può farci vincere»). E un nuovo personale politico dovrà avere un punto di riferimento riconoscibile e mediaticamente forte: non un uomo della provvidenza circondato da nullità che ne esaltano la funzione salvifica (come è stato ed è da due decenni), ma un uomo, o una donna, in grado di aggiungere un personale carisma a un gruppo autorevole e coeso. Anche questo provoca in noi (o almeno in me) non poca diffidenza. Ma il terreno e le modalità dello scontro non li decidiamo noi. Dovremo cambiarli, epperò – qui e ora – non possiamo prescinderne.
Arrivo così alla parte più difficile. Esiste oggi in Italia la possibilità di dar corpo a una prospettiva siffatta (come sta accadendo altrove: dalla Grecia alla Spagna)? Esiste, ma per costruirla bisogna uscire dal generico e avanzare proposte concrete, anche venendo meno al politically correct. Dunque ci provo.
Il nucleo forte della proposta politica non può che essere il lavoro, con le sue condizioni e i suoi presupposti, di cui riappropriarsi sottraendolo a chi lo distrugge ma, insieme, lo declama presentandosi come il suo vero e unico difensore. C’è chi può rappresentare questa prospettiva in modo non personalistico e con un riconoscimento diffuso, verificato in centinaia di piazze e – particolare non meno importante, secondo quanto si è detto – in centinaia di confronti televisivi. È – non devo certo spiegare perché – Maurizio Landini.
Lo so. Landini ha detto più volte che il suo posto è il sindacato e non la politica. È un atteggiamento fino a ieri comprensibile e apprezzabile. Ma oggi c’è una ragione aggiuntiva per chiedergli di farle il salto: il lavoro non lo si può più inventare, creare e difendere solo o soprattutto a livello sindacale. E le occasioni per ribaltare il quadro non si ripetono
postilla
Certamente il tema del lavoro è centrale per operare da subito un ribaltamento del percorso lungo il quale l'Italia corre verso il baratro. Ma il Lavoro non è difendibile se esso non è collegato, fin dalla sua prima enunciazione, ad altri due grandi temi che, con esso, costituiscono i tre pilastri di un nuovo sviluppo: Ambiente e Democrazia. Per ora ci limitiamo qui ad asserirlo. Proveremo presto ad argomentarlo meglio.
 «In assenza dell’apertura di vie legali di ingresso e senza una modifica del Regolamento Dublino III,
«In assenza dell’apertura di vie legali di ingresso e senza una modifica del Regolamento Dublino III,
Mos Maiorum potrebbe costringere i migranti a rivolgersi ancor più ai trafficanti di terra, rafforzando il ricatto delle reti criminali”. Dal sito L’altra Europa con Tsipras, 09 ottobre 2014
Nello stesso momento in cui i governi europei fingono di piangere i morti di Lampedusa, a un anno dalla strage del 3 ottobre, si sta preparando in tutta l’Unione un’autentica retata di migranti, promossa dal governo italiano nelle vesti di presidente di turno del Consiglio. Sono felice che il nostro gruppo si mobiliti, e un grande grazie a chi, nello staff del Gue-Ngl, sta cercando di costruire iniziative in vista della prossima plenaria assieme al gruppo dei Verdi. (1)
L’operazione, battezzata Mos Maiorum, si svolgerà dal 13 al 26 ottobre, ed è stata decisa dal Consiglio dei ministri dell’Interno e della Giustizia il 10 luglio scorso. Ne siamo venuti a conoscenza tardi: in parte perché come Parlamento non siamo stati avvisati, in parte perché non siamo stati attenti. Sarà condotta dentro lo spazio Schengen e, con la scusa della lotta alla tratta di esseri umani, intende rintracciare il più gran numero possibile di migranti cosiddetti irregolari: il più delle volte richiedenti asilo senza documenti, perché in fuga da zone di guerre cui noi stessi abbiamo contribuito.
Mos maiorum – già il nome inquieta, rimanda a tempi di imperi e schiavi – sarà assistita dall’agenzia Frontex, che in teoria controlla le frontiere dell’Unione, non il suo spazio interno. Avviene inoltre quando l’agenzia Frontex è più contestata, per non rispetto del divieto di respingimento sancito dalla Carta europea dei diritti fondamentali, oltre che dalla convenzione di Ginevra. Sono numerosi i casi di respingimento collettivo dai porti dell’Adriatico, e dagli aeroporti siciliani di Comiso (Ragusa) verso l’Egitto e di Palermo verso la Tunisia.
La mancanza di canali legali di ingresso in Europa ha prodotto una crescita esponenziale di fuggitivi, costretti ad entrare (e poi spostarsi nell’area Schengen) senza documenti. Il Regolamento Dublino III, mal congegnato, prevede tempi lunghi delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e produce movimenti secondari di richiedenti asilo verso il Nord Europa, attraverso canali irregolari. Queste persone rischiano di essere le prime vittime di un’operazione di polizia che, a parole, vuol contrastare il crimine che fa profitti sui migranti, sia quando entrano nell’Unione sia quando circolano al suo interno.
Si potrebbe verificare il contrario esatto di quel che si dice di voler ottenere: una criminalizzazione non delle mafie ma delle loro prede: cioè di chi sarà trovato senza regolari documenti di ingresso e soggiorno. Si estenderà la loro possibile reclusione nei centri di detenzione. Saranno ancor più svalutati gli istituti della protezione internazionale.
In assenza dell’apertura di vie legali di ingresso e senza una modifica del Regolamento Dublino III, Mos Maiorum potrebbe costringere i migranti a rivolgersi ancor più ai cosiddetti trafficanti di terra, rafforzando il potere di ricatto delle reti criminali. I meccanismi di emarginazione prodotti dalla fuga nella clandestinità, sostiene il docente di diritto d’asilo Fulvio Vassallo Paleologo, sono una manna per le reti che forniscono servizi e beni primari in cambio non solo di denaro, ma dell’affiliazione a correnti politiche e religiose radicali. Le retate non abbattono le mafie. Le tengono in vita e le nutrono.
1) Su Mos Maiorum, il gruppo Gue-Ngl ha successivamente deciso, nel pomeriggio del 9 ottobre, di inviare subito una lettera al Consiglio dei ministri degli Affari interni e della Giustizia, riuniti nella stessa giornata a Lussemburgo, e di preparare una "richiesta di dichiarazione" del Consiglio durante la prossima plenaria del Parlamento europeo. Alla richiesta aderirà il gruppo dei Verdi.
 Qualcosa di liberale (e non neoliberista) rispunta ancora, di tanto in tanto, dalle rotative del Corrierone. «Prima o poi doveva succedere: la democrazia parlamentare non sopravvive a periodi lunghi di paralisi».
Qualcosa di liberale (e non neoliberista) rispunta ancora, di tanto in tanto, dalle rotative del Corrierone. «Prima o poi doveva succedere: la democrazia parlamentare non sopravvive a periodi lunghi di paralisi».
Il Corriere della Sera, 10 ottobre 2014
Si moltiplicano infatti i luoghi di decisione politica esterna che il Parlamento non può rimettere in discussione: il Patto del Nazareno, un discorso nella Direzione del Pd, un incontro estivo con Draghi. La stessa ratifica parlamentare si fa al contempo obbligata (con la fiducia) e vaga (con la delega), trasferendo sempre più il potere legislativo all’esecutivo: come è avvenuto sulla riforma dell’articolo 18, di cui nei testi votati non c’è niente, e tutto resta affidato alla tradizione orale e agli impegni verbali.
Il parlamentare è ormai un’anima morta, legata al leader da un ferreo vincolo di mandato; il che, come in ogni servitù, lo induce alla rancorosa vendetta ogni volta che può agire in segreto, ad esempio col triste spettacolo della mancata elezione dei giudici della Consulta. In alternativa, se non è d’accordo, può solo disertare dal suo mandato (assentandosi o dimettendosi).
La stessa definizione di presidente del Consiglio non si addice più a Renzi, il quale pur essendo primus non è certamente più inter pares tra i suoi ministri, come testimoniato dalla performance di Giuliano Poletti sulla riforma del mercato del lavoro. Pur senza nostalgie per il regime parlamentare uscente, davvero impossibili, bisogna riconoscere che qui siamo oltre. È come se avessimo sostituito a vent’anni di mancate riforme istituzionali la biografia e la personalità di un leader di quarant’anni: una riforma costituzionale incarnata, in personam invece che ad personam.
Prima o poi doveva succedere: la democrazia parlamentare non può sopravvivere a periodi troppo lunghi di paralisi. A Bersani e D’Alema che protestano per l’andazzo odierno andrebbe risposto che ne sono in buona parte responsabili. Però non è detto che la nuova costituzione materiale che si sta delineando sia l’unica forma di post-democrazia possibile.
Non è vero che funziona così ovunque. Perfino in un regime presidenziale come quello statunitense i parlamentari hanno un incomparabile potere di condizionare le scelte dell’esecutivo. Perfino a Westminster le ribellioni in Aula sono all’ordine del giorno. Perfino in Germania la Merkel ha dovuto spesso ricorrere ai voti dell’opposizione per resistere alle defezioni interne della sua maggioranza. Istituti come la sfiducia costruttiva, sistemi elettorali basati sul collegio uninominale, o anche un presidenzialismo dotato di check and balances, consentono di avere insieme governi autorevoli e Parlamenti liberi.
Sarebbe il caso di pensarci per tempo. Perché democrazia è certamente decisione, ma è anche e soprattutto potere di controllare il potere. Ogni giorno, e non solo una volta ogni cinque anni.

L’accelerazione impressa da Matteo Renzi nel suo “semestre europeo” lascia sul terreno cumuli di macerie (a cominciare da quelle del suo partito). E apre almeno tre grandi questioni, clamorosamente evidenti in questi giorni solo a volerle vedere: una questione istituzionale, annunciatasi fin dalla battaglia d’estate sul (e contro il) Senato. Una “nuova” questione sociale: nuova perché si poteva pensare che già col governo Monti si fosse arrivati a mordere sull’osso del mondo del lavoro, e invece ora si affondano i colpi ben sotto la cintura. Infine una grave questione democratica, resa drammatica dall’intrecciarsi delle prime due, e dal ruolo che la crisi gioca nel dettarne modi e tempi di sviluppo.
Renzi – nonostante le retoriche che ne accompagnano e potremmo dire ne costituiscono l’azione – non rappresenta una possibile soluzione della crisi economica e sociale italiana. Non ha né la forza (nei rapporti inter-europei) né le idee per aprire anche solo uno spiraglio. Ma condensa in sé – nella propria stessa persona, nel proprio linguaggio e nei propri comportamenti quotidiani, oltre che nelle misure che impone – il modo con cui la crisi lavora. E’, si potrebbe dire, il lavoro della crisi tradotto in politica: ne converte in pratica di governo tutto il potenziale destabilizzante. Ne accompagna e ne garantisce lo sfondamento dei residui livelli di resistenza e di ostacolo al libero dispiegarsi del potere del denaro da parte di ciò che resta dei corpi sociali e delle loro consolidate tutele. Ne conduce a compimento la liquidazione dei patti che avevano costituito il tessuto connettivo della “vecchia” società industriale, e delle culture che ne avevano accompagnato sviluppo e conflitto.
In questo senso Renzi non è l’alternativa all’intervento “d’ufficio” della Troika, un male minore rispetto a quello toccato alla “povera Grecia” che ha dovuto subire i tre Commissari-guardiani. Renzi è la Troika, interiorizzata. E’ la forma con cui l’Europa dell’Austerità e del Rigore governa il nostro Paese. Nell’unico modo possibile nelle condizioni date: con una formidabile pressione dall’esterno, e con un’altrettanto forte carica di populismo all’interno. Se li si leggono con un po’ d’attenzione si vedrà che i punti del suo programma, imposti con stile gladiatorio e passo di corsa a un mondo politico attonito, ricalcano fedelmente il famigerato Memorandum che ha prodotto la morte sociale della Grecia: privatizzazioni con la motivazione di far cassa, in realtà per metter sul mercato tutto ciò che può costituire un buon affare; abbattimento delle garanzie e del potere contrattuale del lavoro in nome dei “diritti dell’impresa”; ridimensionamento del pubblico impiego in termini di spesa e di occupazione; rimozione degli ostacoli alla rapidità decisionale da parte delle forme tradizionali della rappresentanza politica e sociale.
Se collocati in questo quadro si spiegano, allora, quelli che altrimenti sembrerebbero solo una sequela di strappi, forzature, ostentazioni di arroganza, maleducazione, guasconeria e improvvisazione (che pure non manca). E’ evidente infatti che un simile progetto non può essere messo in atto con mezzi “ordinari”. Richiede un’eccezionalità emergenziale, sia per quanto riguarda lo sfondamento dell’assetto costituzionale: e a questo è servito l’auto da fé in diretta di uno dei simboli della democrazia rappresentativa, la “camera alta”. Sia per quanto attiene al livello simbolico: ed è quanto sta avvenendo sotto i nostri occhi con l’umiliazione ostentata del movimento sindacale e del mondo del lavoro. Perché se maramaldeggiare con i brandelli residui dell’articolo 18 e con ciò che resta dello Statuto dei lavoratori non porterà un solo posto di lavoro, come è chiaro pressoché a tutti, è pur vero che la celebrazione del sacrificio spettacolare, in piena piazza mediatica, secondo i vecchi riti dell’ordalia, continua ad avere un effetto simbolico straordinario. Tanto più se la vittima sacrificale – l’homo sacer direbbe Agamben -, è uno dei protagonisti centrali del nostro passato prossimo come, appunto, il lavoro nella forma politico-sociale del movimento dei lavoratori.
Imporne la degradazione pubblica. Liquidarlo in otto minuti d’introduzione e un’oretta di udienza. Abbattere anche le residue garanzie perché, come ho sentito dire autorevolmente, occorre liberare gli imprenditori dall’ ”arbitrio di un giudice” (sic!), significa nell’immaginario collettivo rovesciare il mondo. Riscrivere l’articolo uno della Costituzione affermando che “L’Italia è un’oligarchia plebiscitaria fondata sull’impresa” e, al secondo comma, che “la sovranità appartiene ai mercati, i quali l’esercitano in modi e forme discrezionali, senza limiti di legge”. Ha ragione Susanna Camusso nell’affermare che l’unica cosa che interessa al premier è presentarsi all’Europa degli affari con lo scalpo dei lavoratori in mano. Con un’aggiunta: che Renzi quello scalpo lo vuole usare anche nei confronti dei suoi, e di un elettorato frantumato, impoverito, rancoroso per le umiliazioni subìte spesso senza trovare adeguata difesa da parte dei propri rappresentanti politici e sindacali, da catturare con l’immagine forte di una vittoria sacrificale.
Per questo dico – e sono consapevole del peso delle parole – che siamo in presenza di una “emergenza democratica”. Non solo perché il “renzismo” ha già cambiato il DNA del suo partito d’origine, trasformandolo in un ectoplasma risucchiato in alto, tra le mura di Palazzo Chigi, e avviandosi verso quello che a ragione è stato definito il “partito unico del Premier”. Non solo perché, parallelamente, ha ridotto un Parlamento amputato a ufficio di segreteria del Governo, chiamato a firmarne le carte (come si è visto ieri), mentre col patto del Nazareno ha definitivamente omologato l’antropologia politica, rendendo pressoché indistinguibili quelle che un tempo erano state “due Italie” eticamente e culturalmente diverse e ampliando così, d’incanto, il serbatoio di voti a cui attingere. Ma soprattutto perché con Renzi si conclude una vera e propria mutazione genetica del nostro sistema politico e istituzionale, con la verticalizzazione brutale di tutti i processi, concentrati nella figura apicale del Premier; la riconduzione del potere Legislativo non solo “sotto”, ma “dentro” il potere Esecutivo, come sua appendice secondaria; la tendenziale liquidazione dei corpi intermedi – la “società di mezzo”, come la chiama De Rita, comprendente le variegate forme di aggregazione e di rappresentanza sociale -, che potrebbero fare da ostacolo al rapporto diretto del Capo col “suo” Popolo, fascinato (“sciamanizzato”) retoricamente secondo la classica immagine del Demagogo. Con la pessima tecnica di convertire la disperazione in speranza mediante espedienti verbali e l’evocazione del “miracolo”. Una forma di plebiscitarismo dell’illusione, che lascia tutti i problemi irrisolti, ma che premia enormemente in termini di potere personale.
Ora se questo è vero, o anche solo in parte condiviso, quello che s’impone, d’urgenza, è non solo un’opposizione convinta e intransigente sui singoli provvedimenti (che è condizione necessaria, anche se non sufficiente) ma, al di là di ciò, la costruzione di una proposta ampia – politica, sociale, culturale, morale – in grado di contrastare questo processo all’altezza della sfida che lancia. Un fronte articolato, imperniato sui diritti e sul lavoro, capace di radunare tutto ciò che ancora nello spazio rarefatto della politica “resiste” ma soprattutto in grado di mobilitare forze nuove, oggi disperse, con linguaggi, idee, forme organizzative innovative e aperte. Di fare e conquistare opinione e impegno.
Lo dico con molto rispetto per posizioni che so vicine a questo sentire, come quella espressa sul manifesto da Airaudo e Marcon: se ci limitassimo ad assemblare semplici pezzi di classe politica - ciò che resta della sinistra politica “che non si arrende”, i “refrattari” dell’arena parlamentare o delle sue immediate vicinanze -, se pensassimo che il “renzismo” si arresta mobilitando per linee interne la cosiddetta “minoranza” del Pd (alla cui patetica prova abbiamo assistito ieri) saldata a ciò che rimane del tradizionale e ormai cancellato “centro-sinistra” proponendone una nuova piccola casa, temo che non andremmo molti avanti. E anzi, forniremmo a Matteo Renzi un bersaglio perfetto contro cui sparare a palle incatenate, nominandosi campione del nuovo contro tutto ciò che sa di “residuo”.
Serve al contrario, a mio avviso, sfidarlo sul terreno alto dell’alternativa a tutto campo, italiana ma in un quadro a dimensione europea (perché è pur sempre lì che si gioca la partita che conta), dello stile politico e dell’egemonia culturale. Un processo inclusivo di tutti, senza esami del DNA, aperto, innovativo, in grado di riportare dentro quella ampia sinistra diffusa che sta fuori dalla sempre più ristretta sinistra politica. La “chimica” della lista L’altra Europa con Tsipras ha, in qualche modo, anticipato questo approccio (anche nel suo respiro europeo) e costituito un primo passo. Oggi, nelle nuove dimensioni, è a sua volta insufficiente a reggere la sfida: il suo milione e centomila elettori può esserne un nucleo iniziale, non l’intero corpo. Ma credo che sia su quella strada che occorra incamminarci, assumendo intanto come prima tappa la piazza del 25 ottobre. Altre ne verranno.
«Il manifesto, 9 ottobre 201425 ottobre. Le parole di Maurizio Landini chiamano insieme a una grande manifestazione ma anche ad attivare un movimento sul controllo da parte dei lavoratori dei processi della crisi in atto, a partire dalle crisi aziendali
«Questo Parlamento non serve a niente, siamo pronti ad occupare le fabbriche»: Maurizio Landini non poteva essere più esplicito e «storico», anche nel riferimento alle occupazioni di fabbriche che hanno contrassegnato nel secolo breve la storia del movimento operaio, non solo italiano. Qualcuno ci ha letto una sorta di candidatura «politica», altri l’hanno vista come «narrazione» agli iscritti sindacali, la Confindustria l’ha giudicata come una minaccia.
Ma le parole del segretario della Fiom non sono una suggestione, corrispondono in pieno alla precipitosa crisi italiana finita nelle mani, improprie, dell’apprendista stregone Matteo Renzi. Siamo infatti con la fiducia sul cosiddetto Jobs Act, all’ennesima riduzione degli spazi di democrazia, dopo la cancellazione dell’elezione diretta del Senato e l’accumulo di decretazione come mai prima nessun governo della Repubblica. Ma se sui temi del lavoro si cancellano le difese degli stessi lavoratori, è legittimo o no che si alzi la loro voce e di chi legittimamente li rappresenta?
Rendendo così evidente che ormai la questione non è più solo sindacale, ma politica perché chiama in causa contenuti di rappresentanza e di potere. Nella convinzione che la mancanza di lavoro e di investimenti, non sia dovuta al peso delle tutele fin qui faticosamente conquistate dai lavoratori con straordinarie stagioni di lotta che si vogliono azzerare, e che non dipende dalla mancata riforma del mercato lavoro tanto cara alla fallimentare destra neoliberista. Ma al contrario proprio dalla mancata riforma del mercato dei capitali. Vale a dire dal fatto macroscopico, che questo governo misconosce, che la crisi finanziaria del capitalismo ha devastato risorse e umanità. E che ora, come assai timidamente avviene negli Stati uniti per effetto della possibilità di soccorrere con la moneta domanda e investimenti, è necessario un ruolo di controllo e imprenditorialità del governo e dello Stato.
Mentre in Italia e in Europa, irresponsabilmente, invece si avvia l’itinerario opposto delle privatizzazioni, smantellando aziende tutt’altro che in rosso e con capacità di guida e indirizzo dell’intera economia italiana e continentale, privata, pubblica e cooperativa.
Ora — ed è la riflessione che come manifesto vogliamo rilanciare, anche perché è parte della nostra cultura fondativa — le parole di Maurizio Landini chiamano insieme ad una grande manifestazione il 25 ottobre ma anche ad attivare un movimento sul controllo da parte dei lavoratori dei processi della crisi in atto, a partire dalle crisi aziendali. Convinti che dalla crisi si esce con più democrazia non con meno, come vogliono Matteo Renzi e il nuovo Pd. Se tra le pieghe del Jobs Act compariva a gennaio una specie di fantasma di cogestione — tutti uniti tutti insieme, il lavoro subalterno che subisce il disastro dell’impresa capitalistica e il padrone protagonista del crollo — la crisi in corso pone all’o.d.g. ancora una volta il ruolo centrale dei lavoratori.
Si dirà: ma se le fabbriche non ci sono più? Non è proprio vero, ma quando tragicamente lo è, proviamo a capovolgere lo sguardo: non ci troviamo forse da anni di fronte a drappelli di lavoratori protestatari che insistono a trovare un padrone che ripristini mercato e sfruttamento? Oppure, all’opposto, a fabbriche dismesse, considerate inadeguate o obsolete, occupate e riattivate dagli stessi lavoratori? E ancora ai «nuovi lavori» precari o ai senza lavoro spesso in conflitto sordo con chi il lavoro ancora ce l’ha, ma sempre più incerto? Trasformiamo questa protesta che rischia di apparire come routinaria in un presidio di fronte al fantasma del ruolo del «capitalista». «Siamo pronti ad occupare le fabbriche» chiama a ruolo perfino la funzione del governo Renzi che, con l’austerity Ue, adesso siamo costretti a subire in una convivenza forzosa.
 La produzione di cemento è in calo. Un governo responsabile non può lasciare che sia il mercato ad occuparsene «perché il mercato non è mai pienamente libero, come dimostrano i finanziamenti pubblici arrivati a Cementir e Italcementi per “ristrutturare” e trasformare in co-inceneritori di rifiuti gli impianti di Taranto e Rezzato (BS)”».
La produzione di cemento è in calo. Un governo responsabile non può lasciare che sia il mercato ad occuparsene «perché il mercato non è mai pienamente libero, come dimostrano i finanziamenti pubblici arrivati a Cementir e Italcementi per “ristrutturare” e trasformare in co-inceneritori di rifiuti gli impianti di Taranto e Rezzato (BS)”».
Altreconomia.it, 9 ottobre 2014
Se le proiezioni saranno confermate, nel 2014 il consumo di cemento nel nostro Paese scenderanno sotto le venti milioni di tonnellate. Secondo i dati presentati dal centro studi dell'AITEC, l'Associazione confindustriale che riunisce le principali aziende che producono cemento in Italia, il nostro Paese non è mai sceso “così in basso” dal 1961, da prima del boom economico. Se misuriamo la variazione rispetto al 2007, che è l'anno principe della “bolla immobiliare” nel nostro Paese, accanto al segno meno c'è scritto 56,13%: oltre la metà della produzione pro capite di cemento è andata perduta. Peggio di noi, dal 2010 ad oggi, ha fatto solo la Spagna, un altro Paese in cui nei primi anni Duemila si è costruito, costruito, costruito, aumentando a dismisura l'offerta di case, senza badare all'effettiva esistenza di una domanda, o alimentandola in modo fittizio garantendo mutui troppo facili, che oggi -complice la disoccupazione- sono diventati un grave problema sociale.
Di fronte a questi numeri, però, l'unica scelta possibile per il governo Renzi, che avrebbe dovuto cambiare verso al Paese, è quella di (provare a) governare il settore: secondo le informazioni de Il Sole 24 Ore, dal 2008 ad oggi sono stati chiusi 21 dei 60 impianti a ciclo completo presenti sul territorio nazionale, anche se in molti casi non si tratta di chiusure definitive, e il governo dovrebbe aprire un tavolo di concertazione con i produttori di cemento, per pianificare -insieme- il futuro del settore (e dei suoi 8.600 addetti). Non è pensabile, infatti, che la produzione di cemento ritorni ai livelli del 2006-2007, come ha ben evidenziato la scelta di Italcementi di chiudere nell'arco di un triennio quasi la metà dei propri stabilimenti, ma un governo responsabile non può lasciare che sia il mercato a decidere. Perché il mercato non è mai libero pienamente, come dimostrano -ad esempio- i finanziamenti pubblici che attraverso la Banca europea degli investimenti sono arrivati a Cementir e Italcementi per “ristrutturare” e trasformare in co-inceneritori di rifiuti gli impianti di Taranto e Rezzato (BS).
Anche perché, nel caso dei cementifici, stiamo parlando di un'industria insalubre, di uno dei settori le cui emissioni sono monitorate dall'Unione Europea nell'ambito del programma europea di riduzione legato al Protocollo di Kyoto. Così, non dev'essere solo la magistratura amministrativa a dire che cosa si può e non si può fare nei cementifici e coi cementifici, quando i cittadini -o le amministrazioni comunali- si rivolgono ai giudici del TAR per verificare la legittimità di un singolo atto. C'è bisogno della politica, e anche di un po' di buon senso. Quello che vorrebbe, ad esempio, che l'immagine di alcune delle aree più belle del Paese non venisse “sporcata” dalle ciminiere di un cementificio, né che quest'impianti continuino ad esistere nelle nostre città, a ridosso di zone densamente abitate. Partiamo da qui, dalla chiusura dei cementifici di Pederobba, Fumane in Valpolicella, Monselice ed Este, all'interno del Parco dei Colli Euganei, Taranto, Pescara, Piacenza e Barletta.
Così tanto cemento non serve più, prendiamone atto.
Introduzione al libro Rottama Italia, inventato e curato da Tomaso Montanari e Sergio Staino, edito e distribuito gratuitamente da Altreconomia. Testi di 16 sapienti autori e 13 graffianti artisti.
Perché vogliamo che l’Italia cambi verso. Ma davvero. Vogliamo un Paese moderno. E cioè un Paese che guardi avanti. Un Paese che sappia distinguere tra cemento e futuro. E scelga il futuro. Vogliamo un Paese in cui chiamiamo sviluppo ciò che coincide con il bene di tutti, e non con l’interesse di pochi. Un Paese in cui lo sviluppo sia ciò che innalza -e non ciò che distrugge- la qualità della nostra vita. Un Paese che cresca, e non un Paese che divori se stesso. Un Paese capace di attuare il progetto della sua Costituzione. Una Costituzione che da troppo tempo “è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere”, una Costituzione in cui “è scritta a chiare lettere la condanna dell’ordinamento sociale in cui viviamo” (Piero Calamandrei).
Il decreto Sblocca-Italia è, invece, un doppio salto mortale all’indietro. Un terribile ritorno a un passato che speravamo di aver lasciato per sempre. Un passato in cui “sviluppo” era uguale a “cemento”. In cui per “fare” era necessario violare la legge, o aggirarla. In cui i diritti fondamentali delle persone (come la salute) erano considerati ostacoli superabili, e non obiettivi da raggiungere.
Giuseppe Dossetti avrebbe voluto che nella Costituzio- ne ci fosse questo articolo: “La resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino”.
La prima, e più importante, resistenza allo Sblocca Italia passa attraverso la conoscenza, l’informazione, la possibilità di farsi un’opinione e di farla valere. Discutendone nelle piazze e nei teatri, nelle televisioni e alla radio. Richiamando al progetto della Costituzione i nostri rappresentanti in Parlamento. E, se necessario, anche ricorrendo al referendum: se -alla fine e nonostante tutto- questo sciagurato decreto “Rottama-Italia” diventerà legge dello Stato.
Perché non siamo contro lo Sblocca Italia. Siamo per l’Italia.

L‘affermazione “la scienza ha sempre ragione” non è scientifica. È ideologica. Lo è tanto quanto il pregiudizio reazionario per il quale ogni mutamento del modo di produrre, consumare, nutrirsi, avviene nel nome di interessi inconfessabili, e a scapito della salute della collettività umana.
Il Governo negli ultimi mesi ha definito come uno degli obiettivi principali il favorire, o meglio l'imporre processi di fusione e aggregazione tra aziende che gestiscono i servizi pubblici locali. La realizzazione di questo piano in realtà comporterà la definitiva consegna dei beni comuni ai capitali finanziari.
Diversi sono, infatti, gli indizi che vanno esplicitamente in questa direzione: il piano sulla "spending review" che punta alla razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali, seguendo lo slogan "riduzione da 8.000 a 1.000"; il decreto "Sblocca Italia" che, modificando profondamente la disciplina riguardante la gestione dell'acqua, arriva ad imporre un unico gestore in ciascun ambito territoriale e individua, sostanzialmente, nelle grandi aziende e multiutilities, di cui diverse già quotate in borsa, i poli aggregativi; la legge di stabilità in cui probabilmente verranno inserite quelle norme volte a imporre agli Enti Locali la collocazione in borsa delle azioni delle aziende che gestiscono servizi pubblici. Si arriverebbe, addirittura, a costruire un vero e proprio ricatto nei confronti degli Enti Locali i quali, oramai strangolati dai tagli, sarebbero spinti alla cessione delle loro quote al mercato azionario per poter usufruire delle somme derivanti dalla vendita, che il Governo pensa bene di sottrarre alle tenaglie del patto di stabilità.
In questa partita giocherà un ruolo determinante Cassa Depositi e Prestiti che ha annunciato di
mettere a disposizione 500 milioni di €. A riguardo va evidenziato che CDP raccoglie il risparmio postale di oltre 12 milioni di cittadini e lavoratori, che annualmente ammonta a 220 miliardi di euro. Dunque la sua funzione non dovrebbe essere quella di finanziare processi, come fusioni e aggregazioni, che contrastano con l'interesse collettivo bensì utilizzare il denaro raccolto per il finanziamento a tassi agevolati degli investimenti degli Enti Locali, ovvero recuperare la sua funzione pubblica originaria.
Appare sempre più evidente come in queste ultime settimane si stia imprimendo un'accelerazione alla discussione pubblica provando a concentrare l'attenzione esclusivamente su tale tema attraverso la costruzione di una propaganda che prova a disegnare uno scenario di ineluttabilità di questo processo utilizzando argomentazioni come la necessità di superare l'eccessiva frammentazione delle aziende, di ridurre gli sprechi e di realizzare delle aziende di dimensioni tali da essere in grado di competere sul mercato, anche globale, e di effettuare gli investimenti.
Ne emerge così un dibattito pubblico del tutto distorto in quanto si prova a nascondere il reale obiettivo sotteso, ovvero la privatizzazione del servizio idrico e dei servizi pubblici locali, e finanche la finanziarizzazione degli stessi.
A nostro avviso la proposta di creare pochi soggetti gestori, intorno alle grandi multiutilities esistenti, che si spartiscano tutto il territorio nazionale, ripercorre la strada dei fallimenti testimoniati dai bilanci in debito di queste società e ripropone l'idea di vendere servizi essenziali per coprire buchi di bilancio. Si tratta esclusivamente di un’operazione che espropria i consigli comunali dei loro poteri e allontana le decisioni dal controllo democratico. Oggi serve una gestione dell'acqua, dei rifiuti, del TPL, dell'energia, prossima ai cittadini e alle amministrazioni locali, per garantirne la trasparenza e la partecipazione nella gestione dei servizi.
Oggi più che mai una scelta del genere non deve essere perseguita. Al contrario è necessario dare seguito alla volontà popolare espressa con il referendum del 2011 e quindi sottrarre l'acqua e i servizi pubblici dalle logiche di mercato e di profitto. Come Forum dei Movimenti per l'Acqua intendiamo denunciare con forza la gravità di questo progetto e dichiariamo sin da subito che ci mobiliteremo per contrastarlo.

«Il manifesto, 8 ottobre 2014
Non era mai accaduto prima d’ora che un nutrito gruppo di intellettuali, giuristi, storici dell’arte, economisti e ambientalisti scrivessero un instant book contro un decreto legge del governo. Non sono mancate critiche a ogni provvedimento legislativo, ma arrivare a produrre un organico libro segnala la gravità contenuti nel decreto. Esce oggi un agile volume informatico Rottamitalia edito da Altreconomia, ideato da Sergio Staino e curato da Tomaso Montanari. Il libro si può scaricare sul sito www.altreconomia.it/rottamaitalia e lo potete trovare anche sulla edizione on line de Il Manifesto.
Sono due i motivi che hanno reso possibile il volume. In primo luogo i contenuti che denunciano la gravità della crisi di prospettiva delle classi dirigenti del paese. Sbaglierebbe infatti chiunque pensasse che siamo di fronte al pensiero di Renzi, di Lupi o di qualsiasi altro esponente di secondo piano del governo. Il decreto è stato scritto direttamente dalle lobby che nel sonno della politica, dominano incontrastate il paese.
Gli articoli che liberalizzazino le possibilità di trivellazioni petrolifere in ogni parte del paese sono da anni richieste dai petrolieri.
Le norme che annullano il potere di controllo delle Soprintendenze nella tutela dell’ambiente sono da anni nell’agenda dalla lobby delle grandi opere. Quelle che mettono le basi per una nuova fase di cementificazione delle città sono volute dalla lobby dei proprietari immobiliari. Le norme che facilitano la vendita del patrimonio immobiliare dello Stato sono chieste a gran voce dal mondo finanziario internazionale. E, infine, un intero capo del provvedimento (il quarto) affida il futuro delle opere pubbliche e delle città alla finanza di rapina responsabile della crisi mondiale di questi anni.
La gravità dello «Sblocca Italia» sta dunque in questo quadro generale. Una classe dirigente incapace di fare i conti con il fallimento delle ricette neoliberiste vuole continuare ancora con le stesse politiche distruggendo ulteriormente la struttura dello Stato. Mentre ad esempio la tassazione sulle imprese e sulle famiglie cresce senza sosta, con alcuni articoli si regalano milioni di euro alle grandi imprese che si spartiscono da decenni il sistema delle grandi opere. Sono infatti previsti generosi sconti fiscali per le società concessionarie. Milioni di euro che passano dalle famiglie italiane sempre più impoverite ai soliti noti. Il caso ha voluto che negli stessi giorni in cui Renzi proponeva tali sconcezze, la Corte dei Conti ha accertato che solo nel periodo 2006 – 2010 per la costruzione della linea «C» della metropolitana di Roma, devono essere restituiti 370 milioni ingiustamente guadagnati perché le regole sono state cancellate e non ci sono più strumenti di controllo. Ciononostante continua la rumorosa invettiva contro la «burocrazia» e con lo Sblocca Italia si allentano ulteriormente le regole. Lo stesso Raffaele Cantone, in sede di audizione parlamentare ha dato l’allarme su questo punto.
Ma il libro segnala anche una importante novità: la maturazione di una visione alternativa del futuro dell’Italia che in questi anni si è alimentata nelle tante vertenze territoriali e che è oggi arrivata ad una convincente sintesi. La premessa al libro firmata da Paolo Maddalena, vice presidente emerito della Corte Costituzionale, si intitola «Fuori della Costituzione» e ragiona sul fatto che il decreto è contrario alla carta fondamentale in tutte le norme che affidano il futuro dei territori e delle città ai privati invece e che svendono il patrimonio pubblico.
Nel libro, insomma, si ritrova il filo del ragionamento sulla piena attuazione della Costituzione elaborato da Salvatore Settis nel suo Paesaggio, Costituzione Cemento(2012) e completato sempre da Settis con Maddalena in Costituzione incompiuta(2013, con Leone e Montanari) e poi ulteriormente perfezionato da Maddalena in Il territorio bene comune degli italiani (2014). Il legame con la Costituzione fornisce un’inedita forza unificante alle tante lotte dei comitati che un’accorta propaganda ha bollato come affette da sindrome del nimby e che sono invece l’unico strumento in mano alla popolazione per opporsi ai Rottamatori d’Italia.
«Rottama Italia» nasce da un’idea di Sergio Staino, ed è stato curato da Tomaso Montanari. Hanno partecipato — gratuitamente– al progetto Ellekappa, Altan, Tomaso Montanari, Pietro Raitano, Giannelli, Mauro Biani, Paolo Maddalena, Giovanni Losavio, Massimo Bray, Maramotti, Edoardo Salzano, Bucchi, Paolo Berdini, Vezio De Lucia, Riverso, Salvatore Settis, Beduschi, Vincino, Luca Martinelli, Anna Donati, Franzaroli, Maria Pia Guermandi, Vauro, Pietro Dommarco, Domenico Finiguerra, Giuliano, Anna Maria Bianchi, Antonello Caporale, Staino, Carlo Petrini.
 Un'analisi acuta su un tema sul quale la discussione proseguirà anche su eddyburg. «E' facile capire perché oggi, soprattutto tra le nuove generazioni, destra e sinistra sono parole vuote, o se volete contenitori usa e getta».
Un'analisi acuta su un tema sul quale la discussione proseguirà anche su eddyburg. «E' facile capire perché oggi, soprattutto tra le nuove generazioni, destra e sinistra sono parole vuote, o se volete contenitori usa e getta».
Il manifesto, 6 ottobre 2014, con postilla
L’editoriale di Norma Rangeri (il manifesto del 5 ottobre) merita una riflessione a partire dalle “parole” che definiscono il campo politico: la destra e la sinistra nel nuovo secolo. Rangeri parte dalla constatazione di una sinistra da troppi anni terribilmente divisa, litigiosa, autodistruttiva, e auspica la nascita di una «sinistra dei diritti». Soprattutto, mette il dito sul «furto di parole» che contano come «libertà» e «cambiamento», rubate da Berlusconi, la prima, da Renzi la seconda. Ne aggiungerei un’altra rubata dal Pd di Renzi, complice l’ex-Cavaliere: la sinistra.
Ripartirei da qui: dal senso delle parole che nel campo della politica, come lo definiva Bourdieu, contano come pietre, almeno quanto in un campionato di calcio contano i gol. Per questo vale lo sforzo di provare a storicizzare la metamorfosi del linguaggio e delle categorie politiche dell’ultimo trentennio.
C’era una volta una netta distinzione tra i militanti e gli elettori della destra e della sinistra. I primi si potevano identificare facilmente con i conservatori, i secondi con i progressisti. Essere conservatori significava difendere lo status quo, l’ordine sociale e gerarchico esistente, credere in determinati valori quali religione-patria-famiglia, e quindi battersi per la conservazione delle forme sociali, economiche e politiche ereditate, a partire dalla sacralità della proprietà privata. Essere progressisti significava volere il cambiamento dell’ordine sociale, mettere in discussione i privilegi, le forme alienanti della religione, le superstizioni e le forme arcaiche delle culture locali, promuovere il progresso e la modernizzazione della società, della cultura, delle istituzioni.
Cambiamento-Progresso-Modernizzazione: queste sono state per più di un secolo le parole chiave delle forze politiche della Sinistra. Costituivano i pilastri di una visione positivistica della storia umana, che aveva iscritto nel suo codice genetico un lieto fine: la liberazione dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo. L’umanità, grazie al progresso tecnologico, si sarebbe liberata dalla schiavitù del lavoro legata al bisogno, così come era avvenuto per il lavoro dei servi e degli schiavi nelle società premoderne. Questo scenario, in cui si combinavano e marciavano insieme le conquiste di nuovi diritti per i lavoratori e per le fasce più deboli della società (welfare State), la crescita economica ed il progresso tecnologico si è spezzato, prima sul piano culturale e poi politico, alla fine degli anni ’70 del secolo scorso. Si è verificata una “catastrofe”, nell’accezione di René Thom, vale a dire una biforcazione tra forze che si intrecciavano lungo una linea ascendente e che adesso procedono per linee divergenti.
Un primo elemento forte di rottura, all’interno della sinistra europea, è nato con la questione delle centrali nucleari: per la sinistra “storica” rappresentavano una risposta progressista al fabbisogno di energia per lo sviluppo economico; per la sinistra “alternativa” – movimenti pacifisti, ambientalisti, ecc. – le centrali nucleari erano solo il bisogno drogato di un modello di sviluppo energivoro e pericoloso che andava radicalmente cambiato. Quasi contemporaneamente nasceva, nell’area della sinistra “alternativa”, una opposizione all’espansione dell’agricoltura industriale (fino alla contestazione dei primi esperimenti di Ogm), agli ipermercati e alla cementificazione indiscriminata, per finire con la contestazione di alcune Grandi Opere che si andavano progettando. Nasceva un’idea di “locale” come opposizione ai processi di globalizzazione capitalistica, di tradizioni e identità da recuperare (una volta appannaggio della destra storica), di una alternativa alla stessa categoria dello “sviluppo”, come fine dell’agire sociale. In breve: l’equazione progresso/tecnologia/modernizzazione/progresso dell’umanità, era saltata.
Nel corso degli anni ’90 e del primo decennio del nuovo secolo questa spaccatura all’interno della sinistra politica è diventata sempre più profonda, mentre sul campo avverso nasceva una nuova destra neoliberista che si appropriava delle parole “cambiamento”, “progresso”, e persino “rivoluzione” (nei confronti dello Stato burocratico e dei lacci e lacciuoli prodotti dai diritti dei lavoratori). Scioccata dalla vergognosa e rovinosa caduta dei paesi “socialisti”, la sinistra storica tentava di inseguire i processi di modernizzazione capitalistica diventando più realista del re. Le leggi di mercato e la crescita economica, senza se e senza ma, erano diventate le nuove stelle polari, il terreno su cui sfidare la nuova destra.
Questi veloci cambiamenti nel linguaggio come nelle categorie politiche, qui sinteticamente riassunti, hanno portato alla formazione di un Pensiero Unico da cui è difficile uscirne. Allo stesso tempo, il modo di produzione capitalistico si è profondamente trasformato, sia attraverso una torsione finanziaria (il Finanzcapitalismo, secondo la felice definizione di Luciano Gallino), sia attraverso l’adozione di tecnologie sempre più invasive e distruttive rispetto all’ecosistema.
Se tutto questo è vero, allora è facile capire perché oggi, soprattutto tra le nuove generazioni, destra e sinistra sono parole vuote, o se volete contenitori usa e getta. Parlare di “nuovo soggetto politico della sinistra” è un’espressione che parla solo agli addetti ai lavori o alla generazione che ha vissuto le lotte degli anni ’60 e ’70. Intanto, questa ossessione del “nuovo”, come valore in sé, fa parte della stessa ideologia del sistema in cui viviamo e in cui ogni giorno la pubblicità ci mostra un nuovo prodotto. Così come “cambiamento”, la parola più usata da Renzi (e una volta dalle forze della sinistra) è una parola priva di senso. Il mondo cambia comunque perché la vita è divenire di per sé. Bisognerebbe eliminarla dal vocabolario politico o specificare quale cambiamento si vuole produrre.
Piuttosto ci sarebbe da domandarsi come è possibile che un sistema economico-politico fallimentare, che crea povertà crescenti nell’era dell’abbondanza delle merci e delle tecnologie, che crea insicurezza economica e sociale nella maggioranza della popolazione, non venga rovesciato. Come possiamo ricreare un legame sociale e culturale tra milioni di persone, ridotte a individui, che lottano o resistono solo rispetto a una specifica situazione (condizioni di precarietà, licenziamenti, ecc.), ma sono incapaci di mettersi insieme, di essere solidali con chi vive nelle stesse condizioni.
Un esempio tra i tanti: la chiusura della Fiat di Termini Imerese, con cinquemila famiglie sul lastrico, non ha suscitato la solidarietà della società siciliana, a partire dai circa ottomila precari (Lsu, Lpu) che ogni tanto scendono in piazza per i fatti loro. Le parole della Thatcher , alla fine del secolo scorso, suonano come una funesta profezia: «La società non esiste, esistono solo gli individui».
Gramsci scriveva dal carcere che il Mezzogiorno appare come una «grande disgregazione sociale», oggi è tutta l’Italia a trovarsi in questa condizione. Per questo penso che non esista una via di uscita solo pensando al “soggetto politico”, che poi dovrà confrontarsi con un mercato elettorale dove impera ormai un duopolio, in Italia come negli Usa, dove il controllo dei mass media è determinante. Abbiamo invece urgente bisogno di una grande tessitura sociale e culturale e di parole in grado di costruire la visione del futuro desiderabile e credibile. A questo impegno siamo chiamati in tanti, anche chi si è allontanato dalla politica.
postilla
Proprio sabato prossimo, l'11 ottobre, se ne discuterà a Firenze, alla Libera univerità Ipazia, al Giardino dei ciliegi, via dell'Agnolo 8. Qui il link alla locandina
«Dà un’impressione di ascoltare, se per ascoltare intendiamo non tanto sviscerare, ma il mero prendere in considerazione. Una dialettica hegeliana fatta di tesi, finta attenzione all’antitesi, sintesi».
Il Post, 2 ottobre 2014
Nelle ultime settimane Matteo Renzi è stato sempre al centro del dibattito pubblico: il viaggio in America, Marchionne, i Clinton, l’inglese strampalato, l’intervista da Fazio, il bailamme sull’articolo 18, lo sberleffo dei sindacati, la direzione PD, la polemica con la minoranza, le critiche da parte di Corriere eRepubblica, etc… Anche chi non fosse interessato alle questioni del Partito Democratico o agli affari del governo quando entrano nell’occhio di bue, non può evitare di incrociare un affondo di Renzi, una sua dichiarazione, un intervento – che sia all’Onu o allo stadio, un tweet o un’interpellanza. È una forma di ubiquità che vuole significare attenzione, presenza; un dinamismo in perenne accelerazione che è il segno di una condizione di permanente attualità. Stare sempre sul pezzo, questo è il diktat.
Ma cos’ha di diverso, di specifico, la retorica renziana?
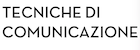 «Il discorso assertivo afferma, dichiara, definisce, prevede e prescrive, senza preoccuparsi di spiegare a chi ascolta né il perché, né il come, né il quando, né con quali mezzi e risorse. E’ un tipo di discorso che fa coincidere nome e cosa, affermazione e fatto».
«Il discorso assertivo afferma, dichiara, definisce, prevede e prescrive, senza preoccuparsi di spiegare a chi ascolta né il perché, né il come, né il quando, né con quali mezzi e risorse. E’ un tipo di discorso che fa coincidere nome e cosa, affermazione e fatto».
Il Fatto Quotidiano, 6 ottobre 2014
Si parla con…, si parla a… Vuol dire che parlare è innanzi tutto comunicare. Ma se la comunicazione non arriva perché chi ascolta non capisce la lingua di chi parla? E viceversa? Be’, smetteranno di parlarsi. E se non possono smettere perché hanno interessi, bisogni, pretese in comune? La situazione che si determina in questi casi è stata descritta per la prima volta nella Bibbia e prende il nome dalla città in cui avvenne: Babilonia. E le conseguenze furono talmente tragiche che tutti, contemporanei e discendenti, furono d’accordo che, dopo il Diluvio, la confusione delle lingue era la punizione più severa che Dio potesse infliggere all’umanità. Non credo che Dio c’entrasse, ma per quanto riguarda la gravità delle conseguenze, non ho dubbi.
Per questo mi preoccupa – e non da oggi – il fatto che il discorso pubblico in Italia si stia svolgendo su due registri diversi, lontani l’uno dall’altro fino al punto di far pensare a due lingue diverse, mentre sono entrambi in italiano.
Nella comunicazione politica italiana si fronteggiano interlocutori che utilizzano il discorso argomentativo e interlocutori che utilizzano il discorso assertivo. E anche i loro ascoltatori (gli italiani) sembra che si dividano tra chi capisce e ama il primo tipo di discorso e chi capisce e ama il secondo. Per discorso argomentativo intendo quel tipo di discorso che, rispettando i principi logici di causa ed effetto e di identità e non contraddizione, si svolge secondo il filo del ragionamento, esplicitando le premesse da cui parte, chiarendo i perché della scelta delle premesse e dei fatti che ne conseguono e concludendo con previsioni di risultati anch’esse razionalmente argomentate. E’ un discorso che non confonde la parte con il tutto, il singolare con il plurale; è un discorso basato su una corretta coniugazione dei verbi, sicché non confonde il presente con il desiderabile futuro; è un discorso che tiene conto del fatto che, quando si vuol cambiare qualcosa, bisogna intervenire anche sulle cause che hanno prodotto quella cosa.
Il discorso assertivo è tutt’altra cosa: afferma, dichiara, definisce, prevede e prescrive, senza preoccuparsi di spiegare a chi ascolta né il perché, né il come, né il quando, né con quali mezzi e risorse. E’ un tipo di discorso che fa coincidere nome e cosa, affermazione e fatto.
Spesso i politici di professione usano il linguaggio assertivo: è semplice da capire, diretto, immaginoso, tocca le corde profonde degli ascoltatori e consente con facilità di camuffare contraddizioni, di evitare rendicontazioni, in una parola di eludere i conti con la realtà. Mussolini era un maestro del linguaggio assertivo, che piaceva molto a molti italiani; fino alla tragica e grottesca conclusione, quel «Li fermeremo sul bagnasciuga» con cui annunciò agli italiani cosa intendeva fare quando gli Alleati fossero sbarcati in Sicilia.
Ma, ripeto, non c’è politico che non faccia ricorso ogni tanto al linguaggio assertivo, agli slogan: “Bandiera rossa trionferà” di contro a “ “I comunisti distruggono la famiglia”. Però ci sono state stagioni della vita politica italiana in cui il discorso assertivo fu utilizzato prevalentemente nei comizi, nei manifesti elettorali, magari nelle feste dell’Unità o nelle adunanze dell’Azione cattolica. Non nelle interviste, nelle conferenze stampa, nelle tribune politiche in tv. E nemmeno per illustrare proposte di legge da discutersi in Parlamento.
Le cose sono cambiate dalla discesa in campo di Berlusconi, altro maestro del linguaggio assertivo. Il milione di posti di lavoro, l’abolizione delle tasse, le grandi opere e il Ponte sullo stretto, la ricostruzione più rapida al mondo della città terremotata, i ristoranti pieni e i voli aerei tutti prenotati, per non ricordare che le asserzioni più celebri. Abilissimo utilizzatore della tv, Berlusconi asseriva anche con le immagini: ricordate l’edificante album di famiglia con cui si presentò in pubblico il patron delle cene eleganti?
Renzi si inserisce bene nella tradizione assertiva. Ha cominciato con l’affermazione dell’esigenza di rottamare (Chi? Perché?) onde realizzare il cambiamento (Quale? Come?) e prosegue con immaginose affermazioni, che raramente rispettano il principio di non contraddizione o chiariscono i rapporti di causa ed effetto.
Come già Berlusconi, anche Renzi ha successo. Il discorso argomentativo annoia, il discorso assertivo eccita, galvanizza. E’ un fatto, il discorso argomentativo è compreso e usato da un numero di persone in costante diminuzione; quello assertivo è sempre più apprezzato e praticato, anche nella sua forma che consiste nel dare sulla voce all’interlocutore (vedi i talk-shows). Questo sì che è un cambiamento, già in atto. E, che piaccia o no, va spiegato e capito. Cosa che tenterò di fare nel prossimo testo.
 «Abbiamo cercato di dare voce a quella sinistra che non vuole chiudersi nell’autocompiacimento dello sconfittismo, o nel ruolo rassicurante di quelli destinati all’opposizione a vita. Ma adesso come continuare il cammino?».
«Abbiamo cercato di dare voce a quella sinistra che non vuole chiudersi nell’autocompiacimento dello sconfittismo, o nel ruolo rassicurante di quelli destinati all’opposizione a vita. Ma adesso come continuare il cammino?».
Il manifesto, 5ottobre 2014, con postilla
Quando ci è stato chiesto di essere presenti ad una iniziativa unitaria della sinistra, a una manifestazione dove Sel ha chiamato a partecipare donne e uomini di una sinistra plurale, abbiamo accettato molto volentieri. Perché è la stessa sinistra che ogni giorno si incontra e discute sulle pagine del manifesto, il giornale che da oltre quarant’anni si batte per rinnovare la sinistra italiana.
E’ stata l’occasione per rivendicare il nostro ruolo, il nostro essere stati l’unico giornale impegnato a sostenere in modo aperto, senza autocensure, una campagna elettorale europea a favore della Lista Tsipras. Un’impresa più difficile del solito, sulla quale in pochi erano disposti a scommettere perché prima del voto la lista era assolutamente sconosciuta. Anche a sinistra. E proprio per questo è stata un’occasione da non perdere per chi non voleva rassegnarsi a votare per Renzi, né per Grillo e nemmeno ripiegare nell’astensionismo.
Non sempre le motivazioni che hanno fatto nascere la Lista Tsipras sono state rispettate. Ci sono stati personalismi esagerati, dosi eccessive di autoreferenzialità, insopportabili elenchi di buoni e cattivi. Ma, nonostante tutto, alla fine ha prevalso l’idea di rompere vecchi steccati, l’unica idea capace di moltiplicare la partecipazione, specialmente delle giovani generazioni. Questa idea si è tradotta in forza che ha poi assunto il peso del quorum elettorale.
Abbiamo cercato di dare voce a quella sinistra che non vuole chiudersi nell’autocompiacimento dello sconfittismo, o nel ruolo rassicurante di quelli destinati all’opposizione a vita. Ma adesso come continuare il cammino?
Vista la sproporzione delle forze in campo sarebbe velleitario dire che vogliamo diventare maggioranza - in Grecia Tsipras ha avuto successo in un paese in macerie - tuttavia vogliamo che si costruisca a sinistra del Pd una forza - o un insieme di forze - che possano farsi sentire con autorevolezza sui temi legati al governo del Paese. Se è chiaro quale può essere l’obiettivo (raggiungibile attraverso una lunga marcia che coinvolga però associazioni, partiti, liste, movimenti), dobbiamo comunque chiederci perché facciamo fatica a farci ascoltare, perché non riusciamo a rappresentare una sinistra larga e popolare, una sinistra del lavoro, dei diritti, del vero cambiamento (non quello sventolato da Renzi) verso una società più democratica e meno liberista.
Una prima risposta, che ha radici antiche, è questa: non sappiamo stare insieme, non sappiamo unire le forze. Questa incapacità è tutta ideologica: l’idea prevale sul rapporto tra le persone, per affermarsi l’idea è disposta a camminare sulle macerie, politiche e personali.
Noi a sinistra abbiamo bisogno di sincerità e franchezza. Se siamo ancora una esigua minoranza, più come rappresentanza politica che nella società italiana, non è per colpa di Berlusconi. E come non era lui in passato il problema, oggi non lo è Renzi.
Perché il problema siamo noi, sempre divisi, sempre convinti di avere la verità in tasca e guai a chi ce la tocca. Ecco, se vogliamo diventare più grandi, più forti, ognuno di noi deve cedere un pezzo della propria sovranità. Senza questa consapevolezza non solo non si fa una sinistra nuova, ma non si tiene insieme neppure un condominio.
Sappiamo che dobbiamo confrontarci con un apparato politico e un peso notevole, quale quello rappresentato dal Pd di Renzi. Ma il suo successo potrebbe non reggere sui tempi lunghi. Anzi, i dati del tesseramento del Pd sono drammatici.
Più in generale, stiamo attraversando una fase molto difficile dal punto di vista economico. Ma adesso, come ieri, sappiamo almeno con chi abbiamo a che fare. E come vent’anni fa il berlusconismo strappò alla sinistra la parola “libertà”, oggi Renzi ha sequestrato la parola “cambiamento”.
Ogni giorno vediamo l’uso spregiudicato che ne fa. Cambia la Costituzione, cambia la giustizia, cambia il lavoro. E chi trova al suo fianco? Berlusconi. E chi canta ogni giorno la serenata al presidente del consiglio? Chi è il più accanito fan del premier? Il Giornale di Arcore che vede nel segretario del Pd il giovane cavaliere che massacra le opposizioni interne e i sindacati.
Renzi e Berlusconi fanno fatica a stare in due partiti diversi, provano a inventarsi qualche motivo di contrasto, ma proprio non ci riescono. Riforme istituzionali, giustizia, lavoro: sono d’accordo su tutto. Guardate le scene di amorosi sensi quando si incontrano in Parlamento deputati e senatori del Pd e di Forza Italia: baci, abbracci, pacche sulle spalle. Guardate le elezioni delle provincie: sono spariti i cittadini e sono comparsi i listoni con Fi e Pd uniti da un’attrazione fatale.
Dovremmo lasciare che la natura faccia il suo corso, dovremmo lasciarli liberi di unirsi in un unico partito. Ma non sarà così. E a noi spetta comunque il compito di costruire una sinistra più forte, più radicata nel territorio, più socialmente utile. Siamo convinti che possiamo darci questo obiettivo? Possiamo, Podemos, come dicono in Spagna, ma ad alcune condizioni. Smetterla di essere solo contro il nemico di turno, e metterci al lavoro per qualcosa.
Come con Berlusconi, anche con Renzi la comunicazione, la televisione, l’informazione è l’arma decisiva. Oggi è persino peggio perché il conformismo, il sostegno, l’adesione, l’applausometro verso l’alleanza tra Renzi e Berlusconi è impressionante. Almeno ai tempi di Berlusconi c’era qualche programma tv, qualche tg che criticava il padrone del vapore.
Oggi tutti i telegiornali cantano la stessa canzone. Se nei giornali a qualche direttore o a qualche fondatore, scappa di scrivere che Renzi è inaffidabile, si strilla ai poteri forti. Come se Marchionne, la finanza internazionale, le banche, Confindustria, il presidente della repubblica, l’industria di stato (e perfino la massoneria) fossero delle mammolette, come se non fossero schierati come un sol uomo con il governo Renzi-Alfano, o se preferite Poletti-Sacconi.
In questa battaglia per una sinistra rinnovata, plurale, ricca di esperienze diverse, chiara in alcuni obiettivi comuni (non bisogna essere d’accordo su tutto), noi del manifesto ci siamo. E ci saremo.
Il nostro giornale ha avuto momenti durissimi nella sua lunga storia. Ma siamo andati oltre le divisioni e siamo riusciti a superare le difficoltà. Oggi il manifesto è vivo e vegeto e spera di festeggiare la fine dell’anno con l’impresa più grande di tutte: ricomprarci la testata
Siamo convinti che le lettrici e i lettori ci aiuteranno nell’impresa, come hanno sempre fatto perché sanno che il manifesto è un bene collettivo: di quelli che lo fanno e di quelli che lo leggono, di quelli che ieri erano in piazza. Perché è un soggetto di questa sinistra, una sinistra con radici profonde, un po’ eretiche, una sinistra che non separa diritti sociali e diritti individuali, libertà e solidarietà, una sinistra fieramente dalla parte del torto soprattutto quando la ragione dei più, della maggioranza, si riconosce la trinità Renzi-Marchionne-Berlusconi.
postilla
Una riflessione sensata; domande penetranti, sulle quali bisogna riflettere e, se possibile, decidere. Rangeri scrive: dobbiamo «smetterla di essere solo contro il nemico di turno, e metterci al lavoro per qualcosa». Dobbiamo insomma metterci al lavoro per qualcosa, raccontare come noi, la nuova sinistra, vogliamo contribuire a un altro cambiamento, alternativo a quello minacciato dai nostri avversari. E allora aggiungo una domanda ulteriore: perché chi si batte per una nuova sinistra non è riuscito a valorizzare e sviluppare quel cambiamento alternativo, radicale ma non utopistico, che è proposto nei documenti fondativi della lista Altra Europa con Tsipras, e anticipata e ripresa in tanti scritti sul manifesto e su altri giornali, da promotori e protagonisti della lista come Guido Viale, Luciano Gallino, Barbara Spinelli?
Thomas Fazi intervista il politologo Kees van der Pijl: «Siamo passati da una forma di capitalismo ancora interessato ai processi di accumulazione reali ad uno puramente speculativo». Sblanciamoci, newsletter 361 del 4 ottobre 2014
Il conflitto ucraino non è solo il frutto di una crescente tensione tra Occidente e Russia. Esso riflette anche una crescente tensione interna all'Occidente, tra Stati Uniti e «vecchia Europa», in cui il tentativo dei primi di mantenere il continente saldamente assoggettato alla propria strategia economico-militare (un esempio su tutti: il fatto che l'adesione delle ex repubbliche sovietiche all'Ue è di fatto condizionale all'adesione alla Nato) si scontra con un'influenza economica e militare in declino e con la crescente ambizione di paesi come Francia e Germania di esercitare una maggiore autonomia in politica estera (ma non solo). Questo scontro, a sua volta, è l'espressione di una politica che, su entrambe le sponde dell'Atlantico, è sempre più asservita agli interessi del grande capitale, il quale ha bisogno di uno stato di «conflitto e destabilizzazione permanente» per portare a termine i suoi obiettivi: l'accaparramento di risorse e materie prime sempre più rare (all'estero) e il saccheggio della cosa pubblica (in casa). Di questo e altro abbiamo parlato con Kees Van Der Pijl, professore di relazioni internazionali all'Università del Sussex.
Professore, lei sostiene che stiamo attraversando una fase inedita del capitalismo. Quali sono le sue caratteristiche principali?
«Nel corso degli anni novanta abbiamo assistito a una serie di mutazioni molto profonde. In ambito economico siamo passati da una forma di capitalismo interessato ancora ai processi di accumulazione reali ad un capitalismo puramente speculativo ed estremamente finanziarizzato che si nutre di enormi bolle destinate inevitabilmente a scoppiare. Uno dei principali fautori di questa forma di capitalismo speculativo è stato Alan Greenspan, governatore della Federal Reserve tra il 1987 e il 2006, che difatti nel corso degli anni novanta ha inaugurato quella politica di "welfare per i ricchi" a cui abbiamo assistito in seguito alla crisi del 2007-8, in cui lo stato, per mezzo di enormi iniezioni di denaro pubblico, si fa carico di tenere in piedi e di "rimpolpare" il sistema finanziario in seguito allo scoppio di ogni bolla. Uno dei problemi del capitalismo speculativo è che tende ad arricchire solo una piccolissima percentuale della popolazione: allo scoppio di ogni bolla le classi medio-basse si impoveriscono sempre di più, mentre gli ultra-ricchi diventano sempre più ricchi. In questo senso è una forma di capitalismo che tende inevitabilmente all'oligarchia.
Lei sostiene che in questa fase è il ruolo stesso dello stato, nell'accezione liberal-democratica del termine, a venire meno e a "disintegrarsi" .
«Assolutamente. Storicamente nelle democrazie occidentali il ruolo dello stato è sempre stato quello di mediare, di trovare una coerenza tra i vari interessi economici, di classe, ecc. che attraversano la società. In un contesto sempre più oligarchico come quello in cui ci troviamo oggi, però, in cui una piccolissima minoranza detiene un potere economico spropositato, lo stato non è più in grado di mediare tra le varie "fazioni" e finisce per diventare asservita unicamente agli interessi nudi e crudi della classe dominante, che non è più obbligata a trovare un compromesso all'interno dell'arena politica. In sostanza, lo stato perde la sua coerenza e comincia a "disintegrarsi". Questo è senz'altro vero negli Usa, come dimostra l'incoerenza di Obama in politica estera. Ma è un discorso che vale anche per l'Europa, dove è sempre meno chiaro quali siano le funzioni esercitate a livello europeo e quali quelle esercitate a livello nazionale. Questo è un classico esempio di incoerenza, di cui le élite possono facilmente approfittarsi per imporre la propria visione senza dover passare per il processo democratico. Nel medio termine una politica di questo tipo ha un effetto estremamente destabilizzante per i processi democratici, e nel caso specifico dell'Europa sta portando a una serie di spinte centrifughe (Scozia, Catalogna, ecc.) che rischiano seriamente di far implodere il processo di integrazione europeo».
Lei traccia una legame tra i processi di disgregazione europea in corso e l'involuzione autoritaria dell'Ue, a sua volta - sostiene - una conseguenza inevitabile del modello di capitalismo predatorio dominante.
«Sì, il caso europeo è particolarmente preoccupante, perché assistiamo a un'involuzione autoritaria non solo a livello nazionale - poiché le élite politiche non sono più in grado di mediare tra gli interessi delle varie classi, come dicevo prima - ma anche a livello sovranazionale, in cui l'Ue è sempre più incapace di mediare tra gli interessi dei vari stati e si fa garante unicamente degli interessi degli stati dominanti e del grande capitale finanziario, assumendo dei tratti sempre più autoritari. Molto si è parlato, infatti, dell'apparato di sorveglianza estremamente pervasivo, facente capo all'Nsa statunitense, portato alla luce da Snowden. Ma la realtà è che tutti governi europei erano - e continuano senz'altro ad essere - complici del programma di sorveglianza americano. A questo poi bisogna aggiungere la crescente incapacità degli Stati Uniti di agire da "collante" e da stabilizzatore politico nel continente. Questo sta determinando una situazione in cui i cittadini si sentono sempre meno rappresentati dalle élite politiche nazionale, ma soprattutto dall'establishment politico europeo. L'acuirsi delle tendenze nazionaliste, regionaliste ed anti-europee e l'ascesa di movimenti populisti e neofascisti in tutta Europa si può in buona parte imputare a questa dinamica».
Che ruolo ha giocato la crisi economica e finanziaria in questo processo in Europa?
«La crisi del 2007-8 ha drammaticamente accelerato queste tendenze già in corso. Mascherandosi dietro al mantra delle riforme strutturali, del consolidamento fiscale, ecc., le autorità politiche europee hanno di fatto implementato una serie di politiche finalizzate unicamente a perpetuare e a rafforzare l'attuale modello di capitalismo predatorio, che sta determinando un trasferimento di ricchezza dal basso verso l'alto senza precedenti. Come dicevo prima, è un capitalismo che non punta più a rilanciare il processo di accumulazione. Il tasso di investimento è ai minimi storici. L'infrastruttura energetica di molti paesi europei è vicina al collasso. L'obbiettivo non è rimettere soldi nel sistema ma sottrarli ad esso, per esempio saccheggiando le infrastrutture pubbliche esistenti attraverso i processi di privatizzazione».
Questa forma estrema di capitalismo predatorio non rischia di mettere a rischio la tenuta stessa del sistema?
«Il processo di concentrazione di ricchezza in corso determinerà tensioni sociali e politiche che il sistema politico farà sempre più fatica a gestire. La risposta iniziale sarà un'involuzione autoritaria e repressiva sempre più forte, un fenomeno a cui stiamo assistendo anche in Europa. Ma prima o poi il sistema - e con esso il processo di integrazione europea - è destinato a implodere. Questo potrebbe avvenire per cause endogene - l'elezione di un partito anti-europeo in un grande paese europeo (la Francia è il candidato più ovvio in questo momento), il moltiplicarsi delle spinte centrifughe, ecc. - o per cause esogene, come per esempio un'altra grande crisi finanziaria, che considero inevitabile. Nel breve termine questo darà luogo a una situazione di grande instabilità. Ma nel medio termine credo che assisteremo a una profonda riforma del capitalismo, in cui le autorità politiche si vedranno costrette a riprendere in mano le redini dell'economia per frenare gli eccessi dei mercati. Di fatto assisteremo a una ripubblicizzazione e ri-democratizzazione dell'economia. E forse alla ripresa del processo di integrazione europeo su basi radicalmente diverse».
 «Per aumentare l’intensità di lavoro remunerato delle famiglie occorrono sia politiche di investimento sociale dirette ai più svantaggiati, giovani e meno giovani, sia politiche di conciliazione famiglia-lavoro: proprio quelle oggetto di drammatici tagli in periodi di austerity».
«Per aumentare l’intensità di lavoro remunerato delle famiglie occorrono sia politiche di investimento sociale dirette ai più svantaggiati, giovani e meno giovani, sia politiche di conciliazione famiglia-lavoro: proprio quelle oggetto di drammatici tagli in periodi di austerity».
Lavoce.info, 3 ottobre 2014 (m.p.r.)
Sistema troppo frammentato
In un rapido accenno nella discussione sul Jobs Act, Matteo Renzi ha annunciato una riforma complessiva del welfare. Che il welfare italiano abbia un urgente bisogno di essere riformato è indubbio, stante che si tratta di uno dei sistemi più frammentati, più pieni di buchi, più esposti a manipolazioni e imbrogli tra quelli europei. Di ambizioni di riforma si parla almeno da venti anni, dalla commissione Onofri istituita dal primo Governo Prodi, senza che se ne sia fatto nulla, salvo i ritocchi a margine, spesso dolorosissimi, varati via via dai vari Governi, che hanno ulteriormente aumentato la frammentazione e i rischi di iniquità. Le analisi e le proposte sono tante e forse, nonostante la sua idiosincrasia per gli intellettuali, non sarebbe male che Renzi e i suoi consiglieri ne prendessero atto, per evitare di inventare l’ombrello, ma anche per comprendere che il sistema di welfare è, appunto, un sistema, che deve (dovrebbe) avere una logica coerente, non un ammasso di frammenti spesso tra loro incoerenti.
La questione dei lavoratori poveri
Senza queste due misure, l’impianto del welfare che il presidente del Consiglio sembra avere in mente rischia di non aggredire la questione della povertà, che pure, specialmente quella assoluta, in questi anni è drammaticamente aumentata in Italia: nel 2013 coinvolgeva il 7,8 per cento delle famiglie e il 10 per cento degli individui, una percentuale quasi tre volte più alta di quella rilevata nel 2007. Può sembrare un giudizio paradossale. Che cosa c’è di più efficace del lavoro (remunerato) per far uscire dalla povertà? Eppure le cose non sono così semplici. In primo luogo, occorre pensare anche a chi non trova lavoro – e per questo non matura il diritto alla indennità di disoccupazione – perché la domanda è scarsa, perché non ha le qualifiche adeguate, perché ha un carico di lavoro famigliare pesante. È certo opportuno incentivare le persone ad attivarsi, a effettuare la formazione necessaria per collocarsi nel mercato del lavoro, posto che vi sia domanda. Ma, mentre cercano e si danno da fare e aspettano che la domanda di lavoro aumenti, bisognerà o no pensare a come aiutare loro e le loro famiglie a sopravvivere, specie se chi è senza lavoro è anche chi, in famiglia, sarebbe teoricamente responsabile del mantenimento?
Riferimenti bibliografici
Cantillon B. e F. Vandenbrouke (eds), Reconciling work and poverty reduction, Oxford, Oxford University Press, 2014
 Di grande attualità il libro
Di grande attualità il libro
I Signori delle autostrade di Giorgio Ragazzi, edizioni Il Mulino, 2008 di cui avevamo già pubblicato alcuni brani all'esordio. Ora riprendiamo la prefazione di Anna Donati.
Questo libro curato dal prof. Giorgio Ragazzi ricostruisce la storia delle concessionarie autostradali dagli anni ’20 ad oggi in Italia. E’ un libro utile perchè mette in luce con rigore e ricchezza di documentazione una storia mai scritta delle regole, dei sussidi, investimenti, tariffe, durata delle concessioni, che hanno determinato il rapporto tra la Stato e le concessionarie autostradali, pubbliche o private che fossero.
Un rapporto che ha subito molte evoluzioni, partendo dalle prime e limitate concessionarie private degli anni ‘20, alla massiccia estensione della rete con le concessionarie pubbliche degli anni ‘60, fino ad arrivare alle privatizzazioni degli anni ’90, del 78% della rete lunga ormai 6840 km. Una ricostruzione che non tralascia i rilevanti ed irrisolti problemi di regolazione oggi più aperti che mai, oggetto di recenti interventi normativi, che alimentano il dibattito politico e le polemiche tra i diversi soggetti in campo e che proseguiranno di certo nei prossimi anni.
Lo studio dimostra che essendo le concessionarie inizialmente prevalentemente pubbliche, dell’IRI o di enti locali, Ministri ed Anas “sono state sempre molto benevoli nel loro confronti, alle spalle degli utenti” perché in fondo si trattava pur sempre di interesse pubblico.
Ma quando arrivano alla fine degli anni ’90 le privatizzazioni questo atteggiamento non cambia, anzi con la vendita della Società Autostrade si innesta una vera e propria “cuccagna” di cui hanno beneficiato anche gli azionisti privati. Scrive Giorgio Ragazzi che è stato «l’obiettivo di massimizzarne il valore che ha indotto alla proroga generalizzata delle concessioni alla fine degli anni 90 ed all’introduzione di un price cap particolarmente favorevole per le concessionarie, per non parlare delle clausole privilegiate inserite nella convenzione di Autostrade».
E’ andata proprio cosi. Il primo Governo Prodi ha intrapreso la strada della privatizzazione per l’urgenza di fare cassa senza adottare preventivamente norme stringenti di regolazione del settore capaci di tutelare in modo adeguato l’interesse generale, per determinare tariffe e profitti delle concessionarie senza essere “catturato” da interessi privati, da interessi locali e da interessi politici.
Per la verità fin dalle nuove norme del 1992, il Cipe ha emanato diverse direttive per costruire un quadro regolatorio del settore, arrivando alla direttiva interministeriale Ciampi-Costa del 1998, che ha fissato regole innovative e stringenti. Regole che poi, come ben ricostruisce il libro, non sono state applicate se non in modo assai elastico e comunque sempre favorevole alle concessionarie autostradali.
Quando cinque anni dopo, alla prima verifica, sono risultati evidenti l’andamento positivo degli utili e degli extraprofitti, gli aumenti tariffari ed i mancati investimenti, invece di riequilibrare e regolare, il Governo Berlusconi ha nuovamente assecondato le concessionarie. E per evitare le esortazioni a cambiare rotta del Nars, dell’Autorità Antitrust e della Corte dei Conti, è stata approvata con legge in Parlamento la nuova Convenzione di Autostrade per l’Italia, con un emendamento del Governo in un decreto legge in scadenza.
Solo nel 2006, su proposta del secondo Governo Prodi, il Parlamento ha approvato nuove norme di regolazione delle concessionarie autostradali che stabilivano che allo scadere dei piani economico-finanziari e comunque entro un anno tutte le convenzioni dovevano essere riscritte per meglio tutelare l’interesse pubblico. Un autentico e positivo cambio di rotta, che però non ha completamente retto all’offensiva delle concessionarie: contestazioni dalla Commissione Europea e delibere Cipe di attuazione che nel giro di sei mesi hanno limitato drasticamente il campo di applicazione solo a nuovi investimenti.
Ma appena insediato, nel giugno 2008, il nuovo Governo Berlusconi ha già annientato questa riforma delle concessionarie autostradali. Con un semplice emendamento ad un Decreto Legge approvato dal Parlamento, ha modificato le norme ed approvato per “legge” tutte le nuove convenzioni già sottoscritte tra Anas e concessionarie. Un’approvazione “per legge” che elimina il parere del Nars, del Cipe e del Parlamento, che avevano osato avanzare obiezioni e richiesto maggiori garanzie e controlli per l’interesse pubblico nelle nuove convenzioni.
Chi trarrà ì maggiori benefici da questa automatica approvazione è certamente Autostrade per l’Italia, la concessionaria che fa capo al gruppo Benetton, che si vedrà riconoscere aumenti tariffari di almeno il 70% dell’inflazione reale, da sommare a parametri di remunerazione degli investimenti, per tutta la durata della concessione fino al 2038.
Via dunque il price cap, la qualità del servizio, la tutela dei consumatori e la realizzazione degli investimenti correlati alla tariffa: una autentica controriforma a solo vantaggio delle concessionarie e che ridimensiona gli strumenti di controllo e regolazione dello Stato nel settore autostradale, già debolissimi.
Ma proprio questo libro dimostra senza equivoci che nuove regole servono e che devono essere applicate con rigore e senza discrezionalità a tutte le concessionarie, così come devono essere fermate le ulteriori proroghe delle concessionarie, in coerenza con le direttive europee, per evitare il perpetuarsi di limitazioni della concorrenza e del mercato. Del resto i tempi lunghi delle durata di molte concessionarie ( la Società Autostrade per l’Italia scade nel 2038) condizionano evidentemente il futuro del settore.
C’è quindi molta strada da fare per passare dal vecchio sistema di concessioni pubbliche ad un nuovo quadro di regole eque e trasparenti tra Stato ed imprese private. Un capitolo di questo volume contiene riflessioni e proposte per il confronto sul futuro delle concessionarie in Italia.
Prima di tutto, dovrebbe essere istituita una Autorità dei Trasporti, prevista ormai da10 anni, per attuare il sistema di regolazione nelle concessionarie ( e non solo quelle autostradali), così come è avvenuto con successo nel campo dell’Energia e delle Comunicazioni. Strumento di regolazione e di tutela degli utenti indispensabile per evitare che la discrezionalità, le pressioni indebite sulla politica o della politica o peggio ancora quelle clientelari abbiano la meglio. E che attui naturalmente gli indirizzi strategici e le regole adottate dalle scelte politiche.
Secondo, va ridefinito il ruolo dell’Anas come soggetto gestore, oggi invece concedente e regolatore, a volte concessionario, a volte in società miste od in competizione con le stesse concessionarie autostradali.
Terzo, bisogna fare una accurata riflessione sul ruolo odierno delle autostrade nel campo della mobilità e dei trasporti, che non possono essere prolungate e raddoppiate all’infinito come i piani delle Concessionarie chiedono costantemente di fare, in un circolo vizioso di nuovi investimenti per ottenere nuove proroghe. Le autostrade nate per la lunga distanza, per accorciare l’Italia, sono oggi diventate le reti per il trasporto quotidiano di breve e media distanza, ma ugualmente si ripropongono grandi autostrade di transito con sistemi chiusi a casello, indifferenti al territorio da servire. Qui serve una forte innovazione di prodotto, con infrastrutture intelligenti, con sistemi aperti e fortemente connessi con la rete locale, con sistemi di pagamento telematici, oggi possibili con le nuove tecnologie.
Quarto, serve riprendere il suggerimento dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, riproposto anche nel presente volume, di inserire l’uso del pedaggio come uno strumento di politica dei trasporti e di finanziamento delle infrastrutture sostenibili, che implica quindi la necessità di rescindere il legame stringente ed esclusivo oggi esistente tra pedaggi pagati dagli utenti, ricavi delle concessionarie, ed investimenti sulla stessa rete autostradale. Discorso assai complesso e di non facile attuazione ma in fondo l’accantonamento della società Autobrennero per gli investimenti ferroviari o l’applicazione in Italia della direttiva Eurovignette che dovremo adottare entro un anno per la tassazione del traffico pesante, vanno esattamente in questa direzione.
Per queste ragioni il libro di Giorgio Ragazzi è utile, perché anche in questo campo, solo capendo la nostra storia passata e recente, possiamo guardare responsabilmente al futuro.
12 giugno 2008
Segnalazioni
Qui alcune pagine del libro I Signori delle autostrade.
Sulle questioni inerenti le autostrade del decreto Sblocca Italia si vedano su eddiburg:
di Tito Boeri Autostrade e Fondazioni, i due veri poteri forti, di Ivan Berni Le autostrade verso il nulla non sono il futuro, di Giorgio Ragazzi Per le autostrade la fine della concessione non arriva mai Autostrade dalle concessioni infinite, di Sergio Rizzo La lobby delle società autostradali trova lo svincolo per saltare le gare. Nei nostri archivi altri documenti facilmente raggiungibili con il cerca
 Intervista di Daniela Preziosi,a un dirigente politico della sinistra che sta meditando ancora sulle sue scelte.
Intervista di Daniela Preziosi,a un dirigente politico della sinistra che sta meditando ancora sulle sue scelte.
Il manifesto, 3 ottobre 2014. con postilla
L'appello. Nichi Vendola chiama il Pd e la sinistra diffusa: Renzi svolta a destra, lavoriamo tutti insieme. «Il premier a un giro di boa, la nouvelle vague renziana è più a destra di Sacconi. Chiedo a chi fa la battaglia sull’art.18: questa volta andate fino in fondo. Sel non starà in prima fila ma accanto agli altri. La lista Tsipras? Una semina»
Quello di Renzi è «un governo conservatore che spara un colpo alla nuca di ciò che resta della civiltà del lavoro». Nichi Vendola pesca a piene mani dal suo canestro di parole perché, spiega, «siamo arrivati a un punto di svolta», «il dibattito sull’art. 18 è una linea di demarcazione che riguarda identità, orgoglio e senso stesso della parola sinistra. Quando la sinistra diventa asociale è meglio chiamarla destra». Lancerà questa proposta alla manifestazione di domani a Roma. In mattinata la formalizzerà alla direzione del partito: «Mettiamo Sel a disposizione, come uno strumento, un lievito, un terreno di incontro per una parte del Pd, i movimenti, le associazioni della sinistra diffusa e del sindacato»,per combattere insieme l’agenda economica del governo Renzi. Con il manifesto Vendola è ancora più esplicito: è «l’inizio di un percorso con un futuro più lungo» e la richiesta «a tutti di fare una battaglia vera, di portarla fino in fondo».
Vendola, prepara un nuovo big bang a sinistra?
La mia proposta è lavorare per una coalizione dei diritti e del lavoro, che abbia la capacità di rendere sempre più stretto il legame fra i diritti sociali e i diritti civili.
È un invito alla sinistra Pd a uscire dal partito? Tutti, o quasi, hanno già detto che saranno fedeli ’alla ditta’, per dirla con Bersani.
Bersani sta facendo la sua lotta politica nel suo partito. Da altre parti si legge anche altro. Non intendo interferire nelle questioni interne al Pd, ma mi rivolgo a tutti quelli che sanno che siamo a un giro di boa della storia e della cultura di questo paese. Propongo di costruire qualcosa di nuovo, non di assembleare le schegge sconfitte della sinistra.
Allora è un invito a Pippo Civati, che sarà sul palco con lei?Tutti coloro che dal Pd muovono una critica radicale al renzismo e alla deriva a destra di questo governo sono interlocutori preziosi. Propongo loro di lavorare insieme, anche da diverse postazioni. Non li voglio iscrivere a Sel, metto a disposizione Sel per costruire qualcos’altro. Sel non vuole stare in prima fila, ma accanto a tutti coloro che si sentono impegnati in un processo indispensabile al paese, non al ceto politico.
Concretamente questa ’coalizione’ cosa farà?
Intanto il 4 ottobre facciamo un’iniziativa insieme, con persone diverse, proprio perché nella sinistra ci sono tante cose, tante idee, tante testimonianze. Hanno il difetto di essere sparpagliate, frammentate, a volte in sonno da troppo tempo. Si tratta di riaggregarle in un progetto che non abbia nessuna torsione minoritaria e testimoniale, lontano dalla trappola per cui o c’è il governismo o c’è il minoritarismo. Rimettiamo in campo le forze che parlino il linguaggio di una sinistra moderna, che non si sente custode di nessuna ortodossia ma che sia protagonista di un cambiamento.
’Cambiare’ è un verbo renziano, ormai.
Dobbiamo liberare questa e altre parole dalla retorica mistificante del renzismo. Mando una lettera a Renzi: “Caro Matteo, c’era un tempo in cui quando si diceva ’riforma’ si parlava di qualcosa che migliorava le vite: pensa al diritto di famiglia, alla riforma sanitaria, a quella psichiatrica. Oggi quando si evoca la parola riforma si parla sempre e solo di qualcosa che ti spoglia di un diritto”.
Renzi promette che il jobs act darà diritti e tutele a chi non li ha.
Renzi dice tutto e il contrario di tutto, è un caleidoscopio di slogan. Sta con Hollande ma anche con Cameron. Dice a Merkel ’non trattarci come scolaretti’ ma poi come uno scolaretto dice ’rispetteremo il 3 per cento’.
Parlava delle «schegge sconfitte della sinistra». Si riferisce alla Lista Tsipras? Vi sentite ancora impegnati in quel percorso?
Credo che quell’esperienza sia stata positiva dal punto di vista della mobilitazione e delle energie, soprattutto quelle giovanili. È stato un segnale di cambiamento. Ha corrisposto a un sentimento e a un bisogno che c’era in una parte dell’elettorato. Purtroppo la sua seconda vicenda, quella dopo il voto, non mi pare che brilli. Neanche dal punto di vista di come marca la scena del parlamento europeo. Ma continuo a considerare quell’esperienza un’importante semina per la sinistra.
Alla riunione della direzione del Pd D’Alema ha quasi rivendicato il referendum per allargare dell’art.18. Era il 2003, gli allora Ds — come lui — fecero campagna contro. Che impressione le fa?
Io ho partecipato a quella campagna per estendere le tutele a tutti. E ancora oggi penso che nonostante non si sia superato il quorum, il dato dei voti — quegli 11 milioni per il sì — resta la più grande consultazione di massa, imparagonabile a un sondaggio pilotato o a un’attività di marketing e propaganda. Fu un responso straordinario, l’espressione di un diffuso sentimento di giustizia sociale. Forse la odierna devastante scena di intere generazioni di precari consente anche a D’Alema un utile ripensamento. Quando poi sento gli esponenti della nouvelle vague Pd parlare di art.18 come di un privilegio, rabbrividisco. Licenziamento senza giusta causa, quello che Renzi chiama «libertà degli imprenditori», vuol dire licenziare uno perché ha il cancro, o è gay, una donna perché è incinta. Il privilegio semmai è l’esercizio arbitrario di un potere. La nouvelle vague Pd culturalmente sta più a destra di Sacconi, il peggior ministro berlusconiano.
Sacconi lamenta che sull’art.18 il jobs act ora è troppo timido.
I diversamente berlusconiani battono un colpo per ricordare che sono un fondamento di questa maggioranza. E lo sono davvero. Anche il cronoprogramma dei mille giorni è scandito dalla destra: all’inizio c’è un colpo al cuore dei diritti sociali, in coda forse forse arriverà una parvenza di diritti civili.
Al senato Sel ha presentato oltre 300 emendamenti sulla legge delega. Farete ostruzionismo?
Lo decideranno i nostri senatori. Io mi auguro di sì.
Fra qualche mese lascerà la presidenza della Puglia. C’è chi parla di un passo indietro, c’è chi dice che ha in testa di trasferirsi in Canada, patria del suo Eddy. Cosa farà davvero?
Farò il leader di Sel finché i miei compagni e le mie compagne me lo faranno fare. Ma non lo intendo come un incarico a vita. Quanto al Canada, è nel mio cuore, ma viverci è in contraddizione con la mia antropologia: sono una creatura mediterranea e ho bisogno del caldo e del mare.
Renzi vuole spianare la sinistra interna al Pd, e quasi quasi ce l’ha fatta. Spianerà anche voi?
postilla
Plagiando Eugenio Montale abbiamo dedicato tre versi ai compagni che restano nel PMR. Li ripetiamo, mutatis mutandis, a Nichi Vendola:
«non so come stremato tu resisti
in questa palude di finanzcapitaliamo
Chi comanda l'Italia oggi non è né re né principe, né duca né marchese, e neppure barone: è solo un baro. Ecco perchè Il manifesto, 1 ottobre 2014
La Repubblica, 2 ottobre 2014
Che l’episodio più clamoroso si sia consumato proprio in provincia di Taranto, una città messa in ginocchio dai compromessi della politica, è forse emblematico, forse casuale. Ma dice molto su una riforma che doveva condurre all’abolizione delle province in Italia, e che in alcuni casi ha invece portato a listoni pigliatutto all’insegna delle larghe intese.
Per fare tutto questo, a Taranto, Vibo Valentia, Ferrara, Genova, Torino, i partiti si sono lasciati andare ad intese che da larghe sono diventate larghissime. In realtà - ufficialmente - nella città dell’Ilva il listone non c’è stato. Centrosinistra e centrodestra erano concorrenti, perché l’accordo cui stavano lavorando il deputato democratico pugliese Michele Pelillo e il consigliere regionale Michele Mazzarano (già indagato per aver avuto a che fare con Giampaolo Tarantini) a sostegno del sindaco forzista di Massafra Martino Tamburrano, era saltato in un tormentato congresso straordinario del Pd locale in cui il segretario regionale Michele Emiliano aveva giurato che mai avrebbe appoggiato alcun inciucio. I democratici avevano quindi candidato il sindaco di Laterza Gianfranco Lopane, tradito però nel segreto dell’urna. A vincere alla fine è stato infatti Tamburrano, nonostante sulla carta la maggioranza fosse tutta a sinistra. Perché gran parte del Pd lo ha votato. E perché quella che è in corso è una battaglia durissima, con lo sfidante di Emiliano alle primarie regionali Guglielmo Minervini che accusa il suo avversario di aver fatto «un inciucio di dimensioni massicce e organizzate». Ovvero, di tramare sottobanco per avere più consensi possibili in vista delle regionali.
È andata molto più tranquillamente a Ferrara per quello che è stato definito «il patto dei cappellacci ». A vincere è stata infatti la lista che aveva come candidato presidente il sindaco della città estense Tiziano Tagliani, e che teneva dentro Pd, Forza Italia, Lega e perfino 5 stelle con il sindaco di Comacchio Marco Fabbri. Quest’ultimo non avrebbe dovuto correre (Grillo lo aveva vietato impedendo una lista unitaria anche al sindaco di Parma Pizzarotti), ma non ha obbedito, ed è perfino risultato il secondo degli eletti (i consiglieri 5 stelle che avevano annunciato l’astensione devono aver cambiato idea all’ultimo momento). Per ora non risponde a chi gli chiede se non abbia paura di essere cacciato dal Movimento, si limita sommessamente a far notare che era una regola un po’ strana, quella che impediva di correre in provincia e lo rendeva possibile invece nelle città metropolitane (ci sono un eletto 5 stelle a Bologna e uno a Firenze).
Altrettanto serena la grande intesa di Genova, dove - addirittura - il sindaco Marco Doria (destinato a guidare la città metropolitana) ha fatto correre la sua lista insieme a Forza Italia, Pd e Nuovo centrodestra, dimostrando che anche Sel, in alcuni casi, è pronta a fare strappi alla regola. Mentre è corso più veleno a sud, nella provincia di Vibo Valentia, dove si sono spaccati un po’ tutti con richieste incrociate di dimissioni e accuse reciproche di candidature poco pulite. A vincere è stata la lista “Insieme per la Provincia di Vibo Valentia Adesso” (detta “l’accorduni”), che vedeva i renziani del Pd con esponenti del Nuovo Centrodestra, Forza Italia e Fratelli d’Italia.
Il prossimo 12 ottobre toccherà a Torino, dove il Pd ha fatto un accordo con Forza Italia, Nuovo Centrodestra e Moderati. L’hanno chiamato «patto costituente » in vista della nascita della città metropolitana, lo hanno fatto - spiegano i democratici - per poter rappresentare meglio il territorio, visto che col meccanismo del voto ponderato il capoluogo rischiava di schiacciare realtà come Ivrea o la Valsusa. Il capogruppo di Sel in comune Michele Curto però la racconta diversamente: «I motivi sono solo due. Piero Fassino vuole scegliersi i suoi 18 consiglieri, e l’attrazione delle larghe intese è stata irresistibile».
La Repubblica, 29 settembre 2014
Matteo Renzi ha dichiarato guerra ai “poteri forti”. Alla domanda di un giornalista che gli chiedeva in cosa consistessero i poteri forti, e cosa intendesse fare, il nostro premier ha preferito glissare. Non sappiamo perciò cosa abbia in mente, oltre forse il sindacato e la battaglia sull’articolo 18. Vorremmo allora suggerirgli due poteri davvero forti che può fortemente ridimensionare senza bisogno di alcun passaggio parlamentare. Gli basterà utilizzare la forza datagli dal voto delle primarie e dal voto europeo.
 L'intervento con il quale l'europarlamentare del gruppo della sinistra europea replica all'intervento del sottosegretario Gozi esprimendo il proprio dissenso in particolare per la fine di Mare Nostrum. Bruxelles,
L'intervento con il quale l'europarlamentare del gruppo della sinistra europea replica all'intervento del sottosegretario Gozi esprimendo il proprio dissenso in particolare per la fine di Mare Nostrum. Bruxelles,
Listatsipras.eu, 24 settembre 2014
Ringrazio il sottosegretario Gozi per il suo intervento, e mi limito a riassumere in tre punti il mio dissenso.
Primo punto: l’immigrazione, che con l’estendersi delle guerre attorno a noi assumerà aspetti sempre più drammatici. Lei ha parlato di “phasing out” dell’operazione Mare Nostrum, che a parere dei maggiori esperti nell’Unione europea ha salvato un gran numero di profughi a rischio naufragio. Consiglierei di non usare parole inglesi ma italiane, e di dire a chiare lettere che di altro si tratta. Si tratta della “fine” di Mare Nostrum, dal momento che nessun’operazione è prevista che sia veramente sostitutiva, e che si occupi dell’essenziale: cioè di cercare e salvare i migranti in fuga (search and rescue). Frontex Plus ha un’altra missione – ormai è chiaro a tutti – e nemmeno sappiamo se potrà disporre di risorse adeguate e quali saranno gli Stati che contribuiranno.
Secondo punto: a proposito della Conferenza sull’occupazione dell’8 ottobre, confermata dal sottosegretario, vorrei citare le sue stesse parole. La conferenza non si occuperà tanto della disoccupazione dei giovani, quanto dell’”ambiente economico e sociale, in modo tale da garantire le riforme strutturali”. Siccome sappiamo quel che significano ai tempi d’oggi le riforme strutturali – riduzione della spesa e degli investimenti pubblici, restrizione dei diritti nella gestione del mercato del lavoro – ne deduco che la Conferenza di ottobre si occuperà in linea prioritaria del piano sul lavoro del governo Renzi più che di vera crescita e veri investimenti, in continuità sostanziale con la politica del rigore e dell’austerità chiesta dalle attuali autorità europee.
Terzo punto: il sottosegretario Gozi ha sostenuto che “si ritrova pienamente” nella scelta della nuova Commissione di Jean-Claude Juncker. Al tempo stesso, ha ricordato che la “difesa della legalità” è, per la presidenza italiana, un tema “centrale”. Le due affermazioni sono quantomeno contraddittorie. Se davvero il governo Renzi “si ritrova” nella Commissione appena designata, non vedo come possa accettare un esecutivo che annovera due membri con forti conflitti di interesse, come Arias Cañete e Jonathan Hill, un commissario come Alenka Bratušek, autocandidatasi utilizzando il suo ruolo di ex Premier in Slovenia, e – non per ultimo – il commissario Tibor Navracsics, noto in Ungheria per essere l’uomo di fiducia di Viktor Orbán, il premier che nel luglio scorso ha attaccato, senza mai smentirsi, i principi della democrazia liberale su cui l’Unione europea è fondata.
x
Eddyburg non si occupa solo di quello che succede ogni giorno. Però siamo distratti, e il tempo collettivo che possiamo dedicare a eddyburg non è tutto quello che sarebbe necessario. Perciò molte cose dell’oggi ci sfuggono. Ma la serendipity ci aiuta. Così troviamo oggi cose che ci sarebbe piaciuto scoprire e segnalare ieri: lo facciamo oggi, chiedendo scusa ai frequentatori troppo esigenti
IO, TU E L'UMANITA'
In un Paese imbarbarito dalla crisi economica, dalla iniqua ripartizione delle risorse e dall’esclusione di masse giovanili dal mercato del lavoro, si avverte più che mai il bisogno di un investimento nella cultura come strumento di maturazione e di crescita morale e intellettuale: si pensi all’importanza della scuola pubblica, dove i figli degli immigrati si incontrano ormai normalmente coi figli degli italiani di antica data. è specialmente qui che ci sarebbe bisogno di una decisa politica di investimenti perché questo è il luogo proprio della educazione alla conoscenza e al rispetto delle diversità. La cronaca quotidiana ci mette davanti di continuo a episodi di intolleranza e a nuove forme di razzismo. Ci sono le figure tradizionali dell’alterità negativa – l’ebreo, il negro, lo zingaro – ma ce ne sono di nuove. L’Europa intera ne è vittima: è noto il caso dell’Ungheria e adesso allarma la vicenda della Francia dove il movimento di destra xenofobo sta diventando maggioritario. La condizione di povertà oggi stimola gli stessi atteggiamenti di rifiuto e di disprezzo riservati tradizionalmente alle “razze” inferiori. Ma come è nato e che cosa è il razzismo e quali fondamenti ha nella storia naturale della specie umana? Su questo tema è concentrato il dialogo di Daniela Padoan con Luca Cavalli Sforza in un libro appena uscito da Einaudi, Razzismo e noismo. Le declinazioni del noi e l’esclusione dell’altro. Al notissimo studioso che ha indagato la storia dell’origine della specie umana e delle migrazioni di popoli, Daniela Padoan pone domande che lo portano non solo a ripercorrere le acquisizioni della sua ricerca ma anche a riflessioni sugli esiti tragici della storia del dominio europeo. Esiti riassunti in una sola parola: Auschwitz, «l’immenso laboratorio dell’umano», come lo definì Primo Levi. Ripercorrere il passato risalendo alla formazione del primo nucleo umano. è qui che l’umanità nasce nel segno dell’incontro tra l’io e il tu, con la formazione della “coppia generativa”, primo nucleo della creazione di gruppi sociali, cioè del “noi”. Circa 6 milioni di anni fa, in Africa, con la separazione dei primi nostri antenati dallo scimpanzé. E da lì, circa due milioni e mezzo di anni fa, cominciò l’avanzata esplorativa verso il resto del mondo da parte di un essere umano che aveva imparato a camminare eretto e a usare utensili. Questa storia è dominata dall’aspetto positivo di quello che Cavalli Sforza ha chiamato il “noismo”, come capacità di collaborazione tra l’io e gli altri. Ma Padoan gli ricorda che c’è anche un lato negativo del “noismo”, quella volontà di affermazione di un gruppo a esclusione degli altri che ha portato all’emergere dell’uomo bianco europeo. Un percorso che se vede da un lato le affermazioni trionfali del sapere e del potere maschile europeo, dall’altro affonda nella notte dello schiavismo, dell’infanticidio, della trasformazione dello straniero in nemico, fino ad arrivare al discorso di Himmler sulla “penosa necessità” di eliminare non solo gli ebrei maschi ma anche le loro donne e i bambini. Impossibile riassumere la ricchezza del libro: ma ricordiamo la conclusione di Cavalli Sforza. La condizione per pensare positivamente al futuro è quella di guardare con occhi diversi al passato: per esempio alla cultura dei pigmei, prediletti da Cavalli Sforza, che pensa che quel popolo, benché a rischio di sopravvivenza, possegga il segreto del vivere in armonia, dell’assenza di aggressività e sopraffazioni e della capacità di risolvere pacificamente ogni crisi di convivenza.