

 «Di mafia, insistono i magistrati, si deve parlare, perché nella "Mafia Capitale" era stato adottato il metodo mafioso, consistente nell’uso "della forza d’intimidazione del vincolo associativo" e nelle "condizioni di assoggettamento e di omertà di cui gli associati si avvalgono».
«Di mafia, insistono i magistrati, si deve parlare, perché nella "Mafia Capitale" era stato adottato il metodo mafioso, consistente nell’uso "della forza d’intimidazione del vincolo associativo" e nelle "condizioni di assoggettamento e di omertà di cui gli associati si avvalgono».
Il manifesto, 3 dicembre 20014 (m.p.r.)
Gli arrestati sono 37, gli indagati 40, ma il conto potrebbe lievitare ulteriormente nei prossimi giorni. Sono nomi pesanti, sia quelli del «mondo di sopra», a partire dall’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, indagato, sia quelli del «mondo di sotto», il sottobosco criminale della capitale, del quale fanno parte Massimo Carminati, arrestato, e Gennaro Mokbel, per il quale la gip Flavia Costantini non ha convalidato la richiesta di arresto.
Il copyright delle definizioni di cui sopra, il «mondo di sopra» e quello di «sotto», è dello stesso Carminati. Le aveva usate nel corso di una conversazione intercettata che ha dato il nome all’inchiesta: «Mondo di Mezzo». Quello in cui si incontrano i colletti bianchi, gli uomini del potere a Roma, e i malavitosi che si sono fatti le ossa sulla strada, sulla piazza già ai tempi lontani della banda della Magliana. Tra i primi ci sono l’ex sindaco Alemanno, il suo capo della segreteria Antonio Lucarelli, Luca Gramazio, ex consigliere comunale e oggi regionale, Luca Odevaine, ex capo della segreteria del sindaco Veltroni, oggi responsabile dell’accoglienza per i richiedenti asilo, Franco Panzironi, ex ad dell’Ama, l’azienda dei rifiuti, Riccardo Mancini, ex ad di Eur spa, i “colletti bianchi” dell’era Alemanno. Tra i secondi lo stesso Carminati, indicato dagli inquirenti come capo dell’organizzazione, Ernesto Diotallevi, un pezzo da novanta della criminalità romana da decenni, Giovanni De Carlo, suo erede, il già ricordato Mokbel.
A tutti è contestata l’associazione mafiosa ex 416bis. Un’imputazione discutibile, e gli stessi inquirenti se ne rendono probabilmente conto, tanto che nell’ordinanza di arresto dissertano a lungo e dottamente per giustificare l’addebito. Agli arrestati e agli indagati, ha chiarito il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone, non vengono accreditati rapporti di complicità con la criminalità organizzata, con mafia, camorra e ‘ndrangheta. Neppure la struttura organizzativa è davvero affine a quelle mafiose, impossibile farlo in una città come Roma dove l’organizzazione deve invece essere «reticolare», meno disciplinata e verticistica, e l’uso della violenza è limitato.
Di mafia, insistono tuttavia i magistrati, si deve ugualmente parlare, perché in quella che viene definita «Mafia Capitale» era stato adottato il metodo mafioso, consistente nell’uso «della forza d’intimidazione del vincolo associativo» e nelle «condizioni di assoggettamento e di omertà di cui gli associati si avvalgono». Il dna propriamente mafioso sarebbe poi garantito dal fatto che, a differenza delle cosiddette «nuove mafie», l’autorità e la capacità di intimidazione del gruppo sarebbero radicati nel passato, nella derivazione dei suoi capi dalla Banda della Magliana e dai «fasciocriminali». Sin dalla notizia degli arresti, ieri, si è parlato di «criminalità nera», in parte perché capo della banda sarebbe appunto «il Nero», come Gianfranco De Cataldo aveva ribattezzato nel suo fortunatissimo Romanzo criminale Massimo Carminati. Ieri tutti i media, riprendendo del resto l’ordinanza, lo hanno definito «ex Nar». Per la verità dei Nar Carminati non ha mai fatto parte, ma neofascista e amico sia di molti militanti dei Nar, oltre che vicinissimo alla Magliana, lo era davvero.
In realtà nell’inchiesta sono coinvolti un po’ tutti: ci sono ex brigatisti come Emanuela Bugitti, esponenti di spicco di An e poi del Pdl. Ma anche del Pd come Odevaine, il presidente dell’assemblea capitolina Mirko Coratti e l’assessore alla casa Daniele Ozzimo (questi ultimi due si sono dimessi dicendosi estranei ai fatti) e il consigliere regionale Eugenio Patanè.
Lo stesso Buzzi, presidente della potentissima cooperativa «29 giugno», l’uomo che dalle indagini risulterebbe il principale complice di Carminati, è un ex detenuto comune politicizzatosi in carcere, ma sul fronte sinistro. Una banda più arcobaleno che nera, da questo punto di vista. Invece l’etichetta nera funziona lo stesso: il momento di snodo, quello che avrebbe permesso al gruppo di spiccare il volo, sono stati gli anni dell’amministrazione Alemanno. Che Carminati e complici abbiano approfittato della ghiotta occasione offerta dalla collocazione in posizione di vertice, in quegli anni, di parecchi esponenti della destra neofascista anni ’70 e ’80, come gli stessi manager Mancini e Panzironi, appare evidente. Per questo Pignatone ha dichiarato senza perifrasi che «alcuni uomini vicini all’ex sindaco Alemanno sono componenti a pieno titolo dell’organizzazione mafiosa». Però ha anche aggiunto che «con la nuova amministrazione il rapporto è cambiato, ma Carminati e Buzzi erano tranquilli chiunque vincesse le elezioni».
Nello specifico, i reati contestati a vario titolo agli indagati sono di diverso tipo. Tra gli altri, estorsione, corruzione, turbativa d’asta, false fatturazioni, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio. Ci sono crimini tipicamente «di strada», come l’usura e il recupero crediti con le cattive. Ci sono faccende di sapore squisitamente tangentaro, come l’indirizzo degli appalti in cambio di tangenti ma anche verso aziende direttamente controllate dall’organizzazione, anche attraverso i classici «prestanome». Le due fasi sembrano però cronologicamente distinte. Partito dall’usura e dai pestaggi per recuperare i crediti, spesso in conto terzi e solo per confermare la propria autorità, il gruppo sembra aver poi aver immensamente ampliato il suo spettro d’azione entrando alla grande nel giro degli appalti di ogni tipo proprio in virtù degli antichi vincoli politici con molte figure chiave dell’amministrazione Alemanno, per poi stringere nuovi e reciprocamente proficui rapporti con i loro successori ai vertici del potere capitolino.
 «Cosa sarà veramente EXPO2015? Innanzitutto 1.000 ettari di suolo agricolo già cementificati: padiglioni, piazzette tematiche, raccordi autostradali e rotonde. Nutrire il pianeta… colando calcestruzzo e stendendo asfalto su terre fertili. Tutto cemento che paghiamo noi».
«Cosa sarà veramente EXPO2015? Innanzitutto 1.000 ettari di suolo agricolo già cementificati: padiglioni, piazzette tematiche, raccordi autostradali e rotonde. Nutrire il pianeta… colando calcestruzzo e stendendo asfalto su terre fertili. Tutto cemento che paghiamo noi».
Il Fatto Quotidiano, 1 dicembre 2014
Sulle reti Rai sono finalmente partiti gli spot di presentazione di EXPO, l’esposizione universale che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015. Tema centrale: il cibo. Lo slogan: nutrire il pianeta, energia per la vita.
Le immagini, i suoni, le suggestioni proposte ai telespettatori in pochi secondi sono coinvolgenti. Un ottimo messaggio, degno di una brillante forza politica ecologista. In pochi frame si diffondono impulsi e stimoli sulla necessità di cambiare paradigma: tutelare le risorse naturali, preservarle per le prossime generazioni, garantire a ciascun abitante del pianeta il diritto al cibo pulito e a buon mercato. Questo è quello che milioni di telespettatori guarderanno dai tinelli in formica e dalle sale da pranzo in noce di tutto il Paese. Gli spot saranno sempre di più. Un crescendo rossiniano pervaderà l’immaginario collettivo italiano e convincerà tutti che a Milano andrà in scena un evento straordinario dove l’agricoltura, l’alimentazione sana, il paesaggio e il territorio saranno al centro dei pensieri della politica. Parallelamente sono già diffuse da tempo altre belle favole: quelle che raccontano di benefici sull’economia e di migliaia di posti di lavoro che gemmeranno dal grande evento vetrina.
Ma che cos’è e che cosa sarà veramente EXPO2015? Innanzitutto sono 1.000 ettari di suolo agricolo già cementificati: padiglioni, piazzette tematiche, raccordi autostradali e rotonde. Nutrire il pianeta… colando calcestruzzo e stendendo asfalto su terre fertili. Tutto cemento che paghiamo noi.
Nei padiglioni di EXPO troveranno spazio le multinazionali dell’agroindustria e degli OGM, i soggetti che dominano sulle terre di tutta la terra, che strozzano i piccoli produttori ingabbiati nella filiera della grande distribuzione organizzata, che spesso sottraggono la terra stessa alle popolazioni dei paesi più poveri del mondo.
Lo sponsor ufficiale dell’acqua, altro elemento indispensabile per nutrire il pianeta? Nel paese che ha visto 27 milioni di elettori dire no alla privatizzazione del servizio idrico, tutti si sarebbero aspettati la “Pisapia H2O”. Invece no. Sarà la San Pellegrino SPA, una controllata della multinazionale Nestlè.
Ma si creeranno almeno i posti di lavoro? Certo! Ma a parte quelli nati in Procura della Repubblica per seguire le inchieste su corruzione e infiltrazioni mafiose, i posti di lavori saranno sopratutto precari. Se va bene. Perché è in corso una bella campagna per trovare i “volunteer Expo”. Con buona pace per chi, pur di pagare l’affitto o la retta universitaria, si sarebbe accontentato anche solo di qualche mese da precario, magari da Eataly, che avrà un padiglione da 8 mila metri quadrati. Insomma, cemento, debito e precarietà. Ma questo spot non lo vedrete in tv.

«». Il manifesto
I risultati delle elezioni parlano chiaro: la “narrazione” renziana è in crisi, ma le forze a sinistra del Pd non appaiono una alternativa credibile.
I sintomi di crisi del renzismo sono nel brusco calo dei votanti in realtà tanto diverse come Emilia e Calabria. Il fenomeno indica non solo l’incrinarsi del potere di attrazione del premier, ma anche consistenti segnali di ribellione dell’elettorato di sinistra verso il Pd. Inoltre, per la prima volta i grillini non intercettano il malcontento. Sembrerebbe una situazione eccellente per chi voglia proporre una alternativa di sinistra. Invece così non è. L’Altra Emilia-Romagna ha raccolto il 4% e Sel, nell’ambito del centro-sinistra, il 3,23%. In Calabria “La Sinistra” (Sel, Pdci, Idv), pur in una coalizione screditata, il 4,36%, e L’Altra Calabria (Prc e Alba, altre componenti della ex Lista Tsipras erano per il non voto) si ferma all’1,32%.
Tutto questo ci dice due cose. In primo luogo, non vi è oggi spazio a sinistra del Pd per più di una proposta politica. In secondo luogo, se le forze a sinistra del Pd si unissero in un Fronte articolato e plurale, lasciando da parte in nome del bene comune le reciproche avversioni, con una leadership collettiva e riconoscibile, questo soggetto politico-elettorale avrebbe di fronte a sé potenzialità rilevanti. Esso potrebbe puntare a conquistare militanti e voti tra i lavoratori sindacalizzati e tra i giovani disoccupati, tra i vecchi iscritti al Pci e tra coloro che sono cresciuti nei movimenti antisistema: insomma, tra i delusi degli ultimi vent’anni di storia politica e sociale del nostro paese.
Parlo di un Fronte della Sinistra (o Fronte del Popolo, o come lo si voglia chiamare) perché l’obiettivo di un unico partito non è realistico. Anzi, i cantieri oggi aperti (Lista Tsipras, Human Factor, nuovo partito comunista) avranno un ruolo positivo solo se non credono di essere autosufficienti, se dialogano fra loro, guardando con rispetto alle forze politiche esistenti, che restano decisive, come al grande mare dei non organizzati o di coloro che lo sono in associazioni e gruppi non partitici.
Bisogna finirla con i veti incrociati e coi risentimenti.
Questo Fronte della Sinistra dovrebbe partire dalle lotte sindacali, dei precari, dei disoccupati: senza radici nel mondo del lavoro non si è sinistra. Ma anche presentare un progetto di rinnovamento e di crescita rivolto a tutta la società. E una elaborazione che prospetti un tipo nuovo di convivenza, alternativa a quella attuale. Credo sia importante avere un duplice programma: uno di misure immediate, per fronteggiare l’emergenza; e un Programma fondamentale, per dire verso quale società si vuole andare.
Da subito poche proposte e chiare: per il lavoro, il Mezzogiorno, i giovani, la scuola e la cultura, la casa, il welfare. Si deve essere in grado di dire dove si troveranno le risorse, colpendo quali interessi: è necessario avere dei nemici. Perché questo nuovo soggetto deve essere di parte, anche se non minoritario. Dovrebbe pronunciarsi, ad esempio, sul ruolo del pubblico, proponendo una economia mista secondo quanto previsto dalla stessa Costituzione. Dovrebbe avviare una Riforma antiliberista.
E, soprattutto, questo Fronte della Sinistra non deve pensare che il suo compito si esaurisca dopo una prima prova elettorale, comunque vada. È un lavoro di lunga lena quello che ci attende, nella società prima che nelle istituzioni. Deve fondarsi sulla promessa reciproca di stare insieme per un lungo tratto di strada, senza cedere a tatticismi e interessi di corto respiro. Non si fa “grande politica” né con una nuova proposta ogni sei mesi né facendo la stampella alla gamba sinistra del Pd. Si metta in cantiere un progetto unitario e partecipato, di alternativa reale. Si lanci una vera sfida egemonica in nome delle classi subalterne, del mondo del lavoro e di chi non ha lavoro, della democrazia e della Costituzione. Oggi si può, la situazione lo richiede.
 «Le idee del rapporto di S
«Le idee del rapporto di S
bilanciamoci! sono il frutto dei calcoli di esperti ed economisti incrociati con le idee delle associazioni che lavorano su alcune grandi questioni aperte sulle quali la politica potrebbe intervenire più e meglio, dall'ambiente, al disagio sociale, all'immigrazione, passando per la cultura». Pagina99.it, 27 novembre 2014
Conti pubblici
La rete di 64 associazioni presenta il suo rapporto 2015. Mantenendo il parametro del pareggio di bilancio e lavorando su fiscalità e tagli alla spesa pubblica sbagliata si troverebbero le risorse per un reddito minimo, la tutela del territorio e risorse per il welfare
Ci risiamo: la discussione sulla legge di stabilità si avvicina – un tempo la chiamavano Finanziaria – e puntuale, come dal 2000 in poi, arriva il rapporto di Sbilanciamoci!, la rete di associazioni, Ong e altre organizzazioni della società civile che ogni anno guarda ai conti dello Stato e cerca di farsi un'idea su come e dove trovare soldi per dare risposte a bisogni diversi dal pareggio di bilancio. Come ogni anno il rapporto è dettagliato, ricco di numeri e attento a individuare la copertura necessaria alle misure proposte.
Le idee del rapporto sono il frutto dei calcoli di esperti ed economisti incrociati con le idee delle associazioni che lavorano su alcune grandi questioni aperte sulle quali la politica potrebbe intervenire più e meglio, dall'ambiente, al disagio sociale, all'immigrazione, passando per la cultura. Il rapporto 2015 contiene 84 proposte e rispetta l'idea del pareggio di bilancio “dimostrando che la quantità delle risorse pubbliche disponibili non è l’unica variabile che condiziona l’impianto della legge di stabilità. Il punto dirimente resta quale modello di economia, di società e di democrazia si ha in mente”, si legge nell'introduzione al rapporto.
Il quadro sociale ed ambientale dell'Italia è quel che è, sostengono le decine di realtà della società civile che danno vita alla campagna e per cercare di invertire la rotta occorre affrontare “i buchi neri del declino del nostro paese: l’economia in declino, un’occupazione in calo e sempre più precaria, un sistema di istruzione e di ricerca pubblico indebolito dai progressivi tagli, un disagio sociale crescente che consegna alla povertà assoluta sei milioni di persone, politiche sociali fragili e sempre più delegate alla famiglia, un patrimonio naturale e culturale in abbandono”. Le associazioni criticano l'austerità imposta dall'Europa alla quale, sostengono, i governi che si sono succeduti negli ultimi anni non hanno saputo opporre nessuna alternativa.
La contromanovra di Sbilanciamoci prevede due assi portanti sul piano delle entrate: una redistribuzione del prelievo fiscale che sposti risorse disponibili dalla ricchezza alla povertà e dai grandi patrimoni e rendite al reddito da lavoro e di impresa; tagli alla spesa pubblica che la campagna chiama “tossica”: meno soldi per Difesa e grandi opere, a sanità e istruzione private per reperire risoprse da impegnare in recupero del territorio, ricerca, istruzione, servizi di welfare.
Di seguito una sintesi delle proposte delle 46 organizzazioni
Riduzione di un punto delle aliquote sui primi due scaglioni, l’aumento di tre punti delle aliquote sul IV e sul V scaglione e la creazione di un VI scaglione, oltre 100mila euro, con aliquota al 50%. Si propone l’aumento di 100 euro delle detrazioni Irpef su redditi da lavoro e pensioni, l’abolizione del regime di tassazione separata per le rendite finanziarie (attualmente al 26%) e della cedolare secca sugli affitti a canone libero (oggi al 21%), con assoggettamento di questi redditi all’Irpef.
Iva: si inverte la tendenza all’aumento, riportando l’aliquota base dal 22% al 21%.
Tassazione del patrimonio: si prevede l’introduzione di un’imposta patrimoniale con aliquote progressive, che nella componente immobiliare operi una redistribuzione a parità di gettito (sostanzialmente esentando i ceti bassi), mentre nella componente finanziaria generi entrate aggiuntive per 4 miliardi (2 dalle famiglie e 2 dalle imprese). La franchigia sulla tassa di successione verrebbe ridotta a 100mila euro con, anche in questo caso, aliquote di tassazione crescenti con la ricchezza. Gli interventi su Irpef e Iva proposti costerebbero rispettivamente 0,9 e 4 miliardi, mentre la tassazione di patrimoni e successioni genererebbe equivalenti entrate aggiuntive.
Altre specifiche misure settoriali genererebbero risorse aggiuntive da impiegare per finanziare la spesa pubblica utile. Tra queste: la tassazione aggiuntiva sui capitali già scudati (5 miliardi), la revoca del condono sui concessionari di videogiochi (2,1 miliardi), il rafforzamento della tassa sulle transazioni finanziarie (0,8 miliardi), la tassazione degli immobili tenuti vuoti (400 milioni), misure di contrasto al canone nero e irregolare (250 milioni), la tassazione dei profitti del settore del lusso (200 milioni) e nocivi, come l’emissione di Co2 delle auto (500 milioni), l’adeguamento dei canoni di concessione per le attività estrattive (205 milioni) e delle acque minerali (250 milioni), le misure fiscali penalizzanti per il rilascio del porto di armi (170 milioni).
Tagli alla spesa
Cancellare gli stanziamenti previsti dalla legge di stabilità 2015 per le scuole private (471,9 milioni) e di sostituire con insegnamenti alternativi l’ora di religione nelle scuole il cui costo è stimato in 1,5 miliardi di euro. La revisione dei criteri di valutazione dei falsi invalidi potrebbe generare un risparmio di 250 milioni.
Si chiedono una riduzione degli stanziamenti per le Grandi infrastrutture strategiche dannose per l’ambiente (1,5 miliardi), l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che esamini lo stato delle convenzioni con le strutture sanitarie private, che generano molti sprechi e abusi (1 miliardo) e l’eliminazione del bonus bebè (202 milioni) a vantaggio della riduzione delle rette per gli asili pubblici.
Si propongono la chiusura dei Cie e dei CARA (191,9 milioni) e la riduzione delle spese militari portando entro il 2016 il livello degli effettivi delle Forze armate a 150.000 unità (400 milioni), eliminando l’ausiliaria per una fascia di ufficiali superiori (440 milioni), azzerando la parte di fondi iscritti al bilancio del ministero per lo Sviluppo Economico a disposizione del Ministero della Difesa per sostenere le industrie a produzione militare per specifici programmi d’armamento (2,2 miliardi). Restano naturalmente le richieste storiche di Sbilanciamoci!: la rinuncia al programma di acquisto degli F-35 (500 milioni) e della seconda serie di sommergibili U-212 (210 milioni) e il ritiro da tutte le missioni a chiara valenza aggressiva (600 milioni).
4 miliardi sono destinati ad un Piano di investimenti pubblici per creare occupazione nel settore dei trasporti ferroviari locali, stabilizzare il personale paramedico precario, assumere figure professionali stabili per combattere gli abbandoni scolastici e mettere in sicurezza il nostro territorio. 900 milioni sono invece destinati a finanziare la ricerca di base e applicata con l’istituzione di un Fondo venture capital “Industrial Compact 2020: industrializzazione della R&S”. Si propone inoltre di attribuire le risorse messe a bilancio per il credito di imposta a favore delle imprese che investono in ricerca ai bilanci degli enti di ricerca pubblici nazionali (costo zero).
Sperimentazione di una misura di reddito minimo garantito
Con 4 miliardi sarebbe possibile garantire 500 euro al mese individuali a circa 764 mila persone che si trovano in condizioni di povertà assoluta, ovvero con una capacità di spesa mensile inferiore a un paniere di beni di “sussistenza” e che sono in cerca di occupazione. Siamo consapevoli che il finanziamento di un vero e proprio reddito di cittadinanza richiederebbe la rivisitazione dell’intero sistema delle politiche del lavoro, sociali e fiscali e un investimento ingente, improbabile nell’attuale contesto economico e politico, ma riteniamo fondamentale l'inizio di una sperimentazione di questo tipo, mancante in Europa, soltanto in Italia e Grecia.
Cultura e conoscenza
Cultura, scuola e università sono state duramente colpite dalla miopia dei tagli lineari degli ultimi anni. Per rafforzare le politiche culturali Sbilanciamoci! propone la costituzione di un fondo rotativo per la ristrutturazione degli spazi di proprietà pubblica da destinare allo svolgimento di attività culturali (20 milioni), misure di sostegno all’accesso alla cultura per studentesse e studenti (20 milioni), l’introduzione di un credito di imposta per le produzioni musicali di artisti emergenti (10 milioni), un’integrazione del Fondo Unico per lo Spettacolo (95 milioni) e del Fondo per le associazioni di promozione cinematografica (300mila euro).
Per migliorare il sistema di istruzione pubblico si propone di varare una piano ventennale per l’edilizia scolastica (1 miliardo per il 2015), di finanziare la legge 440/97 (300 milioni) e garantire il diritto allo studio (300 milioni), di promuovere progetti che favoriscano l’alternanza scuola-lavoro (200 milioni), di costituire un fondo per l’innalzamento dell’obbligo scolastico e per l’integrazione (200 milioni), di finanziare la promozione di progetti studenteschi (10 milioni) e la formazione di docenti curricolari per l’inclusione degli alunni con disabilità (20 milioni). 800 milioni sono destinati a incrementare il Fondo di finanziamento ordinario dell’università e 400 milioni a garantire la copertura totale delle borse di studio.
Case senza persone e persone senza case
Nella legge di stabilità non ci sono risorse per la politica sociale sulla casa. Ma sono circa 700.000 le domande di alloggi popolari non soddisfatte e 70.000 le sentenze di sfratto ogni anno, aumentate a seguito degli effetti della crisi. 30 mila sono gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non assegnati perché bisognosi di ristrutturazione. Si propone di investire di più nel recupero di immobili di proprietà pubblica per uso abitativo (1 miliardo) e nel sostegno sociale all'affitto (300 milioni) e di integrare il Fondo per la morosità incolpevole (300 milioni).
Lo sviluppo è verde
Non c’è futuro senza salvaguardia dell’ambiente. Per attuare una strategia per l’adattamento ai cambiamenti climatici e alla manutenzione del territorio servirebbero investimenti per 2 miliardi di euro per i prossimi 20 anni. Recuperando le risorse dal taglio delle grandi opere e dalla tassazione delle attività che danneggiano l’ambiente, Sbilanciamoci! chiede che nella Legge di Stabilità 2015 siano stanziati a questo scopo almeno 500 milioni di euro. Si propone inoltre di integrare il Bilancio del Ministero per l’ambiente di 100 milioni, di costituire un fondo di rotazione per le demolizioni delle opere abusive (150 milioni), di varare un piano nazionale per la mobilità sostenibile (1 miliardo), di promuovere l’installazione di impianti fotovoltaici con accumulo (200 milioni), di tutelare le aree protette (30 milioni).
Spendere di più e meglio per proteggere le persone
I diritti sociali non sono un lusso né una merce. Per contrastare le scelte di privatizzazione in corso da tempo, Sbilanciamoci! propone di integrare il Fondo Nazionale Politiche Sociali (1,164 miliardi) per riportarlo ai livelli del 2008, impiegare le risorse stanziate per il bonus bebè per ridurre le rette degli asili nido pubblici (costo zero), integrare il Fondo per la non autosufficienza (350 milioni) e quello per l’infanzia (15,2 milioni), varare misure per l’invecchiamento attivo (1 milione) e per l’inclusione attiva delle persone con disabilità (50 milioni). L’inserimento sociale dei detenuti potrebbe avvenire a costo zero.
Ridurre i ticket sanitari e rafforzare la medicina territoriale servirebbe 1 miliardo recuperabile rivedendo le convenzioni con le strutture sanitarie private. Per promuovere le politiche di genere sono fondamentali provvedimenti come l’assegno di maternità universale (900 milioni), incentivi nei settori della formazione tecnico-scientifica delle donne (275,1 milioni) e, visto il pericoloso aumento della violenza sulle donne, un finanziamento per nuovi centri anti-violenza (50 milioni).
L’ampliamento degli interventi di inclusione sociale e lavorativa dei cittadini stranieri (60,9 milioni), l’abolizione della tassa di soggiorno (26 milioni), il rafforzamento del sistema nazionale di lotta contro le discriminazioni e il razzismo (30 milioni) e il varo di un piano nazionale di smantellamento dei “campi nomadi” potrebbero arginare, se accompagnati da un rafforzamento delle politiche di welfare generali, l’ondata di razzismo che sta travolgendo di nuovo il nostro paese.
 «Fiducia al Senato sul Jobs Act: 166 favorevoli, 112 contrari, un astenuto. Mineo (Pd) non ha votato, Ricchiuti e Casson assenti. La manifestazione dello sciopero sociale è stata caricata in via delle Botteghe Oscure a Roma dopo essere stata accerchiata per più di un'ora.
«Fiducia al Senato sul Jobs Act: 166 favorevoli, 112 contrari, un astenuto. Mineo (Pd) non ha votato, Ricchiuti e Casson assenti. La manifestazione dello sciopero sociale è stata caricata in via delle Botteghe Oscure a Roma dopo essere stata accerchiata per più di un'ora.
Il manifesto 4 dicembre 2014 (m.p.r.)
Il Senato ha dato il via libera definitivo al con 166 si, 112 no e un astenuto ieri alle 19,43 . Cinque ore prima a pochi metri di distanza, oltre le linee di un esercito di centinaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri, in via delle Botteghe Oscure, la violenza dei manganelli. Uno spettacolo gratuito e inspiegabile quello visto ieri nelle strade di Roma. Il volto più educato, ma ugualmente pregno di contenuti, il governo l’ha mostrato in aula quando il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha annunciato la fiducia per tagliare le gambe alla sinistra Dem e zittirla sulla riforma del lavoro. Dopo le 14 tra piazza Sant’Andrea della Valle e i binari del tram 8, davanti al teatro Argentina, ha mostrato quello più arbitrario.
Le forze dell’ordine schierate con decine di camionette e un centinaio di uomini hanno negato a trecento persone di tornare a Sant’Andrea della Valle, la piazza concordata con la Questura di Roma fino alle 18. Dopo averli tenuti in ostaggio per più di un’ora, davanti all’insistenza dei manifestanti di uscire dall’accerchiamento, è partita una carica. Due persone sono state fermate, poi rilasciate. Altre picchiate. Erano inermi. La testimonianza di numerosi video da ore in rete mostra la durezza delle scene. «Contenimento per impedire di tornare al Senato» lo definisce una nota della Questura capitolina che sostiene di avere sequestrato 30 petardi e 26 fumogeni. Oggetti evidentemente pericolosi al punto da cancellare la clamorosa sproporzione delle forze in campo. Lasciando defluire un corteo pacifico si sarebbero evitati anche i lanci di petardi e inutili tensioni. Al vaglio ci sono le immagini riprese dalle telecamere montate sulle uniformi degli agenti. Il corteo era partito verso mezzogiorno dal Colosseo con più di cinquecento persone.
«In tutta Europa si manifesta contro leggi che sono ipoteche sul futuro di milioni di persone - ha commentato Francesco Raparelli del laboratorio romano per lo sciopero sociale, uno dei fermati - A Roma no. è vietato manifestare liberamente». «Il nuovo questore di Roma ha esordito in maniera ignobile - ha detto il portavoce Cobas Piero Bernocchi - Non vorrei che quanto accaduto risulti sulla stampa come dipeso da un poliziotto nervoso. Chi ha deciso queste cariche? Renzi è come il padre del Buddha che nascondeva i fiori morti al figlio, non vuole vedere contestazioni e su questo ha messo il carico da undici anche Alfano». «Si è svelata la natura autoritaria del governo, che preferisce far manganellare studenti minorenni che stanno occupando le scuole contro La Buona Scuola e il Jobs Act invece di rispondere ai loro reali bisogni» sostiene Danilo Lampis (Uds). «Questa vicenda non finisce qui - la battaglia proseguirà contro i decreti attuativi della legge delega, per impedire che vengano cancellati diritti e tutele - sostiene il sindacato Usb - la battaglia proseguirà contro i decreti attuativi della legge delega, per impedire che vengano cancellati diritti e tutele».
Decreti che verranno approvati entro giugno. «Le opinioni espresse in parlamento saranno tenute in considerazione nella loro stesura» ha detto Poletti. Saranno cinque e riguardano gli ammortizzatori sociali, i servizi per il lavoro, la semplificazione, il riordino delle forme contrattuali e la conciliazione. Si cancellerà l’articolo 18 sul licenziamento per i neo-assunti che verranno sottoposti alla disciplina del «contratto a tutele crescenti». Le loro tutele saranno vincolate al periodo di lavoro svolto. Meno si lavora, meno soldi si ricevono. Una svolta nella recente, e tribolata, storia del diritto del lavoro sempre più ricalcato sulle esigenze delle imprese. In aula, durante la discussione, i senatori di Sel hanno protestato mostrando cartelli con la scritta: «Jobs Act: ritorno all’800». Per Poletti, invece, «non sono le regole a produrre posti di lavoro, ma siamo convinti che un buon contesto aumenti l’opportunità». Il contesto è quello dove la disoccupazione è arrivata al 13,2%, +286 mila in un anno, e quella giovanile è fuori controllo: 43,3%. Il premier Renzi si è invece complimentato su twitter: «Questa è #lavoltabuona. E noi andiamo avanti». Nella direzione vista ieri a Roma. Il senatore Pd Corradino Mineo non ha votato la fiducia. Lorenza Ricchiuti e Felice Casson (Pd) erano assenti.
 «La fotografia che Enrico Rossi ha postato su Facebook ha fatto politica più di quanta ne abbiano fatto le ultime dieci riunioni della direzione del Pd. Rossi ha compiuto "un significativo gesto di socialità da parte di un uomo delle istituzioni nei confronti di persone tra le meno frequentate e sopportate"».
«La fotografia che Enrico Rossi ha postato su Facebook ha fatto politica più di quanta ne abbiano fatto le ultime dieci riunioni della direzione del Pd. Rossi ha compiuto "un significativo gesto di socialità da parte di un uomo delle istituzioni nei confronti di persone tra le meno frequentate e sopportate"».
Articolo9, 3 dicembre 2014
Ha scritto Leonardo: «Poni scritto il nome di Dio in un loco, e ponvi la sua figura a riscontro: vedrai quale fia più riverita». Lo straordinario potere delle immagini: da millenni strumento di elezione della politica.
Sarà per questo potere che la fotografia che Enrico Rossi ha postato su Facebook ha fatto politica più di quanta ne abbiano fatto le ultime dieci riunioni della direzione del Pd. Pubblicando una sua foto sorridente con una famiglia Rom, e intitolandola «i miei vicini di casa», Rossi ha compiuto – come ha scritto Michele Serra – «un significativo gesto di socialità da parte di un uomo delle istituzioni nei confronti di persone tra le meno frequentate e sopportate».
Una cosa normale, addiritura banale, in un paese civile. Uno scandalo in un'Italia incattivita e sempre più consegnata agli istinti più bassi e ai bisogni più elementari.
E a colpire non sono (solo) i post razzisti, gli insulti, le incitazioni al pogrom berciati dal branco rabbioso e anonimo che si muove sulla rete, né gli scontati attacchi frontali della Lega o di Fratelli d'Italia. No, a colpire sono i silenzi della Chiesa gerarchica fiorentina (qualcuno li ha avvertiti che il papa si chiama Francesco?). O i toni dei giornali di Firenze: ieri un quotidiano che ci si aspetterebbe civile ha scritto, nell'editoriale di apertura, che il gesto di Rossi «voleva dare voce alla seconda curva ultrà, quella dei "tutti onesti e lavoratori", senza tenere conto delle differenze che ci sono in ogni gruppo sociale». Parole davvero sconcertanti. Rossi non ha postato la foto di un rom che chiede l'elemosina, scrivendoci sotto «avanti così»: no, si è fatto ritrarre con una famiglia normale che vive in una casa vicina alla sua. E questo sarebbe un gesto da ultra? Dire che l'integrazione è possibile, pensare che le responsabilità siano individuali, e non del 'gruppo': tutto questo sarebbe da ultra?
Va peggio con i politici: a parte qualche eccezione, il Pd si è defilato come non avrebbe fatto neanche Forza Italia. Il ministro della Repubblica Maria Elena Boschi ha detto che Salvini deve tacere perché la sua foto a torso nudo sarebbe «più imbarazzante» di quella di Rossi. E perché mai quella di Rossi dovrebbe essere «imbarazzante»? Ma l'apice dell'antipolitica l'ha toccato il segretario del Pd toscano Dario Parrini, che prima ha detto «no comment», e poi si è limitato a sillabare che «la parola doveri è di sinistra quanto la parola diritti».
E uno, davvero, si chiede cosa sia successo al Partito Democratico. Non mi risulta che Parrini si sia mai sentito in dovere di commentare le due foto qua sotto.
È forse di sinistra che la Fiat vada a pagare le tasse altrove? E come stanno ripartiti, qua, i diritti e i doveri? E ancora: è forse di sinistra che la Costituzione venga cambiata in base ad un patto segreto contratto tra questi due signori? E qua, con la faccenda dei doveri come la mettiamo?
Dario Parrini è di Vinci, proprio come Leonardo. Il quale Leonardo scrisse che «il pesante ferro si reduce in tanta sottilità mediante la lima, che picciolo vento poi lo porta via». Ecco, la furbesca retorica antipolitica sta limando giorno dopo giorno il progetto di Paese che un giorno apparteneva alla Sinistra. Un progetto fondato sull'uguaglianza: quella possibile, quella che sta a noi realizzare. E tra poco basterà il vento forte dell'astensione e il piccolo vento della Lega di Salvini a portarsi via quel futuro possibile.
Come ha scritto ieri Elle Kappa, «il sonno della politica genera destra».
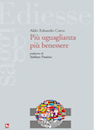 «Per quanto sia importante avere un’occupazione, essa non è tuttavia sufficiente per la realizzazione delle persone; il loro benessere non è favorito se le esigenze produttive impongono condizioni squilibrate di sovraoccupazione che costringono a una «rincorsa permanente» a maggiori consumi o a condizioni di sottoccupazione che deprimono la qualità della vita».
«Per quanto sia importante avere un’occupazione, essa non è tuttavia sufficiente per la realizzazione delle persone; il loro benessere non è favorito se le esigenze produttive impongono condizioni squilibrate di sovraoccupazione che costringono a una «rincorsa permanente» a maggiori consumi o a condizioni di sottoccupazione che deprimono la qualità della vita».
Il manifesto, 28 novembre 2014 (m.p.r.)
Il rapporto tra opportunità di vita e qualità della stessa si presenta contraddittorio fin dagli anni Settanta quando, come ricostruisce Stefano Fassina nella prefazione al libro di Aldo Carra Più uguaglianza, più benessere. Percorsi possibili in tempi di crisi (Ediesse, pp. 156, euro 12), emergono i limiti di uno sviluppo che, pur in forte crescita produttiva, è incapace a rispondere alla domanda di maggiore qualità del lavoro e di estensione del welfare. Il volume sarà presentato oggi a Roma da chi scrive, Stefano Fassina e Norma Rangeri in un incontro con l’autore (appuntamento alle ore 18 alla chiesa valdese, Via Marianna Dionigi 59). Il «ben-essere» (well-being) al quale si riferisce Carra non è la soddisfazione dei soli bisogni personali con beni di mercato, e servizi pubblici, ma anche delle esigenze che attengono alla realizzazione personale e sociale degli individui e, in questo senso, si contrappone al Pil quale misura dei risultati economici di un paese.
Il well-being incontra un limite nel modello produttivo esistente per la subordinazione che impone al lavoro e per le disuguaglianze che genera nella società. Keynes aveva visto giusto nel prevedere l’enorme crescita della produttività del XX secolo, ma non aveva visto giusto nel ritenere che, appagati i bisogni primari, ci sarebbe stato tutto lo spazio per soddisfare le necessità di più alto livello. Le cose non sono andate così; il sistema capitalistico, per non intaccare il suo assetto sociale, ha accompagnato la sua crescita con la trasformazione dei modelli di consumo inducendo i bisogni necessari all’assorbimento dei «suoi» prodotti in un circuito «infernale tra sviluppo che genera bisogni e ricerca di soddisfazione dei bisogni che genera sviluppo».
Una realtà di «minori occupati che lavorano di più» genera una sistematica disuguaglianza che, come esplicita il titolo (Più uguaglianza, più benessere), costituisce un vincolo all’opportunità di scelta della propria vita. Carra parla giustamente, a questo proposito, di «grande inganno» perpetrato da quegli economisti che teorizzano che la disuguaglianza faccia bene; che il mercato premia il merito; che privilegiare l’utilizzo dei pochi che dispongono di maggiori risorse fa «sgocciolare» reddito e opportunità su coloro che non ne sono dotati; che l’esclusione dei molti è giustificata, anzi auspicata per la maggiore «efficienza» dell’economia, dato che i costi sociali e personali dell’esclusione (disoccupazione e precarizzazione) non sono costi economici (da includere nel Pil).
La classe dirigente non riesce solo a creare regole funzionali ai suoi interessi, ma anche a convincere che i rapporti da lei imposti rispondono alle esigenze dei loro subordinati; accettare la «predicazione della disuguaglianza come valore positivo» significa ratificare di fatto la vittoria culturale dell’individualismo, consumismo, liberismo. Si può uscire da questa trappola solo proponendo una politica alternativa che abbia nel lavoro il segno tangibile dell’uguaglianza e della libertà. In questa tensione etico-religiosa – i riferimenti a papa Francesco e al pensiero cattolico e socialista sono frequenti – si colloca la proposta «minimalista» di Carra per «convincerci e convincere» che l’uguaglianza è oggi possibile e necessaria e che per raggiungerla non vi è bisogno di obiettivi radicali di rivolgimento, ma percorsi che la ricostruiscano «a partire da tutti gli aspetti della vita quotidiana delle persone».
La ricerca di Carra si appoggia sulle analisi, e sugli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (Bes), elaborate dalla Commissione Istat-Cnel alla quale ha partecipato come membro. Sulla base dell’architettura del Bes, egli individua gli obiettivi volti a contrastare le molteplici situazioni di disuguaglianze che si presentano nei microcontesti sociali, familiari e culturali della vita quotidiana. I settori del lavoro, del benessere economico, della salute e dell’istruzione sono quelli nei quali più forte è l’incidenza delle disuguaglianze e sono quindi i campi sui quali si concentra la sua attenzione e la sua proposta di microprogetti che viene sviluppata adottando tre chiavi di lettura delle disuguaglianze (di genere, di generazione, territoriali).
Nel libro l’azione pubblica fa riferimento a una testa, a un governo nazionale, che non sembra avere tra i suoi obiettivi quelli auspicati e a gambe, gli enti locali, non sempre dotati di adeguate competenze e volontà (Fabrizio Barca potrebbe meglio qualificare questo aspetto) e tanto meno autonomia finanziaria; non meno secondario è il contesto culturale che falcidia tutte le proposte non conformi all’esistente visione di politica economica. Ma, se non si accetta l’egemonia politica e culturale dominante, come non l’accetta Carra, l’ambizioso progetto del libro richiede di trovare teste e gambe in grado di dare una risposta positiva all’aspirazione di più uguaglianza e più benessere; in sostanza, il nodo è come e dove sono i poteri, le forze (sociali, politiche, di movimento) capaci di mobilitarsi, all’interno di una visione globale, in uno sforzo comune per più uguaglianza e più benessere?
 «Fare sindacato e costruire coalizione per una nuova sinistra sarà difficile, ma più necessario e urgente. Il popolo orfano di una sinistra popolare, in piazza il 25 ottobre e nelle occasioni successive, in moto per uno sciopero generale, dopo anni. Questa sarà la risposta».
«Fare sindacato e costruire coalizione per una nuova sinistra sarà difficile, ma più necessario e urgente. Il popolo orfano di una sinistra popolare, in piazza il 25 ottobre e nelle occasioni successive, in moto per uno sciopero generale, dopo anni. Questa sarà la risposta».
Il manifesto, 26 novembre 2014 (m.p.r.)
Il Jobs Act è passato anche alla Camera. Tornerà per l’approvazione definitiva al Senato, ma non si attendono sorprese. Renzi può portare a Bruxelles lo scalpo dell’articolo 18, anzi di tutto l’impianto dello Statuto dei diritti dei lavoratori, perché senza tutela reale ogni altro diritto è di per sé indebolito se non annullato. Hanno votato in 316 a favore del disegno di legge del governo. La maggioranza assoluta, per un voto, di una camera di nominati già politicamente delegittimata dalla bocciatura del porcellum da parte della Corte Costituzionale. Malgrado ciò quella maggioranza si è assunta la responsabilità di cancellare con un pulsante decenni di storia del conflitto sociale che avevano creato il “caso italiano” durante i “trenta anni gloriosi” del capitalismo occidentale.
Eppure questa volta per Renzi non è stato un trionfo. E’ forse esagerato dire che si è trattato di una vittoria di Pirro, ma per la prima volta Renzi ha dovuto incassare il dissenso aperto della minoranza del suo partito. Civati ha votato no, mentre Fassina e Cuperlo hanno trascinato fuori dall’Aula una trentina di deputati, assieme a quelli di Sel, dei Pentastellati e delle opposizioni di destra. A sua volta Bersani ha votato un sì per pura disciplina e palese nulla convinzione. E così sarà stato probabilmente per diversi altri. La presunta mediazione sul testo non ha tenuto né nel merito né politicamente. Il dissenso non è rientrato, è esploso.
Del resto è davvero difficile considerare un miglioramento quanto è stato precisato alla Camera rispetto al Senato. Per i licenziamenti per motivi economici non c’è alcun reintegro, solo l’indennizzo rapportato alla anzianità di servizio. Il reintegro compare solo per i licenziamenti chiaramente discriminatori e per quelli disciplinari risultati privi di fondamento alcuno, secondo tipicizzazioni ulteriori rimandate ai decreti delegati. Chi mai volendo licenziare potrebbe impegolarsi in queste tipologie potendo adagiarsi sull’andamento economico dell’impresa? Qui si colpisce non solo il diritto al lavoro del licenziato, ma anche il ruolo della magistratura nell’ intervento per reintegrare tale diritto. Due piccioni con una fava. Neanche il nemico per eccellenza dei giudici, Berlusconi, avrebbe potuto tanto.
Nel frattempo Squinzi può sognare, si stropiccia gli occhi, ottiene più di quanto pretendeva e sperava. Non ha neppure avuto bisogno di chiederlo. Anzi, Squinzi aveva combattuto per la presidenza della Confindustria contro Bombassei, dichiarando proprio che l’articolo 18 non era una priorità.
Intanto Pier Carlo Padoan aveva già scritto la sua lettera alla Commissione affinché fosse indulgente nel valutare i conti della legge di stabilità. Il giudizio definitivo sarà a marzo, ma intanto il governo si salva, anche grazie alla approvazione del Jobs Act che, secondo il nostro ministro dell’economia, garantirà una ripresa dell’economia e il sostegno al sistema pensionistico. Come ciò possa avvenire a colpi di precariato, che il decreto Poletti e il Jobs Act stesso ampliano a dismisura, è un mistero da rimandare al mittente.
La novità tanto sbandierata è il famoso contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Le modalità della articolazione di queste tutele sono ancora ignote, perché rimandate al testo di decreti delegati che eventualmente passeranno solo dalle commissioni parlamentari — ma non dall’aula — per un parere non vincolante. Tuttavia è fin d’ora scarsamente credibile che un padrone assuma con questa forma, quando può utilizzare, grazie al decreto Poletti, contratti a termine uno in fila all’altro senza doverne motivare la ragione. Paradossalmente, ma non troppo, proprio il contratto indeterminato a tutele crescenti spingerà ancora di più l’acceleratore sulla totale precarizzazione dei rapporti di lavoro per i nuovi assunti.
Fare sindacato e costruire una nuova coalizione sociale per una nuova sinistra sarà più difficile, ma ancora più necessario ed urgente. Una dimensione europea è indispensabile poiché il sistema non sopporta legislazioni nazionali protettive dei diritti e forme contrattuali che vadano al di là del singolo gruppo o azienda. Jobs, più che voler dire lavori, è un acronimo: Jumpstart Our Businesses (come l’omonimo americano del 2012) cioè «mettiamo in moto le nostre imprese». Di contro, quel popolo di sinistra orfano di una vera sinistra popolare ritrovatosi in piazza il 25 ottobre e nelle occasioni successive, si rimette in moto per uno sciopero generale, dopo tanti anni. Questa sarà la risposta.

« Il manifesto, 26 ottobre 2014 (m.p.r.)
Un’alternativa dal basso alla «globalizzazione dell’indifferenza». Questo il senso dell’Incontro mondiale delle organizzazioni popolari che si svolge a Roma da domani al 29 e che accoglie delegati provenienti dai cinque continenti. La conferenza di presentazione, che si è tenuta nella sala stampa del Vaticano, ha messo in luce la particolarità dell’evento, significata dalla presenza al tavolo di due cardinali – Peter Kodwo Appiah Turkson, presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, e Marcelo Sanchez Sorondo, Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze sociali – e di un attivista argentino, Juan Grabois, della Confederacion de Trabajadores de la Economia Popular (Ctep), una delle strutture che ha organizzato l’incontro internazionale.
Un consesso degli esclusi fortemente appoggiato da papa Bergoglio – ha spiegato padre Federico Lombardi, gesuita come il pontefice argentino. E così, a fianco del Movimiento mundial de Trabajadores Cristianos troviamo i Movimenti delle fabbriche recuperate in Argentina (ci sono anche l’italiana Rimaflow, Communia Network e Genuino clandestino), centri sociali come il Leoncavallo, la Banca etica, e organizzazioni popolari marxiste e laiche, dall’Asia all’Africa, agli Stati uniti e all’America latina: a partire dal Movimento dei Sem Terra, uno dei principali organizzatori.
L’egemonia? Se ne è discusso per qualche mese, non senza defezioni e malumori, ma alla fine ha prevalso la parola «incontro», nel «cammino aperto da papa Francesco, che sostiene di avere molti amici trotskisti e che ci ha aiutato a situare il tema dell’ingiustizia e dell’esclusione», ha detto Monsignor Sorondo, e ha precisato: «D’altronde, Gesù è arrivato prima del marxismo, e poi dopo la caduta del socialismo i marxisti non sono più un pericolo».
E comunque, la chiesa di Bergoglio è tornata a «vedere» quei preti che incrociano il conflitto sociale, e a misurarsi persino coi momenti e coi luoghi in cui è necessario disobbedire. Per l’Incontro mondiale arriverà anche il presidente della Bolivia, Evo Morales, appena rieletto a grande maggioranza: però non come capo di stato, ma come ex sindacalista indigeno e «cocalero».
Dopo la conferenza stampa, Juan Grabois ha spiegato al manifesto che «per superare ostacoli e differenze e affrontare insieme un capitalismo selvaggio che distrugge la natura e condanna i giovani a non avere futuro», si è preferito racchiudere il senso dell’Incontro intorno alle «», terra, casa, e lavoro, «diritti elementari che tutti desideriamo, ma che necessitano di una forte e tenace organizzazione popolare: per spingere i governi progressisti ad approfondirli e combattere quelli che progressisti non sono».
Obiettivi prioritari per i settori sociali maggiormente esclusi: «i lavoratori precari, i migranti, i disoccupati e chi partecipa al settore dell’economia informale e autogestito, senza protezione legale, riconoscimento sindacale o coperture sociali. E poi i contadini, i senza terra, i popoli originari e le persone che rischiano di essere espulse dalle campagne a causa della speculazione agricola e della violenza; le persone che vivono ai margini delle metropoli, dimenticati da una struttura urbana inadeguata». Tra gli obiettivi, c’è dunque «la riforma agraria, quella del lavoro e la costituzione di Consiglio dei movimenti popolari, articolato a livello globale».
In Argentina, il Ctep racchiude oltre 500 organizzazioni, come il Movimento delle fabbriche recuperate, e quello dei Cartoneros, «composto da oltre 5.000 lavoratori che gestiscono il riciclaggio a Buenos Aires e che tengono alle proprie conquiste aperte dalle lotte dei piqueteros nel 2001. Da noi, gli informali sono il 30% della classe lavoratrice, un settore che dev’essere riconosciuto in un nuovo sindacato».
Nessun dubbio, per Grabois, che i movimenti argentini debbano lottare per la sovranità del paese e contro i fondi avvoltoi per ribadire ai poteri forti internazionali «che c’è un limite da non valicare». L’attivista ha al collo un fazzoletto kurdo, e il movimento federalista è presente all’incontro «Lo porto apposta — dice — per appoggiare la loro resistenza contro una banda di mercenari che massacra la popolazione con le armi della Nato. Nella federazione kurda si pratica la democrazia diretta e la parità di genere, un esempio che disturba».
E i movimenti in Europa?«Qui la situazione dei migranti è ben peggiore che da noi, dove almeno possono organizzarsi e lottare. Ne ho visti lavorare in ogni strada di Roma, e come me li vedono tutti, ma restano invisibili e senza diritti. Il cuore di chi ha tutto è chiuso, ma noi dovremmo costruire un’alleanza globale tra giovani precari e migranti e farne la linea principale della battaglia contro l’ingiustizia».
 La crisi di consenso di molti primi cittadini eletti nella
La crisi di consenso di molti primi cittadini eletti nella Il manifesto, 25 novembre 2014
Se Italo Calvino avesse scritto oggi il suo insuperabile «Le città invisibili» avrebbe incluso probabilmente un capitolo dedicato alla «città ingovernabile». Questa è infatti la condizione della gran parte delle città italiane negli ultimi cinque anni, da quando la crisi economica ha prodotto crescente disoccupazione, precarietà, disagio e paura crescenti. Da Pisapia a De Magistris, da Doria a Marino, da Orlando a Pizzarotti, non c’è più un sindaco eletto sull’onda ed il bisogno di una svolta radicale che oggi non sia in crisi di consensi. Persino Renato Accorinti, eletto a Messina a furor di popolo un anno e mezzo fa, il sindaco con la maglietta «No Ponte», icona della pace e della difesa dell’ambiente, è oggi a corto di consensi nella sua città malgrado i risultati conseguiti.
Esattamente venti anni fa si inaugurava la cosiddetta «stagione dei sindaci», partendo dalla rinascita della Napoli di Bassolino, passando per la primavera della Palermo del primo Orlando, e poi ancora Bianco a Catania e Falcomatà a Reggio Calabria, per citare i casi più famosi. Coincideva anche con una stagione di risveglio delle popolazioni meridionali a sostegno dei propri sindaci che avevano dato segni concreti di buon governo dopo la fallimentare gestione democristiana. Non a caso tutti rieletti al secondo mandato. Oggi sarebbe impossibile.
Da una parte, i tagli dei trasferimenti statali ai Comuni, inaugurati dal governo Monti e portati alle estreme conseguenze da Renzi, dall’altra un debito insostenibile ereditato dalle amministrazioni passate, rendono impossibile rispondere ai bisogni crescenti della cittadinanza.
Crisi economica e tagli ai bilanci comunali si traducono in una morsa che impedisce di rispondere a un disagio sociale crescente e, soprattutto, all’insofferenza. Gli abitanti delle periferie sono diventati ansiosi e intolleranti dopo aver sopportato decenni di abbandono e degrado. Infatti, bisogna ricordarlo, anche durante la cosiddetta «stagione dei sindaci» le periferie urbane, di Roma, Napoli o Catania erano rimaste sostanzialmente esterne alla riqualificazione urbana diretta soprattutto ai centri storici. Ma, non c’era la pesantezza di questa crisi e le popolazioni delle periferie si aspettavano ancora di essere incluse nel processo di rinascita cittadino. C’era ancora la speranza. In questi anni è stata seppellita.
Oggi non si dice più «piove governo ladro», ma per ogni guasto sociale e ambientale il «punching ball» è il sindaco. Doria a Genova e Marino a Roma, solo per citare gli ultimi casi, avranno pure le loro mancanze ma sono stati messi alla gogna come gli unici responsabili del disastro dell’alluvione o del degrado/razzismo dei quartieri periferici. E non sono fenomeni isolati, ma destinati ad allargarsi perché il governo Renzi ha una strategia politica chiara: scaricare sugli enti locali il costo della crisi e del debito pubblico insostenibile. Ed è una strategia che funziona.
I tagli alla sanità pesano sulle Regioni che si trovano di fronte una forte opposizione sociale alla cosiddetta «razionalizzazione dell’offerta ospedaliera» che comporta la chiusura di decine di ospedali per ogni regione. I tagli ai comuni si abbattono sui servizi sociali, i mezzi di trasporto locale e, soprattutto, aumentano le imposte locali. Quasi tutte le amministrazioni comunali sono diventate le più odiate dai commercianti, dai proprietari di case, dai soggetti deboli privati dell’assistenza necessaria. Risultato finale: lo scollamento/scontro tra popolazioni ed amministrazioni comunali porta al collasso della democrazia reale, perché è proprio a livello locale che è possibile praticare forme di democrazia partecipativa, di gestione dei Beni Comuni , di autogoverno.
Viceversa tutte le cose positive le fa Renzi. E non solo gli 80 euro. Vorrei citare un fatto recentemente accaduto. In provincia di Cosenza una organizzazione cattolica, il Banco delle Opere di Carità, in collaborazione con diversi comuni collinari e montani, sta distribuendo gratuitamente la frutta alle popolazioni di questi comuni periferici (mele, prugne,ecc.) come sostegno economico alle fasce territoriali più povere. Si è sparsa la voce che questo insolito provvedimento (di solito la frutta che non si vendeva finiva sotto il trattore) sia opera del governo, e così la gente dice : «È arrivata la frutta di Renzi».
Naturalmente c’è sempre il rovescio della medaglia. L’attacco al sindacato e ai lavoratori che scioperano toglie consensi al premier, ma non va sottovalutato il fatto che la strategia principe di Palazzo Chigi è tipica di un’azienda capitalistica: esternalizzare i costi, sociali ed ambientali, e internalizzare i profitti (consensi in questo caso). Per questo gli amministratori locali che rischiano in prima persona dovrebbero unirsi contro questo governo con più forza e determinazione di quello che finora hanno fatto, a partire dalla richiesta di ristrutturazione dei debiti ereditati e non più sostenibili.
 «Il nuovo prodotto è pronto. La politica in crisi di consenso deve produrre leader, venderli e produrne di nuovi, per alimentare lo spettacolo dello scontro bipolarista e il flusso illusione-disillusione su cui si basa». I giornali amici di Renzi gli stanno preparando l'avversario senza il quale non può vincere.
«Il nuovo prodotto è pronto. La politica in crisi di consenso deve produrre leader, venderli e produrne di nuovi, per alimentare lo spettacolo dello scontro bipolarista e il flusso illusione-disillusione su cui si basa». I giornali amici di Renzi gli stanno preparando l'avversario senza il quale non può vincere.
Il manifesto, 23 novembre 2014
Il nuovo prodotto è pronto. La politica in crisi di consenso deve produrre leader, venderli e produrne di nuovi, per alimentare lo spettacolo dello scontro bipolarista e il flusso illusione-disillusione su cui si basa. Il nuovo prodotto è naturalmente Matteo Salvini. I nuovi prodotti politici vengono sempre lanciati da massicce campagne pubblicitarie, ma forse la campagna per la produzione e per la promozione di Salvini non ha precedenti. D’altra parte si partiva da condizioni difficili: una Lega al 3 per cento. L’avventura era particolarmente affascinante.
Il segretario della Lega è ininterrottamente in televisione, spesso due volte al giorno, dalla campagna elettorale per le europee. Non può essere solo perché «fa audience» (fa audience?). Dopo, ci si produce in continue analisi sul perché la Lega cresca nei sondaggi, celebrando le doti del leader, le sue abilità comunicative, la sua bravura ad intercettare gli umori popolari. La Lega cresce perché Salvini è in televisione due volte al giorno. Una parte secondaria del merito va anche alla sua capacità di individuare poche chiare questioni per posizionarsi sul mercato (No all’Euro e all’immigrazione). Ma nessuno se ne accorgerebbe se non ci fosse la prima condizione.
Si può immaginare quali siano gli effetti sperati di questa campagna di successo. Partiamo dal settore di mercato che deve conquistare: il suo principale destinatario sono i ceti popolari, cioè il principale target di tutte le più recenti campagne per il lancio dei leader, che infatti sono cresciuti elettoralmente innanzitutto in quell’area.
Primo effetto: la Lega, nel suo nuovo vestito lepenista, è in grado di spostare il discorso sulla crisi dal piano sociale a quello della sicurezza. Una funzione fondamentale, mentre riemerge in Italia una dialettica sociale che riguarda il lavoro e le condizioni di vita dei settori popolari. A questo si aggiunga la campagna, lanciata dal Corriere e ripresa dai talk show, sulle case occupate. Primo risultato: la rappresentazione è quella di un mondo popolare infiltrato dalla criminalità e il cui problema principale sono gli immigrati. Il suo secondo e terzo problema sono i politici e i sindacati.
Secondo effetto: Renzi è stato in questi mesi il monopolista del mercato politico. Ma la rappresentazione spettacolare dello sport politico non regge se non c’è un nemico, l’antagonista, lo sfidante, il cattivo. A che cosa appassionarsi altrimenti? Il mercato è competizione, il prodotto vincente deve essere sfidato dal prodotto che lo sostituirà. In più: nella prossima campagna elettorale l’ex monopolista potrà dire che bisogna votare Pd per evitare il pericolo-Lega. Così, mentre l’elettorato di sinistra sarà tentato di votare un nuovo possibile soggetto politico, si potrà ancora ricorrere alla magia del voto utile.
Il tema centrale è dunque lo spostamento del conflitto sociale su altri piani. Il prodotto-Grillo e il prodotto-Renzi l’hanno spostato sul piano delle opposizioni tra vecchio e nuovo, tra sistema (politico) e anti-sistema, tra Casta e anti-Casta. Adesso bisogna trovare qualche nuovo terreno di gioco, non si può fare sempre la stessa gara (il pubblico si annoierebbe e guarderebbe altrove). Ed ecco riemergere la questione-sicurezza, eterna Fenice che risorge nei momenti di possibile mutamento politico. Il Corriere della Sera a questi reality partecipa sempre con entusiasmo e da protagonista: il brand della Casta, come la campagna sulla legalità nelle periferie, è nato sulle sue colonne.
Contemporaneamente, tutti i media celebrano dalla mattina alla sera la messa cantata delle virtù dell’impresa. Gli imprenditori licenziano, chiudono, delocalizzano, non pagano i dipendenti, li forzano a dimettersi, rendono le aziende luoghi invivibili (si trovi qualcuno che è contento del suo lavoro) e privi di libertà, non investono in ricerca, corrompono i politici, cercano unicamente posizioni di mercato protette (la meritocrazia è per qualcun altro, è competizione tra i destinatari di queste campagne pubblicitarie). Ma la rappresentazione unanime degli imprenditori è quella degli eroi (in prima fila, nella messa cantata, c’è Salvini). Nei talk show circola costantemente anche una nuova figura: il giovane startupper, magari emigrato in America per aprire un’impresa innovativa che dà tanti posti di lavoro a giovani di talento (agli altri no, se non hai talento puoi stare a casa). Lo sturtupper, vestito a metà tra il virtuoso dello skateboard e il proprietario di un Fondo investimenti, occupa più o meno la posizione del Messia: lo si mette al centro dello studio, lo si celebra, gli si chiede a bocca aperta «Cosa dobbiamo fare?», si punta il dito verso la telecamera e, soprattutto se si è un giornalista del Corriere della Sera, si dice: giovani, avete capito? Dovete fare così.
In questi anni si è esagerato a celebrare la fine della centralità del conflitto di classe in società che erano e restano capitalistiche. Questo conflitto si presenta sempre in forme spurie, cambia nel tempo, a volte è difficile da leggere, ma incide sempre in modo determinante sulla politica. Molte cose rilevanti possono essere lette a partire da questa chiave, che ovviamente non è mai esaustiva. Per esempio, può essere letta così tutta la traiettoria che va dal Pci al Pd: il suo spostamento dalla centralità del lavoro alla centralità dell’impresa è il nucleo fondamentale di ogni suo cambiamento. Oppure le vicende politiche che vanno dal 2006 a oggi: la campagna per la lotta alla Casta e per la diffusione dell’antipolitica, lanciata mentre in Parlamento c’erano 150 rappresentanti della sinistra radicale; la creazione, nello stesso periodo, del Pd, con la promozione del Veltroni innovatore che correva da solo; la grande coalizione Pd-Forza Italia; Renzi; Salvini. Non si possono leggere questi eventi senza considerarli anche un momento del conflitto di classe dei ricchi contro i poveri (e contro i loro rappresentanti), contemporaneo all’esplodere di una crisi finanziaria, economica e sociale quasi-permanente.
Un nuovo soggetto politico della sinistra può solo ripartire da questo luogo, da questo tema e da questi soggetti. Dagli alleati e dagli avversari che può avere in questo contesto. Bisogna farlo in modo innovativo, certo, ma senza più indugiare su alibi come «la società è cambiata», «non ci sono più le grandi fabbriche», «ormai gli operai votano a destra»
 «Se ci si azzarda a dire “approvare una moratoria immediata del consumo di suolo”, o “spostiamo i soldi dalle grandi opere alla cura del territorio” scatta l’allarme rosso. Emerge d’un colpo l’ipocrisia di gran parte della politica e di tanti commentatori».
«Se ci si azzarda a dire “approvare una moratoria immediata del consumo di suolo”, o “spostiamo i soldi dalle grandi opere alla cura del territorio” scatta l’allarme rosso. Emerge d’un colpo l’ipocrisia di gran parte della politica e di tanti commentatori».
Il Fatto Quotidiano, 24 novembre 2014
Nelle ultime settimane, dopo le frane e le esondazioni che hanno provocato morti e che hanno messo in ginocchio la Liguria, la Toscana, il Piemonte e la Lombardia, si susseguono le trasmissioni e gli editoriali che cercano di individuare responsabilità e di immaginare le cure possibili al dissesto idrogeologico del nostro paese, per risollevare lo stivale dal fango in cui sprofonda.
Di fronte alle immagini apocalittiche del Polcevera, del Bisagno, del Seveso, tutti si indignano e si costernano. E l’elenco delle proposte per porre rimedio è lungo. Bisogna rifare gli argini dei fiumi! Bisogna fare manutenzione a tutta le rete idrica! Bisogna smetterla con i condoni! Bisogna curare i boschi e le montagne! Bisogna trovare i soldi per realizzare le opere necessarie alla messa in sicurezza! Bisogna fare prevenzione e riorganizzare la protezione civile! Bisogna cancellare il patto di stabilità che impedisce ai comuni di intervenire!
Fin qui tutti d’accordo (o quasi, perché sui condoni edilizi, una manina furbetta che scriva l’emendamento nascosto da inserire in qualche provvedimento, si trova sempre…).
Ma se qualcuno si azzarda a dire “bisogna approvare una moratoria immediata del consumo di suolo”, oppure “spostiamo i soldi dalle grandi opere alla cura del territorio” scatta l’allarme rosso. Ed emerge tutta d’un colpo l’ipocrisia di gran parte della politica e di tanti commentatori.
Perché finché si tratta di restare sulle enunciazioni di principio, dicendo cose come “curiamo l’ambiente e sistemiamo gli argini dei fiumi", tutto ok. Applausi bipartisan.
Ma se si esclama “Stop al Consumo di Territorio subito, con decreto legge!”, si riceve come risposta immediata: “Impossibile! Va bene essere ambientalisti ma fino a un certo punto!” Se si propone “usiamo i soldi del TAV in val di Susa, del Terzo Valico o della Orte-Mestre! per sistemare il Polcevera, il Bisagno, il Seveso”, arriva puntuale la controrisposta: “Basta con queste provocazioni! Quelle grandi opere servono per creare posti di lavoro ed essere competitivi! Basta demagogia!”
Certo, perché va bene essere dalla parte del diritto dei cittadini a vivere sicuri di non essere travolti da un’alluvione o da una frana (circa 5,8 milioni di italiani), ma non vorremo mica davvero mettere in discussione il potere «degli energumeni del cemento armato», come li chiamava Antonio Cederna?
La narrativa controversa come il decennio. «Periodo così cupo e controverso nell’immaginario collettivo, anche il momento di massima applicazione dei principi costituzionali» (Gabriele Vitello, L’album di famiglia. Gli anni di piombo nella narrativa italiana). Il manifesto, 23 novembre 2014

 «La grande questione che ha di fronte a sé la sinistra politica è quella di istituzionalizzare il conflitto, dargli cioè una rappresentanza stabile. Ormai la crisi procede per accumulazioni successive, da quantitativa si è fatta qualitativa; si è trasformata in crisi organica, che sconvolge ogni aspetto della Repubblica».
«La grande questione che ha di fronte a sé la sinistra politica è quella di istituzionalizzare il conflitto, dargli cioè una rappresentanza stabile. Ormai la crisi procede per accumulazioni successive, da quantitativa si è fatta qualitativa; si è trasformata in crisi organica, che sconvolge ogni aspetto della Repubblica».
Il manifesto, 22 novembre 2014
«Coloro che dannono i tumulti intra i Nobili e la Plebe mi pare che biasimino quelle cose che furono prima causa del tenere libera Roma…». Già il Machiavelli dei “Discorsi” aveva istituito un saldo legame tra conflitto e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
E Giuseppe Di Vittorio, nel presentare all’inizio degli anni Cinquanta del secolo scorso un primo progetto di Statuto dei Lavoratori, avvertì che «la democrazia se c’è nella fabbrica c’è anche nel Paese» e, al contrario, «se la democrazia è uccisa nella fabbrica essa non può sopravvivere nel Paese».
La grande questione che ha di fronte a sé la sinistra politica è quella di istituzionalizzare il conflitto, dargli cioè una rappresentanza stabile. Non da oggi, certo.
Ma ormai la crisi procede per accumulazioni successive, da quantitativa si è fatta qualitativa; si è trasformata cioè da crisi congiunturale in crisi organica, che sconvolge ogni aspetto della Repubblica: economico, sociale, istituzionale. Già si intravedono, minacciosi, disegni per una sua soluzione scopertamente reazionaria. Di qui l’urgenza della ricostruzione di un rapporto virtuoso tra conflitto e rappresentanza politica. Per riprendere i termini di Ernesto Laclau, sul momento orizzontale del movimento si deve saldare il momento verticale della lotta per l’egemonia.
I motivi per cui questo intreccio virtuoso non si è fino ad ora prodotto sono molteplici, fortemente radicati in errori soggettivi, primo tra tutti la mancanza di unità tra le varie forze politiche della sinistra. Ma ci sono cause ulteriori da indagare. Prima tra tutte: può essere ancora il partito novecentesco la sintesi tra conflitto sociale e lotta egemonica? Allo stato dei fatti, i partiti tradizionali attraversano una crisi della propria ragione sociale tutt’altro che episodica. Ridotti a comitati elettorali al servizio del leader di turno, risolvono spesso la propria funzione in quella di “uffici di collocamento” per un ceto medio ipertrofico e in crisi di identità sociale, speranzoso di trovare nel “mestiere politico” un’àncora di salvataggio contro l’inesorabile degradare della propria posizione sociale.
Schiere di candidati si aggrappano a quest’àncora ad ogni tornata elettorale, fino a superare talvolta in numero, per sommo paradosso, gli affluenti al voto. Il trasformismo più estremo è all’ordine del giorno, per cui si trama nei corridoi del Palazzo per allungare legislature ingiustificatamente sopravvissute alla fine della spinta propulsiva dei risultati elettorali che le avevano prodotte. Leggi elettorali liberticide sono promulgate nell’assenso acritico della Camere. Gli enti locali, da elementi di democrazia diretta e popolare, sono ridotti a passacarte delle direttive fiscali dei governi centrali, in nome delle ragioni della “ditta” da far prevalere su quelli della cittadinanza.
La destra cavalca questa crisi della funzione sociale dei partiti, mentre la sinistra stenta, per antico abito mentale (comprensibilmente) duro ad estinguersi, a coglierne i motivi di lungo periodo. Eppure essi dovrebbero essere oggetto di attenta analisi.
Il partito di massa delle classi subalterne si configura, nei sui albori decimononici, come anti-Stato. Il partito è lo strumento di cui le classi subalterne si dotano per agire all’interno dello Stato liberale, e al tempo stesso trasformarlo. Esso nasce per unificare le lotte e dare loro continuità. Se il partito operaio contiene in sé i germi del pluralismo fin dalla sua formazione, la forza trainante è individuata nel proletariato di fabbrica, inteso come classe generale. Questo schema entra in crisi con la rivoluzione del “lungo ‘68″. In questo periodo il conflitto tra classi subalterne ed élite tradizionali da un lato assume la sua massima intensità; dall’altro, per così dire, esplode; si frantuma. Accanto alle lotte del proletariato di fabbrica, riconoscendone solo in una prima fase la guida, fanno la propria comparsa, e poi via vi acquistano rispetto ad esse un grado crescente di autonomia, quelle degli studenti, per l’emancipazione femminile, per la pace, per la salvaguardia dell’ambiente, tutte egemonizzate da una nuova classe media in ascesa.
L’inizio della restaurazione conservatrice si porta dietro la rottura dell’unità tra il movimento operaio e queste nuove classi medie. Si registra, in questi movimenti, un alto tasso di “integrabilità” nel sistema capitalistico, che ne adotta le istanze di avanguardia per rinnovarsi e rinvigorirsi. Il partito operaio di massa, in questo contesto, entra in crisi. Entra in crisi la sua capacità di unificazione ed organizzazione del conflitto. All’interno dei partiti, il rapporto tra intellettuali e militanza operaia si inverte, con i primi che ascendono facilmente e frettolosamente ai posti dirigenti e la seconda che è vissuta quasi come un residuo fastidioso. Si giunge per questa via all’espulsione dei ceti subalterni dalla rappresentanza politica diretta. Ceti subalterni i quali, a loro volta, in parte subiscono questo allontanamento, in parte lo promuovono attraverso l’affermazione, tra di essi, di un nuovo senso comune che rimette in discussione l’utilità e la necessità dell’azione collettiva, e di nuovi modelli di consumo del tempo libero.
In questa fase di scomposta ritirata siamo ancora immersi, proprio nel momento in cui il conflitto sociale riprende vigore. Invece di attardarsi in tentativi di riesumazione di una esperienza storica forse irripetibile, serve trovare risposte innovative. È urgente la creazione di un fronte pluralistico della istanze popolari che sorgono dalla società civile in lotta, cercando di ridurle ad unità in base ad una elaborazione collettiva e ad una ricostruzione di un senso comune che sancisca la loro non-contraddizione; e modellando, su queste nuove modalità di istituzionalizzazione del conflitto, adeguate proposte di rinnovamento democratico delle istituzioni repubblicane. Dalla ricostruzione di questo intreccio virtuoso tra conflitto sociale e risposta politica dipende il futuro della nostra democrazia.
 «E' l’opinione di Hanif Kureishi, lo scrittore anglo-pachistano: “Sono giovani che vivono ghettizzati nella miseria Cercano un modello alternativo al consumismo occidentale”».
«E' l’opinione di Hanif Kureishi, lo scrittore anglo-pachistano: “Sono giovani che vivono ghettizzati nella miseria Cercano un modello alternativo al consumismo occidentale”».
La Repubblica, 21 novembre 2014 (m.p.r.)
 L’ennesima testimonianza del degrade di una politica, ben rappresentata dal solito noto, che, pretendendo di rottamare la storia ha cancellato qualunque ragionevolezza nell’agire. Un buona domanda di Massimo Veltri e una ottima risposta, come al solito, di Corrado Augias.
L’ennesima testimonianza del degrade di una politica, ben rappresentata dal solito noto, che, pretendendo di rottamare la storia ha cancellato qualunque ragionevolezza nell’agire. Un buona domanda di Massimo Veltri e una ottima risposta, come al solito, di Corrado Augias.
La Repubblica, 21 novembre 2014
Lettera di Massimo Veltri
Caro Augias, anni fa sono stato capogruppo Pds in Commissione Ambiente e Territorio del Senato. Credo d’aver svolto una buona attività per la difesa del suolo. Mi chiedo oggi con inquietudine perché, fra gli argomenti toccati in relazione alle frane e alluvioni che ci flagellano, è sempre come se dovessimo partire da capo.
Risposta di Corrado Augias
C’è in questa lettera una domanda chiave: perché ci comportiamo sempre come se fosse la prima volta che succede? Ho sentito in tv esponenti di spicco dei vari partiti, a partire dal Pd, fare dichiarazioni piene di lodevoli propositi: vedremo, faremo, bisognerà, è necessario, si dovrà. Aria fritta.
 Osservando le gesta del Renzi stupiscono due cose: (1) che ci sia ancora nel mondo qualcuno che lo ritiene un uomo di sinistra: (2) che continuino a stare nel suo stesso partito persone che ancora sostengono di nutrire sentimenti e convincimenti di sinistra.
Osservando le gesta del Renzi stupiscono due cose: (1) che ci sia ancora nel mondo qualcuno che lo ritiene un uomo di sinistra: (2) che continuino a stare nel suo stesso partito persone che ancora sostengono di nutrire sentimenti e convincimenti di sinistra.
Il manifesto, 20 novembre 2014
Affermare che «i sindacati cercano scuse per scioperare» è una provocazione voluta, però è anche musica per le orecchie di chi osserva dall’alto con sguardo commiserevole tutti quelli che la crisi colpisce più duramente, quelli che vivono e sopravvivono di stipendio, di pensione, di precarietà.
Dire che lui i posti di lavoro «li crea», che in fondo «Camusso e Salvini sono due facce della stessa medaglia» rivela un forcing che dalla rottamazione della «vecchia politica» (che in realtà era soprattutto emarginazione del gruppo dirigente del Pd), ora procede spedito per impaurire e convincere i perdenti che se non stanno con lui avranno da perdere assai di più, in un gioco al rimbalzo del più precario, del più povero. Così si permette, sulla scia del lepenismo in salsa leghista, di sfottere i lavoratori che lo sciopero lo pagano direttamente sul magro salario. Chi dimentica questo aspetto è un reazionario.
Ma il presidente del consiglio, che intende il governo come esercizio di un potere senza opposizione, perché chi osa criticare è solo un gufo, è anche il segretario del Pd, cioè di una forza che in teoria dovrebbe considerare il mondo del lavoro come casa sua. Abbiamo capito, invece, che Renzi si sente a casa quando incontra la Confindustria di Squinzi.
Non risulta che di fronte a questo attacco sistematico verso il mondo del lavoro si sia alzata una voce di risposta. O che un Bersani, massimo rappresentante fino a ieri del Pd, si sia sentito in dovere di replicare altrettanto duramente. Questo imbarazzante silenzio non deve stupire più di tanto, segna una linea di continuità con l’acquiescenza con cui il Pd ha accolto e sottoscritto, da Monti in poi, tutte le politiche di smantellamento dello stato sociale. Come del tutto congruente è la parte in commedia recitata da alcuni parlamentari della minoranza interna, protagonisti di una simil-trattativa sul Jobs Act il cui esito era già scritto nel testo votato dalla stragrande maggioranza della direzione.
L’unica concreta protesta contro le politiche di smantellamento delle tutele e dei diritti residui del lavoro viene oggi dal sindacato di Susanna Camusso e dalla Fiom. Con la manifestazione del 25 ottobre e ora con lo sciopero generale, la Cgil ha messo in campo la possibilità di un’opposizione sociale nel paese. E la scelta della Uil di unirsi al 12 dicembre, è un altro passo importante.
Anziché sfottere, il segretario-presidente farebbe bene ad ascoltare le campane di una protesta che suonano soprattutto per lui.
 «Un sindaco scelto con le primarie e poi eletto dai cittadini viene sbugiardato da una segreteria di partito che vorrebbe imporgli i nomi degli assessori. Dettano legge ras e capetti di corrente che non sono stati votati da nessuno (anzi, molti di loro hanno perso le primarie per cui hanno gareggiato) o hanno conquistato un posto con la riffa delle preferenze».
«Un sindaco scelto con le primarie e poi eletto dai cittadini viene sbugiardato da una segreteria di partito che vorrebbe imporgli i nomi degli assessori. Dettano legge ras e capetti di corrente che non sono stati votati da nessuno (anzi, molti di loro hanno perso le primarie per cui hanno gareggiato) o hanno conquistato un posto con la riffa delle preferenze».
L'Espresso, 20 settembre 2014
Il sindaco di Roma Ignazio Marino è indifendibile, per tanti motivi. Il puntare tutto sui Fori Imperiali pedonalizzati che in giornate di pioggia come oggi sono ridotti a una risaia asiatica. La Panda rossa e le multe fantasma, più da ridere che da indignarsi. La vanità personale che gli fa dire cose tipo «la linea C della metro è su tutti i giornali del mondo» (sì, ma per la lentezza dei lavori). Il senso di spaesamento che lo accompagna ovunque va, in bicicletta nel centro storico o di fronte alla folla inferocita di Tor Sapienza.
Oggi difendere Marino significa fare come il Marco Antonio nel Julius Caesar di Shakespeare, il capo pugnalato dai suoi dalle parti del Campidoglio: «Vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo… Il nobile Bruto v’ha detto che Cesare era ambizioso: se così era, fu un ben grave difetto: e Bruto è uomo d’onore». Ecco, Marino sarà indifendibile, ma chi accusa oggi Marino può vantare più o meno lo stesso onore di Bruto. E minore coerenza, trasparenza. Coraggio politico.
Quello che sta succedendo a Roma è una storia istruttiva per la politica nazionale, per capire cosa è o che cosa potrebbe diventare il Partito della Nazione di Renzi. Venerdì scorso, mentre il sindaco si avventurava con il terrore negli occhi nello sconosciuto viale Giorgio Morandi teatro dei tumulti di Tor Sapienza, dove stanno arrivando gli inviati di guerra e le migliori firme del giornalismo italiano, il Pd, il suo partito, era riunito in largo del Nazareno. Un processo in piena regola con un solo imputato: il dottor Ignazio. La più scatenata era Michela Di Biase, moglie del ministro Dario Franceschini: «Basta essere proni al sindaco, Marino è il più grande gaffeur d’Italia, sta ridicolizzando il Pd». La direzione si è conclusa con una richiesta: il sindaco azzeri la giunta, altrimenti va a casa. Intanto Marino continuava il suo tour in periferia: accanto a lui non un segretario di sezione, un dirigente del partito, un consigliere del municipio (governato dal Pd). Nessuno, a proteggerlo c’era solo un certo Manlio, abitante del quartiere. Serviva coraggio fisico a stare lì, quella sera e tutti gli altri giorni dell’anno.
Nessuno difende Marino. Perché indifendibile, o anche perché il più debole? Davvero sono le gaffe o la Panda rossa il problema? O forse il sindaco gaffeur è semplicemente una persona perbene con molti problemi di comunicazione con la città che però ha detto qualche no di troppo nella giungla della politica romana? Dove l’ex sindaco Gianni Alemanno, impunito, si è organizzato un bel corteo di protesta a nome delle periferie (e contro chi? Contro se stesso?). E il principale partito lascia solo il suo sindaco a prendere gli insulti e approfitta del caos per chiedere l’azzeramento della giunta, ovvero posti negli assessorati.
Ma il Pd romano, lo stesso che per un anno si è spaccato sul nuovo stadio della Roma, tifando per la cordata dell’uno o dell’altro costruttore, non si è limitato a questo. Per sbrogliare la situazione ha chiesto l’intervento della segreteria nazionale, di Matteo Renzi o del vicesegretario Lorenzo Guerini. Marino è stato convocato in largo del Nazareno e oggi con un’intervista il capigruppo del Pd al Senato Luigi Zanda chiede al sindaco di «obbedire» al partito e di cambiare gli assessori, come gli è stato ordinato. E a questo punto la vicenda da romana diventa nazionale.
Era da anni che non si vedeva uno spettacolo del genere. Un sindaco scelto con le primarie e poi eletto dai cittadini viene sbugiardato da una segreteria di partito che vorrebbe imporgli i nomi degli assessori. Dettano legge ras e capetti di corrente che non sono stati votati da nessuno (anzi, molti di loro hanno perso le primarie per cui hanno gareggiato) o hanno conquistato un posto con la riffa delle preferenze. Non per cambiare la città, sia chiaro, o per rovesciare il sindaco ma ammettendo le loro responsabilità. No, si chiede il commissariamento, togliere potere al sindaco incontrollabile e restituirli al partito, anzi, al Partito, cone se esistesse ancora quello con la maiuscola. Dimenticando che Marino fu scelto da Goffredo Bettini e poi eletto sindaco in un momento in cui l’intera segreteria cittadina era dimissionaria, la dirigenza si era volatilizzata e nessuno voleva metterci la faccia. Era la primavera del 2013, Grillo era ancora fortissimo e faceva paura, Alfio Marchini stava macinando voti, all’epoca i coraggiosissimi dirigenti del Pd romano che oggi reclamano le dimissioni si nascosero dietro la figura del chirurgo. Quello che oggi gli viene imputato, di essere un alieno estraneo alla città, un anno e mezzo fa sembrò essere il suo punto di forza. Se Marino avesse vinto, avrebbe trascinato anche il Pd. Se avesse perso, sarebbe stata unicamente colpa sua.
Roma non è l’unico caso nazionale. C’è l’Emilia che sta per andare al voto nell’assoluta disaffezione dell’elettorato. Ma in quel caso dalla segreteria nazionale è arrivata l’indicazione opposta, non disturbare il candidato Stefano Bonaccini, in nome dell’autonomia del partito regionale. Il Pd, il Partito della Nazione, dopo pochi mesi all’ombra della leadership dello Statista internazionale Renzi, sembra già un partito della Prima Repubblica allo stato terminale. Divisa in correnti individuali (i micro-notabili del politologo Mauro Calise vivono, anzi prosperano) e con l’arroganza che deriva dalla certezza dell’impunità (politica). Se c’è un solo partito di governo in campo, quello di Renzi, se non esiste nessuna alternativa, lo scontro si sposterà tutto all’interno, come avveniva nella vecchia Dc. Calcoli miopi, perché poi un’alternativa si trova sempre, a Roma e in Italia, magari dalla parte sbagliata. E infine: come avrebbe reagito il sindaco di Firenze Matteo Renzi se da Roma il Pd lo avesse convocato per consegnargli la lista degli assessori?
Per questo Marino sarà indifendibile. Ma peggio di lui un partito che lo scarica così. Con quale coraggio.
 «L'obiettivo esplicito e perseguito (e purtroppo raggiunto) dal neoliberismo era (è) quello di voler essere non solo una teoria economica ma una autentica antropologia, per la edificazione di un uomo nuovo neoliberista la cui vita fosse (sia) solo economica». Una recensione dell'ultimo libro di Marco Revelli.
«L'obiettivo esplicito e perseguito (e purtroppo raggiunto) dal neoliberismo era (è) quello di voler essere non solo una teoria economica ma una autentica antropologia, per la edificazione di un uomo nuovo neoliberista la cui vita fosse (sia) solo economica». Una recensione dell'ultimo libro di Marco Revelli.
Sbilanciamoci.info, 11 novembre 2014
La curva di Laffer e la curva di Kuznets. Sono questi gli obiettivi centrali dell’analisi di Marco Revelli nel suo ultimo saggio breve sul tema della disuguaglianza, uscito tra gli Idòla di Laterza e che riprende e sviluppa un tema al centro dell’attenzione (Luciano Gallino, Mario Pianta, Joseph Stiglitz e ora anche Thomas Piketty) con un titolo ad effetto ma sempre replicato dalla realtà: La lotta di classe esiste e l’hanno vinta i ricchi. Vero! La curva di Laffer e quella di Kuznets: due favole economiche nate in epoche diverse (la prima, nel 1974 e – secondo una leggenda metropolitana probabilmente falsa ma capace di colpire l’immaginario collettivo - disegnata da Laffer su un tovagliolo di un noto ristorante di Washington; la seconda, risalente invece al 1955), ma usate come armi pesanti nella costruzione e nella propagazione dell’ideologia neoliberista. Ideologia.
Oppure e forse meglio (e oltre Revelli, ma con Foucault) come biopolitica/bioeconomia neoliberale (concetto che preferiamo), posto che l’obiettivo esplicito e perseguito (e purtroppo raggiunto) dal neoliberismo era (è) quello di voler essere non solo una teoria economica ma una autentica antropologia, per la edificazione di un uomo nuovo neoliberista la cui vita fosse solo economica e a mobilitazione incessante e a flessibilità crescente (lavoratore, consumatore, poi imprenditore di se stesso, precario, nodo della rete), uccidendo il vecchio soggetto illuministico titolare di diritti e trasformandolo in oggetto economico, in merce di se stesso, in capitale umano, in nodo di un apparato. Una biopolitica neoliberista che ovviamente si è subito trasformata in tanatopolitica, perché doveva produrre, per raggiungere il proprio scopo la distruzione (appunto la morte) della società e della socialità, della democrazia politica ed economica, facendo della disuguaglianza il suo target da perseguire e dell’impoverimento la sua disciplina (ancora Foucault) capillare. Qualcosa di paradossale e di assolutamente irrazionale (oltre che di anti-moderno) – appunto: la produzione deliberata di disuguaglianza – ma che tuttavia ha conquistato il cuore di troppi economisti e l’opportunismo di troppi politici diventando spirito del tempo ottuso e ostinato ma capace di volare sull’intero globo.
Questa opzione disegualitaria, se non (scrive Revelli) “apertamente anti-egualitaria”, questa ideologia della disuguaglianza necessaria continua infatti ad essere parte integrante o base strutturante di quella “dogmatica neoclassica che ha offerto il proprio hardware all’ideologia neoliberista fin dall’origine della sua lotta per l’egemonia, alla fine degli anni Settanta e per tutto il corso degli anni Ottanta del secolo scorso”. Disuguaglianze crescenti e quindi e conseguentemente lotta di classe vinta dai ricchi contro il resto del mondo. Attraverso i piani diaggiustamento strutturale del Fondo monetario e della Banca mondiale, le politiche di deregolamentazione dei mercati finanziari e del lavoro, la riduzione dei diritti sociali, oggi l’austerità europea e le riforme strutturali di Draghi, di Angela Merkel e di Matteo Renzi (strutturale: una parola magica per una pedagogia finalizzata alla strutturazione e alla costruzione - è una biopolitica e insieme una forma di costruttivismo - della società come mercato).
Quella uguaglianza che era “l’idea regolativa” o la meta da raggiungere nei trenta gloriosi o nell’età dell’oro del secolo breve secondo Hobsbawm, è stata così rovesciata nel perseguimento dell’obiettivo opposto e contrario, quello appunto della disuguaglianza. Una svolta copernicana, scrive Revelli, che ha avuto “come naturale complemento della supply-side economy – e sua copertura morale – la cosiddetta teoria del trickle-down (letteralmente, ‘gocciolamento)”, per cui se si favoriscono i soggetti che trainano lo sviluppo economico - i capitalisti, i grandi investitori, il potere finanziario – si genera spontaneamente un meccanismo virtuoso “il quale crea ricchezza aggiuntiva e in parte la ridistribuisce per una sorta di ‘forza di gravità’ naturale, senza che l’intervento dello Stato giunga a turbare o inceppare il meccanismo”.
Dunque, la curva di Laffer, favola di uno sconosciuto professore di una periferica business school e diventata poi icona della Reaganomics, sulla base di un ipotetico trade-off tra aliquote ed entrate fiscali. E la curva di Kuznets, secondo la quale un accelerato sviluppo economico produce sì, in una prima fase, disuguaglianze crescenti ma solo fino a un punto di svolta, superato il quale il sistema comincia invece a generare uguaglianza. Nata senza pretendere di avere un valore predittivo né prescrittivo, negli anni Settanta ne venne fatto invece un uso ideologico “al fine di neutralizzare le critiche nei confronti degli effetti disegualitari del modello di sviluppo patrocinato dai fautori della supply-side economy e di propagandare le spregiudicate politiche di imposizione del modello neoliberista ai paesi in via di sviluppo, nonostante gli effetti negativi sui loro equilibri sociali”. Una sua variante venne applicata anche ai temi ambientali, dove era l’inquinamento a scendere, dopo una iniziale fase di sua necessaria crescita.
Due curve-icona, due feticci neoliberisti che Revelli smonta – con una lunga sequenza di statistiche e di analisi empiriche e legando il tema dei redditi calanti ai debiti crescenti (soprattutto privati, come modo per disinnescare politicamente e socialmente l’impoverimento prodotto) – dimostrandone l’assoluta falsità. Le disuguaglianze sono cresciute. La crisi prodotta dal neoliberismo resta crisi e anche l’ambiente è messo sempre peggio, come dimostrato dall’ultimo Rapporto dell’Ipcc dell’Onu. Come falsa era la congettura del gocciolamento.
Citando Keynes e la sua metafora delle giraffe dal collo lungo, Revelli conclude che tale teoria ha semmai “giustificato e incentivato la tendenza bulimica dei colli lunghi”. Favorendo appunto l’avidità delle giraffe dai colli lungi, anzi lunghissimi: gli gnomi di Wall Street e i “velieri corsari dei mercati finanziari”, gli uomini di banca, gli hedge-fund, i conti off-shore (e ora potremmo aggiungere Juncker e il suo Lussemburgo-paradiso fiscale). Mentre le giraffe dal collo corto – che deve restare corto o farsi sempre più corto – continuano a generare una ricchezza “che viene sistematicamente risucchiata in alto, nel circuito da loro inattingibile di una finanza onnipervasiva, diventata principio di organizzazione principale dello stesso assetto produttivo globale e, insieme, proprietaria degli ambiti decisionali strategici, a cominciare da quello politico”.
Revelli, da par suo e con il suo stile, smonta dunque il paradigma (l’ideologia o la biopolitica/tanatopolitica) neoliberista. Ma questo paradigma resta saldamente al potere. Smontare il suo hardware è dunque necessario come necessario è non smettere mai di farlo, altrimenti la sua egemonia e il suo dominio resteranno tali per sempre. Senza dimenticare tuttavia di smontare anche il software (il pensiero unico, il senso comune dominante, l’accettazione del principio per cui non ci sarebbero alternative al capitalismo, la falsa individualizzazione offerta dal consumo, la condivisione in rete, i social network) che incessantemente e contro ogni evidenza, lo giustifica e lo legittima.
 «Alla mobilitazione in strada si uniscono i consigli comunali che continuano a pronunciarsi contro lo Sblocca Italia e chiedono al governatore della Basilicata,e al capogruppo dei socialdemocratici all’Europarlamento, di impugnare l’articolo 38 e salvare Regione e cittadini dai rischi ambientali e sanitari che comporterebbero le trivellazioni».
«Alla mobilitazione in strada si uniscono i consigli comunali che continuano a pronunciarsi contro lo Sblocca Italia e chiedono al governatore della Basilicata,e al capogruppo dei socialdemocratici all’Europarlamento, di impugnare l’articolo 38 e salvare Regione e cittadini dai rischi ambientali e sanitari che comporterebbero le trivellazioni».
Il Fatto Quotidiano, 19 novembre 2019 (m.p.r.)

La pioggia non ferma la protesta in Basilicata contro lo Sblocca Italia. Anche ieri circa un migliaio tra studenti e cittadini, secondo i dati diffusi dagli organizzatori, hanno manifestato a Potenza, arrivando in corteo fino al palazzo della Regione, per continuare a dire no alle ricerche petrolifere e alle trivellazioni autorizzate dallo Sblocca Italia e che minacciano la regione. Al corteo del capoluogo ieri si è unita anche la protesta di circa un paio di migliaia di cittadini e studenti a Venosa. Il consiglio comunale del centro lucano ha chiesto alla Regione di impugnare anche gli articoli 35, 36 e 37 del decreto Sblocca Italia, per non favorire lobby dei rifiuti oltre a quella del petrolio. È proseguita così anche ieri la protesta, arrivata al sesto giorno consecutivo, che vede gli studenti protagonisti e motore propulsivo. Intanto alla mobilitazione in strada si uniscono i consigli comunali che continuano a pronunciarsi contro lo Sblocca Italia e chiedono al governatore della Basilicata, Marcello Pittella del Pd, fratello di Gianni, capogruppo dei socialdemocratici all’Europarlamento, di impugnare l’articolo 38 e salvare Regione e cittadini dai rischi ambientali e sanitari che comporterebbero le trivellazioni. Il presidente avrebbe rassicurato i cittadini dicendo di non avere intenzione di impugnare l’articolo 38. Ricerche e perforazioni, ha detto Pittella, avverranno nel pieno rispetto della salute dei cittadini e dell’ambiente.
 Renzi vuole rottamare la politica ambientale degli ultimi vent’anni. Ma dovrebbe rottamare i governi dei condoni edilizi, ambientali, fiscali: cioè i governi Berlusconi.
Renzi vuole rottamare la politica ambientale degli ultimi vent’anni. Ma dovrebbe rottamare i governi dei condoni edilizi, ambientali, fiscali: cioè i governi Berlusconi.
Articolo21.org, 17 novembre 2014
Il governo Renzi, fin qui, ha voluto fortemente quel decreto Sblocca Italia col quale si cerca di far ripartire edilizia e lavori pubblici riducendo o cancellando tutele, vincoli e controlli sull’uso del territorio. L’esatto contrario di quel Salva Italia di cui abbiamo urgente bisogno, cioè del ripristino di strumenti di verifica, della elaborazione di piani nazionali e regionali idrogeologici, della loro pianificata attuazione in un quindicennio. Invece Matteo Renzi vuol “rottamare gli ultimi vent’anni di politica ambientale” con ciò individuando il “nemico” nelle Regioni. Alcune, a cominciare dalla sua Toscana, gli rispondono che una colpa fondamentale ce l’hanno i condoni edilizi e ambientali decisi dal governo. Già, da quale governo negli ultimi vent’anni? Dai governi Berlusconi, dell’ “amico” e alleato Silvio, a partire dal 1994 per chiudere col 2009, a volte edilizio e ambientale, altre edilizio e fiscale. Congedo col Piano Casa che le Regioni stanno ancora riproponendo col “gonfiamento”, fra l’altro, di cubature per l’edilizia esistente. Quindi Renzi dovrebbe anzitutto “rottamare” Berlusconi e i suoi governi. Cerchiamo di fare discorsi un po’ più seri risalendo alle cause, alle origini di questa vicenda pluriennale, dalla quale escono sfasciati sia il territorio che lo Stato italiano.
Novembre 1966: alluvioni tragiche di Firenze e Venezia. 1970: la commissione De Marchi propone un piano pluriennale di “ricostruzione” del Paese per 10.000 miliardi di lire. Maggio 1989: finalmente il Parlamento vara la legge n. 183 che istituisce le Autorità di bacino, nazionali (dal Po al Volturno) e regionali. Subito Regioni e Comuni ricorrono contro di essa sentendosi spogliati della loro “autorità”. A Londra la Themes Authority ha riunito ben 11.000 enti operando con grande efficacia. Da noi le maggiori Autorità studiano e redigono piani di bacino, localmente contestati e parzialmente finanziati. La Lega propone di dividere in quattro segmenti regionali (Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto) la gestione del Po. Il Titolo V della Costituzione pone allo stesso livello Stato, Regioni, Enti locali…Nel 2000 l’Unione Europea istituisce con direttiva le Autorità di Distretto per la pianificazione e la gestione dei bacini fluviali. I piani devono essere completati per il 2009. L’Ungheria ha già presentato il piano per il bacino del Danubio, l’Italia, sei anni dopo, non ha ancora ottemperato alla direttiva, in generale.
Il rimpianto per la buona legge n. 183 dell’89 (i cui punti essenziali possono essere recuperati) è tale che numerosi e qualificati idro-geologi, amministrativisti, ecc. hanno costituito il Gruppo 183 che periodicamente si riunisce per studi, ricerche, convegni. Le loro proposte si articolano così: 1) facilitazione e incentivazione degli interventi e delle azioni preventive di difesa del suolo; 2) restituzione di centralità al tema della manutenzione programmata del territorio; 3) semplificazione delle procedure amministrative, l’accorpamento dei soggetti istituzionali chiamati in causa, la costituzione di coordinamenti efficaci che presidino l’intero percorso che va dalla programmazione all’attuazione, alla manutenzione e al controllo degli interventi di prevenzione; 4) recupero di istituzioni e meccanismi storicamente affidabili e ingiustamente abbandonati; 5) eliminazione degli sprechi nell’utilizzazione delle risorse economiche e umane disponibili.
Un bilancio: l’Istituto Idrografico Nazionale è stato a suo tempo smembrato. Così confusamente che per alcuni anni la Regione Lazio ha sospeso i rilievi dei regimi di piena e di magra del Tevere, un fiume “pazzo”. L’Istituto Geologico Nazionale è riuscito a completare soltanto al 40 % la carta del Paese. L’Istituto Sismico Nazionale è stato inglobato, ai tempi di Bertolaso, nella Protezione Civile, anche per far fuori il suo direttore, Roberto De Marco, notoriamente di sinistra. L’Istituto Meteorologico Civile ancora non esiste. Vogliamo partire da qui per una visione unitaria, nazionale dei problemi? Gli esperti riuniti nel 2012 ai Lincei hanno constatato un “vuoto di competenze”. La stessa Protezione Civile soffre oggi – dopo anni di assurdo espansionismo (fino a gestire il centenario dei Santi) – di notevoli carenze di fondi. Il Corpo dei Vigili del Fuoco, uno dei più efficienti e generosamente disponibili, rischia di essere anch’esso accorpato. Come il Corpo Forestale. Assurdità della spending review all’italiana.
Poi ci sono i punti critici, ormai cronici. Genova è precipitata dagli oltre 800.000 residenti del 1971 agli attuali 582.000 (-31%). Eppure si continua a costruire, a consumare suoli liberi, magari da rimboschire. Persino nel decennio 2001-2011 le costruzioni, pur di poco (+ 0,6%), sono cresciute, mentre i genovesi continuavano a calare (- 3,2 %). Ma chi a vedere “a monte”? Tutti, o quasi, si fermano “a valle”. A Milano l’acqua straripa da tutte le parti. Da sotto e da sopra. La falda è risalita da quando le industrie siderurgiche e tessili, grandi consumatrici d’acqua, hanno chiuso. Essa minaccia costantemente i piani bassi degli ultimi quartieri e la Linea 3 della metro. Era proprio impossibile prevederlo? No. Fra 2001 e 2011 le costruzioni non sono cresciute in città, ma la popolazione comunale è calata di un altro 1,11 % e, rispetto al picco del 1971, segna un – 28,3 %.
Milano poi è seconda nella impressionante classifica delle città più “impermeabilizzate”, appena dopo Napoli, con un pazzesco 61,47 % fra cemento e asfalto e la contigua Monza è quinta col 48,6%. Questa coltre impermeabile ha impedito a tanta acqua piovana di filtrare: in tre anni è successo a 270 milioni di tonn. di piogge in tutta Italia. Ci fermiamo nel consumo di suoli? Macché. Secondo l’Ispra, nel 2009-2012 è stata “impermeabilizzata” una superficie pari a Milano più Firenze, Bologna, Napoli e Palermo. Un record, malgrado la crisi edilizia. Il 7,3 % del Belpaese è ormai perduto, più del 10 % in Lombardia e nel Veneto (anch’esso in allarme continuo per i fiumi). Piani paesaggistici? Soltanto la Regione Toscana l’ha approvato, con la nuova legge urbanistica, fra polemiche furibonde di cavatori, costruttori, speculatori vari.
Quante sono le costruzioni abusive – ecco l’altro nemico spesso sottaciuto da giornali e tv – alzate nelle golene, negli alvei dei corsi d’acqua o su terreni collinari coperti da vincoli idrogeologici? Una quantità enorme, sempre più colossale man mano che si procede verso sud (ma anche nel Po e affluenti non si scherza) . Se questi abusi – che rendono più micidiali le piene – vengono “sanati” , i disastri non potranno che ripetersi. A Olbia, a Ischia o nella costa del Gargano (Parco Nazionale) la maggior parte delle costruzioni, se non la totalità, sono abusive.
Punti fondamentali per ripartire: attuare finalmente la legislazione UE sui Distretti idrografici, redigere progetti seri, inseriti in piani seri, finanziati non a singhiozzo. La Cassa Depositi e Prestiti si dice disposta a finanziarli se l’UE allenterà eccezionalmente i controllo sul bilancio statale. Sarebbe uno Salva Italia, con l’obiettivo, in 15-20 anni, di “ricostruire” il Paese che alla prima pioggia battente vien giù o va sott’acqua, con morti, dispersi, infortunati, sfollati, traumatizzati. A migliaia. Oltre tutto questi sono posti di lavoro, a migliaia, subito pronti, subito utili.

.Sbilanciamoci.info, 14 novembre 2014
I poteri forti sono, secondo alcuni, quelli che superano le leggi finora valide a favore di altre ancora più forti e assolutamente obbligatorie anche se non sempre conosciute. Spesso si tratta di un potere esterno fortissimo che viene riconosciuto e accettato o sopportato per causa maggiore; sovrapposto alla normale dinamica degli affari e degli affetti per evitare maggiori sofferenze, maggiori guai. In economia e in politica c'è il caso proverbiale del «quarto partito» richiamato da Alcide De Gasperi sul finire degli anni quaranta del secolo scorso, come molto più forte degli altri tre: socialisti, comunisti, democristiani. Ma correva allora la piccola Italia della Ricostruzione e della Guerra Fredda. In un mondo ben più vasto e terribile di quello meschino di economia e politica, di democrazia e guerra, vale sempre il famoso comando di Virgilio al traghettatore che protestava: «Caron non ti crucciare: / vuolsi così cola dove si puote / ciò che si vuole, e più non dimandare». È il canto III dell'Inferno dantesco: già allora la nostra cultura sapeva dell'esistenza di poteri superiori e inconoscibili, e aspettava tempi migliori.
Oggi i poteri forti, economici e culturali, poteri di classe, sono travestiti da Europa. La povera Europa è descritta attentamente nei testi che pubblichiamo in questo speciale: c'è una burocrazia bruxellese senza sentimenti, una finanza crudele, un apparato industriale che, multinazionale e remoto come è, forse risponde a regole ancor più sconosciute. Sono gli articoli di Azzolini, Baranes, Pullano a consentire un rapido sguardo. Poi si parla di poteri più lontani (Diletti), o anche più interni (Martiny), ma pur sempre inarrivabili. Tutti insieme essi descrivono leggi, disposizioni, regolamenti, procedure, abitudini che limitano le nostre scelte nazionali - da dentro oltre che da fuori - ma applicano poteri che valgono anche per noi, a scanso di guai peggiori.
O almeno così crediamo, visto che una minoranza sempre più consistente di nostri connazionali è molto insoddisfatta della situazione attuale e del futuro prossimo venturo che si delinea. Così non teme il cambiamento e sarebbe pronta a rischiare tutto. Decisa, insomma, a scambiare un po' del tranquillo benessere di oggi con una pericolosa e malsicura democrazia, che è l'aspirazione di domani. Il mondo dei poteri forti e sconosciuti da una parte, quello del futuro indecifrabile e molto incerto dall'altra. I poteri sconosciuti cui inchinarsi di qua; e di là altri poteri, difficili da decifrare ma portatori di una magnifica futura democrazia. O rassegnarsi ai poteri forti e sconosciuti o affidarsi agli incerti profitti di un futuro attraente, democratico, ma imprecisato. Tertium non datur.
Ma siamo sicuri che sia così? Se ci dessimo tutti da fare per sostenere e difendere i poteri deboli? Difficile immaginare eresia più invereconda. Gli autori di solito scrivono di poteri deboli per irriderli, per farne un rimprovero alla comunità imbelle che non riesce a esprimere i poteri forti che essi ritengono necessari e che in realtà bramano. I poteri deboli sono invece la capacità di resistere alle oppressioni dei poteri forti, di decidere per sé e per i figli di pochi anni, di andare e di venire. Di imparare e divertirsi, di scegliere e di lavorare, di non essere infastiditi dagli altri, con l'impegno, d'altro canto di non infastidire alcuno.
L'Europa allora sarebbe un paese magnifico, un Erasmus generalizzato, accogliente, nel quale ciascuno può «coltivare il proprio giardino», come suggeriva di fare, con un bel po' di ottimismo, il nostro amato tedesco di Westfalia, francese, concittadino europeo, Candide.
 Ecco il documento che Marco Revelli ha scritto come proposta di manifesto per la formazione politica italiana che prosegua il lavoro iniziato con la campagna elettorale per il Parlamento europeo per incarico del coordinamento italiano della lista "L'altra Europa con Tsipras". Ora è in corso la discussione nella vasta area di riferimento di quella lista. Avremmo voluto pubblicare ben prima, ma altre vicende (e l'età del direttore di questo sito) ci hanno distratti. Il suddetto direttore ha scritto a Revelli che, se si costituirà un soggetto politico basato su questo documento, aderirà senza se e senza ma.
Ecco il documento che Marco Revelli ha scritto come proposta di manifesto per la formazione politica italiana che prosegua il lavoro iniziato con la campagna elettorale per il Parlamento europeo per incarico del coordinamento italiano della lista "L'altra Europa con Tsipras". Ora è in corso la discussione nella vasta area di riferimento di quella lista. Avremmo voluto pubblicare ben prima, ma altre vicende (e l'età del direttore di questo sito) ci hanno distratti. Il suddetto direttore ha scritto a Revelli che, se si costituirà un soggetto politico basato su questo documento, aderirà senza se e senza ma.
perché non si coltivino eccessive aspettative su questo testo che, lo ricordo, è solo una bozza finalizzata alla nostra discussione attuale, voglio precisare che:
1. Non sono le “tesi” del nuovo partito. Non si occupa di tutto ciò che dovrà costituire la nostra identità. Nemmeno del nostro programma (massimo o minimo che dir si voglia) Ha il compito più modesto di mettere a fuoco alcuni aspetti del quadro politico maturati successivamente al 25 maggio (fino ad allora quello che ci univa lo sappiamo) per quanto riguarda la situazione europea creatasi dopo il voto, e la situazione italiana, in particolare segnata dall’accelerazione di Renzi e dalla mutazione genetica del PD.
2. Serve a tentare di definire le coordinate della nostra discussione sul “che fare” nei prossimi mesi (non in tutta la nostra vita), in particolare per quanto riguarda alcune questioni dirimenti: il rapporto tra azione in Italia e azione in Europa; il giudizio sul “renzismo”, che considero la vera discriminante tra chi “è dentro” e chi “sta fuori” dal progetto e, connesso a questo, il giudizio sul PD e sulla sua irrecuperabilità come partito a un discorso di sinistra; le tappe del nostro “processo costituente” e il rapporto tra obbiettivi qualificanti (la presentazione di una lista capace di sfidare Renzi alle prossime elezioni politiche nazionali) e passaggi sottoposti a valutazioni tattiche...
3. Non è dunque un punto di arrivo. E’ il punto di partenza della discussione. Certamente qualcuno lo troverà troppo aperto (include troppi) e altri troppo chiuso (esclude troppi), troppo ampio (tutto il tormentone sul renzismo) o troppo sbrigativo (manca un programma articolato, c’è poco la complessità delle questioni economiche, c’è poco l’ambiente, c’è poco la politica estera e la guerra). Soprattutto resta qui sullo sfondo – ma è il presupposto di tutto il discorso – il contesto della crisi economica e finanziaria globale: la più grave crisi mai attraversata, crisi strutturale, “di sistema”, di cui nessuno oggi intravvede la soluzione e da cui tutti gli assetti sono destinati ad essere trasformati radicalmente. Sono i temi su cui si dovrà lavorate a fondo tutti insieme, una volta accordatici su come e perché stare insieme.
4. Se da questo lavoro scaturisse quanto meno l’uso di un linguaggio comune e l’individuazione delle questioni importanti su cui discutere, allora non sarebbe stato inutile.
Detto questo, buon lavoro a tutti.
Marco Revelli
“Cambiare l’Europa per salvare l’Italia”. Si potrebbe sintetizzare così la proposta che L’altra Europa con Tsipras aveva posto al centro della scorsa campagna elettorale. Significava che la partita vera, quella per la quale un paese sopravvive o va giù, si giocava a quel livello: sulla possibilità di rovesciare l’intero impianto delle politiche europee sostenute dai paesi forti dell’Unione e incentrate sull’Austerità. Che senza una modificazione sostanziale e radicale di quelle politiche comunitarie, l’Italia sarebbe stata condannata o a un brusco default (in caso di fuoriuscita dall’Euro). O a una lunga agonia (nel caso di una permanenza nella sua area).
Ora bisogna aggiungere un secondo passo: “Cambiare l’Italia per cambiare l’Europa”. Perché l’Europa non ha “cambiato verso”. Nonostante che le elezioni europee abbiano sancito una sostanziale delegittimazione della politica delle “larghe intese” (Ppe e Pse, i due partiti contraenti di quel patto, hanno entrambi perso elettori in presenza di un’astensione che supera di molto il 50% mentre cresce minacciosa l’ondata dei populismi di destra). E nonostante che un’opposizione ferma e intransigente di sinistra sia cresciuta soprattutto nei paesi più colpiti dalla crisi, l’asse tedesco Merkel-Schulz è stato riproposto e imposto all’intero continente.
La nuova Commissione non solo replica le linee della precedente, ma le peggiora, come è stato puntualmente e autorevolmente denunciato dai nostri parlamentari Eleonora Forenza, Curzio Maltese e Barbara Spinelli, che vi si sono opposti strenuamente insieme a tutto il gruppo del GUE. Composta da 13 popolari, 7 socialisti, 5 liberali e un conservatore, voluta dalla Merkel e posta sotto il controllo dei falchi, non farà che aggravare una situazione già drammaticamente compromessa. L’Europa continuerà a funzionare come una grande “macchina imperiale” destinata a prelevare risorse in basso, nel mondo del lavoro, e nelle periferie, in particolare nell’area mediterranea, per trasferirle in alto (ai canali finanziari) e al centro (ai “Paesi forti”).
E’ il modo con cui la crisi viene usata da parte dei poteri - prevalentemente finanziari - che controllano la politica europea incarnata dalle “larghe intese”: dal lavoro al capitale. Dal salario al profitto. Dai paesi fragili a quelli forti. Dall’economia reale al circuito finanziario, secondo un meccanismo che continua ad aumentare le diseguaglianze già scandalose e l’iniquità. E’ questa la sostanza delle cosiddette “riforme” che ossessivamente vengono richieste: attacco al reddito e al potere d’acquisto della variegata area del lavoro, privatizzazione di ciò che resta del patrimonio pubblico e che possa essere oggetto di business, riduzione della spesa pubblica e dell’occupazione nelle pubblica amministrazione, eliminazione dei vincoli alla spogliazione del patrimonio paesaggistico, artistico e territoriale e liquidazione del concetto stesso di “bene comune” in nome dell’utilizzo economico privato. Il memorandum imposto alla Grecia e ora generalizzato su scala continentale.
Non solo. Quest’Europa chiusa nei propri egoismi e nelle proprie diseguaglianze all’interno, mostra un volto indecente, sul piano politico e su quello morale, anche all’esterno: nell’assenza assoluta dalla sua agenda – ma anche dall’orizzonte mentale delle scialbe figure che ne occupano i vertici – dei grandi temi che decidono del destino dell’umanità intera, come la questione epocale del crescente degrado ambientale e climatico, la sfida energetica e l’insostenibilità di un modello fondato su un’impossibile crescita illimitata, la mercatizzazione integrale delle risorse e delle fonti della vita contro le esigenze della vita stessa. Per non parlare delle politiche migratorie, scandaloso esempio di chiusura della Fortress Europe, sorda, cieca e muta di fronte alla strage permanente che si consuma lungo i propri confini, testimone-complice di un crimine contro l’umanità reiterato all’infinito; e di una politica estera che non solo non è riuscita a prevenire ed evitare la guerra – secondo il mandato implicito ricevuto nel 1945 di bandire la guerra dalla storia del mondo – ma l’ha disseminata ovunque intorno a sé con decisioni ottuse e colpevoli, dallUkraina (delicatissimo Paese-ponte tra Est ed Ovest, il cui equilibrio avrebbe dovuto essere preservato come un bene prezioso e che invece è stato terremotato da una serie sconclusionata di interventi destabilizzanti) alla Libia, alla Siria e allo sresso Irak… Quella che avrebbe dovuto essere, secondo una felice definizione, una “grande potenza culturale” si è trasformata in un gretto agglomerato di interessi, chiuso nel cerchio opaco del business e della potenza finanziaria come unico criterio di orientamento delle proprie politiche.
Quel cerchio va spezzato. Con una mobilitazione dal basso, forte, transnazionale, di dimensione continentale, che unisca al di là dei confini nazionali (e dei nazionalismi) gli europei che non accettano questo destino, a cominciare dalle vittime di questo uso della crisi e di queste politiche. Ma anche con un’iniziativa che veda protagonisti gli Stati più colpiti, attraverso una politica di alleanze che crei un fronte alternativo alla congregazione dei fondamentalisti dell’Austerità e dei custodi di un Rigore che premia solo i privilegiati, creditori esosi di una massa d’indebitati che non potrà che crescere su se stessa alimentando all’infinito il meccanismo della crisi e della diseguaglianza che ne sta all’origine. Un fronte che abbia al centro i 10 punti che già affermammo in campagna elettorale. E che sono in frontale antitesi alle linee su cui muove la politica e l’ideologia delle “larghe intese”, a cui invece, sciaguratamente, è del tutto interno e subalterno l’attuale governo, nonostante le promesse elettorali di Matteo Renzi e le retoriche che avevano accompagnato la kermesse del “semestre italiano”.
Tra le ragioni del fatidico 40,8% che ne ha certificato la santità come lo scioglimento del sangue di san Gennaro certifica il miracolo, oltre a una buona dose di demagogia comunicativa e all’appoggio monopolistico dei media, c’è anche questa millantata promessa di “farsi sentire” in Europa. La sceneggiata dei “pugni battuti” sul tavolo a Berlino. Gli sfracelli dei sei mesi “alla guida” a Bruxelles. La fine della subalternità montiana, dell’acquiescenza lettiana… Un grande, consapevole imbroglio. Non solo perché al momento buono Matteo Renzi ha approvato senza colpo ferire la Commissione Juncker, col suo pieno di rigoristi e di fustigatori tedeschi e finlandesi, legandosi una macina al collo. E ha scambiato la primogenitura di un Commissario economico con il piatto di lenticchie di una propria fedele a capo di una politica estera che non c’è. Non solo perché si è accucciato buono buono davanti ai diktat della Banca centrale europea, promettendo e consegnando ai banchieri centrali lo scalpo del sindacato italiano appena macellato. Ma anche e soprattutto perché il suo programma è scritto, punto per punto, sul palinsesto della peggiore Europa. Dal primo decreto Poletti, che formalizzava la precarietà del lavoro decretandone la svalorizzazione come destino, al cosiddetto “Sblocca Italia”, giustamente rinominato “Rottama Italia” dai più prestigiosi esperti del patrimonio territoriale, fino alla interpretazione della spending review come prevalente piano di privatizzazioni e al Jobs act come liquidazione della residua civiltà gius-lavoristica moderna. O, in ultimo, alla Legge di stabilità che simula politiche espansive “in libera uscita” rispetto ai “controllori” europei ma scarica in realtà i costi dei “doni” offerti alle imprese sulle amministrazioni locali e quindi sui servizi ai cittadini più bisognosi, in ossequio all’intoccabilità di quel 3% che costituisce (quello sì) il vero totem dell’ideologia tedesca (ed europea) oggi.
Per questo noi diciamo che Matteo Renzi non è l’alternativa alla Troika, al suo minacciato commissariamento, secondo il mantra che ha recitato e che gli ha fruttato la legittimazione. Non è il “male minore”, ultima spiaggia per scacciare il rischio della totale cessione di sovranità. Matteo Renzi è la Troika interiorizzata. E’ la forma personalizzata che assume la cessione di sovranità quando viene camuffata con la retorica del demagogo. Il suo “miracolo” – più simile al gioco di un prestigiatore che al prodigio di un santo – è di far apparire Uno ciò che è Trino (o plurimo), presentando come atto liberatorio ciò che è in realtà una sottomissione servile. Il suo è un Trasformismo di tipo nuovo, non più quello di Agostino Depretis ancor tutto sommato interno alla società politica, ma quello, più adatto alla società dello spettacolo, del “transformer”: dell’illusionista che trucca le carte e se stesso deviando l’ attenzione del proprio pubblico con la tecnica del diversivo.
Allo stesso modo aggiungiamo che Renzi non è la (possibile) soluzione alla crisi economica e sociale. Non ne ha la forza, nei rapporti internazionali, privo com’è di una politica delle alleanze. Non ne ha la cultura e le competenze (la sua squadra di governo, zeppa di figuranti, sembra pensata più per non far ombra al Capo che per trovare soluzioni a una situazione drammatica). Non ha una sola idea adeguata, come dimostra la trovata dell’anticipo in busta del Tfr, sintomo della disperazione di chi per sopravvivere nel presente si mangia il futuro. Lungi dal rappresentarne una qualche, sia pur difficile, via di uscita Renzi è, al contrario, la crisi stessa messa al lavoro in politica. E’ la forma che la crisi assume quando il suo potenziale distruttivo viene trasferito sul piano politico e applicato alla forma di governo. L’”energia” di cui appare dotato il “renzismo” nella sua opera di rottamazione di tutto ciò che si oppone e rallenta il dispiegarsi del suo potere è la stessa energia con cui la crisi distrugge e liquida consolidati equilibri sociali, soggetti collettivi, sistemi di garanzia e di tutela: le forme di mediazione e gli stessi “patti fondamentali” con cui la società industriale aveva mediato i propri conflitti e costruito la propria coesione. Senza la crisi il renzismo non sarebbe neppure concepibile. Senza il renzismo la crisi non potrebbe essere utilizzata dai poteri che reggono l’Europa per realizzare il progetto di trasformazione che gli hanno assegnato come compito, e che costituisce l’effettiva (e occulta) legittimazione del suo potere. E quando diciamo “senza il renzismo” intendiamo senza la sua carica torbida di “populismo dall’alto” (o di “populismo di governo”, che è tra le forme peggiori), senza la sua capacità (polimorfa e perversa) di mutare la disperazione di massa in speranza tramite l’espediente dell’illusione, senza la sua tecnica di mutuare linguaggi ribellistici dentro un progetto reazionario.
Il renzismo non è dunque un punto di caduta temporaneo di una democrazia malata ma ancora vitale. Non è un incidente di percorso, un’occasionale irruzione di Iksos fiorentini che attende di essere riassorbita in una qualche normalità istituzionale romana. Il renzismo porta a compimento la crisi terminale della democrazia rappresentativa. Non la produce, certo (perché essa è il risultato di un processo lungo di deterioramento, svuotamento e degrado), ma la “mette in sicurezza”, per così dire: la certifica e la dichiara normale e definitiva. Anzi, utilizza spregiudicatamente il discredito e la sfiducia di massa – il rancore e il risentimento - nei confronti della classe politica e dei propri “rappresentanti” come leva del proprio consenso personale e del ruolo demiurgico di esecutore fallimentare del parlamento e del sistema parlamentare, considerandosene ormai “oltre”. Irreversibilmente “oltre”, in una post-democrazia plebiscitaria in cui le consolidate istituzioni costituzionali sono poste in disuso (come, appunto, le auto in attesa di rottamazione), e ciò che ancora ne resta viene sistematicamente manomesso.
Così è stato per il principio stesso di rappresentanza, in occasione dell’indecente battaglia di agosto per la liquidazione del Senato come istituzione elettiva. Così è per il rapporto tra Potere Legislativo e Potere Esecutivo – tra Parlamento e Governo -, con l’umiliazione sistematica del primo e l’assolutizzazione del secondo, umiliato a sua volta nella sua collegialità e monocratizzato nella figura del Premier (vera e propria rivoluzione copernicana rispetto a quanto detta la Costituzione). Così è, d’altra parte, per la natura e il ruolo dei partiti politici, a cominciare dal suo, il Pd, il quale ha subìto, sotto l’effetto dell’ elettrochoc renziano, una vera e propria mutazione genetica trasformandosi, alla velocità della luce, da aggregato eterogeneo di gruppi d’interesse e di amministratori (“partito di massa” aveva cessato da tempo di esserlo) in “partito del capo” e, tendenzialmente, “partito unico della nazione”. Struttura amorfa, risucchiata d’autorità in alto, fuori dalla società ma anche dal Parlamento. Appendice del Governo e soprattutto del suo Premier, in attesa di essere sciolto nel serbatoio bipartisan che già emerge dall’omologazione antropologica degli elettorati che furono, fino a ieri, di centro-destra e di centro-sinistra. E che tendono ormai, nei fatti, a diventare un’unica platea plebiscitaria (e pubblicitaria), dopo la stipulazione di quel Patto del Nazareno che riconsegna a un leader squalificato e pregiudicato, in evidente decadenza, il ruolo di partner costituente. E che ipoteca pesantemente il futuro per quanto attiene alle più alte cariche dello Stato.
Sotto questa luce, la vicenda parlamentare della mozione di fiducia sul Jobs Act costituisce un punto di osservazione e di verità straordinario. Una residua istituzione rappresentativa – uno dei due rami del Legislativo – costretta ad approvare a forza (con la minaccia mortale della caduta del Governo e della possibile fine della legislatura) una delega in bianco (destinata ad essere concretizzata unilateralmente dal Governo) relativa alla liquidazione (pratica e, cosa ancor più grave, simbolica) di storiche tutele del lavoro, resa nota la notte precedente il voto, con un pronunciamento pressoché unanime del partito che dovrebbe avere nel proprio dna, se non altro per via degli antenati, il riferimento al movimento dei lavoratori, e con la cooperazione “attivamente passiva” dei senatori berlusconiani assenti al momento del voto. Se si voleva una prova lampante del processo di assorbimento del Parlamento dentro (e sotto) il Governo, e dello “sfondamento” di ogni residuo di autonomia all’interno dell’ex Partito democratico (dell’impotenza della sua cosiddetta “sinistra”), qui la si è avuta. Nel giro di un solo giorno si è potuto assistere pressoché in diretta, alla rappresentazione del processo di verticalizzazione del potere (e della sua personalizzazione in chiave plebiscitaria) che sta nel progetto e soprattutto nella pratica del renzismo e delle forze che senza comparire ne scrivono il copione. Contemporaneamente, dai brandelli di un dibattito sgangherato e frettoloso, si è potuto intravvedere, inquietante, il profilo del nuovo immaginario sociale che avanza, rovesciamento di tutti i valori, modificazione della costituzione materiale prima che di quella formale, con il Profitto, il Business, l’Impresa a fondamento di una Repubblica ormai post-democratica, e il Lavoro, le donne e gli uomini che lo eseguono, ridotti non solo a variabile dipendente, ma a possibile minaccia, con i loro diritti considerati blasfemamente “privilegi”, alla “libertà d’impresa” e all’attrattività degli investimenti. Rovesciamento simbolico, appunto, e proprio per questo tanto più devastante del nostro stato di civiltà.
Le conseguenze politiche di tutto questo – se si condivide il quadro analitico – sono evidenti, e terribilmente impegnative: siamo in presenza di una grave “emergenza democratica” di fronte a un processo che tende a produrre una vera e propria mutazione genetica dell’assetto politico-istituzionale del Paese e del sistema del partiti. Esso sconvolge il tradizionale panorama politico incentrato sulla contrapposizione bipolare centro-destra/centro-sinistra, categorie travolte ora dalla trasversalità del progetto e della pratica renziana. Modifica radicalmente il quadro delle identità politiche, svuotando di significato e rendendo anzi ambigua e deviante l’attribuzione della qualifica di “sinistra” (per quello che ancora può significare), al Partito democratico. E crea un’inedita necessità di mobilitazione capace di porsi all’altezza della sfida che viene lanciata.
Quando diciamo “inedita capacità di mobilitazione” intendiamo dire che non si tratta di un progetto “testimoniale”. Della costruzione di una “piccola casa” per esuli dalle tante vicende politiche della sinistra. O di un’asta a cui appendere stinte bandiere. Intendiamo dire ciò che un’emergenza richiede: il massimo possibile di forza da mettere in campo per invertire una tendenza, per fermare un’azione di devastazione istituzionale e culturale, per scongiurare un pericolo che si avverte potenzialmente irreparabile, per arginare la devastazione di un patrimonio culturale condiviso, e per contrapporre a tutto ciò un sistema di valori e un modello di pratica all’altezza dei tempi. Un fronte più ampio possibile da costruire nella chiarezza su ciò che si vuole contrastare e nella apertura su ciò che si intende unire.
In quest’opera è importante la capacità di opposizione ai singoli passaggi, nelle diverse sedi, dal Parlamento alla piazza, ai luoghi di lavoro e alle aule scolastiche. Per questo siamo e saremo sempre solidali con chiunque, in ogni sede, metta pietre d’inciampo al progetto renziano-berlusconiano che nel pactum sceleris del Nazareno ha trovato la propria sanzione. Ma ancor più importante, perché da essa dipende la possibilità di farcela davvero, è l’elaborazione di un’ effettiva alternativa al renzismo. Di una risposta credibile, adeguata nelle forme e nei contenuti alla sfida che esso apre, capace di coglierne i punti di forza e di rovesciarli, non solo svelando l’inganno (che c’è sempre) ma offendo soluzioni praticabili qui ed ora, e soprattutto offrendo un’immagine di noi diversa da quella che ci accompagna da tempo e che ciclicamente ritorna.
Il principale punto di forza di Renzi è la crisi, come si è detto. La sua stessa gravità. Di più: la sua apparente insuperabilità senza l’ intervento straordinario di una figura salvifica in cui “credere” (e poi magari anche obbedire se non combattere). Il mito, appunto, dell’”ultima spiaggia”, del “dopo di lui il diluvio”, che blocca ogni smottamento, sutura ogni linea di frattura, sana ogni dissenso interno e ogni ribellione esterna. Dobbiamo contrapporgli una linea di uscita, se non dalla crisi – che è endemica di questo capitalismo globale e in particolare nel modello europeo – almeno dall’emergenza. Un programma radicalmente altro rispetto a quello dettato da Bruxelles e da Berlino e fatto proprio dal “bisbetico domato” Matteo Renzi. Pochi punti, chiari come facemmo con i 10 punti della Lista, a cominciare dalla questione del debito e del suo necessario “consolidamento”, dalla rottura dei patti capestro europei e dal superamento del vincoli del fiscal compact, da un programma eccezionale per l’occupazione, per la messa in sicurezza del territorio, per la ristrutturazione energetica, per la rappresentanza dei lavoratori in fabbrica e il superamento vero, non retorico, della jungla contrattuale tra gli “atipici”… Da portare e discutere tra la gente, non tanto o comunque non solo nelle nostre solite assemblee che radunano troppo spesso i già convinti.
Il secondo punto di forza di Renzi è l’evocazione sistematica, ossessiva, della rottura – del “nuovo inizio”, del “cambiar verso”, della “rottamazione” appunto – inserita nel quadro del peggior continuismo (cosa, se non la sintesi del peggio dell’ultimo quarto di secolo è il Patto del Nazareno?). L’assunzione dei codici linguistici propri del “populismo di opposizione” – dei suoi luoghi comuni, dei suoi j’accuse, delle sue domande di tabula rasa – per far da propellente al suo “populismo di governo”. Il lessico del ribelle come scrittura del libro del potere. Evocazione retorica, naturalmente, illusoria, manipolante, ma che affonda le radici in un cratere di disperazione, nell’impossibilità di vedere un futuro, nella consapevolezza che “così non si può andare avanti”, che “ci vuole uno scossone” che se non può più venire dal basso, che almeno venga dall’alto, nell’affidamento superstizioso all’intervento salvifico di chi “può”. Quel cratere, che Renzi non può prosciugare, può soltanto “usare” al proprio fine personale, dovremmo riempirlo noi, almeno in parte. A quella domanda di rottura giustificatissima dovremmo riuscire a rispondere noi.
Ma qui intervengono i nostri punti di debolezza. Il primo del quali siamo noi stessi. La nostra storia deragliata. La nostra antropologia lesionata. I vizi acquisiti e forse anche quelli originari. La principale ragione della nostra difficoltà ad attirare tutti quelli che potenzialmente ci sarebbero, e di trattenere tutti quelli che si avvicinano, è l’immagine che proiettiamo. Quello che fa fuggire la gente normale lontano da noi è la nostra endemica litigiosità, il bisogno costante di identificarci per contrapposizione nei confronti di chi ci sta più vicino, l’incapacità di ascolto degli altri e di interlocuzione con essi, l’intolleranza, la mania di piantar bandierine, la frammentazione spinta fino alla scissione dell’atomo, l’assenza di una visione pragmatica dei processi e la difficoltà a separare l’essenziale dal secondario, lo strategico dal contingente. Questo ci rende incerti e insicuri, come l’Amleto della tragedia, in questi “tempi bolsi e tronfi” in cui ricostruire una prospettiva credibile richiederebbe in primo luogo un taglio netto con pratiche consuete, stili di lavoro e di comportamento improponibili, come in qualche modo, e almeno parzialmente, si era provato a fare nel lancio della Lista la primavera scorsa. E poi una straordinaria mobilitazione di intelligenza, creatività, spregiudicatezza, conoscenza perché il nostro pensiero è oggi insufficiente di fronte alle travolgenti trasformazione della società che vorremmo intercettare: “unire ciò che la crisi e il neoliberismo hanno diviso” è un buon proposito, ma come questo possa essere fatto in presenza di una scomposizione feroce di tutti i soggetti e di tutte le aggregazioni – alla frantumazione del “diamante del lavoro”, come è stato felicemente detto – spinta fino al punto di contrapporne le parti fra loro in una nuova “guerra di tutti contro tutti”, di fronte alla smaterializzazione dei processi produttivi e dei sistemi di relazioni, al primato della dimensione finanziaria su quella produttiva, allo spossessamento dei luoghi tradizionali del conflitto, dobbiamo cercarlo ancora. Allo stesso modo la difesa intransigente della democrazia non solo come principio ma anche come assetto istituzionale, così come è scolpita nella nostra Costituzione, è opera nobile e necessaria, ma non ci possiamo nascondere il grado e la misura in cui il principio stesso di rappresentanza è stato lesionato da processi reali, per certi versi devastanti e purtroppo irreversibili: dalla globalizzazione dei processi non solo economici e comunicativi, ma di comando o come si dice di governance, e dalla totalizzazione di un sistema mediatico pervasivo, multiforme e integrato, a cui occorre dare risposte in avanti, non certo nello scioglimento di quella crisi nel plebiscitarismo del leader più o meno carismatico ma in un di più di partecipazione, sviluppata nei luoghi della vita, al livello territoriale, in forme già in parte sperimentate là dove si sono aperte linee di frattura, conflitti radicati nelle “coscienza di luogo” (si pensi alla Val di Susa) ma che attendono una sistemazione e una riflessione. Per non dire della crisi delle forme organizzative, a cominciare dalla “forma partito”, delle cui dinamiche dissolutive la mutazione genetica del Partito democratico è l’esempio più spettacolare perché lì si rappresenta, in tutta la sua drammaticità. Sarebbe una catastrofe se noi pensassimo di ricostruire una casa (un “piccola casa”) per gli esuli di quel crollo, sulle stesse fondamenta e sullo stesso progetto, senza porci il problema, quello vero, di cosa si sostituisce al modello organizzativo del “partito di massa” che ha dominato l’orizzonte politico novecentesco e che con quel secolo si è inabissato: quale forma di organizzazione della soggettività politica si può immaginare nell’epoca della scomposizione delle soggettività, dell’inoperosità della politica al livello della dimensione nazionale, della crescente difficoltà di ricondurre la disseminazione degli “Io” autoreferenziali e impotenti all’operatività di un “Noi” attivo e consapevole.
Per questo noi non proponiamo oggi un “soggetto politico” già bell’e fatto (o pensato), da “prendere o lasciare”. Proponiamo al contrario un processo – possiamo chiamarlo un “processo costituente” – di lunga durata in grado di proiettare l’esperienza de L’Altra Europa oltre la vicenda, felicemente conclusa, di quella Lista elettorale. Un processo da iniziare subito, questo sì, ma in cui nessuno può pensare di aver già in mano la Costituzione scritta da imporre agli altri, e nemmeno i “lavori preparatori” già compiuti: un processo nel quale davvero si avanzi domandando, forse anche per prove ed errori, e in cui sia ben chiaro il rapporto tra le tappe intermedie e la meta finale che resta, certamente, la volontà di creare quello che potremmo definire, per ora, un “SOGGETTO POLITICO EUROPEO DELLA SINISTRA E DEI DEMOCRATICI ITALIANI”, per sottolinearne la doppia vocazione: la dimensione europea dell’azione strategica e l’apertura a un’ampia area democratica e di sinistra italiana.
Per questo la prima tappa intermedia, da dichiarare subito, senza indugi, è a sua volta l’obbiettivo di giungere alle prossime elezioni politiche – quale che sia il momento in cui si terranno – con una lista in grado di unire tutte le componenti di una sinistra non arresa alla austerità europea e alla sua versione autoritaria italiana incarnata dal renzismo, determinata a sfidarlo in modo credibile sul doppio terreno dell’egemonia e della capacità d’innovazione nel senso migliore di questo termine, cioè facendo proprio il bisogno radicale di mutamento dei tanti sacrificati dalla crisi e dall’austerità. La sfida elettorale sul livello nazionale è senza dubbio la competizione giusta per lanciare il processo qui descritto con tutta la forza e l’estensione rese necessarie dall’importanza della sfida. Alla sua piena riuscita è necessario commisurare ogni altra nostra mossa. D’altra parte per il successo dell’iniziativa è fondamentale lo sviluppo di una proposta programmatica articolata e precisa, con un ventaglio di punti programmatici completo (dal lavoro e dai diritti, naturalmente, all’ ambiente, alla sanità, ai trasporti, all’ istruzione e ricerca, dalla politica estera alla questione dei migranti…) per cui abbiamo ottime basi in quello che abbiamo presentato alle europee ma che deve essere sviluppato e precisato, senza perdere chiarezza e comprensibilità, in una discussione collettiva che richiederà per lo meno qualche mese di lavoro intenso e partecipato per cui è bene che tutti si attrezzino.
In quest’ottica di percorso (di ampliamento della nostra base e di approfondimento dei nostri contenuti) il risultato della Lista L'altra Europa con Tsipras il 25 maggio, può essere considerato, sia pur moderatamente, un buon punto di partenza, date le condizioni in cui era la sinistra italiana, e un incoraggiamento per il futuro: si è evitato il rischio - il "paradosso" come l' aveva definito Tsipras - che per la seconda volta la sinistra italiana non fosse rappresentata in Europa (sono stati portati al PE tre rappresentanti di alto livello); si è dimostrato che anche la soglia incostituzionale del 4% poteva essere superata; si è data a 1.103.000 elettori la possibilità di esprimersi con una scelta limpidamente di sinistra; si è aperta una strada per un percorso che altrimenti, in caso di fallimento, sarebbe stata irrimediabilmente chiusa. Né va sottovalutato il ruolo di Alexis Tsipras, che ci ha permesso di dare con chiarezza al nostro progetto – unico tra tutti - un respiro di esperienza, di pratica e di organizzazione politica trans-nazionale con respiro europeo.
Quel (ancora parziale) successo si è ottenuto con il concorso di diverse forze e realtà: la rete delle associazioni in lotta per un’alternativa e parti dei movimenti critici dell’esistente, a cominciare da quello per l'acqua e i beni comuni; un'area di opinione democratica, impegnata nella difesa della Costituzione e dei diritti e preoccupata della deriva autoritaria dei governo Renzi; le diverse realtà organizzate in forma di partito, fino ad allora divise e talvolta contrapposte; e infine, ma non meno importante, anzi, un robusto gruppo di intellettuali e di esponenti del mondo della cultura che hanno "fatto la differenza" per quanto riguarda l'immagine della lista, oltre al gran numero di persone, cittadini, attivisti, simpatizzanti che si sono impegnati nei comitati (e anche fuori di essi, spontaneamente). E' convinzione condivisa – ed è d’altra parte un dato di fatti evidente - che nessuna di tali componenti sia stata prevalente, perché tutte sono state INDISPENSABILI per garantire il superamento della soglia.
Per questa ragione il percorso oltre l'esperienza elettorale europea per la nascita di una sinistra italiana deve proporsi di mantenere entro i limiti del possibile il coinvolgimento di tutti i soggetti e le realtà che hanno contribuito a quel successo, con l'obbiettivo dichiarato non solo di consolidarlo ma di ampliarlo. Non ci si nasconde infatti che quel 1.103.000 elettori è solo una parte, sottile, di elettorato potenziale: rappresenta un voto ancora prevalentemente d'opinione, concentrato negli strati più colti e informati di popolazione. Occorrerà lavorare molto per radicarci nei territori e tra gli strati di popolazione più sofferenti per la crisi, in parte rifugiatisi nell' astensione, in parte convinti dal populismo grillino, in parte sedotti dalle elemosine di Renzi. Un lavoro inevitabilmente lungo, perché ogni realtà locale ha la propria storia e attori politici eterogenei e richiede attenzione alle specificità”di luogo”, rispetto delle differenti dinamiche di territorio (sfuggendo allo schema da “partito novecentesco” che imponeva la presentazione automatica delle proprie liste a ogni livello elettorale e in ogni sede territoriale), capacità di “governare” il rapporto tra progetto generale e domanda locale secondo logiche non schematiche e soprattutto con attenzione intelligente al rapporto “mezzi-fini”.
Siamo consapevoli che non sarà facile: le condizioni della campagna europea erano in qualche modo eccezionali e ci favorivano, sia per il riferimento a Tsipras, sia perché era senso comune che o si faceva come si è fatto, con una certa forzatura anche verso le forze più organizzate in forma di partito, o non si sarebbe concluso nulla. Quelle condizioni non ci sono più: ora bisogna condurre un percorso condiviso, che porti ad una definizione di forme di rappresentanza pienamente legittimate, e procedere a un complesso lavoro diplomatico di cucitura e convergenza, rispettoso di tutte le storie e di tutte le identità ma anche consapevole della necessita di superare distinzioni e sopravvivenze sempre più parziali e meno riconosciute, consapevoli dell’insufficienza, sempre più palese, di un approccio affidato alla vecchia pratica degli accordi tra apparati di partito o frazioni di ceto politico tanto più dopo che l’attesa di una rottura significativa nei gruppi dirigenti del PD si è rivelata clamorosamente vana (altro discorso, naturalmente, riguarda l’elettorato di quel partito e quanto resta del suo corpo militante).
Per far questo in condizioni adeguate noi riteniamo che sia necessario, preliminarmente, iniziare a tracciare il campo dei partecipanti al processo o, come si è detto, "definire il nostro corpo", attraverso l’adesione individuale ai punti qualificanti di questo Documento. Per far questo in condizioni adeguate noi riteniamo che sia necessario, preliminarmente, tracciare il campo dei partecipanti al processo o, come si è detto, "definire il nostro corpo", attraverso l’adesione individuale ai punti qualificanti di questo Documento. E, in connessione con ciò, la proposta che chiediamo di discutere è di aprire l’Associazione L’Altra Europa con Tsipras, a tutt’oggi rappresentante legale della Lista, all’adesione individuale di massa, scrivendone lo Statuto (entro mesi 9 dall’avvio dalla campagna di adesione) in una chiave partecipativa e democratica e rivolgendoci a tutti coloro che hanno partecipato alla campagna per le europee, che appartengano o meno a partiti o a movimenti o ad altre formazioni. Ai soggetti collettivi, d’altra parte, (partiti, movimenti, associazione) non è richiesto di sciogliersi come condizione di partecipazione al percorso (ogni soggettività è titolare delle proprie scelte), ma ne auspichiamo l’impegno convinto e l’assunzione dell’obbiettivo finale (la necessità e l’urgenza di dar vita a una forma di rappresentanza unitaria nella scena politica nazionale), così come è stato per le elezioni europee.
D’altra parte, intorno a noi, c’è un mondo di donne e di uomini che ogni giorno si sbatte per resistere e per cambiare, o comunque che “non ci sta”: c’è una “sinistra fuori dalla sinistra”, che non trova sponda in ciò che c’è (o che si vede) e che meriterebbe una rappresentanza politica degna di questo nome. E’ con loro che dobbiamo camminare.
Ci saranno senza dubbio tensioni e difficoltà, lungo questo cammino, ma siamo convinti che la forza del progetto generale, come nel modello tracciato da Syriza, sarà più forte.