

Sbilanciamoci.info, 21 gennaio 2015
L'introduzione dell’immunità per gli evasori fino al 3% dell’imponibile, misura che abbatterebbe la pena a Berlusconi, è passata senza troppi scandali, mentre forte è stato il clamore contro i vigili accordatisi per allungare illecitamente le festività di capodanno. Siamo il paese dei due pesi e due misure. E con un’idea bizzarra dell’etica pubblica e privata
Chi ha introdotto nell’ennesima legge dello stato l’immunità per gli evasori fino al 3 per cento dell’imponibile, misura assai discutibile che abbatterebbe la pena assegnata a Berlusconi? Nessuno, chissà come si è infilata nel testo di un distratto Padoan e nella lettura di un distratto Renzi; quanto agli uffici tecnici che lo hanno passato, devono aver pensato che era una misura da attendersi nella filosofia delle larghe intese.
Più accorti sono stati i giornalisti che hanno scritto peste e corna contro i dipendenti pubblici (e i medici) che si sono accordati per allungare illecitamente le festività di capodanno. I giornalisti si sono indignati ma moderatamente, volete mettere lo scandalo di quella massa di sfruttatori dello Stato di fronte a qualche centinaio di ricchi che hanno evaso in varie forme per decine di migliaia di euro le imposte, o si sono avvantaggiati in vario modo, incluse corruzione e concussione, sulla pubblica finanza?
Colpisce in questo sfoggio di moralità la duplice misura usata verso i poco abbienti e verso l’ex presidente del consiglio e profittatore numero uno d’Italia, Berlusconi Silvio. È l’abitudine nazionale di risparmiare i ricchi e i potenti e usare la frusta con chi non lo è. Siamo un paese con un’idea bizzarra dell’etica pubblica e privata.
Alla quale ha dato un vasto contributo Giorgio Napolitano che ho sotto gli occhi dal 1945 come dirigente del mio stesso partito, il Pci. Lo sapevo antifascista a Napoli e autore di scritti interessanti sulla questione meridionale. Non l’ho apprezzato nella sua sorda (ma non tanto) opposizione all’ultimo Berlinguer e neanche come Presidente della Camera, quando avrebbe avuto occasione di far qualcosa contro la crisi della politica, se l’avesse vista venire dall’osservatorio privilegiato che aveva.
Ugualmente non ho apprezzato che nulla abbia fatto per risanare qualche ferita inferta dal suo partito a innocenti del suo partito nell’emergenza, ma nel merito la pensavamo in modo opposto. Quel che mi ha sorpreso è che, appena il Cavaliere è stato condannato a una pena assai mite ma almeno a stare fuori dalla porta del potere pubblico, si sia affrettato a proporre la formula delle “larghe intese” che significava allargare la maggioranza di fatto a Forza Italia, ogni qualvolta il dissenso da sinistra del Pd potesse minacciare la linea Renzi. Non solo, ma tale operazione è nata negli incontri clandestini presso la sede del Pd in via del Nazareno, dei quali non conosciamo né il numero dei partecipanti, né gli accordi intervenuti. Sappiamo solo ormai che essi hanno regolarmente preceduto le riunioni del Pd, del quale Renzi sarebbe il segretario. Non vedo quale insegnamento sia venuto da questa prassi alla coscienza scombussolata del paese, e perché ne sia derivata al nostro Presidente della Repubblica la fama di “grande italiano”.
Si può chiedersi se anche la norma del condono sia un frutto di questo guasto. Vedremo se Renzi la corregge. Intanto il governo ha dichiarato che non se ne era accorto: “Peso el tacon del buso”, come si dice dalle mie parti. Il governo intero lo ha avuto sotto gli occhi per un’intera seduta, ma non ha protestato. È vero che era stato convocato dal frettoloso premier la vigilia di Natale, ma non è da grandi figure l’avere condotto il paese in questo modo e tantomeno favorire gli evasori fiscali, soprattutto uno di essi condannato per aver fatto diverse porcherie in materia fiscale, corruzione e concussione. Già la giustizia è stata particolarmente indulgente sul resto delle sue imputazioni; per non parlare di un parlamento che ha considerato normale le sue menzogne telefoniche alla Questura di Roma per tirar fuori di guardina la denominata Ruby rubacuori.
Sono enormità imperdonabili. Non ho mai apprezzato le galere, quindi pace al vecchio e ormai ridicolo profittatore, ma se si vuole essere decenti bisogna tenerlo fuori dalla politica.
Penso di rientrare nella categoria dei gufi e rosiconi, anche se ignoro quali animali siano questi ultimi nell’italiano approssimativo del nostro presidente del Consiglio; ma preferisco essere un rispettabile uccello notturno, o anche forse un meno rispettabile topo, che un suddito silenzioso e ipocrita.
La Repubblica, 23 gennaio 2014 (m.p.r.)
Il manifesto, 23 gennaio 2014
I maldestri governanti inglesi, che non sempre riescono a garantire il valore costituzionale della governabilità, cioè ad ultimare gli scrutini con un vincitore sicuro riconoscibile la sera stessa dello spoglio, faranno subito la fila al Nazareno per comprare la ricetta miracolosa e archiviare il loro secolare, e piuttosto stupido al cospetto della singolare trovata toscana, formato maggioritario uninominale, che non sempre dà il volto del gran trionfatore.
E così si appresta a fare anche la cancelliera Merkel. Deposta la teutonica presunzione di sufficienza, per via di una decennale stabilità e governabilità superiori a quella di ogni altro sistema politico europeo, la politica tedesca freme per apprendere dalla premiata ditta Boschi-Verdini come si fa a vincere con certezza e a dormire tranquilli la sera stessa del voto, senza essere più appesi alle manovre per varare la grande coalizione e quindi indotti al fastidioso rito delle migliaia di iscritti della Spd che devono dare la loro approvazione al contratto di governo siglato.
Per non dire degli spagnoli o dei greci, che devono faticare sovente per raccapezzare singoli voti di sigle minori per garantire la fiducia a un governo malconcio. O dei virtuosi statisti dei paesi nordici, che spesso dal conteggio dei voti non sanno a chi tocchi lo scettro e si affidano abitualmente a lunghi governi di minoranza. E anche i francesi troveranno presto il modo per seppellire il loro incerto maggioritario uninominale a doppio turno e sostituirlo con il sensazionale maggioritario di lista escogitato al Nazareno.
Ora che l’Italicum ha svelato i sacri misteri della vittoria certa, l’Europa può voltare pagina nella storia delle istituzioni e acquistare a buon mercato il prezioso brevetto della governabilità. La vittoria certa, da consegnare al calar della sera, nel timore che i deputati siano chiamati per esprimere una maggioranza tramite le dinamiche secolari che sorgono in aula, è però del tutto estranea alla logica del parlamentarismo.
La costruzione meccanica di un vincitore, altera a tal punto la struttura del parlamentarismo, che preferibile sarebbe passare, con il rigore necessario e soprattutto i contropoteri richiesti, all’incognita di una forma di governo presidenziale piuttosto che forzare in maniera così irrazionale e costosa le compatibilità del regime parlamentare sino a sfigurarlo.
L’obbligo della vittoria fa inclinare tutto il congegno competitivo nella direzione della governabilità come artificio e la rappresentanza perde qualsiasi rilievo fondativo del rapporto politico, è un mero contorno inessenziale. Non è dalla rappresentanza che si esprime la funzione di governo ma è dalla postazione del governo, aggiudicata da un capo di coalizione, che si procede alla riempitura della rappresentanza con nominati ben retribuiti ma destinati a un ruolo passivo nella legislazione.
E’ evidente che una logica premiale, già di difficile comprensione nella sua configurazione sistemica, è comunque ammissibile come un eccezionale supporto forzoso ad una ricerca di governabilità (in paesi frantumati e bloccati, senza ricambio), altrimenti non garantita, solo se compare come una possibilità. Cioè, fissata al 40 per cento l’opportunità di ottenere un premio in seggi, se il bonus non scatta, perché nessuna lista ha varcato la soglia prevista, diventa una palese forzatura costringere l’elettorato ad una seconda tornata, dove l’entità della partecipazione peraltro sfuma.
Se la previsione di un doppio turno è efficace nei singoli collegi per ampliare il radicamento territoriale del deputato che in astratto si separa dalla disputa nazionale per il governo, del tutto insensato diventa come cornice di una competizione tra liste. La volontà del corpo elettorale, in merito al premio, può manifestarsi nel primo passaggio elettorale. Se gli elettori non hanno offerto un sostegno esplicito al partito maggiore, è una camicia di forza alquanto impropria prevedere la costrizione a dare comunque il premio attraverso un ballottaggio di lista.
Se poi il premio ottimale dal punto di vista numerico è stimato dal legislatore al 15 per cento dei seggi (perché non si può governare con il 50,1 per cento? Kohl aveva nel Bundestag un solo voto di scarto), salta ogni riferimento a un incentivo ragionevole se viene rapportato alla quantità di consenso riscossa nel primo turno. Alla luce dei sondaggi odierni, il Pd avrebbe, in caso di successo al ballottaggio, un premio di oltre il 20 per cento, il M5S del 35 per cento e Forza Italia del 40 per cento.
Le distorsioni del principio di rappresentatività, e la cancellazione della pari influenza delle singole espressioni di voto, restano evidenti. Nell’Italicum, le liste con ripartizione dei seggi stabilita a livello nazionale sono evocate per trascendere i collegi, e il capo di coalizione, investito del supremo comando, è introdotto per rendere irrilevanti le liste.
Nel modello persistente di una investitura del leader o sindaco d’Italia, il parlamento non deve in alcun modo esaltare la sua autonomia funzionale di organo di controllo e di indirizzo. Connessa a tale vocazione all’opacità del ruolo del parlamento, è la strozzatura di ogni nesso tra deputato ed elettori, tra collegi e territori. Il capo vincitore crea la rappresentanza, e una schiera di nominati fa da scudo alla sua volontà di potenza. L’anomalia di un governo costituente, che si crea la legge elettorale per vincere, e la confeziona secondo un calcolo di immediata convenienza, è davvero un unicum in democrazie di un qualche pregio.
La gran fretta di approvare la legge elettorale prima dell’elezione del capo dello Stato (e quindi anche dell’opportunità di un suo preliminare vaglio di costituzionalità) svela una preoccupante caduta del rendimento democratico di istituzioni sfregiate a colpi di canguro.
 «Chi pensa di ricostruire un soggetto di sinistra o socialmente insediato guardando a Sel, Rifondazione, Alba e minoranza Pd sbaglia. Lo dico senza iattanza, ma hanno perduto una capacità interpretativa e rappresentativa della società» .intervista a Stefano Rodotà di Giacomo Russo Spena, Micromeg onlinea, 22 gennaio 2015
«Chi pensa di ricostruire un soggetto di sinistra o socialmente insediato guardando a Sel, Rifondazione, Alba e minoranza Pd sbaglia. Lo dico senza iattanza, ma hanno perduto una capacità interpretativa e rappresentativa della società» .intervista a Stefano Rodotà di Giacomo Russo Spena, Micromeg onlinea, 22 gennaio 2015
«E’ un antidoto per contrastare la crisi economica che, dati alla mano, ha aumentato la diseguaglianza sociale e diffuso la povertà. Una parola tutt’altro che logorata e storicamente legata al nobile concetto di fraternità e allo sviluppo in Europa dei “30 anni gloriosi” e del Welfare State. Poi il termine è stato accantonato e abbandonato. La solidarietà serve a individuare i fondamenti di un ordine giuridico: incarna, insieme ad altri principi del “costituzionalismo arricchito”, un’opportunità per porre le questioni sociali come temi non più ineludibili. La crisi del Welfare non può sancire la fine del bisogno di diritti sociali. Sono legato anche al sottotitolo del libro, “un’utopia necessaria”, la solidarietà va proiettata nel presente ed utilizzata come strumento di lavoro per il futuro: l’utopia necessaria è la visione».
Lei ha parlato di “costituzionalismo arricchito”. Quali sono le pratiche da cui ripartire per riaffermare i diritti sociali in tempo di crisi economica, privatizzazioni e smantellamento dello Stato Sociale?
«Mutualismo, beni comuni, reddito di cittadinanza sono gli elementi innovativi e costitutivi di un nuovo Stato Sociale, almeno rispetto a quello che abbiamo conosciuto e costruito nel Novecento. Durante la Guerra Fredda, i sistemi di Welfare sono stati una vetrina dell’Occidente di fronte al mondo comunista, una funzione benefica volta ad umanizzare il capitalismo in risposta al blocco sovietico. Ragionare sulla solidarietà come principio significa riconoscerne la storicità ed oggi è necessario arricchire le prospettive del Welfare. Ad esempio il reddito, inteso in tutte le sue fasi legate alle condizioni materiali, significa investimenti ed è possibile solo grazie ad un patto generazionale e ad una logica solidaristica dell’impiego delle risorse».
«Il discorso esamina la capacità ricostruttiva della solidarietà che è frutto di una logica di de-mercificazione di ciò che conduce al di là della natura di mercato: ristabilire la supremazia della politica sull’economia. Qual è stata la logica in questi anni? Avendo un tesoretto ridotto, sacrifichiamo i diritti sociali. Tale ragionamento va respinto al mittente. Quali sono i criteri per allocare tali fondi? Come li distribuiamo? Finanziamo la guerra e gli F35 o utilizziamo quei soldi contro lo smantellamento dello Stato Sociale? La scuola pubblica, come dice la nostra Carta, non va resa funzionale al diritto costituzionale all’istruzione? Invece si finanziano le scuole private…»
E i famosi 80 euro del governo Renzi possono essere considerati come forma solidaristica e di Welfare?
«No, manca l’intervento strutturale. La Cgil ha reso pubblici alcuni dati: con quei soldi si sarebbero potuti creare 400mila posti di lavoro. Appena si è parlato del bonus per le neomamme, ho pensato fosse più utile stanziare quelle risorse per la costruzione degli asili nido. Solo un vero discorso sulla solidarietà ci consente di stilare una gerarchia che pone al primo posto i diritti fondamentali. E per questo la modifica dell’articolo 81 della Costituzione, nel quale è stato introdotto il pareggio di bilancio, è un duro colpo per la democrazia. Abbiamo posto fuori legge Keynes».
«Dobbiamo guardare all’Europa, il discorso sulla solidarietà ha un senso esclusivamente se usciamo dalla logica nazionalista, altrimenti si impiglia. Solidarietà implica un’Europa solidale tra Stati con una politica comune e coi diritti sociali come fari. Con Jürgen Habermas dico che è un principio che può attenuare l’odio tra i Paesi debitori e quelli creditori. Persino Lucrezia Reichlin ha parlato di Syriza con benevolenza perché sta avendo il merito di riaprire una riflessione in Europa su alcuni temi non più rimandabili. L’austerity ha fallito ed aumentato le diseguaglianze. Fino a qualche mese fa, i difensori del rigore giustificavano l’enorme forbice tra redditi alti e minimi affermando di aver tolto migliaia di persone dalla soglia di povertà. La diseguaglianza come conseguenza del contrasto allo sfruttamento. Una tesi smentita dagli stessi eventi».
«E’ una vecchissima discussione che si svolse già a Parigi nel 1789. E la Costituzione italiana ha legato diritti e doveri: l’art. 2 si apre col riconoscimento dei diritti delle persone ma poi afferma che tutti devono adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Il tema dei doveri viene sbandierato per chiedere sacrifici alle fasce più deboli mentre rimangono al riparo i soggetti privati forti e le istituzioni pubbliche. Vogliamo discutere dei doveri? Facciamolo senza ipocrisie. Ad esempio, si dovrebbe riaffermare l’obbligo di non esercitare l’iniziativa economica e la libera impresa in contrasto con sicurezza e dignità dei lavoratori. Tale strategia ha fallito e politicamente ha generato un’enorme crisi della rappresentanza: il rifiuto della Casta non sarebbe così forte se non ci fosse stato un ceto politico dipendente dal denaro pubblico».
«Il voto di domenica ha un’importanza enorme soprattutto dopo il deludente semestre italiano a guida Matteo Renzi. Il suo arrivo a Bruxelles aveva generato aspettative per le sue promesse di mettere in discussione gli assetti costituzionali europei. Nulla di tutto ciò, nessun negoziato, eppure non era così costoso intraprendere il discorso dell’“utopia necessaria” della riforma dei trattati. Tsipras può rappresentare la riapertura della fase costituente europea. È la mia speranza. Riapertura perché nel 1999 il Consiglio europeo di Colonia stabilisce la centralità della Carta dei diritti ma poi il processo si è chiuso nel ciclo dell’economia. Una vera e propria controriforma costituzionale. L’Unione europea oltre ad avere un deficit di democrazia ha un deficit di legittimità. Il deficit può essere recuperato attraverso i diritti fondamentali, ispirati alla dignità e alla solidarietà, e non al mercato. Altrimenti i rischi sono gravi, e non si parla di uscita dall’euro ma di deflagrazione dell’eurozona e di sviluppo di movimenti xenofobi ed antieuropei come quelli di Marine Le Pen e Matteo Salvin»i.
«In Italia siamo indietro e rischiamo di rifare alcuni errori. Mentre capisco la scelta del “papa straniero” Tsipras, non condivido l’idea di una “Syriza italiana”. È una forzatura. In Grecia Syriza ha raggiunto l’attuale consenso perché durante la crisi economica ha svolto un lavoro effettivo nel sociale dove ha garantito ai cittadini diritti e servizi grazie a pratiche di mutualismo: penso alle mense e alle cliniche popolari, alle farmacie e alle cooperative di disoccupati. In Italia la situazione è differente».
«In questi anni c’è stata una drammatica deriva oligarchica e proprietaria dei partiti e la capacità rappresentativa è venuta meno anche per la consapevolezza che il potere decisionale fosse esterno alle sedi legittime e in mano a poche persone. La Corte Costituzionale ha emesso due importanti sentenze: una contro il Porcellum, decretando illegittima la legge elettorale in vigore, l’altra contro i soprusi del marchionnismo, stabilendo che non potesse essere esclusa la Fiom dagli stabilimenti. Lego queste due fondamentali sentenze perché entrambe pongono il problema della rappresentanza. E lo pongono nell’impresa e nella società cioè nel lavoro e nella politica, nei diritti sociali e in quelli civili. E’ un punto importante sul quale non abbiamo riflettuto abbastanza ed è la via per far recuperare legittimità alle istituzioni e alla politica».
«La sinistra italiana ha alle spalle due fallimenti: la lista Arcobaleno e Rivoluzione Civile di Ingroia. Due esperienze inopportune nate per mettere insieme i cespugli esistenti ed offrire una scialuppa a frammenti e a gruppi perdenti della sinistra. Chi pensa di ricostruire un soggetto di sinistra o socialmente insediato guardando a Sel, Rifondazione, Alba e minoranza Pd sbaglia. Lo dico senza iattanza, ma hanno perduto una capacità interpretativa e rappresentativa della società. Nulla di nuovo può nascere portandosi dietro queste zavorre. Rifondazione è un residuo di una storia, Sel ha avuto mille vicissitudini, la Lista Tsipras mi pare si sia dilaniata subito dopo il voto alle Europee. Ripeto: cercare di creare una nuova soggettività assemblando quel che c’è nel mondo propriamente politico secondo me è una via perdente. Bisogna partire da quel che definisco “coalizione sociale”. Mettere insieme le forze maggiormente vivaci ed attive: Fiom, Libera, Emergency – che ha creato ambulatori dal basso – movimenti per i beni comuni, reti civiche e associazionismo diffuso. Da qui, per ridisegnare il nodo della rappresentanza».
«Ci vuole pazienza e occorre ricostituire nel Paese un pensiero di sinistra. A livello istituzionale abbiamo assistito alla chiusura dei canali comunicativi tra politica e mondo della cultura, ciò si è palesato durante la riforma costituzionale. Come negli anni '60-'70, per il cambiamento istituzionale, deve tornare la rielaborazione culturale. Il lavoro che ha svolto MicroMega in questi anni è prezioso e va continuato in tal senso. Insieme a Il Fatto sono le due testate che hanno tenuto dritta la barra. Ora vanno moltiplicate le iniziative, vanno connessi i soggetti sociali (anche attraverso la Rete) e va recuperato quel che c’è di produzione culturale operativa. Infine, tassello fondamentale: organizzazione. Tali processi non possono essere affidati semplicemente alla buona volontà delle persone».
«Non so se i 5 stelle siano definitivamente perduti, di certo stanno perdendo molteplici chance. Il movimento ha deluso le aspettative: non ha ampliato spazi di democrazia, non ha inciso in Parlamento e in qualche modo ha accettato le logiche interne. Serpeggia una profonda delusione tra gli stessi elettori grillini. Mentre la vera novità è lo sviluppo di un'opposizione sociale al renzismo, l’embrione della coalizione sociale di cui parlavo prima».
»Renzi ha vinto senza combattere, non c’era nessuno sulla sua strada. Nessuno in grado di contrastarlo, nemmeno Giorgio Napolitano che secondo le mie valutazioni politiche aveva investito sul governo Letta. Ora si sta muovendo qualcosa: Susanna Camusso e Maurizio Landini si sono ritrovati per uno sciopero unitario. Persino la Uil è stata costretta a schierarsi. Si è rivitalizzato il sindacato. Il governo Renzi ha cancellato tutti i corpi intermedi e la Camusso, rendendosi conto dell’attacco subito, deve riconquistare il suo ruolo. Individuare soggetti sia rappresentativi che di opposizione sociale è un dato istituzionalmente interessante. Oltre ad essere un dato politico rilevante. Si è manifestata un’opposizione sociale».
«Sono confronti impensabili, il tessuto del nostro Paese è stato logorato da mille fattori nell’ultimo decennio. Anche dalla crisi economica. Con l’impoverimento drammatico le frizioni e le condizioni di convivenza obbligata diventato più difficili. Una situazione conflittuale che va oltre alla “guerra tra poveri”. Le condizioni materiali della solidarietà sembrano distrutte».
«Prima mettiamo in relazione i soggetti sociali, in primis il sindacato, con le reti civiche e strutturiamo un minimo di organizzazione, rilanciando l’attivismo dei cittadini. Da tempo propongo alcune riforme e modifiche dei regolamenti parlamentari per dare maggiore potere alle leggi di iniziativa popolare. Ad inizio legislatura, in concerto con il gruppo del Teatro Valle, abbiamo inviato ai parlamentari una serie di proposte su fine vita e reddito minimo garantito… non sono nemmeno arrivate in Aula. In questo momento nella democrazia di prossimità, quella dei Comuni, si diffondono pratiche virtuose, penso ai registri per le coppie di fatto, per il testamento biologico, ai riconoscimenti nei limiti possibili di diritti fondamentali delle persone. A Bologna si è proposto di cogestire alcuni beni e il nuovo statuto di Parma è pieno di esperienze simili. C’è una democrazia di prossimità che va presa in considerazione. Così come il ruolo della magistratura».
«I partiti di massa erano i referenti delle domande sociali, le selezionavano e le portavano in Parlamento. Io c’ero, me lo ricordo. Questo non esiste più. Regna un modo autoritario di individuare le domande sociali e il vuoto politico è stato colmato dalla magistratura. La Consulta è intervenuta in questi anni su diritti civili, dal caso Englaro alla Fini Giovanardi sulle droghe o alla legge più ideologica, quella sulla fecondazione assistita. Poi le già citate sentenze su legge elettorale e conflitto Fiom-Fiat. Qui non c’è giustizialismo, ma il ruolo di una magistratura – attaccata e in trincea per difendersi dagli attacchi di Berlusconi e salvaguardare autonomia e indipendenza – che ha maturato una propria elaborazione culturale per fronteggiare emergenza politica e garantire la legalità costituzionale. L’aver individuato nella figura di Raffaele Cantone un soggetto politico ha un’importanza storica visto che in Italia la corruzione è ormai strutturale».
«Bah, spesso si cita il nome di Landini ma mi astengo dal rispondere. Non è prioritaria la questione. È palese che oggi la coalizione sociale ha una sua maggiore evidenza perché la presenza del sindacato è il dato nuovo e accresce le responsabilità di Landini e della Fiom. L’importante è uscire dagli schemi classici e visti finora: non dobbiamo pensare al recupero dei perdenti dell’ultima fase o ai pezzetti ancora incerti (minoranza del Pd). Così non possiamo basare l’iniziativa sul M5S. Sarebbe un errore. I 5 stelle hanno una loro storia, vediamo che faranno in futuro e semmai una coalizione sociale riuscisse a rafforzarsi, capire come reagiranno. Questo è il punto».
Lo stratagemma architettato questa volta per sconfiggere “frenatori e gufi” potrà essere ripetuto in futuro, altri espedienti potranno essere escogitati per silenziare il parlamento, le voci di opposizione, la dialettica politica. Ma alla fine che rimarrà del sistema parlamentare?
«Blindando» l’accordo politico definito in sede extraparlamentare. È l’ultimo tassello di un più ampio mosaico costruito per sottrarre ogni autonomia al parlamento. Già erano state forzate le ordinarie procedure di formazione della legge quando si è imposto alla commissione affari costituzionali di interrompere i propri lavori prima di aver ultimato l’esame e prima di poter votare sul disegno di legge trasmesso dalla Camera. Si è così passati all’esame dell’Aula senza che fosse consentito ai senatori in commissione di pronunciarsi nel merito della riforma. E ciò è avvenuto nonostante una previsione costituzionale — l’art. 72 — imponga l’adozione della procedura “normale” di esame e di approvazione in materia elettorale. In modo disinvolto, si è giustificato lo strappo confidando sull’esame dell’Aula. In fondo — qualche ingenuo poteva ritenere — in questa seconda sede non si poteva di certo sfuggire a quanto scrive la nostra costituzione che stabilisce che ogni disegno di legge deve essere approvato articolo per articolo e con votazione finale. E invece la fantasia ha superato ogni ostacolo, riuscendo a liberare la maggioranza di governo da ogni fastidioso limite d’ordine costituzionale.
L’emendamento Esposito ribalta la ratio della disposizione costituzionale e impone anzitutto una sorta di “votazione finale” per poi obbligare i nostri parlamentari ad adeguarsi nelle successive votazioni articolo per articolo. Contro ogni tecnica di buona legislazione fa premettere alla legge una disposizione (significativamente indicata come art. 01) che non ha nessun contenuto precettivo, bensì si limita a riassumere per intero i principi che devono essere contenuti nelle successive disposizioni. Un inusuale e inutile preambolo d’intenti. Si pensa così di aver trovato il modo per impedire ogni ulteriore possibile discussione, votazione ed eventuale approvazione di articoli non conformi (secondo il regolamento del Senato, infatti, non sono ammessi emendamenti in contrasto con deliberazioni già adottate sull’argomento nel corso della discussione). Lo stravolgimento di ogni logica parlamentare appare evidente, l’uso strumentale del regolamento palese. Eppure tutto ciò sta avvenendo sotto i nostri occhi senza scandalo, in nome del cambiamento, sotto la pressione di una politica concentrata sul risultato da conseguire ad ogni costo. Una politica miope e pericolosa.
Miope perché, ridotto il parlamento ad una sala da poker, dove vince il più abile e più spregiudicato tra i contendenti, non sarà facile garantire la stabilità del governo. Di volta in volta il presidente del consiglio dovrà ricercare una sua maggioranza, variabile se non propriamente occasionale: ora con la minoranza interna ora con frange delle opposizioni. Con ben poche garanzie di tenuta e coerenza dell’indirizzo politico complessivo. Inoltre, i governi a maggioranze variabili sono inesorabilmente esposti al potere di “ricatto” ovvero di veto degli alleati occasionali, i quali, non essendo legati alla strategia complessiva dell’esecutivo, potranno legittimamente porre le proprie condizioni e far valere i propri interessi politici e personali del momento. Confidare sul fatto che tanto qualcuno alla fine si trova per far passare le proprie proposte, vista anche l’attuale frantumazione di tutte le formazioni politiche organizzate, sia di maggioranza che di opposizione, francamente non appare una strategia lungimirante. Ma i giocatori di poker — si sa — confidano più sulla propria abilità e sulla fortuna che non sul rispetto delle regole del gioco.
Ed è qui che si nasconde il pericolo maggiore di una simile politica. Fino a quando e fino a dove può arrivare l’interpretazione disinvolta e cinica dei regolamenti, delle prassi, delle leggi, della Costituzione? Lo stratagemma architettato questa volta per sconfiggere “frenatori e gufi” potrà essere ripetuto in futuro, altri espedienti potranno essere escogitati per silenziare il parlamento, le voci di opposizione, la dialettica politica. Ma alla fine che rimarrà del sistema parlamentare?
UNO SCEMPIO COSTITUZIONALE
di Gianpasquale Santomassimo
Stiamo uscendo dalla democrazia parlamentare, ma la cosa sembra non interessare a nessuno. Anche le opposizioni, interne ed esterne al partito di maggioranza relativa, agitano emendamenti su questioni abbastanza secondarie, come le preferenze, ma sembrano accettare il principio di fondo, lo stravolgimento della rappresentanza, il considerare le elezioni come pura e semplice investitura di un potere assoluto e senza controllo.
Mi pare che l’opposizione all’Italicum, in Parlamento come nel discorso pubblico, guardi all’albero senza vedere la foresta, come si usava dire. L’evidenza è quella di una legge-truffa che dà a un solo partito, che rappresenterà in ogni caso una minoranza relativa sempre più esigua di fronte al crollo della partecipazione popolare, una consistenza parlamentare spropositata, che può consentire di fare il bello e il cattivo tempo, di nominare tutte le cariche istituzionali, di correggere e stravolgere la Costituzione a colpi di maggioranza.
Distruggere insomma la divisione e l’equilibrio dei poteri che nell’esperienza repubblicana furono comunque salvaguardati.
La democrazia parlamentare è stata riconosciuta, da tutte le culture democratiche, come il quadro istituzionale in cui le lotte sociali potevano svolgersi liberamente e potevano ottenere conquiste durature, in un clima che pur nell’asprezza dello scontro poteva garantire condivisione di princìpi e ascolto di istanze. A maggior ragione ciò è stato compreso dopo le esperienze del Novecento, e la Costituzione repubblicana recepiva il lascito di quella consapevolezza.
Ma in Italia sembra essersi smarrita, nell’ultimo quarto di secolo, la nozione di cosa sia e a cosa debba servire il Parlamento: rappresentare fedelmente il paese, dibattere liberamente, elaborare e scrivere le leggi, non votare a comando i decreti del governo.
Si sta per abolire il Senato, trasformato in un “dopolavoro” di consiglieri regionali. Perché non abolire anche il Parlamento, a questo punto? Il contraente più anziano del Patto del Nazareno proponeva di far votare soltanto i capigruppo, col loro pacchetto di voti, e il ducetto di contado che domina questa fase terminale della democrazia italiana non sembra avere idee molto diverse quanto ad autonomia e libertà dell’istituzione parlamentare.
Il partito di notabili che si appresta a questo scempio del principio costituzionale sembra aver rinnegato tutta la sua esperienza repubblicana, e sembra oscuramente far riemergere dal suo lontanissimo passato solo l’antica propensione alle dittature di minoranza, dove il segretario di partito comandava su tutto (ma almeno si aveva il buon gusto di differenziare la carica di primo ministro).
Andiamo verso tempi durissimi, ancor più oscuri di quelli che abbiamo vissuto recentemente, nei quali sarebbe fondamentale avere istituzioni rappresentative che rispecchino realmente e fedelmente la società, pur nella sua frammentazione a volte caotica. Si procede invece verso la negazione di ogni forma di limpida rappresentanza, verso l’instaurazione di un rigidissimo principio oligarchico, che nega alla radice qualunque interlocuzione con la società.
Tutto questo è drammaticamente pericoloso, è una china che andrebbe arrestata in qualunque modo, prima che sia troppo tardi. Bisogna che qualcuno, anche tra i “corpi intermedi” così vilipesi e umiliati, cominci a mettere in dubbio la stessa legittimità di un potere minoritario che vuole spadroneggiare col sopruso, a contestare il delirio di onnipotenza di un’accozzaglia di parlamentari eletti con una legge incostituzionale e che pretende di riscrivere a suo piacimento la Costituzione
Il manifesto, 21 gennaio2015, con postilla
Le critiche da sinistra alla proposta di legge elettorale del governo sono concentrate, soprattutto dentro il Pd, sulle preferenze. E ieri il dissenso si è manifestato con la spaccatura del gruppo nell’assemblea del senato. La scelta dei capilista affidata ai partiti e quindi alle loro segreterie, si sostiene, toglie motivazione e potere agli elettori e ne riduce la rappresentanza.
La critica è certamente fondata. Se, però, ricordiamo quanto nel passato avveniva e non solo al sud con preferenze e voto di scambio, l’alternativa migliore non sembra essere tanto la reintroduzione delle preferenze, quanto l’introduzione di collegi uninominali piccoli attraverso i quali avvicinare candidati ed elettori e, quindi, eletti ed elettori.
Ma la questione preferenze che oggi domina il dibattito, e rinsalda l’alleanza Renzi-Berlusconi non è, a mio parere, la principale criticità dell’Italicum. Essa è solo una faccia della medaglia che in nome della governabilità e dell’efficienza di governo tende a sacrificare la rappresentanza degli elettori. Sentirsi rappresentati nelle istituzioni, dipende da due fattori: la presenza negli organismi eletti delle diverse istanze presenti nel paese nelle quali i singoli cittadini possono ritrovarsi anche se minoranze e la partecipazione attiva dei cittadini, attraverso l’espressione del voto, alla competizione elettorale.
L’altra faccia della legge elettorale è costituita dalla proposta di dare un forte premio di maggioranza alla “lista” che raggiunge il 40% dei voti espressi fino ad attribuirle il 55% dei seggi. Di fronte a questa proposta la “legge truffa” di Scelba apparirebbe oggi iper-democratica ed iper-rappresentativa e se essa fosse stata presentata ai tempi di Craxi, certamente l’avremmo etichettata come segno di una tendenza accentratrice e neo autoritaria. Eppure allora la partecipazione al voto si aggirava intorno all’80%, il che avrebbe significato attribuire il 55% dei seggi ad una lista che col 40% dei voti avrebbe raccolto il consenso del 32% degli elettori.
Oggi, con una partecipazione al voto tendente al 50% la proposta contenuta nell’Italicum significa attribuire la maggioranza assoluta della Camera, adesso unico organismo abilitato a scegliere governo, componenti di organi istituzionali ed a decidere leggi e politiche economiche e sociali, ad una lista scelta dal 20% del corpo elettorale. Un quinto degli elettori, quindi, deciderebbe il futuro di tutto il paese.
Questa seconda faccia dell’Italicum è, a mio parere, pericolosissima e meraviglia che pochi finora abbiano parlato di una legge non tanto ad personam, ma “su misura” perché essa nasce dalla particolare situazione che il nostro paese sta vivendo e che, per la crisi del sistema politico italiano, vede un unico partito al comando, anche per le indubbie capacità di Renzi di muoversi nel nuovo panorama politico e di dominarlo.
Ma si può fare una legge elettorale che dovrebbe durare molti anni (negli altri paesi europei le leggi elettorali durano decenni) in base alla contingenza politica ed alla certezza che il possibile vincitore di oggi è un democratico e, quindi, non correremmo pericoli? E si può fare una legge elettorale che si basa su un assetto politico in transizione che non sappiamo in quale direzione evolverà visto che le forze politiche che seguono al secondo e terzo posto sono forze nuove ed impregnate di populismo.
postilla
L'autore segnala un aspetto certamente molto rilevante del "Renzosconicum". Tuttavia stupisce un'affermazione che egli formula: la sua «certezza che il possibile vincitore di oggi è un democratico». A noi sempra che il distruttore della democraza italiana oggi si chiamo proprio Matteo Renzi.
La Repubblica, 20 gennaio 2015 (m.p.r.)
Dopo il pugno, ora arriva il «calcio dove non batte mai il sole»: decisamente gagliardo il Papa! L’intervista rilasciata nel viaggio di ritorno dalle Filippine tocca temi interessanti. Ma soprattutto mostra un Papa dal linguaggio forse ancora più colorito del solito: segno, a mio avviso, di particolare rilassatezza. Papa Francesco appare proprio contento del grande affetto e dell’enorme simpatia che il mondo intero gli manifesta e si lascia andare al cospetto della stampa mondiale come fosse tra amici. Il che sembra proprio la maniera migliore di interpretare il ruolo di per sé così pesante che l’essere Papa comporta, una spontaneità che l’aveva portato il giorno prima, durante la messa più seguita della storia, a tenere a braccio l’omelia davanti ai sette milioni di partecipanti. Quanta differenza rispetto al rigoroso plurale maiestatis che regnava fino a Paolo VI o anche rispetto ai lunghi discorsi letti su fogli accuratamente preparati prima (e spesso da altri) di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, i quali anche nelle conferenze stampa mai e poi mai avrebbero potuto usare le popolaresche espressioni di Francesco.

Più la spingono sotto il tappeto, più la questione immorale si mostra nella sua sconveniente veste di protagonista della scena politica. Proprio ieri, di fronte a un’aula parlamentare pateticamente vuota, il ministro della giustizia, denunciava «la dimensione intollerabile della corruzione in Italia». Intollerabile specialmente quando mette radici nel partito di cui il ministro fa parte, ma così purtroppo non è. Lo dimostrano alcune recenti vicende, due su tutte: il tentativo, solo rinviato, di salvare l’evasore Berlusconi con la legge sulla delega fiscale, e, di queste ore, i brogli elettorali (con il sospetto di una compra-vendita di voti) nelle elezioni primarie in Liguria.
Due facce della stessa medaglia, visto che il famigerato “patto del Nazareno” è fondativo di questa nuova stagione politica. In piena coerenza con quel conflitto di interessi che il Pd non ha mai risolto nel corso degli ultimi vent’anni. Per questo le dimissioni di Sergio Cofferati sono un fatto politico di prima grandezza, rilevante e rivelatore nello stesso tempo. Perché rilevante è evidente: l’ex segretario della Cgil è stato il simbolo dell’antiberlusconismo di sinistra, capace di organizzare la più grande manifestazione del dopoguerra in difesa dell’articolo 18, a fianco del mondo del lavoro e in rappresentanza di quelle radici che oggi la leadership del Pd ha deciso di recidere, nettamente e orgogliosamente, in profonda sintonia con l’ideologia antisindacale del centrodestra.
Insieme a Camusso e Landini, Cofferati è una bandiera contro il jobs act e la definitiva metamorfosi neoliberista del partito renziano (non “di Renzi”, perché non gli appartiene). Ma il “caso Cofferati” è forse ancor di più rivelatore, cioè specchio limpido, della fisionomia etica del nuovo gruppo dirigente del Nazareno. Lui è il primo politico che in modo clamoroso e drammatico se ne va dal partito — del quale è stato uno dei 45 fondatori — denunciando la presenza di una questione morale: «Me ne vado perché sono stati cancellati i valori stessi su cui è nato il Pd».
Altro che delusione per la sconfitta subita alle primarie (peraltro da dimostrare): è un durissimo attacco al voto di scambio («comprano il voto»), è un j’accuse per la palese offerta e l’altrettanto dichiarata accettazione dei voti portati alla candidata vincente, la renziana Raffaella Paita, da parte dei capicorrente del centrodestra ligure e di personaggi fascistoidi, è la penosa presa d’atto dell’acquisto dei voti dei poveri immigrati.
Così si svende una storia, si svende un partito.
Eppure è ancor più penosa la reazione dei vertici renziani del Pd, a cominciare dai due vicesegretari del partito. Invano Cofferati li aveva, già da alcune settimane, avvertiti di quanto stava accadendo senza ricevere neppure lo straccio di una risposta. Ora, dopo le dimissioni, i due colonnelli, Serracchiani e Guerini, sono diventati particolarmente prodighi di dichiarazioni contro l’ingrato Cofferati, accusato di «inspiegabili» e «ingiustificate» dimissioni. Nemmeno un pizzico di senso del pudore. Avanzano camminando sulle macerie del partito - forse perché convinti delle magnifiche e progressive sorti elettorali in caso di voto anticipato.
E Renzi?
L’immagine più nitida dello specchio che l’addio del dirigente politico riflette è quella del segretario. All’ultima direzione del partito Renzi ha chiuso il “caso” in modo brutalmente provocatorio, facendo i complimenti alla vincitrice per la vittoria e rovesciando sul perdente la definitiva sentenza: «Basta, vogliamo vincere, la discussione è chiusa». Una dimostrazione di arroganza, come è ormai consuetudine di questa nuova leadership, ma particolarmente sottolineata e insistita, perché sia d’esempio a chi in futuro volesse portare all’attenzione del partito fastidiosi problemi etici.
Discutere su come si raccolgono i consensi, su come si finanzia un partito, su quale blocco sociale di riferimento si sceglie sono questioni politiche fondamentali, anche se il personalismo, il leaderismo hanno inquinato il comune sentire della gente di sinistra. Tuttavia è importante discuterne oggi come è stato cruciale per l’allora Pci quando a porre la questione nei termini generali che conosciamo fu Enrico Berlinguer. E vale qui la pena solo accennare alla freddezza, e persino alla derisione, con cui la corrente migliorista di allora, guidata dall’ex capo dello stato, Giorgio Napolitano, accolse la durissima critica berlingueriana alla degenerazione del sistema dei partiti, Pci incluso.
Eravamo negli anni’80 e non a caso la vicenda operaia della Fiat, la battaglia sulla scala mobile e l’esplodere della questione morale tenevano insieme i ragionamenti di Berlinguer verso quell’alternativa di sinistra che, nel momento del craxismo trionfante, la prematura fine non gli consentì di mettere in atto. La questione immorale come “questione democratica” torna, nel Pd di Renzi, a essere derubricata come l’espressione del “tafazzismo” delle minoranze che non si rassegnano a spingere il carro del vincitore. Che, tuttavia, non sembra più tanto trionfante se si dà retta ai sondaggi che, settimana dopo settimana, sgonfiano la bolla elettorale delle ultime elezioni europee di maggio.
In ogni caso se le dimissioni di Cofferati sono rilevanti e rivelatrici del mutamento profondo e irreversibile della natura sociale del Pd, la domanda è: fino a quando le opposizioni interne si acconceranno al ruolo di innocue cassandre, di fiore all’occhiello del segretario?
E, a seguire, adesso può nascere in Italia una forza politica a sinistra che raccolga un consenso significativo, come quello di Syriza?
leader ma con tanti aspiranti al ruolo». Il manifesto, 18 gennaio 2015
Negli ampi spazi del Nuovo cinema Nosadella, esaurito in ogni ordine di posti per l’assemblea dell’Altra Europa con Tsipras, può succedere anche di trovare nel retrobottega il poster di un film uscito la scorsa estate. Dimenticabile (a partire dalla coppia di protagonisti Barrymore/Sandler) ma con un titolo piuttosto aderente agli sviluppi della giornata: «Insieme per forza». Anche per amore. «Per tutti noi - ricorda fra gli applausi Panos Lamprou di Syriza - il movimento contro la globalizzazione è stato un insegnamento. E siamo convinti che la sinistra italiana possa sorprendere ancora il mondo».
Sarà un’impresa, nell’Italia del patto del Nazareno. Però ci sono fatti grandi e piccoli che contribuiscono a tenere accesa la fiamma della speranza. Non solo le elezioni greche e i sondaggi spagnoli. C’è ad esempio la presenza qui a Bologna del senatore ex pentastellato Francesco Campanella. E c’è l’addio di Sergio Cofferati al Pd. Il segretario confederale del Circo Massimo, dei tre milioni in piazza con le bandiere della Cgil per difendere l’articolo 18, agli occhi dell’assemblea certifica con la sua decisione la rottura finale fra il mondo del lavoro e il suo partito di riferimento. «C’è grande emozione in sala - sintetizza il bolognese Sergio Caserta - certo l’avesse fatto dieci anni fa…». E Nanni Alleva, neo consigliere regionale dell’Altra Emilia Romagna, amplifica il concetto: «E’ l’ultima dimostrazione del fatto che il Pd è un posto infrequentabile. Anche un politico navigato come Cofferati alla fine si è trovato di fronte a una situazione impossibile. Ora l’importante è che molti italiani che si sono ’messi in sciopero’, non votando, capiscano che c’è un’alternativa: la sinistra. Unita».
«Cofferati – osserva sul punto Curzio Maltese – è l’unico che ha tratto le conseguenze del fatto che nel Pd esiste una questione morale e, subito dopo, una questione politica. Berlinguer avrebbe detto che ’esiste una questione morale nel partito democratico’: basti pensare alla Liguria, all’Expò, alla Tav, allo scandalo del 3%». Quanto alla questione politica, è l’intervento introduttivo della giornata di Marco Revelli a segnalarla puntualmente: «In Italia si è riaperto il conflitto sociale: nel milione di piazza San Giovanni, nello sciopero generale, nello sciopero sociale. E in questi mesi si è anche consumata una frattura storica, fra il mondo del lavoro e il partito che storicamente ne raccoglieva le istanze. Un partito che oggi invece partecipa alla manomissione della Costituzione democratica, e all’attacco al lavoro».
Revelli riassume anche il compito dell’Altra Europa: «Costruire una casa comune, accogliente, della sinistra. E un nuovo linguaggio. Perché da decenni la sinistra ha smarrito il suo, anzi ha assunto quello del neoliberismo». Il sociologo torinese è fra i primi firmatari del manifesto «Siamo a un bivio» presentato ai 700 partecipanti all’assemblea, fra i quali si notano Franco Turigliatto e Antonio Ingroia. A firmare anche Paolo Cento: «L’abbiamo sottoscritto dopo una discussione nel partito — spiega il presidente dell’assemblea di Sel - perché vanno valorizzati gli sforzi di lavorare in un processo politico, aperto e innovativo, ’della sinistra e dei democratici italiani’. Tanti che sono qui oggi saranno anche a Human Factor. E noi pensiamo di poter dare il nostro contributo, ritenendoci importanti ma non certo esclusivi, per allargare lo sguardo e gli spazi a sinistra».
Molti ma non tutti firmano il «manifesto Revelli», che pone la scadenza di una nuova assemblea a marzo per avviare il futuro percorso della forza politica, con chi aderirà, sul duplice binario locale e nazionale. Non firma Barbara Spinelli che dà voce a un gruppo di comitati locali, critici verso quelle che giudicano lentezze eccessive nel processo costituente di un nuovo partito. I giovani under 35 di Act battono invece il tasto del completo rinnovamento del comitato operativo dell’Altra Europa. Sul punto la discussione va avanti per l’intera giornata, e proseguirà anche oggi.
 "Questione abitativa e trasformazioni urbane": questo il sottotitolo del libro di Gaetano Lamanna, di cui pubblichiamo la prefazione: un libro che ragiona «sulla difficoltà di vivere e di abitare oggi, sviluppando con padronanza e con chiarezza (e con lingua asciutta, frasi brevi ed essenziali) i temi generali e quelli specifici».
"Questione abitativa e trasformazioni urbane": questo il sottotitolo del libro di Gaetano Lamanna, di cui pubblichiamo la prefazione: un libro che ragiona «sulla difficoltà di vivere e di abitare oggi, sviluppando con padronanza e con chiarezza (e con lingua asciutta, frasi brevi ed essenziali) i temi generali e quelli specifici».
L’area sempre più vasta del disagio abitativo in Italia è il tema che Gaetano Lamanna affronta con passione e competenza. La passione del sindacalista militante, la competenza di chi ha studiato e frequentato la materia. Non posso non ricordare che proprio sul tema della casa, e più in generale sulla condizione urbana, il sindacato diventò protagonista della vita pubblica alla fine degli anni Sessanta, contribuendo ad avviare «la più grande stagione di azione collettiva nella storia della Repubblica» (Paul Ginsborg). Tutto cominciò con lo sciopero generale del 3 luglio 1969, a Torino, dove il problema delle abitazioni era stato esasperato dalla decisione della Fiat di assumere quindicimila nuovi addetti da reclutare nel Mezzogiorno, il che avrebbe determinato un pesante aggravamento delle condizioni di vita. La Fiat propose addirittura di costruire baracche nei comuni di cintura e nelle fabbriche dismesse (tolto il letto e le suppellettili, restava uno spazio libero di un metro e sessantacinque centimetri quadrati per persona).
A mano a mano, il movimento si estese da Torino a tutta l’Italia. Per la prima volta, non solo le condizioni di lavoro, ma anche quelle di vita nella città, divennero il terreno di un forte scontro sociale che investì l’intero paese e culminò con il grande sciopero generale del 19 novembre 1969, per la casa e l’urbanistica. Nonostante la violenta reazione degli interessi colpiti (le bombe del 12 dicembre a Milano, le stragi e la strategia della tensione) si raggiunsero risultati importanti, a cominciare dalla nuova legge per la casa del 1971 che riorganizzò le forme, gli strumenti e le modalità dell’intervento pubblico in edilizia. A essa seguirono nel 1977 la legge sul regime dei suoli, l’anno successivo l’equo canone e il piano decennale per l’edilizia.
Parafrasando Giorgio Ruffolo, fu l’età dell’oro del compromesso socialdemocratico. Ma durò poco. Con gli anni Ottanta è cominciata la controriforma, e nel giro di pochi anni sono state cancellate una dopo l’altra le conquiste del ventennio precedente. Sono cadute la legge Bucalossi, le norme sugli espropri e quelle per il contenimento degli affitti, fino alla sostanziale dissoluzione dell’edilizia pubblica.
Ancora peggio con la crisi che dal 2008 continua a tormentare in primo luogo le classi sociali più sfavorite. Di questo soprattutto tratta il libro, della difficoltà di vivere e di abitare oggi, sviluppando con padronanza e con chiarezza (e con lingua asciutta, frasi brevi ed essenziali) i temi generali e quelli specifici, la fiscalità, la tassazione immobiliare, la sempre più pressante domanda inevasa, l’esclusione abitativa, il nodo mai risolto del contenimento della rendita. Lamanna ci spiega come nella politica della casa il valore d’uso (l’abitazione come tetto, spazio domestico) ha finito con l’essere sostituito dal valore di scambio (la casa come funzione finanziaria, come veicolo di risparmio). Non cade nella trappola del social housing all’italiana, “un bluff, o meglio un imbroglio”, business allo stato puro, i cui unici beneficiari sono i costruttori. E al riguardo non salva nessuno, denunciando «il ruolo primario, ma inefficace, delle Regioni».
Approfondisce in particolare l’analisi di una della più drammatiche condizioni abitative, quella degli anziani. Gli anziani soli, anzi le anziane, le vedove, più numerose per il minor tasso di mortalità delle donne. Analizza lucidamente le alternative di cui si discute: il ricovero, la soluzione residenziale, quella domiciliare, il cohousing (già oggetto di interesse di fondi immobiliari e di manovratori della rendita). Ma scrive che se togli un anziano dal suo spazio «lo vedrai deperire in pochi mesi, perdere la voglia di vivere». Sradicarli dal loro ambiente è una violenza. La via maestra è mantenere gli anziani nelle proprie case, senza cedere al fascino o al ricatto del nuovo che avanza.
Alla completezza dell’analisi settoriale fa da contrappeso l’attenzione con la quale Lamanna inquadra la politica della casa negli scenari più complessi ma non meno deprimenti delle politiche finanziarie e territoriali. “Rendita crescente, reddito calante” è il titolo di un capitolo che racconta della stretta correlazione fra declino dell’industria e sviluppo immobiliare. Una delle conseguenze del perverso intreccio fra mattone e finanza è stata l’immane valorizzazione delle aree urbane centrali, con l’espulsione dei residenti costretti a trasferirsi in periferie sempre più lontane, stressati dal traffico e dall’alienazione. Alla fine, l’urbanistica è stata obliterata, e anche da questo punto di vista destra e sinistra non sono riconoscibili. «Le amministrazioni locali – scrive Lamanna – hanno dovuto rincorrere i processi anziché programmarli. E i condoni edilizi a livello nazionale, le continue sanatorie a livello locale, tramite varianti, deroghe, cambi di destinazione d’uso degli immobili, sono stati rimedi peggiori del male». Ma di che meravigliarsi, nel 2005 non fu Piero Fassino, allora segretario dei democratici di sinistra, in un’intervista al Sole 24 ore, a riconoscere agli speculatori immobiliari il rango e la dignità di imprenditori?
Nel libro comanda il pessimismo, non si colgono orizzonti di cambiamento a portata di mano. Inutile illudersi e illudere che si possano facilmente riprendere linee di riforma, svolte e ripensamenti rispetto ai disastri dell’ultimo trentennio. Lamanna fa capire che per ricominciare la strada sarà lunga, faticosa, disseminata di insidie. Ma non viene meno al dovere di proporre istruzioni per il futuro. E ho specialmente apprezzato il suo schierarsi a favore di impostazioni alternative in materia di urbanistica, per il recupero e la fine delle espansioni, consapevole che il buongoverno urbanistico è la prima condizione per ridurre il disagio abitativo.
Il manifesto, 17 gennaio 2015
A pochi passi, nel Transatlantico, infuria la battaglia sul prossimo presidente della repubblica. Qui, nell’auletta delle conferenze stampa, le cinquanta sfumature della sinistra sono d’accordo su un nome. Però è Alexis Tsipras, e non stiamo parlando dell’Italia ma della repubblica greca che il prossimo 25 gennaio andrà al voto. Tsipras e la sua Syriza, la coalizione della sinistra radicale, sono favoriti e da ieri puntano persino a un governo monocolore.
L’occasione della rimpatriata è la presentazione ai media della campagna di solidarietà “Cambia la Grecia, cambia l’Europa”. C’è un appello firmato da mille e cinquecento persone e c’è una spedizione della autonominata (e autoironica) “Brigata Kalimera”, duecento italiani che andranno ad Atene, spiega Raffaella Bolini (dell’Altra Europa, già dell’Arci), «a portare a Syriza la nostra vicinanza e ammirazione, a chiedere a loro di vincere anche per noi».
La campagna di solidarietà infatti «va rovesciata», spiega Luciana Castellina, giornalista e fondatrice del manifesto ma anche politica di lungo corso, «in realtà non è Syriza a ricevere la nostra solidarietà, ma noi la loro». Non è una battuta: in Grecia la sinistra sta per vincere le elezioni, in Italia fin qui ha miracolosamente messo insieme un 4 per cento alle europee, un milione di voti. Ma la speranza c’è: «Non avrei mai pensato - dice Castellina - che la sinistra greca, litigiosa come e più di quella italiana, sarebbe riuscita a stare unita».
Ma il punto non è (per ora) l’Italia, o solo l’Italia, ma il cataclisma politico che può portare su tutta Europa l’eventuale vittoria di Alexis Tsipras.
«Tsipras è l’alternativa alla povertà e alla paura», attacca Vendola, al contrario di Renzi che ha vissuto il «fallimentare» semestre di presidenza della Ue «come una critica di costume alle politiche dell’austerità, non come una critica politica all’impianto liberista dell’Europa». Per Pippo Civati le elezioni in Grecia «rappresentano una sfida che investe anche il Pd. C’è una continuità che dobbiamo ritrovare», dice, all’indirizzo degli ex alleati di Sel, quelli della ‘sinistra di governo’.
Stavolta con Civati è d’accordo anche Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione comunista, che rivendica la primazia dei rapporti con la sinistra radicale greca, quando da noi Tsipras era un nome sconosciuto. Oggi in Grecia si può puntare, dice, a «un’alternativa che non sia solo pratica di opposizione e di conflitto ma anche di governo. E’ il segnale che dovremmo dare anche noi in Italia». Insomma, la morale è che per vincere le scommesse italiane serve innanzitutto che i greci vincano le loro.
Per Stefano Fassina, Pd, sono «inaccettabili le ingerenze che tanti governi e istituzioni europee hanno fatto pesare sulla Grecia» (Più tardi, alla direzione del suo partito propone una mozione che dice esattamente così: e sarà approvata, anche Renzi dirà sì). Quelle di Tsipras, conclude Fassina, non sono ricette estremistiche: «E’ proprio il contrario: la proposta di Syriza è realistica e mette in evidenza che un’alternativa è possibile e necessaria. La sinistra riesce a unirsi e a vincere, quando costruisce un programma autonomo rispetto al paradigma dominante». E anche qui si parla di Grecia, ma il discorso sembra perfetto anche per l’Italia.
Linkiesta.it, 18 gennaio 2015
L’Italia è uno dei Paesi con la popolazione più anziana del mondo. E anche le nostre case lo dimostrano. I palazzi sparsi lungo la nostra penisola sono vecchi, divorano energia in eccesso e hanno bisogno di continui interventi di manutenzione. Lo aveva detto il rapporto Cresme 2013 sull’edilizia italiana. Ora lo conferma l’ultima indagine dell’Ufficio studi di Immobiliare.it, il portale degli annunci immobiliari online: il 36,6% delle abitazioni italiane, ossia 11,6 milioni di unità immobiliari, ha più di 40 anni di vita, con picchi di oltre il 40% in alcune città come Potenza, Palermo, Napoli e Catanzaro. Solo a Palermo, il Comune di recente ha censito 1.300 edifici instabili, di cui 228 a rischio crollo.
Se si considera come anno di riferimento il 1977, momento cruciale per l’edilizia per via dell’entrata in vigore delle prime norme sull’efficienza energetica degli edifici, la percentuale di abitazioni costruite prima di questa data arriva al 58,4%: 18,5 milioni di immobili su tutto il territorio nazionale non sono stati progettati quindi in un’ottica di risparmio energetico. L’età avanzata dell’Italia del mattone la rende quindi, oltre che anziana, anche particolarmente energivora: un immobile che supera i 30 anni di età consuma in un anno, mediamente, dai 180 ai 200 chilowattora ogni metro quadro. Un fabbisogno enorme se si considera che un’abitazione in classe B, standard minimo per le nuove costruzioni, arriva a consumare in media tra i 30 e i 40 chilowattora al metro quadro all’anno.
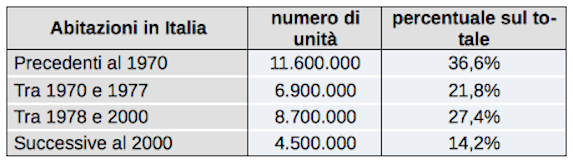
«È ora di riqualificare il nostro patrimonio immobiliare», dice Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it, «e per farlo bisogna limitare la costruzione di nuove abitazioni, puntando alla manutenzione di quelle già esistenti e invecchiate. In questo modo, si ridurranno il consumo del suolo, il fabbisogno energetico globale e la necessità di infrastrutture per la mobilità. Reinvestire sui quartieri obsoleti delle nostre città, infine, può rivelarsi la risposta migliore alla nuova domanda abitativa».
Le case più vecchie si trovano nel Mezzogiorno. Tra le regioni, quella che conta il maggior numero di abitazioni costruite prima del 1970 è la Basilicata, dove gli edifici obsoleti sono il 39,3% del totale. In Sicilia, Campania e Abruzzo la percentuale di abitazioni con oltre 40 anni di età rappresenta il 38,3%; nelle Marche e in Calabria il 38,2 per cento. In Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige si registra invece la percentuale più bassa di edifici precedenti al 1970, con percentuali rispettivamente del 31,2% e del 31,3% sul totale, che restano comunque molto alte.
Tra le città, la più traballante è Potenza, con il 42% del totale delle abitazioni che hanno più di 40 anni. La segue Palermo, dove l’incidenza degli immobili vecchi è a quota 41,3 per cento. A contare il dato più basso è Rimini, dove ci si ferma al 32,2 per cento. A Roma il livello è elevato, toccando quota 38,3%; più bassa l’età del patrimonio immobiliare di Milano, dove il 33,5% degli edifici risale a prima del 1970.
Secondo i calcoli dell’ufficio studi di Immobiliare.it, gli appartamenti over 40 non ristrutturati hanno un prezzo al metro quadro mediamente inferiore del 25% rispetto ad abitazioni realizzate a partire dal 2000. Effettuare lavori di ristrutturazione permetterebbe quindi di evitare la svalutazione degli immobili. Le differenze di prezzo più alte tra immobili ultraquarantenni allo stato originale e immobili nuovi si riscontrano a Trieste e Torino, dove le abitazioni più vecchie costano in media circa il 30% in meno. In base ai calcoli dell’ultimo rapporto Cresme, fra soli dieci anni nelle 14 città metropolitano gli appartamenti con oltre 40 anni di vita saranno l’85 per cento. Se non si interviene, gran parte del nostro patrimonio immobiliare continuerà a divorare energia e a svalutarsi di anno in anno.
Le case più vecchie si trovano nel Mezzogiorno. Tra le regioni, quella che conta il maggior numero di abitazioni costruite prima del 1970 è la Basilicata, dove gli edifici obsoleti sono il 39,3% del totale. In Sicilia, Campania e Abruzzo la percentuale di abitazioni con oltre 40 anni di età rappresenta il 38,3%; nelle Marche e in Calabria il 38,2 per cento. In Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige si registra invece la percentuale più bassa di edifici precedenti al 1970, con percentuali rispettivamente del 31,2% e del 31,3% sul totale, che restano comunque molto alte.
Tra le città, la più traballante è Potenza, con il 42% del totale delle abitazioni che hanno più di 40 anni. La segue Palermo, dove l’incidenza degli immobili vecchi è a quota 41,3 per cento. A contare il dato più basso è Rimini, dove ci si ferma al 32,2 per cento. A Roma il livello è elevato, toccando quota 38,3%; più bassa l’età del patrimonio immobiliare di Milano, dove il 33,5% degli edifici risale a prima del 1970.
Secondo i calcoli dell’ufficio studi di Immobiliare.it, gli appartamenti over 40 non ristrutturati hanno un prezzo al metro quadro mediamente inferiore del 25% rispetto ad abitazioni realizzate a partire dal 2000. Effettuare lavori di ristrutturazione permetterebbe quindi di evitare la svalutazione degli immobili. Le differenze di prezzo più alte tra immobili ultraquarantenni allo stato originale e immobili nuovi si riscontrano a Trieste e Torino, dove le abitazioni più vecchie costano in media circa il 30% in meno. In base ai calcoli dell’ultimo rapporto Cresme, fra soli dieci anni nelle 14 città metropolitano gli appartamenti con oltre 40 anni di vita saranno l’85 per cento. Se non si interviene, gran parte del nostro patrimonio immobiliare continuerà a divorare energia e a svalutarsi di anno in anno.
La Repubblica, 17 gennaio 2015
Eppure Greta e Vanessa non erano alla loro prima missione umanitaria, non erano ragazzine sprovvedute, ma giovani donne con degli interessi e degli ideali. Qualche decennio fa alla loro età si era già madri: cerchiamo di uscire quindi dal luogo comune della gioventù irresponsabile che va criticata se perde tempo a laccarsi le unghie, a farsi canne o a bere birre ai bar, ma che diventa bersaglio anche quando occupa la propria vita in maniera diversa. Greta e Vanessa, due giovani donne, non due ragazzine viziate, non due amanti dell’uomo con il kalashnikov, fondano, insieme a Roberto Andervill, Horryaty, un progetto di assistenza con l’obiettivo di portare medicine e generi di prima necessità alla popolazione siriana. Ecco perché partono, per portare aiuti alla popolazione che sta subendo gli attacchi di Assad. Ma al commentatore medio che ci siano centinaia di migliaia di persone a cui manca tutto non interessa: gli elementi su cui si basano le critiche a Greta e Vanessa sono la loro giovane età, l’essere donne e le foto che vengono diffuse dai media, che le ritraggono insieme, abbracciate e sorridenti. Foto ingenue di ragazze abbracciate, foto allegre, che sono in ogni album di famiglia. Come se chi critica non avesse foto come quelle, come se non le avessero i loro figli.
Come è possibile — c’è addirittura chi si domanda in un ignobile e falso paragone — prodigarsi, lavorare, pagare per loro e non per i marò?
Che sia stato pagato o no un riscatto, la canea è scattata sulla cifra dei 12 milioni che sarebbero stati pagati. La notizia è stata diffusa tramite un account Twitter (@ekhateb88) ritenuto vicino alle milizie jihadiste. Qualsiasi altra affermazione avesse diffuso non sarebbe stato creduto: ma in questo caso la frase è diventata oro colato.
Tutto serve a sporcare la vicenda di Vanessa e Greta. Come le balle diffuse da alcuni media, che le accusano di essere sostenitrici dei terroristi, per una foto scattata in Italia durante una manifestazione che si è tenuta a Roma il 15 marzo scorso. In quell’immagine Greta e Vanessa, coperte da bandiere della Siria libera, mostrano un cartello in arabo con su scritto “Agli eroi di Liwa Shuhada grazie per l’ospitalità e se Dio vuole vediamo la città di Idlib libera quando ritorneremo”. Uno slogan di chiaro sostegno alla dissidenza laica in Siria, proprio quella abbandonata, proprio quella schiacciata da Assad e da chi lo sostiene.
Greta e Vanessa non erano e non sono dalla parte dei terroristi, ma dalla parte del pane. Erano in Siria per portare impegno. E qui arrivano gli insulti che più di tutti mi colpiscono perché, se non puoi dir loro che sono contigue ad Al Qaeda e all’Is, se non puoi dir loro che sono bambine viziate, se non puoi dir loro che sono due incoscienti, allora hai sempre a disposizione l’accusa più inutile, quella però che fa subito presa perché è banale e in fondo non sembra offensiva: «Ma se volevano fare del bene, non potevano farlo in Italia?». Come è accaduto a Fabrizio Pulvirenti, il medico di Emergency colpito da Ebola in Sierra Leone: quando rientrò in Italia ci fu una parte del Paese che senza vergogna disse che se l’era cercata. Il pensiero principale sembra essere che siano responsabili delle loro sciagure e che per questo motivo non solo non devono essere aiutate, ma magari anche punite.
E qui dobbiamo fare uno sforzo, dobbiamo andare oltre le parole e capire il fallimento del Paese insito in questi giudizi. Parole che sono una scarica incontenibile di frustrazione, la frustrazione di chi non è in grado di muovere un passo, di chi è fermo al palo, di chi non riesce a immaginare una vita diversa e se la prende con chi decide di mettere la propria a disposizione di un ideale.
L’Italia è un Paese che esporta soprattutto solidarietà ed è molto triste pensare che gli stessi che insultano Greta e Vanessa ritengano invece che sia fondamentale imbracciare fucili e organizzare missioni militari. «Dobbiamo difendere, dobbiamo attaccare, dobbiamo prevenire con la forza, ma gli aiuti umanitari, quelli sono materia per ragazzine viziate ». Tutti Charlie Hebdo, ma a casa propria ché se poi vi capita qualcosa ve la siete cercata.
Un Paese che non riesce a mostrare solidarietà verso due ragazze sequestrate rischia di essere un Paese fallito, che fa vincere il livore, la rabbia, l’idiozia. Stati Uniti e Gran Bretagna hanno deciso di non pagare riscatti e questo è il motivo per cui i loro giornalisti vengono uccisi così barbaramente: lì il dibattito è esattamente l’opposto di quello che sta animando la nostra peggiore stampa. Ma in quei Paesi non passa per la mente a nessuno di dire che in luoghi come la Siria le missioni umanitarie non vadano fatte, che meglio sarebbe fare beneficenza a casa propria per non correre rischi. Non passa per la mente a nessuno di dire che chi viene rapito e poi magari ucciso da giornalista in trincea, poteva restare in patria e accontentarsi di rimasticare agenzie.
Se incoscienza c’è stata, c’è stata dalla parte del pane, delle bende, del mercurocromo, delle tende da montare, dell’acqua e il nostro Paese sta dando uno spettacolo indegno, sta mostrando la sua incapacità di sognare, di lottare, di impegnarsi, di prendere parte alla trasformazione della realtà. La cooperazione internazionale è la migliore esportazione possibile. Il nostro Paese sta dando prova di non capire che esistono diversità, che c’è chi resta in Italia e lavora per rendere il Paese migliore dall’interno e chi va fuori e si occupa di cose apparentemente lontane, ma che hanno un’ovvia connessione con ciò che ci circonda. L’Italia sta dando prova di non capire che il mondo non è diviso per compartimenti stagni, che ciò che accade in Siria interessa anche noi, che a essere contagiosa non è la presenza di democrazia, ma la sua assenza. Il mondo non è sotto casa, quel che accade in Siria ci riguarda da molto vicino. È al cospetto di queste situazioni che si tempra l’unità del Paese e la sua capacità di vedere oltre il proprio recinto. Mi vergogno delle reazioni di molti miei connazionali, delle loro parole, del loro livore, del loro odio. Se un Paese non è capace di stare accanto a due giovani donne volontarie, che hanno passato in condizioni di sequestro quasi sei mesi della loro vita, allora merita il buio in cui sta vivendo.
Il manifesto, 16 gennaio 2015
Un week end di discussione, il prossimo, a Bologna organizzato dall’Altra Europa; quello successivo a Milano convocato da Sel. Poi il voto per le presidenziali greche, che cadrà il 25 gennaio, dove è molto probabile la vittoria di Alexis Tsipras, leader della coalizione Syriza. Un voto, quello greco, che cade prima di quello per il capo dello stato italiano e rischia di avere un impatto anche più forte sulla politica del nostro paese. Nella variegata galassia delle sinistre nostrane parte una mobilitazione che punta su Atene per arrivare a Strasburgo, passando per Roma.
Stamattina infatti alla camera un gruppo di personalità diversamente collocate a sinistra (fra gli altri Luciana Castellina, Nichi Vendola, Paolo Ferrero, Marco Revelli, Antonio Ingroia ma anche Pippo Civati e Stefano Fassina) presenteranno le iniziative di una campagna di mobilitazione internazionale nata dall’appello ’Cambia la Grecia, cambia l’Europa’ firmato ormai da migliaia di cittadini per «sostenere la libera scelta del popolo greco contro le pressioni dei mercati finanziari e la disinformazione di molte testate giornalistiche sul programma di Syriza». Fra le iniziative, quella della ’Brigata Kalimera G25’, che dall’Italia si prepara ad andare ad Atene a sostenere Tsipras e Syriza nei giorni del voto. Iniziative analoghe sono partite nelle capitali di tutta Europa. Occhi puntati sulla Grecia, ma anche sull’Italia che dal voto greco potrebbe ricevere una scossa se non uno scrollone.
A questo sarà dedicato gran parte del dibattito che si terrà a Bologna (al cinema Nosadella) sabato e domenica prossimi. Lì l’Altra Europa con Tsipras, la lista che si è presentata alle scorse europee, discuterà di Grecia ma anche del massacro della redazione del Charlie Ebdo parigino. Nel pomeriggio di sabato affronterà invece il ’manifesto siamo a un bivio’ (testo integrale su lista tsi pras .eu). Il ’bivio’ fa riferimento alla strada europea del dopo-voto greco, ma anche alla strada italiana che potrebbe trasformarsi, dal viottolo di un’ennesima nuova sigla a sinistra, nella via più larga di una ’cosa’ comune a sinistra, invocata agognata e data per imminente persino da chi non se la augura — come il presidente del consiglio Matteo Renzi — ma ancora impelagata in una lunghissima fase di gestazione. Il documento che arriva alla discussione dell’assemblea nazionale, condiviso dalla stragrande maggioranza del gruppo preparatorio ma non da tutti, parla chiaro: «Intendiamo metterci al servizio di un processo che porti alla costituzione di una sola “casa comune della sinistra e dei democratici italiani in un quadro europeo”» che dovrebbe sfociare alle politiche in «un’unica lista», come succede già in Grecia e in Spagna, «in grado di unire tutte le componenti sia organizzate che disperse di una sinistra non arresa alla austerità europea e alla sua versione autoritaria italiana incarnata dal renzismo». «Il 2015 può essere davvero l’anno del cambiamento», è la conclusione «facciamo ciascuno un passo indietro, per fare insieme due passi avanti».
Il week end successivo, quello che va dal 23 al 25 gennaio, gli attivisti dell’Altra Europa, ma stavolta insieme a molti altri provenienti da mondi diversi e anche dalla sinistra Pd, si ritroveranno a Human Factor, la ’Leopolda rossa’ di Sel, a Milano. Incontri ravvicinati che dovrebbero superare le incomprensioni e le divisioni del dopo-europee. Almeno nelle intenzioni di tutti, o quasi. E che potrebbero portare a candidati unitari anche alle prossime regionali, in calendario per maggio. Così è già nelle Marche, dove ieri un ampio cartello delle sinistre ha annunciato la corsa contro il candidato del Pd qualunque sarà (in regione i dem si stanno dilaniando nella scelta se fare o no le primarie). Così potrebbe essere anche in Liguria, dove Sergio Cofferati è stato sconfitto alle primarie del centrosinistra ed ora molte voci, alcune anche del Pd, chiedono un nome alternativo alla burlandiana Lella Paita.
Nell’album delle figurine di famiglia manca ancora anche la casella di Pippo Civati. Che da tempo guarda a sinistra fuori dal suo partito ed ha già spiegato che «se si andasse al voto ora» non si ricandiderebbe su un programma «che non condivido», quello di Renzi. Sulla sua scelta peserà il nome del presidente della repubblica che Renzi proporrà al Pd. Se sarà evidentemente frutto del Patto del Nazareno, o un nome concordato con la sinistra del suo partito.
«Vi sono nelle nostre culture utopie positive alle quali fare appello perché il futuro sia sottratto all’orizzonte pessimistico? Oggi la libertà è minacciata ma in questo momento la parola più difficile da pronunciare è fraternità o solidarietà. Ma solidali con chi?». La Repubblica, 16 gennaio 2015
mass media tentano di cancellare: la proposta politica della sinistra europea, presentata in Grecia dalla lista Syriza, è ragionevole e realistica la vittoria di Tsipras il 25 gennaio: aiuterebbe davvero l'Europa a uscire dalla crisi. Il manifesto, 16 gennaio 2015
«Il rischio per l’Europa non è Tsipras ma la Merkel». Questa verità espressa qualche settimana fa da Piketty mi ha dato una botta di ottimismo. Perché Piketty, pur non avendo alcun potere deliberativo, si è accreditato come voce ascoltata e rispettata (basti pensare alle astronomiche cifre raggiunte dalla vendita del suo ultimo libro); e, sia pure sempre meno, l’opinione pubblica ancora conta un po’.
Piketty non è del resto il solo economista importante ad essersi espresso in questo senso su Syriza: sui più importanti quotidiani europei e persino americani sono state non poche le voci autorevoli che hanno analizzato con serietà il programma del partito che nei sondaggi appare vincente nelle prossime elezioni greche, e ne hanno tratto la conseguenza che non si tratta di grida di un insensato estremismo, ma di proposte largamente condivisibili.
Se questo è accaduto è perché Tsipras non ha solo ottenuto l’appoggio di così larga parte del popolo greco che chiede giustizia, ma anche di un bel nucleo di economisti del paese che sono diventati suoi consiglieri (e alcuni candidati a ministro nell’ipotesi di conquistare la direzione del governo di Atene). Si tratta di ex studenti greci che, come tantissimi, sono emigrati nel mondo per frequentare le università eccellenti del Regno Unito, della Francia, della Germania; e anche di quelle americane. Per questo sono conosciuti e ascoltati anche fuori dal loro paese.
Il potere deliberativo ce l’ha per ora questo esecutivo dell’Unione europea che proprio nel suo ultimo vertice - sordo e cieco rispetto alla realtà greca - ha ribadito le solite posizioni: no a ogni ristrutturazione del debito, ma solo un breve prolungamento dei tempi di restituzione. Del tutto insufficiente a impostare una politica di lungo periodo per garantire una ripresa economica quale sarebbe necessaria.
Né le annunciate promesse di aumento della liquidità annunciate dalla Bce (il Qe, quantitative easing) sembra possano davvero aiutare: l’esperienza di questi anni sta lì a dimostrare come ogni volta che le banche ottengono soldi si affrettano a darli ai big più sicuri e non ai protagonisti di una diffusa e minuta economia autoctona.
Quanto la Grecia chiede non è l’elemosina, ma i mezzi per impostare un nuovo modello di sviluppo, che non sia la riproposizione di quello eterodiretto adottato negli anni passati dagli speculatori stranieri in combutta con quelli locali, responsabile di aver portato il paese alla catastrofe.
Senza neppure porsi qualche interrogativo autocritico l’esecutivo europeo, e i governi che ne sostengono le posizioni, non intendono capire che non si uscirà dalla crisi se non con un mutamento radicale, non limitandosi a consentire ai cittadini un po’ più di inutile consumo nelle catene dei supermarket internazionali (il modello degli 80 euro di Renzi). Una vittoria di Syriza il prossimo 25 gennaio può aiutare tutti a riproporsi questo ordine di problemi. Speriamo.
 «L'anticipazione. "Governare non significa avere il potere. Siamo all’inizio di un processo di lotta. Come in Brasile col Pt, dobbiamo cercare di mantenere la coesione sociale". Tsipras tratteggia le caratteristiche di un potenziale governo di sinistra: "Ci saranno grandi trasformazioni e la priorità, in questo momento, è la fine dell’austerità».
«L'anticipazione. "Governare non significa avere il potere. Siamo all’inizio di un processo di lotta. Come in Brasile col Pt, dobbiamo cercare di mantenere la coesione sociale". Tsipras tratteggia le caratteristiche di un potenziale governo di sinistra: "Ci saranno grandi trasformazioni e la priorità, in questo momento, è la fine dell’austerità».
Il manifesto, 14 gennaio 2015
Teodoro Andreadis Synghellakis, greco ma quasi dalla nascita residente in Italia dove i suoi genitori si erano rifugiati durante la dittatura, ha scritto un libro – Alexis Tsipras. La mia sinistra – che contiene una assai interessante intervista con il leader di Siryza che qui si sofferma soprattutto sulla natura del nuovo partito che la sinistra greca ha saputo darsi.
La prefazione al volume - che sarà nelle librerie da giovedì 15 - è di Stefano Rodotà e contiene anche i giudizi di un certo numero di protagonisti della politica italiana. Ve ne diamo, in anteprima, alcuni stralci.
Il rafforzamento della sinistra è ancora un processo in divenire?
Dovremo sempre tenere a mente che abbiamo l’obbligo di suscitare tra i nostri sostenitori una presa di coscienza sempre più democratica, radicale, progressista. Non possiamo permetterci il lusso di ignorare il fatto che gran parte della società greca, e anche una percentuale di nostri sostenitori, abbiano assorbito idee conservatrici; che c’è stato un tipo di progresso il quale aveva come punto di riferimento la conservazione.
Dobbiamo, inoltre, separare il significato che ha un governo della Sinistra, da un rischio di abuso di potere da parte della Sinistra. Il potere è una cosa più complessa, che non viene esercitata solo da chi governa. È qualcosa che ha a che fare anche con le strutture sociali, con chi controlla i mezzi di produzione. Noi rivendicheremo il governo del paese, così da poter dare avvio – da una posizione di forza – a quella grande battaglia ideologica e anche sociale che porterà a cambiamenti e trasformazioni i quali daranno il potere alla maggioranza dei cittadini, sottraendolo alla minoranza.
Ma la gente deve comprendere bene che il fatto che Syriza andrà al governo non significa automaticamente che il potere passerà al popolo. Significa, invece, che inizierà un processo di lotta, un lungo cammino che porterà anche a delle contrapposizioni - un cammino non sempre lineare - ma che verrà sicuramente caratterizzato dal continuo sforzo di Syriza per riuscire a convincere delle forze ancora più vaste, per accrescere la sua dinamica maggioritaria ed il consenso verso il suo programma, con l’appoggio di forze sociali sempre più ampie.
Tutto questo, per riuscire a compiere passi in avanti assolutamente necessari. Sto descrivendo un cammino che in questo periodo, seguono molti partiti e governi di sinistra in America Latina, anche se mi rendo conto che, in parte, si tratta di una realtà che può risultare estranea alla quotidianità europea. So bene che la grande domanda che provoca un interesse cosi forte nei nostri confronti, è come tutto ciò potrà diventare realtà nel contesto della globalizzazione e all’interno dell’Unione Europea, visto che la Grecia non è un giocatore solitario.
C’eravamo schierati, ritrovati tutti a Sinistra - anche io, ovviamente - avevamo accettato e sostenuto un modo di vita, che aveva a che fare, principalmente, con la resistenza, con la denuncia ed un approccio teorico tendente ad una società “altra”. Non c’eravamo confrontati, però, con il bisogno pratico di aggiungere ogni giorno un piccolo mattone per poter costruire questa società di cui parlavamo, specie in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Se domani Syriza sarà chiamata a governare, sarà obbligata ad affrontare una situazione sociale, una realtà drammatica: la disoccupazione reale al 30%, una povertà diffusa, una base produttiva praticamente distrutta. E si tratterà – fuor di dubbio – di una scommessa enorme, anche questa di portata storica.
Si potrebbe dire che sarà una scommessa simile a quella del Brasile di Lula, quando venne eletto presidente. Noi, intendo la Sinistra nel suo complesso, dobbiamo cercare (senza trovarci nella difficilissima posizione e nel ruolo del capro espiatorio), di riuscire a mantenere la coesione dei gruppi sociali, all’interno di un progetto di ricostruzione produttiva, di democratizzazione e di uscita dalla crisi. Ed è un’impresa molto difficile.
Guardando tutto ciò anche da fuori, si può guardare in questo momento a Syriza quasi come ad un caso unico, dal momento che non appartiene alla famiglia della socialdemocrazia, non si identifica nelle posizioni dei partiti tradizionalmente comunisti e sta cercando di tracciare una strada nuova, creando un spazio nuovo tra queste due grandi famiglie. Si potrebbe parlare di un esperimento che cerca di riformare le posizioni della Sinistra, tenendo insieme, appunto, i suoi “punti forti” e il bisogno di modernità?
Possiamo dire che è cosi, ma si tratta di un processo che è iniziato da metà degli anni Novanta, quando in Grecia è stata creata la Coalizione della Sinistra e del Progresso, Synaspismòs. Parliamo del periodo in cui, in Europa, una serie di partiti post comunisti - dopo la caduta del Muro di Berlino - cercavano di apporre il loro tratto ideologico e politico, andando oltre i confini della socialdemocrazia e della strada seguita sino ad allora dai partiti di area comunista. È in quel periodo che si è formato anche il Partito della Sinistra Europea che comprendeva e continua a comprendere anche alcuni partiti comunisti. Sono dei partiti, tuttavia, che hanno compiuto una seria autocritica riguardo al periodo stalinista ed hanno rinnovato il loro modo di interpretare ed elaborare la realtà. Tra i membri del Partito della Sinistra Europea, ovviamente, ci sono anche forze come Syriza, la coalizione in cui si è trasformato Synaspismòs.
Analizzando la cosa, qualcuno potrebbe dire che questo tratto ideologico è riuscito a raggruppare delle forze appartenenti a una Sinistra indebolita ed in disfacimento, che non riusciva a superare il 6 o 7%. Ora, però, Syriza sta rivendicando la guida della Grecia, il governo del paese. Io vedo come una cosa estremamente positiva il fatto che il nostro sia un partito giovane ma con alle spalle, tuttavia, una lunga tradizione. Le sue radici affondano nel secolo passato, ma quello che abbiamo, appunto, è un partito giovane. Altrettanto positivo è il fatto che non appartenga al blocco di forze le quali continuano a seguire l’ortodossia comunista, e che non faccia parte della famiglia socialdemocratica.
Stiamo parlando, ovviamente, di una socialdemocrazia che oggi è parte integrante della crisi in atto e che ha una grande responsabilità per lo stato in cui si è venuta a trovare l’Europa. È una socialdemocrazia “geneticamente modificata”, che ha adottato quasi tutti i credo neoliberisti. In questo senso, quindi, potremmo dire che tanto Syriza quanto gli altri partiti della nuova Sinistra dell’Europa non portano sulle spalle il peso dei “peccati originali” di alcune forze che appartengono alla nostra tradizione. Contemporaneamente, non sono neanche responsabili dei grandi delitti perpetrati dalla socialdemocrazia nel periodo che stiamo vivendo.
Siamo in grado, cioè, di offrire una prospettiva più ampia, di catalizzare ed unire forze ancora maggiori, rispetto a quelle raggruppate, tradizionalmente, dalle forze del blocco socialista.
A chi è solito sottolineare che siamo un partito filoeuropeo - il quale comprende la situazione che si è venuta a creare con la realtà data della globalizzazione - ma non apparteniamo a nessuna grande famiglia politica dell’Europa, vorrei ricordare questo: nel 1981, anche il Partito Socialista del Pasok, di Andreas Papandreou, si trovava esattamente nella nostra stessa situazione: non apparteneva, in realtà, né all’Internazionale Socialista, né ai partiti socialdemocratici e neanche alla sinistra socialista.
il manifesto 14 gennaio 2014 (m.p.r.)
Il bicchiere è mezzo pieno, ma non per questo bisogna berselo tutto d’un fiato. Considerando la posta in gioco, le associazioni ambientaliste non intendono accontentarsi della normativa approvata dal Parlamento europeo che lascia ai paesi membri la facoltà di decidere se coltivare o meno Ogm. La palla adesso passa al governo Renzi, anche perché a febbraio scadrà il bando provvisorio che vieta gli Ogm in Italia.
Per l’attivista indiana Vandana Shiva le norme approvate ieri sono anche un successo dei movimenti: «Gli europei sono da oggi un po’ più liberi e il resto del mondo ha un modello da seguire». Tuttavia c’è qualcosa che non va, in particolare “alcuni regali” fatti alle «Gli stati hanno il diritto di non permettere la coltivazione di Ogm per questioni socio-economiche, mentre non possono ricorrere a motivazioni essenziali come quelle ambientali, che rimangono di competenza europea. Il timore è che il paese che dice no al biotech diventi giuridicamente fragile e possa essere aggredito dalle multinazionali». Anche perché presto in Europa arriveranno nuovi brevetti da valutare. Vandana Shiva rivolge poi un appello all’Italia: «Approvi leggi per rafforzare le basi giuridiche della scelta anti-Ogm. Facciamolo subito».
Sono le medesime preoccupazioni di Greenpeace. «E’ una norma lacunosa - spiega Federica Ferrario - che avrà bisogno di mesi prima di essere recepita in Italia: dobbiamo invece difenderci subito dal mais della Monsanto”. Ferrario si sofferma sulla lacuna più insidiosa: «I governi non possono basare i divieti su specifici impatti ambientali o evidenze di possibili danni da parte delle coltivazioni Ogm a livello nazionale, anche nel caso in cui questi rischi non siano stati presi in considerazione da parte della valutazione dell’Efsa» (agenzia europea, ndr).
Anche Legambiente, pur esprimendo soddisfazione, chiede al governo una prova di “fedeltà” alla nuova «Adesso per salvaguardare l’agricoltura italiana va subito prorogato il decreto di divieto di coltivazione degli Ogm attualmente in vigore nel nostro paese», dice il presidente Vittorio Cogliati Dezza. Vincenzo Vizioli, presidente di Aiab, punta il dito contro la “vaghezza” di alcune norme ed è preoccupato anche per i possibili giochi si sponda che si potranno aprire tra la nuova normativa sugli Ogm e il Ttip (trattato di libero scambio tra Usa e Ue), poiché non gli sembra credibile che gli Usa rinuncino ad imporre le sementi modificate. Ecco perché chiede «l’approvazione di una norma che estenda l’obbligo di etichettatura anche ai prodotti derivati da animali alimentati con Ogm».
Chi invece non esprime alcuna riserva è Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti: «Siamo di fronte ad un importante e atteso riconoscimento della sovranità degli stati di fronte al pressing e alle ripetute provocazioni delle multinazionali del biotech. L’Europa da un lato, le Alpi e il mare dall’altro, renderanno l’Italia finalmente sicura da ogni contaminazione Ogm a tutela della straordinaria biodiversità e del patrimonio di distintività del made in Italy”.
Dopo quattro anni di trattative serrate poco trasparenti e molto complicate, ieri a Strasburgo il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva Ue che permetterà agli stati membri di vietare sul proprio territorio la coltivazione di organismi geneticamente modificati (Ogm); possibilità che viene garantita anche per quegli Ogm che sono già stati autorizzati a livello comunitario.
Si tratta dunque di una norma che rafforza quella sovranità nazionale che le multinazionali del biotech hanno cercato di mettere in discussione in nome di una libertà di commercio che avrebbe potuto (e potrebbe) condizionare il sistema agroalimentare del pianeta. La partita non è ancora finita e considerando la posta in gioco a pensar male non si fa peccato. Si spiega così la prudenza con cui alcune associazioni ambientaliste hanno accolto la (sostanzialmente) buona notizia che in fondo era attesa da anni. Il timore è che alcune parti piuttosto deboli e confuse della direttiva sembrano scritte dagli azzeccagarbugli per lasciare spazi di agibilità alle aziende che commerciano sementi modificate.
Il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina non nutre dubbi in proposito e passa all’incasso. «In materia Ogm - spiega - il punto di novità europeo è molto importante e si iscrive nei successi della presidenza italiana. Non era scontato che finisse così». Il ministro ha anche confermato la vocazione Ogm-free del governo. Altro fatto tutt’altro che scontato, anche se nessun governo europeo (Spagna e Portogallo a parte) oggi potrebbe permettersi di sfidare l’opinione pubblica lasciando campo libero agli Ogm: 8 italiani su 10 da un decennio dicono di non volerne sapere. «Continuo a rimanere dell’idea che l’Italia - ribadisce il ministro - faccia bene a lavorare oltre il tema Ogm sì Ogm no, confermando la non coltivazione perché il modello agroalimentare italiano ha bisogno di posizionarsi sempre di più su fattori distintivi che stanno tutti dentro il lavoro sulle qualità agroalimentari italiane. Per questo una coltivazione Ogm mi sembrerebbe incoerente con questo lavoro che dobbiamo fare”.
La nuova direttiva è stata approvata con 480 voti favorevoli, 159 contrari e 58 astenuti (tra due anni si cercherà di raggiungere un nuovo accordo unanime). Le nuove norme entreranno in vigore in aprile. Si può dire che il braccio di ferro tra paesi pro e contro gli Ogm alla fine si sia risolto in favore di questi ultimi, anche se non va trascurato il fatto che la libertà di dire “no” agli Ogm viene compensata dall’introduzione di procedure più snelle per la loro autorizzazione a livello comunitario. Significa che uno stato d’ora in poi potrà più facilmente decidere anche di “aprirsi” agli Ogm, creando non pochi problemi ai paesi confinanti (perché mai uno stato dovrebbe convertirsi agli Ogm, per fare un esempio, lo spiega il caso dell’Ucraina che ha appena fatto gli onori di casa a Monsanto, mentre prima della “svolta” filo occidentale quei semi erano vietati).
Le norme approvate ieri dicono che gli stati membri contrari agli Ogm possono esprimere il proprio diniego durante la fase di approvazione comunitaria, inoltre potranno vietare la coltivazione con un divieto valido entro dieci anni dall’approvazione comunitaria (il testo precedente ne indicava due). In più, potranno vietare la coltivazione non solo di un singolo tipo di Ogm ma anche di un gruppo di Ogm che presentano caratteristiche simili. Un altro miglioramento decisivo, rispetto al testo precedente, cancella la norma secondo cui uno stato per vietare gli Ogm avrebbe dovuto confrontarsi direttamente con la società biotech: sarà invece la Commissione europea a fare da cuscinetto per la trattativa.
L’aspetto più scivoloso della normativa, quello che lascia perplesse alcune associazioni, si riferisce invece alla motivazioni con cui uno stato sarà chiamato a spiegare il divieto di coltivazione. I divieti potranno essere motivati per ragioni socio-economiche, di politiche agricole, di interesse pubblico, di pianificazione urbana e - naturalmente - anche per “ragioni di politica ambientale”. Tuttavia in quest’ultimo caso la valutazioni non potranno fornire valutazioni opposte rispetto a quelle fornite dall’Autorità europea di sicurezza alimentare (Efsa), solitamente piuttosto tenera nel valutare l’impatto degli Ogm.
Il problema relativo al potenziale inquinamento dei campi Ogm nei pressi delle frontiere è stato risolto imponendo alcuni vincoli: misure obbligatorie di “coesistenza” (la distanza di sicurezza tra un campo e l’altro, poiché i pollini volano per chilometri) e la costruzione di barriere fisiche, a meno che i paesi non siano separati da montagne o mare. Stando così le cose - e forse sottostimando la capacità di persuasione delle multinazionali del biotech - l’Europa può dirsi quasi salva dall’invasione. Oggi, infatti, solo la Spagna coltiva una superficie considerevole di Ogm (116 mila ettari di mais Monsanto 810, l’unico fino ad ora autorizzato dalla Ue). Mentre altri paesi coltivano piccoli appezzamenti (Portogallo 9 mila ettari, Romania 217 e Slovacchia 189).
La Repubblica, ed. Firenze, 14 gennaio 2015 (m.p.g.)
Quanti secoli ci ha messo il cristianesimo a ripudiare la convinzione che si possa uccidere in nome di Dio? Quando aveva l'età che ha ora l'Islam, in Europa scorrevano fiumi di sangue. E sembra che ci siamo dimenticati che, in nome del cristianesimo, solo vent'anni fa furono uccise decine di migliaia di musulmani bosniaci, a poche centinaia di chilometri da Ancona.Se vogliamo accelerare un simile ripudio nell'Islam italiano, se vogliamo che siano più numerose e più forti le voci di chi dice «not in my name» (come ha subito gridato Igiaba Scego, scrittrice musulmana di origine eritrea, che vive a Roma), abbiamo un'unica strada: accelerare l'integrazione. Ma quella vera.
Per far questo occorre radicalizzare la laicità, e dunque la terzietà religiosa, dello Stato: e contemporaneamente consentire il più pieno esercizio della vita religiosa delle comunità islamiche nel nostro Paese. Esattamente il contrario di ciò che propone la Destra (Lega e Forza Italia): che difende i presepi e i crocifissi nelle scuole (così che i bambini musulmani che ci studiano mai potranno sentirsi pienamente cittadini italiani) e al tempo stesso si oppone vigorosamente alla costruzione di nuove moschee. Ma anche la Sinistra, e l'intera classe dirigente italiana, non sembrano consapevoli che questa è una delle partite cruciali per il futuro del Paese.
Il caso di Firenze è emblematico. Qui la comunità islamica ha presentato un progetto per una grande moschea nel settembre del 2010. L’arcivescovo (cui certo non spettava esprimere un giudizio) sostenne che sarebbe stato meglio non pensare ad un unico tempio, ma a tanti piccoli luoghi di preghiera, possibilmente senza minareto. E il sindaco Matteo Renzi mise subito le mani avanti, dichiarando: «al momento non c’è un progetto, non c’è un’ipotesi di lavoro». Per poi chiudere ogni prospettiva: «Non vedo spazi nel centro storico di Firenze per farla, in questo momento». Oggi, cinque anni dopo questo esorcismo, tutto è ancora fermo: e l'assenza della moschea è assai eloquente sulle vere intenzioni di chi parla di integrazione.
Ebbene, è da questa miopia che dobbiamo liberarci: quando ci sembrerà finalmente venuto il momento di costruire l'Italia del futuro? Soffocati dagli eterni tatticismi della politica e prigionieri in un discorso pubblico inchiodato alla cronaca di un presente mortificante, sembriamo non sapere che presto anche in Italia si porranno le questioni che oggi agitano la Francia.
La sera del massacro di Charlie Hebdo, davanti a una televisione inevitabilmente accesa, mio figlio (che fa la prima elementare in una scuola pubblica fiorentina) mi ha detto che lui non ha paura dei suoi (tanti) compagni di classe musulmani. Mi sono chiesto quanto ci metteremo a rovinare questa naturale armonia: quanto ci vorrà perché cambi idea?
Tutto si deciderà nelle nostre città, così strettamente legate alla storia delle libertà (appunto) civili italiane. Come dimostra ciò che è successo nelle banlieuses francesi, le politiche urbanistiche hanno un peso straordinario nel futuro sociale di un Paese. Per secoli le città italiane hanno creato cittadini: italiani non per stirpe, ma per cultura. Siamo una nazione non per via di sangue, ma – letteralmente – iure soli: per la forza di un territorio che ci ha fatto comunità. Lo riconosce l'articolo 9 della Costituzione, uno dei pochissimi che spenda appunto la parola 'nazione': associandola al patrimonio storico e artistico e al paesaggio. Cioè allo spazio pubblico: luogo terzo in cui non siamo divisi né per fede né per censo, ma siamo cittadini ed eguali.
Oggi questo patrimonio può tornare a giocare nella direzione del futuro. Quante chiese abbandonate potrebbero diventare moschee (invece che alberghi di lusso)? Quanti centri storici possono rinascere accogliendo anche un'altra cultura, invece che avviarsi ad un'imbalsamazione turistica? Una moschea nel centro di Firenze sarebbe un segno potente, capace di indicare la direzione del cammino che dobbiamo intraprendere. Un modo per dire che ora, sì, sappiamo come costruire un'integrazione vera. Che passa attraverso città che permettono l'incontro quotidiano, la mescolanza, la conoscenza. E non attraverso quartieri ghetto: periferie chiuse e separate, luoghi fatti apposta per fomentare il risentimento verso quella separazione e nutrire un'identità basata sull'alterità radicale.
È una partita che ci mette di fronte alle nostre antiche carenze: non siamo mai riusciti a formare veri cittadini, a costruire uno Stato impermeabile al pervasivo secolarismo della Chiesa, a dare un senso attuale e progressivo al patrimonio storico e artistico delle nostre città. Ebbene, è venuto il momento di farlo.
Corriere della Sera, con chi invoca la guerra contro l'Islam come risposta ai terroristi . Il manifesto, 13 gennaio 2015
E, come si poteva prevedere, la risposta c’è stata, anche se ha non solo complicato le cose, ma non è escluso che abbia aggravato il bilancio delle vittime; mentre non v’è dubbio che ha acuito la paura e l’odio, a dispetto dei cartelli innalzati nella prima manifestazione spontanea già della sera del 7 genaio scorso, della quale sono stato testimone diretto, a Place de la République, che proponevano matite piuttosto che mitra, amore invece di odio, tolleranza invece di discriminazione, accoglienza in luogo di rifiuto.
Ma queste erano le belle e se si vuole ingenue richieste dal basso: ancora una volta le classi dirigenti – politici e intellettuali – si sono rivelate al di sotto del sentimento delle popolazioni. E in Italia, mi pare, in modo più pesante che in Francia, che pure è la prima vittima degli eventi di questi giorni da cane.
Era ovvio che la destra si sarebbe scatenata, e in un paese dove il lepenismo è diventato la prima forza politica, era il minimo sentire l’appello della leader alla reistituzione della pena capitale, ma con un certo bon ton la signora si è limitata a proporre un referendum consultivo. Mentre il suo amico e sodale italiano, il Salvini, che ormai ha la leadership della destra nostrana, ha raggiunto nuovi vertici parlando del nemico in mezzo a noi, che abita sul nostro stesso pianerottolo ed è «pronto a sgozzarci». La premessa teologica è che non vi sono distinzioni né differenziazioni possibili: l’Islam «non è una religione come le altre». E ad essa si deve rispondere, dunque, con mezzi adeguati: la forza. Magari bruciando il Corano?
Non si pensi che l’estremismo becero di questo rozzo bestione (uso la nobile espressione di Giambattista Vico, non si offenda il Matteo «lumbard»), sia mero folclore leghistico. Si sfogli la stampa nazionale: lascio stare fogli come Il Giornale, Libero, e anche giornali locali come Il Tempo e la galassia del Quotidiano Nazionale, perché vi si trova ciò che ci si attende.
Mi soffermo invece niente meno sul Corriere della Sera, il «più autorevole» giornale italiano.
Da tempo questa imponente macchina volta alla costruzione del senso comune sta indirizzando la pubblica opinione verso l’idea di una inevitabilità ma anche di una necessità della guerra «contro il Terrore», con i suoi Panebianco e Galli della Loggia, ed altri minori, fino ad Antonio Polito, il cui editoriale del 10 gennaio a dir poco fa cascare le braccia.
Se la prende con il Parlamento che era a ranghi ridotti quando il ministro Alfano proferiva le solite vuote parole. E Polito accusa: «È lo stesso Parlamento che, rinunciando agli F35, sarebbe pronto a disfarsi dell’arma aeronavale nel Paese che è geograficamente una portaerei nel Mediterraneo» . Ma di che anno è questo giornale, si chiederebbe un lettore distratto? 1935? Ma l’editorialista continua, e il bersaglio diventa — come non aspettarselo? — «un’intellettualità diffusa», «colta», deve ammettere, ma «faziosa», nella quale «pullulano»… chi? «Antiamericani» e «filorussi». Di nuovo, l’effetto di spiazzamento: siamo negli anni Cinquanta?
Ma arriva al top, quando lamenta che non abbiamo da noi un Houellebecq, sincero nemico dell’Islam, e nessuno abbia perso il posto della Oriana Fallaci, che sulla medesima prima pagina del quotidiano milanese, viene evocata con la ri-pubblicazione di una intervista del 1970. Quali colpe, dunque, hanno gli intellettuali «faziosi» (ossia di sinistra), secondo Polito? Ecco: «sono molto più a loro agio con l’appeasement che con la guerra, se la cavano meglio con la retorica del dialogo che con quella dello scontro di civiltà. Sanno apprezzare un ‘ritiro’ e deprecare una battaglia».
Non c’è che dire: con il richiamo all’inevitabile Huntington, il quadro è completo. Siamo alla chiamata alle armi. Una vecchia storia per il giornale di Via Solferino. Nel 1911 con la Libia, nel 1915 con la Grande guerra, nel 1935 con l’Etiopia, nel 1936 con la Spagna, nel 1940 con il Secondo conflitto mondiale, è sempre il dannunziano maggio radioso. Una bella crociata, come ai vecchi tempi, insomma: la croce che diventa spada. Ma possibile che Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, e via enumerando, non insegnino nulla

Now, when we are all in a state of shock after the killing spree in the Charlie Hebdo offices, it is the right moment to gather the courage to think. We should, of course, unambiguously condemn the killings as an attack on the very substance our freedoms, and condemn them without any hidden caveats (in the style of "Charlie Hebdo was nonetheless provoking and humiliating the Muslims too much"). But such pathos of universal solidarity is not enough – we should think further.
Such thinking has nothing whatsoever to do with the cheap relativisation of the crime (the mantra of "who are we in the West, perpetrators of terrible massacres in the Third World, to condemn such acts"). It has even less to do with the pathological fear of many Western liberal Leftists to be guilty of Islamophobia. For these false Leftists, any critique of Islam is denounced as an expression of Western Islamophobia; Salman Rushdie was denounced for unnecessarily provoking Muslims and thus (partially, at least) responsible for the fatwa condemning him to death, etc. The result of such stance is what one can expect in such cases: the more the Western liberal Leftists probe into their guilt, the more they are accused by Muslim fundamentalists of being hypocrites who try to conceal their hatred of Islam. This constellation perfectly reproduces the paradox of the superego: the more you obey what the Other demands of you, the guiltier you are. It is as if the more you tolerate Islam, the stronger its pressure on you will be . . .
This is why I also find insufficient calls for moderation along the lines of Simon Jenkins's claim (in The Guardian on January 7) that our task is “not to overreact, not to over-publicise the aftermath. It is to treat each event as a passing accident of horror” – the attack on Charlie Hebdo was not a mere “passing accident of horror”. it followed a precise religious and political agenda and was as such clearly part of a much larger pattern. Of course we should not overreact, if by this is meant succumbing to blind Islamophobia – but we should ruthlessly analyse this pattern.
What is much more needed than the demonisation of the terrorists into heroic suicidal fanatics is a debunking of this demonic myth. Long ago Friedrich Nietzsche perceived how Western civilisation was moving in the direction of the Last Man, an apathetic creature with no great passion or commitment. Unable to dream, tired of life, he takes no risks, seeking only comfort and security, an expression of tolerance with one another: “A little poison now and then: that makes for pleasant dreams. And much poison at the end, for a pleasant death. They have their little pleasures for the day, and their little pleasures for the night, but they have a regard for health. ‘We have discovered happiness,’ - say the Last Men, and they blink.”
It effectively may appear that the split between the permissive First World and the fundamentalist reaction to it runs more and more along the lines of the opposition between leading a long satisfying life full of material and cultural wealth, and dedicating one's life to some transcendent Cause. Is this antagonism not the one between what Nietzsche called "passive" and "active" nihilism? We in the West are the Nietzschean Last Men, immersed in stupid daily pleasures, while the Muslim radicals are ready to risk everything, engaged in the struggle up to their self-destruction. William Butler Yeats’ “Second Coming” seems perfectly to render our present predicament: “The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity.” This is an excellent description of the current split between anemic liberals and impassioned fundamentalists. “The best” are no longer able fully to engage, while “the worst” engage in racist, religious, sexist fanaticism.
However, do the terrorist fundamentalists really fit this description? What they obviously lack is a feature that is easy to discern in all authentic fundamentalists, from Tibetan Buddhists to the Amish in the US: the absence of resentment and envy, the deep indifference towards the non-believers’ way of life. If today’s so-called fundamentalists really believe they have found their way to Truth, why should they feel threatened by non-believers, why should they envy them? When a Buddhist encounters a Western hedonist, he hardly condemns. He just benevolently notes that the hedonist’s search for happiness is self-defeating. In contrast to true fundamentalists, the terrorist pseudo-fundamentalists are deeply bothered, intrigued, fascinated, by the sinful life of the non-believers. One can feel that, in fighting the sinful other, they are fighting their own temptation.
It is here that Yeats’ diagnosis falls short of the present predicament: the passionate intensity of the terrorists bears witness to a lack of true conviction. How fragile the belief of a Muslim must be if he feels threatened by a stupid caricature in a weekly satirical newspaper? The fundamentalist Islamic terror is not grounded in the terrorists’ conviction of their superiority and in their desire to safeguard their cultural-religious identity from the onslaught of global consumerist civilization. The problem with fundamentalists is not that we consider them inferior to us, but, rather, that they themselves secretly consider themselves inferior. This is why our condescending politically correct assurances that we feel no superiority towards them only makes them more furious and feeds their resentment. The problem is not cultural difference (their effort to preserve their identity), but the opposite fact that the fundamentalists are already like us, that, secretly, they have already internalized our standards and measure themselves by them. Paradoxically, what the fundamentalists really lack is precisely a dose of that true ‘racist’ conviction of their own superiority.
The recent vicissitudes of Muslim fundamentalism confirm Walter Benjamin's old insight that “every rise of Fascism bears witness to a failed revolution”: the rise of Fascism is the Left’s failure, but simultaneously a proof that there was a revolutionary potential, dissatisfaction, which the Left was not able to mobilize. And does the same not hold for today’s so-called “Islamo-Fascism”? Is the rise of radical Islamism not exactly correlative to the disappearance of the secular Left in Muslim countries? When, back in the Spring of 2009, Taliban took over the Swat valley in Pakistan, New York Times reported that they engineered "a class revolt that exploits profound fissures between a small group of wealthy landlords and their landless tenants". If, however, by “taking advantage” of the farmers’ plight, The Taliban are “raising alarm about the risks to Pakistan, which remains largely feudal,” what prevents liberal democrats in Pakistan as well as the US to similarly “take advantage” of this plight and try to help the landless farmers? The sad implication of this fact is that the feudal forces in Pakistan are the “natural ally” of the liberal democracy…
So what about the core values of liberalism: freedom, equality, etc.? The paradox is that liberalism itself is not strong enough to save them against the fundamentalist onslaught. Fundamentalism is a reaction – a false, mystifying, reaction, of course - against a real flaw of liberalism, and this is why it is again and again generated by liberalism. Left to itself, liberalism will slowly undermine itself – the only thing that can save its core values is a renewed Left. In order for this key legacy to survive, liberalism needs the brotherly help of the radical Left. THIS is the only way to defeat fundamentalism, to sweep the ground under its feet.
To think in response to the Paris killings means to drop the smug self-satisfaction of a permissive liberal and to accept that the conflict between liberal permissiveness and fundamentalism is ultimately a false conflict – a vicious cycle of two poles generating and presupposing each other. What Max Horkheimer had said about Fascism and capitalism already back in 1930s - those who do not want to talk critically about capitalism should also keep quiet about Fascism - should also be applied to today’s fundamentalism: those who do not want to talk critically about liberal democracy should also keep quiet about religious fundamentalism.
Altri mi scrivono da vari luoghi: Turchia, Argentina, Stati Uniti…Tutti esprimono compassione e solidarietà, ma anche inquietudine: per la nostra sicurezza, democrazia, civiltà, direi quasi per la nostra anima. È a loro che voglio rispondere, cogliendo l’occasione dell’invito di Libération.
È giusto che gli intellettuali si esprimano, senza privilegi, soprattutto senza pretendere una particolare lucidità, ma senza reticenze e senza calcoli. È un dovere funzionale, affinché la parola circoli nell’ora del pericolo. Oggi, nell’urgenza, non voglio enunciare che tre o quattro parole.
Comunità
Sì, noi abbiamo bisogno di comunità: per il lutto, per la solidarietà, per la protezione, per la riflessione. Questa comunità non è esclusiva, in particolare non lo è rispetto a coloro fra i cittadini francesi o immigrati che una propaganda sempre più virulenta, che ricorda i più sinistri episodi della nostra storia, assimila all’invasione e al terrorismo per farne i capri espiatori delle nostre paure del nostro impoverimento o dei nostri fantasmi.
Ma non lo è neppure rispetto a coloro che credono alle tesi del Fronte nazionale o che si lasciano sedurre dalla prosa di Houellebecq. Essa deve dunque spiegarsi con se stessa. Non si arresta alle frontiere, dal momento che è chiaro che la condivisione dei sentimenti, delle responsabilità e delle iniziative evocate dalla “guerra civile mondiale” in corso deve farsi in comune, su scala internazionale, e, se possibile (Edgar Morin ha perfettamente ragione su questo punto), in un quadro cosmopolitico.
Per questo motivo la comunità non si confonde con l’unione nazionale. Questo concetto non è in pratica servito ad altro che a scopi inconfessabili: imporre silenzio alle domande scabrose e far credere all’inevitabilità delle misure d’eccezione. La stessa Resistenza (per buone ragioni) non ha invocato questo termine. E abbiamo già visto come, proclamando il lutto nazionale in base alle sue prerogative, il Presidente della Repubblica ne abbia approfittato per giustificare di soppiatto i nostri interventi militari, che probabilmente hanno contribuito a far scivolare il mondo sulla china attuale. Dopo di che vengono tutte le discussioni-trappola sui partiti che sono “nazionali” o meno, anche se ne portano il nome. Si vuol far concorrenza alla signora Le Pen?
Imprudenza
I vignettisti di Charlie Hebdo sono stati imprudenti? Sì, ma la parola ha due sensi, più o meno agevolmente districabili (e qui c’entrano certo valutazioni soggettive). Sprezzo del pericolo, gusto del rischio, eroismo se vogliamo. Ma anche indifferenza per le conseguenze eventualmente disastrose di una provocazione: magari il sentimento di umiliazione di milioni di uomini già stigmatizzati, abbandonati alle manipolazioni di fanatici organizzati.
Credo che Charb e i suoi colleghi siano stati imprudenti nei due sensi del termine. Oggi che questa imprudenza è costata loro la vita, rivelando allo stesso tempo il pericolo mortale che corre la libertà di espressione, non voglio pensare che al primo aspetto. Ma domani e dopodomani (questa storia non si esaurirà in un giorno) preferirei che si riflettesse sul modo più intelligente di gestire il secondo e la sua contraddizione con il primo. E non si tratterà necessariamente di viltà.
Jihad
Di proposito pronuncio solo alla fine la parola che fa paura, perché è tempo di esaminarne tutte le implicazioni. Ho appena uno spunto di idea in materia, ma ci tengo: la nostra sorte sta nelle mani dei Musulmani, per imprecisa che sia tale denominazione.
Perché? Perché è giusto, certo, mettere in guardia contro gli amalgami e contrastare l’islamofobia che pretende di ritrovare l’appello all’omicidio nel Corano o nella tradizione orale. Ma questo non basterà. Allo sfruttamento dell’Islam operato dalle reti jihadiste –di cui, non dimentichiamolo, i Musulmani ovunque nel mondo e anche in Europa sono le vittime principali– non può rispondere se non una critica teologica e, da ultimo, una riforma del “senso comune” della religione, che faccia dello jihadismo una controverità agli occhi dei credenti. Altrimenti saremo tutti presi nella morsa letale del terrorismo, capace di attirare a sé tutti gli umiliati e offesi della nostra società in crisi, e delle politiche sicuritarie, liberticide messe in opera da Stati sempre più militarizzati.
C’è dunque una responsabilità dei Musulmani, o piuttosto un compito che tocca loro. Ma è anche il nostro, non solo perché il ‘noi’ di cui parlo, qui e ora, include per definizione molti Musulmani, ma perché le possibilità, già esili, di tale critica e di tale riforma diverrebbero francamente nulle se noi ci contentassimo ancora a lungo di discorsi di isolamento di cui essi, con la loro religione e la loro cultura, sono generalmente il bersaglio.
La Repubblica, 13 gennaio 2015
C’è chi ha contato i turchi di Imperia e chi ha fotografato i cinesi di La Spezia, chi ha ascoltato i marocchini ad Albenga e chi ha avvistato gli alfaniani a Genova, e vai a sapere quanto hanno pesato queste incursioni sospette sulla vittoria della renziana Raffaella Paita.
È vero: non si raccolgono 29mila voti — quattromila in più di Sergio Cofferati, uno che non ha mai avuto bisogno di stampare volantini per farsi riconoscere dai suoi elettori — portando ai seggi i cinesi con il pulmino. E infatti persino ad Albenga, dove i marocchini reclamavano la ricompensa, non basterebbe annullare il voto di tutti i 147 extracomunitari che hanno votato lì per riequilibrare un risultato davvero senza storia: 1320 voti per la Paita, 246 per Cofferati. Eppure c’è qualcosa che non va, in quelle comitive di cinesi che si so- no presentati al seggio di La Spezia o in quella processione di settanta turchi che andavano a votare a Porto Maurizio.
Così come c’è qualcosa che non va in quel sindaco ex An di Albisola Superiore che ha radunato gli amministratori della Riviera per sostenere la Paita, o in quel capogruppo dell’Ncd che candidamente annuncia che manderà i suoi elettori a votare per la candidata renziana, dando nomi e volti ai sospetti di un inquinamento politico di una consultazione promossa, organizzata e riconosciuta dal Partito democratico.
Cosa c’è che non va? C’è che le primarie, quella festa della democrazia e della partecipazione che abbiamo importato — insieme a tante altre cose — dalla politica americana, rischiano di essere macchiate, snaturate e delegittimate dalle incursioni e dalle scorribande di chi non c’entra nulla né col Pd né con le elezioni italiane, e si presenta al seggio solo per dare un voto venduto davanti alla porta oppure per scegliersi l’avversario preferito. Non è, quella di Genova, una storia nuova. Le primarie per il sindaco di Napoli, quattro anni fa, furono annullate per i troppi sospetti, e poi si scoprì il tariffario del clan Lo Russo: dalla borsa di pane-latte-carne per un voto singolo ai cinquanta euro per un voto doppio, il primo alle primarie e il secondo alle amministrative. E anche adesso, in Campania, organizzare le primarie è diventato un incubo, visto che dopo aver rinviato la data per due volte stanno cercando di “superarle” con un candidato scelto a Roma.
L’invocazione delle primarie si è tramutata nella paura delle primarie. Ma sarebbe un errore imperdonabile tornare indietro. Senza le primarie, uomini estranei alla nomenklatura di partito non sarebbero diventati sindaci di Milano, di Genova, di Roma o di Cagliari. Senza le primarie, i partiti — non tutti: quelli che le hanno adottate, perché per gli altri non è cambiato nulla — continuerebbero a scegliere i candidati senza tener conto della volontà dei loro militanti, dei loro iscritti, dei loro elettori.
Ma le primarie, per funzionare, hanno bisogno di regole efficaci. La prima regola è che le primarie funzionano quando più persone si battono per una sola candidatura, perché così lo scontro diretto per la maggioranza assoluta fa emergere pregi e difetti di ciascuno. Sono invece un disastro se vengono organizzate per compilare una lista, quando basta un consenso parziale, perché allora si torna alla guerra delle preferenze (e ci sarà un motivo se il candidato più votato d’Italia alle primarie del Pd per il Parlamento, il messinese Francantonio Genovese, è stato anche il primo a finire in galera).
La Federal Reserve e la crisi finanziaria", il libro di Ben S. Bernanke, che ne è stato governatore in America negli anni caldi. Le iniezioni di liquidità non sono tutto e non abbattono l'instabilità del mercato». Il manifesto, 13 gennaio 2015