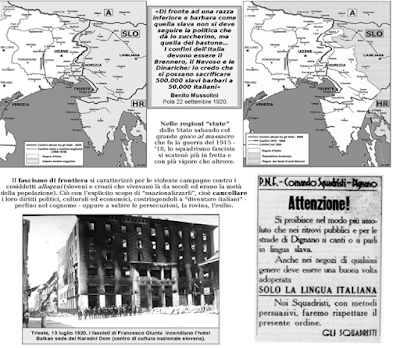il manifesto,
Ha ragione Piero Bevilacqua a sottolineare la «distrazione» nell’attuale campagna elettorale rispetto a un tema strategico come quello dell’istruzione. Esiste però un testo che affronta la decostituzionalizzazione intenzionale cui la scuola è soggetta da 20 anni.
Si tratta della Lip (legge di iniziativa popolare) Per la scuola della Costituzione. L’8 settembre è stata depositata in Cassazione e da qualche giorno è iniziata la raccolta delle firme per proporne la discussione parlamentare. 37 articoli, che abrogano gran parte della normativa degli ultimi 15 anni, dalla riforma Moratti, alla Gelmini, alla «Buona Scuola», tentando di riportare la scuola al modello dettato dagli artt. 3, 9, 33 e 34 della Carta.
Non solo abrogare, dunque, ma anche ri-costruire e ri-portare la scuola all’altissimo rango di organo costituzionale, quale fu pensata – non a caso – nell’Italia che risorgeva sui principi dell’antifascismo. La Lip non si propone di intervenire su tutti gli aspetti della normativa scolastica, ma di disegnare un’idea di scuola. Vi si parla di gratuità e di inclusione, perché la scuola è lo strumento che la Repubblica ha in mano per «rimuovere gli ostacoli»; di laicità (sono vietate le cerimonie di culto negli edifici scolastici; l’IRC è in orario extracurricolare; viene abolito l’inserimento delle scuole paritarie private dal sistema nazionale di istruzione); si prevede un rapporto alunni-docente che scongiuri per sempre le classi pollaio; l’unico insegnamento obbligatorio esplicitamente previsto (la legge non si occupa di programmi e discipline) è quello di Costituzione e cittadinanza; diritto allo studio e all’apprendimento; sapere disinteressato ed emancipante; si rende obbligatorio il terzo anno di scuola dell’infanzia, in previsione della generalizzazione; si abrogano i test Invalsi e il voto numerico alla primaria e alle medie; si ripristinano tempo pieno e prolungato; si riconducono alla loro centralità gli organi collegiali, riaffidandogli prerogative che sono espressione della democrazia scolastica; il biennio è unitario, posticipando così la scelta della scuola superiore – troppo spesso compiuta su base socio-economica – di due anni e garantendo i saperi imprescindibili per tutti più a lungo; l’obbligo al termine della scuola superiore, in modo che la scuola riprenda ad essere ascensore sociale e garanzia di pari opportunità per tutti, nessuno escluso; un presidente del collegio sovrano, eletto dai docenti, affiancherà il dirigente scolastico, con funzioni amministrative; l’autonomia scolastica viene riportata nel suo alveo costituzionale, quello del principio della libertà dell’insegnamento, strumento dell’interesse generale.
L’alternanza scuola lavoro diventa un «percorso di cultura del lavoro», obbligatoria per tutti gli indirizzi di scuola superiore, organizzati dalle scuole, che «possono prevedere, sia l’intervento in aula di esperti/e, oltre a quello degli insegnanti curriculari, sia l’inserimento del/la singolo/a allievo/a in realtà di lavoro e di ricerca nel rispetto degli artt. 2, 35 e 36 della Costituzione». Si effettuano al fine di «garantire agli studenti e alle studentesse attività coerenti con il loro percorso di istruzione, utili per acquisire gli strumenti critici necessari a comprendere non solo gli aspetti operativi della realtà lavorativa analizzata, ma anche il quadro dei diritti e delle responsabilità e il rapporto fra i processi produttivi ed economici e le implicazioni sociali e ambientali».
Grande attenzione, nel testo, al linguaggio di genere e alla purificazione da anglicismi e tecnicismi di matrice anglofona ed economicista. Si prevede di spendere il 6% del Pil nazionale, come da media dei paesi europei: anche per questo la raccolta si affianca a quelle – promosse dal Coordinamento Democrazia Costituzionale – per ripristinare il testo originario dell’art. 81 della Costituzione, eliminando l’equilibrio di bilancio; e per una legge elettorale proporzionale – per sanare tre ferite che gli ultimi parlamenti hanno inflitto alla democrazia nel Paese.
Ribaltare il paradigma corrente, privatistico e classista, disinfestare lo spazio culturale dal dominio del mercato, ricostruire l’equilibrio di diritti e poteri, restituire il sistema scolastico alla funzione di promozione del pensiero critico e della cittadinanza consapevole: questo e tanto altro nel testo che troverete in www.lipscuola.it.
Qui il testo originale dell'articolo

il manifesto,
«Sono venuto a Napoli a imparare, qui fate la lotta per la rivoluzione in Europa»: Jean-Luc Mélenchon, leader di France Insoumise, esordisce così dal palco del teatro popolare dell’Ex Opg Je so’ pazzo. Mélenchon a gennaio ha ospitato a Parigi Potere al Popolo, ieri è arrivato con una delegazione di medici di Marsiglia per far coincidere il racconto con la prassi, per verificare cioè come a Napoli si coniuga politica e impegno sociale. Un’esperienza che La France Insoumise vorrebbe replicare proprio a Marsiglia.
La prima tappa è stata dal sindaco Luigi de Magistris per discutere di acqua pubblica, beni comuni e di debito odioso. Il comune è gravato da circa 90 milioni lasciati dal commissariato per il terremoto del 1980 e circa 27 dal commissariato per l’emergenza rifiuti, il governo aveva promesso di intervenire ma il dossier è rimasto sul tavolo così il sindaco manifesterà a Roma il 21 febbraio.
Il pomeriggio è però dedicato all’Opg. Ieri era di turno lo sportello legale e Mélenchon si è fermato ad ascoltare le storie dei migranti e la loro condizione in Italia, è stata poi la volta dei ragazzi al doposcuola, infine spazio ai medici: in due anni l’ambulatorio ha assicurato più di 1.500 visite gratuite in una città dove la Sanità sta scivolando fuori dall’universalismo e le prestazioni pubbliche sono gravate dai ticket più alti d’Italia. In platea ad ascoltare il leader di France Insoumise, Sabina Guzzanti e Alberto Lucarelli, il docente di diritto ex assessore comunale che curò la trasformazione della Spa che si occupava della distribuzione dell’acqua in azienda speciale. «Abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno dell’Italia per cambiare l’Europa verso una società più uguale – attacca Mélenchon -. Le forme tradizionali della socialdemocrazia, del comunismo e del neoliberismo non sanno più dare risposte. Negli ultimi 20 anni abbiamo subito la distruzione di ogni struttura solidaristica. I governi hanno messo lavoratori contro lavoratori, autoctoni contro migranti, hanno alimentato la violenza tra i popoli lasciando spazio alla destra, che si è inserita nei conflitti. Dobbiamo mandare a casa i governi europei che difendono il capitale contro il popolo».
La France Insoumise alle presidenziali francesi ha sfiorato il 20%, contro il 6% del partito socialista. Mélenchon invita la sinistra ad aver coraggio: «In Spagna ci hanno messo circa sette mesi per fare un governo, sei mesi in Germania per fare le larghe intese quando la Spd aveva giurato che non le avrebbe più fatte. Anche in Italia si rischia di andare in quella direzione. Basta scegliere ’il male minore’. La nostra storia è racchiusa in ’potere al popolo’, riempiamo questa frase di significato. L’Europa ci vuole imporre i pesticidi, il governo francese vuole sviluppare il nucleare, sono politiche contro l’ecosistema. L’Europa si fa guidare dagli Stati uniti e decide che il nemico è la Russia, allineandosi alle politiche Nato che preparano le prossime guerre. Diciamo no alla Nato, difendiamo la pace».
Viola Carofalo, capo politico di Pap, riassume il terreno comune con France Insoumise: «Equità sociale, diritto a un lavoro degno, accesso ai servizi per tutti: la nostra lotta nasce sui territori, vogliamo portarla a un livello nazionale ma molti attacchi arrivano da Bruxelles, è necessario un piano di lotta comune in Europa». A Mélenchon le conclusioni: «In Francia esiste il mito della coppia franco tedesca, ma la Germania sta portando avanti una politica per una popolazione vecchia, ricca e capitalista. La ricetta è aumentare la rendita e abbassare i salari. Il modello tedesco non è stato capace di abolire la povertà: è fatto per quelli che hanno ricchezze». E sui migranti: «Stiamo producendo immigrati perché produciamo guerre. C’è anche un’emigrazione europea più silenziosa che parte dalla Grecia, dalla Spagna per ragioni molto simili, la ricerca di una vita migliore. Con Potere al Popolo, Podemos, Unità popolare in Grecia e Die Linke potremo cambiare l’Europa».

il Sole 24 ore, 16 febbraio 2018. Il continente le cui popolazioni sono le più povere del mondo continua a essere saccheggiato dalle nazioni che il capitalismo (privato o di Stato) ha reso più feroci e aggressive, con postilla
Nel mondo ricco i governi impongono limiti alle emissioni delle auto. I costruttori puntano sull’elettrico. Nel mondo povero è una nuova corsa dell’oro, legata alla conquista dei minerali per alimentare le batterie delle auto del futuro.
Con le società minerarie che fanno a gara per aggiudicarsi licenze di esplorazione e terreni da sfruttare. L’Africa, il continente più povero - per una sorta di condanna del destino ineluttabile come una malattia - è quello più ricco di materie prime. Dal Niger alla Costa d’Avorio, dalla Repubblica Democratica del Congo alla Tanzania, il Malawi, il Mozambico fino alla Namibia, la domanda di metalli per lo sviluppo delle “tecnologie pulite” sta aprendo nuove frontiere all’industria mineraria. A caccia di cobalto, grafite, litio, neodimio, niobio, praseodimio, terre rare.
Alla conquista dell’Africa
Tutti gli operatori, i grandi come Bhp Billiton e Rio Tinto, ma anche i piccoli, sono in fermento. Gli ultimi in ordine di tempo. Noble Group, quotata a Singapore, nel novembre scorso ha annunciato investimenti per 17 milioni di dollari in Malawi per l’estrazione di metalli da terre rare. In Tanzania dietro al progetto Panda Hill per avviare una miniera di niobio, metallo superconduttore, c’è il fondo americano Denham Capital. Nel Nord del Mozambico è appena partita la produzione nella più grande miniera di grafite, minerale utilizzato nelle batterie delle auto elettriche di nuova generazione, come la Model 3 di Tesla. Miniera controllata dalla società australiana Syrah Resources.
Il colosso delle materie prime Glencore è tra i principali produttori di cobalto nella Repubblica Democratica del Congo. Il cobalto è un minerale essenziale nelle nuove batterie ricaricabili agli ioni di litio che alimentano le auto elettriche, ma anche gli smartphone, i tablet e i computer. China Molybdenum, società mineraria parastatale lo scorso anno ha comprato la miniera di Tenke sempre in Congo per 2,6 miliardi di dollari. Una miniera che contiene una delle più grandi concentrazioni di cobalto al mondo e offre per i decenni a venire la sicurezza della fornitura. I prezzi del cobalto sono triplicati negli ultimi due anni.
Le società minerarie cercano di conquistare nuovi siti estrattivi per il litio, principale componente per le batterie, nei giacimenti in Congo, Namibia, Niger, Costa d’Avorio. Il gruppo minerario Desert Lion Energy ha acquisito i diritti di esplorazione nella Namibia occidentale. Le azioni della società mineraria Avz hanno avuto un balzo clamoroso alla Borsa di Sydney del 1.500% dopo l’annuncio di investimenti in una delle miniere di litio più grandi al mondo nel Congo. Anche qui, i prezzi sono quasi raddoppiati negli ultimi due anni. Ma in generale tutti i prezzi delle materie prime legate alle auto elettriche sono alle stelle. Le società minerarie aumentano i loro ricavi e la capitalizzazione di Borsa.
L’altra faccia della medaglia
Vista dall’altro lato la storia prende un altro sapore: centinaia di migliaia di persone in Africa lavorano nelle nuove miniere, compresi i bambini, in condizioni di lavoro durissime e spesso pericolose se paragonate agli standard occidentali. A centinaia di metri di profondità, con dispositivi di sicurezza minimi. Spesso solo con le mani, le mazze e i picconi, senza ausili tecnologici. Morti e gravi incidenti sul lavoro sono la norma. Come ha raccontato recentemente Todd Frankel del Washington Post in un reportage da una miniera in Congo dove si estrae cobalto.
Il Congo è uno Stato enorme. Un Paese instabile, abituato a entrare e uscire dalle guerre civili, con una mappa mineraria infinita e una lunga storia di sfruttamento delle risorse naturali cominciata nell’era coloniale. «L’Africa è una magnifica torta da spartire»: la celebre, quanto infelice frase del Re Leopoldo II del Belgio al Congresso di Berlino del 1876 tra le potenze coloniali, ha fatto storia.
Da allora non molto è cambiato. Il colonialismo ora è di tipo economico, con il Paese che annega nella corruzione. L’attività mineraria, soprattutto quella fatta dalle piccole aziende meno controllate di quelle internazionali, o dai subfornitori di qualche grande società, sottopone le comunità locali a livelli di esposizione ai metalli tossici mai visti prima, che inquinano i terreni e le falde acquifere. In Africa aumentano le neoplasie, malattie quasi sconosciute fino a qualche anno fa, ora anche tra i bambini. Aumentano anche le malformazioni tra i neonati.
L’aria pulita dell’Occidente ha un prezzo molto salato per l’Africa. Almeno fino a quando le grandi società non renderanno chiara e tracciabile la provenienza delle materie prime che alimentano le proprie batterie. Impresa impossibile probabilmente, considerando la grande “fame” di minerali da parte dell’industria dell’auto e la scarsità delle risorse naturali. La miniera dell’inchiesta del «Post» è di una società cinese: Zhejiang Huayou Cobalt, uno dei principali produttori mondiali di cobalto - che controlla anche DongFang International Mining accusata da Amnesty International di comprare minerali estratti dai bambini - e fornisce i metalli ai principali produttori di batterie contenute nelle auto ma anche nei prodotti hi-tech, come l’iPhone.
Apple dopo l’inchiesta del WP ha fatto sapere di aver aumentato i controlli sulla provenienza del cobalto. Lg, uno dei principali produttori di batterie, ha bloccato l’import di cobalto dal Congo. Samsung Sdi, la divisione del colosso coreano che produce batterie, ha effettuato delle investigazioni interne all’aziende e ha fatto sapere che per le sue batterie non utilizza minerali provenienti dal Congo.
La nuova corsa all’oro
In questa nuova corsa dell’oro il principale destinatario dei minerali africani è la Cina. Le auto elettriche sono una delle aree principali di sviluppo del piano Made in China 2025. La Cina è divenuta in pochi anni il primo mercato mondiale dell’automotive superando anche gli Stati Uniti nel 2015. E ha anche il primato delle vendite di auto elettriche e ibride che nel 2017 hanno superato per la prima volta il milione di unità, favorito dai ricchi incentivi governativi per l’acquisto di veicoli puliti. Gli obiettivi del governo sono ambiziosi. Uno di essi è il raggiungimento dei cinque milioni di veicoli elettrici sulle strade entro il 2020. L’industria delle batterie per veicoli elettrici è giudicata strategica dal governo che punta a conquistare la supremazia mondiale. «Le batterie al litio sono state inventate dai giapponesi e perfezionate dai coreani. Ora però saranno i cinesi a prendersi il mercato grazie agli aiuti all’industria da parte del governo», dice Mark Newman, analista di Bernstein.
Finora il mercato è stato dominato dalla giapponese Panasonic e dalla coreana Lg. Panasonic è ancora il primo al mondo nelle batterie per auto elettriche, sta costruendo il mega stabilimento di Tesla in Nevada, la Gigafactory. Ma i cinesi avanzano. Contemporary Amperex Technology ltd (Catl) società creata nel 2011 dall’ingegnere Zeng Yuqun, 50 anni, che ha sede a Ningde, metropoli da 3 milioni di abitanti nel Sud-Est del Paese, zona famosa per la produzione del thè verde, è già il primo fornitore di batterie nel più grande mercato per le auto Ev, la Cina. Ma sta pensando a una Ipo per crescere e assicurarsi forniture da marchi europei e americani.
La cavalcata della Cina
Catl è valutata 20 miliardi di dollari. Punta a quotare il 10% del capitale per raccogliere due miliardi di dollari. Fondi che serviranno a finanziare la realizzazione di un mega stabilimento produttivo per le batterie a Ningde. Il nuovo stabilimento quintuplicherà la produzione di Catl facendola salire al primo posto nella classifica mondiale tra i produttori di batterie elettriche, prima di Tesla, dell’altra cinese Byd (Build your dreams) partecipata al 10% da Warren Buffett, specializzata nella produzione di batterie per bus e scuolabus. E prima ancora delle coreane Lg Chem e Samsung Sdi. Oltre ai sussidi governativi all’industria e alle barriere d’ingresso per le aziende straniere, il grande vantaggio dei produttori di batterie cinesi rispetto ai concorrenti è l’accesso alle materie prime. Grazie al fatto che le società minerarie cinesi in Africa in questi anni hanno fatto razzia di miniere di cobalto e litio e degli altri metalli per assicurarsi le forniture. «La Cina – conclude Anthony Mimlewski del fondo svizzero Pala Investments - vuole diventare la Detroit delle auto elettriche. Non ho dubbi sul fatto che nei prossimi anni guiderà il mondo per capacità produttiva e, probabilmente, anche nella tecnologia».
postilla
Nel suo interessante articolo (un vero - ma implicito - atto d'accusa verso il capitalismo saccheggiatore e mortifero) l'autore pronuncia una squalificante menzogna. Egli afferma che l’Africa è «il il continente più povero - per una sorta di condanna del destino ineluttabile come una malattia». Nessun "destino ineluttabile, signor Barlaam, ma il pluricentenario saccheggio delle risorse naturali (e umane) operato dal colonialismo imperialistico, nelle sue forme vecchie e in quelle recenti. È il capitalismo baby.

Avvenireprogetto del tipo "aiutiamoli a casa loro",che nasconde sotto la maschera dell'aiuto benefico il ghigno consueto dello sfruttamento
La Francia denuncia la pseudo cooperazione e se ne va. Il gran rifiuto, come lo avrebbe definito Dante, è avvenuto l’8 febbraio con un’insolita e persino sorprendente scelta a fianco dei piccoli contadini africani che le multinazionali dell’agrobusiness forse non perdoneranno mai a Emmanuel Macron. Il programma da cui Parigi ha deciso di ritirarsi si chiama"Nuova Alleanza per la sicurezza alimentare e nutrizionale" (in sigla Nasan), un’iniziativa decisa nel corso del G8 che si tenne nel 2012 a Camp David.
Al pari del titolo, dal forte richiamo biblico, anche le finalità hanno un vago sapore messianico: in 10 anni liberare dalla povertà e dalla fame 50 milioni di africani attraverso una collaborazione fra Governi africani, Governi dei Paesi ricchi e imprese private. Ma a una verifica di metà periodo, si scopre che il progetto è servito a creare dei paradisi fiscali agricoli, come li ha definiti l’organizzazione francese Action contre la Faim : occasioni di guadagno per le grandi imprese dell’agroindustria, non di liberazione dei piccoli contadini le cui condizioni sono addirittura peggiorate. In effetti il progetto nasce dalla vecchia convinzione che per risolvere fame e povertà basta aumentare la produzione. Per cui l’unica cosa da fare è facilitare gli investimenti da parte di chi i soldi ce li ha, ossia le grandi imprese nazionali e transnazionali.
Da qui la Nuova Alleanza che ai Governi locali africani chiede di mettere a disposizione terre e un contesto legislativo favorevole alle imprese, ai Governi del Nord di mettere qualche soldo per la costruzione di qualche infrastruttura a titolo di cooperazione, alle imprese private di metterci gli investimenti e guadagnarci. Le imprese che hanno aderito al progetto sono un centinaio, per investimenti complessivi dichiarati attorno ai 5 miliardi di dollari, in sei Paesi: Ghana, Etiopia, Tanzania, Costa d’Avorio, Burkina Faso e Mozambico.
Il progetto non prevede la trasparenza fra i propri princìpi, ma dalle informazioni trapelate si apprende che due multinazionali coprono da sole due quinti dell’importo: Syngenta, azienda di sementi, filiale svizzera della cinese ChemChina, con 500 milioni di investimenti e Yara, multinazionale di fertilizzanti che batte bandiera norvegese, con 1,5 miliardi di investimenti. Neanche Cargill, multinazionale agro-commerciale americana, se la cava affatto male con 525 milioni di investimenti, per poi trovare più giù in graduatoria altre famose multinazionali come Mars, Monsanto, Louis Dreyfus.
Dal che si capisce che il risultato finale della Nuova Alleanza sarà un rafforzamento dei prodotti agricoli destinati all’esportazione (cacao, caffè, olio di palma) e un ulteriore spinta ai contadini africani affinché si gettino definitivamente fra le braccia dell’agricoltura industriale basata sulle sementi selezionate, fertilizzanti e pesticidi. Insomma tutto il contrario dell’idea di sovranità alimentare che ha come obiettivo la produzione per i bisogni locali e come strategia produttiva l’autoproduzione delle sementi e l’agricoltura biologica, due modi per rispettare la natura ed impedire che i contadini finiscano nella trappola dei debiti.
Già nel 2016 il Parlamento di Strasburgo aveva chiesto alla Ue di togliere il proprio sostegno al Nasan. In particolare richiamava «il pericolo di replicare in Africa lo stesso modello di "rivoluzione verde" attuata in Asia negli anni 60, senza tenere conto dei suoi impatti sociali e ambientali». Il governo francese, che partecipava alla Nuova Alleanza come partner del Burkina Faso, non ha dato una motivazione ufficiale del suo ritiro dal Nasan, ma un funzionario governativo ha dichiarato a Le Monde che «l’approccio del progetto è troppo ideologico ed esiste un vero rischio di accaparramento di terre a detrimento dei piccoli contadini».
I quali confermano: «A noi che produciamo per il mercato locale, la Nuova Alleanza non elargisce nessun vantaggio fiscale, mentre alle imprese che producono per l’esportazione garantisce terre e ogni altro genere di facilitazione. Dov’è l’interesse per la sicurezza alimentare del nostro Paese? I piccoli contadini hanno mostrato di saper produrre, pur ricorrendo ai metodi tradizionali; assicurano il 40% del consumo interno di riso. Ciò nonostante il Nasan si prefigge di modernizzare 30mila ettari di terreni e di assegnarne 5mila ai villaggi. Il che significa far passare da un’agricoltura di tipo pluviale a un’agricoltura basata sull’irrigazione artificiale.
Ma la pioggia la dà la natura gratuitamente, l’acqua del sottosuolo, invece, sarà disponibile solo per chi ha soldi perché richiede macchinari ed energia. In conclusione i contadini più deboli si impoveriranno ulteriormente e la nostra sicurezza alimentare sarà sempre più a rischio». Preoccupazioni fatte proprie dal Governo francese considerato che l’uscita dal Nasan è stata giustificata dal fatto che «la Francia preferisce dare il proprio sostegno all’agricoltura familiare attraverso un’intensificazione dell’agro-ecologia». Parole su cui meditare, specie oggi che si parla tanto di"aiutarli a casa loro".

la Repubblica, blog Articolo 9, 14 febbraio 2018. Se la politica fosse quella che il ministro renziano Dario Franceschini ritiene che sia - e di fatto pratica - bisognerebbe vergognarsi di farla. Ma cè un'altra Politica, bella e utile a tutti
Per la seconda volta in poco tempo (la prima qualche giorno fa a Otto e mezzo, la seconda oggi a L’Aria che tira), il ministro uscente per i Beni Culturali Dario Franceschini risponde alle mie obiezioni in materia di governo del patrimonio culturale dicendo che non parlo da storico dell’arte, ma da politico. Ebbene, vorrei rispondergli una volta per tutte: e vorrei farlo perché quella sua affermazione (che è, di fatto, una piccola furbizia mediatica) è capace di rivelare molto circa la concezione della politica che è propria non solo di Franceschini, ma di una larga parte del nostro ceto politico.
C’è innanzitutto un ammiccamento all’antipolitica, un inchino al populismo. Franceschini dice ai cittadini: "badate che Montanari non parla come tecnico autorevole, o come cittadino indignato, ma come politico. E dunque non dice la verità, ma fa propaganda". L’opposizione popolo-politica è il cardine stesso di ogni populismo. Così come la presunzione che il politico sia mendace per natura, e, più in generale, il disprezzo per la politica.
A me non verrebbe mai in mente di dire: "guardate che Franceschini è un politico". Perché ho un’enorme considerazione per la vera politica, e semmai penso proprio il contrario: e cioè che il nostro ministro abbia un’idea assai modesta della politica. Troppo modesta.
Se Franceschini invece ricorre a questo "argomento" è proprio – questo è il paradosso –a causa della sua consumata abilità di professionista della politica come la intende lui. Di politico abilissimo a galleggiare in ogni stagione: un vero e proprio"autoreggente"della politica, come lo definisce Alessandro Gilioli in questo immortale ritratto pubblicato sull’Espresso. Una carriera inaffondabile: Franceschini è in politica dal 1980, quando era già consigliere comunale. Grazie a questa carriera Franceschini ha imparato ad annusare l’aria: e ora sa bene che lui (purissimo politicante da una vita) deve cavalcare l’antipolitica e mescolare le carte. Fino ad arrivare a suggerire che la politica è una cosa sporca, intessuta di menzogne: e che dunque chi parla da ‘politico’ non merita una risposta nel merito.
Ma perché Franceschini mi definisce politico?
Forse perché, con molti altri colleghi storici dell’arte, archeologi, archivisti, bibliotecari abbiamo organizzato un cartello di associazioni che si chiama Emergenza Cultura, e che cerca di difendere le ragioni dell’articolo della Costituzione che dà il nome a questo blog.
O forse ancora perché sono il presidente di Libertà e Giustizia, una associazione di cultura politica, che non dà indicazioni di voto e che è guidata da un consiglio di presidenza composto da persone che nessuno definirebbe "politici" (Sandra Bonsanti, Salvatore Settis, Gustavo Zagrebelsky, Lorenza Carlassare, Nadia Urbinati, Roberta de Monticelli, Paul Ginsborg, Valentin Pazè, Elisabetta Rubini).
O infine perché ho cercato (senza peraltro riuscirci) di costruire una sinistra nuova e radicale, nel cosiddetto percorso del Brancaccio. Un percorso in cui ho annunciato fin dall’inizio che non mi sarei candidato ad alcunché e che concepivo quell’impegno come una forma di cittadinanza attiva. Quello stesso modo di fare politica senza essere un politico per cui oggi ho presentato la proposta di reddito minimo di dignità della Rete dei Numeri Pari di Libera: e non so se Franceschini chiamerebbe "politico" anche don Ciotti, che sedeva al mio stesso tavolo.
Insomma, se un cittadino prova a dedicare una parte della sua vita a invertire la rotta di questa sciagurata società; se prova a intendere la politica non come una cosa che serve a cambiare la sua stessa vita, ma quella di tutti; se prova a correggere i danni fatti dai professionisti della politica, come Franceschini: ecco che questi ultimi si difendono nel più incredibile dei modi: "sei un politico, e dunque non ti rispondiamo".
E così siamo oggi davanti al paradosso di un Franceschini che (vivendo di politica da quando io avevo nove anni, ed essendo oggi candidato al Parlamento) dice che io (che faccio un altro lavoro, e non sono candidato al Parlamento) lo attacco "da politico".
No, signor ministro: io la attacco da cittadino, da storico dell’arte, da intellettuale.E visto che da anni le pago, con le mie tasse, il suo lauto stipendio mi aspetto che risponda ai miei argomenti con altri argomenti. E non con quelli che vorrebbero essere insulti.

Internazionale online, 12 febbraio 2018. Cronaca di una grande dimostrazione contro il rigurgito razzista e fascista, che ha visto a Macerata uno dei suoi momenti più truci nel tentato assassinio di innocenti di colore
“Black lives matter”, le vite dei neri valgono. La vita diJennifer, quella di Wilson, quella di Gideon e quella di tutti gli altri. AMacerata una ragazza nera, che se ne sta in disparte dietro allo striscione deimetalmeccanici, ha scritto su un cartoncino bianco questa frase in inglese.Ricalca lo slogan del movimento antirazzista statunitense, nato nel 2013 perdenunciare le violenze sistematiche della polizia contro i neri. Come tanti, èvenuta a ribadire un principio fondamentale: lo stato moderno nasce dal ripudiodella violenza arbitraria di un essere umano su un essere umano. Vale anche perla repubblica italiana.
A Macerata il 10 febbraio qualcuno è venuto semplicemente adare “un abbraccio collettivo a Wilson Kofi, Omar Fadera, Jennifer Odion,Gideon Azeke, Mahamadou Toure, Festus Omagbon” (come è scritto su unostriscione), cioè a dimostrare solidarietà ai feriti della
sparatoriaavvenuta il 3 febbraio nella cittadina marchigiana, quando LucaTraini, un estremista di destra di 28 anni, ha impugnato una pistola e si èmesso a girare per la città in auto, sparando a caso contro i neri che haincontrato per strada.
Molti cittadini sono scesi in piazza per criticare ladecisione delle autorità di non far visita ai feriti in ospedale, altri hannocontestato la scelta di alcuni partiti e organizzazioni di non partecipare auna manifestazione unitaria contro il razzismo, una settimana dopo lasparatoria. Altri ancora sono arrivati a Macerata per ribadire chel’antifascismo è ancora un valore fondamentale.
Tante ragioni
 |
| fotografia di Michele Lapini |
Il movimento spontaneo che si è materializzato a Macerata il10 febbraio ha portato in piazza diverse rivendicazioni e almeno ventimilapersone: gruppi di attivisti, centri sociali, sindacati come la Fiom, i Cobas el’Usb, alcune sezioni dell’Anpi e dell’Arci, i collettivi antifascisti e quellifemministi, la rete nazionale Non una di meno, alcune organizzazioni comeLibera ed Emergency, parlamentari e partiti come i Radicali italiani di PiùEuropa, Potere al popolo e Liberi e uguali, molti operatori sociali impegnatinel sistema dell’accoglienza come il Gus e infine organizzazioni di migranticome il Movimento di rifugiati e migranti dell’ex Canapificio di Caserta.
“La politica non sopporta vuoti e se le istituzionidemocratiche si ritirano, lasciano il campo ad altre forze violente che sonopronte a riempire questi vuoti, come stanno facendo in questo momento i partitixenofobi e fascisti”, afferma Simona Baldanzi, scrittrice toscana arrivata aMacerata dopo tre ore e mezzo di viaggio in macchina da Barberino del Mugello.Con tre amici dell’Anpi ha portato la bandiera ricamata a mano della BrigataGaribaldi, il gruppo partigiano d’ispirazione comunista che combatté contro inazifascisti durante la resistenza. Per Baldanzi l’antifascismo non è un valoresuperato, ma significa “resistere ai soprusi, combattere le ingiustizie”.
Almeno sessanta sezioni locali dell’Anpi, come quella RenatoBiagetti di Roma,
hanno volutopartecipare alla manifestazione nonostante la decisionecontraria della segreteria nazionale, che aveva deciso di non scendere inpiazza accettando la proposta del sindaco di Macerata Romano Carantini diannullare tutte la manifestazioni. Anche Stefano Bucchioni, delegato deimetalmeccanici della Fiom di Monza, ritiene che non partecipare sia stato unerrore: “Questa timidezza delle istituzioni deve far preoccupare, perché è giàsuccesso all’inizio del novecento e il risultato è stato il ventenniofascista”.
Per Bucchioni l’intolleranza contro gli immigrati èalimentata dalla crisi economica, “causata dalla mancanza di strategieindustriali nel nostro paese e da scelte sbagliate che hanno dato troppo poterealle multinazionali”. Così i capri espiatori diventano gli immigrati, “che sonovenuti in Italia per lavorare, come noi in passato siamo andati in altripaesi”. Un’altra voce critica con i vertici della propria organizzazione èquella di Eliana Como, rappresentante di minoranza della direzione nazionaledel più grande sindacato italiano, la Cgil, che ha definito la scelta dirinunciare a manifestare “sbagliata e in qualche modo irresponsabile”, perché èimportante “opporsi ai segnali di riorganizzazione del neofascismo”.
“Una delle cose che mi scandalizza di più”, continua Como,“è che si sia voluto giustificare il gesto di Traini come una vendetta per ilfemminicidio di Pamela Mastropietro”. Per la sindacalista, si tratta dellastrumentalizzazione del corpo di una donna. Anche le
femministe delmovimento Non una di meno sono d’accordo e chiedono di nonusare la morte di Pamela Mastropietro per giustificare la violenza di LucaTraini. Per l’omicidio della ragazza
sono indagatitre nigeriani e Traini ha riferito di aver deciso di compiereuna strage dopo aver avuto notizia del ritrovamento del corpo smembrato diMastropietro.
Stefania Dimento, di un collettivo femminista maceratese,spiega che “ancora una volta il corpo di una ragazza è usato per giustificarela violenza razziale, contro altri corpi che sono considerati inferiori perchéneri”. Per Dimento la violenza razzista, il sessismo e il fascismo hanno unamatrice comune. La donna, che vive a Macerata, spiega che la città è ancorasotto shock sia per l’omicidio di Mastropietro sia per la tentata stragecompiuta da Traini. Per questo, conclude, voler annullare le manifestazioni ” èil tentativo di far finta di niente, di riportare tutto alla normalità. Maquesto non è possibile. Si deve parlare di quello che è successo”.
L’impressione però è che i maceratesi vogliano rapidamenteuscire dal clamore delle cronache nazionali in cui sono finiti nelle ultime duesettimane. Anche per questo hanno vissuto con ostilità il corteo pacifico chesabato ha attraversato la città. “Fino a due settimane fa i cittadini diMacerata discutevano animatamente delle conseguenze della pedonalizzazione delcentro storico, poi l’omicidio feroce di Pamela Mastropietro e la sparatoriadel 3 febbraio hanno gettato la città nella paura”, spiega una giornalistalocale.
Una città blindata
Quando intorno all’una del pomeriggio attivisti e cittadinida tutta Italia cominciano ad arrivare davanti ai giardini Diaz di Macerata, lacittà è blindata. I poliziotti e i carabinieri in tenuta antisommossa chiudonoil centro storico e i negozi sono sprangati. Alcuni commercianti hanno montatodelle protezioni di legno e ferro sulle vetrine. Il sindaco in una nota suFacebook aveva annunciato che tutte le scuole di ogni ordine e grado sarebberorimaste chiuse e il trasporto pubblico interrotto dalle 13.30. Anche ilcarnevale è stato rimandato al fine settimana successivo. I giornali locali hannotitoli allarmistici.
La decisione di alcune organizzazioni e partiti di nonpartecipare al corteo per il timore di nuove violenze appesantisce il clima chesi respira in città. “Hanno disdetto una manifestazione che non hannoconvocato”, sintetizza Valentina Giuliodori dell’Ambasciata dei diritti delleMarche. Il cielo è carico di nuvole grigie e un freddo umido avvolge i bastioniausteri della città, che lentamente si colorano di striscioni e bandiere.
“La manifestazione antirazzista e antifascista di Macerata èstata convocata già sabato sera (3 febbraio) dal centro sociale Sisma diMacerata, dal Collettivo Antifa e da molti gruppi e movimenti attivi sulterritorio, ma alcuni giochi politici nell’arco della settimana hanno tentatodi sabotarla e di dargli un altro significato”, spiega Giuliodori, primadell’inizio del corteo.
Il raid razzista nelle Marche – avvenuto a un mese dalle elezionipolitiche del 4 marzo – ha stravolto la campagna elettorale italiana e hariportato la questione dell’immigrazione al centro del dibattito, fino a quelmomento dominato da temi come le tasse, le pensioni e il reddito di base.L’opposizione – in particolare la Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – haaccusato il Partito democratico di aver favorito un’immigrazione incontrollata.
All’indomani dell’attentato, il leader di Forza ItaliaSilvio Berlusconi ha annunciato di voler rimpatriare 600mila immigratiirregolari, mentre il leader della Lega Matteo Salvini ha detto che“un’immigrazione fuori controllo, voluta e finanziata in questi anni, portaallo scontro sociale”. Le posizioni della destra hanno finito per creare unatteggiamento giustificatorio intorno alla violenza razzista di Traini.
Dal canto loro, i rappresentanti del Partito democratico,che si giocano un’importante partita elettorale nelle Marche (il ministrodell’interno Marco Minniti è candidato al collegio uninominale di Pesaro),hanno chiesto di abbassare i toni della polemica politica e di nonstrumentalizzare l’accaduto, ma non hanno riconosciuto la matrice ideologicadell’attentato e hanno deciso di non scendere in piazza, per non contrapporsi aun’opinione pubblica sempre più spaventata, secondo i sondaggi, dalla presenzadegli immigrati nel paese. Il ministro dell’interno, parlando a Pesaro duranteun comizio elettorale, pochi giorni prima della manifestazione, avevarivendicato la politica migratoria restrittiva adottata nell’ultimo annoe
l’avevagiustificata dicendo che “aveva visto Traini all’orizzonte”.
E aveva aggiunto: “Ringrazio Anpi, Cgil, Arci e Libera, chehanno accolto la richiesta del sindaco di Macerata di sospendere lemanifestazioni in questo momento così delicato per la città, che ora ha bisognodi pace e di tranquillità. Al tempo stesso mi auguro che anche altreorganizzazioni che hanno annunciato manifestazioni accolgano l’invito delsindaco di Macerata. Se questo non avverrà, ci penserà il ministro dell’internoa evitare tali manifestazioni”.
La paura
Minniti, insieme al leader della Lega Matteo Salvini, è stato uno dei bersaglidegli slogan della manifestazione di sabato. Il ministro è accusato dagliattivisti di aver favorito lo spostamento del corpo sociale a destra conmisure, come i decreti sull’immigrazione e quelli sulla sicurezza urbana, chehanno criminalizzato i migranti. A Minniti è contestata, da alcuni settori della sinistra,anche la chiusura della rotta del Mediterraneo centrale attraverso un accordocon il governo di Tripoli, che ha avuto come conseguenza la detenzione deimigranti nelle carceri libiche per periodi più lunghi, e infine la
campagna dicriminalizzazione delle organizzazioni non governative, che nelcorso dell’estate 2017 ha avvelenato ancora di più il dibattitosull’immigrazione.
Minniti ha giustificato spesso le sue scelte con il timore“per la tenuta democratica del paese” e la necessità di “arginare i populismi”.Ma tra i manifestanti di Macerata molti sospettano che la politica migratoriadel governo, concentrata sull’obiettivo della riduzione degli sbarchi, abbiamostrato le sue contraddizioni più evidenti proprio dopo l’attentato del 3febbraio.
Articolo ripreso da "internazionale online" qui raggiungibile.

Comune-info.net
«Possiamo affrontare il tema del lavoro in modo diverso? Possiamo dire chiaramente che non si difende qualsiasi lavoro? Che non possiamo proteggere la produzione di armi o la produzione di morte come avviene ad esempio a Taranto? È giunto il momento di smettere di produrre “ciò che produce profitto” per dedicarci a ciò che “serve collettivamente per vivere,” spiega Marvi Maggio. “Il tempo liberato dal lavoro è il criterio per capire quanto si stia andando nella direzione della trasformazione sociale…”. I soldi? “Ci sono e vanno dirottati dalle guerre e dagli sgravi alle imprese…Analisi e strategia, un nuovo stato sociale»
Neoliberismo: ruolo dello stato e
della pubblica amministrazione
e privatizzazione
Noi come lavoratori del pubblico impiego siamo colpiti in modo estremo dal neoliberismo, inteso come politica di rivalsa delle classi dirigenti, tesa a riprendere il potere perduto negli anni del dopoguerra e soprattutto negli anni Settanta. David Harvey, geografo marxista, definisce il neoliberismo come politica di restaurazione del potere di classe (quello della classe dirigente, del capitalismo). Una politica che si somma al funzionamento del capitale come motore del sistema economico, con il suo sfruttamento di esseri umani e della natura, con il suo produrre beni e servizi solo per chi può pagare, il suo dissipare risorse e la sua capacità di disumanizzazione. Tratta le cose da persone e le persone da cose. Il neoliberismo è iniziato a fine anni Settanta e continua ancora oggi.
Il neoliberismo è contro le norme ambientali e le norme che difendono i lavoratori, è contro ogni regola che controlli e restringa lo spazio dell’impresa e dell’investimento. È, quindi, contro le norme urbanistiche e paesaggistiche quando dettano regole che riducono la possibilità di estrarre profitto e rendita (intesa come profitto da monopolio).
Tuttavia il neoliberismo e il capitalismo utilizzano lo stato e la pubblica amministrazione come garante dell’ordine sociale che gli è necessario: primo fra tutti del diritto di proprietà. La utilizzano anche perché costruisca con finanziamento pubblico il capitale fisso di cui le imprese (o più in generale il capitalismo) hanno bisogno per funzionare: infrastrutture di trasporto e di connessione in rete in primis. Ne consegue che chi nelle pubbliche amministrazioni contribuisce alla progettazione delle infrastrutture, se queste funzionano dal punto di vista della produzione e realizzazione, contribuisce anche alla produzione di plusvalore. Dico, se funzionano dal punto di vista della produzione e realizzazione, perché alcune infrastrutture potrebbero in effetti essere semplicemente l’effetto di un fenomeno corruttivo: un finanziamento all’impresa costruttrice da parte dello stato anche se si tratta di una infrastruttura non necessaria alla produzione e realizzazione di plusvalore (né al trasporto delle persone). Il neoliberismo da subito si muove contro le leggi che lo ostacolano, abolendo fra l’altro lo stato sociale, per poi sostituirle con le sue leggi.
Il neoliberismo nasce con la Thatcher e Reagan proprio a fine anni Settanta e fa parte di una politica internazionale volta a distruggere tutto quello che avevamo costruito: i movimenti degli anni Settanta nelle scuole, università e posti di lavoro avevano spostato in modo rilevante i rapporti di forza a livello internazionale a favore delle classi subalterne. Il neoliberismo vuole eliminare le leggi e le regole che riducono il potere delle classi dominanti ma ne vuole altre che sostengono il suo potere.
Lo stato non è un corpo unico e univoco: al suo interno ci sono o ci sono stati elementi di welfare, di politiche di riequilibrio territoriale, di promozione di qualità territoriale, e contemporaneamente elementi di controllo, repressione di possibilità, tutte tese a conservare il potere delle classi dirigenti. Gli stessi servizi offerti dallo stato che oggi ci troviamo a proteggere dalla privatizzazione sono gli stessi che sono stati giustamente criticati per la scarsa qualità, l’ideologia e il pregiudizio familistico-democristiano che spesso contenevano, per la scarsa capacità di mettersi in rapporto con i fruitori, per la riduzione e semplificazione della complessità dei destinatari in categorie prestabilite e non verificate. Case solo per famiglie nucleari, scuole che tramandano ideologie del potere e non spirito critico, solo per fare degli esempi.
Ma con il neoliberismo appare sempre più forte il sostegno pubblico alle politiche di sviluppo economico capitaliste, in contrasto netto con qualsiasi ipotesi di qualità ambientale, sociale, territoriale. I piani strutturali e i piani operativi in diverse regioni (gli ex Piani Regolatori Generali) troppo spesso hanno come principale obiettivo politico da realizzare lo sviluppo economico capitalista, che ipotizzano possa essere compatibile con le qualità ambientali e sociali, fatto che però non si realizza mai.
Chi lavora nella pubblica amministrazione assiste a processi di privatizzazione dei servizi, ma anche delle attività di governo: per esempio in Regione Toscana si ampliano i settori che si occupano di appalti di servizi e di progettazione, in cui il compito diventa dettare le regole in base alle quali il servizio verrà offerto o il progetto verrà redatto da soggetti privati, imprese o cooperative.
Accanto a queste attività di esternalizzazione ci sono attività di finanziamento alle imprese, quelle vincenti come recita un adagio neoliberale: sostenere le imprese vincenti e abbandonare quelle perdenti, secondo l’idea (mai risultata vera) che le imprese vincenti traino lo sviluppo delle altre. Ma lo sviluppo che viene sostenuto è lo sviluppo capitalista: uno sviluppo in cui si produce quello che crea più profitto e non quello che è più utile e necessario. E si produce anche quando comporta la distruzione della natura non umana e l’alienazione dei lavoratori e della collettività. Si privatizzano anche le attività di governo quando, per fare un esempio, la pubblica amministrazione assume in toto nei propri piani urbanistici e territoriali quelli redatti da imprese private, immobiliari (tutto iniziò con le aree FIAT) o di settore (cave per esempio).
Con la scusa di promuovere lo sviluppo (capitalista) la Regione Toscana, ad esempio, distribuisce miliardi di finanziamenti europei alle imprese, che sono anche esonerate dalle tasse per il loro presunto ruolo di creare occupazione. Ma di quale occupazione stiamo parlando? Una produzione che risponde ai bisogni sociali e offre valore d’uso a tutti, oppure offre quel valore d’uso solo a chi lo può pagare? Bisogni fondamentali come quello della casa e quello della salute non trovano risposta, anzi ciò che prima, grazie alle lotte del passato (e non al compromesso capitale lavoro), era patrimonio di tutti, viene negato. Tutto quello che abbiamo avuto e abbiamo come diritto lo ha sempre conquistato chi ha lottato davvero per migliorare la situazione e non chi ha fatto compromessi. Ci sono riforme che sono un passo nella direzione di una trasformazione radicale e riforme che sono una scambio al ribasso (e questo descrive il compromesso). La descrizione dello stato sociale come compromesso elide la realtà: è stato conquistato con dure lotte inscritte in una ipotesi di trasformazione complessiva e non come contentino per stare zitti e piegare la testa.
Lavoro per tutti, ma utile per tutti
Oggi c’è un enorme bisogno di lavoro concreto che produce valore d’uso (non alienato).
La società in cui viviamo ha bisogno di una grande quantità di lavoro. Sto parlando di società, non del lavoro alienato di cui ha bisogno il capitalismo, ma del lavoro utile di cui abbiamo bisogno noi tutti.
Abbiamo bisogno di lavoro per far funzionare i servizi da offrire in modo universale: scuola, dagli asili nido, all’università, all’istruzione permanente; sanità a tutti i livelli, consultori; cura degli anziani di qualità e umana; cura del territorio, per garantire qualità idrogeomorfologica ed ecosistemica, per garantire qualità urbana, case per tutti, spazio pubblico, luoghi di incontro; cultura: biblioteche, archivi, teatri, luoghi per prove e per concerti, solo per fare degli esempi. C’è bisogno di numerosi nuovi servizi oltre che di far funzionare quelli che ancora esistono. In Italia un vero stato sociale, come è esistito nel Regno Unito del dopoguerra o nei Paesi Bassi, non è mai esistito.
C’è bisogno di un vero stato sociale ma diverso da quello del passato, diverso per contenuti, modalità organizzative, organizzazione del lavoro e per diritti dei lavoratori (che devono essere molti di più, assoluti e incondizionati). Reagan affermava: basta togliere i finanziamenti ai servizi pubblici e la gente si arrabbierà così tanto del fatto che non funzionino che accetterà di eliminarli e sostituirli con il privato.
Si tratta di dirottare i finanziamenti dalle imprese (e dalla guerra) ai servizi e alla produzione che serva per rispondere ai bisogni della popolazione a basso reddito. Contemporaneamente questa strategia offrirebbe una soluzione ai disoccupati. Si unirebbe la risposta a bisogni sociali di servizi e beni, alla risposta a chi ha bisogno di un reddito.
Ma il lavoro non dovrebbe solo essere utile (produttore di valore d’uso) ma anche non alienato (e questo attiene ai diritti del lavoro). Appare evidente che il lavoro nelle pubbliche amministrazioni oggi sia alienato: non controlliamo nulla di quello che facciamo, molto è lavoro meccanico e burocratico, malgrado i nostri sforzi di dargli senso. La qualità del lavoro che offriamo alla collettività dipende solo in minima parte dal nostro impegno, per il resto dipende da scelte politiche spesso tese a ridurre l’offerta pubblica e la sua qualità per garantire nuovi ambiti di investimento economico per le imprese.
Un lavoro non alienato
La rivendicazione di nuove massicce assunzioni nel settore pubblico per risolvere la domanda sociale (per dare corpo allo stato sociale) e per garantire lavoro ai disoccupati, deve coniugarsi con la rivendicazione di un lavoro non alienato. Non alienato perché i lavoratori conoscono le ragioni, contribuiscono a individuare le soluzioni, a garantire la qualità del lavoro che offrono. E contribuiscono a definire i limiti: pensioni di vecchiaia a 60 e orario. Ci vuole una vera democrazia organizzativa e per far questo il diritto del lavoro deve essere trasformato in meglio.
Siamo in tanti a criticare molti dei servizi pubblici esistenti, come fruitori e come lavoratori. Come lavoratori vediamo un’organizzazione gerarchica, i cui vertici sono scelti con lo spoil system e non sono mai all’altezza del ruolo. Disciplina e valutazioni spinte al massimo, ma non per migliorare le attività, bensì per renderle militari, tese all’obbedienza ai capi (e ai politici al comando) e non alla soluzione dei problemi e alla risposta di domande sociali che sono plurime e non possono essere presunte come faceva lo stato sociale democristiano.
Sono necessari democrazia organizzativa nel lavoro e partecipazione dei fruitori per la conoscenza dei bisogni a cui rispondere e per la definizione del servizio o del bene da offrire.
Non si tratta certo di difendere l’esistente né tanto meno di tornare al passato.
Perché mentre vanno chiesti servizi che rispondano ai bisogni sociali è necessario che siano organizzati direttamente dai lavoratori e dai fruitori, in un contesto di vera democrazia partecipativa (o autogestionaria). Non servizi solo rivolti agli indigenti (come stanno cercando di fare per le case popolari in un ottica neoliberale in base alla quale lo stato può offrire servizi e beni fuori mercato solo agli indigenti, tutti gli altri devono passare attraverso il mercato), ma servizi di alta qualità rivolti a tutti in modo universale.
Questa è una proposta per rispondere con un lavoro non alienato alla domanda di lavoro.
I sintomi sono chiari, ma la vera questione sono le soluzioni. Io credo che la questione cruciale sia lo scenario in cui poniamo le nostre lotte.
Se è quello che propongo, non si difende qualsiasi lavoro, perché non difendo la produzione di armi o la produzione di morte come avviene a Taranto. Non si baratta l’occupazione con la vita e poi una volta morti che conta il reddito? E qui parlo quindi di cosa produco: non deve essere prodotto ciò che produce profitto ma ciò che ci serve collettivamente per vivere, e la produzione non deve distruggere il nostro patrimonio collettivo, il territorio e l’ambiente, la natura (per quanto già seconda natura trasformata dall’interazione con le società nel corso del tempo, conserva sempre una componente di naturalità).
Veniamo poi al lavoratore, all’alienazione dal lavoro, alla perdita di umanità (il lavoratore è alienato dalla sua stessa essenza, poiché il suo non è un lavoro costruttivo, libero e universale, bensì forzato, ripetitivo e unilaterale (Marx paragona l’operaio al Sisifo della mitologia greca). L’organizzazione del lavoro deve essere nelle mani dei lavoratori. Il tempo liberato dal lavoro è il criterio per capire quanto si stia andando nella direzione della trasformazione sociale, come giustamente pensava Marx.
Il punto cruciale è promuovere e costruire una società umana e non alienata, in cui i bisogni delle persone trovino risposta.
Per iniziare ad andare in questa direzione è necessario una massiccia e imponente assunzione di nuovi lavoratori che offrano i servizi in tutti i settori che ho citato (istruzione a tutti i livelli, sanità, cultura, cura anziani, cura dei bambini, cura del territorio) attraverso una organizzazione del lavoro finalizzata al destinatario del servizio, non gerarchica e fondata sulla cooperazione. Un lavoro pubblico che usi soldi pubblici per attività davvero utili e non per rincorrere lo sviluppo capitalista.
Questa ri-pubblicizzazione dei servizi e nascita di nuovi (per esempio per la cura degli anziani) serve ad andare nella direzione opposta della privatizzazione (che è finalizzata ad aprire nuovi settori al mercato capitalista) cioè a rendere di nuovo bene comune il benessere di tutti ottenuto attraverso servizi pubblici. Servizi che non siano organizzati come istituzione totale ma come servizio che riconosce la piena umanità del fruitore. Di conseguenza anche l’organizzazione del lavoro deve trasformarsi rispetto a quella esistente: invece delle gerarche e della competizione (la corsa dei ratti promossa dal governo) cooperazione e umanità.
La tattica del governo è quella di stanziare pochi soldi per il pubblico impiego in modo che la stabilizzazione dei tempi determinati sia in alternativa con gli aumenti stipendiali dei tempi indeterminati, in modo che solo una minoranza possa avere la produttività mentre i disoccupati, che premono fuori, faranno intendere che gli occupati siano dei privilegiati. Il discorso va ribaltato. I soldi ci sono e vanno dirottati dalle guerre, dagli sgravi alle imprese, dalle infrastrutture non funzionali che ai profitti delle imprese di costruzione, e dai politici e sottosegretari, al lavoro utile e necessario, in modo da sottrarre settori alle imprese, e al capitalismo e alla sua logica segregante, alienante, escludente e disumana, per renderli un nuovo bene pubblico.
 il manifesto, 15 febbraio 2018 Mentre la lista di "estrema" sinistra Potere al popolo(dove sono le "sinistre" non estreme?) sta superando la soglia per entrare in Parlamento, ecco un finalmente un documento politico che affronta i problemi che gli altri trascurano
il manifesto, 15 febbraio 2018 Mentre la lista di "estrema" sinistra Potere al popolo(dove sono le "sinistre" non estreme?) sta superando la soglia per entrare in Parlamento, ecco un finalmente un documento politico che affronta i problemi che gli altri trascurano
Un gruppo di urbanisti, architetti, agronomi, ecologi, ambientalisti, attivisti ha lanciato un appello perché nella campagna elettorale e nel voto del 4 marzo assuma rilievo politico la città, il territorio e l’ambiente. I promotori dell’appello, Ilaria Boniburini, Paolo Cacciari, Eddy Salzano, Sergio Brenna, Guido Viale, Enzo Scandurra, affermano che non c’è più tempo per trasgiversare.
«I cambiamenti climatici, inquinamenti, perdita della biodiversità e della fertilità dei suoli, rarefazione delle risorse naturali, devastazione del paesaggio, emarginazione dei soggetti più fragili, la lotta di tutti contro tutti ci dicono che il nostro habitat è prossimo al collasso».
La politica dei partiti ha ignorato la dimensione fisica, territoriale e ambientale delle scelte politiche. La pianificazione pubblica è stata delegittimata per lasciare campo libero alle singole iniziative immobiliari, alle «grandi opere», all’urbanizzazione selvaggia, alle forze economiche di mercato, alle rendite immobiliari e finanziarie. Nel nostro paese non vi è mai stata una visione strategica per un uso ecosostenibile e condiviso del territorio.
Non è solo una crisi «nel» sistema, né una crisi solo italiana. E’ una crisi «del» sistema capitalistico e dell’attuale modello di sviluppo, che brucia risorse naturali vicine all’esaurimento e restituisce scarti tossici non metabolizzabili, che espelle gli abitanti meno abbienti e più fragili dal loro habitat e produce diseguaglianze sempre più accentuate.
Il sistema va profondamente cambiato, a partire dalle sollecitazioni dei comitati, movimenti e associazioni che agiscono in difesa della salute e della qualità dei territori, dell’agricoltura contadina, del diritto alla città, e del patrimonio naturale e storico.
Un’idea convincente di ciò che occorre fare è espressa nel programma elettorale di Potere al popolo:
* rivendicare un radicale cambiamento negli investimenti pubblici. Le risorse finanziarie destinate alle missioni militari, alle «grandi opere» (come il Mose, la Tav in Val di Susa, la Pedemontana) e ad altri progetti ambientalmente dannosi (come la Tap, le trivellazioni petrolifere, l’eolico selvaggio), in quanto dispendiosi, devastanti, spesso del tutto inutili che impoverisco territori e indebitano i cittadini, dovrebbero essere destinati al benessere di tutti gli abitanti;
* un massiccio programma di manutenzione e cura del patrimonio naturale, infrastrutturale ed edilizio, a partire della messa in sicurezza idrogeologica e sismica;
*centralità della salute ambientale nelle scelte di sviluppo economico, culturale e sociale: dalla tutela della qualità dell’aria e dell’acqua alla sovranità e qualità alimentare; dall’eliminazione dell’energia da combustibili fossili e altre fonti ambientalmente dannose, alla bonifica dei siti inquinati, dal potenziamento di una mobilità sostenibile e il trasporto pubblico allo stop del consumo di suolo; dalla ripubliccizazione della acqua, a una gestione dei rifiuti basata sulla loro riduzione, riuso e riciclo;
* priorità della vivibilità delle città sugli interessi della rendita: da un piano di riqualificazione delle periferie a un potenziamento dei servizi pubblici, da un piano straordinario di alloggi sociali a una nuova legge per il controllo degli affitti; da una pianificazione democratica dei territori e un reale decentramento delle decisioni al prevalere delle virtù sociali della cooperazione, solidarietà, mutualismo e valorizzazione delle differenze.
Il testo integrale dell’appello e l’elenco dei firmatari è pubblicato su eddyburg.it
PRIMI FIRMATARI:
Maurizio Acerbo, Paolo Baldeschi, Piero Bevilacqua, Giancarlo Consonni, Lidia Decandia, Enzo Di Salvatore, Maria Pia Guermandi, Susanna Böhm Kuby, Giorgio Nebbia, Cristina Quintavalla, Maria Rosa Vittadini, Alberto Ziparo

cittànuova.it
Siamo nel 1992 quando Norberto Bobbio, filosofo e giurista, scriveva in un “messaggio” per lungo tempo inedito: «In tutti questi anni si sono succedute sempre nuove Carte dei diritti, ma la maggior parte di questi diritti sono rimasti, letteralmente, sulla carta. A cominciare dal diritto alla pace che è strettamente legato ai due diritti fondamentali dell’uomo, il diritto alla vita e il diritto alla libertà». Così, a distanza di anni, sembra riecheggiare allora come oggi, nella sua perenne attualità, quanto scritto dai Padri costituenti nella nostra Carta costituzionale all’art. 11: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
È la ferma volontà di esprimere, anche nei confronti del mondo internazionale, la condanna e la rinuncia alla guerra, in forza di quella dichiarazione contenuta tra i Principi fondamentali della nostra Costituzione.
Guardando già allora a un futuro d’unità fra le Nazioni, anche oltre i confini dell’Europa, non si taceva dai Padri costituenti l’obiettivo di «aprire tutte le vie ad organizzare la pace e la giustizia fra tutti i popoli».
Le leggi non mancano
Sono le tante vittime di guerre taciute o dimenticate, ma alle quali il Comitato Riconversione RWM ha inteso dar voce in nome della pace e dell’umana dignità, nonostante il parere contrario di Confindustria e delle principali sigle sindacali a difesa e sostegno della piena legittimità e del diritto all’attività produttiva della fabbrica di armi in attesa di ulteriore espansione.
A livello internazionale l’Italia, fra l’altro, ha ratificato il Trattato sul commercio internazionale di armi convenzionali (Arms Trade Treaty – ATT), adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, New York, 2 aprile 2013 ed entrato in vigore il 24.12.2014. Ricordiamo che, in particolare l’art. 7, comma 7 prevede che lo Stato Parte esportatore, anche dopo la concessione dell’autorizzazione, possa venire a conoscenza di nuove informazioni rilevanti; in tal caso, lo stesso Stato sarà «incoraggiato a riesaminare» l’autorizzazione accordata.
Basta, dunque, per legittimare il commercio e l’esportazione di armamenti dall’Italia l’iniziale autorizzazione, pur prevista dalla legge 185 del ’90, se è vero che il nostro ordinamento affida proprio alle istituzioni la verifica circa il permanere delle condizioni iniziali?
Quell’autorizzazione non costituisce evidentemente un mero atto formale, ma chiede una verifica sostanziale, affinché l’attività prima consentita non incorra successivamente nei divieti espressamente previsti, che attendono il rispetto da parte di tutti, istituzioni comprese.
Le Risoluzioni europee
Non manca neanche la voce della stessa Unione Europea. Con la Risoluzione del 25 febbraio 2016sulla situazione umanitaria nello Yemen (2016/2515(RSP)) il Parlamento europeo ha chiesto espressamente «l’embargo sulle armi nei confronti dell’Arabia Saudita», sia per le gravi segnalazioni di violazione del diritto umanitario, sia per la conseguente considerazione «del fatto che il continuo rilascio di licenze di vendita di armi all’Arabia Saudita violerebbe […] la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell’8 dicembre 2008». Analogamente, la successiva Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017(2017/2727(RSP)).
Ma ha a che fare tutto ciò con il lavoro, diritto/dovere previsto dalla Costituzione tra i principi fondamentali? Lo è anche quel lavoro produttivo di armi, oggi rivendicato e difeso a favore di una terra certo povera, ma non di bellezze naturali, come l’Iglesiente?
Eppure oggi sempre più spesso accade di sperimentare una drammatica alternativa: tra lavoro e salute (v. caso Ilva di Taranto), o lavoro e rispetto di principi/diritti altrettanto fondanti della convivenza, quali quelli enunciati nell’art. 11 Costituzione.
Gli illegalismi legali e le radici del diritto
Dobbiamo allora essere consapevoli che per operare la riconversione di una attività produttiva occorre ancor prima togliere terreno alle armi, posto che la prima cornice di ogni attività lavorativa è la garanzia di legalità. Quest’ultima deve farsi sostanziale fino ad affermarsi come cultura della legalità per cittadini e istituzioni, e superare il rischio di ricadere in quelli che sono stati definiti “illegalismi legali”.
Ma anche la legalità, nell’ effetto ultimo di ordinare le relazioni sociali, comporta che il suo contenuto non si limiti al “non nuocere”, “non offendere”, “rispettare le norme”, ma arrivi a “guardare al bene dell’altro come al proprio”.
Se i profitti si possono sommare perché non hanno volto e non esprimono identità né storia, nell’obiettivo del bene comune non si può sacrificare il bene di qualcuno, magari distante e sconosciuto, per migliorare quello di qualcun altro, perché quel qualcuno è pur sempre una persona umana.
Una scelta che chiede il coraggio di fermarsi, perché, è il messaggio di Norberto Bobbio, «dobbiamo essere sempre più convinti che il rispetto dei diritti dell’uomo e la conservazione della pace cominciano da ciascuno di noi, singoli uomini e singole donne inermi di tutto il mondo, all’interno di ciascuno di noi, dei nostri pensieri, e delle azioni, anche se piccole, che riusciamo a far seguire con coerenza ai nostri pensieri».
È questo forse il coraggio degli ultimi e il richiamo ai potenti.

La Stampa, 12 febbraio 2018.Esodo, un libro che non si può non leggere. (i.b.)
Stiamo in guardia! Verità nuove si annunciano in questa parte del mondo corrosa dalla miseria con la lentezza di una malattia. Non facciamo i gradassi con le nostre armate luccicanti e il drenaggio dei migranti «a casa loro». Arrivo in Niger, Paese chiave del passaggio della Migrazione, per raccontare il luogo dove l’Italia sta per mandare 470 soldati. Ho provato, semplicemente, a rovesciare il punto di vista sulla «tragedia statistica» dell’Africa e guardare dal punto di vista degli africani. Op! tutto quello che da noi appare certo, il flusso che si ferma, i governi locali che, era ora! collaborano, il denaro europeo che assicura rimpatri «dignitosi», spariscono. I soldati americani, francesi, italiani così indispensabili alla lotta ai lanzichenecchi islamisti diventano invasori che si ritagliano, arroganti, coloniali fette di sovranità. Tutto è il contrario, dunque, e diventa una grande finzione.
Intanto specchiandosi nella tragedia della migrazione i giovani del Sahel hanno preso coscienza delle loro ingiustizie e non le accettano più. I migranti come miccia, come lievito di rivoluzione, i ragazzi, quando scenderanno in piazza, avranno con sé ogni diritto. Nulla del nostro blaterare sulla sicurezza e le necessità della geopolitica li interesserà, non leggeranno i nostri articoli, non ascolteranno i nostri discorsi di bottegai dell’umanesimo. Le nostre idee, ahimè!, le saluteranno sputandoci sopra.
Discussione di fantasmi
Il dibattito infervorato su come fermare i migranti e rispedirli a casa, visto da questa parte, è una discussione di fantasmi, le ambizioni di bloccare la migrazione, drenandola nel Sahel, sono comiche. Tra qualche mese, forse, saremo qui a raccontare folle in tumulto che danno l’assalto ai Palazzi di cleptocrazie nauseabonde su cui abbiamo puntato carte truccate. Ricordate il 2011? I ragazzi di Tunisi, di Tripoli, di Hama? Una Primavera del Sahel che ci lascerà, un’altra volta, senza parole, umiliati dalla nostra cecità. Gli uomini, i giovani che vivono qui non sono logori, sono sfiniti. Prima di questo viaggio pensavo che il problema fosse che abbiamo cessato di dare. Ai poveri, ai migranti. Torno convinto che non sappiamo più dare. Ed è peggio.
Niamey, la capitale: una distesa di tuguri vivi e decomposti, folle di sciancati, di senzatutto vagabondano come polvere che non vale nulla. Ti immergi dentro, sempre, anche dopo anni di viaggi qui, con occidentale sgomento. In verticale, come una bestemmia, si alzano i palazzi lussuosi di innumerevoli banche e delle sedi del governo. I binari di una ferrovia nuova di zecca, costata miliardi di franchi Cfa, fanno da spartitraffico. Nel viaggio di prova il treno si è rovesciato. Hanno riprovato: un altro disastro. L’hanno costruita male. Mi sussurrano un nome potente in Africa e non solo: «Bolloré», come se fosse una formula di cattivo augurio.
A un semaforo un mendicante cieco guidato da un ragazzo, pacato, mi incalza con i suoi occhi opachi: dammi qualcosa «Non ho monete locali, solo centesimi di euro: valgono troppo poco nessuna banca te li cambierebbe». «Dammeli, dammeli, c’è Cobrà che li cambia». Si perché per Cobrà , il serpente, nulla è troppo piccolo. Cambia, guadagnandoci la metà, a medicanti e facchini degli alberghi i centesimi occidentali, fa mucchio e poi va in banca dove lo accolgono come un finanziere. La infinita ingegnosità della miseria. La piazza delle manifestazioni: è un «tabà», un luogo in cui i giovani si incontrano, tessono sogni, discutono. Un ragazzo mi mostra i grandi ritratti dipinti sui muri dei presidenti dei cinque Paesi del Sahel. Sono riuniti a Niamey per «rendere sicura la regione». Sembrano già identikit di ricercati su cui si sfogherà la rabbia della gente. Un ragazzo mi dice: la sicurezza è un bel concetto. Importante. ma se non hai da mangiare che ti importa della sicurezza?».
I 43 ministri
Il governo, che non ha più soldi nemmeno per gli stipendi, ha imposto tasse ai più poveri del mondo: lo Stato è povero, pagate voi! Ci sono quarantatré ministri in Niger. Ognuno di loro ripaga armate di parenti e portaborse con incarichi, missioni, commende. Attingendo ai fondi dello Stato, ai contratti con l’estero, ai soldi dati per fermare i migranti. Non lo sapete? Suvvia.
Prestiamo attenzione ai rumori sempre più forti. A Niamey si scende in piazza da settimane, il potere risponde con arresti di leader e giornalisti che raccontano. In Ciad ci sono già i primi morti. Ho incontrato gente diversa, non è più rassegnata, non ha più quella apparenza di colpevoli che hanno le vittime. I presidenti-padroni, i nostri soci, indifferenti, vengono in Europa a raccogliere sorrisi riconoscenti. È gente che non ha nulla da proporre ai propri popoli, vuol solo rubare, il male eterno dell’Africa che traffica con noi, complici consapevoli.
Intanto su, ad Agadez e nelle città del deserto, migliaia di migranti sopravvivono, attendono che torni il tempo buono del viaggio, i passeur lucidano i veicoli e predispongono nuove piste sicure da percorrere con i gps, lanciati a cento all’ora verso la Libia. Aggireranno i controlli: di gendarmi che hanno bisogno delle loro mance per sostituire stipendi da fame e in continuo ritardo.
È chiaro che noi occidentali siamo qui a combattere per i nostri soli interessi. Questa parte del mondo perde le proprie povere viscere. Bisognerebbe ricucire, e presto: non c’è un secondo da perdere. Costoro sono condannati. Ma noi spediamo inutili soldati e paghiamo i grandi ladri vestiti di eleganti boubou.
Saliamo ad Agadez, per l’ennesima volta: con fatica, senza speranze, sapendo che Agadez è una ricapitolazione di quanto accadrà ed è accaduto.
Ah, il vecchio aereo dei palestinesi! È sempre lì, il vecchio Fokker ad elica con la sua scomodità e la sua austerità, simbolo appropriato della preparazione alle dure gioie del raccontare luoghi come questi. Tutto vi assume una sobrietà accogliente mentre sorvola il Sahel. Il grande bricco con cui servono il tè, i racconti dell’equipaggio: vengono da Gaza e da Hebron.
Una volta Agadez mi piaceva: le fragili, eterne architetture di sabbia che annunciano il deserto, c’era un calore di partenza, di viaggio e di orizzonte libero. Adesso ci vedo solo una città di miseria e di agonia; è rimasta la luce che regna indisturbata. Il resto è solo povertà, stratificata, dura come una crosta che copre uomini e cose. Il miracolo degli alberi è macchiato da sudice sagome che ondeggiano al vento. Credevo fossero grossi corvi appollaiati. Invece sono lembi di sacchetti di plastica neri.
Un uomo con una ascia preistorica fa a pezzi un tronco abbattuto: altri secoli di vita miracolosa che andranno in cenere. Tra gonfi mucchi di immondizia e rigagnoli puzzolenti tre vecchi dalla barba bianca: immobili. Nulla si muove. Nulla è urgente. Tutto è crudele.
Agadez viveva di turismo: è finito nel 2006 con la rivolta dei tuareg. Poi è venuto l’oro, scoperto nelle montagne intorno. Il governo ha vietato ai cercatori privati di avvicinarsi e vende le concessioni alle grandi compagnie straniere. Le imprese dell’uranio hanno appena licenziato 700 persone. Erano rimasti i migranti, l’oro nero come li chiamavano: trecentomila almeno nel 2016. A luglio, dopo gli accordi con l’Europa, è diventata un’attività illegale e si è pressoché fermata. Si calcola che Agadez abbia perso 65 milioni di euro. Ecco. Non è rimasto niente. Attorno alla città, sulle montagne, si moltiplicano i gruppi armati. Non sono jihadisti, ma banditi che assalgono viaggiatori e camion. Diventeranno, al momento giusto, reclute della guerra santa.
Nascosto nel turbante
Le delegazioni europee che vengono qui, giulive, per controllare come funziona bene il controllo, dovrebbero farsi accompagnare nel quartiere di Obitara. Dove ci sono i «ghetti», li chiamano così. Durante la stagione delle piogge diventa palude, non c’è la corrente elettrica e nemmeno l’acqua. In grandi cortili circondati da muri di fango secco tengono i migranti. Scoprirebbero che ce ne sono almeno quaranta di questi luoghi infernali, e zeppi di gente. I passeur si fanno dare i soldi dalle famiglie, le ragazze quasi tutte nigeriane si prostituiscono per pagare.
Ci vado di notte, mi nascondo dietro un turbante da tuareg. Una discesa tra le ombre da cui spiritualmente non si torna più indietro come chi scendeva nell’Ade. Attraverso la città senza illuminazione in moto. Piccoli fuochi accendono il buio, bruciano le immondizie. Le luci dei telefonini illuminano i volti di ragazzi riuniti, a mazzi, agli angoli delle strade. Dopo il tramonto Agadez diventa un villaggio, solo le voci dei cani nella notte chiara. Nei cortili dei ghetti mi muovo inciampando. Puzza di escrementi, di cibo guasto, di umori umani. Aleggia dalle stanze un rumore indefinito fatto di rauchi ronfi, di gemiti oscuri, del raschiare di latta, quasi un battere arterioso. Entro e cala il silenzio. Volti duri, assonnati, reclinati cui il buio conferisce un’aria spettrale. Tacciono enigmaticamente. Ho paura di vedere questi visi serrarsi, facendosi lisci come muri. Questa è la gente che abbiamo fatto sparire ma senza annullarla, come il prestigiatore con una carta del mazzo: è lì, attende, ci inchioda alle nostre responsabilità.
Sidi il passeur ha deciso: «Giovedì ricomincio, vado a Dirkou, a nord ci sono migliaia di migranti in attesa, riallaccio i miei contatti, in Libia, in Senegal, in Gambia. Non posso più aspettare. Si riparte». Aveva smesso quando hanno arrestato i primi passeur e sequestrato i veicoli. Mi fa vedere il formulario con cui aveva chiesto i fondi di riconversione promessi dalla Unione europea: 2000 euro per avviare un commercio, un’attività agricola, allevare bestiame. Lui ne guadagnava con i migranti settemila la settimana. Alla voce professione è scritto: passeur di migranti. Hanno fatto la domanda in mille. Non è arrivato finora un centesimo. E i soldi? Si sono fermati a Niamey. Forse sono serviti a pagare gli stipendi arretrati ai funzionari. «Anche i poliziotti hanno bisogno di soldi, li pago perché mi avvertano quando è prevista una retata, così nascondo i miei migranti e tutto fila liscio. Ma con i viaggi il denaro tornerà a girare. I soldati francesi a Madamà, il posto di frontiera sul confine libico? Ci sono passato decine di volte, avevo i pick up carichi, mi guardavano e non dicevano niente… Forse eran lì per altro. Adesso ci vanno gli italiani? Tutto è cambiato? Fratello, voi buttate via soldi, dammi retta. Chi ci passa più a Madamà? C’è una pista magnifica tra due montagne che aggira la città, i libici aspettano lì adesso. I prezzi con tutto questo bordello sono alle stelle, si guadagnerà bene».
Ieri notte ad Agadez c’è stata una retata, hanno catturato molti migranti. Il guineiano è contento perché adesso avrà molto lavoro, guadagnerà bene. Era un migrante. Ha due volte attraversato l’oceano in piroga dalla Mauritania alla Spagna. Un sopravvissuto. Adesso lavora all’Oim, l’organizzazione internazionale per le migrazioni che ha un campo ad Agadez. Non nel senso che ne è un dipendente: nel senso che la utilizza. Compra dai migranti in attesa di rimpatrio molte cose. «Sapete, hanno con sé cose interessanti da comprare a poco prezzo, incredibile dopo il viaggio che hanno fatto fino qui: orologi telefonini. Guarda questi sandali, belli no? Cuoio magnifico, li ho comprati da un migrante. Hanno bisogno di soldi per ritentare, hanno fatto debiti per partire che dovrebbero pagare se tornano a casa. Non lo sapete? Possono farlo solo se arrivano in Europa, da voi, a costo di crepare. Io li faccio uscire dal campo, diciamo che dentro ho dei contatti, le famiglie mi mandano i soldi. Escono, si nascondono, possono ritentare».
Riparto. L’aereo palestinese è in ritardo, cinque ore. Un soldato nigerino, l’elmetto in testa mitra scarponi da deserto, tutto nuovo, corre a perdifiato verso la pista lanciando urla terribili. Un gruppo di caprette ha adocchiato una lisca di erba vicino alla pista. Ridiventato pastore il soldato le fa fuggire. Sta atterrando un nero, lucente trasporto americano.
Americani in assetto da guerra si dispongono a raggiera, i fucili puntati in tutte le direzioni. Un grande bulldozer infila i denti di ferro nella pancia dell’aereo ed estrae una piccola cassa di legno. Caricano la cassa su un camion aperto che potrebbe portare un carro armato. Si forma un convoglio di autoblinde che sfuma nella calura del deserto verso la base. L’aereo che non ha nemmeno spento i motori riparte nella luce… lente, immense nubi di polvere scivolano sulla città.
Tratto da Informazione Corretta che l'ha a sua volta ripreso dalla Stampa del 12/02/2018, pag.1-3.
Nigrizia, 9 febbratio 2018. Un chiaro messaggio di 20 associazioni del mondo cattolico ai partiti che si presentano alle elezioni del 4 marzo. Non sarà difficile rispondere: difficile sarà mantenere le promesse
Gli enti cattolici impegnati a vario titolo nell’ambito delle migrazioni sentono la necessità di aprire uno spazio di confronto in cui dare voce alle esigenze di convivenza civile e di giustizia sociale che individuano come prioritarie, per il bene di tanti uomini e donne di cui si impegnano a promuovere i diritti e la dignità.
Nell’orizzonte di un welfare che metta sempre più al centro una visione di comunità civile inclusiva e solidale, le migrazioni pongono questioni cruciali e non rimandabili e che riguardano tutti indipendentemente dalla provenienza.
I diversi schieramenti politici che si presentano al prossimo appuntamento elettorale sono chiamati ad esprimersi su come intendono affrontare tali questioni. La crisi dei migranti che attraversa oggi l’Europa mette chiaramente in luce una crisi profonda dei valori comuni su cui l’Unione si dice fondata.
La questione delle migrazioni sembra essere diventata un banco di prova importante delle politiche europee e nazionali. In tale contesto il fenomeno migratorio è cruciale per il futuro dell’Italia e occupa spazi sempre più rilevanti all’interno del dibattito pubblico e, lo sarà ancor di più in vista delle prossime scadenze elettorali. Per questo, riteniamo fondamentale creare occasioni di confronto schiette e costruttive, grazie alle quali gli schieramenti politici che si candidano a governare il Paese possano prendere impegni chiari e precisi nei confronti dell’opinione pubblica.
In quest’ottica, il presupposto è quello di uscire dalla logica emergenziale per ripensare il fenomeno migratorio con progettualità. In questo quadro abbiamo comunque la certezza che nel Paese, quando si parla di immigrazione, esista un ampio bisogno di riflessione, azione e cambiamento che anima tanti cittadini. La campagna Ero straniero - L’umanità che fa bene, lanciata in aprile per cambiare la legge Bossi-Fini e conclusasi a ottobre con oltre 90 mila firme raccolte, lo ha confermato: esiste una forte domanda di informazione, di senso e di risposte concrete. A formularla è un numero crescente di cittadini che ha capito quanto sia cruciale per tutti affrontare il tema in maniera diversa.
Sulla base delle nostre esperienze sul campo, ispirandoci ai costanti appelli di Papa Francesco ad Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare i migranti e i rifugiati, e richiamando i 20 punti proposti dal Dicastero per la promozione dello sviluppo umano integrale del Vaticano per la stesura del Global Compact - l’accordo sui migranti e sui rifugiati che verrà adottato dalle Nazioni Unite nel 2018 -, abbiamo elaborato sette proposte per altrettanti ambiti nei quali è cruciale intervenire al più presto. Sono sette sfide che, citando proprio questo importante documento, vanno affrontate non solo per contribuire alla “protezione della dignità, dei diritti, e della libertà di tutti i soggetti di mobilità umana”, ma anche per “costruire una casa comune, inclusiva e sostenibile per tutti”.
Agenda sulle migrazioni, 7 punti specifici:
1.Riforma della legge sulla cittadinanzaDa troppi anni il nostro Paese non adegua la sua legislazione sull’acquisizione della cittadinanza al mutato contesto sociale e troppi cittadini di fatto non sono riconosciuti tali dall’ordinamento. Varare un provvedimento che sani queste contraddizioni non è più rimandabile.
2. Nuove modalità di ingresso in ItaliaServe un nuovo quadro giuridico per accogliere quanti arrivano nel nostro Paese senza costringerli a chiedere asilo. A fronte di flussi migratori che gli esperti definiscono sempre più come misti, creare una divisione politica tra richiedenti asilo e “migranti economici” è difficile, anacronistico e inefficace. Bisogna andare oltre. Chiediamo una rapida riattivazione dei canali ordinari di ingresso che ormai da anni sono pressoché completamente chiusi, con l’inevitabile conseguenza di favorire gli ingressi e la permanenza irregolari. Per entrare in Italia secondo la legge servono modalità più flessibili e decisamente più efficienti, a cominciare da un immediato ritorno del decreto flussi, per arrivare fino a proposte più ampie e organiche di modifica del testo unico sull’immigrazione: permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di occupazione, attività d’intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari e reintroduzione del sistema dello sponsor (sistema a chiamata diretta).
3. Regolarizzazione su base individuale degli stranieri “radicati”Gli stranieri irregolari, seguendo i modelli di Spagna e Germania, dovrebbero avere la possibilità di essere regolarizzati su base individuale, qualora dimostrino di avere un lavoro, di avere legami familiari comprovati oppure di non avere più relazioni col paese d’origine. Si tratterebbe di un permesso di soggiorno per comprovata integrazione, rinnovabile anche in caso di perdita del posto di lavoro alle condizioni già previste per il “permesso attesa occupazione”. Infine, il permesso di soggiorno per richiesta asilo si potrebbe trasformare in permesso di soggiorno per comprovata integrazione anche nel caso del richiedente asilo diniegato in via definitiva che abbia svolto un percorso fruttuoso di formazione e di integrazione.
4.Abrogazione del reato di clandestinità
Il reato di immigrazione clandestina, che è ingiusto, inefficace e controproducente, è ancora in vigore: va cancellato al più presto, abrogando l’articolo 10-bis del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.
5. Ampliamento della rete SPRARLo squilibrio a favore dei Cas, i Centri di Accoglienza Straordinaria, è ancora troppo forte e a risentirne è la qualità dell’accoglienza. L’obiettivo deve essere riunificare nello SPRAR l’intero sistema, che deve tornare sotto un effettivo controllo pubblico, che deve prevedere l’inserimento dell’accoglienza tra le ordinarie funzioni amministrative degli enti locali e che deve aumentare in maniera sostanziale e rapida il numero di posti totali.
6. Valorizzazione e diffusione delle buone praticheSiamo ormai da tempo sommersi da casi di cattiva accoglienza. Esistono, sono purtroppo numerosi e non bisogna mai smettere di denunciarli con forza e rapidità, senza il minimo timore. C’è però anche un’altra faccia dell’accoglienza dei migranti, meno esposta e ben più positiva. Va raccontata il più possibile, proprio attraverso un osservatorio capace di individuare e diffondere le buone pratiche, affinché vengano il più possibile replicate.
7. Effettiva partecipazione alla vita democraticaSi prevede l’elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Acli, Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo (ASCS Onlus),Associazione Papa Giovanni XXIII, Azione Cattolica, Centro Astalli, Centro Missionario Francescano Onlus (Ordine dei Frati Minori Conventuali), CNCA, Missionari Comboniani, Comunità Sant'Egidio, Conferenza Istituti Missionari Italiani, Federazione Salesiani per il Sociale, Fondazione Casa della carità, Fondazione Somaschi, GiOC - Gioventù Operaia Cristiana, Istituto Sturzo, Movimento dei Focolari Italia, Paxchristi, Vides Italia.
Il testo è ripreso dalla rivista online Nigrizia, ed è raggiungibile su questa pagina

globalproject, L'Huffington post, il manifesto,
Huffington post
«TEMPO DI RISCATTO E INSUBORDINAZIONE»
OLTRE 30.000 aA MACERATA CONTRO OGNI
FASCISMO, SESSISMO E RAZZISMO
Migliaia di persone - giunte da tante città d’Italia e da ogni angolo delle Marche – hanno raggiunto i giardini Diaz a Macerata per la grande manifestazione contro ogni fascismo, sessismo e razzismo, convocata dai movimenti dopo la tentata strage fascista della scorsa settimana. Sono tantissimi anche gli abitanti di Macerata, ribaltando quella ricostruzione fatta ad hoc dai media mainstream, di una «città chiusa, blindata e ostile».
L’unico a voler blindare, e addirittura impedire, la piazza di Macerata di oggi è stato il ministro dell’Interno Marco Minniti. Ma, nonostante il tentativo d’intimidazione e la minaccia politica, d, oggi Macerata è attraversata da una moltitudine di persone che hanno scelto di esprimere la propria indignazione, la propria indipendenza, ripristinando dal basso l’agibilità democratica.
«Ci sono momenti in cui la storia si comprime, dove tutto sembra accadere in un lasso di tempo troppo breve perfino per rendersene conto. L’ultima settimana maceratese ci ha forse insegnato che della storia occorre esserne parte, senza tirarsene indietro, declinando la tanto sbandierata responsabilità in altri termini». Questo dicono i compagni e le compagne del centro sociale Sisma, che per primi hanno respirato l’angoscia di questi giorni, ma anche il senso di un riscatto collettivo, che da subito si è messo in moto.
Mentre ancora dovevano arrivare decine di pullmann, i giardini Diaz già erano stracolmi di gente. «Siamo tantissimi e tantissime e stiamo aspettando ancora che arrivino numerosi. Siamo qui per dire che noi siamo la vita, loro sono la morte, loro l'odio noi la gioia. Loro sono quelli che respingono, noi quelli che accolgono». dicono dal camion d'apertura prima della partenza del corteo.
La manifestazione di oggi è una grande vittoria almeno per due ragioni: innanzitutto perché contro tutto e conto tutti si è riusciti a strapparla a chi cavalca il clima di paura anziché dare la possibilità a chi vuole combatterlo di scendere in strada. La seconda ragione è che è stata una vittoria collettiva, costruita insieme alle tante e ai tanti insubordinati che hanno continuato ad inviare appelli e adesioni nonostante le minacce velate del ministero, ai tanti che si sono rifiutati di cedere ai diktat di chi dall’alto voleva imporre “la rinuncia” e anche grazie ai tanti maceratesi che hanno riscattato la storia della città partecipando alla costruzione di questa giornata.
Paolo dei centri sociali delle Marche interviene alla partenza del corteo: «tantissime persone stanno invadendo le strade nonostante i tentativi istituzionali di fermare questa manifestazione, nonostante i tatticismi elettorali delle grandi organizzazioni della “sinistra”, subordinate al Pd. Quello che è accaduto, una sparatoria fascista su donne e uomini migranti e tutto quello che ne è conseguito, ci ha portato a indire questo corteo. Lo abbiamo fatto per dire che siamo tutti antirazzisti, perché siamo convinti che solo il legame sociale fra gli ultimi, fra chi subisce questo sistema economico, può rappresentare la forza per cambiare al mondo. Perché solo i movimenti sociali reali possono cambiare la realtà». E ancora: «Caro Minniti se il tentativo era imporci il silenzio, ci sembra che tu abbia fallito. L’insubordinazione che abbiamo visto in questi giorni è qualcosa di inedito e di estremamente potente».
«Siamo migliaia, siano insubordinati, siamo semplici cittadini. Grazie a tutti, era necessario dare una risposta forte. Stiamo dimostrando insieme che Macerata è una città degna della tradizione antifascista che porta» dice Simone del centro sociale Sisma, dando il benvenuto alle tantissime persone giunte a Macerata. Mentre il corteo giunge in fondo a via Pantaleoni, avendo percorso già diverse centinaia di metri, molte persone ancora devono partire dai giardini Diaz. Dal palco viene annunciata la presenza di oltre 20.000 manifestanti; anche se i numeri sono destinati ad aumentare, visto che diversi autobus ancora devono arrivare a Macerata.
Determinazione e insubordinazione sono concetti che emergono anche in altri interventi dal camion, che si susseguono in continuazione. «La determinazione delle tante e dei tanti che sono oggi a Macerata ha smascherato i tentativi di normalizzare il fascismo. Grazie a tutte e tutti quelli che sono qui», dice Pierpaolo dell’Ambasciata dei diritti delle Marche.
Intervengono anche diversi iscritti ai circoli Anpi, che nei giorni scorsi hanno disobbedito al tentativo della loro organizzazione di sabotare la manifestazione di oggi. «Ringrazio i compagni delle Marche per non aver ceduto alle minacce di Minniti. Io sono iscritto all'Anpi e sono qua per mio padre, che era partigiano, e per respingere il fascismo. Un fascismo al servizio di chi vuole tutelare i privilegi e chi vuole che gli sfruttati si combattano tra di loro» sono le parole di un iscritto del Veneto.
Nel frattempo giungono notizie di manifestazioni di solidarietà a quella di Macerata che in questo momento si stanno svolgendo in diverse città d'Italia e d'Europa. A Cosenza, proprio in questi minuti, antifascisti e antifasciste stanno contestando la presenza del leader di Forza Nuova Roberto Fiore. Nel corso del corteo tantissime persone si affacciano dalle finestre e dai balconi per salutare i manifestanti. Con la manifestazione giunta quasi a metà percorso, la coda si è appena messa in marcia: sono presenti oltre 30.000 persone, un numero impressionante per una città "di provincia".
Continuano gli interventi. Mamadou, del movimenti migranti e rifugiati di Caserta, ricorda i 7 migranti uccisi a Castel Volturno nel 2008, vittime della criminalità organizzata e del razzismo. In piazza ci sono centri sociali provenienti da tutta Italia. Marco Baravalle, dei centri sociali del Nord-Est, ricorda Pamela «che è stata uccisa due volte e la seconda è quando hanno strumentalizzato la sua morte. Anche questo è decidere sul corpo delle donne».
Da Napoli Eleonora del centro sociale Insurgencia: «Quello che è successo oggi è la cosa più bella e potente che poteva succedere. Vogliono farci credere che il fascismo ha conquistato la società. Oggi abbiamo dimostrato che quando i fascisti scendono in strada sono quattro gatti, quando lo facciamo noi siamo migliaia. Oggi il Ministro Minniti dovrebbe dare le dimissioni! Grazie Macerata per aver rimesso le cose apposto e per averci ricordato che l'unica lotta che ha senso è dal basso verso l'alto». Luca dei centri sociali di Roma: «Dobbiamo ribaltare il paradigma di un paese che prova ad alimentare la guerra tra poveri. A Roma nelle prossime settimane sono previste diverse iniziative antifasciste e antirazziste. Ci difenderemo dalla barbarie con ogni mezzo necessario».
«Oggi Macerata dà una grande risposta moltitudinaria contro i fascisti e contro chi istituzionalmente fa il loro gioco. E oggi è successo l'impensabile, perchè la base di Anpi, Arci e Cgil oggi ha realmente disobbedito ai loro vertici, scendendo in piazza con noi» dice Alessandro dello spazio sociale Arvultura di Senigallia. Interviene anche Vittoria di Veneto Accoglie: «la scorsa settimana siamo andati in migliaia a Chioggia e oggi siamo a Macerata perché su diritti e accoglienza si gioca una battaglia decisiva per l'umanità. A chi ci vuole divisi rispondiamo oggi uniti. Nessuno spazio ai razzisti, ai fascisti, a Minniti, a Salvini!»
In piazza anche le realtà di lotta per il diritto all’abitare. Per Paolo dei Blocchi Sociali Metropolitani di Roma: «non possiamo lasciare il disagio sociale nelle mani dei fascisti e dei leghisti. Italiani e migranti sono un unico fronte sociale e l'insubordinazione di chi è oggi in piazza è comune». Tutti gli interventi rimarcano la questione del sessismo e la necessità di riaprire ancora di più spazi di lotta femminista nella nostra società. Un’attivista di Non una di Meno prende la parola: «oggi le femministe di tutta Italia hanno raccolto l'invito di Macerata. Le attiviste che hanno aderito al corteo sono state minacciate e oggetto di stalking. Vogliamo spazi che siano abitabili per tutte e tutti e non solo per l'uomo bianco e ricco. Antirazzismo e antisessismo sono nel nostro DNA».mL’antirazzismo si intreccia con le pratiche solidali e di mutualismo. Per questa ragione anche le Brigate di Solidarietà Attiva hanno aderito al corteo di oggi.
Il corteo ritorna ai giardini Diaz. Una manifestazione immensa, che potrà realmente sovvertire l'involuzione reazionaria che stiamo vivendo, in Italia e non solo. Nell'intervento finale Nicola, dei centri sociali delle Marche, ringrazia le donne e gli uomini liberi e antifascisti che, con questa piazza, mettono una pietra tombale su chi diceva che l'antifascismo era minoritario. «Noi ci siamo! Ringraziamo chi ha resistito al ministro Minniti, al Partito Democratico, ai fascismi! Ringraziamo chi è venuto qua a metterci corpo e faccia. Ringraziamo tutti quelli che sono qua. Speriamo che oggi da Macerata possa nascere qualcosa di nuovo. Oggi non abbiamo voluto un palco, perché non è una fine, ma un inizio. Dobbiamo ripartire dai territori, dalle periferie, dal lavoro e dalle scuole. Questo paese è ancora antifascista e da oggi cominciamo a riprendercelo con ogni mezzo necessario».
Qui l'articolo di globalproject completo di immagini e filmati
«PERCHÈ IL PD E LE ISTITUZIONI NON SONO QUI?»
intervista di Gabriella Cerami a Gino Strada
Gino Strada guida la delegazione di Emergency al corteo contro il razzismo e il fascismo a Macerata
Gino Strada guida la delegazione di Emergency. Sono stati tra i primi ad arrivare ai Giardini Diaz di Macerata dove c'è il concentramento del corteo contro il razzismo e il fascismo a una settimana esatta dagli spari di
Luca Traini contro gli immigrati.
Il presidente di Emergency si chiede però come mai non ci siano in piazza anche le Istituzioni e il Pd. «Intervenire sarebbe doveroso. È il compito delle istituzioni. Invece ho sentito le istituzioni e il sindaco Pd che in questi giorni hanno invitato a non manifestare. Credo che ci sia un affievolimento dell'antifascismo e bisognerebbe chiederlo a loro perché non sono qui a Macerata. Quell'atto di terrorismo è successo qui. Quando hanno fatto saltare in aria molti ragazzi nei bar d'Europa, non hanno fatto le manifestazioni a Tunisi, le hanno fatte a Parigi o a Barcellona. Perché oggi non sono qui a Macerata? Hanno paura di qualche potenziale terrorista? Vanno isolati perché quando li si isola anche politicamente non si manifestano».
CONTRORDINE MINNITI
IL CORTEO DI MACERATA NON SARà VIETATO
di Mario Di Vito
Oggi in piazza. La prefettura revoca il divieto alla manifestazione: non sussistono ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Il sindaco chiude le scuole e ferma il carnevale dei bambini di domani. La diocesi lo segue: oggi le chiese non apriranno
È il giorno dell’antifascismo a Macerata. A una settimana esatta dalla sparatoria di Luca Traini, la città si appresta a ospitare il corteo organizzato dal centro sociale Sisma, al quale hanno aderito decine e decine di associazioni da tutta Italia, con quaranta pullman in arrivo da Trento a Palermo.
Il raduno è previsto alle 14.30 ai giardini Diaz e il percorso si snoderà intorno alle mura della città per poi tornare al punto di partenza. Secondo gli organizzatori - che assicurano si tratterà di un corteo «assolutamente pacifico» - arriveranno almeno cinquemila persone. Il sindaco Romano Carancini, dopo aver invocato uno stop a tutte le iniziative, con un’ultima dichiarazione ha quasi corretto il tiro: «Condivido pienamente i valori della manifestazione antifascista. I miei dubbi erano solo sull’opportunità del momento, visto il clima che si respira in città». Il primo cittadino ha anche deciso di chiudere le scuole per oggi e di annullare il carnevale dei bambini di domani. La diocesi lo ha seguito pronta chiudendo le chiese in centro città, stop a messe e catechismo, e invitando i cittadini a rimanere chiusi in casa e pregare.
Il segretario del Pd Matteo Renzi chiede di «non consegnare il paese agli estremisti», continuando a mettere fascisti e antifascisti sullo stesso piatto della bilancia. La risposta arriva dal leader di Leu Pietro Grasso: «La piazza si può gestire in modo ordinato e sicuro, negandola si creano più tensioni. Cavalcare la paura non fa bene al paese». Sulla tentata strage di Luca Traini ieri è intervenuto anche il premier Paolo Gentiloni: «Il dibattito politico è libero, la giustificazione del fascismo è fuori dalla Costituzione italiana», ha detto durante l’apertura della campagna elettorale della federazione Pd di Ascoli Piceno. «Non scambiamo la situazione migratoria che stiamo affrontando con quella della sicurezza», ha proseguito, contraddicendo la linea Minniti, «Chi soffia sul fuoco trova spazio. Ma noi lavoriamo dalla parte opposta».
La questura di Macerata, a ben guardare, non ha mai vietato il corteo di oggi, e nei giorni scorsi sul centro sociale Sisma si è scatenata una incredibile tempesta di fake news istituzionali quando dopo il famigerato appello del sindaco, le segreterie nazionali di Cgil, Anpi, Arci e Libera avevano deliberatamente parlato di annullamento della manifestazione. Infine il comunicato un po’ surreale della prefettura, arrivato nella tarda serata di mercoledì, nel quale si diceva che ogni corteo sarebbe stato vietato. Tesi poi ribadita dal ministro Minniti con una dichiarazione: il risultato è stato una gran confusione sui social network, con tante persone a chiedersi se alla fine si sarebbe fatto qualcosa o no a Macerata. Poi ieri pomeriggio la prefettura ha sciolto ogni riserva, nel prendere atto «dell’impegno degli organizzatori a garantire il carattere pacifico della manifestazione» ha decretato che «non esistono ragioni di ordine e sicurezza pubblica per un provvedimento di divieto»: è il via libera definitivo.
Già tre giorni fa il leader di Casapound Simone Di Stefano si è fatto la sua passeggiata elettorale in centro con tanto di cronisti al seguito, mentre giovedì sera è stata la volta di Roberto Fiore, accompagnato da una trentina di militanti di Forza Nuova. La nottata è stata piuttosto tesa: arrivati nella centralissima piazza della Libertà, i manifestanti di ultradestra sono entrati in contatto con gli agenti di polizia in assetto antisommossa. Risultato: sei contusi lievi e quattro fermati, mentre poco distante un pugno di antifascisti protestava gridando «assassini» e «terroristi» all’indirizzo di Fiore e dei suoi. La tensione si è sciolta nel giro di una mezz’ora.
Il clima non è dei migliori in città, e non soltanto perché per oggi è prevista una leggera pioggerella, in aggiunta alle consuete temperature rigide. Come in uno stanco gioco delle parti, diversi militanti locali del Pd continuano ad evocare lo spettro di una piazza violenta, chiedendo un non meglio precisato «rispetto» per una Macerata sconvolta dai fatti delle ultime due settimane. Rispettare la città, però, significa anche dire no al fascismo. E rispetto, d’altra parte, meritano anche Wilson Kofi, Omar Fadera, Jennifer Otiotio, Gideon Azeke, Mahamadou Toure e Festus Ogmabon. I sei ragazzi rimasti feriti dalla follia fascista di Luca Traini.

il manifesto e la Repubblica.
CHI ÈSCESO IN PIAZZA
CI HA SALVATO LA FACCIA E LA COSTITUZIONE
di Marco Revelli
Macerata ritorna umana. Nonostante il coprifuoco di un sindaco dal pensiero corto, che ne ha reso spettrale il centro storico. Nonostante il catechismo sospeso e le chiese chiuse da un vescovo poco cristiano. Nonostante gli allarmi, i divieti, le incertezze della vigilia. Nonostante tutto. Un’umanitá variopinta, consapevole e determinata, l’ha avvolta in una fiumana calda di vita, ritornando nei luoghi che una settimana prima erano stati teatro del primo vero atto di terrorismo in Italia in questo tormentato decennio. Un terrorismo odioso, di matrice razzista e fascista, a riesumare gli aspetti più oscuri e vergognosi della nostra storia nazionale.
Era un atto dovuto. La condizione per tutti noi di poter andare ancora con la testa alta. Senza la vergogna di una resa incondizionata all’inumano che avanza, e rischia di farsi, a poco a poco, spirito del tempo, senso comune, ordine delle cose. Un merito enorme per questo gesto di riparazione, va a chi, fin da subito, ha capito e ha deciso che essere a Macerata, ed esserci in tanti, era una necessità assoluta, di quelle che non ammettono repliche né remore. A chi, senza aspettare permessi o comandi, nonostante gli ondeggiamenti, le retromarce, le ambiguità dei cosiddetti «responsabili» delle «grandi organizzazioni», si è messo in cammino. Ha chiamato a raccolta. Ha fatto da sé, come si fa appunto nelle emergenze.
Il Merito va ai ragazzi del Sisma, che non ci hanno pensato un minuto per mobilitarsi, alla Fiom che per prima ha capito cosa fosse giusto fare, ai 190 circoli dell’Arci, alle tante sezioni dell’Anpi, a cominciare da quella di Macerata, agli iscritti della Cgil, che hanno considerato fin da subito una follia i tentennamenti dei rispettivi vertici.
Alle organizzazioni politiche che pur impegnate in una campagna elettorale dura hanno anteposto la testimonianza civile alla ricerca di voti. Alle donne agli uomini ai ragazzi che d’istinto hanno pensato «se non ora quando?». Sono loro che hanno «salvato l’onore» di quello che con termine sempre più frusto continua a chiamarsi «mondo democratico» italiano impedendo che fosse definitivamente inghiottito dalla notte della memoria. Sono loro, ancora, che hanno difeso la Costituzione, riaffermandone i valori, mentre lo Stato stava altrove, e contro.
Tutto è andato bene, dunque, e le minacce «istituzionali» della vigilia sono alla fine rientrate come era giusto che fosse. Il che non toglie nulla alle responsabilità, gravi, di quei vertici (della Cgil, dell’Arci, dell’Anpi…) solo parzialmente emendate dai successivi riaggiustamenti. Gravi perché testimoniano di un deficit prima ancora che politico, culturale. Di una debolezza «morale» avrebbe detto Piero Gobetti, che si esprime in una incomprensione del proprio tempo e in un’abdicazione ai propri compiti.
Non aver colto che nel giorno di terrore a Macerata si era consumata un’accelerazione inedita nel degrado civile del Paese, col rischio estremo che quell’ostentazione fisica e simbolica di una violenza che del fascismo riesumava la radice razzista, si insediasse nello spazio pubblico e nell’immaginario collettivo, fino ad esserne accolta e assimilata; aver derubricato tutto ciò a questione ordinaria di buon senso, o di buone maniere istituzionali accogliendo le richieste di un sindaco incapace d’intendere ma non di volere, accettando i diktat di un ministro di polizia in versione skinhead, facendosi carico delle preoccupazioni elettorali di un Pd che ha smarrito il senno insieme alla propria storia e rischiando così di umiliare e disperdere le forze di chi aveva capito…
Tutto questo testimonia di una preoccupante inadeguatezza proprio nel momento in cui servirebbe, forte, un’azione pedagogica ampia, convinta e convincente. Un’opera di ri-alfabetizzazione che educasse a «ritornare umani» pur nel pieno di un processo di sfarinamento e di declassamento sociale che della disumanità ha ferocemente il volto e che disumanità riproduce su scala allargata. Quell’ opera che un tempo fu svolta dai partiti politici e dal movimento operaio, i cui tardi epigoni ci danzano ora davanti, irriconoscibili e grotteschi.
Negli inviti renziani a moderare i toni e a sopire, mentre fuori dal suo cerchio magico infuria la tempesta perfetta, o nelle esibizioni neocoloniali del suo ministro Minniti, quello che avrebbe voluto svuotare le vie di Macerata delle donne e degli uomini della solidarietà allo stesso modo in cui quest’estate aveva svuotato il mare delle navi della solidarietà, quasi con la stessa formula linguistica («o rinunciate voi o ci pensiamo noi»).
Il successo della mobilitazione di ieri ci dice che di qui, nonostante tutto, si può ripartire. Che c’è, un «popolo» che non s’è arreso, che sa ancora vedere i pericoli che ha di fronte e non «abbassa i toni», anzi alza la testa. Ed è grazie a questo popolo che si è messo in strada, se del nostro Paese non resterà solo quell’immagine, terribile e grottesca, di un fascista con la pistola in mano avvolto nel tricolore.
il manifesto
«IRRIDUCIBILI DELLA DEMOCRAZIA»
UNA SINISTRA UNITA SENZA I PARTITI
di Luca Pakarov
«Presenti i centri sociali da tutta Italia. Bus cancellati, allarmi assurdi dei quotidiani locali, negozi sbarrati. Ma è stata una festa di popolo»
La risposta di Macerata, ma di quasi tutta l’Italia antifascista e antirazzista, c’è stata. I km dell’anello che circonda le mura medievali della città hanno manifestato quasi 20mila persone. Qualcosa che non si era mai visto e che ha rotto l’isolamento di una piccola provincia.
In una mattina gelida e senza sole, già dalle 11 è cominciato l’assembramento ai giardini Diaz, con i ragazzi dei centri sociali che organizzavano il servizio d’ordine e distribuivano volantini. Visto lo spazio ristretto della piazza davanti al parco, man mano che arrivavano i pullman da ogni parte d’Italia la testa del corteoavanzava, fino a fermarsi in viale Trieste. Da lì, allle 15 è partito, in un clima finalmente disteso e gioioso. Un paio d’ore di di musica e colori, benefica decompressione, in cui tutti quelli che hanno deciso di partecipare sono riusciti a liberarsi delle tensioni accumulate nella settimana.
Tutto il contrario di come era stato prospettato dai quotidiani locali, ancora ieri in prima pagina con titoli allarmistici, come «Barricati» o «Strade deserte e clima da coprifuoco» e le foto dei pochi che, al pari dell’arrivo di un ciclone, avevano bollato con tavole di legno l’ingresso delle loro attività. Quelli aperti sono stati sì presi d’assalto, ma dai clienti. Le forze dell’ordine con una presenza massiva ma defilata e mai invasiva, hanno serrato gli accessi al centro storico evitando ogni tipo di contatto.
Le scuole erano state chiuse, i mezzi pubblici fermati e le arterie principali interdette al traffico, un’ordinanza vietava la somministrazione di bevande in bottiglie di vetro. Una serie di misure che a un abitante non avvezzo alle grandi manifestazioni aveva fatto pronosticare il peggio, così già da ieri sera le strade erano vuote e i parcheggi liberi. Chi individualmente o con le basi di gruppi di appartenenza come Libera, Anpi, Cgil e Arci che hanno deciso a un certo punto di partecipare, hanno spinto il motore di questa giornata rappresentato dai centri sociali, arrivati con quasi 50 pullman. Una risposta, la loro, immediata e unanime, a cui poi si sono unite tutte le sigle, a partire dalla Fiom.
Egidio del centro sociale Insurgencia di Napoli è chiarissimo: «Questa è una chiamata per gli irriducibili della democrazia. Quello che è accaduto dopo l’attentato terroristico di Macerata è imbarazzante, le forze politiche e le organizzazioni di categoria non si sono dimostrate all’altezza rispetto al fenomeno del fascismo e del razzismo dilagante in questo paese».
Una festa di civiltà e rispetto, dove c’è stata una scelta precisa, quella di non avere un palco finale né di annunciare chi, dai microfoni della testa del corteo, ha parlato in nome dell’antifascismo. Nessun nome, come per un po’ sono state le vittime di Traini. Da quei microfoni si sono levate tante voci di resistenza che hanno preso di mira soprattutto il ministro Marco Minniti e il sindaco. Si è trattata di una piazza multirazziale, composita e eterogenea nel rivendicare le colpe di chi la voleva far tacere.
Ai più è sembrato uno spartiacque fra la sinistra partitica e quella che cerca di lavorare sul territorio, Jacopo del centro sociale Rivolta di Marghera ci dice: «Da noi il razzismo è il pane quotidiano. La cosa assurda è che chi governa la nostra regione ha additato prima al sud e poi ai migranti le colpe della crisi economica. Nei nostri territori la sinistra partitica ha dimostrato la sua inadeguatezza nel rispondere ai problemi dei cittadini, i centri sociali sono rimasti presenti nel territorio e siamo vicini ai cittadini nella questione della casa o studentesche».
Un concatenarsi di storie, come quella di Mamadou Sy del Movimento dei Migranti e dei Rifugiati di Caserta e presidente dell’Associazione dei Senegalesi, da 16 anni in Italia che ci racconta le similitudini con i 6 migranti uccisi a Castel Volturno nel 2008: «Dopo 10 anni è la stessa situazione, con la difficoltà di far capire chi siamo, le nostre storie o che lavoro facciamo».
Un segnale però sembra partito, e proprio da dove non te lo aspetti, Macerata.
Abbiamo distrutto la dicotomia fascismo/antifascismo violento. Il messaggio oscuro di Minniti è stato letteralmente disintegrato. Nando, del centro sociale Pedro di Padova sintetizza così: «Non c’entrano la grandezza della città ma i ruoli che i centri sociali hanno assunto nelle varie fasi storiche. Oggi siamo riusciti a distruggere quella dicotomia fascismo/antifascismo violento, sorta a causa delle imposizioni di Minniti. Un messaggio oscuro che è stato letteralmente disintegrato».
Si sono visti fra gli altri Adriano Sofri, Cecile Kyenge, Sergio Staino, Gino Strada di Emergency o Pippo Civati (Leu), ma la metafora più calzante sullo stile di fare politica forse è stata la presenza della novantenne partigiana Lidia Menapace (candidata con Potere al popolo: «Fino a quando ho voce e forza preferisco stare in mezzo alle persone che capiscono il mondo in cui stiamo»), arrivata da Bolzano, e l’assenza del primo cittadino Romano Carancini, che da casa sua a pochi metri ha dichiarato di esserci col cuore.
PPIAZZE ANTIRAZZISTE IL PD RESTA AI MARGINI
E DISORIENTA LA BASE
di Alessandra Longo
«Dopo il raid contro gli immigrati. Centri sociali e associazioni di solidarietà trainano le manifestazioni In 20mila a Macerata con slogan anti Minniti. A Milano anche Fiano»
Macerata. È il giorno della piazza che divide e disorienta la sinistra in tutta Italia. Macerata è l’epicentro della lacerazione. Una città blindata che non partecipa fisicamente alla manifestazione contro il fascismo e il razzismo. Le finestre sono chiuse, i negozi hanno le porte protette dal compensato come per gli uragani in America. Ventimila, trentamila persone sfilano dai giardini Diaz, là dove lo spaccio si consuma vicino alle giostre per i bambini. Un fiume di militanti, centri sociali, anarchici, la Fiom, ma non la Cgil, Libera, Emergency con Gino Strada, i Cobas, Potere al Popolo con Lidia Menapace che tiene lo striscione a 94 anni, i comunisti con Marco Ferrando, i leninisti di Che fare (scatenati contro «la stampa di regime»), i deputati di Leu Civati, Fratoianni e Zoggia, segmenti di Arci, partigiani locali e l’Anpi di Roma, contraria all’assenza decisa dall’Anpi nazionale, i neri, regolari e non, l’ex ministra Kyenge, gli studenti, i vecchi di Lotta Continua che riabbracciano Adriano Sofri e a qualcuno vengono le lacrime.
Ma il Pd non c’è. Il Pd è il grande assente. Non solo a Macerata ma anche a Milano dove altri ventimila, soprattutto giovani, occupano la piazza ed Emanuele Fiano, promotore Pd della legge sul divieto di propaganda fascista, si materializza quasi timidamente. C’è anche Pierfrancesco Majorino. Li conti sulle dita di una mano. È Laura Boldrini a tenere banco: « Non c’è posto per l’apartheid in Italia. Mi fa piacere ci siano Fiano e Majorino, ma il Pd ha sbagliato a non esserci » . E poi una frecciata ad Emma Bonino: « Come fa a stare col Pd che non ha voluto lo Ius soli?». A Palermo il sindaco Orlando sfila sotto le bandiere di Cobas, Arci e Anpi.
Su temi come l’antifascismo, potevano essere assieme. Ecco, a Macerata, Sergio Staino: « Doveva esserci una grande manifestazione repubblicana ma il Pd, che è l’asse di riferimento, ci ha spiazzati tutti ». Nei più vecchi militanti c’è sofferenza per la scelta del vertice di lasciare vuoto il campo. Alvaro, 74 anni, iscritto all’Anpi di Cerreto Desi, si guarda intorno: «Non c’è il Pd, non ci sono i compagni dell’Anpi nazionale. Provo un sentimento, strano, confuso » . Forse lo stesso sentimento che porta all’abbraccio tra Vasco Errani, passato a Leu, e Gianni Cuperlo. Loro sono a Bologna, altro sit in in questa giornata difficile. Cuperlo è amaro: «Dividere le piazze sull’antifascismo è l’errore più grave che possiamo fare». Però ormai è andata così. E i giovani che sfilano sotto le Mura Urbiche di Macerata sfogano la loro rabbia contro Marco Minniti. Gli danno del “nazista”, della “ testa d’uovo”. Portano cartelli del tipo Minniti=Cossiga, Minniti fascisti garantiti. Molto più rari gli slogan a pennarello contro la Lega. Uno dice : “Salvini fascista”. Se la prendono più volentieri con il sindaco Pd di Macerata Romano Carancini che aveva chiesto, per la sua comunità choccata, una pausa di silenzio e riflessione. E quasi ignorano Pamela uccisa, Pamela fatta a pezzi e chiusa in due valigie. Lei è il non detto, lo sfondo macabro da cui è partito tutto.
Macerata città non c’è, si blinda, i fiori alle finestre, la pace perduta. Non è un corteo dove ci sono le famiglie, è un corteo “politico”, che parla all’Italia e non alla città. Sofri la spiega così: «Hanno spaventato la gente con l’allarme su possibili disordini. Avrei voluto telefonare a Renzi e dirgli: “Vieni in incognito ma vieni”» . Fratoianni, la giacca d’ordinanza con su scritto “parlamentare antifascista”, mette sale sulla ferita: «Questa è una sconfitta per il Pd, la sua scelta di non esserci è stata incomprensibile» . Da un comizio a Porto Torres, il capogruppo dei senatori dem Luigi Zanda cerca una connessione con i manifestanti: «Il fascioleghismo di Salvini ha prodotto gli spari razzisti di Macerata e non possiamo sottovalutarlo».
Certo, con il Pd sarebbe stata una manifestazione diversa, forse senza slogan isolati ma indegni come quello scandito da un centro sociale del Nord Est: “Ma che belle sono le foibe da Trieste in giu”. O come l’orrendo coro già usato dopo il delitto Mattei e risentito ieri: “I covi dei fascisti si chiudono con il fuoco; con i fascisti dentro sennò è troppo poco”.
Le parole pesano, dice Susanna Camusso, con Matteo Orfini alla manifestazione di Roma per le foibe, a Tor Bella Monaca: «L’attentato terrorista va chiamato con il suo nome». La giornata è difficile: a Piacenza gli antagonisti vanno all’assalto di CasaPound, cinque carabinieri feriti; a Torino sassi contro la polizia. Ma a Macerata, presidiata come per un G8, fila tutto liscio. Ulderico Orazi, consigliere comunale del Pd a Macerata, e titolare del bar di fronte al monumento ai caduti dove si è consegnato il pistolero filoleghista Luca Traini, guarda scorrere il fiume in piena dei manifestanti e si sente contento di aver sparigliato: «Sono qui con orgoglio piddino». Renziano, fa finta di non sentire quello che dice un “compagno” con l’altoparlante: «Caro Renzi, stai delirando tu e il tuo partito. Altro che silenzio. Noi siamo qui a manifestare!il» . A sera, Elena, una giovane mamma di Terni, dà il biberon ad Edera, 4 mesi. Non ha avuto paura di portarla qui, così piccola? « Mi fa paura altro, la direzione che sta prendendo questo Paese».
 Parliamo di foibe e di popolazioni ma, a differenza di Sergio Mattarella, presidente della nostra Repubblica, ne parliamo in un'ottica libera da ogni traccia di ipertrofia nazionalistica
Parliamo di foibe e di popolazioni ma, a differenza di Sergio Mattarella, presidente della nostra Repubblica, ne parliamo in un'ottica libera da ogni traccia di ipertrofia nazionalistica
Fu negli anni del secondo governo Berlusconi che il Parlamento italiano approvò la legge 30 marzo 2004, n.92,
«Istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti
degli infoibati». Le foibe, l’esodo giuliano-dalmata: due espressioni su cui giova riflettere, ancora una volta.
Il 9 febbraio scorso il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, intervenendo solennemente sul ricordo tragico delle foibe, ha parlato anche lui (l’aveva già fatto anni fa il suo predecessore Giorgio Napolitano) degli eventi accaduti a oriente delle frontiere dell’Italia negli anni 1943-1945. Mattarella ha detto: «Capitolo tragico, violenza ingiustificabile. Alla durissima occupazione nazi-fascista di queste terre, nelle quali un tempo convivevano popoli, culture, religioni diverse, seguì la violenza del comunismo titino, che scatenò su italiani inermi la rappresaglia, per un tempo molto lungo: dal 1943 al 1945»
E ha proseguito: «Le stragi, le violenze, le sofferenze patite dagli esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati non possono essere dimenticate, sminuite o rimosse. Esse fanno parte, a pieno titolo, della storia nazionale e ne rappresentano un capitolo incancellabile, che ci ammonisce sui gravissimi rischi del nazionalismo estremo, dell'odio etnico, della violenza ideologica eretta a sistema».
Le Foibe
Domandiamoci intanto che cosa sono le “foibe”, una parola che ha assunto un significato truce, una parola adoperata come un manganello chiodato per colpire slavi e comunisti.
Le foibe sono, geomorfologicamente, voragini di varia ampiezza e profondità caratteristiche dei territori carsici, come in parte dell’Italia nordorientale e della Slovenia. Sono state usate, nell’Europa contadina e silvo-pastorale, come qualunqua altro fosso o dirupo nascosto nella boscaglia e nella campagna: un luogo nel quale nascondere i rifiuti domestici o del lavoro, le carogne degli animali, e occasionalmente i cadaveri dei briganti sorpresi e vinti e dei nemici ammazzati in duelli o un agguati. È evidente che sono state largamente utilizzate nei momenti delle più cruente guerre civili.
Le foibe sono divenute negli ultimi decenni il simbolo di un tragico capitolo della nostra storia. Un capitolo che non si comprende (e anzi se ne rovescia il senso) se lo si guarda e valuta con l’occhio di una sola delle vittime. Chi vuole comprendere che cosa furono davvero le foibe, come e da chi vi gettarono persone vive o cadaveri, legga la documentatissima e rigorosa narrazione della storica Claiudia Cernigoi, una volta disponibile su eddyburg, ora raggiungibile in un volume cartaceo oppure online: Clara Cernigoi, Operazione foibe a Trieste.
Le popolazioni
Il presidente della Repubblica italiana, quando oggi ricorda «la grande sofferenza delle popolazioni istriane, fiumane, dalmate e giuliane» dovrebbe ricordare anche le ancor più grandi sofferenze patite, prima del 1943, dalle popolazioni della Slovenia, della Croazia, del Montenegro e inflitte con indicibile crudeltà da chi portava quella stessa bandiera tricolore che oggi distingue la nostra Repubblica.
Dovrebbe ricordare le stragi di popolazioni inerme, di interi paesi e villaggi rei di ospitare popolazioni slave. La bandiera tricolore la impugnavano gli sgherri italiani agli ordini del generale Mario Roatta, il quale, posto a capo delle truppe italiane dal governo italiano emanò, l’ordine: «non “dente per dente”, ma “testa per dente”»: per ogni colpo sparato da un partigiano slavo contro un italiano, ammazzate lo slavo, anche se l’italiano appartiene all’esercito invasore che sta trucidando la sua famiglia, saccheggiando il suo patrimonio, bruciando le sua case e i suoi villaggi.
Dovrebbe sapere, e ricordare, che tra il 1941 e il 1943 nella provincia di Trieste furono bruciati per rappresaglia contro i partigiani sloveni e italiani i paesi di Mavhinje-Malchina, Čerovlje-Ceroglie, Vižovlje-Visogliano, Medjevaš-Medeazza, Mačkovlje-Caresana, Gročana-Grozzana. Dovrebbe sapere che in quegli anni decine di partigiani sloveni (la Slovenia era stata inghiottita dall’Italia fascista come provincia di Lubiana) furono impiccati o fucilati o avviati nelle camere a gas.
L’occupazione manu militari dei territori e dei popoli slavi era stata accompagnata da una massiccia e penetrante campagna propagandistica. Si vedano in proposito i materiali esposti nella mostra “Testa per dente”. La prima cosa che balza agli occhi, è una frase di Benito Mussolini pronunciata a Pola nel 1922: «Di fronte a una razza inferiore e barbara come quella slava non si deve seguire la politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone. I confini dell’Italia devono essere il Brennero, il Nevoso e le Dinariche: io credo che si possono sacrificare 500.000 slavi barbari per 50.000 italiani»
Un annuncio, quello di Mussolini, cui più tardi seguirono i fatti. L’Italia savoiarda e fascista si è impegnata, a partire dagli anni Venti del secolo scorso (quindi ben prima della Germania di Hitler) in una penetrante operazione di cancellazione di ogni elemento della cultura e dell’identità slovena, croata, montenegrina (in una parola, slava). A partire dalla toponomastica, dalla lingua insegnata e parlata negli asili e nelle scuole (50 scuole slovene erano state chiuse), dai nomi e cognomi degli impiegati pubblici e privati (un volume di 350 pagine conteneva l’elenco di 3mila cognomi da cambiare Un migliaio di circoli culturali, assistenziali, sportivi e ricreativi sloveni e croati furono chiusi, e i patrimoni assegnati a destinatari italiani.
Il primo episodio vistoso riguardò ovviamente la cultura: nel luglio 1920 fu bruciato dai fascisti il Centro sloveno di cultura di Trieste
Mistificazione continua.
I rapporti tra l'Italia e le popolazioni slave sono stati spesso occasioni di mistificazioni. Attribuire agli sloveni o ai croati delitti o stragi o altre forme di annullamento delle persone o delle cose fu prassi consolidata. Qualche volta fu clamorosamente smentita nel momento stesso in cui avveniva. La disavventura capitò una volta a Bruno Vespa.
Nel corso di un dibattito a più voci nella trasmissione "Porta a porta" Vespa mostrò un'immagine fotografica che rappresentava la fucilazione alla schiena di un gruppo di persone, presentandola come un'esecuzione, compiuta dai comunisti jugoslavi, di un gruppo di partigiani italiani. Uno storico presente all'incontro ebbe buon gioco nel dimostrare che si trattava, all'opposto, di civili sloveni fucilati da ben riconoscibili (in altre foto) militari italiani. Come spiegò più tardi il giornalista Michele Smargiassi sul sito "Fotocrazia, nel quale si riportano anche i nomi delle vittime, tutte slovene.
Per concludere, tutto quello che abbiamo sommariamente ricordato lo abbiano tratto dalla lettura del libro di Claudia Cernigai, dell'archivio di
eddyburg o dal sito web
10 febbraio. Consigliamo caldamente la lettura di quest'ultimo per chi non vuol essere accusato come (per adoperare le parole di Sergio Mattarella), di «nazionalismo estremo, dell'odio etnico, della violenza ideologica eretta a sistema», vizi dai quali lui stesso non ci sembra essere del tutto esente.
piccolo campionario delle nefandezze dell'Italia in Slovenia e Croazia

il manifesto,
Male ha fatto il sindaco di Macerata Carancini a chiedere la sospensione di tutte le manifestazioni, come se fossero uguali. Non lo sono affatto. Quelle che presidiano i valori democratici, che protestano contro un vile attacco fascista alla convivenza civile, hanno un valore positivo. Un valore che manca in quelle di segno opposto, che inneggiano alla violenza come strumento risolutore del disagio e del conflitto sociale. Le prime sono a difesa della Costituzione, le seconde la attaccano. E non si può applicare alla Costituzione il concetto che certe questioni si sottraggono alla politica, e non sono - come a qualcuno piace dire - né di destra né di sinistra.
La Costituzione non è mai indifferente. Al contrario è in servizio permanente effettivo - come direbbe il ministro Minniti - per le libertà, i diritti, l’eguaglianza, la tolleranza, la solidarietà, la pace. E a tutto questo un sindaco, tenuto per l’art. 54 a osservare la Costituzione e le leggi e ad esercitare la sua funzione con “disciplina ed onore”, è obbligato a essere sensibile, che gli piaccia o no. Diversamente, si dimetta.
Per questo, c’è chi non condivide la decisione di Anpi, Cgil, Arci e Libera di accettare la richiesta del sindaco. Sono organizzazioni vicine al cuore di molti di noi, e non dubitiamo che la decisione sia stata sofferta. Ma è legittimo il dubbio che proprio l’eccezionalità delle circostanze, e la gravità dell’accaduto, avrebbero consigliato la scelta opposta. Essere un presidio essenziale della democrazia nel nostro paese - come indubbiamente quelle organizzazioni sono - impone un particolare carico di responsabilità. Una bocciofila o un club del golf avrebbero bene il diritto di non vedere, non sentire, non parlare, per non turbare la serenità dei soci. Non è così per loro.
Veniamo al ministro Minniti.
Capiamo bene che vuole costruire l’immagine di uomo forte del centrosinistra, capace di iniziative efficaci sul terreno incandescente della sicurezza. Che abbia o meno disegni futuri sulla poltrona più alta di Palazzo Chigi non interessa. Intanto, capiamo la valenza elettorale per un centrosinistra che insegue con affanno i voti perduti. Capiamo, ancora, che il tema sicurezza è comunque centrale e che anche la sinistra deve darsene carico, se non vuole ridursi in una nicchia irrilevante per il futuro del paese. Ma questo non giustifica ricostruzioni di fantasia e stravolgimento di fatti.
Minniti ci informa di aver fermato gli sbarchi proprio per la previsione che un caso Traini potesse verificarsi. Ma è banale la constatazione che averli “fermati” non ha prevenuto o impedito il caso Traini. E se poi l’aveva previsto, perché non ha adeguatamente aumentato la vigilanza su chi era lecito sospettare avrebbe potuto causare problemi? Non aveva forse avvertito crescere nel paese un clima pericoloso, non aveva percepito i rigurgiti fascisti?
Ci dice che l’accordo con le autorità libiche è un patrimonio del paese. Sappia che rifiutiamo un patrimonio intriso di sangue, torture e morte nei lager libici. Ci dica piuttosto qual è la sua soluzione, se la politica delle espulsioni non funziona. Essendo del tutto ovvio che non si fermano le migrazioni di masse di disperati in fuga dalla guerra, dalla fame, dalla morte schierando manipoli di soldati sulle rotte dei mercanti di carne umana.
Infine, il ministro apprezza la cancellazione della manifestazione, e annuncia che interverrà contro chi non dovesse seguire il buon esempio. A chi si rivolge davvero? Intanto, la sua vasta esperienza politica certo gli dice che proprio le sue parole possono aumentare la tensione. Dovrebbe poi sapere che le riunioni non si vietano preventivamente, e a prescindere. La formulazione dell’art. 17 della Costituzione non è affatto casuale, e gli consigliamo una rilettura. Cosa intende fare? Mandare cingolati e forze antisommossa nelle piazze d’Italia, a tutela della pubblica tranquillità?
Una pacifica dimostrazione di massa non è solo l’esercizio di diritti costituzionalmente protetti, fondamentali in un sistema democratico. È anche il migliore antidoto contro il veleno sparso da chi cinicamente sfrutta le paure profonde di una parte del paese per guadagnare un pugno di voti. Anche questa è una violenza contro la Costituzione. E ci aspettiamo che un ministro della Repubblica sia in trincea per fermarla.
la Stampa
«Dai social solidarietà al naziskin accusato di strage»
Lo hanno applaudito al passaggio per i corridoi del carcere, Luca Traini. I detenuti italiani, ovviamente, non tutti. E lui s’è impettito. Orgoglioso di quello che ha fatto. Altro che «gesto folle di un fascista che ha infangato il tricolore», come sosteneva ieri il ministro Andrea Orlando, in visita ai feriti di Macerata. No, Traini per tanti è ormai un eroe.
Sembra davvero aver scoperchiato i sentimenti più segreti di una parte d’Italia, questo naziskin dall’aria truce. In tanti solidarizzano. Non soltanto sui social, ma anche nelle strade. E il suo avvocato Giancarlo Giulianielli è il primo a esserne sbalordito. Due giorni fa l’ha chiamato un normale cittadino da una cittadina della civile Toscana, e ha chiesto come fare a collaborare alle spese della sua difesa. Anche diversi gruppi dell’estrema destra dichiarano di essere pronti a pagarne le spese legali. Giulianielli, correttamente, ha informato il suo assistito di queste iniziative. Gli ha chiesto: che vuoi fare? E Traini, che si è detto onorato di riscuotere tanto consenso, ha risposto: «Che diano tutto alle famiglie bisognose. Ma che siano famiglie italiane».
Si sentono i suoi dieci anni di militanza nei gruppi più estremi, quelli che già da tempo fanno raccolte di cibo a favore dei poveri, alla maniera dei neonazisti greci di Alba Dorata. Al sostituto procuratore Stefania Ciccioli, Traini ha raccontato la sua vita di adolescente emarginato e triste, con una difficile storia familiare, che a 17 anni trovò finalmente un gruppo dove sentirsi spalleggiato. La sua prima manifestazione, un raduno di Forza Nuova ad Ascoli. Ma poi di queste iniziative ce ne sono state tante. L’innamoramento per la Lega e per Matteo Salvini è storia recente.
Brutti sporchi e cattivi, in genere i naziskin si vantano di essere diversi dalla brava gente borghese. Traini non fa eccezione. Sulle nocche delle mani si era fatto tatuare la parola inglese «Outcast». Significa: emarginato. Così come farsi tatuare sulla tempia la runa celtica: a un certo punto ha intrapreso un percorso di non ritorno. E se ora in tanti a Macerata s’interrogano su come sia stato possibile, Luca Traini evidentemente aveva varcato la sua linea d’ombra. Non per caso, se fino a un anno fa in palestra lo chiamavano «Big John» e lui ci stava a questo ruolo abbastanza inoffensivo, e con gli amici il massimo dell’esagerazione era mangiare 10 hamburger al fast food, ora aveva preso a farsi chiamare «Lupo». Un percorso verso il precipizio che in palestra era stato ben percepito. La storia era davvero diventata un’altra. E ora? «Siccome si sente orgogliosamente un emarginato tra gli emarginati - racconta il suo legale - dice che il carcere non gli sta stretto. Anzi, lo sente come se fosse casa sua». Un successo.

il manifesto, il Fatto Quotidiano,
il
DESTRA IN PIAZZA
SINISTRA A CASA
di Norma Rangeri
Ad essere sinceri, la campagna elettorale non è entusiasmante né coinvolgente. Semmai, il contrario. Tuttavia qualcosa viene a galla in questi giorni, e risalta più che nel recente passato: è quella parte di Italia razzista, fascista e abusivista. Che viene sostenuta, esaltata, alimentata dal peggiore centrodestra degli ultimi anni. I suoi leader cercano di strappare voti, ma non agli avversari quanto agli alleati di coalizione, per guidare le danze dopo il 4 marzo.
L’appello all’abusivismo del pregiudicato (perché condannato fino in Cassazione per frode fiscale), Silvio Berlusconi, dà il tocco da maestro allo schieramento di un centrodestra che combatte la sua battaglia elettorale purtroppo dettando l’agenda. Questi campioni di un Italia nefasta, violenta, corrotta sono i portabandiera dei peggiori umori e «sentimenti» del belpaese.
I fascisti, o fascistelli, hanno ben rialzato la testa. Da qualche tempo a Ostia e in altri territori dove criminalità, violenza e degrado sociale sono dominanti. Ma i fatti di Macerata dimostrano che anche in situazioni meno marginalizzate, gli xenofobi di Salvini hanno tolto i freni e grufolano dentro la caccia all’immigrato.
Questa destra è la stessa che nei social, nella pancia della società incivile, ispira la persecuzione di una donna di sinistra – Laura Boldrini – diventata il bersaglio di uno stupro mediatico ormai quotidiano. La violenza è totalmente sdoganata sul piano del linguaggio, oltreché, purtroppo su quello della cronaca.
In questa deriva fascistotide è netta l’impressione che manchi una risposta di forte contrasto. Perché se di Macerata il leader a 5 Stelle preferisce «non strumentalizzare», sugli immigrati il governo – e quindi il Pd – non è stato capace di una risposta alta, non difensiva. Certo è che se Renzi dice «aiutiamoli a casa loro » e con il ministro Minniti che mette in pratica la linea del Nazareno, il leader del Pd non sa come distinguersi da Di Maio, Salvini e Berlusconi. E non lo fa nemmeno sulle vicende di Macerata, dove il «fronte democratico» si sfila dalla manifestazione in programma e, a cominciare dal sindaco piddino, obbedisce a Renzi che invita a starsene a casa. (Del resto nulla di nuovo. Ricordiamo quel che accadde con Veltroni ancora sindaco nel 207 prima della campagna elettorale che approderà nel 2008 con l’elezione della destra di Alemanno. Una donna fu uccisa da un rumeno e il governò varò un decreto ad hoc, incostituzionale, contro gli immigrati rumeni).
In questa situazione i 5Stelle stanno alla finestra, convinti di essere i vincitori morali della campagna elettorale se si confermeranno il primo partito. E se riusciranno a prendere una parte dei voti in libera uscita che, stando ai sondaggi, potrebbero essere proprio quelli del Pd. Sono diventati europeisti (una giravolta sorprendente), sull’immigrazione dicono le stesse cose di Minniti, e martellano sul reddito garantito.
Come risulta evidente, lo spazio per una campagna elettorale di sinistra, capace di battere un colpo e farsi sentire su temi che non siano la sicurezza, è ridotto. Se non era per i braccialetti di Amazon, il tema del lavoro non avrebbe bucato lo schermo negli ultimi giorni. Noi non siano la Germania, ma non sempre questo significa che sappiamo fare meglio. Il contratto dei metalmeccanici potrebbe essere un ottimo spunto per parlare di salario e orario di lavoro, della condizione sociale drammatica della disoccupazione, delle nuove povertà che hanno la brutta faccia della diseguaglianza.
Ma intanto l’Italia canta. Mancano nemmeno quattro settimane al voto e va in onda Sanremo che raccoglie il 52% dell’audience. In buona parte merito del ciclonico Fiorello che ha messo in scena il giochino del voto. Per chi votate?, ha chiesto alla platea il recordman di ascolti. Poi ha nominato il Pd, il centrodestra, i 5Stelle e «liberi e belli», ha detto scherzando con il pubblico. Una battuta per dire che nella cabina elettorale c’è un po’ di tutto. Grasso, il cui faccione di bell’uomo tranquillo spicca sui manifesti per strada, questa volta ha azzeccato la risposta: «Grazie Fiorello, vuol dire che oltre che liberi e uguali siamo anche belli». E speriamo che, prima e dopo il 4 marzo, siano anche forti.
il Fatto Quotidiano
MACERATA
PD E ANPI MOLLANO
E OGGI ARRIVA FORZA NUOVA
di Pierfrancesco Curzi
La manifestazione - Sinistra divisa, anche Cgil e Libera rinunciano a sfilare contro l’estrema destra. Ieri CasaPound in piazza con la scorta
Il magico mondo della sinistra italiana si è diviso sui fatti traumatici di Macerata. Il Pd, da Roma, ha spinto i suoi all’annullamento della grande manifestazione del popolo della sinistra, organizzata per sabato pomeriggio in citàà. A segno l’appello del sindaco di Macerata, Romano Carancini: “Ero fiducioso che le forze democratiche ed antifasciste – ha detto il primo cittadino Pd – avrebbero saputo ascoltare la voce della città. La sospensione dimostra la sensibilità verso una comunità che intende rialzarsi e tornare ad essere se stessa dopo le ferite subite. Fermarsi a respirare non significa rinunciare a combattere per i valori”.
Resta da capire di quale voce stia parlando Carancini, dietro al cui messaggio sembra esserci la regia di Matteo Renzi. Al sindaco l’ordinaria amministrazione, ai vertici, specie in una fase pre-elettorale, la strategia sul “caso Macerata”: il tiro al bersaglio con la pistola contro gli immigrati (sei feriti, uno più grave ma fuori pericolo) scatenato da un ex candidato leghista con tatuaggi neonazisti che voleva “vendicare” la 18enne Pamela Mastropietro, la cui morte è ancora un mistero mentre un pusher nigeriano resta in carcere per l’atroce vilipendio del suo cadavere, in mancanza di indizi precisi sull’omicidio.
La presa di posizione del Pd ha diviso il fronte della sinistra. Senza scalfire la controparte di destra, piuttosto estrema. Nessun divieto da parte della polizia. Ieri CasaPound, stasera Forza Nuova e la sua iniziativa: “Di immigrazione si muore”. Il Partito democratico si è portato dietro sigle, organizzazioni e movimenti, lasciando da sola la sinistra radicale e antagonista. Una spaccatura inattesa. La manifestazione di sabato resta in cartellone ma senza i vessilli di Pd, Cgil, Arci, Libera e soprattutto dell’Anpi, che martedì sera ospitava l’assemblea generale in vista di sabato. Liberi e uguali, dopo l’iniziale adesione, ne sta discutendo ma gli esponenti locali sono per rinunciare. Gli ambienti più a sinistra, tra anarchici, formazioni studentesche, autonomi e così via, la vedono così: “Eravamo stati chiari – dicono gli antagonisti –, niente vessilli di partito o di tendenza politica. Questa la spaccatura. Sembra che senza Pd, Cgil e associazioni collegate non si possa fare nulla, è l’esatto contrario. Loro non ci comandano, per questo abbiamo deciso di confermare la manifestazione, fissata per il primo pomeriggio a Macerata. Ci sono decine di pullman in arrivo dalle Marche e dal resto del Paese”.
All’assemblea dell’altra sera erano presenti i responsabili locali del Pd, tra cui il coordinatore regionale, Francesco Comi. Nella sede dell’Anpi anche i rappresentanti di Potere al Popolo: “Noi ci saremo sabato – precisa Maurizio Acerbo, leader di Rifondazione comunista e candidato del neonato movimento politico –. Dispiace apprendere che diverse sigle abbiamo deciso di non partecipare. Rinunciare significa darla vinta a chi vuole un clima di paura”.
Ieri, intanto, CasaPound ha svolto la sua iniziativa politica a Macerata, con tanto di corteo di un centinaio di persone blindato dalla polizia in assetto antisommossa, alla presenza del segretario nazionale, Simone Di Stefano: “Non sono a favore, ma di fronte a certi crimini efferati, come la morte di Pamela Mastropietro, la pena di morte potrebbe essere una liberazione”.
I fatti di Macerata suscitano reazioni diverse. Il vescovo della città, Nazzareno Marconi ha invitato tutti ad una preghiera, insieme alle comunità protestanti, ortodosse, islamiche ed ebraiche. A Roma invece, vicino al Colosseo, gli antagonisti hanno piazzato un manichino a testa in giù con una croce celtica e una scritta: “Minniti e fascisti la vostra strategia della tensione non passerà”. Ieri, forse anche per distinguersi dal Pd, il guardasigilli, Andrea Orlando, ha fatto visita ad alcuni degli africani feriti, uno dei quali, un ghanese ferito ad una gamba, è scappato dall’ospedale.
MACERATA
LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE NON SI FARÀ
LO CHIEDE IL SINDACO
di Mario Di Vito
Retromarcia. Anpi, Arci, Cgil e Libera revocano la convocazione antifascista indetta per sabato. Il centro sociale Sisma: noi andremo in piazza. L’appello di Carancini per fermare i cortei in una città blindata tra comizi di Casapound e Forza Nuova. Il ministro Orlando in ospedale dalle vittime della sparatoria
Alla fine la Macerata antifascista scenderà in piazza comunque, sabato pomeriggio. La decisione è stata presa nel tardo pomeriggio di ieri, ai margini di una giornata segnata dalla clamorosa retromarcia di Cgil, Anpi, Arci e Libera, che invece hanno scelto di non aderire alla manifestazione nazionale contro il fascismo e i razzismo, convocata dal centro sociale Sisma in seguito alla sparatoria del 28enne militante della Lega Luca Traini, la settimana scorsa.
Il fronte si è spaccato nella serata di martedì, dopo l’ennesima assemblea. Le posizioni dei centri sociali e quelli delle associazioni e dei partiti, divisi soprattutto da questioni organizzative e di ‘paternità’ della piazza. La frattura sembrava tuttavia ancora sanabile, ma poi, ieri mattina, il sindaco Romano Carancini (Pd) ha sferrato quello che è da leggere come il colpo di grazia all’unità dei movimenti antifascisti. Da un post pubblicato sul proprio profilo di Facebook, il primo cittadino di Macerata ha infatti chiesto uno stop per tutte le manifestazioni, brandendo la retorica del «rischio di ritrovarsi dentro divisioni e possibili violenze che non vogliamo». Parole al vento se si considera che appena poche ore dopo il leader di Casapound Simone Di Stefano ha camminato in tutta tranquillità tra le vie del centro, chiedendo la pena di morte per chi ha fatto a pezzi la giovane Pamela Mastropietro. Lo scenario è stato piuttosto surreale, con una decina di ragazzi a fare da codazzo al proprio capo tribù, tra un turbinio di telecamere e di cronisti con il taccuino aperto. Nessun incidente, ma nemmeno particolare trasporto da parte della cittadinanza: va sempre ricordato, in fondo, che a Macerata non esistono sedi né di Casapound né di Forza Nuova.
Nemmeno un’ora e mezza dopo, Di Stefano era già ad Ancona, altra tappa marchigiana del suo tour elettorale. Il comizio è andato in scena nell’aula consiliare, con i rappresentanti di Casapound che, per accaparrarsela, hanno anche messo la firma in calce al regolamento comunale per quello spazio, che impone una dichiarazione di adesione ai dettami antifascisti della Costituzione. Almeno formalemente, si può dire che Casapound ha rinnegato il Ventennio, in nome della campagna elettorale. Qualche minuto prima gli antifascisti del centro sociale Asilo Politico avevano fatto un breve blitz nella sala, esponendo striscioni contro il fascismo.
Carancini, moderato per abito e vocazione, alfiere di Matteo Renzi che se l’è pure portato dietro a Roma alla presentazione dei candidati, si sforza ancora di descrivere la sua città come una tranquilla oasi di felicità – e la foto a margine del post, con una piazza della Libertà affollata per un grande aperitivo vorrebbe confermare queste intenzioni -, probabilmente nel tentativo di non sporcare troppo il buon nome di una Macerata candidata a diventare la capitale europea della cultura nel 2020, con la decisione che verrà presa nei prossimi giorni. La sparatoria di sabato scorso viene vista come cattiva pubblicità, con buona pace dei sei ragazzi feriti dalla follia fascista di Traini.
È così che i vertici nazionali di Cgil, Arci, Anpi e Libera si sono sfilati dal corteo in programma per sabato, con una presa d’atto dell’appello, «seppur tardivo», di Carancini. Per le quattro sigle firmatarie del comunicato di dissociazione dal corteo, comunque, l’appuntamento con la piazza è solo rimandato.
Il Sisma ha deciso di andare avanti lo stesso: appuntamento confermato per sabato. Le parole più dure sono riservate al sindaco Carancini, la cui presa di posizione viene bollata come «irricevibile» perché «pone sullo stesso piano le iniziative lanciate da quanti rivendicano l’attacco terroristico di sabato scorso e la grande manifestazione di condanna di quanto accaduto. Così facendo, cede e alimenta il clima di paura che vorrebbe tenere in ostaggio la città». Hanno confermato la loro presenza in città anche tante altre realtà, come Potere al Popolo e il Baobab di Roma, oltre a vari centri sociali da tutta l’Europa.
A Macerata, ieri mentre la partita politica si intrecciava, il ministro della Giustizia Andrea Orlando si è recato all’ospedale, dove sono ancora ricoverati due dei sei feriti di sabato scorso: il 20enne ghanese Wilson Kofi e la nigeriana Jennifer Otiotio, che però al momento del suo arrivo era in sala operatoria. «Credo sia giusto manifestare la nostra solidarietà a questi ragazzi colpiti solo per il colore della loro pelle – ha detto il ministro -. Un fascista ha infangato il tricolore, io come ministro devo difendere la nostra bandiera». A seguire, Orlando si è recato anche in tribunale, dove ha incontrato il procuratore Giovanni Giorgio e il presidente Gianfranco Coccioli.
Domani la sortita istituzionale proseguirà con una visita alla madre di Pamela Mastropietro.

l'Avvenire,
Ma in ospedale, a visitare e portare solidarietà ai feriti di Macerata, a tre giorni dagli spari del filonazista Luca Traini non c’è andato nessuno. Nessun rappresentante del governo, solo un paio di deputati. Unici, e gliene va riconosciuto il merito, l’esponente di Leu Beatrice Brignone e (non ricandidato) il cattolico e demo-solidale Mario Marazziti. Come mai, viene da domandarsi? È usanza normale da parte delle autorità andare a stringere la mano ai feriti innocenti, dopo un episodio di violenza. Stavolta no.
Forse perché di questi tempi farsi riprendere mentre si stringe la mano a un migrante, a un nero di pelle, sia pure in ospedale, non giova. In questi tempi di elezioni, in un’Italia esacerbata da propagande odiose. Si sa, poi su media e social la foto gira, la vedono in milioni. E al 4 marzo, manca meno di un mese.
Segni inquietanti da Macerata. La solidarietà allo sparatore espressa da alcuni cittadini all’avvocato di Traini, che ne è rimasto stupefatto. Solidarietà, a dire il vero, con una sola remora: «Ecchè, se va a spara’ così? Poteva piglia’ qualcuno», è il commento di un salumiere del centro della città, riferito dalle cronache del "Corriere". «Poteva piglia’ qualcuno, qualcuno di noi; per fortuna ha colpito solo quei là».
Quei là, ecco. Di cui quasi nessuno di noi sa il nome, perché i media per lo più non ci si sono molto soffermati. Quei sei ragazzi: Wilson Koff, 20 anni, ghanese; Omar Fadera, 23 anni, dal Gambia; Jennifer Otiotio, 25 anni, Gideon Azeke, 25 anni, e Festus Omagbon, 32 anni, tutti nigeriani; Mahamadou Toure, 28 anni, dal Mali.
All’età in cui i nostri figli sono ancora in casa, hanno già traversato il deserto, i campi profughi, il Mediterraneo. Alcuni di loro hanno regolari documenti. Altri no, come uno dei nigeriani, che appena medicate le ferite al pronto soccorso se la è filata alla svelta, temendo altri guai. Perché anche tra le lenzuola candide e le attenzioni dei medici non si sentiva al sicuro. Lo sanno, le giovani ombre che lavorano in nero e dormono negli scantinati, che non sono "come noi". Che ci sono gli uomini, e poi ci sono loro, gli invisibili. «Non si spara così, poteva colpire qualcuno...». Invece quel neonazista ha colpito soltanto dei migranti, cioè nessuno.
Hannah Arendt nei tempi della persecuzione antiebraica parlava di "non uomini"; di masse di persone cui venivano tolti i diritti civili, il passaporto, le proprietà, e che venivano respinti da Paesi fino a allora democratici. Finché, ovunque cacciati, diventavano appunto, nei lager, «non uomini». Displaced people, sfollati, senza terra: ieri su "Avvenire" la filosofa Laura Boella osservava come oggi si usi la stessa espressione per profughi e migranti.
C’è da riflettere, su questo processo di "anonimizzazione" che coinvolge anche italiani per niente razzisti. È quello sguardo che non si posa nemmeno un istante, per strada o in metrò, sul nero che ci affianca; quasi avendolo meccanicamente già infilato in una categoria, "vù’ cumprà", "clandestino". Insomma, altri da noi. Tacitamente, senza pensarlo apertamente,«non uomini».
Non possiamo certo accogliere, e nemmeno dare l’elemosina, a tutti i poveri che incrociamo.
Emagari non siamo noi che possiamo dar loro un lavoro non in nero. Guardarli in faccia, quello sì però possiamo, fare un cenno di saluto, chiedere magari a quello che è sempre al solito angolo come si chiama, e da dove viene. È poco, è quasi niente: ma è almeno un cominciare a riconoscere, nella massa indistinta che spaventa tanti, dei volti, degli esseri umani. Come noi.
Intanto, da Macerata arriva la notizia che il gip dubita dell’accusa di omicidio per il nigeriano arrestato per la morte di Pamela Mastropietro, tanto che non ha convalidato il fermo per questo reato, ma "solo" per vilipendio e occultamento di cadavere. Si sospetta che la povera ragazza potrebbe essere morta di overdose (e per una dose comprata coi soldi ottenuti vendendo il proprio corpo a un italianissimo "cliente").
Anche se poi Innocent Oseghale, forse con un complice, ne avrebbe fatto a pezzi e occultato il corpo. Oseghale potrebbe non essere un assassino, come ha invece rapidamente giudicato il vendicatore nero di gesti e di parole, con trascorsi in Casa Pound e Lega. Che ha preso un tricolore e una pistola, e dall’auto ha cominciato a sparare. Mirando solo ai neri di pelle, solo a quei là, nel mucchio. Un mucchio in cui indistinguibili erano i nomi, le facce, le storie.
A terra, sanguinanti, solo «non uomini». Che non è bene andare a trovare in ospedale. Poi ti fotografano mentre gli stringi la mano. E non conviene, meglio di no – al 4 marzo, manca meno di un mese.

Doppio Zero
Il 5 febbraio 2004all’età di 85 anni ci lasciava Nuto Revelli. Ha saputo scrivere della guerracome pochi in Italia, una guerra vissuta sia da ufficiale dell’esercito che dapartigiano. Ha passato il resto della vita a lavorare sulla memoria e araccogliere le testimonianze di vita di quella che riteneva la sua gente.Questo articolo riflette su una parte della sua eredità. Sono rimastosull’uscio per qualche minuto. Entrando mi pareva di disturbare. Anche se inquel piccolo studio con le pareti rivestite di legno, non c’era nessuno.
Non ero mai stato primanella casa di Nuto Revelli in corso Brunet 1 a Cuneo. Oggi è la sede dellafondazione che porta il suo nome. Laddove c’era la camera da letto condivisacon l’amata Anna, sono ora conservati i documenti di una vita che compongonol’archivio in fase di riordino. La stanza del figlio Marco si è invecetrasformata in un ufficio. Mentre il salotto non sembra aver mutato destinazioned’uso: gli amici di un tempo lo ricordano come luogo di lunghe chiaccherate.
Se una persona l’haiconosciuta esclusivamente attraverso le parole dei suoi libri, fa un certoeffetto essere a un paio di metri dalla sua macchina da scrivere. Per questaragione tentenno sull’uscio, osservo da lì le foto in bianco e nero, i tantilibri riposti nella libreria sulla destra. Molti dei titoli rimandano al chiodofisso, probabilmente la ragione principale per cui Nuto Revelli ha dovutoscrivere: la guerra, in tutte le sue forme.
Rimango lì, a quella cheritengo essere la giusta distanza.
Le tante vite di Nuto
Revelli è stato prima unufficiale dell’esercito italiano, convinto alla guerra da un’educazione in annidi fascismo. Poi partigiano, convinto dalla guerra, quella combattuta, e dallaritirata nel ghiaccio della Russia. Nella vita in borghese degli anni ‘50 èdiventato commerciante di ferro, inizialmente per necessità, dopo come “scusa”per evitare di essere definito intellettuale, storico, scrittore. Ritrosiatutta cuneese da una parte, consapevolezza profonda da un’altra: la suascrittura – più che vocazione o vezzo – è stato un strumento, l’unico, con cuiprovare a estinguere il debito contratto. Una cambiale da onorare, un«pagherò»: «Ricorda - mi dicevo - ricorda tutto di questo immenso massacrocontadino, non devi dimenticare niente».
I creditori di Nutoerano i tanti soldati che aveva visto morire al fronte, i partigiani inbattaglia con lui nelle valli cuneesi e i loro genitori ad attendere notizienelle povere case. Per lo più contadini i primi, i secondi e i terzi. Solo cosìsi può capire perché Nuto arrivi a intraprendere, dopo i libri in cui raccontala guerra e la resistenza, il viaggio nel “mondo dei vinti”. Di come, a uncerto punto, il suo chiodo fisso sia testimoniare le conseguenze di una guerrainedita, combattuta senza clamore né armi ma così intensa da mettere a rischioun’intera civiltà, un’intera cultura: quella contadina. Il debito contratto sipoteva estinguere solo alimentando una memoria negata, solo concedendo voce eassicurando «un nome e un cognome ai testimoni».
Duecentosettanta storiedi vita. Sette anni di ricerca. E poi il secondo viaggio, altri anni, il ritornareper sentire le voci al femminile: “l’anello forte” silenzioso ma semprepresente. E una fortissima sensazione d’urgenza, quella che ricorda MarcoRevelli pensando a suo padre negli anni a cavallo tra il decennio sessanta etutti gli anni settanta. Le sere quasi sempre rintanato nel suo studio adascoltare le voci dei suoi testimoni e prendere annotazioni. E poi tutti i finesettimana vederlo prender l’auto armato solo del suo fidato magnetofono: «lascatola che ascolta e scrive tutto». Le valli, le colline e la pianura cuneesebattute palmo a palmo per fotografare con parole ciò che per Nuto aveva tuttele caratteristiche di un «genocidio». Laddove non erano riusciti i dueconflitti mondiali e la continua emigrazione, erano arrivate la modernizzazionee l’industrializzazione. Un «esodo» che dalle montagne e dalle aree piùmarginali spingeva le persone verso la città e la fabbrica. Interi territoriabbandonati, le case lasciate lì ferme nel tempo come dopo un terremoto.
Era facile nel 1977quando per i tipi di Einaudi uscì Il mondo dei vinti, ed è facile ora,liquidare Nuto Revelli col ritratto del nostalgico, del cantore dei “bei tempiandati”. È una scorciatoia per evitare il confronto con ciò che ha scritto e lestorie che ha portato fuori dall’oblio. Nuto però non era contro l’industria diper sé, non ha mai creduto alla «libertà dei poveri» ma era preoccupatodall’«industria che aveva stravinto», dall’imposizione di una monoculturaeconomica e dall’assenza del limite: «La terra gialla, intristita daidiserbanti, mi appariva come il simbolo dei vinti. Il mio chiodo fisso era chesi dovesse salvare un equilibrio tra l’agricoltura e l’industria prima chefosse troppo tardi».
Resistenze, lucciole emasche
Prima erano serviti ifucili e le bombe. Dopo solo un registratore e delle parole da mettere in filale une alle altre. Una resistenza che continua in altre forme, per certi versimolto più complessa. Il Nuto comandante partigiano a capo di un gruppo diragazzi nascosti nelle montagne, è diventato il Nuto cercatore che si avvale diuna brigata di mediatori: gente in grado di portarlo a conoscere uomini come inesilio nelle proprie valli. Con loro Nuto arrivava in luoghi sperduti a parlarecon testimoni autentici ‘dl’aut secul. I mediatori, figure che meriterebberoromanzi, erano conoscitori eccellenti del proprio territorio e della sua gente,garantivano a Nuto il lasciapassare: quella fiducia iniziale senza la quale alforestiero non si confessava alcunché.
Non è eccessivoraccontare questo lavoro di ascolto e di emersione come una diversa forma diresistenza. Ha senso se si crede che la modernizzazione e la civiltà deiconsumi siano arrivate su quelle persone con la stessa violenza diun’imposizione e con la conseguenza di un lento annichilimento. Riecheggiano leargomentazioni di Pier Paolo Pasolini e la sua critica a un’ideologia dellosviluppo che definiva, senza mezzi termini, come un «nuovo fascismo». Unatendenza all’omologazione culturale e all’erosione di qualunque residuo diautonomia che, secondo il poeta friulano, nemmeno il fascismo storico o lachiesa erano riusciti a minare.
Il mondo dei vinti diRevelli può essere anche raccontato come un resoconto in presa diretta diquesto processo. Però con l’attenzione, e l’attitudine, a evitare astrazioni eil rischio di scivolare nel mito: «Sapevo che la stagione antica delle lucciolee delle cinciallegre era felice soltanto nelle pagine scritte dagli “altri”,dai letterati, dai “colti”».
Anche per questo Nutopredilige le testimonianze dirette con la loro forza di vita raccontata.Nonostante si distanzi dalla nostalgie delle «lucciole» di Pasolini, Nuto trovain realtà nelle baite e nei ciabot il paesaggio umano degli Scritti corsari edelle Lettere luterane. Nelle storie di quei montanari e di quei contadiniemerge come il fascismo era passato da quelle parti senza lasciare traccia, difatto subito nell’indifferenza. La Chiesa era il vero potere storicamenterispettato, anche se un potere esterno, anch’esso accettato più per necessitàche per sincera adesione. Prova ne è l’autonoma religiosità e spiritualità diquel mondo popolato di masche, le streghe delle credenze popolari piemontesi.
E poi il dialetto, dicui proprio in quegli anni i giovani hanno iniziato a provare vergogna perchésimbolo di arretratezza. Io mi ricordo quando mia nonna si sforzava di parlarecon me in italiano: non voleva passare per ignorante. Quella linguarappresentava invece un codice esclusivo e protetto di una propriarappresentazione delle cose, la garanzia di una biodiversità culturale. Certoera anche una barriera capace di escludere: «chi non parla piemontese èstraniero».
Ci ha pensato la«modernizzazione», con il ruolo centrale della televisione, a indebolire, sinoquasi alla completa scomparsa, quella cultura millenaria. Ha promosso nuovi,vincenti, modelli antropologici (che poi siamo noi).
La diserzione
Nuto Revelli aveva paurache il «testamento di un popolo» emerso anche con le sue interviste, venisseconsiderato con il distacco del «documento antropologico» quando invece era, edè, una «requisitoria urlante e insieme sommessa». Non un materiale buono soloper farci convegni ma un atto di accusa che meritava risposte e nuoveconsapevolezze. Nuto se la prendeva con chi aveva praticato la «diserzione»,con chi stava lasciando quel mondo al suo destino senza fare nulla. Se alledestre e alla Democrazia Cristiana imputava le responsabilità per essere igaranti degli equilibri di quello sviluppo così ineguale e dannoso; dalle forzedella sinistra esigeva risposte e linfa nuova perché anche loro «non capivano ofingevano di non capire». Si rendeva conto che anche in quella parte, la suaparte, la forza persuasiva dell’industrializzazione e di quel modello disviluppo a crescita infinita aveva fatto breccia. I comunisti così come leforze della nuova sinistra dei gruppi extraparlamentari sembravano condividerein quegli anni l’euforia produttivista. È sempre Marco Revelli, all’epocamilitante di Lotta Continua, a offrire uno spaccato: «io non capivol’ostinazione di mio padre, quel dedicare così tanto tempo a un mondo indeclino. A me sembrava positivo allora che quelle persone se ne andassero viada quei posti per scendere in fabbrica, da militanti di sinistra poi pensavamoche una volta operai avremmo potuto parlarci mentre diversamente i nostridiscorsi non facevano breccia».
In un’intervista aNuova Società, Nuto rivolgeva nel settembre del 1977 il suo appello: «Oggianche un politico di sinistra non sa cosa fare. Ma, se il PCI non risolve certiproblemi, in Italia non li risolve nessuno. […] Le parole d’ordine d’allarmenon sono state sentite da chi deteneva il potere, ma anche all’interno dellasinistra il discorso ha sempre privilegiato l’industria. L’interesse per ladiscussione sui problemi delle campagne è sempre stato flebile». E in undialogo su «Ombre Rosse» nel dicembre dello stesso anno spronava: «Un cordoneombelicale la mantiene (la manodopera della Michelin, della Ferrero ndr)collegata alla terra in cui è nata e cresciuta. Se un sindacalista, se ilsindacato non conosce questo contesto, tutto quello che sta fuori e prima dellafabbrica, parla a questi operai con un linguaggio sconosciuto, e non deve poistupirsi della sindacalizzazione che non c’è, degli scioperi che non riescono.[…] questi operai invece di andare a cercarli davanti alle porte dellaMichelin, dove escono storditi che cercano d’arrivare a casa prima che sianotte, andateli a trovare in campagna, dove lavorano ancora. Capirete che sonorimasti dei contadini. […] È in campagna che potete parlare della fabbrica».
Parole che ricordanoquelle del 2001 di Paolo Rumiz, in La secessione leggera, in cui racconta ilfenomeno leghista nel nord Italia: «Le radici non sono affatto una cosa didestra, ma lo diventano eccome quando la sinistra ne ha orrore». E diventadifficile non collegare, non mettere insieme le cose: quanto c’entra a sinistrala subalternità a un modello economico con la fuga dei «naufraghi dellosviluppo» dal proprio popolo?
È tuttaqui l’attualità del messaggio di Nuto Revelli, dei suoi appelli urlanti einsieme sommessi alla sinistra perché cambiasse approccio, acquisisse nuoveconsapevolezze sul modello di sviluppo che stava vincendo. C’era da mettere indiscussione un’impostazione, provare a guardare il mondo oltre le lentidell’operaio della “grande fabbrica”.
Unalezione inascoltata, con il senno di poi, evidente anche nel come a sinistral’ambientalismo sia arrivato come un oggetto estraneo. Ed è continuata quelladifficoltà a parlare a quel mondo che non fosse città, ha pesato su questo unatara della cultura “ufficiale” comunista: l’avversità ai piccoli proprietariterrieri che la vulgata marxista avrebbe voluto veder presto proletarizzati peringrossare le file del proprio blocco sociale. Negli anni ‘50 una polemicaintercorsa tra alcuni intellettuali del PCI e figure come Ernesto De Martino,Carlo Levi, Rocco Scotellaro, Manlio Rossi Doria e lo stesso Pasolini,testimoniava il perdurare del pregiudizio e del fastidio rispetto ai temi delmondo contadino.
CarloPetrini, il fondatore di Slow Food, ricorda quell’indifferenza quandoera militante della sinistra extraparlamentare: «ricordo una riunione delgruppo del Manifesto in cui Lucio Magri disse: “Cos’ha Petrini che parla sempredi cibo?”. Io parlavo di cibo perché condividevo i ragionamenti di Revelli,avevo visto ciò che scriveva frequentando la gente di una Langa allora ancorapovera e il mangiare era il punto d’attacco per parlare con quelle persone».
Un’ereditàsenza testimoni?
Viene dachiedersi cosa sia rimasto oggi di quell’eredità che quel «testamento di unpopolo», rappresentato da Il mondo dei vinti, ha lasciato. Di certo cisono oggi nuove consapevolezze sui limiti dello sviluppo e sugli squilibrisociali e territoriali. Cresce, seppur troppo lentamente, una coscienzaambientale che impone una revisione delle nostre priorità. Nel senso comuneaffiora l’idea che un modello economico sempre destinato a crescere siaqualcosa di irrazionale.
D’altraparte il mondo rurale e contadino gode di un rinnovato interesse. Siamo nel belmezzo di un revival della campagna, dei suoi prodotti e dei suoiprotagonisti. Il cibo è al centro della scena.
È lariscossa dei «vinti»? Chissàcosa penserebbe Nuto di questo cibo diventato spettacolo, di fabbrichecontadine e di reality dove ai contadini si cerca moglie. Riderebbe,forse, pensando ai bacialè conosciuti nei suoi giri. Veri e proprimediatori di matrimoni contadini che giravano le cascine con un “campionario”di ragazze con fotografie e indirizzi, che combinavano matrimoni tra icontadini scapoli dell’alta Langa e le ragazze calabresi in cerca di marito, edi nuove vite.
Più che uninedito rispetto per la diversità del mondo contadino, sembra di assistere a unprocesso di assimilazione. Non proprio il riscatto che immaginava Nuto. Anchese c’è speranza in alcuni giovani che ritornano nelle case abbandonate dei proprinonni, in nuovi stili di vita e in tanti esperimenti che raccontano una diversapossibilità.
C’è dachiedersi infine se quella civiltà contadina abbia preservato o meno alcuni deisuoi caratteri di autonomia culturale su cui era possibile innestare percorsidi sviluppo alternativi. C’è da chiedersi, insomma, se quel popolo c’èancora. O se forse “manca”.
Un’autonomiae una cultura di cui non bisogna dimenticare anche gli aspetti negativi, glielementi di arretratezza che nessuno rimpiange. Ma ci sono tratti di quelmestiere di vivere da riscoprire nel nostro mondo zeppo di nevrosi. Eservirebbe anche un progetto politico e culturale capace di farsene carico,valorizzando, come in qualche modo chiedeva Nuto, il buono che si scorge incontroluce nelle testimonianze dei vinti.
Civorrebbe un poco della saggezza inconsapevole dei tanti testimoni di Nuto, comequel montanaro preso ad esempio da Alessandro Galante Garrone in una recensionedel luglio 1977. La sua è una domanda, pensata in qualche borgata nascostanelle nostre Alpi, che oggi ci fa sospirare: «se le fabbriche si fermano aforza di far macchine, che cosa succederà?».

Huffpost 3 febbraio 2018. Dalla violenza delle parole degli energumeni a quella stragista dei fatti criminali il passo non è tanto lungo. Ma porta all'abisso. A Macerata è avvenuto.
Era solo questione di tempo e il tempo è arrivato. Un crimine all'americana, dell'America di oggi, un raid razzista fatto sparando in giro per le strade della città, una tentata strage nutrita di odio razziale e di rabbia, una generica vendetta diretta non a questo o a quel colpevole ma a una razza, a un colore, a tutto ciò che non siamo noi. Stavolta però non d'America si è trattato ma della provincia italiana, la provincia tranquilla, una volta luogo di certezze e solidità contrapposte alle nevrosi e violenze della città. Provincia oggi raggiunta e travolta, anch'essa, dall'onda lunga dell'ansia italiana. Inatteso ed estremo risveglio del Paese tutto davanti a quelle molteplici firme identitarie: saluto fascista, bandiera tricolore sulle spalle, e quel "Viva l'Italia". L'Italia, sì, è stata chiamata in causa tutta – e davvero siamo arrivati a questo, siamo diventati questo?
A Macerata un limite è stato attraversato, una barriera è stata rotta. Dagli slogan violenti è stata generata vera violenza. Una affermazione banale, eppure sempre negata, dalla leggerezza e dalla irresponsabilità di un dibattito politico che detesta e disprezza come buonismo gli inviti al rispetto, che boccia come evirato ogni tentativo di ragionare invece che inveire, una cultura tornata in voga perché usa le parole come sostituto delle pallottole – per ferire l'anima, per sminuire la dignità altrui, e per soddisfare ego sminuiti gonfiandoli di finta superiorità.
E se pensate che sto pensando a Salvini e alla estrema destra, ebbene sì: è proprio a loro che sto pensando. Penso a tutte le colonne di stampa che grondano parolacce, volgarità, battute e tanti, tanti incitamenti a reagire, colpire. Fino a divenire l'inno – e abbiamo visto anche questo – alla reazione individuale contro il mondo, armi in mano e resistenza al "nemico" nel cuore. Diritto alla difesa, viene chiamato, anche se dovrebbe più spesso definirsi diritto all'offesa.
Macerata è oggi al centro di una orribile storia: una ragazza diciottenne, scappata da una comunità di recupero dalla droga, uccisa e fatta a pezzi in due valigie da un nigeriano spacciatore di droga. La polizia pare sicura della colpevolezza. La storia dolorosa, la morte efferata che è stata inflitta a Pamela Mastropietro merita ogni indagine, ogni severità, ogni condanna.
Una storia così crudele invoca anche ogni domanda di sicurezza e deve indicare anche la responsabilità dello Stato nel non saper gestire, o anche solo capire, le conseguenze di una politica dell'immigrazione mai davvero pensata e organizzata. La politica tutta ha l'obbligo di pensare alla sicurezza del paese. E certamente è colpevole di inadeguatezza. Ma la risposta a tutto questo, ai tanti errori non possono portare certo all'odio, allo scontro, alla giustizia individuale, alla strage pianificata.
E quando vi si arriva, siamo molto vicini, come si diceva, a entrare in un territorio tutto nuovo, da cui sarà molto difficile tornare.
Peccato che Salvini, così ambizioso, così dinamico, così voglioso di fare qualcosa per il Paese non abbia colto che anche per lui, soprattutto per lui, oggi era arrivato il momento di non attraversare il limite, di porre un argine alla follia attraverso una netta presa di distanza. Di dire parole di cautela e avviare un dialogo e una riflessione con il suo popolo. Non l'ha fatto. E non è stato un errore, il suo. È evidentemente una convinzione: perché questa è l'Italia che Salvini vuole, evidentemente.
Per la politica italiana questo è stato un giorno in cui la verità sui rischi che corre il Paese ha fatto irruzione nei riti sempre finti della campagna elettorale. Le conseguenze di questo scossone si possono avvertire fin da ora: l'episodio crea scompiglio nella coalizione della destra, obbliga la sinistra a ripensare un po' alle proprie divisioni interne, e mette sotto pressione il Movimento 5 Stelle che come sempre preferisce rimanere nel vago, come già è successo, quando avvengono storie scomode. Sempre che la verità la si voglia ascoltare.

il manifesto, 4 febbraio 2018.
Di colpo, il buio. A Macerata, ieri, siamo caduti in uno dei punti più oscuri della nostra storia recente. Di quelli in cui sembrano materializzarsi i peggiori incubi, da «scene di caccia in Bassa Baviera». Il folle tiro al bersaglio su base etnica, i corpi che cadono uno dopo l’altro, la corsa dell’auto alla ricerca di nuove vittime di colore, la città paralizzata, rinchiusa in casa, tutto questo ci dice che un nuovo gradino dell’orrore è stato sceso.
Non è il primo caso di violenza sanguinosa di tipo razzista: il 13 dicembre del 2011, in Piazza Dalmazia a Firenze, due giovani senegalesi, Samb Modou e Diop Mor, caddero sotto i colpi della 357 Magnum di Gianluca Casseri, un fascista di Casa Pound che poco dopo, braccato dalla polizia, si suicidò. Ed è di appena un anno e mezzo fa l’omicidio di Emmanuel Chidi Namdi, nigeriano, massacrato a botte da un energumeno di estrema destra mentre cercava di difendere la fidanzata a Fermo, non molto lontano da Macerata.
Ma questo di Macerata sta ancora un passo oltre. Per la modalità e il movente del fatto: l’intento di vendicare l’atroce morte di Pamela Mastripietro, secondo le cadenze tipiche del linciaggio nell’America dell’apartheid, colpendo indiscriminatamente i presunti compatrioti del presunto assassinio (e dimenticando, fra l’altro, che la rapidissima cattura di questo si deve alla preziosa testimonianza non di un italiano ma di un africano).
Per le caratteristiche del protagonista, ancora un fascista, candidato senza fortuna nella Lega, ma prima già vicino a Forza nuova e Casa Pound come Casseri, che però a differenza di quello non si è suicidato ma ha inscenato una teatrale rappresentazione, salendo sulla base del monumento ai caduti avvolto nel tricolore, quasi a lanciare un proclama alla nazione. Prontamente accolto, d’altra parte, da un impressionante seguito sui social, ed è questo il terzo fattore che colloca Macerata «oltre»: energumeni della tastiera che invocano «Luca Traini Santo Subito», invitano a fare altrettanto e proclamano che «questo non è che l’inizio» scaricando su «chi apre le porte all’invasione» degli africani la colpa sia dell’uccisione di Pamela che della reazione del «giustiziere» di Corridonia. Un argomento quest’ultimo, sostanzialmente in linea con le prime esternazioni di Matteo Salvini, che nel segno di una feroce campagna d’odio sta conducendo il proprio giro elettorale.
Non possiamo più ignorarlo. Macerata non è un fatto isolato. Né semplicemente opera di un disadattato. Macerata si inserisce in un quadro spaventosamente degradato. Ci parla di un vero sfondamento antropologico del nostro Paese. Viene dopo le oscene esternazioni della sindaca di Gazzada sul giorno della memoria nella terra del leghismo. Dopo la pubblicazione in rete di un aberrante fotomontaggio in cui la testa mozzata della Presidente della Camera Boldrini appare sotto la scritta «Sgozzata da un nigeriano inferocito, questa è la fine che deve fare così per apprezzare le usanze dei suoi amici», e dopo il rogo del manichino che la rappresentava, da parte dei «giovani padani» di Busto Arsizio. Dopo un lungo rosario di dichiarazioni, atti, ordinanze di sindaci leghisti, sfregi da parte di squadristi fascisti di cui si va perdendo il conto.
Macerata ci dice che l’azione dei tanti «imprenditori dell’odio» in felpa o in camicia bianca, sta tracimando oltre il terreno delle propaganda, e generando vere e proprio azioni terroristiche. Perché quello che si è visto a Macerata è in senso proprio un episodio di terrorismo, non diverso da quelli organizzati dall’Isis o dai suoi cani sciolti a Barcellona, Londra o Bruxelles, con le persone inermi fatte bersaglio e le città chiuse nel terrore. Come tale va trattato l’attentatore di Macerata. E come tale il mondo democratico dovrebbe trattare l’evento, organizzando subito una risposta di massa, lì dove il fatto è avvenuto, mobilitando chi ancora crede che quella deriva possa essere arrestata. E che la notte della memoria non è del tutto caduta su di noi. Se non ora, quando?

la Stampa, 2 febbraio 2018.Nessuno dei popoli nell'ambito dei quali sono avvenuti delitti contro l'umanità, e che non abbia reagito, può proclamare "noi siamo brava gente"
«Il Senato approva la legge che punisce chi si riferisce a “campi di concentramento polacchi”. Israele reagisce e valuta il richiamo dell’ambasciatore: "Così si rischia di negare l’Olocausto"»
Come non fosse successo nulla, sordi alle proteste delle vittime dell’Olocausto, dell’opposizione interna, di Israele, dell’Ue e degli Stati Uniti, pochi minuti prima delle due di mercoledì notte, la Camera alta polacca ha approvato con 57 voti favorevoli, 23 contrari e due astenuti la controversa legge sui campi di sterminio che prevede pene fino a tre anni di carcere per chiunque si riferisca ai lager nazisti come campi «polacchi». Ma il punto che più fa scatenare le reazioni è un altro: diventerà illegale accusare la nazione polacca di collaborazionismo con il regime hitleriano.
Ora gli occhi sono tutti puntati sul presidente Duda che dovrà decidere se approvare la legge, bloccarla o imporre modifiche. Il governo polacco non accenna a passi indietro e i legami tra il presidente e il leader del partito al potere, il PiS di Kaczynski, sono molto stretti. Così che Duda potrebbe assecondare i desideri del partito ultraconservatore. «Noi polacchi, siamo stati vittime, come lo erano gli ebrei», ha detto l’ex premier Beata Szydlo. «È un dovere difendere il buon nome della Polonia». Ma il «buon nome della Polonia» e la sua reputazione internazionale è precipitata dopo le condanne incrociate degli Stati Uniti, che vedono la legge come una «minaccia alla libertà di parola» e ne chiedono il veto, di Israele che accusa Varsavia di negazionismo e anche del ex premier Donald Tusk e attuale presidente del Consiglio europeo: l’espressione campi polacchi riferita ai lager nazisti «è una spregevole diffamazione» ma la legge approvata dal Senato ha avuto l’effetto boomerang di «promuovere questa vile calunnia in tutto il mondo, efficacemente come nessuno ha mai fatto prima». Il primo vicepresidente della Commissione Europea Timmermas riporta il dibattito al punto cruciale: «Tutti i Paesi europei occupati da Hitler hanno avuto, oltre ai molti eroi, anche collaborazionisti».
I colloqui diplomatici delle ultime 72 ore hanno portato a un nulla di fatto, e l’ira di Israele contro la legge non si placa: «Non lasceremo che la decisione del Senato polacco passi senza reazioni. L’antisemitismo polacco ha alimentato l’Olocausto» ha detto il ministro Yoav Gallant. Mentre il premier Benjamin Netanyahu, potrebbe richiamare l’ambasciatore israeliano in Polonia per consultazioni, come chiesto da più parti.
In Israele il dibattito era scoppiato già nel fine settimana, dopo il primo via libera alla Camera polacca: «La nostra posizione è che il testo deve essere cambiato», aveva affermato Netanyahu, chiarendo che «non abbiamo tolleranza per la distorsione della verità e la riscrittura della storia o la negazione dell’Olocausto». Fonti diplomatiche di Varsavia sono al lavoro per tentare di contenere i danni, ma non nascondono la sorpresa: «La legge è stata studiata ed emendata con l’aiuto di autorità ed esperti israeliani. E nella maniera più assoluta non protegge i criminali, e non limita le discussioni pubbliche su i casi di pogrom contro gli ebrei, verificati in tutta l’Europa occupata, inclusa la Polonia. A questi crimini hanno partecipato anche i polacchi».

Avvenire,
«Sarebbero solo tre i sopravvissuti, fa sapere l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), dell'ennesima tragedia del mare che si è consumata venerdì notte davanti alle coste della Libia»
Sarebbero almeno 90 i migranti morti nella notte tra giovedì e venerdì al largo delle coste della Libia. A dare la notizia dell'ennesimo naufragio, l'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. La barca su cui i migranti stavano viaggiando, in legno, si è ribaltata. Solo tre i sopravvissuti. A bordo, riferisce l'agenzia delle Nazioni unite, ci sarebbero stati soprattutto cittadini pachistani.
Dieci corpi senza vita, conferma la portavoce dell'agenzia, Olivia Headon, sono stati ritrovati sulla spiaggia. Si tratta di due libici e otto cittadini pachistani. Dei tre sopravvissuti, due hanno nuotato fino a raggiungere la spiaggia, dove sono stati trovati stremati e sotto-choc. il terzo è stato salvato da un peschereccio che si trovava nell'area del naufragio.
"Secondo i dati in nostro possesso - aggiunge Olivia Headon - solo 29 libici sono stati salvati o intercettati in mare nel corso del 2017. Ma stimiamo che la cifra reale sia molto più alta". Sempre nello stesso anno, sono stati in tutto 3.138 i pachistani che hanno raggiunto le coste dell'Italia, confermandosi come 13esima nazionalità nella lista generale, per cittadinanza, dei migranti salvati e sbarcati. Quest'anno però, la geografia degli arrivi sta cambiando. Il Pakistan rappresenta infatti già la terza nazionalità per numero di arrivi. Dal primo gennaio, sono infatti già 240 i cittadini pachistani sbarcati in Italia. Nello stesso periodo, di un anno fa, erano solo 9.
Con quest'ultima tragedia del mare, l'agenzia delle nazioni unite aggiorna anche il contatore degli arrivi, in questo primo mese dell'anno. Sono complessivamente 6.624 i migranti e rifugiati entrati in Europa via mare fino al 28 gennaio. L'Italia rappresenta circa il 64% del totale degli arrivi, seguita da Spagna (19%) e Grecia (16%).
"Ogni vita persa in mare è una vita di troppo persa" ha detto una portavoce della Commissione europea, Catherine Ray, commentando il naufragio al largo della Libia. "Abbiamo visto i diversi rapporti e il comunicato dell'Organizzazione Internazionale delle migrazioni", ha aggiunto la portavoce. "Ogni vita persa in mare è una vita di troppo persa. È per questa ragione che continuiamo le nostre azioni lungo tutta la rotta del Mediterraneo centrale per fare delle operazioni di salvataggio e ricerca in mare e lottare i trafficanti e le reti che mettono questa gente in pericolo", ha detto Ray. "Continueremo le nostre azioni laddove le nostre imbarcazioni possono operare", ha concluso la portavoce.
Non sono i trafficanti i principali responsabili dello sterminio. Essi sono solo l'ultimo anello della catena criminale i cui primi anelli sono costituiti dal susseguirsi dei colonialismi che hanno consentito al Primo mondo di costruire il proprio benessere a spese degli altri, condannati agli inferni da cui tentano di fuggire

milex.org
Il Rapporto MIL€X 2018 - presentato oggi alla Sala Stampa della Camera dei Deputati alla presenza di Daniel Högsta, coordinatore della campagna ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) insignita del Premio Nobel per la Pace 2017 - mostra un’ulteriore incremento della spesa militare italiana: 25 miliardi di euro nel 2018 (1,4% del PIL), un aumento del 4% rispetto al 2017 che rafforza la tendenza di crescita avviata dal governo Renzi (+8,6 % rispetto al 2015) e che riprende la dinamica incrementale delle ultime tre legislature (+25,8% dal 2006) precedente la crisi del 2008.
Cresce nel 2018 il bilancio del Ministero della Difesa (21 miliardi, +3,4% in un anno, +8,2% dal 2015) e i contributi del Ministero dello Sviluppo Economico all’acquisto di nuovi armamenti (3,5 miliardi di cui 427 milioni di costo mutui, +5% in un anno, +30% nell’ultima legislatura, +115% nelle ultime tre legislature) per i quali nel 2018 verranno spesi 5,7 miliardi (+7% nell’ultimo anno e +88% nelle ultime tre legislature). Tra i programmi di riarmo nazionale in corso (tutti elencati nel Rapporto MIL€X) i più ingenti sono le nuove navi da guerra della Marina (tra cui la nuova portaerei Thaon di Revel), i nuovi carri armati ed elicotteri da attacco dell’Esercito, e i nuovi aerei da guerra Typhoon e F-35.
Agli F-35 il Rapporto MIL€X dedica un approfondimento che analizza costi effettivi (50 miliardi con i costi operativi), reali ricadute industriali ed occupazionali, difetti strutturali (che rischiano di mettere fuori servizio gli F-35 finora acquistati dall’Italia per 150 milioni l’uno) e funzione strategica di questo sistema d’arma prettamente offensivo e intrinsecamente contrario all’articolo 11 della Costituzione Italiana e al Trattato di non Proliferazione Nucleare.
Un altro approfondimento del Rapporto riguarda proprio i costi della “servitù nucleare” legata alle spese di stoccaggio e sorveglianza delle testate atomiche tattiche americane B-61 nelle basi italiane (23 milioni solo per l’aggiornamento delle apparecchiature di sorveglianza esterna e dei caveau contenti le venti B-61 all’interno degli undici hangar nucleari della base bresciana) e alle spese di stazionamento del personale militare USAaddetto e di mantenimento in prontezza di aerei e piloti italiani dedicati al “nuclear strike” (lo stesso acquisto del bombardiere nucleare F-35 da parte italiana, secondo il Pentagono, rappresenta “un fondamentale contributo al missione nucleare” americana).
Il commento di Daniel Högsta: “Questi dati dimostrano come la presenza di armi nucleari abbia impatto negativo per i paesi che le ospitano non solo dal punto di vista politico, ma anche della spesa pubblica. L’opinione pubblica dovrebbe rendersene conto! Sono invece già positivi gli impatti del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari votato all’ONU a luglio 2017: diversi enti finanziari internazionali hanno iniziato a disinvestire dalla produzione di armi nucleari. Anche gli Stati dovrebbero fare lo stesso”.
Tra gli ulteriori focus del Rapporto MIL€X 2018: le spese italiane di supporto alle 59 basi USA in Italia (520 milioni l’anno) e di contribuzione ai bilanci NATO (192 milioni l’anno), i costi nascosti (Mission Need Urgent Requirements) delle “infinite” missioni militari all’estero (con approfondimenti sui costi di 16 anni di presenza in Afghanistan e 14 anni in Iraq), il costo della base militare italiana a Gibuti intitolata all’eroe di guerra fascista Comandante Diavolo (43 milioni l’anno), il “tesoretto” armato da 13 miliardi nascosto nel Fondo Investimenti voluto dal Governo Renzi (destinato anche ai nuovi droni armati della Piaggio Aerospace*), lo “scivolo d’oro” dimenticato per gli alti ufficiali (condannato dalla Corte dei Conti) e l’onerosa situazione dei 200 cappellani militari ancora a carico dello Stato (15 milioni l’anno tra stipendi e pensioni).
NB per un mero errore materiale in una prima stesura di questo articolo (fino alle 17.30 di giovedì 1 febbraio) si faceva riferimento alla “Piaggio” come azienda produttrice di droni, mentre è invece “Piaggio Aerospace” ad essere coinvolta in tale produzione e a ricevere finanziamenti pubblici a riguardo (come correttamente evidenziato nel testo del Rapporto Mil€x 2018). Ce ne scusiamo con gli interessati.