


Il manifesto, 23 giugno 2015
La costruzione della grande muraglia cinese fu iniziata nel 700 a. C. per concludersi nel 206 a.C. per volere dello zar Qin Shi Huang. Serviva a difendersi dalle incursioni dei popoli confinanti, soprattutto dai mongoli. Ma non risultò molto efficace — anche se misurava 6.350 metri, si trovava sempre un punto valicabile e non coperto. In piccolo fu nei secoli imitata da molte fortezze e castelli sempre per impedire l’entrata ai non desiderati o ai nemici. Dopo la seconda guerra mondiale un muro venne eretto a Berlino per separare le due Germanie. Fu abbattuto con grande giubilo il 9 novembre del 1989 e la Germania tornò ad essere di nuovo una sola.
Oggi l’Europa sta erigendo nuovi muri. L’Europa comunitaria, l’unica che si ritiene degna di portare questo nome. Altri paesi — per lo più quelli formatisi dopo la dissoluzione della Jugoslavia, eccezion fatta per la Slovenia e la Croazia, — non sono più «Europa», sono un continente nuovo ancora senza nome.
Tra poco anche la Grecia, la culla democratica di tutti gli altri, il paese dove la democrazia è nata mentre nei paesi oggi «sviluppati» gli uomini vivevano ancora sugli alberi, non sara più «Europa», con buona pace del Fondo monetario internazionale.
Anche la grande Russia sembra non essere più Europa – il muro verso di lei sono le sanzioni – che danneggiano più noi che i russi – e la Nato che la circonda da tutte le parti approfittando dell’ospitalità dei paesi «vendicatori». (Ricordiamoci il terrore quando la marina sovietica si era avvicinata alle coste di Cuba!).
L’Ungheria, un paese di estrema destra, chiede che si costruisca un muro tra il suo confine e quello della Serbia. L’esempio sono i muri in Texas verso il Messico, quelli a Belfast ovest che dividono i cattolici dai protestanti, di Nicosia, i turchi dai greci e soprattutto il muro che Israele ha eretto a Ramallah per separare i territori palestinesi dai «propri». Muri che servono a difenderci dagli «infetti» che noi abbiamo contaminato. Sono di Belgrado, ma vivo da italiana in Italia da quasi cinquant’anni. Ho militato in un partito che oggi non esiste più (il Pci), sono stata l’interprete anche di Enrico Berlnguer. Ho cercato di diffondere la cultura del mio paese (allora la Jugoslavia) traducendo le opere degli scrittori più importanti. Avendo parenti in tutte le regioni delle ex repubbliche, sono etnicamente «sporca» come si direbbe oggi. Ma sono contenta, il mio mondo è il Mondo anche se le radici contano.
I grandi paesi come la Francia e l’Inghilterra (per non parlare degli Stati Uniti e del disastro provocato negli anni recenti in Iraq, Libia ecc.) non vogliono la nuova ondata degli immigrati dopo aver sfruttato fino all’osso le colonie. Al confine di Ventimiglia arrivano centinaia di stranieri al giorno: sono sbarcati con le loro misere cose in Italia (purtroppo la sua geografia lo permette) ma vogliono andare oltre; spesso hanno già i parenti in altri paesi europei con i quali si vorrebbero congiungere.
Nel periodo dei bombardamenti «umanitari» della Serbia per raggiungere la famiglia che viveva a Belgrado, si andava a Budapest e poi con un pullman sgangherato si proseguiva per la capitale. Al confine i finanzieri non erano proprio gentili, spesso si doveva dar loro qualcosa per essere lasciati in pace. Dicevano: «Avete vissuto bene sotto Tito, ora siete voi ad avere bisogno!».
Asotthalom è una cittadina ungherese al confine con la Serbia. È qui soprattutto che si assiepano immigrati da diversi paesi africani e asiatici in fuga dalle guerre e dalla miseria. Qualche contadino ungherese porge loro un bicchier d’acqua e un po’ di pane. Sono esausti sotto il sole di giugno dopo aver fatto migliaia di chilometri a piedi e negli scafi strapagati dove hanno visto morire i propri compagni. Cimitero azzurro è il poema del serbo Milutin Bojic dedicato ai caduti serbi nel Mediterraneo nella prima guerra mondiale. Il sindaco dice che la cittadina ha 4.000 abitanti e che da qui hanno transitato 40 mila illegali. Arrivano in Serbia dall’Albania e dal Kosovo e poi capiscono che non c’è molto da aspettarsi da un paese già povero. E ora sono qui a cercare di andare oltre, oltre e ancora oltre. Spesso non sapendo nemmeno dove, per riprendere anche un briciolo della vita che hanno perduto.
Sono stati abbattuti i muri dei campi di concentramento e internamento, ci siamo tutti sentiti più uomini. Ma i nuovi muri ci riportano indietro. Capisco anche la gente che ha paura dell’«altro»: rubano, puzzano, sono violenti. Ma dopo giorni e settimane senza mangiare, noi saremmo diversi? Ora che l’unico di sinistra sembra essere papa Francesco, che ci richiama a scoprire un po’ di umanità in noi, come convincere i grandi ad aiutare i «piccoli» che spesso non considerano nemmeno umani? Una scrittrice croata molto polemica (Vedrana Rudan) profetizza che un giorno guardaremo i bambini americani star male e non ci dispiacerà dopo aver visto i volti dei bambini palestinesi, siriani, ivoriani, nigeriani… Certo, un mondo così ingiusto dovrà esplodere. E allora si dovrà ricominciare. Putroppo non sarò in grado di dare il mio contributo.
* scrittrice e traduttrice, ha tradotto in italiano tutte le opere di Ivo Andric
 «Il filosofo tedesco: i politici non possono nascondersi dietro le lacune dovute a chiare incapacità istituzionali». Ancora una voce dal mondo della saggezza a favore delle ragioni di Alexis Tsipras.
«Il filosofo tedesco: i politici non possono nascondersi dietro le lacune dovute a chiare incapacità istituzionali». Ancora una voce dal mondo della saggezza a favore delle ragioni di Alexis Tsipras.
LaRepubblica, 23 giugno 2015
La recente sentenza della Corte di Giustizia europea getta una luce impietosa su un errore di fondo della costruzione europea: quello di aver costituito un’unione monetaria senza un’unione politica. Tutti i cittadini dovrebbero essere grati a Mario Draghi, che nell’estate 2012 scongiurò con un’unica frase le conseguenze disastrose dell’incombente collasso della valuta europea. Aveva tolto la patata bollente dalle mani dell’Eurogruppo annunciando la disponibilità all’acquisto di titoli di stato senza limiti quantitativi in caso di necessità: un salto in avanti cui l’aveva costretto l’inerzia dei capi di governo, paralizzati dallo shock e incapaci di agire nell’interesse comune dell’Europa, aggrappati com’erano ai loro interessi nazionali. I mercati finanziari reagirono positivamente a quell’unica frase, benché il capo della Bce avesse simulato una sovranità fiscale che non possedeva, dato che oggi come ieri, sono le banche centrali degli Stati membri a dover garantire i crediti in ultima istanza.
GLI SPAZI DELLA BCE
Di fatto, la Corte di Giustizia europea non poteva confermare questa competenza, in contraddizione col testo dei Trattati europei; ma dalla sua decisione consegue la possibilità per la Banca centrale europea di disporre – tranne poche limitazioni - dei margini di manovra di un erogatore di crediti di ultima istanza. La Corte di Giustizia ha dunque ratificato quell’azione di salvataggio, benché non del tutto conforme alla Costituzione. Verrebbe voglia di dire che il diritto europeo dev’essere in qualche modo piegato, anche se non proprio forzato, dai suoi stessi custodi, per appianare di volta in volta le conseguenze negative del difetto strutturale dell’unione monetaria. L’unione monetaria resterà instabile finché non sarà integrata da un’unione bancaria, economica e fiscale. In altri termini, se non vogliamo che la democrazia sia palesemente ridotta a puro elemento decorativo, dobbiamo arrivare ad un’unione politica.
Fin dal maggio 2010 la cancelliera tedesca ha anteposto gli interessi degli investitori al risanamento dell’economia greca. Il risultato è che siamo di nuovo nel mezzo di una crisi che pone in luce, in tutta la sua nuda realtà, un altro deficit istituzionale. L’esito elettorale greco è quello di una nazione la cui netta maggioranza insorge contro l’opprimente e avvilente miseria sociale imposta al paese dall’austerità. In quel voto non c’è nulla da interpretare: la popolazione rifiuta la prosecuzione di una politica di cui subisce il fallimento sulla propria pelle. Sorretto da questa legittimazione democratica, il governo greco sta tentando di ottenere un cambio di politica nell’Eurozona; ma a Bruxelles si scontra coi rappresentanti di altri 18 paesi che giustificano il loro rifiuto adducendo con freddezza il proprio mandato democratico.
Il velo su questo deficit istituzionale non è ancora del tutto strappato. Le elezioni greche hanno gettato sabbia negli ingranaggi di Bruxelles, dato che in questo caso gli stessi cittadini hanno deciso su un’alternativa di politica europea subita dolorosamente sulla propria pelle. Altrove i rappresentanti dei governi prendono le decisioni in separata sede, a livelli tecnocratici, al riparo dell’opinione pubblica, tenuta a bada con inquietanti diversivi. Le trattative per la ricerca di un compromesso a Bruxelles sono in stallo, soprattutto perché da entrambi i lati si tende a incolpare gli interlocutori del mancato esito nei negoziati, piuttosto che imputarlo ai difetti strutturali delle istituzioni e delle procedure. Certo, nel caso di specie siamo di fronte all’attaccamento cieco ostinato a una politica di austerità giudicata negativamente dalla maggior parte degli studiosi a livello internazionale. Ma il conflitto di fondo è un altro: mentre una delle parti chiede un cambiamento di rotta, quella contrapposta rifiuta ostinatamente persino l’apertura di una trattativa a livello politico: ed è qui che si rivela una più profonda asimmetria.
SCELTE SCANDALOSE
Occorre avere ben chiaro il carattere scandaloso di un tale rifiuto: se il compromesso fallisce, non è per qualche miliardo in più o in meno, e neppure per la mancata accettazione di una qualche condizione, ma unicamente per via della richiesta greca di dare la possibilità di un nuovo inizio all’economia della Grecia, e alla sua popolazione sfruttata dalle élite corrotte, attraverso un taglio del debito o una misura analoga, quale ad esempio una moratoria collegata alla crescita. I creditori insistono invece sul riconoscimento di una montagna di debiti che l’economia greca non riuscirà mai a smaltire. Si noti che presto o tardi un taglio del debito sarà inevitabile. Eppure, contro ogni buon senso, i creditori non cessano di esigere il riconoscimento formale di un onere debitorio realmente insostenibile. Fino a poco tempo fa ribadivano anzi una pretesa surreale: quella di un avanzo primario superiore al 4%, ridotto poi a un 1% comunque non realistico. Così è fallito finora ogni tentativo di arrivare un accordo da cui dipende il futuro dell’Ue, soltanto in nome della pretesa dei creditori di mantenere in piedi una finzione.
Per parte mia, non sono in grado di giudicare se i procedimenti tattici del governo greco siano fondati su una strategia ragionata, o in qualche misura determinati da condizionamenti politici, incompetenza o inesperienza dei suoi esponenti. Ma le carenze del governo greco non tolgono nulla allo scandalo dell’atteggiamento dei politici di Bruxelles e Berlino, che rifiutano di incontrare i loro colleghi di Atene in quanto politici. Anche se si presentano come tali, sono presi in considerazione esclusivamente sul piano economico, nel loro ruolo di creditori. Questa trasformazione in zombie ha il significato di conferire alle annose insolvenze di uno Stato la parvenza di una questione di diritto privato, da deferire a un tribunale. In tal modo risulta anche più facile negare qualsiasi responsabilità politica.
L’ADDIO DELLA TROIKA
La nostra stampa ironizza sul cambio di nome della troika, che effettivamente assomiglia a un’operazione di magia. Ma è anche espressione del desiderio legittimo di far uscire allo scoperto, dietro la maschera dei finanziatori, il volto dei politici. Perché è solo in quanto tali che i responsabili possono essere chiamati a rispondere di un fallimento che porta alla distruzione di massa delle opportunità di vita, alla disoccupazione, alle malattie, alla miseria sociale, alla disperazione.
Per le sue opinabili misure di salvataggio Angela Merkel ha coinvolto fin dall’inizio l’Fmi. Questa dissoluzione della politica nel conformismo di mercato spiega tra l’altro l’arroganza con cui i rappresentanti del governo federale tedesco – persone moralmente ineccepibili, senza eccezione alcuna - rifiutano di ammettere la propria corresponsabilità politica per le devastanti conseguenze sociali che pure hanno messo in conto nell’attuazione del programma neoliberista. Lo scandalo nello scandalo è l’ingenerosità con cui il governo tedesco interpreta il proprio ruolo di guida.
IL RUOLO TEDESCO
La Germania deve lo slancio della sua ascesa economica, di cui si alimenta tuttora, alla saggezza delle nazioni creditrici, che nell’accordo di Londra del 1954 le condonarono la metà circa dei suoi debiti.Ma non si tratta qui di scrupoli moralistici, bensì di un punto politico essenziale: le élite della politica europea non possono più nascondersi ai loro elettori, eludendo le decisioni da prendere a fronte dei problemi creati dalle lacune politiche dell’unità monetaria. Devono essere i cittadini, e non i banchieri, a dire l’ultima parola sulle questioni essenziali per il destino dell’Europa. E davanti all’intorpidimento post-democratico di un’opinione pubblica tenuta ove possibile lontano dai conflitti, ovviamente anche la stampa dovrà fare la sua parte. I giornalisti non possono continuare a inseguire come un gregge quegli arieti della classe politici che li già li avevano ridotti a fare da giardinieri.
 La follia, accettata da (quasi) tutti è che si accetti come un fatto normale che in questa Europa le decisioni che ammazzano i popoli e le loro volontà democraticamente espresse siano affidate a una Triade nessuno dei quali membri siano stati eletti (e due non siano neppure europei).
La follia, accettata da (quasi) tutti è che si accetti come un fatto normale che in questa Europa le decisioni che ammazzano i popoli e le loro volontà democraticamente espresse siano affidate a una Triade nessuno dei quali membri siano stati eletti (e due non siano neppure europei).
La Repubblica, 22 giugno 2015
Il meeting di giovedì scorso dell’Eurogruppo è scivolato via e passerà alla storia come un’occasione perduta di dar vita a un accordo tra la Grecia e i suoi creditori, per altro già tardivo. Forse, l’osservazione più significativa proferita da un ministro delle Finanze tra i partecipanti è stata quella dell’irlandese Micheal Noonan, che ha protestato perché i ministri delle Finanze non erano stati messi al corrente della proposta avanzata dalle istituzioni al mio governo. La zona euro si muove in modo misterioso. Decisioni di importanza preminente sono approvate senza riflettere da ministri delle Finanze che restano all’oscuro dei dettagli, mentre i funzionari non eletti di istituzioni potentissime sono bloccati in negoziati con una parte sola, un governo isolato e in difficoltà.
 Come si sta distruggendo la democrazia in Italia. in Francia e in Europa, senza che la "libera stampa" taccia quando si dovrebbe svelare e denunciare (e protesti solo a cose fatte).
Come si sta distruggendo la democrazia in Italia. in Francia e in Europa, senza che la "libera stampa" taccia quando si dovrebbe svelare e denunciare (e protesti solo a cose fatte).
Sbilanciamoci.info, 21 giugno 2015
Non è neppure sfiorato dal sospetto che le minoranze non sono una disgrazia ma una condizione della democrazia; forse non ha mai saputo che della loro possibilità di muoversi in parlamento il garante è lui in quanto leader della maggioranza, convinto com’è che governare sia decidere da solo e per tutti. Due giorni dopo ha messo in atto le sue vendette rinviando una riforma della scuola e le attesissime centomila assunzioni di insegnanti che essa comportava dopo anni e anni di immobilità.
In verità gli attuali governi si prendono più di una libertà con i principi di quella democrazia rappresentativa che per loro sarebbe il santo dei santi, metro della misura della maturità e convenienza del sistema politico. Francia e Italia li stanno violando tutte e due sulla scuola, dove le politiche governative hanno incontrato resistenze inattese. In Italia, Renzi non è riuscito a far digerire agli insegnanti la sua “buona scuola”; quasi nelle stesse settimane in Francia la giovane ministra dell'istruzione Najat Vallaud-Belkacem (che ha sostituito il precedente ministro Benoît Hamon, messo da Hollande nella condizione di doversi dimettere perché troppo di sinistra) ha rapidamente deciso assieme al premier di ricorrere al fatale articolo 39-4, marchingegno infilato da De Gaulle nella costituzione del 1958, grazie al quale il governo ha diritto una volta per sessione parlamentare di bypassare il parlamento sulla misura che più gli preme; stavolta era la riforma del Collège, simile alla nostra media. Sembra che a suo tempo Michel Rocard vi sia ricorso una trentina di volte. Per chiudere il becco ai deputati il nostro governo ha finora usato il voto di fiducia, ma qualcuno deve aver suggerito a Renzi, Padoan, Poletti e compagnia di imitare i francesi introducendo il via libera anche da noi. Così ce lo troveremo nella prossima legge costituzionale nella distrazione (o accettazione) di tutto il Pd. Lo aveva già adocchiato nel 1935 Benito Mussolini. Ma soltanto i vecchi rottamandi e qualche gufo come me ne sono rimasti strabiliati, sia per l'Italia sia per la Francia, madre – a sentirla – di tutte le repubbliche.
Così non ci si deve più meravigliare se un centinaio di migranti abbia dormito alcune notti sugli scogli adiacenti al posto di frontiera vicino a Ventimiglia perché tirato giù a forza dalla polizia dai vagoni della linea che, percorsa la Costa azzurra, raggiunge Parigi e il sospirato nord e di là l'Olanda, magari l'Inghilterra, invece che la più ospitale ma linguisticamente incomprensibile Svezia. Quel gruppetto di disgraziati, avvolti dal freddo e dall'umidità oltre che indolenziti dalla dura roccia, è l'immagine parlante di un'Europa spietata, anzi della Commissione spietata che la governa perché gli abitanti francesi e italiani, al di qua e al di là del confine, lo varcano per dare loro una coperta calda.
La gente è meglio dei governi del nostro continente senza vergogna che, se potesse, metterebbe sugli scogli, e non gli mancano, l'intera Grecia, colpevole di avere speso senza pagare le tasse, peraltro non sotto l'egida dei detestati Tsipras e Varoufakis, ma dei precedenti Papandreu e Samaras. Nessuno quanto la Commissione era in grado di conoscere per filo e per segno l'allegra finanzia ellenica, ma a quei governi non aveva rimproverato né segnalato niente.
Della Commissione europea la perla è la libera stampa che si sveglia ogni tanto dal suo sonno scoprendo, a cose fatte, qualche orrore del Jobs Act tranquillamente digerito a suo tempo come la libertà data all'impresa di spiare con ogni possibile mezzo i suoi dipendenti, vita privata e opinione politica. Anche i sindacati più benigni con il padronato stanno protestando indignati. E non si può neanche dire meglio tardi che mai, perché la delega imposta è passata a suo tempo senza che battessero ciglio e ora disfare il già legiferato non sarà facile. Renzi, Poletti e le loro ministre dalle chiome lunghe come l'abitudine di non aprire il becco sembrano aver approvato alcune misure del premier che sta confezionando un paese su misura della destra, tale che nemmeno Berlusconi se l’era sognato.
 «L’Unione europea non ha più alibi; un diritto di asilo europeo sarebbe un passo necessario, e un segno di voler invertire questo elenfantiaco attendismo, a tutti gli effetti un invito ai singoli Paesi a fare da soli, magari alzando muri».
«L’Unione europea non ha più alibi; un diritto di asilo europeo sarebbe un passo necessario, e un segno di voler invertire questo elenfantiaco attendismo, a tutti gli effetti un invito ai singoli Paesi a fare da soli, magari alzando muri».
La Repubblica, 22 giugno 2015
Poco europeista, e indifferente alle critiche rivolte dai partner europei alla riforma autoritaria della Costituzione varata nel 2013, il primo ministro ungherese Viktor Orbán è diventato all’improvviso il difensore delle frontiere europee, deciso a costruire una barriera fisica che sigilli l’Europa sigillando l’Ungheria. E ha dato l’annuncio proprio mentre Papa Francesco lanciava il suo monito a quelle nazioni che “chiudono le porte” a coloro che cercano non tanto una vita migliore, ma la vita pura e semplice. Criticando la decisione ungherese, il rappresentante dell’Agenzia Onu per i Rifugiati, Kitty McKinsey, ha ricordato che «quello di chiedere asilo è un diritto inalienabile. Erigere una barriera significa mettere ulteriori ostacoli a questo diritto ». I diritti inalienabili sono però impotenti, senza Stati ed eserciti che li impongano e li difendano. E la buona volontà e lo spirito umanitario si fanno moneta rara in questi tempi di crisi economica e con un’Europa che non ha autorità ed è destituita di autorevolezza. A premere verso l’Europa ci sono in primo luogo rifugiati, persone che sono sradicate dai loro Paesi a causa di guerre e persecuzioni, e della fame e assenza totale di risorse che esse provocano. Non emigrano ma fuggono; non cercano una vita più decente ma cercano di sfuggire alla morte e alla tortura. E l’Europa si trova all’improvviso viva; anzi, la sua esistenza si intensifica mano a mano che questi disperati premono alle sue frontiere.
Strano destino quello dell’Europa: un’entità che non è politica (e non sembra volerlo essere) e che però scopre di poter avere frontiere arcigne e ben protette, proprio come se fosse uno stato fortemente nazionalista. Un paradosso stridente di cui l’Europa né carne né pesce si rende responsabile, poiché questo non-essere-politica la rende un facile espediente nelle mani di chi si trova per caso ad essere un guardiano delle sue frontiere. Il ministro ungherese degli affari esteri ha detto che il suo governo ha ordinato che comincino subito i lavori per la costruzione di una barriera lunga 175 chilometri. La decisione ha generato sorpresa e indignazione, soprattutto tra i serbi, anche se, in effetti, non sono loro i veri destinatari di questo nuovo muro, ma i migranti dall’Africa e dal Medio oriente. La Serbia si adonta ma per una ragione che non è più nobile: perché si sente resa responsabile della situazione che ha provocato queste ondate di migranti, mentre ad essere responsabili di questa crisi, si legge in alcuni commenti, sono gli Stati Uniti, o per non essere intervenuti (come in Siria) o per essere intervenuti (come in Libia). L’Europa e gli Stati europei come vittime, dunque.
E intanto, ci si dimentica che l’Europa, nata per smantellare le barriere al suo interno ed essere un territorio di libera circolazione per cittadini di varie nazionalità, oggi diventa un comodo paravento per nuovi e rinati nazionalismi. Ancora in questi giorni, i ministri degli esteri dei Paesi europei non sono riusciti a giungere alla decisione di redistribuire tra i vari Paesi membri le diverse migliaia di siriani ed eritrei arrivati sul vecchio continente.
A fronte di questi dati e dei soldi spesi a creare barriere stanno migliaia di rifugiati e richiedenti asilo che non hanno di che ripararsi e vivere. L’Unione europea non ha più alibi; un diritto di asilo europeo sarebbe un passo necessario, e un segno di voler invertire questo elenfantiaco attendismo, a tutti gli effetti un invito ai singoli Paesi a fare da soli, magari alzando muri.
 Le cinque bugie dei media d'osservanza renziana a proposito del mostro "la buona scuola" partorito dal nefasto comandante ancora insediato al vertice dei Palazzi. Dal
Le cinque bugie dei media d'osservanza renziana a proposito del mostro "la buona scuola" partorito dal nefasto comandante ancora insediato al vertice dei Palazzi. Dal
blog di Walter Tocci, 22 giugno 2015
1. Assunzioni – E’ l’argomento più devastato dalla disinformazione. Intanto i posti disponibili non sono 100 mila ma circa 150 mila, come d’altronde ammise lo stesso governo nel documento iniziale della buona scuola. Ci sarebbero quindi la capienza e i soldi per assorbire già quest’anno quasi tutte le graduatorie a esaurimento, gli idonei e una parte degli abilitati, completando poi l’operazione con il piano poliennale.
Si poteva dare una risposta ai precari prima della “buona scuola”, come si fece guarda caso nei confronti degli imprenditori con il decreto Poletti approvato prima del Jobs Act. I fondi stanziati nella legge di stabilità consentivano di approvare già a gennaio una legge di poche righe per chiamare i nuovi insegnanti. Anche senza la legge bisognava comunque coprire 44 mila posti, anzi sarebbe un’omissione di atti d’ufficio non assumere nessuno. Le procedure dovevano essere attivate con largo anticipo, e invece si faranno le nomine in affanno ad agosto. Il governo rischia il caos all’inizio dell’anno scolastico per utilizzare i centomila come arma di pressione nell’approvazione di una legge sbagliata.
2. Autonomia. Si continua a ripetere che per fare le chiamate occorre il nuovo modello organizzativo della buona scuola. E’ falso. Già sono in vigore tutte le norme sull’organico dell’autonomia, sul potenziamento, sulle reti di scuole. Furono ben scritte nella legge n. 35 del 2012 sotto la guida di un sottosegretario competente come Marco Rossi Doria:
“Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, .. secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro.. sono adottate.. linee guida per conseguire le seguenti finalità: a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.. ; b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico; c) costituzione di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie; d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica”.
Il governo doveva quindi solo adottare le linee guida e procedere alle assunzioni. Ma era forse troppo semplice, ha preferito riscrivere le stesse norme in un confuso testo di cento pagine pur di poter dire che si faceva la riforma della scuola. Comunicare è sempre più facile che governare.
3. Alternanza scuola lavoro – Anche qui si tratta di una novità già vista. Il Parlamento aveva legiferato in materia (n. 128 del 2013), rinviando l’attuazione a un regolamento, ma il governo invece di scriverlo ricomincia da capo chiedendo una delega a scrivere il regolamento. Fa più notizia approvare una legge che attuarla. Bastava finanziare la norma esistente e occuparsi invece di come si innalza la didattica del saper fare. L’alternanza non va confusa con l’apprendistato, non è neppure un pendolo tra scuola e lavoro, ma una connessione cognitiva tra due diverse esperienze formative.
4. Più soldi agli insegnanti – I soldi promessi con la Card (spese per la formazione e la cultura) e l’incentivo individuale non compensano i tagli subiti in busta per i mancati rinnovi contrattuali e il blocco degli scatti. Bastava restituire il maltolto e gli insegnanti avrebbero speso gli adeguamenti salariali a loro piacimento. Non hanno bisogno dei consigli del governo per acquistare un libro o andare al cinema.
Sull’incentivo si sono dette tante sciocchezze. Non c’entra nulla con la valutazione, come spiegano bene gli esperti, si ridurrà a un compenso per le persone che coadiuveranno il preside nelle funzioni didattiche e gestionali, come previsto al comma 6 dell’articolo 9 del testo Camera. Anche questo strumento è già disponibile nella normativa vigente, con la retribuzione di incarichi e progetti finanziati dal Fondo MOF che però ha subito un taglio di circa il 50%. Bastava rimpinguarlo almeno con i 200 milioni previsti per l’incentivo e il governo si sarebbe risparmiato il conflitto con il mondo della scuola.
5. Cultura umanista(ica) – L’attenzione si è rivolta all’errore grammaticale dello speech presidenziale, ma è più grave il contenuto. Si complica la questione didattica invece di migliorarla. Sono ripristinate alcune discipline che erano state cancellate dalla Gelmini, dall’arte, alla musica, non la geografia chissà perché. È una meritoria intenzione ma il metodo è vecchio. Si aggiungono singole discipline che inevitabilmente vanno a restringere il tempo disponibile delle altre, senza una rielaborazione della metodologia. Si aggrava il difetto dell’attuale didattica, già troppo estensiva e poco intensiva. Il mondo nuovo richiede precisamente il contrario.
Questi cinque punti seguono le schema utilizzato dal Presidente Renzi per riassumere la “buona scuola”. Come si vede sono tutte vecchie novità, che riprendono le norme già in vigore e in molti casi le complicano inutilmente. L’unica vera novità è il potere del preside di nominare gli insegnanti. Si apre una breccia al clientelismo, all’aumento delle diseguaglianze, alle scuole di tendenza ideologica proprio mentre premono alle porte i fondamentalismi, come si è visto nella manifestazione dei cattolici integralisti. Soprattutto, la chiamata diretta conferisce al preside il potere illegittimo di derogare le graduatorie di merito certificate dallo Stato nei concorsi pubblici. L’insegnante perderebbe la titolarità della cattedra e quindi la libertà di insegnamento, come il lavoratore perde la tutele con il Jobs Act.
L’unica novità è l’applicazione ossessiva di uno solo al comando anche nel mondo della scuola. Nessuno dei veri problemi viene affrontato, né la riforma dei cicli, né l’abbandono degli studenti, né il neoanalfabetismo degli adulti. I centomila sono utilizzati come una clava per imporre scelte inutili o dannose. Uno, nessuno e centomila, è il titolo di un dramma che racconta lo smarrimento del protagonista.

Le immagini dei profughi bloccati a Ventimiglia hanno scioccato l’opinione pubblica da una parte e dall’altra delle Alpi. Ma tra quelle immagini c’è una foto che va ben oltre l’indignazione suscitata dal blocco. In essa si vedono dei migranti avvolti in coperte isotermiche che lottano contro il freddo sugli scogli in riva al mare. È stata scattata il 15 giugno. Se è assurta a icona probabilmente è perché quei rifugiati avvolti in coperte non hanno più forma umana, sono fantasmi, spettri, marziani venuti da un altro pianeta. In ogni caso non sono del tutto umani, della loro antica condizione conservano solo un’impronta sulla pellicola di poliestere che funge loro da involucro, sono dei mutanti, dei white walkers, dei morti viventi… Sono lo spettro della nostra società. L’immagine ci invita ad analizzare gli avvenimenti di questi ultimi giorni non solo in termini giuridici, politici o morali, ma come un teatro, il teatro della sovranità perduta.
 «Non votano più. Perché non solo vanno trovate parole che scaldino il cuore e la mente, che dicano di mondi da cambiare, di giustizia da rivendicare, di lotte da sostenere. Servono volti che quelle parole, quei mondi, quelle lotte le rendano riconoscibili».
«Non votano più. Perché non solo vanno trovate parole che scaldino il cuore e la mente, che dicano di mondi da cambiare, di giustizia da rivendicare, di lotte da sostenere. Servono volti che quelle parole, quei mondi, quelle lotte le rendano riconoscibili».
Il manifesto, 21 giugno 2015
Un messaggio che va oltre il tracollo del Pd, travalica la baldanza della destra con la faccia feroce di Salvini e della Lega, il consolidamento nei territori dei M5S, proiettati su una dimensione di governo. Preferiscono di no, gli elettori e le elettrici di sinistra. Preferiscono non votare, e se votano, allora scelgono M5S. Almeno sembra utile.
È la fine non della storia, ma di una storia, proprio come se fosse una storia d’amore. E come nella fine degli amori quello che si perde sono le parole, i luoghi, i riti. Quello che aveva un senso unico e speciale, e brillava di una chiarezza luminosa di immediata comprensione, d’improvviso si spegne, ritorna parola e luogo anonimo, indistinguibile tra gli altri. Si scioglie il legame stringente, sembra che nulla riesca più ad accendere la passione. Rimangono ricordi, memorie, a volte brevi fiammate.
Il linguaggio amoroso restituisce e chiarisce più di altri, a me sembra, quanto avviene. E ben di più dell’uso indiscriminato della categoria dell’antipolitica rende ragione della fine dell’avventura. Non siamo negli anni Novanta, e neppure nel primo decennio del Duemila. Non è solo né principalmente il rancore, che tanto si è analizzato in passato, il motore della nuova astensione e dei nuovi flussi di voto. Gli elettori e le elettrici che hanno preferito di no, in questa tornata elettorale, quelli con radicate scelte di sinistra, come già si era visto in Emilia Romagna lo hanno fatto per scelta politica. Quasi un atto estremo, disperato, forse, ma l’unico possibile. Per dire che non ci credono più. Non credono più all’insieme di sigle che a ogni competizione elettorale si presentano a garantire con i loro richiami al passato comune la continuità di una storia. Perché in realtà non garantiscono nulla. Da tempo. Perché quella storia non c’è più.
È un punto di non ritorno, in cui è essenziale la comprensione di quanto avviene, nel gioco delle forze come nel dispiegarsi dei sentimenti. Per questo non è il momento di rinvii o indugi. Bisogna buttarsi nell’impresa, dove si è, come si è.
Non ci sono trucchi, formule magiche, autorità esterne che possano garantire alcunché. È l’atto di coraggio che il presente richiede. Quale impresa? Entrare con molta attenzione nello spazio vuoto che gli elettori hanno creato. Con l’atto netto, autorevole e umile di aprire ora, adesso un processo costituente, in un’assemblea entro luglio. Indetta da parte di chi c’è, ora, adesso: forze politiche, gruppi, associazioni, chi si muove nell’area aperta alla sinistra del Pd. Con la consapevolezza che il gesto – necessario – non è per nulla sufficiente. Per questo, tra le virtù richieste, l’umiltà è indispensabile. L’impresa più difficile è essere credibili e convincenti, mostrare nelle pratiche che non ci si muove in una logica pattizia, che non si tratta di manovre in vista di nuovi cartelli elettorali, per esempio per le elezioni della prossima primavera in comuni importanti come Milano e Napoli. Insomma, occorre un passo indietro. Bisogna agire il paradosso attuale, oggi assumersi responsabilità politica significa fare spazio, allargare, aprire. Non solo perché gli elettori non perdonano, quindi una scelta adottata per necessità tattica. Ma per convinzione intima, autentica. È la parte più difficile.
Perché non solo vanno trovate parole che scaldino il cuore e la mente, che dicano di mondi da cambiare, di giustizia da rivendicare, di lotte da sostenere. Servono volti che quelle parole, quei mondi, quelle lotte le rendano riconoscibili. Come in un romanzo, o in un film, o in una serie tv, sono i personaggi che danno gambe alla storia che si racconta. Che la rendono vera e potente, viva nella mente di chi partecipa. E visto che non scriviamo un romanzo, ma parliamo di vite, di dolori, di rabbia reale, sono le lotte in corso, i protagonisti e le protagoniste sociali a interpretare questa storia.
Tutto il movimento intorno alla scuola, compreso il sommovimento intorno alla pretesa «ideologia di genere», le lotte per la casa, la nuova attenzione ai beni comuni, il lavoro sempre più svalorizzato. Che qui, in Italia, si faccia fatica a fare spazio alle donne, che pure esistono, attive e autorevoli, fa parte del problema. Che sia così arduo creare una mobilitazione convinta intorno alla tragedia della migrazione dice fino a che punto sono logori i legami, i vincoli, perfino le scelte ideali. È tempo di un nuovo amore.
Non ho usato volutamente termini come coalizione sociale e coalizione politica, non ho parlato d’altro. Ciò che importa è lo spazio che si apre, in queste azioni che non possono che intrecciarsi. Da cui possono passare soggetti, movimenti, persone che da troppo tempo vivono altrove e altrimenti. Fino a quando si potrà dire: preferisco di sì.

Quale sarà il grave pericolo per i bambini che ieri ha fatto scendere in piazza decine di migliaia di persone al grido di “salviamo i nostri figli”?
A sentir loro è l’indistinzione dei sessi, che sarebbe la conseguenza sia di una educazione che insegni a maschi e femmine a rispettarsi reciprocamente e a non chiudersi (e non chiudere l’altra/o) in ruoli stereotipici e rigidi, sia del riconoscimento della omosessualità come un modo in cui può esprimersi la sessualità, della legittimità dei rapporti di amore e solidarietà tra persone dello stesso sesso e della loro capacità genitoriale. Stravolgendo le riflessioni di sociologhe/i, filosofe/ i, antropologhe/i, persino teologhe/i sul genere come costruzione storico-sociale che attribuisce ai due sessi capacità, destini (e poteri) diversi e spesso asimmetrici, attribuiscono ad una fantomatica “teoria del genere” e alla sua imposizione nelle scuole - e la parola gender spiccava ieri sui cartelloni innalzati in piazza - la negazione di ogni distinzione tra i sessi e la volontà di indirizzare i bambini e i ragazzi verso l’omosessualità o la transessualità, quasi che l’orientamento sessuale sia esito di scelte intenzionali e possa essere orientato dall’educazione.
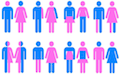 «Una manifestazione così massiccia come si è vista ieri a Roma contro «l’ideologia
«Una manifestazione così massiccia come si è vista ieri a Roma contro «l’ideologia
gender», ha fatto esplodere un sentimento covato da una parte consistente del mondo cattolico, ma senza input dall’alto, senza la mobilitazione partita dai pulpiti». Ne siamo proprio sicuri? Corriere della Sera, 21 giugno 2015 (m.p.r.)
Parte del mondo cattolico ha manifestato la sua disperazione culturale per un modo di vedere le cose, il demonizzato «gender», che sradica l’umanità da se stessa. È stata fornita un’immagine implicitamente polemica verso l’atteggiamento «accomodante» del Papa.
Afferma il filosofo, intervistato da Anais Ginori:«Penso in particolare ad afgani, iracheni, siriani, etiopi, libici, maliani. Noi occidentali abbiamo, almeno in parte, la responsabilità di queste persone: se non possono restare nel loro Paese è anche per colpa nostra».
La Repubblica, 21 giugno 2015 (m.p.r.)
Parigi. «Le scene di respingimento degli stranieri al confine franco-italiano sono insopportabili, vergognose». Il filosofo bulgaro Tzvetan Todorov è indignato dall’atteggiamento del governo socialista che ha blindato le frontiere, esattamente come fece quattro anni fa l’esecutivo della destra di Nicolas Sarkozy. Le maggioranze politiche cambiano ma la paura ancestrale dei “barbari”, che Todorov ha raccontato nei suoi saggi, riaffiora comunque. «Siamo responsabili in parte di questi movimenti migratori », spiega ricordando come il rigetto dello straniero non sia nuovo per i francesi. Centocinquant’anni fa, i “topi” da cacciare erano gli italiani che varcavano il confine per sfuggire alla povertà. «La Francia ha sempre avuto difficoltà ad accettare il passaggio da grande a media potenza, sperimentando nella sua Storia regolari picchi di febbre nazionalista».

I rapporti tra Grecia ed Europa sono arrivati a una stretta decisiva. Tra ora e lunedì pomeriggio, quando si riunisce a sorpresa il Consiglio europeo, possono succedere quattro cose.
La prima – quella auspicabile — è un accordo sulla base della proposta del leader greco Alexis Tsipras: fine dell’austerità, sblocco degli aiuti europei previsti, ristrutturazione radicale del debito. Ma perfino il più morbido, Jean-Claude Juncker, ha detto ieri «non capisco Tsipras. Non mi è possibile evitare ad ogni costo il fallimento dei colloqui». Non si prepara un accordo dicendo che c’è un dialogo tra sordi.
La seconda possibilità è che i colloqui di questo fine settimana portino a un compromesso intermedio: fondi ponte europei per il rimborso degli 1,6 miliardi di euro da restituire al Fondo monetario a fine giugno. E nel frattempo, ieri sono arrivati 2 miliardi del fondo di liquidità di emergenza fornito da Mario Draghi alle banche di Atene. Dopo che molti miliardi di capitali sono fuggiti dal paese.
La terza possibilità è la più probabile. Una rottura radicale tra Atene e Bruxelles. Il primo messaggio l’ha dato Mario Draghi lunedi scorso (ma l’aveva già detto il 18 aprile) «se la crisi dovesse precipitare, entreremmo in acque sconosciute». Pierre Moscovici, commissario europeo all’economia, l’ha confermato venerdi: «Siamo alla fine dei giochi. È ora di agire e decidersi. Non c’è molto tempo per evitare il peggio». Ancora più esplicito Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo: la Grecia deve accettare la nostra offerta, «o avviarsi verso il default». Ma la proposta europea è quella di una ritorno al passato che Syriza non potrà mai accettare. Così Alexis Tsipras, ieri a San Pietroburgo con Putin, ha replicato tranquillo: «Siamo al centro di una tempesta, ma non ci spaventa il mare aperto, siamo pronti a solcare nuovi mari».
Quale forma potrà prendere la rottura? E con quali tempi? Ci sono tre «strappi» possibili. Il più morbido è una dichiarazione d’insolvenza senza uscire dall’euro. Atene annuncia che non ripagherà il debito pubblico detenuto per l’80% da fondi europei d’emergenza, paesi membri, Fmi, Bce, né pagherà gli interessi dovuti. Si toglie in questo modo la pietra che ha al collo, la spesa pubblica greca non viene intascata dalla finanza, l’economia riparte.
Se la Bce fosse d’accordo, continuerebbe ad alimentare la liquidità delle banche greche, e troverebbe il modo di gestire senza troppi danni i 322 miliardi di euro non ripagati. Il grande vantaggio sarebbe evitare il contagio: nessuna speculazione sulla fine dell’euro. Ma sarebbe un precedente pericoloso di vittoria di un paese indebitato e un trionfo politico per Syriza che Berlino difficilmente potrebbe permettere. L’alternativa opposta – un’uscita dall’euro senza insolvenza – darebbe ad Atene solo svantaggi: svalutazione e un debito sempre più impossibile da restituire.
Resta l’uscita dall’euro accompagnata dal default sul debito pubblico. L’Eurozona e Berlino si liberano del paese membro indisciplinato, Atene riprende la sua autonomia di politica economica con una dracma che si svaluta immediatamente (magari del 40%), il debito che non si paga, i mercati finanziari che dichiarano guerra alla Grecia, l’economia che crolla per poi riprendersi. Berlino tira un sospiro di sollievo, ma a Roma, Madrid e Lisbona e nei piccoli paesi dell’est europeo inizia l’incubo: spread alle stelle, scommesse su chi sarà il prossimo a uscire, assalto della speculazione.
A meno che l’Eurozona garantisca a tutti i soci «buoni» dell’euro le garanzie che avrebbero potuto salvare la Grecia e l’Europa fin dall’inizio: mutualizzazione del debito, azzeramento dello spread con gli interventi della Bce, blocco della speculazione della finanza.
Come si realizza questa rottura? Prima un periodo di attesa e le rassicurazioni sulla stabilità dell’euro e dell’Europa, poi si aspetta la chiusura di borse e banche il venerdi sera, il sabato e domenica si bloccano i movimenti di capitale e – se torna la dracma – si forniscono le banche delle nuove banconote fresche di stampa in arrivo da Mosca o Pechino.
Nel week end si annuncia la rottura, a mercati chiusi, e il lunedi il Consiglio europeo sancisce il cambiamento, spergiurando sull’unità dell’Europa e dell’euro. È quello che è successo nei giorni scorsi e che potrebbe succedere proprio in queste ore. Oppure tutto questo si prepara per il prossimo fine settimana, alla scadenza del rimborso per il Fondo monetario. O magari nel mezzo dell’estate, come la fine di Bretton Woods il 15 agosto 1971.
Un interrogativo decisivo è se l’eventuale rottura avviene in forma concordata — una separazione consensuale — o al culmine di uno scontro politico. Nel primo caso l’Europa potrebbe sopravvivere e lo choc in una Grecia impoverita, ma non più oppressa, potrebbe essere superato in qualche mese. Nel secondo caso potrebbe succedere qualunque cosa, un avvitamento caotico che farebbe a pezzi l’Europa insieme alla Grecia.
Lo scenario più drammatico sarebbe proprio questo: nessuna proposta al Consiglio europeo di lunedì, nessun «piano B», nessun accordo nemmeno su come separarsi, l’Europa che si accanisce contro la culla in cui è nata, una crisi verticale dell’economia greca, una strategia della tensione contro il governo di Syriza, un contagio che da debito si estende al collasso politico dell’Europa. C’è qualche margine per evitare questo peggio. E per sostenere fino in fondo le ragioni di Alexis Tsipras e della Grecia, con l’euro o con la dracma. Che sono le ragioni della democrazia, ad Atene come in Europa.
 «Primo Levi scriveva che ciò che è successo avrebbe potuto, per ciò stesso, succedere ancora. Pareva esagerato. Invece no. Tra i campi nazisti e le odierne barriere vi è ancora una non trascurabile differenza. Ma la strada è tracciata se non invertiamo la marcia».
«Primo Levi scriveva che ciò che è successo avrebbe potuto, per ciò stesso, succedere ancora. Pareva esagerato. Invece no. Tra i campi nazisti e le odierne barriere vi è ancora una non trascurabile differenza. Ma la strada è tracciata se non invertiamo la marcia».
Il Garantista, 20 giugno 2015
Chi l’avrebbe detto che dopo l’abbattimento festoso del muro di Berlino nel 1989, i muri si sarebbero moltiplicati? Le note di Bach, dalle suite per violoncello solo, suonate davanti a quelle storiche macerie da Mstislav Rostropovich accorso a Berlino l’11 novembre del 1989, sembravano avere posto fine alle divisioni, agli steccati, alla visione concentrazionaria del mondo. Pure illusioni.
Chi costruisce muri o produce filo spinato, fa affari al giorno d’oggi. Mari e muri si ergono come barriere mortali contro i migranti. Da Ceuta a Melilla; da Tijuana al costruendo muro in Ungheria; dal muro costruito dagli israeliani per separarli dai palestinesi a quello tra India e Bangladesh; e altri ancora: sono 50 le barriere artificiali e ostili sparse in tutto il mondo. Circa 8mila chilometri hanno il compito di separare esseri umani e difendere i più ricchi dalla contaminazione con i più poveri. Alcuni sono grezzi, altri in mattoni, altri mettono in campo materiali più moderni, altri tornano al filo spinato dei campi di concentramento della seconda guerra mondiale. Non a caso Primo Levi scriveva, a conclusione della sua opera, che quello che voleva dire poteva essere riassunto nel fatto che ciò che è successo avrebbe potuto, per ciò stesso, succedere ancora. Pareva esagerato. Invece no. Certo tra i campi nazisti e le odierne barriere vi è ancora una non trascurabile differenza. Ma la strada è tracciata se non invertiamo la marcia.
Papa Francesco ha fatto sentire la sua voce, potente e chiara. Nella sua ultima enciclica non si rivolge solo agli uomini di buona volontà, come Giovanni XXIII nella “Pacem in terris” ma a “ogni persona che abita questo pianeta”. Gli è toccata la risposta volgare di un qualunque Salvini. Pietà l’è morta? Come diceva una bella canzone partigiana? No, non ancora per fortuna. Lo dimostra la manifestazione di sabato 30 a Roma, e tante iniziative di solidarietà che hanno alleviato in qualche misura le pene dei profughi in questi giorni nelle stazioni delle grandi città o sugli scogli di Ventimiglia. Ma l’aiuto spontaneo può bastare? Ovviamente no.
Il problema migratorio, date le cause di fondo che lo hanno generato che ci rimandano alla struttura del capitalismo globalizzato e finanzia rizzato, è di lungo periodo. Uno degli elementi caratterizzanti dell’epoca attuale. Con il quale la politica, se ancora esiste, deve misurarsi. Bisogna sapere affrontarlo nel breve e nel più lungo periodo. L’Europa non lo fa. Anzi su questa questione rinascono i nazionalismi, si ringalluzziscono con forza le organizzazioni di destra, si riproducono i più meschini conflitti di frontiera.
Invece ci sono delle cose che è possibile fare subito, come attivare un programma di ricerca e salvataggio in tutta l’area del Mediterraneo; evitare di pensare a interventi armati contro i paesi di provenienza; aprire canali umanitari e vie d’accesso al territorio europeo; sospendere il regolamento di Dublino che blocca i migranti nei paesi di primo arrivo; sospendere gli accordi di Rabat e di Khartoum che vorrebbero esternalizzare fino in Africa i confini europei; provvedere a piani di investimenti che favoriscano lo sviluppo dei paesi di provenienza, anziché vendere armamenti e fomentare guerre; favorire la rinegoziazione dei debiti pubblici di quei paesi, come del resto la Ue dovrebbe fare nei confronti della Grecia, anziché portarla irresponsabilmente sull’orlo del default.
Non è vero che l’Italia non può accogliere migranti. Anzi. Dal punto di vista squisitamente numerico la situazione è tutt’altro che quella che le televisioni ci trasmettono e che è frutto dell’incapacità di governo del fenomeno. In una recente intervista al Sole24Ore il responsabile dell’accoglienza immigrati, Mario Morcone, ci fa capire che c’è un’agitazione spropositata e strumentale attorno al tema, fino a farlo diventare uno degli argomenti o principali delle recenti campagne elettorali. “Ci sono oggi circa 90mila immigrati in accoglienza in tutta Italia – dice Morcone – è come dire che possiamo distribuire circa dieci stranieri per ognuno degli 8mila comuni del nostro Paese. L’impatto è senza dubbio sostenibile. Le cifre sono molto basse.” Certo la politica, neppure quella dell’accoglienza, si può fare con l’aritmetica, ma questa considerazione smonta alla radice l’allarmismo gettato a piene mani da Salvini a da Grillo.
E poi, è proprio vero che gli immigrati sono un peso e non una risorsa per il nostro paese? Il nostro è un paese che invecchia – ci avverte l’Istat -; la crescita demografica è sotto zero; il movimento naturale della popolazione, cioè il saldo tra nascite e decessi, ha fatto registrare nel 2014 un computo negativo di quasi 100mila unità, come non succedeva dagli ultimi due anni dalla “Grande Guerra” del ’15-’18; gli arrivi dall’estero hanno a mala pena compensato questo calo. Nessuno sogna una famiglia con sei figli, come al tempo del Duce, ma una società che solamente invecchia e non partorisce non ha un grande futuro.
Quindi le politiche di accoglienza dei flussi migratori dovrebbero fare parte non dell’emergenza negativa, ma delle nuove politiche di un nuovo modello di sviluppo per un paese europeo, e in particolare per il nostro paese. Questo chiama in causa le responsabilità della Ue e del governo Renzi. L’Europa pensata a Ventotene è sepolta dalle politiche di austerity e dalle concezioni del Vecchio Continente come fortezza.
Mentre scorrono le immagini delle forze dell’ordine che trascinano chissà dove i pacifici corpi dei migranti, si sta consumando il dramma greco. Sia verso l’esterno che al proprio interno le attuali politiche della Ue non reggono e rischiano di fare implodere il continente. L’intransigenze del Fmi e delle elite europee nei confronti della Grecia sono tipiche di chi si vuole perdere. Ha ragione Jeffrey Sachs, un economista americano, che ha recentemente avvertito che "Il governo greco ha ragione ad avere tracciato un limite invalicabile. Ha una precisa responsabilità nei confronti dei suoi cittadini. La vera scelta. dopo tutto, non spetta alla Grecia, bensì all'Europa" Quel limite invalicabile riguarda le pensioni, con cui gli anziani vengono in aiuto ai giovani, visto l’inesistenza , come in Italia, di qualunque forma di reddito minimo garantito, e i contratti collettivi nazionali di lavoro. Limiti di civiltà, di cui una volta il nostro continente andava fiero, ma che il cinismo del neoliberismo nella sue versione peggiore ha distolto dalla mente dei governanti europei.
 «Per tenere insieme i suoi valori, uguaglianza e fraternità, la socialdemocrazia ha sempre avuto bisogno di molti soldi, di crescita economica e forte tassazione, per pagare un sistema di welfare che è diventato il vanto del Vecchio Continente, ma oggi ne è anche la soma».
«Per tenere insieme i suoi valori, uguaglianza e fraternità, la socialdemocrazia ha sempre avuto bisogno di molti soldi, di crescita economica e forte tassazione, per pagare un sistema di welfare che è diventato il vanto del Vecchio Continente, ma oggi ne è anche la soma».
Corriere della Sera, 20 giugno 2015, con postilla
Come i dinosauri, anche il gigante della socialdemocrazia rischia l’estinzione? Le dimissioni presentate ieri alla regina di Danimarca da Helle Thorning-Schmidt, la più glamour dei leader della sinistra europea (Renzi escluso), sembrano l’ultimo segno di un destino crudele, e forse irreversibile, che si sta abbattendo sulla storia centenaria del riformismo. La vicenda danese è altamente simbolica. La giovane premier, sposata col figlio di Neil Kinnock, storico capo del laburismo britannico, non esce infatti di scena per una delle solite oscillazioni del pendolo elettorale; ma è stata travolta dal boom di quella destra anti-immigrati che dal circolo polare in Norvegia fino alla linea gotica in Italia sta rubando voti alla sinistra in nome di un «sacro egoismo» nazionale.
postilla
Il vicedirettore del Corriere della sera ha evidentemente dimenticato le sue letturegiovanili. Altrimenti ricorderebbe cosa accadde quando i “padroni delvapore” furono costretti a ridurre i loro profitti riducendo così lo sfruttamento in patria ed “esportarono lecontraddizioni” del sistema capitalistico, allargando l’area dello sfruttamentoad altri popoli e ad altri gruppi sociali. E’ certamente noto anche a lui che questomodo del sistema capitalistico di “salvarsi” ha prodotto, saccheggi, attizzato fuochi e disperazioni in ogni partedel globo, generato ribellioni e guerre. Sa certamente che guerresono utili al sistema capitalistico perché le spese militari contribuiscono acreare una domanda di merci che tiene in piedi quel sistema. Ci rendiamo contoche via Solferino è lontana dal Vaticano, e che nelle stanze del Corsera èdifficile formulare l’idea che ridurre drasticamante le spese militari, e lagigantesca lievitazione delle rendite finanziarie, potrebbe contribuire a garantirela sopravvivenza del welfare dove c’è, e magari a estenderlo dove ancora nonc’è. Ce ne dispiace un po', perchè Poilito è un bravo giornalista e il Corriere un giornale spesso interessante.
 «L’appello di Ian McEwan ai giovani americani “Solo il sapere umanistico ci rende sensibili ai diritti”».
«L’appello di Ian McEwan ai giovani americani “Solo il sapere umanistico ci rende sensibili ai diritti”».
La Repubblica, 20 giugno 2015 (m.p.r.)
Vorrei condividere con voi qualche riflessione sulla libertà di parola (e libertà di parola qui include la scrittura e la lettura, l’ascolto e il pensiero): la libertà di parola, la linfa vitale dell’esistenza, la condizione essenziale dell’educazione umanistica che avete appena ricevuto. Partiamo da una nota positiva: con ogni probabilità oggi sulla terra esiste più libertà di parola, più libertà di pensiero, più libertà di ricerca che in qualsiasi altro momento della storia conosciuta ( anche prendendo in considerazione l’età dell’oro dei cosiddetti filosofi “pagani”). Ma la libertà di parola è stata, è e sarà sempre sotto attacco: da destra, da sinistra, dal centro. L’attacco verrà da sotto i vostri piedi, dagli estremisti religiosi come da ideologie non religiose.
 «Con questa enciclica il gioco di far finta di non capire non sarà più possibile. Bisognerà stare o dalla parte di Francesco o contro di lui, perché sta chiedendo una scelta. E questo vale non solo per i politici, per gli opinionisti, per i giornali, vale anche per i vescovi, per i cardinali. E vale anche per i semplici fedeli».
«Con questa enciclica il gioco di far finta di non capire non sarà più possibile. Bisognerà stare o dalla parte di Francesco o contro di lui, perché sta chiedendo una scelta. E questo vale non solo per i politici, per gli opinionisti, per i giornali, vale anche per i vescovi, per i cardinali. E vale anche per i semplici fedeli».
Il manifesto, 19 giugno 2015 (m.p.r.)
C’è un debito estero dei Paesi poveri che non viene condonato, e anzi si è trasformato in uno strumento di controllo mediante cui i Paesi ricchi continuano a depredare e a tenere sotto scacco i Paesi impoveriti, dice il papa (e la Grecia è lì a testimoniare per lui). Ma il “debito ecologico” che il Nord ricco e dissipatore ha contratto nel tempo e soprattutto negli ultimi due secoli nei confronti del Sud che è stato spogliato, nei confronti dei poveri cui è negata perfino l’acqua per bere e nei confronti dell’intero pianeta avviato sempre più rapidamente al disastro ecologico, all’inabissamento delle città costiere, alla devastazione delle biodiversità, non viene pagato, dice il papa (e non c’è Troika o Eurozona o Banca Mondiale che muova un dito per esigerlo).
La denuncia del papa («il mio appello», dice Francesco) non è generica e rituale, come quella di una certa ecologia “superficiale ed apparente” che si limita a drammatizzare alcuni segni visibili di inquinamento e di degrado e magari si lancia nei nuovi affari dell’economia “verde”, ma è estremamente circostanziata e precisa: essa arriva a lamentare che la desertificazione delle terre del Sud causata dal vecchio colonialismo e dalle nuove multinazionali, provocando migrazioni di animali e vegetali necessari al nutrimento, costringe all’esodo anche le popolazioni ivi residenti; e questi migranti, in quanto vittime non di persecuzioni e guerre ma di una miseria aggravata dal degrado ambientale, non sono riconosciuti e accolti come rifugiati, ma sbattuti sugli scogli di Ventimiglia o al di là di muri che il mondo anche da poco approdato al privilegio si affretta ad alzare, come sta facendo l’Ungheria. L’«appello» del papa giunge poi fino ad accusare che lo sfruttamento delle risorse dei Paesi colonizzati o abusati è stato tale che dalle loro miniere d’oro e di rame sono state prelevate le ricchezze e in cambio si è lasciato loro l’inquinamento da mercurio e da diossido di zolfo serviti per l’estrazione.
Questa enciclica rappresenta un salto di qualità nella riflessione sull’ambiente, si potrebbe dire che apre una seconda fase nella elaborazione del discorso ecologico, così come accadde nel costituzionalismo quando dalla prima generazione dei diritti, quelli relativi alle libertà civili e politiche, si passò alla considerazione dei diritti di seconda e terza generazione, sociali, economici, ambientali, e cambiò il concetto stesso di democrazia.
Ora il discorso della giustizia sociale e della condizione dei poveri, a cui nei Paesi del Sud «l’accesso alla proprietà dei beni e delle risorse per soddisfare le proprie necessità vitali è vietato da un sistema di rapporti commerciali e di proprietà strutturalmente perversi», viene introdotto organicamente da papa Francesco nella questione ecologica, sicché essa non riguarda più semplicemente l’ambiente fisico, il suolo, l’aria, l’acqua, le foreste, le altre specie viventi, ma assume la vita e il destino di tutti gli esseri umani sulla terra, diventa un’«ecologia integrale», a cui è dedicato l’intero capitolo quarto dell’enciclica: «Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale», dice il papa; e la prima cosa da sapere, come dicono i vescovi boliviani ma anche molte altre Chiese, è che i primi a essere colpiti da «quello che sta succedendo alla nostra casa comune» sono i poveri. E il salto di qualità è anche nel rigore dell’analisi, nella cura con cui vengono ricercate tutte le connessioni tra i diversi fenomeni ed ecosistemi, e anche nell’onestà con cui si dice che non tutto possiamo sapere, che la scienza deve fare ancora un grande cammino, e che non si può presumere di prevedere gli sviluppi futuri, sicché il principio di precauzione diventa un obbligo di saggezza e di rispetto per l’umanità di domani, contro l’ideologia della ricerca immediata del profitto e dell’egoismo realizzato.
Si può capire allora come con questa enciclica che comincia con un cantico di san Francesco e finisce con una preghiera in forma di poesia, l’idillio del mondo ricco con papa Francesco sia finito. «Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra», dice il papa nella sua preghiera. «Non occuparti di politica, perché l’ambiente è politica», gli dicono i ricchi. E mentre da un lato quello che negli Stati Uniti non si fa chiamare Bush per riprendersi in famiglia il governo dell’America dice che non si farà dettare la sua agenda dal papa, dall’altro quello che da noi pubblica sulle sue felpe messaggi di razzismo e di guerra dice che non c’è proprio di che essere perdonati per le porte chiuse in faccia ai profughi e tutti i «clandestini» vorrebbe metterli a Santa Marta.
«Questo papa piace troppo» diceva la destra più zelante, allarmata al vedere masse intere di persone in tutto il mondo affascinate da un pensiero diverso dal pensiero unico. Però si faceva finta di niente, sperando che la gente non capisse. Il papa diceva che l’attuale sistema non ha volto e fini veramente umani, e stavano zitti. Diceva che questa economia uccide, e stavano zitti. Diceva che l’attuale società, in cui il denaro governa (Marx diceva «il capitale») è fondata sull’esclusione e lo scarto di milioni di persone, e stavano zitti. Diceva ai politici che erano corrotti, e stavano zitti. Diceva ai disoccupati di lottare per il lavoro e ai poveri di lottare contro l’ingiustizia, e facevano il Jobs Act.
Ma con questa enciclica il gioco di far finta di non capire non sarà più possibile. Bisognerà stare o dalla parte di Francesco o contro di lui, perché non sta facendo una predica, sta chiedendo una scelta. E questo vale non solo per i politici, per gli opinionisti, per i giornali, vale anche per i vescovi, per i cardinali. E vale anche per i semplici fedeli perché, scrive Francesco «dobbiamo riconoscere che alcuni cristiani impegnati e dediti alla preghiera, con il pretesto del realismo e della pragmaticità, spesso si fanno beffe delle preoccupazioni per l’ambiente».
Quello che infatti da Francesco è posto davanti al mondo è il problema vero: «il grido della terra» è anche il «grido dei poveri», ma nel monito che si leva dai poveri perché la loro vita non vada perduta, c’è un monito che riguarda tutti, perché senza un rimedio, senza un cambiamento, senza un’assunzione di responsabilità universale la vita di tutti sarà perduta.
Ed è per questo che l’enciclica di papa Francesco è rivolta a «ogni persona che abita questo pianeta»: non ai cattolici, e nemmeno agli «uomini di buona volontà», come faceva la «Pacem in terris» di Giovanni XXIII, in cui si poteva sospettare ancora un residuo di esclusione, nei confronti di qualcuno che eventualmente fosse di volontà non buona. Qui papa Francesco abbraccia veramente tutti (come ne sono figura essenzialissima per il cristiano le braccia di Cristo aperte sulla croce) e si pone non come capo di una Chiesa, e nemmeno come profeta dei credenti, ma come padre della intera umanità. Perché il messaggio è il seguente: non questa o quella Potenza o Istituzione, non questo o quello Stato, non quel partito o movimento, ma solo l’unità umana, solo la intera famiglia umana giuridicamente costituita e agente come soggetto politico può prendere in mano la terra e assicurarne la vita per l’attuale e le prossime generazioni.
 «È caduto ogni divieto sul controllo dei dipendenti. Pc, posta elettronica, telefonate non hanno più segreti per gli imprenditori. Gli unici limiti arrivano dal Garante della privacy: non si può abusare dei dati».
«È caduto ogni divieto sul controllo dei dipendenti. Pc, posta elettronica, telefonate non hanno più segreti per gli imprenditori. Gli unici limiti arrivano dal Garante della privacy: non si può abusare dei dati».
La Repubblica, 19 giugno 2015 (m.p.r.)
Siamo tutti lavoratori sorvegliati. Il Grande fratello c’era già prima che il governo approvasse l’ultimo decreto sul Jobs act. I “padroni della rete” sanno tutto di noi: conoscono i nostri gusti alimentari, i libri che leggiamo, la musica che ascoltiamo, i vestiti che indossiamo, i film che vediamo, probabilmente pure il partito che votiamo o che abbiamo intenzione di votare. Anche il “nostro padrone” sa quasi tutto di noi. Lo sa, ma non lo dice. La nostra posta elettronica nel posto di lavoro può essere controllata, i nostri accessi a internet pure, le nostre telefonate altrettanto. Tutto è tracciato. La rete, si sa, non dimentica, o non vuole dimenticare, mai. I dati sono ormai facilmente acquisibili, bisogna vedere l’uso che se ne fa dopo. Questo è il punto più delicato.
 Il dilemma dell'Europa: ignorare la storia e sottomettersi ai diktat del "fondamentalismo del mercato" che ovunque applicati hanno condotto al disastro e alla povertà diffusa, oppure opporsi fermamente e costruire una soluzione alternativa.
Il dilemma dell'Europa: ignorare la storia e sottomettersi ai diktat del "fondamentalismo del mercato" che ovunque applicati hanno condotto al disastro e alla povertà diffusa, oppure opporsi fermamente e costruire una soluzione alternativa.
Il manifesto, 18 giugno 2015
Altro che la storia «luce della verità» o «vita della memoria» di cui parlava Cicerone nel De oratore. Raramente si rivela «maestra di vita», perché il mondo umano non ha alcuna intenzione di farsi suo discepolo o anche solo di prestare attenzione alle forti testimonianze che pur essa ci dispensa.
È questo il caso della teologia economica, ossia dell’idea (o meglio: ideologia), secondo cui si cerca di imporre i dogmi della finanza a guisa di leggi naturali e indiscutibili, perfettamente in grado di garantire la salvezza e financo il progresso di quei paesi che si sottomettono al «fondamentalismo del mercato».
E dire che non ci si sarebbe dovuti spingere tanto lontano con la memoria (Marx, Keynes), perché un perfetto e lapalissiano esempio della fallacia dei diktat imposti dal fondamentalismo del mercato lo avremmo potuto riscontrare anche ai giorni nostri.
Per la precisione pochi anni prima che la grande crisi economica colpisse anche il mondo occidentale, partendo dagli Stati Uniti per deflagrare poi in Europa tra il 2008 e il 2009.
I dogmi del mercato
Né era stato un testimone qualunque a documentare con indiscutibile lucidità i fallimenti prodotti dai dogmi mercatisti, bensì quel Joseph Stiglitz che parlava con cognizione di causa (oltre che valente economista era stato vicepresidente della Banca mondiale ai tempi della presidenza di Clinton) e che per questo fu insignito del premio Nobel per l’economia nel 2001.
In un libro fondamentale per comprendere il nostro tempo (Globalization and Its Discontents, tradotto per Einaudi col titolo La globalizzazione e i suoi oppositori), infatti, Stiglitz spiegava con precisione certosina e analisi incontrovertibile il fallimento a cui erano andati incontro i paesi (per esempio l’Argentina) che negli anni Novanta del secolo scorso si erano sottomessi ai diktat della troika mondiale (Fmi, Banca mondiale, Wto). Mentre per esempio la Cina, fra quelli che respinsero con sdegno le suddette imposizioni (anche perché poteva permetterselo in virtù della sua potenza militare), costruì proprio in quegli anni le premesse per la sua esplosione come potenza economica mondiale.
Circa un decennio più avanti, dopo che gli imprevedibili sviluppi del capitalismo finanziario hanno visto crescere proprio quei paesi che a suo tempo si opposero ai dogmi del neoliberismo (la stessa Cina, ma anche India, Brasile), tocca stavolta all’Europa non soltanto fare i conti con una gravissima e prolungata fase di stagnazione e crisi, ma anche con quegli stessi identici diktat con i quali la teologia economica vorrebbe indicargli la via della salvezza.
Per il tramite di una nuova e specifica troika (Commissione europea, Bce, Fmi), quell’entità fumosa e incompiuta che risponde al nome di Europa si trova di fronte al deja vu più drammatico della sua storia recente: ignorare la storia e sottomettersi a dei diktat che ovunque applicati hanno condotto al disastro e alla povertà diffusa, oppure opporsi fermamente e costruire una soluzione alternativa.
In un libro uscito recentemente (Against the Troika. Crisis and Austerity in the Eurozone, proemio di Oskar Lafontaine, prefazione di P. Mason, postfazione di A. Garzón Espinosa, Verso), Heiner Flassbeck e Costas Lapavitsas affermano apertamente la «forte e rimarchevole correlazione fra gli aggiustamenti richiesti dalla troika e il declino economico dei paesi periferici dell’Euro» (Grecia su tutti), non mancando di menzionare i casi della Francia e dell’Italia, che periferici non sono ma stanno subendo un fortissimo ridimensionamento delle rispettive economie e, soprattutto, della qualità della vita dei cittadini che vi abitano.
Disuguaglianze crescono
I due studiosi mettono in evidenza senza mezzi termini il bivio di fronte al quale si trovano le democrazie europee, che secondo loro sembra destinato ad assumere più che altro le fattezze di un falso bivio e, piuttosto, di un circolo vizioso: da una parte, infatti, cedere ai diktat della troika significa aumentare ulteriormente le disuguaglianze e impoverire la classe media, ponendo le basi per un aumento smisurato di quel malcontento e conflitto sociale che i populismi, i nazionalismi e le destre estreme sono pronti a cavalcare con esiti ancora più nefasti.
Dall’altra, a fronte di governi sedicenti di sinistra, ma più in generale di forze antagoniste al capitalismo che però si rivelano incapaci di elaborare e mettere in atto strategie alternative, si lascia inevitabilmente campo aperto ed esclusivo a soluzioni destinate a distruggere definitivamente quel poco che resta dell’ (incompiuta) unità europea. Creando di fatto le condizioni perché a combattersi (ma poi per davvero?) rimangano soltanto le destre populiste (il cui programma è semplice: uscire dall’euro) e il fondamentalismo del mercato.
Con esiti deleteri in entrambi i casi: «Le divergenze accumulate in questi primi anni di Unione europea e la natura terribile dei programmi di aggiustamento (in senso neoliberista, n.d.r.) pongono la questione quanto mai centrale della sopravvivenza stessa dell’Unione. La prospettiva di un’eventuale disintegrazione e collasso dell’Unione europea non può essere ignorata più a lungo», si legge nel libro. Da questo punto di vista emerge con chiarezza, stando ai due autori di Against the Troika, che spetta alla variegata e spesso frammentaria galassia delle sinistre antiliberiste ricostruire un consenso popolare.
Consenso popolare su cui impostare una dichiarazione di default rispetto al debito, sospendendo il pagamento degli interessi maturati e rinegoziando le forme di appartenenza all’Unione europea.
Solo una sinistra rinnovata e coraggiosa, insomma, possibilmente fornita di un programma fondato e credibile, può giocarsi seriamente la partita con la teologia liberista, riuscendo a tenere in pieni il grande progetto dell’Europa (salvaguardando la sua specificità a livello mondiale: lo stato sociale) ma nella consapevolezza che la prospettiva dell’uscita non è qualcosa né di proibito né di inimmaginabile.
Doppio risultato per il renzismo: si rafforza il controllo su quei potenziali facinorosi che sono i lavoratori, e s'incentiva ulteriormente la produzione di prodotti digitali.
La Repubblica, 18 giugno
Il decreto che attua il Jobs Act va in Parlamento Niente permessi per vigilare. Sindacati in rivolta
ROMA. Le informazioni raccolte dalle aziende - tramite cellulari, smartphone, tablet, portatili, badge in dotazione al lavoratore, ma anche telecamere di sorveglianza - «sono utilizzabili a tutti i fini». C’è anche questo, in uno dei decreti attuativi del Jobs Act, arrivato martedì nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato, per un parere non vincolante.
Quindi non solo d’ora in avanti il datore di lavoro non avrà più bisogno di un accordo con i sindacati né del permesso delle Direzioni territoriali del lavoro (il ministero) per controllare da remoto il proprio dipendente tramite vecchi e nuovi strumenti high-tech. Non solo per le telecamere quell’accordo non sarà più obbligatorio, come dal 1970. Ma l’utilizzo dei dati a posteriori (tutti i dati, anche quelli video) potrà essere praticamente infinito. Utilizzo «ad ogni fine, connesso al rapporto di lavoro», si legge nella relazione illustrativa al decreto. «Purché sia data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità d’uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli, sempre comunque nel rispetto del Codice della privacy».
Un rispetto che ora i sindacati, uniti e furiosi, mettono in dubbio. Come anticipato da Repubblica , la norma non poteva non sollevare un polverone. «Siamo al colpo di mano», denuncia Serena Sorrentino, segretario confederale Cgil, che parla di «arretramento pesante» rispetto allo Statuto dei lavoratori (il cui articolo 4 in materia di controlli a distanza viene aggiornato). «Non solo daremo battaglia in Parlamento», annuncia. Ma «verificheremo anche con il Garante della privacy se ciò si può consentire». Anche la Cisl chiede una riscrittura del testo. «Così com’è non va bene, va cambiato, perché è attraverso la contrattazione sui luoghi di lavoro che si devono gestire questi aspetti così delicati per la vita di un lavoratore, ma anche per l’azienda», commenta Annamaria Furlan, segretario generale Cisl, in linea con le posizioni della Uil. Si allarma anche Cesare Damiano, presidente pd della commissione Lavoro della Camera: «Non bisogna far rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta. La delega prevede un controllo sugli impianti e non sulle persone. Buon senso vorrebbe che il governo, com’è avvenuto nel passato, affidasse questa regolazione alla contrattazione delle parti sociali. E soltanto nel caso di mancata intesa, far intervenire la legge».
La norma tra l’altro non vale per gli statali, altra benzina sul fuoco delle polemiche. «Il Grande fratello è nelle cose, già oggi», commenta il giuslavorista e senatore pd Pietro Ichino a Radio24 . «I controlli a distanza sono stati inseriti nel 1970, nello Statuto dei lavoratori, ma con l’obbligo di negoziazione. Mezzo secolo dopo, passare da accordi con i sindacati vorrebbe dire non fare una rete Internet aziendale oppure le auto con il gps o rinunciare a dotare i lavoratori del cellulare». Il dibattito è aperto.
Il decreto sulle Semplificazioni, con la norma incriminata (l’articolo 23), dovrà ora essere esaminato dalla commissioni parlamentari, le cui raccomandazioni potrebbero o meno essere accolte dal governo (con altri decreti del Jobs Act, però, è successo).

«C’è un’amnesia totale. Nessuno si ricorda più di quando a emigrare eravamo noi italiani: milioni di persone in cerca di futuro e anche loro a bordo di carrette».
Emma Bonino ne è sicura, non ci sarà nessuna barriera in grado di fermare chi è disposto a lasciarsi alle spalle tutto ciò che ha pur di salvarsi la vita o provare o ricrearsela in un altro continente.
«L’Unhcr ci dice che a breve ci saranno 50 milioni di rifugiati veri e propri. Poi bisogna considerare le migrazioni di altro tipo - spiega -. Quello migratorio è un fenomeno strutturale e anche se ci sono delle punte emergenziali nei vari continenti, convive da sempre con l’umanità. Noi italiani ne siamo stati grandi protagonisti in passato, tra la prima e la seconda guerra mondiale. Dico sempre che una delle cose migliori che potrebbero fare le scuole italiane è portare i ragazzi a visitare i musei dell’emigrazione italiana. C’è un episodio che mi piace citare: una volta un museo ha fatto un esperimento mettendo a confronto due fotografie. Una rappresentava una nave di emigranti italiani, l’altra la prima nave carica di albanesi che arrivò in Italia nel 1991. Poi hanno chiesto ai ragazzi quali erano gli italiani e quali gli albanesi. I ragazzi non hanno quasi mai indovinato».
I demografi spiegano come l’immigrazione sia sempre più importante per le popolazioni occidentali. Eppure alziamo muri, facciamo blocchi navali, respingiamo le persone. Il nostro è egoismo o incapacità di capire quanto queste persone possono essere preziose per noi?
Secondo me c’è una incapacità della classe dirigente di governare il fenomeno e di mandare i messaggi giusti. E’ chiaro che se una persona vede solo Salvini che sbraita in televisione finirà per credere che se suo figlio non trova lavoro è perché c’è un keniota che glielo ha rubato. Parlare alla pancia funziona sempre, specie in un periodo di crisi vera. Eppure abbiamo tutte le informazioni per capire che l’immigrazione può essere una risorsa. Oggi gli immigrati (legalizzati) in Italia sono circa 5 milioni, contribuiscono all’8.8% del Pil, contribuiscono all’Inps, pagano le nostre future pensioni che loro godono molto poco perché la stragrande maggioranza rientra al suo Paese appena può. Quindi cosa siamo, egoisti o incapaci di capire? Io direi che siamo vittime del populismo della classe dirigente, ma per quanto riguarda l’opinione pubblica in generale parlerei di ignoranza. Hanno creato una guerra tra poveri che funziona benissimo. La verità è un’altra, ed è che noi non vogliamo i poveri, italiani o non italiani che siano.
Lei in passato ha sempre sottolineato la necessità di avere rapporti di partenariato con i paesi del Mediterraneo e ha sponsorizzato la costituzione di un commissario europeo per il Mediterraneo invece di uno per l’Immigrazione. Per quello che valgono i ragionamenti fatti con i senno di poi, se tutto questo si fosse attuato sarebbero diverse le cose?
Parliamo un attimo prima di quanto accade oltre il Mediterraneo. In Asia c’è un grandissimo movimento di cui i Rohingya sono solo la punta dell’iceberg. Pensi inoltre ai Karen che, poveracci, stanno nei campi profughi della Thailandia ormai da tre generazioni e non riescono a rientrare a Myanmar né Myanmar - che ha un centinaio di etnie - li vuole. Poi c’è la frontiera tra Messico e Stati uniti, che ora è diventato il problema Guatemala, Messico, Stati uniti, o l’esodo dalla Colombia per esempio. C’è il Venezuela… Molti sono movimenti migratori prevalentemente interlatini, perché il Brasile va piuttosto bene economicamente. Anche le migrazioni del Mediterraneo le possiamo considerare intracontinentali, perché il Mediterraneo è poco più di un grande lago che ci unisce all’Africa. E qui cosa abbiamo? Da una parte un continente in rapido declino demografico, l’Europa, ma che è ancora il più ricco per quanto riguarda welfare, istruzione, siamo anche più equilibrati degli Stati uniti. A Sud invece c’è un giardino d’infanzia, un continente con una crescita demografica ovunque perlomeno del 3–4%. Poi c’è la parte Sahel tormentata da guerre, dittature, Boko Haram, Shabaab (movimento islamista somalo, ndr). Dove vuoi che vada questa gente? In Botswana? Non è che uno siccome è poveraccio e senza prospettive di vita nel suo Paese, è anche ignorante. Quindi va dove pensa di avere una speranza, una possibilità, cioè in Europa. Dove magari ha già famiglia o conoscenti o amici.
Il problema è che il numero dei conflitti presenti a Sud aumenta quotidianamente.
Questo è un momento della storia che possiamo definire di risveglio arabo e di contaminazioni di vario tipo, perché c’è anche il terrorismo. Noi europei eravamo abituati a lavorare solo con le élite, ne conoscevamo vita, morte e miracoli, le mogli, le amanti e con loro trattavamo. Ricordo che quando mi sono trasferita al Cairo, nel 2001, dopo un po’ cominciai a fare una rassegna stampa del mondo arabo per Radio Radicale nella quale provai a dire: guardate che qui c’è veramente una bomba a orologeria. Parlavo dal punto di vista sociale demografico, non intereligioso. In quegli anni l’Egitto era pieno di bambini, ma con nessuna crescita economica, un milione di nuovi ragazzi che si affacciavano al mercato del lavoro ogni anno, prospettive zero, tutti interconnessi e la stragrande maggioranza di loro non aveva mai visto un’altra faccia oltre alla fotografia di Mubarak appeso al muro di casa sua. Mi sembrava che ci fosse un subbuglio, un popolo che in qualche modo brontolava. Avevo la stessa impressione anche per la Tunisia per dire la verità, ma quando provavo a dirlo mi rispondevano che no, erano popoli stabili.
Perché vivevano sotto dittature che li obbligavano a essere stabili.
Certo, ma erano come una pentola a pressione senza valvola e quindi pronti a scoppiare. Non avevano nessuna agibilità politica, o sindacale. Niente di niente. All’epoca si poteva fare politica solo il venerdì nelle moschee, unico spazio che veniva dato, con tutte le complicazioni che ne potevano derivare. Non sapevo quando e dove tutto questo sarebbe sfociato, ma avevo l’impressione che tutta la regione fosse così: un giardino d’infanzia, senza sfoghi politici né possibilità di alternative politiche, nessuna prospettiva economica salvo ovviamente le monarchie del Golfo, ma questo è un altro discorso. E infatti sia l’Egitto che la Tunisia finché hanno potuto hanno fatto una grande politica di sussidi, al pane, alla benzina, a qualunque cosa. Però non hanno retto, nonostante i potentissimi servizi segreti. Torniamo allora alla mia proposta di un commissario per il Mediterraneo. Quando la lanciai ho pensato che sarebbe stato importante – e lo penso anche ora — fare una politica di contenimento, cercare di aiutare quei Paesi che ancora non sono nel baratro: Tunisia, Marocco, Algeria. Vogliamo parlare dell’Algeria, capire un attimo cosa sta succedendo lì? Quaranta milioni di persone, tantissimi giovani, quasi tutti nati dopo o durante la guerra civile, un bilancio dello Stato che si è ridotto del 50% per il crollo del petrolio. E’ vero che hanno riserve per due o tre anni, ma anche in Algeria - che non esporta nulla - hanno sempre tenuto calma la popolazione con sussidi che prima o poi dovranno cominciare a ridurre. E allora cosa accadrà?
Certo che di fronte a un simile scenario l’Europa che litiga per dividersi 40 mila profughi fa pensare.
Il piano Juncker è importante dal punto di vista del principio, perché in definitiva rimette in discussione il trattato di Dublino. Non è tanto quindi il risvolto pratico della vicenda. Nella timidezza complessiva bruxellese a cui siamo abituati, in particolare della commissione Barroso, devo dire che la commissione Juncker è stata piuttosto decisa e ha posto almeno in discussione tre o quattro argomenti considerati finora un tabù, anche se per ora una revisione del regolamento di Dublino non passa, perché non ci sono i numeri necessari.
L’Italia aveva salutato come un successo la proposta della commissione Juncker di dividere 40 mila profughi tra gli Stati membri, ma l’entusiasmo è durato poco.
Il fatto è che i migranti sono una priorità per noi, ma non per i Paesi che si trovano dall’altra parte del Mediterraneo. Non possiamo andare in Tunisia a dire: tenetevi i migranti, anzi aprite un campo profughi e un ufficio per gestire l’emigrazione legale perché noi prima o poi apriremo le quote. La reazione è scontata: oltre al milione di libici che già abbiamo, e che in un Paese di 11 milioni di abitanti sono un problema non da poco, dovremmo ospitare anche tutti gli africani che verrebbero in attesa di avere un canale legale? E non basta promettere ulteriori finanziamenti. La mia idea è che nessuno ha soluzioni miracolose, neanche i più decisi guerrafondai, quelli convinti che bisogna andare in Libia e bombardare non si è capito chi, come, né dove, però poi boots on the ground nessuno li vuole mettere.
Sarà anche per questo che l’Onu tarda a fare la risoluzione che darebbe il via alla missione europea contro gli scafisti?
L’Onu tarda perché sono state espresse una serie di riserve. Una è quella della Russia, che non vuole essere bypassata come accadde nel 2011 quando con la motivazione di salvare Bengasi è stato fatto fuori Gheddafi. Quindi fino a quando non c’è un linguaggio preciso che assicuri alla Russia chi, dove, come, quando vuole fare questa operazione, non si muove nulla. Il piano presentato poi è troppo ambiguo, non si capisce cosa si deve fare e per quanto tempo. Tutta questa operazione a mio modesto avviso non va da nessuna parte, almeno non come era stata pensata inizialmente.
E allora come ne usciamo?
Chiunque abbia in mente una soluzione miracolosa, secondo me vende fumo. Credo che questa situazione si trascinerà ancora a lungo. In Libia, per esempio, oltre alle milizie locali è in corso la continuazione della guerra intrasunnita, perché Tobruck rappresenta Egitto, Arabia Saudita ed Emirati mentre Tripoli Qatar e Turchia. Poi la politica è molto fragile e non so se adesso la Turchia vuole ancora continuare la sua precedente politica regionale oppure no. Ma anche quello che sta succedendo in Arabia saudita dove la transizione dopo la morte del re non è affatto così tranquilla come ce l’hanno dipinta. Attenzione, perché le alleanze sono fragili. Penso che oggi stiamo assistendo a una guerra tra di loro, una guerra che noi abbiamo contribuito a far scoppiare dal 2003 con l’Iraq senza sapere bene che fare il giorno dopo.
 L'Ungheria traduce in fatti concreti, ferrigni e spinosi, l'ideologia dominante nell'Unione europea, che solo il velo dell'ipocrisia nasconde agli ingenui.
L'Ungheria traduce in fatti concreti, ferrigni e spinosi, l'ideologia dominante nell'Unione europea, che solo il velo dell'ipocrisia nasconde agli ingenui.
La Repubblica, 18 giugno 2015
Budapest. Quando l’annuncio è venuto, non voleva crederci nessuno: in Europa, con Orbàn e con la marea dei migranti, torna l’èra dei Muri, proprio quei Muri della cui caduta Orbàn allora giovane dissidente liberal fu coraggioso protagonista.
 Il 15 giugno le quattro associazioni ambientaliste Fondo Ambiente italiano, Italia Nostra, Legambiente, Rete dei comitati per la difesa del territorio, WWF hanno sottoscritto unitariamente un appello per chiedere continuità nelle politiche portate avanti in questi cinque anni sul governo del territorio e del paesaggio. Nessun quotidiano l'ha ripreso.
Il 15 giugno le quattro associazioni ambientaliste Fondo Ambiente italiano, Italia Nostra, Legambiente, Rete dei comitati per la difesa del territorio, WWF hanno sottoscritto unitariamente un appello per chiedere continuità nelle politiche portate avanti in questi cinque anni sul governo del territorio e del paesaggio. Nessun quotidiano l'ha ripreso.
Le Associazioni ambientaliste - Fondo Ambiente italiano, Italia Nostra, Legambiente, Rete dei comitati per la difesa del territorio, WWF - hanno condotto insieme una battaglia per affermare in Toscana i valori dell'ambiente, del territorio, del paesaggio. In modo particolare, hanno contribuito, nella passata legislatura, a far approvare provvedimenti legislativi di portata nazionale come la Legge per il governo del territorio e il Piano paesaggistico.
La battaglia però non può fermarsi qui. È necessario che nella prossima legislatura questi provvedimenti siano salvaguardati e correttamente applicati e, in proposito, le Associazioni auspicano e chiedono continuità nel lavoro svolto da Anna Marson durante la scorsa legislatura: e ritengono, inoltre, che la garanzia più efficace di una corretta gestione del Piano consista nel mettere prima possibile in funzione l’Osservatorio del paesaggio previsto dall’art. 59 della nuova Legge per il governo del territorio, articolato in una struttura regionale e in una rete di nodi locali aperti alla partecipazione delle comunità locali, come «strutture ecomuseali, associazioni ambientali e civiche, già attivi sul territorio» (da Relazione generale del Piano, p. 24). Se ciò, come vivamente è auspicabile, sarà realizzato le Associazioni ambientaliste si propongono di fornire al governo regionale il proprio contributo per mettere in atto i risultati positivi della precedente legislatura.
Firenze, 15 giugno 2015.
Fondo Ambiente italiano, Italia Nostra, Legambiente, Rete dei comitati per la difesa del territorio, WWF

. Comune.info, 17 giugno 2015
In questo periodo alcuni dirigenti politici alzano la voce contro gli stranieri, quelli miserabili (non i miliardari arabi che si stanno comprando mezza Italia), quelli che scappano dalla fame, dalla guerra, dalle situazioni disumane e tragiche prodotte dalle politiche occidentali, in primis gli Usa e le multinazionali euro-statunitensi che sfruttano le risorse dell’Africa e del Medio-oriente. Quei dirigenti usano una violenza verbale, veicolata dai media, che fanno così da cassa di risonanza allacostruzione del capro espiatorio in una situazione di crisi sociale, culturale, morale, politica ed economica che sta affondando la democrazia italiana, ma anche di molti paesi europei.
La violenza verbale si accompagna purtroppo anche dalla violenza fisica di chi viene sfruttato da scafisti di tutte le nazionalità, basta vedere la vicenda di Roma (sulle vicende di Roma, Milano, Ventimiglia e, più in generale sulla situazione dei migranti in questo momento, leggi anche Migranti in trappola di Fulvio Vassallo Paleologo e la durissima denuncia di Amnesty). L’importante è fare crescere l’odio verso i poveri del mondo che chiedono aiuto, l’importante è metterli alla gogna facendo tremare i cittadini impoveriti e impauriti con le favole sulla scabbia, il terrorismo ecc. La cosa grave è che il giornalismo italiano sembra non avere senso del pudore e della responsabilità sociale nell’influenzare l’opinione pubblica, anzi più si sbatte il mostro in prima pagina nei tg, più si dà spazi ai deliri razzisti e volgari di certi personaggi, più si amplifica il fenomeno della presunta invasione del paese. E se il paese è invaso vuol dire che siamo in guerra. Contro chi? Contro i poveri che arrivano dal Corno dell’Africa (ex colonie italiane), dal Medio-oriente (Sira, Iraq distrutti dalla guerre occidentali), dall’Africa centrale sfruttate dalle multinazionali per le sue materie prime. Non guerra alle diseguaglianza e alla povertà nel mondo e anche alle sue cause, dunque, ma guerra ai poveri.
Austerity
D’altronde che la guerra contro i poveri sia una realtà i cittadini europei se ne accorgono con le politiche di austerity che hanno avuto finora l’effetto d’impoverire la popolazione e di distruggere i sistema di diritti e di tutela dei lavoratori. Allora bisogna far crescere l’odio contro i profughi, scatenare la guerra tra i poveri facendo leva sugli istinti più bassi e incivili dell’essere umano per fare dimenticare che la crisi sociale in Italia e in Europa ha dei responsabili, cioè chi governa e conduce per conto dei mercati della finanza le politiche di distruzione dello Stato sociale per favorire il trasferimento di ricchezza verso chi è ricco e per rendere schiavi i salariati.
Come ha scritto René Girard nei suoi testi La violenza e il sacro e Il capro espiatorio, l’aggressione razzista è proporzionata non alla diversità dello straniero ma al fatto che ci assomiglia tanto, insomma aggrediamo l’altro perché è molto simile a noi e non il contrario (è quello che il filosofo francese chiama “la vendetta mimetica”). Nel caso dell’Italia con la sua storia d’emigrazione (rimossa anche se molto attuale, visto che negli ultimi tre anni hanno lasciato il paese 350.000 mila italiani) la questione diventa ancora più complicata poiché i profughi ci ricordano molte cose sulla sua storia passata e anche attuale. L’aggressività razzista e xenofoba è anche sempre lo specchio di una paura irrazionale, di una insicurezza e di un tentativo di eliminare l’altro diverso da sé per non fare i conti con se stesso, quindi con l’altro che ci sta dentro.
Il dominio sull’altro secondo Fanon
Psicologicamente si può dire, con lo psichiatra afro-martinichese Franz Fanon, chel’aggressività linguistica e simbolica nonché la violenza fisica sono parte di una logica di dominazione sull’altro agita da chi si sente insicuro (agendo come un “ferito psico-affettivo” che costruisce un rapporto di doppio legame con l’oggetto del proprio odio e della propria violenza). Si tratta di un tratto patologico che, negando dignità e umanità all’altro, porta a annichilire la propria dignità e umanità, quindi la propria capacità riflessiva lasciandosi travolgere dalle pur emozioni del momento, emozioni che non diventano sentimenti poiché quest’ultimi ci portano a relazionarci con i sentimenti dell’altro e quindi a considerarlo nella propria umanità.
L’odio ha purtroppo sempre funzionato nella storia umana permettendo alle classi dominanti di trovare, tra una parte dei dominati e sfruttati autoctoni, delle truppe e dei sostegni per continuare ad essere dominanti. L’odio è anche un modo molto più semplice di non dovere fare i conti con se stessi nella relazione con l’altro e quindi con la propria coscienza. Giuseppe Mazzini l’aveva già capito nella prima metà dell’800 e sosteneva che solo la fratellanza tra i popoli, in particolare tra i popoli sfruttati e oppressi avrebbe permesso di costruire una Europa più democratica e più giusta, scrisse anche in un proclama indirizzo ai giovani italiani che bisognava “abolire la parola straniero dalla favella dell’umanità”!
 «La superficialità, l’inconsistenza e la criminalità tanto delle soluzioni della Lega e delle destre europee quanto delle non-soluzioni dei governi italiani ed europei è una drammatica spia del tarlo che rode da anni l’edificio dell’Unione Europea».
«La superficialità, l’inconsistenza e la criminalità tanto delle soluzioni della Lega e delle destre europee quanto delle non-soluzioni dei governi italiani ed europei è una drammatica spia del tarlo che rode da anni l’edificio dell’Unione Europea».
Il manifesto, 16 giugno 2015
È come se l’Europa fosse piombata di nuovo in una guerra. Solo i suoi governanti non se ne sono accorti. Pochi di noi, sempre meno, in tutta Europa, sono ormai sicuri di poter tornare domani nella fabbrica o nell’ufficio dove hanno lavorato fino ad oggi; e non perché quei luoghi siano stati distrutti da una bomba, ma perché rischiano di venir chiusi dai debiti o da una delocalizzazione. Lo stesso vale per la casa dove si è abitato fino a ora: sfratto per morosità o rateo del mutuo non pagato. O per la pensione, dissolta, dimezzata o allontanata da un diktat della Commissione Europea.
Ma le manifestazioni di insipienza non finiscono qui: emergono ora con virulenza nella vicenda dei profughi: anche in questo campo Grecia e Italia sono state elette a vittime sacrificali di una politica senza futuro. Quello che Maroni vorrebbe fare delle Regioni dell’Italia meridionale e che Salvini (nella sua nuova veste di eroe nazionale) vorrebbe fare della Libia - trattenere là i profughi che non vogliono accogliere qua - l’Europa, cioè i governi dei paesi membri, incalzati e travolti dai furori xenofobi e antieuropei delle destre, lo stanno già facendo nei confronti di Grecia e Italia: «È un problema vostro; teneteveli. Siamo stati così designati a campo profughi, nuova Libia delle guerre che investono ormai i confini di tutta l’Unione.
E’ la prova di una totale mancanza di visione di che cosa possa, ma anche debba, essere l’Europa; e di una totale mancanza di strategia di fronte ai problemi più gravi. Dal canto suo, il governo italiano, investito direttamente dall’ondata montante (ma prevedibile) dei profughi, ha messo a punto (accanto alla iniziativa salvifica, ma a termine, di Mare Nostrum) due soluzioni emblematiche del modo con cui affronta le emergenze. La soluzione Alfano-Buzzi: speculare a man bassa, sia in termini economici che elettorali, su quei disperati. E la soluzione Alfano-Pansa: farli scappare dai luoghi di accoglienza (cioè di detenzione); lasciarli per strada. Che si arrangino a riempire stazioni, giardini, fabbriche abbandonate, ricoveri improvvisati. Così si alimenta allarmismo tra popolazioni ignare della dimensione geopolitica del problema e indotte a guardare solo ciò che interferisce con le loro vite quotidiane. Ma soprattutto si offrono nuovi argomenti alle strategie di Salvini.
Ma che cosa succederà se o quando vincerà Salvini? O quando le sue ricette saranno fatte proprie da chi ci governa (il piano B)? I campi profughi in Libia non si faranno. Ci sono già: sono quelli da cui si imbarcano a decine di migliaia. Chi o che cosa potrebbero mai ottenere che non succeda più? L’occupazione di tutta la costa libica? Ci vuole quella guerra che l’Onu per ora non permette; ma che poi, comunque, bisognerebbe vincere. Ma l’ultima guerra contro la Libia l’Europa in realtà l’ha persa. Così, sarebbe comunque il deserto a inghiottire i profughi e migranti tenuti lontani dal mare (e dal nostro sguardo: chi si è mai preoccupato dei morti nel deserto, che sono già ora di più di quelli annegati in mare?). E magari, bisognerebbe anche ricacciare verso i territori occupati dallo Stato Islamico i profughi accampati in Libano, Giordania e Turchia prima che cerchino anche loro di raggiungere l’Europa.
Oppure, si può smettere di salvarli in mare, o respingerli con la forza quando chiedono aiuto. Cioè farli annegare. In sostanza la proposta vera è questa, e si chiama sterminio. Ma alcuni, anzi molti, riuscirebbero comunque a raggiungere i nostri porti. Li si affonda lì? Davanti ai turisti che fanno il bagno? Senza neanche capire che un’accoglienza come quella inaugurata dalla sindaca di Lampedusa è riuscita a salvare sia turismo che vite umane?
Oppure, ancora, si adotta la linea Maroni, Zaia e Toti e si nega l’apertura di ricoveri decenti nelle regioni a cui i profughi sono stati destinati. Spingendoli così ad accamparsi nelle stazioni e nei giardinetti e, se vengono cacciati anche di lì, a spostarsi in altre stazioni e in altri giardinetti (in una girandola come quella imposta ai campi rom): affidandoli alle cure di quei tanti cittadini e associazioni che mostrano ancora una grande voglia di aiutarli (ciò che dà ancora speranza di poter costruire una società solidale). Ma mettendoli anche alla mercé di squadracce decise a farla pagare a quei disgraziati, rei di essersi salvati da una guerra, dal mare e dalle torture inflitte loro durante il loro viaggio.
La superficialità, l’inconsistenza e la criminalità tanto delle soluzioni della Lega e delle destre europee quanto delle non-soluzioni dei governi italiani ed europei è una drammatica spia del tarlo che rode da anni l’edificio dell’Unione Europea. Vent’anni fa era già stato detto che, se non si fossero adottate misure adeguate, profughi e migranti dall’Africa e dal Medio Oriente ci avrebbero raggiunti anche a nuoto. Ora quel momento è arrivato e si parla solo di come fermarli o fargli invertire rotta; ma nessuno ha ancora detto come. La soluzione finale, lo sterminio dei profughi in mare o in Libia o nel deserto, ciò che l’Europa si era impegnata a non permettere mai più, è inaccettabile.