

 La paura ha mutato la sua funzione sociale: era il timore di un evento da cui lo Stato aveva il dovere di proteggere il cittadino, è diventato lo strumento adoperato da chi ha il potere, con la complicità dello Stato, e vuole accrescere il proprio dominio sulla società.
La paura ha mutato la sua funzione sociale: era il timore di un evento da cui lo Stato aveva il dovere di proteggere il cittadino, è diventato lo strumento adoperato da chi ha il potere, con la complicità dello Stato, e vuole accrescere il proprio dominio sulla società.
Comune.info online, 10 gennaio 2016
Non è possibile capire l’obiettivo reale della proroga dello stato di emergenza in Francia [prorogato fino alla fine di febbraio] se non la si colloca nel contesto di una radicale trasformazione del modello statale che ci è più familiare.
Bisogna prima di tutto smentire quel che dicono donne e uomini politici irresponsabili, secondo i quali lo stato di emergenza sarebbe uno strumento a difesa della democrazia. Gli storici sanno bene che è vero il contrario. Lo stato di emergenza è infatti il dispositivo attraverso il quale i regimi totalitari si affermarono in Europa. Negli anni che precedettero la salita al potere di Hitler, ad esempio, i governi socialdemocratici di Weimar avevano fatto un tale ricorso allo stato di emergenza (o stato di eccezione, come dicono i tedeschi) che è lecito dire che la Germania aveva smesso di essere una democrazia parlamentare già prima del 1933.
Il primo atto politico di Hitler, dopo la sua nomina, fu proclamare lo stato di emergenza, che da allora in poi non fu mai più revocato. Quando ci si stupisce del fatto che in Germania i nazisti abbiano commesso impunemente così tanti crimini, si dimentica che quelle azioni erano perfettamente legali, poiché il paese era sottoposto allo stato di emergenza e poiché le libertà individuali erano sospese.
Non c’è motivo di escludere che uno scenario analogo possa ripetersi in Francia: non è difficile immaginare un governo di estrema destra mentre si serve di uno stato di emergenza al quale i cittadini sono stati assuefatti dai governi socialisti. In un paese che vive in uno stato di emergenza continuo e nel quale le operazioni di polizia sostituiscono progressivamente il potere giudiziario, è lecito attendersi una dissoluzione rapida e irreversibile delle istituzioni pubbliche.
Sostenere la paura
Questo è ancor più vero in considerazione del fatto che lo stato di emergenza si inserisce, oggi, all’interno del processo che sta trasformando le democrazie occidentali in qualcosa che bisogna ormai chiamare «Stato di sicurezza» (o Security State, come dicono i politologi statunitensi). La parola «sicurezza» è entrata a tal punto nel lessico politico che possiamo dire, senza paura di sbagliare, che la «ragion di sicurezza» ha preso il posto di quella che un tempo si chiamava la «ragion di Stato». E tuttavia un’analisi di questa nuova forma di governo è attualmente difficile da fare: lo Stato di sicurezza non si riferisce né allo Stato di diritto né a quello che Michel Foucault chiamava «disciplinamento sociale». È quindi opportuno mettere qui qualche paletto in vista di una possibile definizione.
Nel modello del filosofo inglese Thomas Hobbes, che ha influenzato profondamente la nostra filosofia politica, il contratto con cui i poteri erano trasferiti al Sovrano presupponeva la paura reciproca e la guerra di tutti contro tutti: lo Stato era per l’appunto ciò che doveva mettere fine alla paura. Nello Stato di sicurezza questo modello è ribaltato: lo Stato si fonda durevolmente sulla paura e deve sostenerla ad ogni costo, perché da essa trae la sua funzione essenziale e la sua legittimazione. Già Foucault aveva dimostrato che, quando la parola «sicurezza» fece la sua comparsa nel lessico politico francese con i governi fisiocratici precedenti alla Rivoluzione, non si cercava di prevenire le catastrofi o le carestie ma di lasciare che accadessero per poi guidarle e orientarle nella direzione che si riteneva più conveniente.
Non c’è alcun senso giuridico
Allo stesso modo, la sicurezza di cui si parla oggi non mira affatto a prevenire gli atti di terrorismo (cosa peraltro molto difficile, se non impossibile, dato che le misure di sicurezza sono efficaci solo ad attacco avvenuto e dato che il terrorismo è per definizione un attacco senza preavviso), ma mira a stabilire un nuovo tipo di rapporti fra le persone, basato su un controllo generalizzato e illimitato: dal che l’attenzione particolare sui dispositivi che permettono un controllo totale dei dati informatici e delle comunicazioni dei cittadini, compresa la possibilità di accedere integralmente al contenuto dei computer personali.
Il primo rischio è una deriva verso la creazione di una relazione sistemica fra terrorismo e Stato di sicurezza: se lo Stato ha bisogno della paura per legittimarsi, allora è necessario provocare il terrore o, nella migliore delle ipotesi, fare in modo che non sia ostacolato. Si vedono così paesi che perseguono una politica estera che alimenta quel terrorismo che poi pretendono di combattere all’interno, che intrattengono relazioni cordiali o addirittura vendono armi a Stati che sono noti finanziatori delle organizzazioni terroristiche.
Un secondo aspetto che è importante tenere a mente è il cambiamento nello statuto politico dei cittadini e del popolo, che si reputava depositario della sovranità. Nello Stato di sicurezza si osserva una tendenza irrefrenabile verso una depoliticizzazione progressiva dei cittadini, la cui partecipazione alla vita politica si riduce ai sondaggi elettorali. Tale tendenza è ancor più inquietante se si considera che era stata teorizzata dai giuristi nazisti, che definivano il popolo come un elemento sostanzialmente impolitico al quale lo Stato doveva garantire protezione e crescita. Ora, secondo questi teorici c’era un unico modo per politicizzare questo elemento impolitico: attraverso la comunanza della nascita e della razza, che avrebbe distinto il popolo dallo straniero e dal nemico. Non si tratta qui di confondere lo Stato nazista con lo Stato di sicurezza contemporaneo. Quello che bisogna capire però è che quando si depoliticizzano i cittadini poi l’unico modo per farli uscire da questa passività è mobilitarli con la paura di un nemico straniero ma non del tutto estraneo: gli ebrei nella Germania nazista, i mussulmani nella Francia di oggi.
È in questo contesto che bisogna pensare all’inquietante progetto di cancellazione della cittadinanza per i cittadini con doppia nazionalità, che ricorda la legge fascista del 1926 sulla denazionalizzazione dei «cittadini indegni della cittadinanza italiana» e le leggi naziste sulla denazionalizzazione degli ebrei.
Incertezza e terrore
Un terzo aspetto, del quale non bisogna sottovalutare l’importanza, è la radicale trasformazione dei criteri che stabiliscono la verità e la certezza nella sfera pubblica. Ciò che più colpisce l’osservatore scrupoloso nella lettura dei comunicati ufficiali sugli atti di terrorismo, è la totale rinuncia alla ricerca di una verità giudiziaria. Mentre nello Stato di diritto è dato per fondamentale che un crimine debba essere definito tale attraverso un’indagine giudiziaria, nel paradigma securitario bisogna accontentarsi di quello che dice la polizia o di quello che dicono i media basandosi sulla prima: due fonti che sono sempre state considerate troppo deboli. Da qui l’ondata di incredibili e palesi contraddizioni nelle ricostruzioni ufficiali dei fatti, che eludono sapientemente ogni possibilità di verifica o falsificazione e che assomigliano molto di più a chiacchiere da bar che a vere inchieste. Questo vuol dire che lo Stato di sicurezza ha tutto l’interesse che i cittadini – dei quali deve garantire la protezione – restino nell’incertezza riguardo a ciò che li minaccia, perché incertezza e terrore vanno sempre a braccetto.
Questa incertezza la si ritrova nel testo della legge del 20 novembre sullo stato di emergenza, che fa riferimento a «ogni persona nei confronti della quale esistono seri motivi per pensare che il suo comportamento costituisca una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza». È del tutto evidente che questa formula («seri motivi per pensare») non ha alcun senso giuridico, poiché poggiando sull’arbitrarietà di chi «pensa», può di fatto essere applicata in qualunque momento a qualunque persona. Ora, nello Stato di sicurezza queste formule indeterminate, che i giuristi hanno sempre considerato contrarie al principio della certezza del diritto, diventano invece la norma.
Depoliticizzazione dei cittadini
La stessa imprecisione e gli stessi equivoci ritornano nelle dichiarazioni degli uomini politici che pensano che la Francia sia in guerra contro il terrorismo. Una guerra contro il terrorismo è una contraddizione di termini, perché uno stato di guerra può essere definito tale solo se esiste la possibilità di identificare con certezza il nemico che si intende combattere. Nella prospettiva securitaria, al contrario, l’identità del nemico deve restare nell’incertezza affinché chiunque – all’interno come all’esterno – possa essere identificato come tale.
Mantenimento di uno stato di paura generalizzato, depoliticizzazione dei cittadini, rinuncia a qualsiasi certezza del diritto: ecco tre caratteristiche dello Stato di sicurezza che hanno tutti i numeri per far rabbrividire gli animi. Da una parte infatti lo Stato di sicurezza verso il quale stiamo scivolando fa il contrario di quanto promette, poiché se sicurezza significa assenza di preoccupazioni (sine cura) esso al contrario sostiene la paura e il terrore. D’altra parte lo Stato di sicurezza è uno Stato di polizia, poiché attraverso l’eclissi del potere giudiziario generalizza quei margini discrezionali della polizia che, in uno stato di emergenza divenuto la norma, sono sempre più determinanti.
Attraverso la depoliticizzazione del cittadino, diventato in un certo senso un terrorista in potenza, lo Stato di sicurezza esce dal campo tradizionale della politica per dirigersi verso una zona grigia, nella quale pubblico e privato si confondono ed è difficile tracciare una linea di confine netta.
Fonte originale lemonde.fr (dove è stato pubblicato con il titolo “Giorgio Agamben: «De l’Etat de droit à l’Etat de sécurité»”, Dallo stato di diritto allo stato di sicurezza). Tradotto per comedonchisciotte.org da Martino Laurenti (che ringraziamo).
 Come i mass media, enfatizzando e anticipando gli atti (effettivi o probabili) del terrorismo ne amplifichino l'efficacia propagandiatica ed accrescano la paura percepita.
Come i mass media, enfatizzando e anticipando gli atti (effettivi o probabili) del terrorismo ne amplifichino l'efficacia propagandiatica ed accrescano la paura percepita.
Il manifesto, 17 gennaio 2016
«Jihadismo e comunicazione. Il meta-terrorismo si nutre dell’amplificazione dei codici comunicativi che l’Isis ha mutuato da Hollywood, investendo molto nella post-produzione e nella strategie di marketing e lancio in prime time. Invece che interrogare esperti di sociologia visuale che tramite quattro coordinate tecniche sappiano decodificare i messaggi e inserire le immagini in un contesto interpretativo, i nostri media le infarciscono di commenti che ne sublimano immancabilmente il potere comunicativo».
L’assalto gemello dello scorso novembre, che prese di mira il Radisson Blue Hotel nella capitale del Mali, aveva già proposto lo schema: la replica «a rullo» della stessa sequenza, una ripresa del vano scale e poco altro nei dintorni dell’albergo, e un imbarazzante vuoto di altre immagini della città e del paese. Poi arrivano i commentatori del caso – spesso volti consueti avvezzi a parlare di tutto — affiancati da immagini di propaganda jihadista, intervallate da mappe improvvisate.
Nell’era dell’informazione globale, questo è lo sconcertante poco con cui abbiamo ormai quotidianamente a che fare: un chiodo ribattuto all’infinito, una miscela di immagini catturate fra circuiti internazionali e social media. Bagliori violenti, punti che raramente vengono uniti da analisi minimamente convincenti: quando si parla di terrorismo ognuno dice un po’ quello che gli pare, vai poi tu a verificare.
Una settimana fa Cheikh Ould Salek evade dal carcere di Nouakchott, capitale della Mauritania, dove pende sulla sua testa una condanna a morte per attentato alla vita del Presidente. La sera prima della fuga aveva chiamato a raccolta i compagni di cella, distribuendo laute somme di danaro; la mattina dopo sulla sua branda hanno trovato una bandiera di Al Quaeda nel Maghreb (Aqim) e una dedica al fantomatico leader della brigata Al-Morabitoun, Mokhtar bel Mokhtar – noto come le borgne, «il guercio». Più volte dato per morto (da ultimo dopo un raro attacco aereo statunitense sui cieli libici) «il guercio» si è recentemente riallineato con i comandi di Aqim, impegnandosi nella costituzione di un ampio fronte quaedista ad ampio raggio, «Al-Qaeda dell’Africa Occidentale».
Sotto la presidenza di Blaise Compaoré, cacciato da una sollevazione popolare un anno fa, Ouagadougu giocò un importante ruolo di mediazione su diversi fronti, dal conflitto in Costa d’Avorio a quello nel Nord del Mali, impegnandosi in trattative che condussero al rilascio di ostaggi occidentali tenuti in mani jihadiste.
Scosso dalle convulse vicende della transizione, il Burkina Faso resta un paese a forte presenza cristiana, dove è debole la pressione di gruppi per l’introduzione della sharia, e dove la propaganda armata quaedista ha tutto sommato poco senso: gli attacchi di ieri vanno dunque letti alla luce di una emergente serialità su scala regionale.
Perché questa lettura sia possibile occorre cercare di illuminare le zone d’ombra del racconto ufficiale – magari proprio a partire dalle incongruenze che hanno segnato l’attacco al Radisson di Bamako, dove gli attentatori ebbero anche il tempo per mettersi a cucinare.
Nulla di tutto questo traluce dai resoconti mediatici a cui ci stiamo abituando, che sostanzialmente alternano immagini di palazzi assediati e clip di propaganda jihadista. Quando si parla di Europa lo schema è ormai consolidato, e si appresta a diventare un genere vero e proprio: si parte con la notizia di «allerta terrorismo a (città X)», corredata da foto di polizie pesantemente armate e strade deserte; a seguire, precisazioni da fonti rigorosamente anonime, e commenti di «esperti» che sempre più spesso si sporgono a speculare su scenari tanto implausibili quanto terrificanti: ad esempio, armi la cui stessa esistenza stessa è un atto sostanzialmente speculativo, come i dispositivi di dispersione radiologica.
Questo genere emergente può essere ricondotto a un fenomeno specifico, a cui è bene dare un nome: meta-terrorismo. Adam H. Johnson sulla rivista statunitense Alternet (Independent Media Institute) lo definisce come il terrore propagato dalla replica non-stop di attacchi terroristici passati e dalla continua speculazione sugli attacchi futuri.
Il meta-terrorismo si nutre dell’amplificazione dei codici comunicativi che l’Isis ha mutuato da Hollywood, investendo molto nella post-produzione e nella strategie di marketing e lancio in prime time. Invece che interrogare esperti di sociologia visuale che tramite quattro coordinate tecniche sappiano decodificare i messaggi e inserire le immagini in un contesto interpretativo, i nostri media le infarciscono di commenti che ne sublimano immancabilmente il potere comunicativo.
Sicuramente sono in arrivo servizi sulle destinazioni di vacanza degli italiani al riparo dal rischio-terrorismo. Un sistema comunicativo in crisi trova nel meta-terrorismo un’occasione per rifiatare.

Carissime amiche e amici, carissimi compagni di strada. 2006-2016: dieci anni della nostra vita e dieci anni e più di impegno per la Costituzione. Per attuarla e aggiornarla. Per non perderla. Per questo vi chiedo di perdonare questa mia lettera a tutti voi, con i quali siamo cresciuti e invecchiati, imparando ad ascoltare, capire e apprezzare le parole di maestri a cui va la nostra gratitudine.
Perdonate se sento la necessità e il desiderio di rivolgermi ancora a voi, perché mentre riconosciamo tra noi una storia che abbiamo scritto insieme, io voglio trasmettervi preoccupazioni e speranze che mi inducono oggi, certo non più giovane di allora e forse nemmeno più saggia, o meno irruente e impulsiva, a riprendere il cammino. La strada non è la stessa dell’altra volta, ma il punto di arrivo sì che assomiglia a quello del 2006. Ancora una volta dobbiamo cercare di fermare con il nostro No un referendum, una legge del governo molto pericolosa per gli equilibri istituzionali, una legge che cancella e riscrive 41 articoli sui 139 della Costituzione entrata in vigore il 1°gennaio del 1948. Quasi un terzo.
Ho trovato, tra le carte che mi ostino a non gettare, un foglietto, una lettera datata 8 novembre 2004 e firmata da Oscar Luigi Scalfaro. Era rivolta al responsabile dei Comitati Dossetti e ai presidenti della associazione Astrid e Libertà e giustizia. Pochi giorni prima avevo chiesto dal palco di un teatro milanese a Scalfaro se avrebbe accettato di fare da presidente del coordinamento di associazioni, cittadini e partiti che con noi si fossero battuti per cancellare la riforma del governo Berlusconi.
Improvvisavo, anche allora. Ma conoscevo bene il presidente emerito dai giorni in cui era un importante esponente della Democrazia cristiana e io facevo la cronista. Su quel palco ci chiese solo di poterci pensare, e intanto ringraziò. E poi scrisse: “Grazie, cari amici, per l’onore grande che mi fate offrendomi la presidenza del coordinamento di tutte le forze politiche, sociali, di tutti i movimenti, di tutti i cittadini che si ribellano all’attuale capovolgimento della nostra Carta Costituzionale... Accolgo volentieri il vostro unanime invito, ben conoscendo le difficoltà che abbiamo dinnanzi, ma la fede nella libertà e l’entusiasmo per difenderla nei valori fondamentali della nostra Costituzione non viene meno”. Terminava secondo il uo stile: “Con l’aiuto di Dio, metterò ogni impegno per continuare con voi questa pacifica ma intransigente battaglia per la nostra Italia, per il nostro popolo. Eccomi dunque al vostro fianco con tanto amore. Oscar Luigi Scalfaro”.
Leopoldo Elia ci fu accanto, insieme a molti altri costituzionalisti. Elia insisteva sui guasti che avrebbe prodot- to un premierato fondato sulla “insostituibilità” del primo ministro durante tutta la legislatura e sui suoi enormi poteri che colpivano le garanzie dell’opposizione.
Si distinsero tra i costituzionalisti i due padri dell’attuale riforma: Augusto Barbera e Stefano Ceccanti ai quali si rivolse polemico Giovanni Sartori accusandolo di dividere il fronte del No... quando invece ci sono duecento costituzionalisti, non nani e ballerine, che fanno presente come il premierato della Casa della libertà sia assoluto”. Barbera e Ceccanti: il primo adesso è alla Corte Costituzionale, il secondo è il suggeritore zelante del governo.
Voi tutti sapete che grande lezione di democrazia e libertà fu per tutti noi quella campagna referendaria, quanta gente incontrammo, quanti ragazzi, quanti vecchi, quanto imparammo. Quanti cittadini ci ringraziavano per le informazioni che davamo ma eravamo noi a dover dire quel “grazie”. Abbiamo conosciuto una bella Italia e abbiamo vinto strepitosamente il referendum. A chi ora ci deride (vedi Pierluigi Battista sul Corriere della Sera) affermando che siamo gli avanzi della sinistra che perde sempre possiamo, denunciando la pochezza e la viltà di quelle affermazioni, replicare: “No, noi siamo quelli e quelle del 2006. Siamo quelle e quelli che portarono a votare il 53,7 per cento degli aventi diritto, e il 61,3 per cento dei votanti bocciò la riforma di Berlusconi e Calderoli. Noi siamo quelli. Abbiamo vinto una volta”. E domani, cosa accadrà?
Il nostro è un tempo diverso, un tempo “esecutivo” come dice Gustavo Zagrebelsky, un tempo in cui c’è uno solo al comando e uno solo che fa. Non c’è più Berlusconi da combattere, c’è però il Partito democratico renziano. Renzi ha ingaggiato un guru americano per centomila euro. Non c’è Calderoli, c’è la Boschi. La Rai è del governo, più di prima e i grandi giornali stravolgono la realtà. Abbiamo, però, un Comitato per il No con grande studiosi e giuristi che hanno già preparato le basi costituzionali e scientifiche per il nostro No. Abbiamo due giornali (il Fatto Quotidiano e il manifesto) che ci aiuteranno a non scomparire del tutto. E abbiamo ancora tanti comitati locali e compagni di strada che ci sollecitano ad agire.
 Quando i media sono servi del potere vuol dire che la democrazia è ferita. Questa piccola testimonianza di un giornalista fuori dal coro che risponde a un lettore ci aiuta a comprendere quanto in Italia la ferita sia profonda.
Quando i media sono servi del potere vuol dire che la democrazia è ferita. Questa piccola testimonianza di un giornalista fuori dal coro che risponde a un lettore ci aiuta a comprendere quanto in Italia la ferita sia profonda.
Il Fatto Quotidiano, 16 gennaio 2016
La domanda
Caro Furio Colombo, hai notato che la decadenza di Roma, raccontata a base di buche, di fermate improvvise e inspiegate della metropolitana e di autobus fermi si è risolta da sola? Rimosso Marino, e con la serena guida del prefetto Tronca, tutto risolto. Manlio
La risposta
La domanda propone una riflessione sul modo di dare le notizie (o di crearle) da parte dell’intero sistema dell’informazione in Italia. Di Ignazio Marino ricorderemo, oltre all’impeccabile onestà, la testardaggine nel non cambiare idea anche quando gli conveniva, e la solitudine, che in politica è sempre un problema, in tutte le direzioni: il suo staff, il Comune, il partito e persino molti cittadini che lo avrebbero aiutato di più se lo avessero capito di più.
Però i media sono un’altra cosa. Una volta diffusa la parola d’ordine, di fonte politica, di Roma decadente e decaduta, dove tutto è ridotto a uno stato di rovina, una Roma Piranesi fatta di ruderi (a partire, s’intende, dai servizi mancanti del Comune) si è mobilitata una quantità di immagini uguali, di interviste identiche, di commenti che sembravano l’uno la riproduzione dell’altro, e una formidabile campagna “destra-sinistra” degna di un grande match di pugilato. A un colpo contro la Roma in rovina di Libero e
Avevano ragione. Una volta eliminato il sindaco, con l’espediente di far dimettere la parte la maggioranza del consiglio comunale eletta dallo stesso partito con lo stesso sindaco, la gravissima situazione della città di Roma, per miracolo, si è risolta. Sparite praticamente subito le tetre inquadrature delle bottigliette di plastica vuote che rotolano nell’incuria verso un Colosseo in evidente rischio di crollo. Si apprende dagli utenti quotidiani che le occasioni in cui i convogli della Metro partono e arrivano a porte aperte continuano come prima, ma non creano “incidente giornalistico”.
I cittadini hanno smesso di scrivere (o radio e giornali hanno smesso di pubblicare) i messaggini indicanti le condizioni insopportabili della via tale o tal’altra. Non so se sia vero che sono ritornati i camion-bar Tredicine, ma vedo aumentare ogni giorno l’ingombro di occupazioni abusive che erano scomparse con il Marziano a Roma.
Il fatto è che Roma non fa più scena, le foto delle piazze disastrate non fanno più prima pagina, i turisti stranieri non sono più esasperati, quelli italiani provano un nuovo affetto per Roma. E il Papa va da solo, in Panda, a farsi aggiustare gli occhiali. Non c’è un questuante in meno, ma una volta abbattuto un sindaco ingombrante, a che serve la noia di discutere un problema che non si può risolvere?
 Chi vuole cambiare il perverso sistema di potere che domina oggi e conduce l'Italia al declino morale, sociale, economico non perda l'occasione delle elezioni amministrative e, soprattutto, delle battaglie referendarie per far sentire una voce unitaria.
Chi vuole cambiare il perverso sistema di potere che domina oggi e conduce l'Italia al declino morale, sociale, economico non perda l'occasione delle elezioni amministrative e, soprattutto, delle battaglie referendarie per far sentire una voce unitaria.
Il manifesto, 16 gennaio 2016
La rottura intervenuta all’ormai famoso tavolo promosso da L’Altra Europa con Tsipras per un processo costituente di un soggetto politico della sinistra – avvenuta per ben distribuite e differenziate responsabilità – non può e non deve significare l’abbandono di quel progetto. Diversi sono gli appelli unitari che vengono dai territori in questi giorni che ne reclamano giustamente il perseguimento. Certamente quel tavolo non può essere rimesso in piedi così come era. Probabilmente la sua stessa ristretta composizione non ha aiutato. Logiche identitarie e conservative hanno prevalso. Né si può accettare il paradosso che l’allargamento della sua composizione a chi nel frattempo ha abbandonato il Pd sia stato di per sé fattore di crisi anziché di arricchimento. Il percorso si fa quindi più articolato, complesso e forse più lungo. Ma non va abbandonato.
Tanto più che l’anno che comincia ci offre una occasione difficilmente ripetibile di fare rivivere alla politica una dimensione di massa. Mi riferisco in primo luogo alla stagione referendaria che sta per aprirsi, senza trascurare le elezioni amministrative in importanti città. Renzi scommette tutto sul referendum costituzionale. Ha posto una sorta di fiducia sul suo esito. Vuole ingaggiare il guru della campagna per l’elezione di Obama, per una campagna martellante e non solo televisiva. Battaglia soda, avrebbe detto il Machiavelli. Da un lato dimostra tutta la pochezza di questa classe dirigente. Mai i costituenti di un tempo avrebbero pensato di schiacciare sulla contingenza politica il tema della Costituzione che dovrebbe avere ben altro respiro. Dall’altro lato è vero che se dovesse perdere, neppure l’Italicum starebbe in piedi e crollerebbe l’intero impianto neoautoritario su cui Renzi fonda il suo governo e il suo potere. E questo Pd senza il governo non è nulla. Anche perché nella sua foga di distruggere i corpi intermedi della società, tra cui i sindacati e i partiti, Renzi ha in primo luogo macinato il proprio.
Il referendum costituzionale è senza quorum, uno scontro diretto fra il No e il Sì senza l’ausilio dell’astensione.. Se lo si vuole vincere – e non è impossibile –bisogna mettere in campo tutta la passione, l’intelligenza e le forze di cui disponiamo e che dobbiamo accrescere e affinare nella campagna stessa. Non solo, ma è fondamentale legare i temi sociali con quelli istituzionali. Per questo sarà decisiva la raccolta delle firme nella primavera per l’abolizione dell’Italicum, delle cattive leggi sul lavoro, la scuola e l’ambiente che hanno caratterizzato il neoliberismo renziano. Non c’è nulla di automatico in questo, anzi ci vorrà molto pensiero e buona comunicazione: ma l’occasione per legare assieme battaglia politica e sociale, per fornire nuova linfa alla coalizione sociale e ad un necessario nuovo soggetto politico della sinistra è troppo ghiotta. L’idea che si possa fare a meno di una rappresentanza politica della sinistra bastando in sua vece l’autorappresentazione sociale è smentita dalla storia e anche dai recenti successi di una rinata sinistra in più punti d’Europa.
Un contributo alle prove di una sinistra autonoma dal Pd e da un centrosinistra -morto nell’anima e di cui si vorrebbero fare sopravvivere solo le vuote spoglie – potrà venire anche dalle prossime elezioni amministrative. A condizione che si separi concettualmente prima ancora che fattualmente, la politica delle alleanze dalla logica del vincolo coalizionale. La prima è un classico sempre rideclinabile della politica del movimento operaio, a livello politico e sociale. Ma parte dalla condizione imprescindibile dell’autonomia politica e organizzativa del soggetto di sinistra. La seconda costituisce una prigione che condanna forze minori a essere satelliti attorno al pianeta Pd. E’ curioso che di fronte a una legge elettorale che conferisce il premio di maggioranza alla lista e non alla coalizione, ci sia ancora chi indulge al tema delle primarie e della coalizione preventiva con il Pd. Tema che solleverei anche all’attenzione di Aldo Bonomi, pur nel rispetto delle specificità sociali e culturali del quadro milanese, che non mi sono ignote. In alcune città, ricordo per difetto Torino, Bologna, Roma, si stanno costruendo percorsi che dimostrano non solo la necessità, ma la possibilità di liste unitarie di sinistra alternative al Pd capaci di affrontare nella sua complessità la problematica del vivere urbano.
Nel frattempo non vanno perdute occasioni di incontro unitario. Non è l’inizio del processo immaginato dal tavolo, ma l’appuntamento previsto per febbraio da Act può diventarne una tappa se si apre alla codecisione di temi, modalità e finalità. Se così non avverrà, sarà una sconfitta per tutti.
Ma che caratteristiche deve avere questo nuovo soggetto politico della sinistra? In molti giustamente se lo domandano e tutti invocano innovazione. Più facile dire cosa non deve essere – viste le esperienze fallimentari in questo campo – cioè non un semplice soggetto elettorale, non una federazione di sigle, certamente non un partito ‘monolitico’. Alcuni si ispirano ai modelli esistenti - da Syriza a Podemos passando per la Linke, spingendosi fino alle formazioni latinoamericane - che però sono uno diverso dall’altro e ogni processo se è reale deve anche essere originale. Se pensiamo che si tratti di organizzare politicamente una parte della società, ora depredata delle sue rappresentanze e delle sue “casematte”, la parola partito non dovrebbe costituire uno scandalo per alcuno, pur non esaurendo l’opera di ricostruzione dei corpi intermedi, cioè delle vene della democrazia.
Ma non nasce come Minerva dalla testa di Giove. Deve essere frutto di un processo costituente, immerso nel dibattito culturale e teorico – senza la costruzione di un profilo politico e programmatico riconoscibile non si va da nessuna parte - quanto nella più concreta lotta sociale e politica. Ma questo comporta che non si pongano pregiudiziali tanto all’inizio del processo – come lo scioglimento immediato delle forze esistenti, perdendosi così nel bicchiere d’acqua dei veti e delle pretese – quanto e soprattutto al suo esito che, per avere successo, dovrà andare ben oltre il quadro peraltro assai gracile e incerto che oggi ci offre la sinistra.
Nota redatta per l’associazione
Primalepersone in vista del prossimo Forum dell’economia sociale e solidale in programma a Bruxelles il 28.gennaio 2016
Poiché considero la questione dei profughi centrale per il futuro nostro e dell’Europa, cerco di chiarire e riassumere qui per punti le posizioni che sono andato definendo approfondendo il problema nel corso dell’ultimo anno e mezzo.
1. Migrazioni ed esodo, problema centrale
2. Insensate le politiche di respingimento
Dove respingerli? Rigettarli tra le braccia dell’Isis, o di suoi emuli, ormai presenti in quasi tutti i paesi da cui si originano quei flussi, accrescendo del pari le loro forze sia là che, per solidarietà, tra gli immigrati nei paesi europei? Non farebbe che moltiplicare sia i fronti di guerra fuori e dentro i confini dell’Europa, sia nuove e più consistenti migrazioni.
Stringere accordi con i governi dei paesi di origine perché li riaccolgano o li trattengono in patria? Non sono disposti a farlo nemmeno a caro prezzo (e il prezzo è comunque destinato a salire, e di molto, mentre i paesi europei meno esposti non sono assolutamente disposti a condividerlo). Lo ha dimostrato il vertice di La Valletta e lo dimostra la fragilità del cinico patto stretto dalla Commissione europea con Erdogan sotto la supervisione di Angela Merkel.
Costruire e gestire più o meno direttamente (anche se sotto il velo di un coinvolgimento dei governi locali) dei campi di concentramento – e, in buna misura, di sterminio – in cui rinchiudere tutte le persone in fuga o sbandate che cercano di effettuare o stanno intraprendendo un viaggio verso l’Europa? Quei campi raggiungerebbero presto dimensioni smisurate, e sempre più difficili da gestire.
3. Catastrofiche conseguenze delle politiche attuali
Ma l’esito più probabile di una politica di respingimento è quello di scaricare sui paesi di primo accesso che non possono erigere barriere fisiche ai confini (sostanzialmente Grecia e Italia) tutto il peso dei nuovi arrivi, chiudendo nei loro confronti le frontiere interne del resto d’Europa. Inutile dire che questo porterebbe rapidamente alla saturazione delle capacità di accoglienza (per quanto sommaria e mal gestita) di questi due paesi; ma anche delle loro capacità di respingimento: i rimpatri diventerebbero ben presto “affar loro”, mentre gli altri paesi membri “se ne lavano le mani”, come sta già succedendo con le ridotte quote di riallocazioni definite dalla Commissione europea.
E’ ciò che di fatto sta già succedendo con il cosiddetto “decreto di espulsione differita”: si abbandonano per strada senza soldi, senza documenti, senza riferimenti, senza la conoscenza della lingua, persone a cui è stato ingiunto di lasciare il paese a loro spese entro una settimana E’ come consegnarli alla clandestinità, alla criminalità, allo stupro, alla disperazione e alle mafie.
Ma se è ancora possibile fare questo giochetto con alcune centinaia di profughi, è evidente che non lo sarà più con le decine di migliaia che arriveranno. L’Italia non ha una politica su questa questione, perché nonostante le (molto recenti) uscite di Renzi sul tema, non ha mai posto il problema in sede Europea nella sua dimensione e drammaticità effettive. Ma una prospettiva del genere corrisponde alla dissoluzione dell’Unione.
4. Una prospettiva diversa
Per colmare questo vuoto demografico l’Europa dovrebbe “importare”, di qui al 2050, tre milioni di immigrati all’anno: il triplo dei profughi che sono arrivati nel 2015. Potrebbe anzi assorbirne anche il doppio senza subire alcun tracollo; ma cambiando ovviamente in modo radicale sia le sue politiche economiche che quelle sociali. Peraltro, fino al 2008, arrivava in Europa un milione di nuovi migranti economici all’anno, cioè quanti sono stati i profughi quest’anno.
Sono le politiche di austerità che, oltre a creare in Europa milioni di nuovi disoccupati, hanno trasformato in un problema l’assorbimento di nuove forze di lavoro proveniente da altri paesi. D’altronde, tra il 1945 e la metà degli anni ’60 quattro paesi dell’Europa centrale, UK compreso, avevano assorbito circa 20 milioni di profughi e di immigrati: 10 milioni dall’Est e 10 milioni dai paesi mediterranei dell’Europa, dall’Africa e dal Maghreb. La minaccia di un sovraffollamento è dunque esclusivamente il frutto di politiche economiche restrittive e, sul lungo periodo, suicide.
5. Servono politiche radicalmente diverse
6. Il mercato non può, serve l'intervento del Terzo settore
In Italia abbiamo ottimi esempi di questo lavoro, ma anche clamorose prove della sua degenerazione in organizzazioni come quelle di Buzzi (mero strumento o braccio armato della corruzione e della criminalità che alligna nelle alte sfere della politica e dell’amministrazione pubblica). Il 28 gennaio di questo mese si terrò a Bruxelles il primo Forum europeo dell’economia sociale e solidale (SSE). E’ stato proposto che, tra le altre cose, venga messo all’ordine del giorno il ruolo che la SSE può e deve assumere nei confronti del problema profughi, lanciando un grande piano europeo per creare lavoro nei settori decisivi ai fini della conversione ecologica (agricoltura, edilizia, energie rinnovabili, mobilità, riassetto del territorio e assistenza alle persone).
Un piano da affidare alle imprese – esistenti o da costituire – della SSE, in modo che l’inserimento lavorativo venga accompagnato da programmi personalizzati di inclusione sociale. Questa proposta è stata ascoltata con interesse ma non è stata sviluppata in modo adeguato. Nonostante tutto, nella maggioranza dei paesi europei, per lo meno nell’ambito della cosiddetta sinistra che fa capo al GUE, promotore del Forum, la centralità del problema dei profughi non viene ancora avvertita con l’urgenza che meriterebbe. Aggiungo che un piano di questo genere potrebbe avere un risvolto di grande interesse anche nell’ambito delle politiche di cosiddetto rientro, di cui parlerò in seguito.
7. Le condizioni per invertire la tendenza all'esoto
Ma il problema centrale è quello di creare dei circuiti in base ai quali agli arrivi possano corrispondere, anche se in misura minore, ma non irrilevante, dei ritorni volontari e delle motivazioni forti per farlo. Occorre considerare l’Europa e i paesi africani, ma anche quelli mediorientali, da cui provengono oggi i profughi e i migranti come un’unica grande area attraversata da interscambi non solo economici (necessariamente squilibrati per molto tempo ancora), ma anche culturali, sociali e civici.
Quei confini dell’Europa che l’Unione vorrebbe allargare riducendo i paesi di origine dei flussi migratori in avamposti della sua trasformazione in fortezza, occorre invece riuscire a farli percepire e vivere, innanzitutto nella coscienza dei cittadini europei, dei profughi e dei migranti di prima, seconda e terza generazione, come il perimetro di una nuova comunità euromediterranea ed euroafricana. Ma come? Dire che occorre “bonificare l’Africa” per fermare quei flussi è davvero troppo poco.
8. "Aiutiamoli a casa loro": ma come?
Il secondo modo è quello invocato da Salvini (ma, ahimè, sostenuto anche dalla Merkel) per cui stanziamenti anche molto più consistenti, posto che si trovino, vanno destinati prioritariamente a trattenere (e internare) profughi e migranti in strutture appositamente costituite nei paesi di origine o di transito dei flussi. Che ciò significhi nient’altro che dichiarare guerra ai migranti si è già detto.
Il terzo modo è tutto da costruire perché mira a rendere le comunità espatriate in Europa, cioè i profughi e i migranti (di prima, ma anche seconda e terza generazione) protagonisti di una politica di ricostruzione di un tessuto sociale ed economico in grado di offrire delle prospettive di maggior benessere anche agli abitanti dei paesi di origine. Profughi e migranti sono in gran parte la componente più istruita, più giovane, più intraprendente (quelli che hanno avuto la forza e l’iniziativa di affrontare un viaggio così pericoloso) della popolazione da cui provengono: un apporto che l’economia, la cultura e le società dell’Europa potrebbero valorizzare molto, mentre oggi lo svalutano, lo disprezzano e lo degradano.
Ma soprattutto sono una risorsa strategica per la costruzione di una grande comunità euroafricana ed euromediterranea. Sono persone che ancora intrattengono forti legami con le loro comunità di origine, o che possono facilmente riattivarli; che in Europa possono costruirsi o affinare delle competenze, delle conoscenze, delle professionalità, delle esperienze da mettere a disposizione dei loro paesi di origine con grande vantaggio per tutti, qualora se ne creino le condizioni. Non solo per reinserirsi nei loro paesi di origine, andando a occupare posizioni già esistenti, ma per creare opportunità e modalità di produzione di reddito e di ricchezza completamente nuove.
9. Condizione di base: riconoscimento politico delle comunitá espatriate
Prima ancora di pensare ai finanziamenti, o anche a progetti di cooperazione allo sviluppo - in gran parte pensati e progettati dall’esterno - occorre lavorare con le comunità di profughi e migranti nella prospettiva di aiutarli a rendersi attori e protagonisti di un nuovo processo di integrazione delle economie e delle società dei paesi di origine e di quelli di arrivo. Non credo che esistano alternative a una prospettiva del genere che non siano quelle prospettate nella prima parte di queste note; anche se realizzarla, soprattutto nel clima di ostilità crescente nei confronti degli immigrati chestiamo vivendo, sarà sempre più difficile.
I sottotitoli sono di eddyburg

Il manifesto, 16 gennaio 2016 (m.p.r.)
L’Aquila. L’Abruzzo abbandona il referendumantitrivelle. E lo fa con una decisionedella Giunta regionale che, ingran segreto, ingrana la marcia indietro,ignorando il mandato del Consiglio regionaleche, invece, compatto, il 24 settembre2015 aveva scelto di portare avanti laconsultazione popolare insieme ad altrenove Regioni (Basilicata, Marche, Puglia,Sardegna, Veneto, Calabria, Liguria,Campania e Molise).
Voltafaccia delpresidente Luciano D’Alfonso (Pd) chein questa maniera lancia un chiaro segnaledi fedeltà al premier Matteo Renziche si sta muovendo su ogni fronte perevitare il referendum antipetrolio.D’Alfonso baratta la cancellazione delprogetto «Ombrina Mare» e i soldi del Masterplan(753 milioni) con l’abbandono delreferendum? Sta di fatto che la RegioneAbruzzo, senza farlo sapere troppo in giro,ha revocato l’incarico all’avvocato StelioMangiameli per i quesiti referendari antitrivelleche il 19 gennaio saranno all’attenzionedella Corte Costituzionale.
«Si tratta di un atto gravissimo ed irresponsabile,dell’ennesimo colpo inferto allademocrazia nel nostro Paese», fa presenteil Coordinamento nazionale No Triv.«Non solo il referendum non è più da temponella disponibilità di nessuno se nondella Corte Costituzionale - aggiungono iportavoci dei No Triv - ma, volendosi spingerefino ad infrangere le regole, avrebbedovuto essere il Consiglio regionale, cherappresenta tutti gli abruzzesi, a discuteree decidere se deliberare su questo drasticocambio di rotta. Il presidente D’Alfonso ela giunta si dimettano immediatamente!!!»
«L’Abruzzo ha rotto di fatto il fronte delleRegioni che si erano coalizzate contro il dilagaredelle trivellazioni in mare - commentaMaurizio Acerbo, di Rifondazione comunista-. La cosa più grave è che lo ha fattonon solo nascondendolo alla cittadinanzama persino in maniera illegittima visto cheil Consiglio regionale è all’oscuro di tutto.Da quel che mi risulta l’Abruzzo ha decisonon solo di non affiancare le altre Regioninel conflitto di attribuzione davanti allaCorte Costituzionale, ma persino di ritirarsidefinitivamente dalla compagine referendaria.Lo avranno deciso D’Alfonso e il suoesecutivo per ingraziarsi Renzi ma va sottolineatoche non era nelle loro facoltà inquanto queste decisioni spettavano al Consiglio.Tutto ciò - prosegue l’ex consigliereregionale ed ex parlamentare, Acerbo - dàla misura della senso dalfonsiano delle istituzioniché neanche la conferenza dei capigruppoè stata sentita. Non credo che l’avvocaturaregionale o il delegato LucrezioPaolini in questa materia possano legittimamenteassumere posizioni senza mandatodel Consiglio come invece sembra siaaccaduto».
«Può il presidente surrogare il Consiglioregionale, che aveva deliberato intal senso? O in un delirio di onnipotenzacrede di poter sostituire chicchessìa?»:lo chiede il senatore Fabrizio Di Stefano(FI), che aggiunge: «Una cosa è certa:questa scelta non rappresenta la volontàdegli abruzzesi e sicuramente dei consiglieriregionali di Forza Italia, che si farannosentire per contrastare questa iniziativache di certo nessuno vuole. Nonsi dica che la Legge di stabilità ha fermato"Ombrina" - aggiunge Di Stefano -."Ombrina" forse è stata bloccata, ma altretrivellazioni, anche più devastanti,possono ancora essere autorizzate. Sommiamola sospensione dell’autorizzazionead "Ombrina", l’autorizzazione allasocietà Petroceltic in Puglia e questa iniziativa:sono a mio giudizio indizi che cifanno preoccupare».

Il Fatto Quotidiano, 15 gennaio 2016 (m.p.r.)
Ancora una fumata nera per ladecadenza da deputato diGiancarlo Galan. Con scambiodi accuse tra MovimentoCinque Stelle e Pd. I grillini, infatti,hanno accusato i dem di rallentarel’iter che, secondo la legge Severino,porterà l’ex governatore del Venetoalla perdita del seggio parlamentare.Galan, infatti, nell’ottobre del 2014ha patteggiato una condanna a 2 annie 10 mesi diventata definitiva il 3 luglio2015, arrivata per l’inchiesta relativaagli appalti del Mose, che Galansta scontando ai domiciliari dopoaver passato 78 giorni in carcere. Daallora sono passati sette mesi, mal’ex ministro berlusconiano èancora deputato.
«È intollerabileche Galan sia ancora un deputatodella Repubblica nonostantela sua condanna definitiva.Questo succede perchéil Pd ha disertato perben due volte la giuntaper le elezioni permettendoa Forza Italia e Ncddi prendere tempo»,ha attaccato ieri DavideCrippa, capogruppo deiCinque Stelle in giuntaper le elezioni. Secondo ilgrillino «la diserzione inmassa dei deputati del Pdnon può essere casuale,ma è evidentementefrutto di un ordine discuderia». Accuse rispediteal mittente daidem. «Le parole di Crippa stupisconoassai. Avendo chiarito con lui cheil Pd vuole senza dubbio andare avantisulla decadenza di Galan nellaprossima riunione, le polemichestrumentali lasciano il tempo chetrovano», ha osservato il capogruppodem Giuseppe Lauricella.
Per la precisione ieri è saltata lariunione del comitato permanenteper le incompatibilità, ovvero un incontrodella giunta ristretto, che dovràrelazionare sulla vicenda. Poi laparola tocca alla giunta per le elezioninel suo complesso, che si esprimeràcon un voto, e infine la palla passaall’aula, che voterà anch’essa.«Le polemiche dei grillini sono strumentali.Gli slittamenti sono successia causa degli impegni parlamentari,per esempio, a dicembre, la legge distabilità. Ma da parte nostra non c’èalcuna remora, anzi siamo più decisiche mai a votare la decadenza», ha assicuratoLauricella. Ma il MovimentoCinque Stelle non sembra convintoe aspetta il Pd al varco alla riunioneprevista per la prossima settimana.
Sta di fatto, però, che il deputato azzurrocontinua a percepiredenaro pubblico nonostantela condannadefinitiva. Non tuttele indennità previstedal trattamento economicodei parlamentari,ma una buona fetta. Galan,infatti, riceve i 5 mila euro nettimensili previsti dallo stipendio.Mentre non gli viene assegnata né ladiaria (circa 3.500 euro), né il rimborsospese per l’esercizio di mandato(3.690), e nemmeno gli altri rimborsiprevisti, come quelli per le spese telefoniche.Dalla condanna, luglio2015, Galan a oggi, gennaio 2016, hapercepito circa 35 mila euro come deputatoancora in carica. A cui vannoaggiunti gli accantonamenti per il vitalizio.All’ex governatore sono staticontestati i reati di corruzione, concussionee riciclaggio.
Secondo laprocura del capoluogo veneto, infatti,l’ex ministro della Cultura ha percepito «uno stipendio di un milione dieuro l’anno più altri due milioni unatantum per le autorizzazioni necessarieall’opera». Così, il 22 luglio2014, la Camera decise sul suo arresto,nonostante il tentativo di rinvioda parte del capogruppo di Forza ItaliaRenato Brunetta perché Galan, acausa di una frattura del perone, eraricoverato in ospedale e non potevaessere in Aula a difendersi. L’Aulaconcesse l’arresto non ravvisando ilfumus persecutionis con 395 voti e favoree 138 contrari. E ora, a causa dellaSeverino, arriverà anche la decadenza.Sempre che la giunta per elezioniriesca a riunirsi e a votare.
 «L’allarme di Bruxelles Il commissario europeo Avramopoulos avverte: “Rinunciare alla libera circolazione è la fine del progetto europeo».
«L’allarme di Bruxelles Il commissario europeo Avramopoulos avverte: “Rinunciare alla libera circolazione è la fine del progetto europeo».
Il Fatto Quotidiano, 16 gennaio 2016 (m.p.r.)
Il primo luglio del 2000, il ponte di Oresund ha unito ciò che la fine dell'era glaciale aveva diviso: cioè Svezia e Danimarca. Sedici chilometri, sette anni di lavoro, 14 euro di pedaggio (oggi), quel ponte è diventato il simbolo di un'Europa ricca e pacifica che si poteva attraversare in auto, senza confini, grazie all'accordo di Schengen che giusto l'anno prima aveva raccolto nuovi membri, contando tutti gli Stati dell'Unione europea tranne Irlanda e Gran Bretagna. Alla mezzanotte di domenica 3 gennaio 2016, la Svezia ha deciso di ripristinare almeno per un mese i controlli sul ponte di Oresund, con una sospensione temporanea di Schengen.

KAMIKAZE NEL CUORE DI GIACARTA “L’IS VOLEVA UN'ALTRA PARIGI”
Giacarta. Ci sono ancora transenne e soldati a bloccare la strada dove passanti e curiosi si accalcano a tarda sera nel luogo dove ieri un numero ancora imprecisato di kamikaze si è fatto esplodere spostando, dopo Parigi e Istanbul, il terrore a Oriente, nel Paese islamico più popoloso del mondo: l’Indonesia.
Il manifesto
A JAKARTA «ATTACCO AI CROCIATI»
di Emanuele Giordana
La rivendicazione è arrivata a distanza di qualche ora dall’ennesimo attentato coordinato e che questa volta prende di mira Jakarta, la capitale del più popoloso Paese musulmano del pianeta. Prima un sito vicino al sedicente Califfato poi un messaggio di Daesh che certifica la nuova battaglia contro i «crociati» anche se per la verità, nel cuore di Jakarta, di crociati ve ne sono pochi: tra le vittime ci sono un canadese e un indonesiano (il bilancio è di sette morti di cui 5 sono attentatori, tutti locali) e nella ventina di feriti un algerino, un austriaco, un tedesco e un olandese. Sembra più un caso che un target. La dinamica dell’attentato multiplo è ancora confusa: il numero degli attentatori a cavallo di motorini varia sino a 14.
Le esplosioni sarebbero state almeno sei o sette e sembrerebbero imputabili a tre kamikaze (che fan saltare una baracca della polizia a un incrocio) e a lanci di granate. Un kamikaze entra da Starbacks, la catena internazionale del caffè, fa poco danno ma gli avventori entrano nel mirino dei jihadisti all’uscita dall’edificio.
Ci sono già i primi arresti e la conferma che ci sarebbe proprio Daesh dietro una tentata strage che in realtà è un mezzo fiasco: la paura c’è tutta e nel mirino forse anche ambasciate e una sede dell’Onu ma nella realtà è la popolatissima e popolare zona del Sarinah, uno dei primi centri commerciali della città, a farne le spese e con lei i tanti feriti colpiti dalle schegge di detonazioni tutto sommato poco potenti. Con la paura c’è anche l’effetto mediatico: l’Indonesia come la Francia, Jakarta come Parigi. Lo spettro della guerra totale ancora una volta la fa da padrone colpendo la quotidianità dello shopping in una zona frequentata da ricchi e poveri, magnati in auto sportive e venditori ambulanti.
Le piste sono diverse. Quella di Daesh, secondo la polizia indonesiana, porterebbe a Bahrun Naim, un locale che starebbe combattendo in Siria. La polizia aggiunge che dietro il colpo ci sarebbe anche il tentativo di prendere il comando dei simpatizzanti di Daesh, un movimento che è presente in Indonesia ma senza grandi numeri anche se, alcuni giorni, fa la polizia ha arrestato una serie di sospetti affiliati allo Stato islamico che avrebbero avuto in mano piani di attacco a diversi località nazionali tra cui la capitale. Un piano, dicono gli inquirenti, finanziato con denari provenienti da Raqqa.
Ma in Indonesia c’è anche Al Qaeda: gli attentati - riferisce la Bbc - sono stati preceduti, l’altro ieri, da un messaggio audio di Ayman al-Zawahiri rivolto agli indonesiani e ai musulmani nel Sudest asiatico. Messaggio che li esortava a colpire interessi di Usa e alleati. Poi c’è la pista Abu Bakar Bashir:
Condannato a 15 anni di prigione per un campo di addestramento jihadista, Bashir è considerato il leader spirituale della Jemaah Islamiyah, l’organizzazione terroristica responsabile della strage di Bali del 2002 rivendicata dai qaedisti. Bashir se l’è sempre cavata ma proprio due giorni fa si è visto rifiutare un appello che richiedeva l’applicazione di una sentenza minore comminatagli da una corte di giustizia ma il cui verdetto è stato annullato. Bashir avrebbe giurato fedeltà a Daesh nell’agosto del 2014 ma secondo alcune fonti avrebbe poi ritrattato l’adesione che aveva creato divisioni nel suo gruppo, la Jemaah Ansharut Tauhid (Jat), fondata nel 2008 proprio per non farsi coinvolgere nelle indagini sulla JI.
Il quadro insomma è complesso. Certo Daesh ha un progetto nel Sudest asiatico: dei 30mila non arabi che pare combattano per Daesh, quelli di quest’area sono solo alcune centinaia e gli indonesiani han scelto la linea dura: chi va in Siria (5 o 600 persone) non potrà più tornare a casa. Per adesso nell’arcipelago non si è andati più in là di manifestazioni di sostegno a Daesh — come quella organizzata a Giacarta dal gruppo Islamic Sharia Activists Forum — o dell’adesione di vecchi maestri di jihadismo come nel caso di Bashir. A occuparsi di questi problemi c’è comunque Densus 88, un gruppo d’élite anti terrorismo dalla mano pesante. L’Indonesia infine ha una tradizione di islam moderato che vede i gruppi più importanti del Paese condannare Daesh e venir coinvolti dal governo per evitare che il contagio degeneri.
Sul piano strettamente locale le cose sono però confuse dal fatto che le indagini hanno spesso portato le autorità a fare i conti con la malavita locale, uomini d’affari e agenti deviati, legati da una rete nostalgica della vecchia stagione della dittatura del generale Suharto, durata trent’anni e abile nel manovrare gruppuscoli e sigle per controllare l’opposizione. E con una vocazione al caos da cui far uscire una nuova richiesta di ordine che riproponga il pugno di ferro e gli affari che il clan Suharto garantiva a una compagine di affaristi protetti dal regime.
Povertà, predicatori d’odio e amministrazioni corrotte così la Jihad contagia l’Asia
di Jason Burke
IL 2016 non è iniziato bene. Ogni settimana ha portato con sé nuovi attentati e minacce. Chi sperava in una pausa dal ritmo incessante della violenza è rimasto deluso. All’inizio di questa settimana le prime pagine dei giornali hanno aperto con gli attentati terroristici in Egitto e Istanbul. L’ultimo, un attentato suicida contro turisti tedeschi in una delle mete più celebri d’Europa, ha accentuato la sensazione di pericolo immediato per l’Occidente.
E non solo da Raqqa. L’Indonesia, fino ad allora sopratutto meta turistica e, per i più edotti l’ex regno di una dittatura ultratrentennale, fece parlare di sé nel 2002 con la bomba di Bali. Duecentodue morti in maggioranza stranieri quando ancora colpire i turisti era una novità. Le indagini, indirizzate sulla Jemaah Islamiyah e sul controverso guru islamico Abu Bakar Bashir, rivelarono piste che puzzavano di bruciato. Alcune infatti portavano più in là del jihadismo locale, tutto sommato un fenomeno - oggi come allora - residuale.
Portavano a figure oscure che si muovevano tra la potente malavita indonesiana, ricchi businessman, settori dell’esercito, l’unico soggetto in grado di possedere esplosivi e che vantava una lunga storia di infiltrazioni nei movimenti islamisti e settari perché servissero a scatenare il caos: prima in funzione anti comunista, poi - dopo il golpe del 1965 e con l’avvento di Suharto - per controllare possibili ribelli.
Poi ancora - nella nuova e fragile stagione di una neonata democrazia - per poter di nuovo servirsi del caos e instillare l’idea che un ritorno della vecchia guardia al potere fosse la panacea: ordine, la stessa parola che aveva segnato la stagione del dittatore che l’aveva appunto chiamata Orde Baru, «ordine nuovo».
Dunque malavita, potentati economici legati al crony capitalism della famiglia Suharto, pezzi dei servizi militari deviati e riconducibili al periodo della dittatura. Questa società nascosta e segreta aveva e ha in odio la nuova stagione democratica. Se n’è fatta in parte una ragione ma rimpiange la belle epoque della dittatura.
Legami diretti tra la stagione stragista iniziata nel 2002 (e ripetutasi sino al 2009 con le bombe negli alberghi e poi ancora, solo qualche tempo fa, con un’esplosione davanti alla casa del sindaco di Bandung) non sono mai stati dimostrati ma a tratti i nomi di qualche businessman o di qualche agente o di qualche militare saltava fuori. Poi - complice una magistratura molto morbida - le sigle Al Qaeda e Jemaah Islamiyah coprivano tutto.
Se dietro ai fatti di ieri ci sia qualche burattinaio locale è presto per dirlo ma nel conto bisogna metterci anche questa ipotesi se non si vuole che il brand Daesh serva a insabbiare possibili piste dove si muovono i protagonisti di un’epoca che ancora non è passata. Anzi, proprio il nuovo segno della politica indonesiana, incarnata dall’outsider Joko Widodo, deve mettere in guardia.
È in quell’oscura trama di interessi che Daesh o chi per lui può trovare alleati. Ancor prima che tra qualche giovane dei sobborghi di Jakarta o di Bandung abbagliato dall’utopia jihadista di Al Bagdadi.
Il manifesto, 15 gennaio 2016,
Il progetto di costruire un nuovo partito della sinistra italiana procede faticosamente; da una parte, c’è un’attesa diffusa, che rischia di essere frustrata: dall’altra, le cronache politiche si soffermano sulle schermaglie tra i vari gruppi che dovrebbero dar vita al processo costituente. Un osservatore esterno, per quanto partecipe, non può che restare perplesso; e così pure le migliaia di potenziali aderenti. Beninteso, i problemi da risolvere sono obiettivamente tanti e complessi, ma non si può pensare di risolverli tutti e subito: un concreto avvio del processo costituente del partito (un partito, non una qualche altra vaga formula) appare urgente, se si vogliono incanalare e valorizzare energie e volontà.Tra le questioni da affrontare, ancora largamente irrisolta è quella della cultura politica del nuovo soggetto, ossia di quell’insieme di idee e di principi, schemi interpretativi e modelli valutativi, che costituiscano una cornice condivisa e riconoscibile, sia per chi che al partito aderisce, sia per coloro che ad esso possono guardare con interesse. Il richiamo alle ragioni della sinistra, per quanto necessario, non è sufficiente: che tipo di partito si vuole? Posto che un partito di mera testimonianza, per quanto nobile, oggi non ha alcuna potenzialità espansiva, quale potrebbe essere il profilo ideale, politico e programmatico, del nuovo soggetto?
Per cominciare ad abbozzare una risposta, forse è opportuno, anche in modo provocatorio, dare qualche modesto consiglio. Intanto, si lasci da parte la «carta dei valori»: la si scriva pure, se si vuole, ma sapendo che serve a poco. In genere, non la legge nessuno (qualcuno si ricorda la carta dei valori del Pd, faticosamente elaborata nel 2006–7?). Si può anche scrivere di riconoscersi nei valori della «libertà, dell’uguaglianza e della fraternità», o nel «valore del lavoro»… già, e poi? «Libertà» e «uguaglianza» sono parole terribili, che riempiono intere biblioteche, ma resta per intero il problema di capire in che modo, ad esempio, un ideale egualitario si possa tradurre in un determinato programma politico.
Un partito non è una creatura effimera se è in grado di proporre un proprio discorso pubblico, ossia un insieme di idee capaci di orientare e formare l’opinione pubblica, di farsi «senso comune», e di misurarsi efficacemente con altre idee. E il discorso pubblico di un partito si articola attraverso tre livelli, tra loro strettamente legati:
1 Il primo è quello che possiamo definire una «filosofia pubblica»: non un ideale, o un modello astratto della società futura, ma un insieme di idee e di schemi interpretativi sulla società presente, sui suoi conflitti, sui potenziali mutamenti. Un partito si radica e ha una funzione se riesce ad alimentare un dibattito politico e culturale che faccia emergere visioni alternative e diverse del «bene comune» o dell’«interesse generale», diversi sistemi di idee e di immagini della società e delle finalità del suo possibile sviluppo, a cui una comunità politica può ispirarsi.
2 Il secondo è quello che possiamo definire il «profilo programmatico», su grandi questioni e grandi aree di problemi: ad esempio, un’idea del welfare, dei suoi principi, di come concepire e orientare le sue finalità e la sua gestione.
3 Il terzo livello è quello delle «politiche», cioè delle specifiche proposte con cui si articolano una «filosofia pubblica» e un «programma».
Ebbene, il nuovo partito sarà in grado di dire qualcosa su ciascuno di questi livelli? Certo, è un compito di lunga lena, non si può essere troppo esigenti nell’immediato. E non bisogna cedere alla demagogia imperante della comunicazione facile: per rispondere adeguatamente occorrono studi, analisi, documenti anche ponderosi e faticosi. Occorre partire da un documento politico, articolato e ben strutturato, sulle cui singole tesi o formulazioni si possa discutere, nero su bianco, proporre modifiche, facendo anche emergere le differenze che certo si può facilmente prevedere esistano, ma che è bene circoscrivere dentro una cornice condivisa.
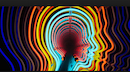 Ipotesi inquietante: se il malefico regista dell'ignominiosa caccia alla donna non fosse né islamista fanatico né razzista furbastro ma l'automatismo dei meccanismi cibernetici che ogni giorno usiamo?
Ipotesi inquietante: se il malefico regista dell'ignominiosa caccia alla donna non fosse né islamista fanatico né razzista furbastro ma l'automatismo dei meccanismi cibernetici che ogni giorno usiamo?
Il manifesto, 14 gennaio 2016
Sugli attacchi alle donne la notte di capodanno in diverse città della Germania c’è ancora molta luce da fare. C’è chi parla di una regia, di una strategia escogitata non si sa bene da chi, né a che scopo, tuttavia finora nessuna «mente» è stata identificata, né è chiaro come questa avrebbe agito, per coordinare un così grande numero di attacchi in parecchie città diverse e lontane.
Senza essere esperta sociologa, ritengo possibile che quel che è avvenuto sia uno esempio di «fenomeno emergente», un effetto imprevedibile sviluppato in modo pressoché autonomo, come diretta conseguenza delle condizioni date.
Come prima condizione vediamo un gran numero di persone frustrate da una qualità di vita decisamente scarsa, a volte pessima, in un paese in cui per contro, la maggior parte degli «altri» gode di un sistema che invece funziona bene (per gli altri), almeno apparentemente. La seconda componente del sistema è il fatto di trovarsi in grande numero tutti insieme contemporaneamente, nello stesso posto; dove questo non è fisicamente vero, la connessione via social network fa le veci della vicinanza. Allora un possibile supporre uno scenario in cui «semplicemente» sia avvenuta una prima aggressione, forse semplici insulti (certo, non sarebbe un bel gesto, ma nemmeno un fatto raro in occasioni di folle, magari tutti un po’ ubriachi o esaltati dal clima); supponiamo che uno dei protagonisti abbia postato su Fb o Twitter il fatto.
Tra chi ha ricevuto il messaggio, è certo possibile che qualcuno abbia «tratto ispirazione» ed emulato il fatto. Naturalmente, nel mondo social, è come non averlo fatto se non lo condividi, ed ecco che il giro si allarga, rimbalza, si carica, e quella che poteva essere una semplice bravata diventa sempre più grave e pesante fino ad arrivare a quella che oggi viene descritta come una violenza inaudita e organizzata contro le donne (tedesche?). In ambito scientifico c’è un filone di studio che si occupa proprio delle proprietà emergenti, e di forme «attive» di autorganizzazione, in cui per esempio anche semplici sfere in un fluido, possono acquisire comportamenti apparentemente organizzati (flussi di massa, spirali, fontane..) senza che nessun impulso esterno abbia fornito indicazioni, ma solo in presenza della alta concentrazione, e del fatto che vi sia dell’energia disponibile.
Questo avviene perché il comportamento di un elemento influenza ed è a sua volta influenzato da quello degli altri elementi intorno, un fenomeno che si sviluppa anche in forme viventi, come per esempio nel volo degli stormi di uccelli. Anche dal punto di vista teorico è possibile simulare le condizioni e produrre comportamenti emergenti, e addirittura è possibile creare <TB>«sciami di robot» che si autorganizzano, e si comportano in modo coordinato, anche senza che nessuna indicazione di comportamento venga imposta al sistema.
C’è da augurarsi che l’ipotesi sia sbagliata: è meno spaventosa l’idea che ci fosse sotto un disegno, perché in questo caso sapremmo (almeno in teoria) come affrontarlo. Ci sarebbe molto da temere invece di fronte ad un fenomeno che coinvolge così facilmente un così grande numero di persone, senza nessun controllo, e senza che vi sia modo di prevedere, e possibilmente prevenire lo svolgersi delle cose.
* Institute of Clinical Physiology – Cnr Pisa, Italia
 Cronaca semiseria d'una storia dell'Italia di oggi. Una sindaca con gran voglia di far bene, strattonata tra partiti di opposti populismi, la criminalità organizzata e i media ingordi di scandali.
Cronaca semiseria d'una storia dell'Italia di oggi. Una sindaca con gran voglia di far bene, strattonata tra partiti di opposti populismi, la criminalità organizzata e i media ingordi di scandali.
Il Fatto quotidiano, 14 gennaio 2016

Il manifesto, 14 gennaio 2016
Domenica si riunirà il Comitato Nazionale dell’Altra Europa per Tsipras , l’organismo — un centinaio di persone — eletto ormai parecchio tempo fa, quando si decise di rendere stabile la rete dei comitati che aveva partecipato alla campagna elettorale europea del maggio 2014. Sarà il primo incontro dopo la così detta rottura del famoso tavolo incaricato di negoziare come far partire il processo di costituzione di un nuovo soggetto della sinistra, un passaggio dunque importante per tutti quelli che ancora insistono nel puntare a questo obiettivo.
Dico “così detta” rottura, perché una percezione così drammatica di quanto è accaduto quel giorno io francamente non la condivido. Sebbene speri in una sua ulteriore riflessione, ho compreso la posizione espressa con molta onestà da Paolo Ferrero quando ha dichiarato l’indisponibilità del suo partito anche solo di ipotizzare il proprio scioglimento, perché Rifondazione è un partito molto strutturato e identitariamente determinato. E ho pensato che per ora occorresse prenderne atto, indicando subito, però, come stabilire un’intesa per continuare a collaborare.
Il processo costituente del resto non è chiuso, è appena aperto, e se funzionerà gli innesti potranno (e dovranno) essere ancora molti.
Ho capito meno le reazioni che ho visto espresse on line da molti dell’Altra Europa, perché non vedo francamente in cosa consista il colpo di stato che sarebbe stato operato da chi ha deciso di procedere con chi sia d’accordo nell’avviare un processo — che tutti sappiamo lungo e per niente garantito — al termine del quale, e solo allora, nascerà — forse — un soggetto unitario. Non un’alleanza elettorale, e dunque non fondata soltanto sulla cessione di ciascuna componente della sovranità in questa peraltro quantomai scivolosa materia: questa l’abbiamo già sperimentata e non è stata mai brillante.
Fino a quando non si rimescolano le carte — e cioè non ci si mischia anche umanamente nelle stesse sedi; non si creano nuove amicizie e nuove solidarietà; non si discute assieme senza la paura che un’ipotesi o l’altra privilegi questo o quello; non ci si senta solidali anziché pronti all’accusa reciproca; non ci si impegni a capire le ragioni dell’altro, che non vanno solo rispettate ma anche usate come risorsa critica per se stessi — non si andrà da nessuna parte. Per questo la formula “arcobaleno” non va bene: significa immobilizzare le diversità anziché farle vivere come positivo innesco.
Ho detto che quanto si discute importa a chi ancora insiste nel puntare all’obiettivo del nuovo soggetto, perché mi rendo conto che siamo sempre meno a sperarci e io che sono piuttosto attempata comincio a sentirmi persino un po’ ridicola. Gli amici e compagni — tanti — che so che potrebbero esser coinvolti nell’avventura cominciano a guardarmi come personaggio un po’ patetico. Il linguaggio del dibattito che si è sviluppato on line è di per sé sufficiente a farsi passare la voglia: grondante di sospetti; a prendere qualsiasi perplessità — pur comprensibile — da parte di chi ha passato anni impegnato in questa o quella amministrazione locale come mero desiderio di mantenere uno sgabello; qualsiasi impazienza per intenzione di tagliar fuori questo o quello; un’intervista di Fassina per indebito protagonismo (che qualcuno esca dal comodo Pd per unirsi alla nostra, per ora almeno, armata brancaleone, non c’è tutti i giorni, non vi pare?); e così via. Ce l’ho anche con chi, a una come me e a tanti compagni anche parecchio più giovani di me, dice che siamo compromessi col ‘900: certo che lo siamo, perché lo abbiamo vissuto pienamente senza tirarci indietro. Ogni generazione ha evidentemente il diritto di ricominciare daccapo: ma lasciamo a Renzi (e a Berlusconi) giudicare quel secolo come fosse stato solo immondizia, gli serve a cancellare tutte le cose che bene o male, e in mezzo a tanti errori, si sono pur conquistate.
Io capisco i timori di molti compagni di comitati locali per la possibilità che le organizzazioni nazionalmente strutturate e persino dotate di una rappresentanza parlamentare possano prevaricare le altre. Ma, suvvia, avete paura della “corazzata” Sel? (Magari fosse una nave un po’ più solida!). Se si sentisse tanto autosufficiente non si sarebbe resa disponibile a sciogliersi, tanto più che c’è — ancora, per fortuna — aspettativa in una parte del popolo di sinistra per uno nuovo corso, un’area che non si esaurisce con chi stava a quel famoso tavolo e cui Sel potrebbe guardare. Credo che se Sel insiste nel rapporto in particolare con l’Altra Europa sia per il desiderio di non perdere una esperienza e una cultura — quella che è stata chiamata “generazione di Genova” — che è propria invece ai comitati o reti che a quel tavolo avevano fatto capo.
Sia pure quantitativamente non decisivi, quelle forze sono importanti per caratterizzare il nuovo soggetto che intendiamo costruire; ed è perciò che l’apporto dell’ “Altra Europa” è importante. Ma non si può neppure pensare che questa area rappresenti tutta la forza potenzialmente aggregabile. Se tergiversa troppo, rischia di ignorare pericolosamente l’importanza dei tempi politici: siamo alla vigilia di una battaglia referendaria decisiva, di scadenze di lotta sui temi del lavoro e a urgenze di iniziativa internazionale che non consentono tempi biblici.
Credo sia il momento di avere il coraggio di provare. Cosa sarà il nuovo soggetto della sinistra dipenderà da chi nel corso del processo ne conquisterà l’egemonia (non il controllo, fido che tutti abbiano letto Gramsci) . Perché di una egemonia c’è bisogno, perché se non riusciamo ad esprimere una leadership, resteremo sempre paralizzati.
La costruzione di un gruppo dirigente è stata per qualsiasi forza che ambisca a cambiare il mondo uno dei processi più delicati e importanti, non è una “bestemmia novecentesca”. E’ indispensabile se si vuole un soggetto deliberante e capace di un pensiero lungo, non solo un aggregato che testimonia confuso malessere. (Il 99% contro l’1% può sembrare una bella formula ma non è un caso che quel 99 non vinca mai: perché è facilissimo unirsi sulla protesta, difficilissimo sulle proposte).
Non si evitano i rischi di prevaricazione, di autoreferenzialità, di arrogante pretesa di essere il solo soggetto della politica (questo il difetto maggiore del vecchio Pci), di separatezza, in cui sono caduti vittime anche i migliori partiti , evitando di porsi questo problema. (Pensate al leaderismo estremo di tutte le formazioni che si sono volute informali, dal Partito radiale, a Cinque stelle in poi). Si evitano se si riescono a costruire, assieme al partito (io lo chiamo così, ma anche questo è un tema da discutere), forme nuove, stabili e partecipate di democrazia organizzata, che investano il partito e lo costringano a ridefinirsi in rapporto alle nuove soggettività che crescono nella società.
Ad impedire ogni separazione interna fra vertice e base serve poi ben più che un insieme di regolette lo sforzo di ridurre al minimo la distanza fra dirigenti e diretti, che vuol dire anche trovare i modi di una crescita collettiva che non separi chi sa (o pretende di sapere) da chi davvero non sa. L’arbitrio ha sempre origine da qui.
E allora: possiamo farcela? Potremmo se nessuno si ritrae con paura ma se tutti si sentono abbastanza forti da contribuire a fare questa cosa che vogliamo fare. Come sarà è esito ancora piuttosto aperto. Ed è naturale che sia così. Perché la difficoltà dell’operazione non sta nella malafede di questo o di quello, ma negli stravolgimenti che hanno colpito il mondo e che ci costringono a ripensare tutto. Uno spaesamento di fronte al quale purtroppo nessuno è riuscito a trovare strategie vincenti.
Ci sono fasi della storia così, e noi siamo nel pieno di una di queste fasi. E’ una constatazione che rischia di diventare paralizzante, e infatti è qui la radice di tanti abbandoni. Credo sia necessario impegnarsi ugualmente perché c’è speranza di trovare una via se ci parliamo, con la pazienza di ascoltarci reciprocamente, non se restiamo ciascuno a casa propria.
 «Il problema è l’altissimo livello di tolleranza che atti di questo genere suscitano» replica Flinkman. «Ma non direi culturale nel senso di arabo: semmai nel senso di maschile. In Germania, come a Piazza Tahrir, nessuno è intervenuto. È questa accettazione a essere gravissima».
«Il problema è l’altissimo livello di tolleranza che atti di questo genere suscitano» replica Flinkman. «Ma non direi culturale nel senso di arabo: semmai nel senso di maschile. In Germania, come a Piazza Tahrir, nessuno è intervenuto. È questa accettazione a essere gravissima».
La Repubblica, 12 gennaio 2016 (m.p.r.)
«Un cancro: le molestie sessuali hanno un meccanismo simile a quello di cellule cancerogene che si aggregano. A scatenare la malattia intervengono fattori diversi ma il risultato è il medesimo: la molestia come tumore sociale, che se non viene fermato in tempo continua a propagarsi. Perché è bene dirlo subito: sbaglia chi pensa che quello che è accaduto a Colonia sia importato, appartenga al solo mondo arabo, un’epidemia importata. È un male che ha radici profonde: e molto complesse».
Non è un caso che Shereen El Feki usi termini medici. L’autrice anglo-egiziana di un saggio molto importante sulla sessualità nel mondo arabo intitolato Sex and the Citadel: Intimate Life in a Changing Arab World (Sesso e la cittadella: la vita intima nel mondo arabo che cambia), è un’immunologa che dopo essersi occupata di Aids ha focalizzato la sua attenzione sul rapporto che il mondo arabo ha con il sesso e ora sta lavorando a un progetto finanziato dalle Nazioni Unite per capire meglio la galassia maschile giovanile in 4 paesi arabi, Egitto, Marocco, Libano e Palestina.
L'opinione di un intelligente politologo sul caso dell'inquinamento in un comune amministrato da una sindaca del M5S, e sul suo presunto significato generale. La Repubblica, 14 gennaio 2015, con postilla
Come ricordava Ilvo Diamanti su queste colonne, il M5S assumerà sempre più nettamente i contorni di un partito. È per questo, per questa sua inevitabile trasformazione, che difficilmente potrà mantenere la quota di consensi ottenuta finora. Perché sarà obbligato a strutturarsi più “tradizionalmente”, e perché dovrà definire meglio le sue proposte politiche. Fin qui il partito di Grillo e Casaleggio non ha dovuto fare scelte. Ha navigato sull’onda dell’”antipolitica”, e cioè della insofferenza, indistinta quanto feroce, per tutto quello che non va bene, e che viene imputato alla classe politica, all’establishment, agli “altri”. Nemmeno la rivoluzione renziana ha contenuto questa ondata. Il desiderio di cambiamento palingenetico invocato dai sostenitori grillini non si accontentava di un passaggio generazionale che poggia su radici antiche. Anche Matteo Renzi, ai loro occhi, rappresenta “il vecchio”.
Ma il consenso che è piovuto sul M5S è amorfo, indistinto, negativo: non dà indicazioni su dove andare. Non che il M5S sia composto di acchiappanuvole. Al contrario, grazie anche alla formazione tecnico-scientifica di molti suoi eletti, esprime un tasso di pragmatismo notevole, in linea con gli obiettivi originari dei cinquestelle, dall’energia pulita alla libera fruizione della Rete, dalla difesa dell’ambiente allo sviluppo ecosostenibile. Però, sbandierando quegli obiettivi, Grillo sarebbe rimasto confinato in una dimensione da partito verde. Il suo successo l’ha costruito sulla rabbia antipolitica. Con un consenso trasversale e indifferenziato. Ora che il partito è cresciuto, deve intervenire su un ampio ventaglio di questioni e questo, inevitabilmente, creerà sacche di scontenti. In effetti il successo dei M5S si regge (ancora per poco) su una doppia ambiguità di fondo: essere un non-partito diverso dagli altri e non schierarsi né a destra né a sinistra. La prima ambiguità sta arrivando al redde rationem e il caso di Quarto è solo uno dei segnali che obbligano i grillini a “istituzionalizzarsi”, cioè ad adottare regole e modalità di funzionamento interno più formalizzate, e a definire compiti e funzioni più precisi: in tal modo il partito si irrigidisce e nascono delle gerarchie. La seconda ambiguità è più sottile ma anch’essa sta per arrivare a scadenza. Come suggeriscono le biografie degli eletti e lo stesso programma del partito, il M5S è fortemente sbilanciato a sinistra (una inclinazione appena compensata da tirate anti-euro e anti-tasse). La polemica contro tutto il sistema dei partiti nasconde la vera posta in gioco: la competizione con il Pd per sottrargli quella parte di sostenitori perplessi che farebbero la differenza in un ballottaggio. Non per nulla, su alcuni temi — reddito di cittadinanza e diritti civili — il M5S lo scavalca a sinistra. Urla e sbraita contro i democratici, e recalcitra ad accordarsi anche quando ci sono evidenti sintonie; e questo per marcare le distanze. Lo scontro con il Pd è destinato a spostarsi da una dinamica antipolitica ad una squisitamente politica. Questo passaggio, che potremmo considerare virtuoso perché normalizza e stabilizza il sistema, non sarà indolore per il M5S perché parte dei moderati affluiti sotto le sue insegne se ne andrà. La necessità di mutare pelle sul piano organizzativo e di adottare un profilo politico più preciso porta con sé una riduzione della sua base elettorale. Il M5S è quindi arrivato oggi all’apice delle sue fortune. Così com’è configurato non può andare oltre.
postilla
Si può convenire sul fatto che la forma di democrazia adottata dal movimento di Beppe Grillo abbia più difetti che pregi, e che quindi debba essere modificata se i suoi membri ne vogliono conservare, e anzi aumentare, l'attuale consenso. Ma non è detto che l'unica alternativa per costruire "partiti", cioè formazioni espressive di una parte della società determinati a concorrere alla politica nazionale debba essere quella di assumere la forma e le regole di quelli nati, vissuti (e morti) nei due secoli scorsi, nè tanto meno a quelli esistenti
 La cronaca di Fazila Mat, i commenti di Marco Ansaldo, Fabio Mini e Andrea Tarquini, l'intervista di Andrea Bonanni a Federica Mogherini.
La cronaca di Fazila Mat, i commenti di Marco Ansaldo, Fabio Mini e Andrea Tarquini, l'intervista di Andrea Bonanni a Federica Mogherini.
Il manifesto, la Repubblicail Fatto quotidiano, 13 dicembre 2016
Il Manifesto
«ATTACCO ISISt» A SULTANAHMET
di Fazila Mat
Turchia. Esplosione nel cuore turistico e commerciale della città turca tra Santa Sofia e la Moschea Blu. Dieci le vittime, otto sono turisti tedeschi. Per il governo è stato lo Stato Islamico
Un nuovo attentato, questa volta a Istanbul, nel cuore economico e commerciale del paese. Dopo gli attacchi kamikaze di Suruç del luglio scorso (33 vittime) e di Ankara a ottobre (con oltre 100 morti)il governo turco guidato dal premier Ahmet Davutoglu (e di fatto dal presidente Recep Tayyip Erdogan) deve affrontare il terzo attacco attribuito — dalle stesse autorità — allo Stato islamico (Isis). Una diretta conseguenza, secondo gli oppositori dell’esecutivo, della politica estera condotta da Ankara, e principalmente in Siria.
Le vittime dell’esplosione avvenuta ieri mattina alle ore 10.20 locali, sono «tutti cittadini stranieri», così come confermato nel tardo pomeriggio di ieri Davutoglu ai giornalisti. Si contano anche 15 feriti (tutti stranieri) due dei quali sarebbero in gravi condizioni. L’attentatore, sempre secondo le affermazioni del premier, sarebbe un cittadino saudita - una novità questa rispetto ai precedenti attentati - di 28 anni, giunto in Turchia dalla Siria. Si è fatto esplodere a Sultanahmet, quartiere in cui sono concentrati i principali monumenti storici della città come Santa Sofia o la Moschea Blu e per questo sempre meta privilegiata dei turisti.
La deflagrazione è avvenuta all’Ippodromo romano, nei pressi dell’obelisco egiziano (di Teodosio), mentre stava passando una comitiva di cittadini tedeschi. Nove, tra le vittime, sono infatti tedeschi, il decimo, un cittadino peruviano. Un’ora dopo l’esplosione, così forte da essere stata sentita anche in quartieri sull’altra sponda del Corno d’oro, il Consiglio superiore per la radio e la televisione (Rtuk, organo governativo) ha emanato un divieto temporaneo sulla «diffusione delle immagini del luogo del delitto e dei corpi, sia in diretta che dopo», sollevando non poche critiche, soprattutto nei social media.
«Vi abbiamo esortato più volte a non trascinare la Turchia nella palude del Medioriente» è stata la reazione del leader Chp (Partito repubblicano del popolo, principale formazione d’opposizione) Kemal Kilicdaroglu che ha attaccato il governo accusandolo di essere «incapace di gestire questo paese». Come di consueto, più interventista la reazione del leader del Partito di azione nazionalista (Mhp, i lupi grigi) Devlet Bahceli che invitato Ankara a «reagire pesantemente l’atto sanguinoso» punendo «i mandanti, gli esecutori e i collaborazionisti che operano contro l’umanità e che si annidano nelle case-celle (così chiamate le case dove i membri dell’Isis abiterebbero in gruppi di 12, nda)». Un’altra condanna è arrivata da Selahttin Demirtas, co-leader del Partito filo-curdo democrtico dei popoli (Hdp). «Vogliamo che sappiate che lotteremo fino all’ultimo respiro finché i responsabili non verranno resi noti», ha detto Demirtas.
Per diversi mesi il governo di Ankara è stato accusato da più fronti di appoggiare logisticamente i gruppi d’opposizione - al Nusra e Isis compresi - in lotta in Siria contro il regime di Bashar al Assad. Le accuse sono proseguite anche dopo che nel luglio scorso la Turchia ha preso apertamente parte nella coalizione anti-Isis guidata dagli Usa e dopo una serie di arresti effettuati contro presunti membri dell’Isis in Turchia. Date poi le continue rimostranze degli Stati occidentali - Ankara ha messo in atto un maggiore controllo alle proprie frontiere sudorientali – definite dalle autorità troppo estese per essere interamente controllate - per impedire che i jihadisti potessero transitarvi con agio, come invece denunciato da diversi media.
Ma la lotta del governo turco contro l’Isis è sempre proseguita parallelamente alle operazioni effettuate contro due altre organizzazioni considerate terroristiche da parte di Ankara: il Pkk (Partito dei lavoratori del Kurdistan) e il Dhkp-C (Fronte rivoluzionario per la liberazione del popolo), con un bilancio finale di detenzioni a carico dell’Isis, in netta minoranza. Questo atteggiamento che mette sullo stesso piano «tutte le organizzazioni terroristiche» ha fatto sì che i precedenti attentati, ma soprattutto quello di Ankara, fossero attribuiti dall’esecutivo turco ad un «cocktail terroristico», sebbene sia stato accertato dlla polizia che gli esecutori fossero membri di cellule turche dell’Isis.
Anche la dichiarazione rilasciata ieri dal premier Davutoglu segnala il rischio di ripetere la stessa linea. «Da qualunque parte provenga e qualunque motivo si adduca chi fa terrorismo compie un reato contro l’umanità. La Turchia ha dimostrato un atteggiamento aperto e di principio contro tutte le organizzazioni terroristiche, che sia il Pkk o l’Isis…», ha detto Davutoglu.
Ma se la lotta del governo turco contro il Pkk, ripresa a tutto campo dallo scorso luglio non lascia ombra di dubbio, considerati anche i coprifuochi che interessano il Sudest del Paese da diverse settimane e le costanti perdite di vite umane, non risulta ancora chiaro quale sarà la strategia che Ankara intende adottare per impedire che l’Isis preda piede in Turchia e minacci nuovi attentati.
La Repubblica
ISTAMBUL COLPITA AL CUORE.
UN KAMIKAZE FA STRAGE.
UCCISI DIECI TURISTI OTTO ERANO TEDESCHI
di Marco Ansaldo
Ora, nella notte, c’è solo silenzio. E poliziotti al lavoro in tuta bianca e copriscarpe azzurri per rilievi che compiono chinandosi a terra, misurando distanze, parlandosi sottovoce dopo che anche il corpo dell’ultimo turista tedesco è stato rimosso. Ma a Piazza Sultanahmet, nel quadrilatero che i viaggiatori di ogni parte del mondo conoscono, fra la Moschea blu, la basilica di Santa Sofia, il Topkapi e la Cisterna, i jihadisti hanno lasciato per terra una macchia scura. Nessuno riesce a lavarla. Colpendo al cuore l’unica città al mondo che si estende su due continenti, cerniera fra Asia e Europa, hanno voluto spezzare l’ultimo lembo di dialogo che adesso sarà difficile ricostruire.
Come sempre Tayyip Erdogan, l’uomo forte della Turchia, voce tonante e ciglio asciutto, lancia accuse all’esterno. L’altro ieri lo faceva contro i militari, contro i curdi, poi gli alleati islamisti, la finanza mondiale e i media internazionali. Oggi allunga la lista al terrorismo e agli “intellettuali stupidi”. Ma per molti osservatori indipendenti è proprio l’ambiguità mostrata dal suo governo con il Califfato nero, durata quasi tre anni e giocata sul filo di un’acquiescenza criticata da molti, a essere considerata come la causa reale dell’attentato nel centro di Istanbul. Dove l’accordo raggiunto con Angela Merkel e con un’Europa convinta infine a concedere all’alleato turco tre miliardi euro in cambio della lotta al terrorismo e dell’aiuto nel controllare frontiere sempre più porose per lo sbarco di profughi e per l’attraversamento di terroristi, non ha salvato i turisti tedeschi. Solo lo scorso anno sono stati 5 milioni e mezzo dalla Germania. Il prevedibile crollo del turismo, adesso, e le difficoltà dell’economia turca faranno riconsiderare a molti l’affidabilità del loro Presidente.
Tutti i 10 morti sono stranieri e ben 8 quelli tedeschi saltati in aria con l’attentatore, un kamikaze saudita di origine siriana che il premier Ahmet Davutoglu ha spiegato essersi arruolato nel cosiddetto Califfato islamico (secondo alcune fonti, si sarebbe registrato come rifugiato). Alle 10,20 ora locale (le 9,20 in Italia), Piazza Sultanahmet per fortuna non era zeppa di turisti come d’estate. Il freddo incombente in questa stagione in Turchia ha contribuito a tenere molti visitatori lontani. Gruppi di autobus stazionavano comunque davanti alla Moschea blu. Ed è qui, nel piazzale antistante, colmo di giardini fioriti e di fontane, nei pressi dell’obelisco di Teodosio, che l’attentatore si è fatto esplodere.
Una deflagrazione tanto potente da essere percepita fino nella parte asiatica. «La terra ha tremato e c’era un odore pesante che mi ha bruciato le narici», haraccontato una turista tedesca. «Abbiamo sentito un boato fortissimo - dice Turgut, il portiere di uno degli alberghi nella zona, tantissimi ormai e quasi sempre di ottimo livello visto il copioso giro di affari - ma dobbiamo avere paura qui: sia per il nostro lavoro, perché le gente ha subito disdetto molte prenotazioni; sia per la Turchia, ora al centro di giochi che passano sopra le teste di noi cittadini». A guardarli bene negli occhi, i turchi oggi hanno volti affranti: visi impauriti, e pensieri che si immaginano incapaci di immaginare un futuro di pace, stretti come sono fra la minaccia terrorista, la guerra curda riscoppiata in Anatolia, le tensioni con la Russia, e un braccio di ferro irrisolto con l’Europa.
Passa una manciata di ore, e Erdogan compare alla tv. Ne ha per tutti. «La Turchia continuerà a lottare sino a quando le organizzazioni terroristiche non saranno totalmente annientate. Il problema oggi è il terrorismo, non la questione curda. Dobbiamo dirlo al mondo. Sono stupidi gli intellettuali che imputano al governo di aver compiuto qualche tipo di strage. Il governo conosce come il palmo delle sue mani il Sud-Est dell’Anatolia, mentre loro non lo conoscono e non sanno neppure il nome delle strade». Sotto tiro gli intellettuali, gli scrittori, gli accademici, come il sociologo americano Noam Chomsky: tutti colpevoli di criticare l’operato del governo: «Queste persone devono scegliere se stare dalla mia parte o dalla parte dei terroristi». E poi accuse a Russia e Mosca, «che vogliono espandere la loro area di influenza in Siria».
Metà Turchia applaude Erdogan. Lo dimostrano le elezioni stravinte lo scorso novembre, quando ne è uscito premiato con oltre il 49 per cento dei voti, perché considerato l’uomo della stabilità. L’altra metà letteralmente lo odia, giudicando come irresponsabile il suo obiettivo di polarizzare il Paese, mettendo in un angolo avversari politici, magistratura e media, licenziando e facendo arrestare i giornalisti per i loro scoop antigovernativi. In serata la sua polizia scate- na la caccia ai terroristi, e arresta nella capitale Ankara 16 sospetti jihadisti.
Ma questo è un Paese che vive ormai nella paura del terrorismo, alla media di un attacco ogni due mesi. A giugno a Diyarbakir 6 morti, poi a Suruc i 32 giovani che volevano ricostruire la biblioteca della città siriana di Kobane, quindi il 10 ottobre le 102 vittime curde ad Ankara poco prima delle elezioni. Ora l’attacco più duro per l’immagine del Paese. Con un governo che sull’esplosione di Piazza Sultanahmet impone il silenzio stampa, vietando, decreta il tribunale di Istanbul, «tutti i tipi di notizie, interviste, critiche e pubblicazioni simili sulla carta stampata, le televisioni, i social media e tutti gli altri tipi di mezzi di informazione su Internet».
Il Fatto Quotidiano
ERDOGAN HA VOLUTO STRAPPARE
LA CERNIERA TRA EUROPA E ORIENTE
di Fabio Mini
È strabiliante vedere con quanta sicurezza i leader turchi abbiano subito individuato autori materiali e mandanti dell’attentato a Istanbul. Sulle vittime si sapeva ancora quasi nulla e già i vertici politici, della polizia e dei servizi segreti davano nomi e cognomi: erano siriani dell’Isis che, nel lessico politico turco, significa amici del regime di Assad o curdi comunisti del Pkk o tutti e due. La stessa certezza era stata manifestata giorni fa dalle informative inviate dai servizi turchi ai colleghi europei sulla minaccia di attacchi terroristici in Europa. I potenziali autori si trovavano ancora in Siria ma il loro progetto e i loro nomi erano già nelle schede segnaletiche delle polizie europee.
Questa formidabile efficienza dovrebbe essere una rassicurante dimostrazione di forza e coerenza della Turchia e dei suoi alleati, ma non riesce a fugare i sospetti e le ambiguità che ormai costituiscono il terreno di coltura di tutti i “batteri” turchi e mediorientali. La Turchia così maschia e determinata è in realtà una complessa entità ambigua e ambivalente. Da sempre. La Turchia moderna occupa i territori che furono colonie iranico-scite e greche, che furono provincie e clientes di Roma. Il nome Ponto originariamente significava “sentiero” lungo la costa del Mar Nero e nel tempo passò da “sentiero inospitale” a “sentiero ospitale” (Ponto Eusino). Tanto per restare nell’ambiguità. È il limite della migrazione pontica delle orde turco-mongole che convivevano nella Siberia del lago Baikal e si confederarono sotto Gengiz Khan.
La Turchia è l’erede dell’impero Ottomano che rivendicò per sé la funzione di Califfato o difensore di tutti gli islamici nel 1517. Il califfato turco durò fino al 1924, ben 6 anni dopo la fine della Prima guerra mondiale e la caduta dell’impero, quando Kemal Ataturk (generale ottomano) diventato presidente della repubblica turca indisse un congresso che ne decise l’abolizione. La Turchia moderna ha bandito molti costumi del sultanato, ma non ha mai ripudiato l’ascendenza imperiale e soprattutto non ha mai ammesso le responsabilità ottomane negli eccidi e nelle pulizie etniche ai danni dei popoli sottomessi tra cui armeni e greci del Ponto.
Questa Turchia ambigua e reticente avrebbe dovuto essere il ponte tra Europa e Asia: non ci credevano davvero né i turchi né gli europei. La Turchia ha preferito pensare ai propri affari diretti dal panturchismo e la sua funzione di raccordo è sempre nella nebbia. Doveva essere l’interlocutore privilegiato e il massimo mediatore tra cultura occidentale e cultura islamica: tra giochi di potere e giochi di convenienza è riuscita a inasprire le differenze facendo dimenticare le affinità.
Per un certo periodo si è creduto che la Turchia dei generali potesse diventare il ponte tra mondo islamico e Israele: ci fu un’alleanza tutt’altro che chiara tra due regimi che avevano in comune solo il forte militarismo e la predilezione per le soluzioni armate. L’ambiguità fu comunque peggiorata con la deriva islamista del regime di Erdogan che staccò di nuovo i due ambiti politici, ma non quelli commerciali. Doveva essere la sponda asiatica della Nato a guardia del blocco occidentale: si è persa nelle pastoie delle diatribe territoriali e ideologiche con la Grecia mettendo più volte in crisi tutta l’alleanza. Doveva essere il ponte tra curdi e iracheni, iraniani e siriani: con il paravento dell’appoggio al Kurdistan iracheno ha tentato la carta della divisione di tutti i curdi, che oggi o fanno affari con la Turchia o la odiano. E perciò sono “terroristi”. Doveva essere il faro laico di un nuovo approccio alla società islamica: è divenuta sempre più fondamentalista e nazionalista. Doveva essere alleata della Russia e dell’Iran per un nuovo assetto mediorientale e una nuova stagione di rapporti internazionali tra Usa, Europa e Mondo orientale: oggi è vista come un pericolo da tutti i principali interlocutori. Doveva essere un baluardo a salvaguardia della protezione dei rifugiati e della sicurezza europea: ha usato l’emigrazione come valvola di scarico a favore e contro la stessa Europa. Quasi sempre contro e solo dietro pagamento di miliardi sonanti “a favore”.
Dietro la maschera della sicurezza, la Turchia continua a essere un bastione dell’ambiguità. Non sa neppure quale sia il suo destino o il suo nemico. Nessuno può mettere la mano sul fuoco in merito alle sue affermazioni, nessuno può dire chi stia manovrando i terroristi in Turchia e fuori. Nessuno può dire a cosa tendano le informazioni turche condivise col contagocce. Nessuno si può fidare dell’ambiguità e ancor meno dell’arroganza delle affermazioni. L’ambiguità può anche essere una necessità politica, e ne sappiamo qualcosa noi, ma l’arroganza e la sicumera sono vere pazzie. E ne sappiamo qualcosa noi.
LA GERMANIA: NOI NEL MIRINO
di Andrea Tarquini
Colonia. Angela Merkel non ha perso un istante: ha parlato subito ai tedeschi scossi dai loro morti a Sultanahmet. «Almeno otto sono i nostri concittadini assassinati, forse il bilancio aumenterà; il terrorismo ha di nuovo mostrato il suo volto più brutale e crudele, il nostro lutto è solidale col lutto della Turchia, sono vicina al suo popolo», ha detto la cancelliera, pallida in volto in tv. Germania nel mirino, ancora una volta un amaro risveglio. E parole scelte non a caso, a indicare una partnership strategica con Ankara che non vuol lasciarsi intimidire.
Otto cittadini federali uccisi, almeno altri nove feriti di cui alcuni in gravi condizioni. Lo shock è enorme. «I terroristi sono i nemici dell’umanità intera, che colpiscano in Francia o in Germania, in Siria o in Turchia: il loro bersaglio è la nostra vita libera, di liberi cittadini di democrazie moderne», ha aggiunto la cancelliera, «li combatteremo con tutta la determinazione necessaria». Tutto il giorno è stata in contatto telefonico col premier Davutoglu e col presidente Erdogan, poi ha convocato una riunione d’emergenza del governo, in teleconferenza con l’esecutivo di Ankara. «Siamo vicini al popolo turco, spesso vittima dei terroristi». «È una guerra»: ha detto il premier francese, Manuel Valls. «Sono minacce che conosciamo».
«Non ci lasceremo intimidire », ha incalzato il ministro degli Esteri, Frank-Walter Steinmeier. Gli appelli alla fermezza indicano che la Germania sa benissimo di essere un bersaglio preferito, speciale, nella strategia del Daesh. «Quelli», dicono fonti dell’esecutivo, «hanno nel mirino la strategia di Berlino. E cioè la strategia di mano tesa a tutti i costi verso la Turchia, l’obiettivo tedesco di agganciare sempre più Ankara all’Europa, nella lotta al terrore come nell’economia, nella geopolitica, nella ricerca di interessi comuni».
Credito per tre miliardi, incontri al vertice frequentissimi, passi a Bruxelles con la Commissione europea per la marcia di Ankara verso l’associazione alla Ue. Tutto nella politica tedesca verso la Turchia, anche negli ultimi mesi, anche dopo svolte autoritarie, ha un obiettivo chiaro: rendere ancor più saldi i legami con l’alleato, fa notare un diplomatico occidentale. Con tre milioni di turchi ormai minoranza etnica in casa, rapporti economici in decollo, e l’uso indispensabile alla Luftwaffe della base di Incirlik per i Tornado da ricognizione che indicano ai jet francesi, americani e russi i siti del Califfato da bombardare e per gli Airbus-cisterna con la croce nera che riforniscono in volo i Rafale decollati della Charles de Gaulle, Berlino è insieme amico-chiave di Ankara in Europa e belligerante nella coalizione antiterrorismo. E ne paga le spese.
“CORSA CONTRO IL TEMPO PER FERMARE IL TERRORE L'IS STA REAGENDO ALL'ASSEDIO DEL MONDO”
intervista di Andrea Bonanni a Federica Mogherini
Bruxelles. Le bombe a Istanbul, le stragi in Libia, le violenze contro le donne a Colonia, l’attentato al premier libico designato che lei aveva appena incontrato a Tunisi cronaca degli ultimi giorni e delle ultime ore: permetta una domanda personale, signora Mogherini, ma non le capita mai di sentirsi in guerra?
Federica Mogherini, l’Alto rappresentante per la Politica estera e la sicurezza europea, ci pensa un attimo. «No. L’unica guerra che mi sento addosso, ed è drammatica, è la guerra contro il tempo. I fatti che lei ha citato dimostrano che c’è un’accelerazione e un’estensione anche geografica di alcune tendenze già emerse l’anno scorso. Un’accelerazione che diventa tanto più rapida quanto più, in Libia come in Siria, si intravvedono possibilità di soluzione. E noi non possiamo permetterci di perdere questa battaglia contro il tempo per fermare questa valanga di follia che incombe».
La strage di tedeschi a Istanbul lascia pensare che la valanga sta ormai estendendosi anche alla Turchia?
«Non è la prima volta che la Turchia subisce un attentato. Sappiamo da mesi di avere un interesse comune nel contrastare e sconfiggere Daesh. Per questo abbiamo rafforzato la nostra collaborazione nell’antiterrorismo con la Turchia e con altri Paesi della Regione».
In Libia e in Siria la diplomazia stanno facendo progressi. Ma anche Daesh è all’offensiva. Chi la spunterà?
«Non sono un’indovina. Quello che cerchiamo di fare non è tanto prevedere ma determinare il corso degli eventi. Ma la mia percezione è che si siano messi in moto meccanismi impensabili anche solo un anno fa e che finiranno per indebolire Daesh dovunque si trovi. E questo naturalmente provoca reazioni».
Quali meccanismi?
«Intanto per la Libia e per la Siria si è aperto un canale di consultazione permanente tra Europa, Stati Uniti e Russia che ha portato anche alle risoluzioni votate all’unanimità dall’Onu. Sulla Siria abbiamo un coordinamento che comprende tra gli altri Turchia, Egitto, Arabia Saudita e Iran: anche questo sembrava un traguardo impossibile prima dell’accordo sul nucleare iraniano che abbiamo negoziato l’anno scorso. Il 25 gennaio si terrà il primo incontro negoziale tra il regime siriano e le opposizioni. Tra pochi giorni si dovrebbe insediare il primo governo di unità nazionale libico. Il cerchio politico si sta stringendo attorno a Daesh».
È prevedibile un intervento militare europeo in Libia?
«Se c’è una lezione che abbiamo imparato è che queste crisi non si risolvono dall’esterno. Devono essere i libici a indicare le soluzioni. Non credo che il nuovo governo di unità libico chiederà un intervento militare dell’Occidente. Credo invece che domanderà il nostro sostegno in una serie di settori, che vanno dagli aiuti umanitari, alla ricostruzione, alla creazione di un nuovo esercito e di nuove forze di polizia, al loro addestramento e al loro sostegno logistico per far fronte alla minaccia terrorista. E su questo la Ue e i suoi stati membri, con l’Italia in prima fila, sono da tempo pronti a fornire tutto l’aiuto necessario. Un intervento militare esterno darebbe solo argomenti alla propaganda di Daesh».
A complicare i suoi compiti ci si è messa anche la nuova tensione tra Iran e Arabia Saudita, che minaccia di riacutizzare il conflitto tra sciiti e sunniti...
«Dai miei colloqui con Iran e Arabia Saudita, e altri partner del mondo islamico, ho avuto assicurazioni che tutti vogliano evitare che questi contrasti si ripercuotano sulla crisi siriana o su altri Paesi vulnerabili, come il Libano e l’Iraq. Teheran e Riad siedono insieme al tavolo dei colloqui di pace per la Siria. È importante che continuino a farlo. È importante per la Siria, per le prospettive di stabilità in tutto il Medio Oriente e per evitare di infiammare con scontri settari le comunità musulmane di altre parti del mondo, dall’Africa all’Asia».
Finora si guardava a queste crisi come alla manifestazione di una guerra intra-islamica tra sciiti e sunniti, di cui noi eravamo semmai vittime collaterali. Ma i fatti di Colonia sembrano dirci che non è così. Stiamo vivendo uno scontro di culture che ci colpisce ben al di là del terrorismo?
«Sulle violenze contro le donne nella notte di Capodanno vorrei, come politico ma anche come donna, richiamare alla razionalità. Metterei tre punti fermi. Primo: le autorità tedesche devono fare piena luce su quello che è successo, e sulle responsabilità penali, che sono comunque e sempre individuali, anche per evitare strumentalizzazioni politiche. Secondo: le leggi vanno rispettate da tutti, e in particolare quelle che tutelano i diritti umani e la libertà della donna. Terzo: la violenza sulle donne non è un fenomeno nato a Colonia il 31 dicembre. Vorrei ricordare che la violenza sulle donne fa una vittima al giorno anche in Paesi dell’Unione europea. La condanna per la violenza sulle donne a Colonia è totale. Ma non esiste una singola cultura cui si possa attribuire questo fenomeno».
Anche a causa dei fatti di Colonia, però, la cancelliera Merkel si trova sotto attacco sia in patria sia sui grandi organi di stampa mondiali. Questo fatto la preoccupa?
«Da un punto di vista politico, credo che il sistema tedesco sia abbastanza solido. Quello che mi preoccupa è la dinamica profonda che può innescarsi nella società e che può portare a una ridiscussione della identità tedesca. Finora, sull’accoglienza ai rifugiati, la Germania è stata tra i Paesi in grado di proiettare un’immagine positiva dentro e fuori la Ue. È importante che continui a farlo. Così come è importante che l’intera Europa preservi i valori su cui è stata fondata».

Il Fatto Quotidiano, 13 gennaio 2016 (m.p.r.)
Fin dall’inizio è con le parole che l’Europa ha tradito. Quel che chiamò crisi del debito greco doveva chiamarlo, in osservanza del principio di realtà: crisi dell’intero progetto d’unificazione europea. L'imprecisione linguistica non è mai casuale. Serve a nascondere, è una strategia di evitamento. Circoscrivere la crisi al debito greco neutralizza le responsabilità dell’Unione, la spoliticizza. Ingrandisce i poteri di una governance sempre più incontrollata e sopprime quelli dei cittadini, che non sanno più a quale governo rivolgersi né dove sia la sovranità (governance non è governo: è potere senza imputabilità). Il progetto europeo nacque col proposito di curare i tre mali che avevano distrutto il continente: l'ingiustizia sociale, l'ostilità fra Stati, l'autoritarismo. Oggi quei fini non sono raggiunti.
Basti ricordare la risposta di Cecilia Malmström, Commissario al Commercio a una domanda sul Ttip: a cosa sono servite le petizioni contro il Trattato transatlantico in vari Paesi europei (circa 4 milioni di firme)? La replica della Malmström: «Non ricevo il mio mandato dal popolo europeo». Se la Commissione non ha ricevuto un mandato dal popolo, da chi lo riceve? Chi controlla il sempre più potente controllore? Da chi ricevono il mandato la Banca centrale europea, la troika e l’Eurogruppo, struttura completamente fuori dal controllo parlamentare e che non tiene verbali delle proprie riunioni? L’ottimismo panglossiano ha sempre fatto dire ai responsabili Ue: “L’Unione politica che farà funzionare l’euro e legittimerà i vari organi tecnici dell’attuale governance verrà, perché necessaria”. Non è venuta e non viene. Il presidente della Bundesbank già dice che non serve più.
Il negoziato con Atene ha offerto un'occasione decisiva per sperimentare e consolidare una sorta di diritto emergenziale permanente, uno stato di eccezione che sfigura senza più pudore il progetto europeo, e non i valori astratti ma i diritti iscritti nella Carta e gli obiettivi fissati negli articoli 2 e 3 del Trattato (pluralismo, tolleranza, giustizia, solidarietà, e piena occupazione, progresso sociale, sviluppo sostenibile). Il diritto emergenziale si applica in tempi di guerra, e dopo gli ultimi attentati i leader europei non esitano a proclamare proprio lo stato di guerra. Il caos alle frontiere è stato spesso acceso dalle nostre politiche estere.
L'Europa ha subappaltato agli Usa la gestione della pace e della guerra, ma gli Usa hanno mostrato di essere non una potenza creatrice di ordine internazionale, ma un impotente artefice di caos globale. In questo senso, l’Europa deve darsi subito una politica razionale e seria verso la Russia: tra le tante sue mancanze, questa è oggi la più vistosa. Se non si mobilitano al contempo l’exite il voice, non ci sarà modo di opporsi alla strategia dell’evitamento che permette all'Europa di ignorare ciò che ha suscitato al suo interno prima l'ansia, poi la chiusura mentale, infine la propensione ad autodistruggersi.
 Sbilanciamoci.info, newsletter n. 456 del 13 gennaio 2016
Sbilanciamoci.info, newsletter n. 456 del 13 gennaio 2016
Il 2016 non si apre sotto i migliori auspici. Una situazione politica incerta su diversi fronti, i problemi dell’emigrazione in Europa, il terrorismo, le apparenti sbandate della Cina, un livello di indebitamento molto rilevante in diverse aree del mondo, sembrano essere alcuni dei fattori negativi che abbiamo davanti.La crescita mondiale
Solo qualche mese fa l’FMI prevedeva per il 2016 una crescita del pil mondiale del 3,6%. Ora la Banca Mondiale stima per l’anno in corso un aumento del pil del 2,9%; ricordiamo, tra l’altro, che nel 2014 si era registrato il 3,4% e nel 2015 il 3,1%. Si tratta di un rilevante rallentamento, che dovrebbe lasciare il campo nel 2017 ad una ripresa minima (3,1%).
Bisogna comunque distinguere tra le varie aree del mondo (Guélaud, 2016, a), perché comunque lo sviluppo appare molto ineguale. Per gli Stati Uniti la stima di crescita è del 2,5% per il 2015 e del 2,7% per il 2016; per la zona euro il quadro appare meno positivo, indicando rispettivamente l’1,5% e l’1,7%.
Ma il peggioramento delle previsioni globali deve essere collegato soprattutto al rallentamento di una parte dei paesi emergenti. Ricordiamo che, sempre secondo le stime dell’FMI, il loro peso sul pil mondiale è stato nel 2015 del 58%: quindi i destini di tale area, in particolare del continente asiatico, sono ormai determinanti per il futuro economico del mondo, più di quelli dei paesi ricchi.
Le previsioni sono parecchio negative per il Brasile e per gli altri paesi dell’America Latina, anche se esse appaiono meno disarmanti che per il 2015. L’Africa del Nord e quella sub-sahariana cresceranno un po’ di più. Ma gran parte dell’Asia andrà decisamente bene: 7,3% per l’India, 6,3% per l’Asia dell’Est e il Pacifico, 7,3% per l’Asia del Sud, 6,7% per la Cina, in leggero rallentamento; in miglioramento, anche se ancora in territorio negativo, la Russia.La Cina
La Cina rappresenta un caso a se e, anche per la sua importanza per la crescita mondiale, merita una trattazione a parte.
Ricordiamo intanto che un aumento del pil ormai intorno al 7% all’anno significa – se utilizziamo per le stime il criterio della parità di potere di acquisto-, che ogni anno si aggiunge a quello precedente un pil pari grosso modo a quello spagnolo, un dato enorme.
Come è noto, il paese sta effettuando il passaggio da un’economia centrata sull’industria ad una sui servizi, da una crescita basata su investimenti ed export ad una basata sui consumi interni, inoltre con gli assi dello sviluppo puntati verso un’economia pulita e l’acquisizione di un alto livello tecnologico.
Nel frattempo si deve governare una riduzione della capacità produttiva in alcuni settori (non si può produrre più del 50% dell’acciaio mondiale!), ridurre l’ingorgo del settore immobiliare, ristrutturare le imprese statali, controllare l’indebitamento, combattere la povertà. Compiti immani, ma la dirigenza cinese ha mostrato in tutti questi decenni di saper gestire problemi anche più rilevanti.
Mentre tutti sottolineano il rallentamento dell’industria, inevitabile nel perseguimento di tale strategia, molti censurano invece la forte crescita dei servizi; così, ad esempio, il turismo è in pieno boom e quello estero è aumentato del 16% nel 2015, le vendite di biglietti per il cinema sono cresciute del 50%, quelle dismartphone si riducono in quantità, ma aumentano fortemente in valore unitario (The Economist, 2015).
Nel 2015 dovrebbero essere stati creati intorno ai 14 milioni nuovi posti di lavoro, mentre i salari crescono in maniera sostenuta.Le due crisi
Ma ora siamo di fronte alla crisi della borsa e a quella della moneta.
Per quanto riguarda la prima, bisogna ricordare che gli investimenti stranieri nel settore sono quasi inesistenti e che quindi non ci dovrebbero essere ripercussioni dirette delle difficoltà sul resto del mondo. La borsa cinese è un affare quasi solo spinto dalla speculazione e non ha alcun collegamento con l’economia reale (Authers, 2016). D’altro canto, i titoli erano saliti troppo in alto e ancora oggi essi sono grosso modo dove erano un anno fa. Peraltro i regolatori cinesi devono imparare a gestire meglio la questione.
Qualcuno ha scritto che la Cina dovrebbe semmai celebrare il collasso del suo mercato di borsa, che era molto gonfiato rispetto alla realtà (Zhang Joe, 2016).
Più importante appare la svalutazione della moneta. L’intento ufficiale non è certo quello di incoraggiare le esportazioni, dal momento che le priorità politiche sono diverse. L’obiettivo è quello di sganciare il cambio dello yuan da quello del dollaro ed ancorarlo invece ad un basket di monete, aiutando il passaggio ad una situazione maggiormente determinata dalle forze del mercato.
Ma l’operazione è stata portata avanti in maniera maldestra e poco chiara, insospettendo i mercati internazionali, che, più in generale, in questo momento non si fidano dei dati cinesi. Essi temono una forte svalutazione della moneta (per volontà cinese o per una fuga di capitali fuori controllo) e una rilevante riduzione del tasso di crescita del pil.
Ma il paese ha un bilancio forte, con entrate crescenti, con riserve di cambio molto elevate, alimentate da un considerevole surplus della bilancia dei pagamenti. D’altro canto, l’instabilità dei mercati appare anche un riflesso delle paure degli stessi per la situazione dell’economia occidentale.Le novità non hanno effetti solo negativi sul resto del mondo
Nonostante il rallentamento, la Cina resta il paese che ha maggiore influenza sullo sviluppo mondiale; nei prossimi anni essa probabilmente peserà tra un terzo e la metà della crescita globale del reddito, del commercio e della domanda di materie prime e la sua importanza continuerà ad aumentare insieme alla sua quota dell’economia mondiale (Summers, 2015).
La modifica del suo modello di sviluppo non ha effetti solo negativi sugli altri paesi (Guélaud, 2016, b). Certo, la riduzione nei livelli di acquisto delle materie prime sta portando rilevanti danni all’America Latina, a diversi paesi africani e a qualcuno asiatico. Più in generale il rallentamento delle importazioni, generato, oltre che dalla riduzione nei tassi di crescita, anche dall’aumento della percentuale dei prodotti fabbricati in patria – tra l’altro, la componente di importazioni dei consumi è in genere di circa 11 punti inferiore a quella degli investimenti- e dalla maggiore qualificazione delle produzioni, danneggia diversi paesi nel mondo, tra cui anche Germania, Corea del Sud, Giappone; d’altro canto, la crescita degli investimenti esteri, lo sviluppo dei grandi progetti della “nuova via della seta”, il varo di diverse banche di investimento per i paesi emergenti, la spinta del turismo, dovrebbero servire a riequilibrare almeno in parte la partita. Così la forte crescita del turismo dovrebbe portare benefici a diversi paesi asiatici, Giappone, la Corea del Sud, Tailandia, Vietnam, Taiwan; in alcuni di tali paesi l’aumento della spesa dei viaggiatori cinesi negli ultimi anni ha compensato la riduzione delle esportazioni.
La crescita delle delocalizzazioni verso altri paesi, indotta dall’aumento del costo del lavoro, favorisce diverse realtà, dal Vietnam, all’Africa del Sud, alla Tailandia, alle Filippine.Conclusioni
l’economia mondiale rallenta a causa di problemi economici, finanziari, politici, non risolti e la situazione non appare brillante sino a tutto il 2018. Sarebbero necessari, tra l’altro, maggiori stimoli alla domanda e agli investimenti (Ragot, 2016), frenati invece, tra l’altro, da interessi forti e da un alto livello di indebitamento.
Ma tale rallentamento appare distribuito in maniera non uniforme sulla superficie del globo. La volata dello sviluppo continua ad essere comunque tirata dai paesi asiatici. Al di la del fatto che le autorità cinesi devono imparare a gestire meglio la finanza e a mandare segnali più chiari al mercato, non sembrano esserci ragioni importanti che facciano temere che le cose in Cina si potrebbero deteriorare fortemente.
Il paese dovrebbe proseguire con i suoi programmi di ristrutturazione dell’economia, certo senza escludere qualche intoppo. Ma bisogna avere una visione realistica delle cose e considerare che la sua influenza sul resto del mondo appare, al momento, insostituibile. In particolare anche nel 2016 il paese sarà determinante nel fissare la strada dell’economia mondiale.Appendice
Non molti anni fa i politologi anglosassoni si domandavano se la Cina, sviluppandosi, si sarebbe rivelata come una attrice “responsabile” del sistema economico e politico globale (Stephens, 2015). Ma appare sempre più chiaro che la crescita del paese è l’evento più importante della nostra epoca e che Pechino intende essere ormai un produttore di regole, non un allievo ubbidiente ai vecchi padroni, anche perché l’Occidente le ha offerto sino ad oggi appena uno strapuntino al tavolo del potere mondiale. Ma questa sarebbe un’altra storia da raccontare.
Testi citati nell’articolo
Authers J, A frail economy caught in China’s tumble, www.ft.com, 8 gennaio 2016
Guélaud C., A peine repartie, l’économie mondiale patine, Le Monde, 8 gennaio 2016, a
Guélaud C., Les deux faces de la décélération en Asie, Le Monde, 8 gennaio 2016, b
Ragot X., Le progrès technique n’est pas le problème, Alternatives Economiques, n. 353, gennaio 2016
Stephens P., Now China starts to make the rules, Financial Times, 29 maggio 2015
Summers L., Grasp the reality of China rise, www.ft.com, 8 novembre 2015
The Economist, Doughty but not superhuman, 26 settembre 2015
Zhang Joe, Deflate stock market and allow China’s fortunes to swell, www.ft.com, 4 gennaio 2016

 «Con il ddl Boschi assistiamo alla blindatura del potere, alla sua concentrazione nelle mani dell’esecutivo ai danni di Parlamento e cittadini». L'ingenua (o molto furba) Liana Milella intervista l'autorevole giurista, membro del comitato per il no allo stravolgimento della costituzione operato dal governo.
«Con il ddl Boschi assistiamo alla blindatura del potere, alla sua concentrazione nelle mani dell’esecutivo ai danni di Parlamento e cittadini». L'ingenua (o molto furba) Liana Milella intervista l'autorevole giurista, membro del comitato per il no allo stravolgimento della costituzione operato dal governo.
La Repubblica, 13 gennaio 2016
È un riforma? «Lo sa come si chiama la corazza della tartaruga? Carapace. La mia risposta allora è: questa riforma è il carapace del potere». Comincia così l’intervista con il professor Gustavo Zagrebelsky.
Dicono che sarà divertente vedere alleati lei, Rodotà, Berlusconi, Brunetta e Salvini. Non è una compagnia imbarazzante?
«Ma davvero a qualcuno è venuto in mente di dire questo? E a chi?».
A Orfini e Boschi, e non solo...
«Ma fanno torto alla loro intelligenza».
E perché mai?
«Perché confondono la Costituzione con la politica d’ogni giorno. Si può essere lontanissimi politicamente e concordare costituzionalmente ».
Non mi dica che pure Berlusconi difende la Costituzione...
«Io non faccio processi alle intenzioni. Non la colpisce il fatto che a favore della riforma sia il governo e tutta la maggioranza e contro siano tutte le opposizioni, destra e sinistra, senza eccezione?».
E che ci trova di strano?
«Soffermiamoci sul punto. La Costituzione dovrebbe essere la regola della convivenza tra tutti. Di tutti con tutti. Una garanzia reciproca. Invece, nel nostro caso, la riforma della Costituzione è stata promossa dal governo, imposta dal governo e votata dalla maggioranza del governo. Questi dati di fatto non le fanno sospettare che questa cosiddetta riforma della Costituzione sia una “blindatura” di un giro di interessi che ha conquistato il potere e se lo vuole tenere stretto?».
Ammetterà che senza questa “blindatura” non si sarebbe mai riusciti a cambiare la Costituzione in modo condiviso.
«E con ciò?».
Renzi e i suoi ritengono che cambiarla serva all’Italia.
«In realtà dicono che l’Italia aspetta da 30 anni questa riforma. Sarebbe più giusto dire che a qualcuno, e tra questi ora i nostri “riformatori”, la vigente Costituzione non è mai piaciuta».
Invece lei perché la difende a ogni costo?
«Qui tocchiamo la vera posta in gioco. È in corso da 30 anni un’involuzione che ha rovesciato la piramide della democrazia. La base, cioè i cittadini, le loro associazioni, le strutture sociali, contano sempre di meno, e sempre di più contano i vertici, che siano i vertici dei partiti o delle istituzioni. Questa è un’involuzione che tecnicamente si può chiamare il passaggio dalla democrazia all’oligarchia».
Il suo timore qual è? Il partito unico? Il leader unico? L’opposizione azzerata? Il suo pessimismo cosa nasconde?
«La mia è una pura constatazione. I partiti, a cominciare dal Pd, che dovevano essere canali di organizzazione e partecipazione politica, sono stati distrutti. In essi domina ormai il “caro segretario” che controlla il partito e attraverso di esso opera nelle istituzioni. I sindacati sono in grave difficoltà e chi governa, invece di preoccuparsi, se ne compiace. La maggioranza del Parlamento opera sotto la sferza del governo. La legge elettorale, Porcellum o Italicum che sia, mette nelle mani del segretario del partito la selezione dei candidati sulla base di un rapporto di fedeltà personale. E il governo è composto da ministri a disposizione del leader. Non le pare che tutto ciò comporti una concentrazione del potere al vertice e una privazione alla base?».
Renzi e Boschi le risponderebbero che queste sono le analisi dei professoroni che vogliono mantenere lo status quo.
«Lo status quo è per l’appunto quello che ho appena detto, ed è proprio ciò che noi vogliamo combattere. Onde, se vogliamo usare l’abusata categoria dei conservatori, siamo noi gli innovatori e sono i sedicenti innovatori costituzionali a essere paradossalmente i veri conservatori o, per essere espliciti, i blindatori ».
Davvero pensa che modificare l’attuale Senato risponda a questo progetto?
«Guardi che la riforma costituzionale non tocca solo il Senato, ma in generale redistribuisce i poteri in maniera tale che il baricentro si sposta radicalmente a favore dell’esecutivo. Il Parlamento risulterà sottomesso alle iniziative del governo. Gli organi di controllo, Corte costituzionale e perfino il presidente della Repubblica, ricadranno nell’orbita di Palazzo Chigi. Non di per sé, ma per l’effetto congiunto della riforma costituzionale e della legge elettorale. La verità è che i problemi istituzionali vanno visti nella complessità di tutti i loro elementi».
Per questo parla di riforma “esecutiva”?
«Viviamo in un tempo esecutivo. Ha notato come vengono denominati i vagoni di lusso nei treni ad alta velocità? Executive, non legislative, or judiciary... Segno dei tempi».
Esecutivi di cosa?
«Se guardiamo la letteratura internazionale si direbbe degli interessi dei grandi gruppi economico-finanziari e militari. Vuole qualche citazione?”.
No, per carità... Ma con riguardo al nostro Paese?
«A vederli da qui appare solo la mediocrità della nostra classe dirigente. Che qualità di interessi sono quelli che emergono, per esempio, in questi giorni dalle indagini sul sistema bancario?».
Dice Renzi «se perdo il referendum lascio la politica». Che effetto le fa?
«Un po’ di megalomania».
E perché?
«Per due motivi. Primo: sembra una parodia del generale De Gaulle del 1969. Anche lì un referendum, guarda caso sul Senato, dal cui esito il Generale fece dipendere la sua permanenza in carica. Secondo: il proprio futuro politico scommesso sulla riforma della Costituzione. Renzi ha posto quella che tecnicamente si chiama una questione di fiducia sulla riforma. In questo modo ha dichiarato ufficialmente che questa riforma non è costituzionale, ma è governativa».

Che bisogno c’è di surrealismo e nonsense quando ci sono i sondaggi? Sul famoso referendum che deciderà del destino delle riforme costituzionali - si usano chiamare così le tracce di cingoli sulla Costituzione - i numeri che girano sembrano il teatro dell’assurdo. Solo il 20 per cento degli elettori dice di aver capito esattamente di cosa si parla, e il 60 per cento degli stessi elettori dichiara che voterà sì. Come dire che due italiani su tre tra quelli favorevoli voteranno sulla base del sentito dire, dell’aria che tira e della propaganda.
La cronaca del voto alla Camera di Alessandra Longo, la presentazione dei Comitati promotori del No di Andrea Fabozzi e Silvia Truzzi, l’intervento del professore Zagrebelsky. La Repubblica, il manifesto, il Fatto Quotidiano, 12 gennaio 2016 (m.p.r.)
RIFORME, ALLA CAMERA È SÌ “AVANTI TUTTA”
BOSCHI SOTTO TIRO IN AULA
Roma. Una passeggiata, diciamo la verità. All’ora del tè la Camera approva il disegno di legge Boschi. 367 sì, 194 no, 5 astenuti. Renzi non twitta, si affida a Facebook: «Oggi quarto voto sulle riforme costituzionali: maggioranza schiacciante in attesa di conoscere il voto dei cittadini in autunno. Stiamo dimostrando che per l’Italia niente è impossibile. Con fiducia e coraggio, avanti tutta». Breve e indolore, come previsto. Maria Elena Boschi richiude la sua borsa color salmone e riceve i complimenti di rito. Il sorriso, però, è tirato. I Cinquestelle ci sono andati giù pesanti con le vicende di Banca Etruria e il ruolo di suo padre, che ne è stato il vicepresidente.
La fila è lunga. «Abbiamo già superato il quorum?», si scherza sperando di riuscire a entrare. Al debutto del comitato del No si riempie subito l’aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio, mentre nell’aula quella vera - stesso palazzo - la riforma procede sul velluto. Arriva l’ultimo sì della prima lettura e comincia in contemporanea il lungo avvicinamento al referendum, che in questo caso non prevede quorum. Allora la domanda è un’altra: come ci si oppone a un plebiscito? Come si sfugge, cioè, allo schema innovatori contro conservatori? Secondo Gaetano Azzariti centrando la campagna elettorale sugli enormi problemi della rappresentanza e del parlamento, per mettere in luce quanto sia «scarsa» la riforma di Renzi di fronte alla «crisi dello stato costituzionale». Secondo Stefano Rodotà bisogna fronteggiare «l’antipolitica di governo» avviando una lunga stagione referendaria.
Ma il primo problema che ha davanti il comitato promotore del No riguarda la sua stessa genesi. Se è vero che il referendum non può chiederlo il presidente del Consiglio, come invece racconta di voler fare (in sua vece firmeranno la richiesta un numero sufficiente di parlamentari renziani), è vero anche che un comitato di cittadini avrebbe bisogno di 500mila firme per opporsi in questa veste alla revisione costituzionale. Firme che andrebbero raccolte in tre mesi dall’ultima approvazione del disegno di legge Renzi-Boschi, prevista per la seconda decade di aprile. L’alternativa - dovendo escludere che si trovino cinque consigli regionali contrari alla riforma - resta quella delle firme di 126 deputati o 65 senatori di opposizione: quelle sono assicurate. Se non si raccolgono le firme dei cittadini, al referendum si andrà per questa strada, come fu nel 2001 quando il centrodestra provò a opporsi al nuovo Titolo V approvato dal centrosinistra. Anche allora firmarono sia i parlamentari favorevoli che quelli contrari alla riforma, che il referendum alla fine confermò.
Questa volta i parlamentari che raccoglieranno le firme, e tra questi ci saranno anche quelli di Forza Italia e della Lega, potranno costituire anche più di un comitato per il No: costituirsi in comitato dà diritto a spazi televisivi e a un rimborso sulla base dei voti. Neanche i parlamentari del Movimento 5 Stelle aderiranno al comitato lanciato ieri, che è presieduto dal costituzionalista Alessandro Pace e che ha come presidente onorario il professore Gustavo Zagrebelsky. È questo il gruppo dei costituzionalisti che si sono opposti in ogni modo alle riforme spinte da Renzi (ma anche prima da Letta) negli ultimi tre anni, attraverso numerosi appelli (l’ultimo quello firmato da Lorenza Carlassare, Gaetano Azzariti, Gianni Ferrara, Stefano Rodotà e Massimo Villone, tutti presenti ieri, a ottobre sul manifesto). Questo comitato sta mettendo in piedi comitati locali nelle città e si è già dato un altro appuntamento per il 30 gennaio alla Sapienza a Roma, coinvolgendo le associazioni - a cominciare da Anpi e Arci.
Il Fatto Quotidiano
Il Manifesto
VOI AL GOVERNO, COSA AVETE CAPITO?
di Gustavo Zagrebelsky
Ampi stralci dell’intervento del professore Zagrebelsky, letto ieri davanti all’assemblea del comitato del No dal professore Francesco Pallante.
Coloro che vedono le riforme costituzionali gravide di conseguenze negative non si aggrappano alla Costituzione perché è «la più bella del mondo». Sono gli zelatori della riforma che usano quell’espressione per farli sembrare degli stupidi conservatori e distogliere l’attenzione dalla posta in gioco. La posta in gioco è la concezione della vita politica e sociale che la Costituzione prefigura e promette, sintetizzandola nelle parole «democrazia» e «lavoro» che campeggiano nel primo comma dell’art. 1.
Quali credenziali possono esibire gli attuali legislatori costituzionali? A parte la questione, bellamente ignorata, dell’incostituzionalità della legge elettorale in base alla quale essi sono stati eletti; a parte la falsificazione delle maggioranze che quella legge ha comportato, senza la quale non ci sarebbero stati i numeri in Parlamento; a parte tutto ciò, la domanda che deve essere posta è: quale visione della vita politica li muove? A quale intento corrispondono le loro iniziative? C’è un «non detto» e lì si trovano le ragioni di tanta enfasi, di tanto accanimento, di tanta drammatizzazione che non si giustificherebbero se si trattasse solo di riduzione dei costi della politica e di efficientismo decisionale. La posta in gioco non è di natura economica e funzionale. Se fosse solo questo, si dovrebbe trattare la «riforma» come una riformetta da discutere tecnicamente, incapace di sommuovere acute passioni politiche. Invece, c’è chi la carica d’un significato eccezionale, si atteggia a demiurgo d’una fase politica nuova e dice d’essere pronto a giocarsi su di essa perfino il proprio futuro politico.
Ciò si spiega, per l’appunto, con il «non detto». Cerchiamo, allora, di dirlo, nel quadro delle profonde trasformazioni istituzionali degli ultimi decenni, trasformazioni che hanno comportato un ribaltamento della democrazia parlamentare in uno strano regime tecnocratico-oligarchico che, per sua natura, ha come punto di riferimento l’esecutivo. Viviamo in «tempi esecutivi»! La politica esce di scena. I tecnici ne occupano lo spazio nei posti-chiave, cioè nei luoghi delle decisioni in materia economica, oggi prevalentemente nella versione della finanza, e nel campo della politica estera, oggi principalmente nella versione degli impegni militari. La partecipazione politica che dovrebbe potersi esprimere nella veritiera rappresentazione del popolo, cioè in parlamento, a partire dai bisogni, dalle aspirazioni, dagli ideali non è più considerata un valore democratico da coltivare, ma un intralcio.
L’informazione si allinea; la vita pubblica è drogata dal conformismo; gli intellettuali tacciono; non c’è da attendersi alcuna vera alternativa dalle elezioni, pur se e quando esse si svolgano, e se alternative emergessero dalle urne, sarebbe la pressione proveniente da fuori (istituzioni europee, Fondo monetario internazionale, grandi fondi d’investimento) a richiamare all’ordine; nella scuola si affermano modelli verticistici e i nostri studenti e i nostri insegnanti gemono sotto programmi ministeriali finalizzati a produrre non cultura ma tecnica esecutiva.
La chiamiamo «riforma costituzionale», ma è una «riforma esecutiva». Stupisce che tanti uomini e tante donne che hanno nella loro storia politica numerose battaglie per la democrazia, si siano adeguati a subire questa involuzione, anzi collaborino attivamente chiudendo gli occhi di fronte a ciò che a molti appare evidente. La riforma costituzionale è il coronamento, dotato di significato perfino simbolico, di un processo di snaturamento della democrazia che procede da anni. Coloro che l’hanno non solo tollerato ma anche promosso sono oggi gli autori della riforma. Sono gli stessi che ora ci chiedono un voto che vorrebbe essere di legittimazione popolare a un corso politico che di popolare non ha nulla.
I singoli contenuti della riforma importano poco o nulla di fronte al significato politico. Contano così poco che chi avesse voglia di leggere e cercare di capire ciò su cui ci si chiede di esprimerci nel referendum resterebbe sconcertato (…). Siamo di fronte a un testo incomprensibile. Verrebbe voglia di interrogare i fautori della riforma — innanzitutto il presidente della Repubblica di allora, il presidente del Consiglio, il ministro — e chiedere, come ci chiedevano a scuola: dite con parole vostre che cosa avete capito. Qui, addirittura, che cosa avete capito di quello che avete fatto? Saprebbero rispondere? E noi, che cosa possiamo capirci?