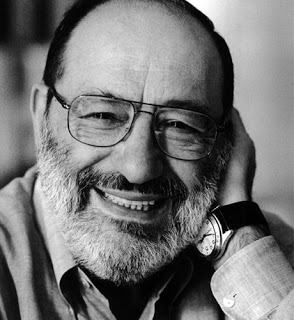Sempre più ampio l'abisso che separa l'Italia dal resto dell'Europa in tema di diritti civili. Principi universali, tradotti in codici europei cui tutti dovrebbero uniformarsi, calpestati in nome della sopravvivenza di un califfo.
Sempre più ampio l'abisso che separa l'Italia dal resto dell'Europa in tema di diritti civili. Principi universali, tradotti in codici europei cui tutti dovrebbero uniformarsi, calpestati in nome della sopravvivenza di un califfo.
La Repubblica, 25 febbraio 2016
UNA soluzione che ben potrebbe essere considerata paradossale, se i modi fantasiosi dell’attuale politica non l’avessero spinta verso funambolismi che la destituiscono di vera credibilità. Si rafforza, infatti, l’attuale maggioranza di governo proprio sul terreno più “divisivo” tra Pd e Ncd. Ma non sarebbe questo l’unico paradosso, o l’unica contraddizione, di una fase così confusa e politicamente così mal gestita. E allora è il caso di fare una prima valutazione di quel che è già avvenuto, di quanto si è già perduto e di quanto si può ancora perdere.
La discussione sulle unioni civili era cominciata sottolineando che finalmente era alle porte una legge da troppo tempo attesa, che avrebbe consentito all’Italia di recuperare un livello di civiltà dal quale si era allontanata e che, in questo modo, l’avrebbe riportata in Europa. Ma, avendo perduto troppi pezzi, la legge approvata finirà con l’essere considerata come una nuova testimonianza di una arretratezza di fondo che, anche quando si fanno sforzi significativi, non si riesce davvero a superare.
Che cosa vuol dire Europa in una materia davvero fondamentale, non per una forzatura ideologica, ma perché riguarda i fondamenti stessi del vivere? Vuol dire costruzione di un sistema sempre più diffuso e condiviso di principi e regole, che è stato poi affidato ad un documento comune, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che dal 2009 ha lo stesso valore giuridico dei trattati e che, quindi, dovrebbe essere costante punto di riferimento nelle discussioni legislative dei singoli Stati membri.
Proprio per il tema affrontato in questi giorni al Senato, l’innovazione della Carta è stata massima. L’articolo 21 ha vietato ogni discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale. L’articolo 9 ha cancellato il requisito della diversità di sesso per il matrimonio e per ogni forma di organizzazione familiare, e i giudici europei seguono ormai questo criterio. Eguaglianza, parità dei diritti, libertà nelle scelte. Principi essenziali, che avrebbero dovuto guidare i dibattiti parlamentari e che lì, invece, sono comparsi in maniera sempre più pallida. Sono stati spesso sopraffatti da un coacervo di confusi riferimenti morali, strumentalizzazioni politiche, controversi riferimenti scientifici. Si finisce così con l’avere la sensazione che l’Italia — al riparo da un “Grexit” per ragioni economiche e da un “Brexit” per ragioni politiche — abbia scelto la strada di un “exit” dall’Europa tutto culturale.
Già possiamo misurare gli effetti sociali di questo modo di procedere. Sono tornati nella discussione pubblica, con una rinnovata e violenta legittimazione derivante da toni del dibattito parlamentare, argomenti omofobi, discriminatori, aggressivi, incuranti dell’umanità stessa delle persone. Si è minacciato il ricorso ad un referendum popolare contro la norma che avesse ammesso l’adozione del figlio del partner. Forse vale la pena di ricordare che, nel 1974, quando ci si avviava verso l’eliminazione delle discriminazioni contro i figli nati fuori del matrimonio (i “figli della colpa”, gli “illegittimi”), i professori Sergio Cotta e Gabrio Lombardi, che già avevano promosso il referendum contro la legge sul divorzio, ne minacciarono uno contro una riforma che fosse andata in quella direzione (intenzione caduta dopo che l’abrogazione del divorzio fu respinta dal voto popolare).
E proprio intorno alla norma sull’adozione si è concentrato oggi un fuoco di sbarramento che colpisce, insieme, i diritti delle coppie e quelli dei bambini. Proprio dei bambini, strumentalmente indicati come oggetto di una necessaria tutela e che, invece, rischiano d’essere ricacciati in una condizione di discriminazione, creando una nuova categoria di “illegittimi”. Più che un intento discriminatorio, ormai uno spirito persecutorio. Si può in concreto indebolire o cancellare la tutela di cui essi già godono fin dal 1983 attraverso un saggio intervento e una valutazione dei giudici, che hanno applicato le norme sull’adozione in casi particolari in nome dell’interesse “supremo” del minore. Una conquista civile dalla quale non si dovrebbe uscire, richiamata dall’Avvocatura dello Stato davanti alla Corte costituzionale, che ieri ha deciso un caso relativo all’adozione da parte di due donne sposate negli Stati Uniti delle reciproche figlie. Dallo scarno comunicato della Corte non si può dedurre con certezza se le sue indicazioni puntuali consentiranno di continuare a ricorrere alle diverse soluzioni già utilizzate dai giudici.
La prudenza e il rigore dovrebbero sempre guidare il legislatore. Ma più ci si inoltra negli intricati meandri in cui si è cacciato il Senato nella tenace sua volontà riduzionistica delle unioni civili, più si coglie l’approssimazione e l’incapacità di comprendere la rilevanza dei diritti in questione. L’esecrazione per l’utero in affitto, improvvisamente evocata contro l’adozione del figlio del partner nelle coppie omosessuali mentre è pratica al 93% di quelle eterosesuali, porta a declamare la sua qualificazione come “reato universale” con condanna del genitore e divieto di riconoscimento del figlio.
Ma si ignora che la questione è stata risolta il 26 giugno 2014 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha condannato la Francia a trascrivere l’atto di nascita dei figli nati all’estero da una madre surrogata, anche se in Francia, come in Italia, questa pratica è vietata. E la Cassazione francese ha dato seguito a quella decisione. Ma la nostra aggrovigliata discussione ignora a tal punto l’Europa da aver subito dimenticato che il Parlamento non ha scelto liberamente di legiferare in questa materia, ma è stato obbligato a farlo da una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2015, che ha condannato lo Stato italiano a riconoscere alle coppie di persone dello stesso sesso uno statuto giuridico adeguato.
Un “obbligo positivo”, al quale si tenta di sottrarsi con mille sotterfugi, cominciando con il trascurare che quella sentenza è fondata sull’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che riconosce il diritto alla “vita privata e familiare”. A questo non basta fare un riferimento generico. Poiché la sentenza dice che “le coppie dello stesso sesso hanno una situazione sostanzialmente simile a quelle delle coppie di sesso diverso”, e qui la discrezionalità del legislatore è ridotta, il riferimento alla vita familiare deve essere inteso nella sua pienezza organizzativa. Altrimenti si fa una operazione culturalmente regressiva, un altro atto implicito di uscita dall’Europa.
È in corso una grottesca operazione di ripulitura di ogni accenno che possa far pensare al matrimonio. Persino l’idea della fedeltà nelle coppie di persone dello stesso sesso deve essere allontanata, quasi che l’affetto e il “diritto d’amore” possano scomparire per effetto di arzigogoli verbali. In realtà si sta preparando una linea interpretativa rigidissima della nozione di famiglia per bloccare ogni ulteriore sviluppo in materia. È urgente invece un riflessione culturale sul sistema costituzionale, quella che nel 1975 aprì la strada alla riforma del diritto di famiglia.
Tutto questo, e molto altro che si potrebbe aggiungere, ci dice con quale spirito si dovrà accogliere la legge ora annunciata. Nessuno predica il tanto peggio tanto meglio. Ma nessuno potrà negare che un testo scarnificato, impoverito, mortificato porterà al suo interno il segno di una sconfitta politica e culturale. Condannando l’Italia, la Corte europea aveva parlato di un tradimento della fiducia e delle attese delle persone omosessuali. Tradimento che oggi riguarda tutti i cittadini ai quali spetta di vivere in un paese coerentemente inserito nel contesto culturale europeo. E invece si annunciano nuove distanze nuovi conflitti, rinvii a testi futuri, giochi d’inganni.
 «Questa legge è irricevibile. pensare che uno Stato in Europa possa fare una legge sulle unioni civili senza garantire i diritti dei bambini è inconcepibile». Ma ormai è una tattica consolidata:basta approvare una legge la cui etichetta possa essere venduta nella campagna elettorale: non fa nulla se dentro c'è solo veleno.
«Questa legge è irricevibile. pensare che uno Stato in Europa possa fare una legge sulle unioni civili senza garantire i diritti dei bambini è inconcepibile». Ma ormai è una tattica consolidata:basta approvare una legge la cui etichetta possa essere venduta nella campagna elettorale: non fa nulla se dentro c'è solo veleno.
Il manifesto, 25 febbraio 2016
Si sentono trattati come cittadini di serie B, le cui vite possono essere svendute e sacrificate. E loro non ci stanno. Anzi. Centinaia di militanti di associazioni lgbt si sono riuniti ieri pomeriggio sotto il Senato per protestare contro lo stravolgimento del disegno di legge sulle unioni civili. «Vergogna», «Tradimento», «Non ci rappresentate» hanno urlato rivolti verso palazzo Madama dove Pd e Ncd erano impegnati a mercanteggiare sul loro futuro e su quello dei loro figli. A un certo punto un gruppo ha anche cercato di bloccare il traffico sedendosi in mezzo alla strada , ma è stato immediatamente fermato dalla polizia.
Tra le associazioni lgbt la rabbia per come si sta stravolgendo il ddl Cirinnà è tanta e cresce con il passare delle ore. Per il 5 marzo è stata indetta una manifestazione che si terrà a piazza del Popolo a Roma.
Non più tante iniziative sparse per le città italiane, come avvenuto il 23 gennaio scorso, ma un’unica grande manifestazione alla quale si spera che parteciperanno decine di migliaia di persone. Anche per rispondere al Family Day che si è tenuto il 30 gennaio al Circo Massimo e a quanti non vogliono che l’Italia si allinei finalmente con il resto d’Europa. «Grideremo al nostra rabbia per questo tradimento», hanno spiegato ieri i manifestanti.
Traditi dal Pd e in particolare da Matteo Renzi, che non ha saputo mantenere la parola data quando venne eletto segretario. ma anche dai tanti parlamentari, a partire proprio dall’ex relatrice del testo Monica Cirinnà, che non hanno difeso un disegno di legge fatto proprio dalle associazioni omosessuali anche se ben al di sotto di quanto richiesto. «L’emendamento sul quale il governo si appresta a chiedere fiducia in aula è una dichiarazione di resa, incondizionata, un insulto alla dignità delle persone perché frutto di strategie che svendono le vite di tutti e tutte — è il commento di Arcilesbica -. Se il risultato sarà quello di tenere in piedi una legge per fare campagna elettorale e proclami di tenuta del governo ci troveremo di fronte ad uno scempio agito, deciso, sulle vite, sui corpi di cittadine e cittadini di questo paese».
«Ai partiti e alla politica — afferma la vicepresidente, Lucia Caponera — diciamo chiaramente che una legge confezionata come vessillo politico, svuotata e consegnata alla corte degli omofobi non è quello che vogliamo. Non è più il tempo dei compromessi. La politica deve assumersi le proprie responsabilità e sapere che non vi sarà alcun plauso. Nessun consenso può esserci laddove manca una democrazia dei diritti».
Dura anche la reazione della presidente di Famiglie Arcobaleno, Marilena Grassadonia: «Questa legge è irricevibile. Nel 2016 pensare che uno Stato in Europa possa fare una legge sulle unioni civili senza garantire i diritti dei bambini è inconcepibile».
«La Repubblica
, 25 febbraio 2016
La legge elettorale, l’Italicum, finirà all’esame della Corte costituzionale. Lo ha deciso il Tribunale di Messina che ha dichiarato non infondate 6 delle 13 questione di illegittimità che erano state depositate dal Comitato per la democrazia costituzionale. I giudici dello Stretto hanno così battuto sul tempo i colleghi degli altri 17 tribunali dove sono stati depositati dei ricorsi analoghi dal comitato coordinato da Felice Besostri. Si ripete così uno schema politico-procedurale che portò all’esame del Porcellum da parte della Corte e alla sua bocciatura.
Un iter veloce, quindi. E che non servirà aspettare molto per la decisione lo spiega subito il neo presidente della Consulta, il fiorentino Paolo Grossi: «Penso che si possa arrivare in un tempo ragionevolmente breve a qualche cosa di definito».
I giudici messinesi hanno deciso che la Consulta dovrà pronunciarsi sul alcuni nodi dell’Italicum. A partire dalla questione di una soglia minima per accedere al ballottaggio. I ricorrenti, infatti, fanno notare che si potrebbe verificare una situazione di frammentazione politica per cui andrebbero al ballottaggio due forze politiche premiate solo il 20 per cento dei voti.
Il meccanismo dell’Italicum a quel punto prevede il secondo turno e l’assegnazione di 345 seggi al vincitore. E questo viene ritenuto incostituzionale dai ricorrenti. Ma anche il premio di maggioranza viene considerato contrario ai principi costituzionali, perché lede il «principio di rappresentanza democratica». Nel mirino sono finite anche la norma che prevede 100 seggi bloccati per i capilista e la relativa «impossibilità di scegliere direttamente e liberamente i deputati».
«Spero che quello di Messina sia soltanto il primo - ha detto Besostri - e che magari alla fine la questione di costituzionalità giunga alla Consulta su tutte e 13 le obiezioni ». Soddisfatti anche i grillini che hanno firmato il ricorso. Il rinvio dell’Italicum alla Consulta, spiega il gruppo della Camera, «rafforza la nostra convinzione che la legge sia incostituzionale». Scettico e perplesso, invece il ministro dell’Interno Angelino Alfano: «Non mi stupisce. Siamo in Italia, dove una legge prima di diventare vigente è già mandata alla Consulta».
 Svelare le menzogne e i depistaggi, appoggiare senza riserve i ragazzi di piazza Tahir, recidere i legami di affari e di guerre inutili e devastanti che ci asservisce ai torturatori assassini. Articoli di Luciana Castellina, Giuseppe Acconcia, Jean-Pierre Filiu.
Svelare le menzogne e i depistaggi, appoggiare senza riserve i ragazzi di piazza Tahir, recidere i legami di affari e di guerre inutili e devastanti che ci asservisce ai torturatori assassini. Articoli di Luciana Castellina, Giuseppe Acconcia, Jean-Pierre Filiu.
Il manifesto, 25 febbraio 2016
IN PIAZZA PER GIULIO
di Luciana Castellina
Terminati i riti funebri e versate le lacrime di stato, la vita - per chi ce l’ha ancora - riprende il corso normale. Come gli affari, perché business is business.
Tanto, a un mese dalla scomparsa di Giulio Regeni e a 22 giorni dal ritrovamento del suo corpo torturato possiamo stare tranquilli, veniamo avvertiti: le autorità egiziane e italiane stanno collaborando alla ricerca della verità sull’assassinio. Le medesime autorità che ci stanno aiutando hanno peraltro - è l’ultima delle fantasiose scoperte del governo del Cairo - tirato fuori una nuova tesi: Giulio sarebbe stato ammazzato per una vendetta personale.
Una vendetta di chi? Non c’è il coraggio di dirlo apertamente ma si torna ad alludere, esattamente come tentato fin all’inizio, a rapporti personali non meglio precisati, niente a che vedere con l’attività di ricerca di Giulio. Meno che mai la politica e quanto di orribile accade oggi in Egitto.
Se non ci fosse stato quell’articolo, scritto con un altro collaboratore, sulla situazione sindacale in Egitto, quel testo con cui Giulio era entrato in contatto con noi, così come le coraggiose testimonianze dei suoi amici e colleghi che al Cairo studiano, chi ha ritirato fuori una simile fantasiosa tesi, vale a dire un altro depistaggio, pretenderebbe persino di esser creduto.
È possibile accettare tutto questo? No, non è possibile. Ma come sempre in questi casi si sente pesante la nostra impotenza contro il cinismo di questo mondo.
Oggi alle 14 a Roma, Antigone e Amnesty chiamano ad un sit in davanti all’Ambasciata d’Egitto. Saremo il più possibile. Anche se sentiamo tutti la sproporzione fra la nostra forza, la rabbia e il dolore che proviamo.
Raccogliendo l’invito della famiglia di Giulio, moltiplicheremo gli atti intesi a non far dimenticare, attaccare striscioni, lasciare scritte, vale a dire moltiplicare per 1000 i sit-in come quello di oggi, ma soprattutto nel nostro lavoro quotidiano. Non è molto, ma è indispensabile: per Giulio, per la nostra coscienza, per la dignità del nostro paese ma anche dell’umanità: che non può accettare, non può abituarsi ad accettare che uno degli umani oggi, come sempre più numerosi in questi bruttissimi anni, possa subire, senza che si reagisca, la sorte di Giulio.
Impegniamoci anche se a volte avvertiamo la sproporzione fra quanto dovrebbe esser fatto e non si fa a livello istituzionale: per via degli affari, e perché nella dissennata spedizione che si prepara in Libia non possiamo litigare con l’Egitto, e anzi è bene che continuiamo a dare armi anche a paesi come l’Arabia Saudita che in fondo sarebbe un’alleata.
Non è combattendo l’Isis in questo modo che riusciremo a vincerlo.
Potranno riuscirci soltanto i ragazzi che a piazza Tahrir si sono mobilitati contro i regimi inaccettabili del loro paese, islamici o laici. A condizione che li sosteniamo «senza condizioni», rinunciando anche a qualche affare. Se li aiutiamo come si era impegnato a fare Giulio in prima persona con la ricerca e la conoscenza.
REGENI
L'ULTIMO DEPISTAGGIO
di Giuseppe Acconcia
Egitto. Il governo: «Vendetta personale». La famiglia: «Reagiremo ad ogni verità di comodo». Gentiloni: «Subito accesso agli atti» Altri due stranieri desaparecidos. Fermato attivista
Il ministero dell’Interno egiziano ci riprova. Sarebbe una «vendetta personale» a spiegare le circostanze della morte e tortura di Giulio Regeni. «Non ci accontenteremo di verità di comodo e reagiremo ad ogni tentativo di depistaggio», è la giusta reazione della famiglia di Giulio.
A questo punto, gli inquirenti egiziani starebbero indagando tra i contatti del dottorando friulano. È proprio nella cerchia dei suoi amici che potrebbe trovarsi la risposta sulle responsabilità nella morte del giovane ma non per vendetta. È plausibile invece che il suo arresto possa essere spiegato come uno scambio di persona considerando quanto Giulio fosse vicino, ma estraneo, ad ambienti dell’attivismo politico di sinistra al Cairo.
La pista della vendetta personale, dopo i depistaggi su incidente stradale, delitto sessuale, coinvolgimento della Fratellanza musulmana, sembra un nuovo asso nella manica lanciato dagli egiziani che dal canto loro nulla stanno facendo per fornire prove significative al team Ros, Sco e Interpol, da tre settimane al Cairo. Neppure i tabulati telefonici sono stati consegnati nelle mani degli inquirenti italiani, quindi ad un mese dalla scomparsa di Giulio non è possibile dire con certezza neppure dove sia stato prelevato, se sotto casa sua (a Doqqi) o nei pressi di piazza Tahrir.
Su questo punto finalmente è insorto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, che ha chiesto che gli inquirenti italiani abbiano «accesso a tutti i documenti sonori e filmati, ai referti medici e a tutti gli atti del processo nelle mani della procura di Giza».
È già passato un mese dalla scomparsa di Giulio Regeni del 25 gennaio scorso. Per ben sei giorni nessuno ha saputo che il giovane e brillante ricercatore friulano fosse sparito nel nulla. E da lì sono iniziati i ritardi di un caso tanto atroce quanto simbolico da aver imposto ogni tipo di depistaggio e intimidazione, fino al momento del ritrovamento del cadavere il 3 febbraio scorso.
Uccidendo e torturando Giulio Regeni è stato violato il taboo dell’inviolabilità del corpo degli stranieri in Egitto. E questo cambierà per sempre il rapporto che molti cittadini europei avranno con il regime militare di al-Sisi nei prossimi anni.
Non era forse necessariamente questo l’obiettivo dei poliziotti egiziani che hanno arrestato, ucciso e torturato Giulio. Ma di sicuro hanno colto nel segno. Ormai anche gli stranieri devono temere la Sicurezza di Stato come fanno gli egiziani.
È di pochi giorni fa la notizia di due giovani fratelli di nazionalità turca, Mucahit e Cihat Kirtoklu, di cui si sono perse le tracce al Cairo. In questo caso la loro scomparsa è stata immediatamente resa nota ai media. E questo potrebbe essere essenziale per evitare che i due finiscano nelle mani degli stessi carnefici di Giulio.
Ieri il giovane dottorando friulano è stato ricordando all’Università americana del Cairo (Auc) con letture di poesie di Ungaretti e Quasimodo.
Oggi alle 14 si svolgerà in via Salaria a Roma, alle porte dell’ambasciata egiziana in Italia, una piccola commemorazione silenziosa di Giulio, organizzata dall’Associazione Antigone. Anche la sorella di Giulio, Irene, ha voluto far sentire la sua voce chiedendo che vengano esposti gli striscioni gialli che chiedono «Verità per Giulio» come annunciato nella campagna lanciata da Amnesty International.
Si tenta in qualche modo di dare così un segnale alle autorità egiziane che i riflettori sulla vicenda in Italia non si sono spenti anche all’indomani della condanna dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo nel caso Abu Omar.
Dopo il ritrovamento del cadavere in un fosso della periferia della capitale egiziana, molti hanno avanzato sospetti di tentativi di complotto.
In realtà, secondo molti attivisti al Cairo, la prassi di liberarsi dei cadaveri torturati da parte della polizia egiziana è diventata una consuetudine. «In passato i corpi dei prigionieri venivano seppelliti negli stessi edifici della Sicurezza di Stato, ora vengono lasciati sul ciglio della strada», ci riferiscono ambienti della sinistra egiziana.
La repressione del dissenso al Cairo non si ferma. Nonostante le promesse di al-Sisi che aveva assicurato di voler intervenire per arginare gli attacchi indiscriminati della polizia alla gente comune, continuano gli episodi di repressione e arresti sommari.
Ieri l’attivista per la difesa dei diritti umani, Hossam Bahgat, è stato fermato all’aeroporto del Cairo e gli è stato impedito di lasciare il paese. Bahgat era diretto in Giordania per partecipare a un incontro delle Nazioni unite quando è stato fermato. Era in precedenza stato arrestato per le sue dichiarazioni critiche verso il regime.
Anche il giudice, Amir Awad, è stato arrestato dopo aver presentato un appello firmato da 31 giudici contro il prepensionamento di quattro toghe, accusate di essere vicine alla Fratellanza musulmana.
IL SUPPLIZIO DI GIULIO REGENI
AFFARE DI STATO PER L’EUROPA
di Jean-Pierre Filiu
Diplomazia. L’Italia mal ricompensata della comprensione di cui aveva dato pubblicamente prova dopo il colpo di stato di al-Sisi del 2013
L’inchiesta sulla tortura a morte di Giulio Regeni è arenata, come potevamo purtroppo aspettarci. Il ricercatore italiano di 28 anni è scomparso nel centro del Cairo, la sera del 25 gennaio 2016, quando i quartieri della capitale erano controllati palmo a palmo dalle forze di sicurezza, messe in allerta massima per il quinto anniversario delle rivolte anti-Mubarak. È ora certo che Regeni sia stato lungamente e meticolosamente torturato, prima che le sue spoglie fossero gettate in un fosso nella periferia del Cairo, dove il corpo è stato ritrovato il 3 febbraio.
Non c’è niente di peggio della solitudine di una vittima abbandonata ai suoi carnefici, ora dopo ora, giorno dopo giorno. Il
New York Times ha ricostruito delle testimonianze sull’arresto di Giulio Regeni da parte dei servizi egiziani e sulla sua detenzione nelle loro mani. Magdy Abdel Ghaffar, il ministro dell’Interno, ha indetto una conferenza stampa straordinaria per smentire categoricamente tutte queste accuse. È vero che lui stesso ha fatto tutta la sua carriera nella sinistra Sicurezza nazionale, precedentemente chiamata Sicurezza di Stato, verso la quale si orientano tutti i sospetti.
Più di quattro mila universitari di tutto il mondo hanno pubblicato una lettera aperta al presidente Abdel Fattah al-Sisi perché si faccia luce su questo dramma. Il portavoce del ministero degli Esteri egiziano ha subito reagito esprimendo il suo «rifiuto totale per le affermazioni contenute in questa lettera sugli arresti sommari, le torture e le sparizioni in Egitto». Ha aggiunto che queste affermazioni «deformano completamente la realtà sul campo e rappresentano delle generalizzazioni basate sul sentito dire e su manipolazioni di chi vuole riprendere piede in Egitto dopo essere stato cacciato dal popolo». Questa espressione era rivolta ai Fratelli musulmani, da cui proveniva il presidente Mohammed Morsi, rovesciato nel luglio 2013 dal generale al-Sisi.
Ho potuto misurare, durante un mio recente soggiorno al Cairo, quanto le teorie del complotto, già molto popolari in Egitto, abbiano preso, durante la presidenza al-Sisi, una dimensione aggressiva e anti-occidentale di una virulenza senza precedenti.
I Fratelli musulmani sono assimilati ai jihadisti di Daesh e stigmatizzati per lo stesso «terrorismo». Gli uni e gli altri parteciperebbero ad una vasta campagna internazionale di destabilizzazione dell’Egitto da parte di Servizi stranieri di informazione. In un clima così deleterio, non stupisce che una stampa agli ordini del regime abbia ripreso delle illazioni nauseabonde sui supposti legami tra Regeni con questo o quell’altro ufficio anglo-sassone (prima di ammettere la morte sotto tortura, le autorità avevano tentato in vano di accreditare la versione di un incidente automobilistico, poi di un crimine sessuale).
L’inchiesta sulla morte di Regeni è stata affidata a un ufficiale egiziano… condannato nel 2003 per tortura su un detenuto. L’impunità assoluta di cui gioiscono i servizi di «sicurezza» in Egitto si è tradotta in questi ultimi giorni in proscioglimenti scandalosi: è stata cancellata in appello, il 14 febbraio 2016, la condanna pronunciata contro i poliziotti che avevano ucciso con dei colpi di pistola una manifestante pacifica, Shaimaa el-Sabbagh, nel gennaio 2015, nel quarto anniversario dalle proteste anti-Mubarak. Il 17 febbraio, studenti e insegnanti dell’Università americana del Cairo (denominata con la sua sigla inglese Auc) hanno manifestato in memoria di Giulio Regeni ricordando come «la bolla dell’Auc non ci protegge».
L’Italia viene davvero mal ricompensata della comprensione di cui aveva dato pubblicamente prova dopo il colpo di Stato di al-Sisi del 2013. Il premier Matteo Renzi, accogliendo al-Sisi nel suo primo viaggio in Europa, nel novembre 2014, aveva celebrato il «partenariato strategico» tra Roma e il Cairo. Il supplizio di Giulio Regeni non dovrebbe preoccupare solo l’Italia, ma è una sfida per l’intera Europa, il cui silenzio è stato assordante dopo la rivelazione del dramma.
Quanto ai «realisti», che difendono la cooperazione più stretta possibile con i servizi egiziani nella lotta al terrorismo, e sono indulgenti verso gli «eccessi» di una tale lotta, guadagnerebbero molto se meditassero sulle lezioni del caso Regeni. La verità è che mezzo milione di militari egiziani confermano dopo anni di essere incapaci di ridurre una insurrezione jihadista nel Sinai che conta su poco più di mille combattenti. La realtà è che i servizi detti di «sicurezza» sono responsabili in Egitto di un’insicurezza generalizzata per l’impunità che è loro garantita. No, non dispiaccia ai «realisti», ma assolvere il regime di al-Sisi per i crimini perpetrati nel suo nome o nella sua ombra rivela una delle cecità più pericolose. Non possiamo che sostenere coloro i quali, come Thibaut Poirot su Le Monde, chiedono invece all’Europa di mobilitarsi perché venga fatta luce sulla verità nel caso della morte di Giulio Regeni. Da parte mia, dopo il minuto di silenzio che ha aperto la mia recente conferenza al Cairo, dedico ogni mio intervento pubblico, a Parigi, Montpellier, Le Hauvre o Saint-Malo, alla memoria del ricercatore suppliziato. Giustizia per Giulio.
L'autore è professore di Storia del Medio Oriente, Università Sciences-po Paris
 ». Anche questa vota la notizia viene dalla stampa internazionali.
». Anche questa vota la notizia viene dalla stampa internazionali.
Il manifesto, 24 febbraio 2016
Droni killer a Sigonella per bombardare le postazioni Isis in Nord Africa. La notizia, ancora una volta, arriva dall’altra parte dell’oceano. The Wall Street Journal, citando una fonte ufficiale delle forze armate Usa, ha rivelato che da circa un mese il governo italiano ha autorizzato il decollo di droni armati statunitensi dalla stazione aereonavale di Sigonella in Sicilia per effettuare «operazioni militari contro lo Stato islamico in Libia e attraverso il Nord Africa».
Sempre secondo il quotidiano, il via libera da parte del governo Renzi sarebbe giunto «dopo più di un anno di negoziati» e con una alcune limitazioni alle regole d’ingaggio. «Il permesso sarà dato dal governo italiano ogni volta caso per caso e i droni potranno decollare da Sigonella per proteggere il personale militare in pericolo durante le operazioni anti-Isis in Libia e in altre parti del Nord Africa», scrive il Wsj.
L’amministrazione Obama avrebbe tuttavia richiesto l’autorizzazione a operare dalla Sicilia anche per missioni offensive, dato «che sino al mese scorso i droni Usa schierati a Sigonella erano solo per scopi di sorveglianza».
Le autorità italiane hanno confermato le rivelazioni Usa ma la versione soft-difensiva sui velivoli senza pilota è assai poco credibile; inoltre è tutt’altro che vero che i droni-killer operino da Sigonella solo da un mese a questa parte. I sistemi di volo automatizzati in mano alle forze armate Usa sono i famigerati MQ-1 Predator e MQ-9 Reaper, armi letali da first strike, in grado d’individuare, inseguire ed eliminare gli obiettivi «nemici» grazie ai due missili aria-terra a guida laser AGM-114 «Helfire».
Questi droni sono stati impiegati negli ultimi dieci anni per più di 500 attacchi in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Siria, Yemen e Libia con oltre 4.200 vittime. L’ultimo strike con i droni-killler è stato effettuato la settimana scorsa contro un presunto «campo d’addestramento» delle milizie filo-Isis a Sabratha, in Tripolitania, vicino al confine con la Tunisia.
Secondo Washington, il raid avrebbe causato la morte di una trentina di jihadisti tra cui il tunisino Noureddine Chouchane, ritenuto uno dei responsabili degli attentati effettuati lo scorso anno al Museo del Bardo e sulla spiaggia di Sousse. Il campo di Sabratha (ad una ventina di chilometri dal terminal gas di Melitha gestito dall’Eni) è stato colpito da missili aria-terra lanciati da alcuni bombardieri Usa decollati dalla Gran Bretagna e da Predator o Reaper presumibilmente di stanza proprio a Sigonella, come riferito da alcuni organi di stampa internazionali.
I Predator Usa erano stati impiegati da Sigonella per le operazioni di guerra in Libia nella primavera-estate 2011. Un rapporto dell’International Institute for Strategic Studies di Londra sulle unità alleate impegnate nell’operazione «Unified Protector», aveva documentato come a partire della metà dell’aprile 2011 due squadroni dell’Us Air Force con droni-killer erano stati trasferiti nella base siciliana. I primi raid furono effettuati il 23 aprile contro una batteria di missili libici nei pressi del porto di Misurata; un secondo raid fu sferrato invece a Tripoli il giorno seguente contro un sistema anti-aereo «SA-8».
Da allora l’uso della base di Sigonella come piattaforma di lancio dei droni Usa non ha conosciuto interruzioni e le operazioni sono state estese a tutta l’Africa sub-sahariana, alla Somalia, allo Yemen e più recentemente anche alla Siria.
Nel maggio 2013, l’Osservatorio di Politica Internazionale, un progetto di collaborazione tra il CeSI (Centro Studi Internazionali), il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e il Ministero degli Affari Esteri, pubblicò uno studio sui velivoli senza pilota statunitensi a Sigonella in cui si documentò la presenza di «non meno di sei Predator Usa da ricognizione e attacco». «I droni temporaneamente basati a Sigonella hanno fondamentalmente lo scopo di permettere alle autorità americane il dispiegamento di questi determinati dispositivi qualora si presentassero delle situazioni di crisi nell’area nordafricana e del Sahel», scriveva l’Osservatorio.
«Ai tumulti della Primavera Araba che hanno portato alla caduta dei regimi di Tunisia, Egitto e Libia ha fatto seguito un deterioramento della situazione di sicurezza culminato nel sanguinoso attacco al consolato di Bengasi e nella recente crisi in Mali, dove la Francia ha lanciato l’Operazione Serval. In considerazione di tale situazione, la Difesa Italiana ha concesso un’autorizzazione temporanea allo schieramento di ulteriori assetti americani a Sigonella».
Anche allora si tentò comunque di edulcorare la pillola dei droni-killer con il Parlamento e l’opinione pubblica. «Concedendo le autorizzazioni, le autorità italiane hanno fissato precisi limiti e vincoli alle missioni di queste specifiche piattaforme», aggiungeva il rapporto. «Ogni operazione che abbia origine dal territorio italiano dovrà essere condotta come stabilito dagli accordi bilaterali in vigore e nei termini approvati nelle comunicazioni 135/11/4a Sez. del 15 settembre 2012 e 135/10063 del 17 gennaio 2013».
Nello specifico, si potevano autorizzare solo le sortite di volo volte all’«evacuazione di personale civile, e più in generale non combattente, da zone di guerra e operazioni di recupero di ostaggi» e quelle di «supporto» al governo del Mali «secondo quanto previsto nella Risoluzione n. 2085 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite». Le forze armate Usa sarebbero state tenute ad informare le autorità italiane prima dell’effettuazione di qualsiasi attività. Mistero fitto però sul modo in cui si potrà mai impedire a Washington di utilizzare Sigonella per operazioni contrarie alla Costituzione o agli interessi strategici nazionali.

«Libia, sfuma il piano Onu pronto l’intervento l’Italia prepara la missione servono 5mila soldati» già, 300 kmq di deserto a soldato. Uno stuzzichino, tanto per cominciare. La Repubblica, 24 febbraio 2016
NELLA STESSA giornata in cui Italia e Stati Uniti si confrontano sullo spionaggio del governo di Silvio Berlusconi, ponendo la questione di principio sul rispetto della sovranità nazionale, i due paesi cercano insieme una difficile intesa sul modo di affrontare la più grave minaccia terrorista mai sorta nel Mediterraneo: il radicamento del Califfato in Libia.
Il tempo per la diplomazia si sta rapidamente consumando. Anche ieri il parlamento di Tobruk ha rinviato il voto sull’esecutivo unitario nato dalla mediazione delle Nazioni Unite e ormai nelle capitali occidentali si spegne la fiducia nel successo dell’iniziativa benedetta dall’Onu. Così Washington, Roma, Parigi e Londra stanno lavorando freneticamente a una soluzione alternativa, un piano B con un solo punto certo: l’espansione del feudo jihadista in Libia va fermata, anche a costo di rassegnarsi a una divisione sostanziale del paese. Brett McGurk, l’uomo a cui Barack Obama ha affidato la lotta contro lo Stato Islamico, è tornato a sottolineare la preoccupazione della Casa Bianca. Gli americani non sono disposti ad assistere alla crescita delle brigate libiche con la bandiera nera, che «tentano di attrarre quanti più combattenti stranieri» dal Maghreb e dall’Africa centrale. Per niente intimoriti dal bombardamento statunitense della scorsa settimana, i miliziani islamici hanno attaccato di nuovo le installazioni petrolifere distruggendo due grandi depositi di greggio a Sida. L’obiettivo di queste incursioni è chiaro: azzerare l’unica risorsa che finanzia le istituzioni libiche rivali e le formazioni locali che si oppongono al Daesh. La premessa per costruire il caos totale e imporre il dominio del Califfato.
Così gli alleati europei si stanno allineando alla nuova posizione della Casa Bianca: «Agiremo ogni volta che verrà individuata una minaccia diretta». Una dichiarazione che in pratica permette di attaccare qualunque base dell’Is. E alla quale per la prima volta sembra avvicinarsi anche Matteo Renzi, che ieri ha detto «se ci sono iniziative contro terroristi e potenziali attentatori dell’Is, l’Italia farà la sua parte insieme con gli alleati ».
Dal punto di vista militare, la macchina dei raid è già in azione. C’è una ricognizione aerea continua, condotta dai droni americani e italiani che decollano da Sigonella; da quelli francesi che perlustrano l’area desertica del Fezzan e da quelli britannici che partono da Cipro. Altri velivoli spia, inclusi i nostri Amx schierati a Trapani, scattano foto e monitorano le comunicazioni radio grazie ad apparati a lungo raggio, che gli permettono di restare fuori dallo spazio aereo libico. Una sorveglianza che avrebbe permesso di selezionare circa duecento potenziali bersagli.
Ma l’Italia al momento resta ancorata alla sua posizione iniziale: non è disposta a partecipare ad azioni su larga scala senza una cornice legale, ossia la richiesta di un governo riconosciuto a livello internazionale. E senza i nostri aeroporti, non è possibile una campagna aerea su vasta scala. La scorsa settimana, gli F-15 statunitensi che hanno raso al suolo il comando di Sabratha sono decollati dalla Gran Bretagna: una missione che richiede almeno sei rifornimenti in volo di carburante per arrivare sull’obiettivo e tornare indietro. Per questo il Pentagono ha dovuto accettare il diritto di veto della Difesa italiana pur di utilizzare la pista di Sigonella per i pattugliamenti dei droni armati durante i raid delle forze speciali. I blitz di Navy Seal e Delta Force richiedono una sorta di scorta volante, pronta a proteggere la ritirata, che può partire solo dalla Sicilia. In questo modo, però, il nostro governo avrà la certezza di essere informato di ogni attacco condotto dagli incursori statunitensi e potrà pronunciarsi sui bersagli da colpi- re o meno. L’unica garanzia per evitare di venire spiazzati dall’iniziativa di altre nazioni, come accadde nel 2011 con l’operazione franco-britannica contro Gheddafi.
Ma nessuno si illude: una manciata di bombardamenti e colpi di mano isolati non riuscirà a fermare la crescita del Califfato. Per sconfiggerlo servono truppe di terra: soldati libici con un sostegno occidentale. E bisogna trovare un governo riconosciuto che legittimi questo “sostegno”. Ed ecco materializzarsi il “piano B”: l’ipotesi che sta rapidamente prendendo piede tra Roma e Washington è quella di abbandonare il parlamento di Tobruk e l’armata del generale Haftar — che stanno soffocando anche il secondo tentativo dell’Onu — per puntare sull’altra compagine, quella di Tripoli. Al momento è una sorta di “ultima minaccia”, per cercare di sbloccare le resistenze di Tobruk ma potrebbe trasformarsi in fretta in un’opzione concreta. Con un ribaltamento di fronti: mentre a Tripoli il potere è in mano a formazioni islamiche più o meno moderate, il governo rivale aveva ispirazione laica e supporto occidentale. E con la prospettiva di dividere il paese in tre entità principali, che ricalcano l’antica organizzazione amministrativa ottomana: Tripolitania, Cirenaica e Fezzan. Una soluzione che potrebbe placare anche le potenze regionali, come Egitto, Turchia, Qatar ed Emirati.
Nella storica capitale verrebbero concentrati gli sforzi per debellare lo Stato islamico. Mobilitando le altre milizie più combattive, come lo schieramento di Misurata. E schierando in Tripolitania un contingente occidentale che contribuisca a difendere le infrastrutture chiave per la sicurezza e la ripresa economica: porti, aeroporti, oleodotti, terminal petroliferi. Una missione rischiosa, che verrebbe affidata all’Italia: il piano elaborato da oltre un anno che prevede «fino a cinquemila soldati». Se ne è parlato tante volte, ma adesso la macchina militare e diplomatica sta accelerando. Perché lo Stato islamico avanza ogni giorno: ieri sera ci sono stati combattimenti proprio alle porte di Tripoli.
 «Sinistra. L’ottimismo e la fiducia per il leader del Pd. Scetticismo e recriminazioni per Cosmopolitica. Ma appena inizia l’assemblea della sinistra l’umore cambia verso».
«Sinistra. L’ottimismo e la fiducia per il leader del Pd. Scetticismo e recriminazioni per Cosmopolitica. Ma appena inizia l’assemblea della sinistra l’umore cambia verso».
Il manifesto, 23 febbraio 2016
Renzi abbaia all’Europa per farci girare dall’altra parte e distrarci dai problemi irrisolti del nostro paese. Questo è abbastanza chiaro a tutti. Ma come mai raccoglie ancora il consenso di un terzo degli italiani ed addirittura registra qualche miglioramento? Oltre al neopopulismo renziano di cui si è parlato, c’è un altro fattore che non va trascurato: il consenso reale di cui Renzi gode nel paese. Questo consenso poggia intanto su un fattore storico: l’effetto trascinamento dell’elettorato proveniente dall’eredità di sinistra che sentiva fortemente il bisogno di accedere al governo nazionale da cui era stato escluso per decenni e che egli soddisfa.
Ma oltre a questo c’è il mondo social che interviene a sostegno. Per limitarci a Facebook esistono una varietà di gruppi di supporter di Renzi: Italiani con Renzi, gruppo dedicato a coloro che credono in Matteo Renzi; Italiani in Polonia con Renzi, Amici lucani insieme con M. E. Boschi; Matteo Renzi il futuro è solo l’inizio; Per M. Renzi insieme, ed altri ancora.
Si tratta di decine di migliaia di partecipanti che sono portatori del messaggio renziano.
Che rimbrottano chi protesta per le statue coperte dicendo che «parlando di questo si fanno passare in secondo piano i miliardi che arrivano e che creeranno posti di lavoro»; che si vittimizzano perché «tutti attaccano Renzi» e si consolano perché «questo dimostra il suo grande potere e questo giustifica tanti nemici»; che tifano «Renzi e vai.…l’Italia sta proprio prendendo il volo!»; che minacciano «volete riportarci all’immobilismo.…non ci provate»; che non sono ancora contenti della svolta di Repubblica: «bene Calabresi, ma ancora poco perché nel tono degli articoli prevale ancora la linea livorosa di Scalfari e Mauro»; non abbastanza soddisfatti nemmeno della Gruber perché ospita Scanzi e Travaglio; per non parlare della crociata antifannulloni: «era ora di un bel repulisti!!»; o dello squallido post con una M.E.Boschi in ampio décolleté e un commento che più maschilista non si può: «rosicate, rosicate..gufi e corvi!».
Naturalmente talvolta esagerano e ricevono questo post: scusatemi siete stati gentili ad inserirmi in questo gruppo, ma purtroppo non ho alcun interesse per il partito della nazione, anzi contatemi tra gli avversari non violenti, ma decisi. Succede, per eccesso di euforia, ai neofiti di esagerare.
Questi agit prop di nuova generazione sono la vera la base attiva del Pd di oggi.
Naturalmente vi sono anche quelli che non condividono, ma subiscono e quelli che si sono allontanati. Ma in un partito sempre più rinsecchito di circoli ed iscritti questo è il corpo vero del partito e la relazione affidata a tweet e social è il vero canale di comunicazione democratica. E’ la combinazione di questa componente con quelle prima descritte la vera chiave del successo renziano, malgrado tutto.
Ma se questo è lo scenario come vi si colloca la sinistra? Una carrellata parallela negli ambienti social frequentati dalla sinistra ci mostra una realtà ben diversa da quella prima descritta: sostanzialmente inesistenti post e commenti ottimisti o entusiasti.
Amarezza, contrapposizione, critiche su tutto, astio, processi al passato ed alle intenzioni, ferite recenti e lontane visibili, sono i tratti più diffusi. La comunità di sinistra somiglia ad una massa di persone che si aggira tra le macerie di un terremoto e che guardano con invidia chi ha subito meno danni, che si rinfacciano l’un l’altro le responsabilità dell’accaduto, perché c’era chi aveva previsto tutto e non è stato ascoltato e così via.
Quasi nessuno parla di proposte e cose da fare, quasi tutti di schieramenti, il nemico è sempre il vicino, nessuno guarda avanti e trascina gli altri verso un progetto di ricostruzione.
Emerge, insomma, una sinistra che non ha ancora elaborato il lutto delle vecchie sconfitte e divisioni e che guarda con sospetto e sfiducia ogni tentativo.
«Il nuovo partito sarà l’ufficio di collocamento dei sinistri che vogliono tenere il culo al caldo su una poltroncina gentilmente offerta dal Pd». «Cosmopolitica, una iniziativa totalmente preconfezionata: sabato andrò a scuola di mazurca»; «Una iniziativa veramente pessima: andate a quel paese!»; «Si debbono rimuovere gli errori commessi!», (intendendo naturalmente sempre gli errori degli altri).
Tutto questo fino a pochi giorni fa. Ma con Cosmopolitica qualcosa sembra poter cambiare. E, ad evento ancora in corso, cominciano a circolare post di tutt’altro segno: «Ci siamo! Dobbiamo svegliare questo paese addormentato», «Spero che i giovani riescano a prendere in mano il loro futuro». Fino ai cori da stadio: «Daje!», «E SIiiiii! Grande!!»; «Avanti compagni, diciamo SI!».
L’iniziativa dell’Eur, gestita bene dai giovani — i cosmopolitani sono stati i veri protagonisti organizzativi e politici — sembra segnare una inversione fino ad elevarsi in un: «Domenica sarebbe bello se potessimo dire: la sinistra è bellissima, senza frontiere e senza confini. Ovviamente potrà farlo chi ha il coraggio di mollare la terra ed assaltare il cielo. Buona cosmoavventura!».
Uno scatto di fiducia e speranza improvviso e nuovo. Una bella scommessa ed una enorme responsabilità per chi dovrà facilitare il processo. E, se così è, questa volta non si potrà certo sbagliare.
Mentre al di là dell'Atlantico, «i giudici americani hanno affermato il loro dovere di sottrarre i diritti fondamentali alle vicissitudini della politica», nella palude italiana si cancellano, per bieche ragioni di sopravvivenza di un premier illegittimo sostenuto da un parlamento incostituzionale, diritti già presenti nel nostro ordinamento giuridico. La Repubblica, 23 febbraio 2016,
.
La discussione sulle unioni civili avrebbe bisogno di limpidezza e di rispetto reciproco, invece d’essere posseduta da convenienze politiche, forzature ideologiche, intolleranze religiose. Di fronte a noi è una grande questione di eguaglianza, di rispetto delle persone e dei loro diritti fondamentali, che non merita d’essere sbrigativamente declassata, perché altre urgenze premono. I diritti, dovremmo ormai averlo appreso, sono indivisibili, e quelli civili non sono un lusso, perché riguardano libertà e dignità di ognuno.
Bisogna liberarsi dai continui depistaggi. La maternità surrogata, vietata fin dal 2004, viene evocata per opporsi all’adozione dei figli del partner, penalizzando proprio quei bambini che si dice di voler tutelare e tornando così a quella penalizzazione dei figli nati fuori dal matrimonio eliminata dalla civile riforma del diritto di famiglia del 1975. E si dovrebbe ricordare che la Costituzione parla della famiglia come società “naturale” non per evitare qualsiasi accostamento alle unioni tra persone dello stesso sesso, ma per impedire interferenze da parte dello Stato in «una delle formazioni sociali alle quali la persona umana dà liberamente vita», come disse Aldo Moro all’Assemblea costituente. Altrimenti ricompare la stigmatizzazione dell’omosessualità, degli atti “contro natura”.
L’impegno significativo del presidente del Consiglio per arrivare ad una disciplina delle unioni civili rispettosa di quello che la Corte costituzionale ha definito come un diritto fondamentale a vivere liberamente la condizione di coppia, si è via via impigliato nel prevalere delle preoccupazioni legate alla tenuta della maggioranza. Il riconoscimento effettivo di diritti fondamentali viene così subordinato ad una esigenza propriamente politica che sta svuotando la portata della nuova legge. E non si può dire che si cerchi di procedere con la cautela necessaria, data la delicatezza dell’argomento, perché la cautela si è trasformata nel progressivo abbandono di una linea rigorosa, nel gioco delle concessioni verbali che tuttavia inquinano il senso della legge in punti significativi.
È indispensabile riprendere una strada coerente con il fatto che si sta discutendo di dignità e identità delle persone, dunque di una materia dove non tutto è negoziabile. Il legislatore sta oscillando tra concessioni improprie e irrigidimenti ingiustificati. Una assai discutibile e discussa sentenza del 2010 della Corte costituzionale viene eretta a baluardo inespugnabile, che non consentirebbe neppure di adempiere a quel dovere positivo di riconoscimento pieno dei diritti delle coppie tra persone dello stesso sesso imposto all’Italia da una sentenza di condanna del 2015 della Corte europea dei diritti dell’uomo. Per sfuggire a questa responsabilità, più si va avanti più si delinea una situazione in cui il legislatore sta costruendo una sua gradita impotenza.
Non posso intervenire perché avrei bisogno di una legge costituzionale. Non posso intervenire perché devo ancora considerare il codice civile come un riferimento ineludibile. Non posso muovermi nel nuovo contesto costruito dai principi e dalle regole europee. Non posso intervenire perché l’opportunità politica variamente mascherata me lo preclude.
Nessuno di questi argomenti regge. Nel 2013 la Corte di Cassazione ha detto esplicitamente che le scelte in questa materie sono affidate al legislatore ordinario. Ricostruire il principio di riferimento nel fatto che il codice civile parla ancora di diversità di sesso nel matrimonio è un errore di grammatica giuridica perché si dimentica che la Costituzione si pone in una posizione gerarchicamente superiore al codice civile e bisogna interpretare la Costituzione partendo dal principio di eguaglianza. Proprio la forza di questo principio ha determinato un radicale cambiamento del sistema istituzionale europeo. La Carta dei diritti fondamentali ha cancellato il requisito della diversità di sesso sia per il matrimonio, sia per ogni altra forma di costituzione della famiglia, e ha ribadito con forza che non sono ammesse discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale. Se si guarda più a fondo nel nostro sistema, neppure l’accesso al matrimonio egualitario sarebbe precluso al legislatore ordinario.
In questo nuovo mondo, che pure le appartiene e nel quale ha liberamente deciso di stare, l’Italia è recalcitrante ad entrare. E così conferma un ritardo culturale, che in altri tempi aveva vittoriosamente sconfitto, anche in occasioni difficili come quelle dell’approvazione delle leggi sul divorzio e dell’aborto, senza restare prigioniera delle preoccupazioni della Chiesa, che oggi tornano in maniera inquietante e inattesa.
Di nuovo lo sguardo si fa ristretto, la riflessione culturale si rattrappisce e non si riesce a dare il giusto rilievo al fatto, sottolineato con forza dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ormai la maggioranza dei Paesi del Consiglio d’Europa riconosce le unioni civili e che aumentano continuamente gli Stati dov’è riconosciuto il matrimonio tra persone dello stesso sesso - Francia, Spagna, Portogallo, Stati Uniti, Danimarca, Inghilterra, Irlanda, Svezia, Norvegia, Svizzera, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, Argentina, Brasile, Uruguay, Sudafrica. Strada che questi Paesi non percorrono con avventatezza, ma riflettendo con serietà, e che dovrebbero essere un riferimento per sfuggire alla superficialità con la quale troppo spesso in Italia si affrontano questioni serie come quelle riguardanti le adozioni coparentali (stepchild adoption).
Tema, questo, che trascura del tutto le dinamiche degli affetti, la genitorialità come costruzione sociale e che, a giudicare da alcuni improvvidi emendamenti al disegno di legge in discussione al Senato, rischia di lasciare bambine e bambini in un avvilente limbo, che di nuovo nega dignità ed eguaglianza.
Ancora e sempre l’eguaglianza, che la Corte costituzionale non ha adeguatamente considerato in quella sentenza del 2010, la cui interpretazione dovrebbe essere seriamente riconsiderata a partire dal nuovo contesto istituzionale europeo. Perché no? Ricordiamo che, con una violazione clamorosa del principio di eguaglianza, nel 1961 la Corte costituzionale dichiarò legittima la discriminazione tra moglie e marito in materia di adulterio. La Corte si ravvide nel 1968, mostrando che l’eguaglianza e la vita non possono essere consegnate alla fissità di una decisione.
Un legislatore, che sta costruendo la sua impotenza, dovrebbe piuttosto riflettere sulla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che, nel 2015, ha ammesso il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Ferma restando la legittima manifestazione di ogni opinione, i giudici americani hanno affermato il loro dovere di sottrarre i diritti fondamentali alle «vicissitudini della politica».

LIBIA, L'ITALIA DICE SÌ ALL'AMERICA,
“DRONI AMATI USA DA SIGONELLA”
di Giampaolo Cadalanu
L’Italia ha concesso le piste di Sigonella ai droni armati americani diretti in Libia, nel nord Africa e in genere contro Daesh, il sedicente Stato Islamico: è un nuovo passo del crescente impegno militare sulle sponde del Mediterraneo, in attesa del possibile intervento di terra. Si tratta con ogni evidenza dei Predator B, ribattezzati non a caso “Reaper”, mietitori, che il Pentagono già utilizza ampiamente per “esecuzioni mirate” in Pakistan, Yemen e Somalia. Non sono invece dotati di armamento i droni da ricognizione Global Hawk, che gli Usa schierano a Sigonella già dal 2011.
Alla Difesa sottolineano che non si tratta di un “via libera” indiscriminato: dalla base siciliana i velivoli a pilotaggio remoto partono esclusivamente per compiti di protezione degli “operatori impiegati nella lotta al terrorismo”, e solo dopo una autorizzazione del governo che viene concessa volta per volta. In altre parole, al governo italiano viene di fatto concesso un potere di “veto” sui bersagli oggetto dei raid e quindi sulle operazioni con le forze speciali, che potranno essere seguite anche dai droni italiani da ricognizione. È una situazione molto diversa rispetto al 2011, quando le “minacce” dell’aeronautica francese contro le installazioni dell’Eni spinsero l’Italia a superare le esitazioni per partecipare alle operazioni contro Gheddafi. Le missioni dei Reaper serviranno a sostenere le operazioni più o meno clandestine delle forze speciali americane, britanniche, francesi e italiane. Nei fatti è la prima conferma concreta della presenza delle avanguardie militari occidentali sul territorio libico.
La notizia è comparsa ieri sul sito del Wall Street Journal, che cita come fonte funzionari del Pentagono e precisa che la decisione è stata presa già il mese scorso, “silenziosamente”. Quest’ultimo termine, “quietly”, compare persino nel titolo del giornale americano, il quale sottolinea che gli Usa incontrano serie difficoltà nel convincere gli alleati a impegnarsi nella lotta a Daesh. Secondo il Wsj, il governo americano sta facendo pressioni perché Roma autorizzi l’uso delle sue basi per operazioni come l’attacco di venerdì scorso su Sabratha, che aveva per obiettivo Noureddine Chouchane, il leader jihadista considerato responsabile dell’assalto al museo del Bardo, a Tunisi, il 18 marzo scorso. Ma il governo italiano non sembra disponibile a questo passo. Anonimi “funzionari italiani” citati dal quotidiano sottolineano in privato che una decisione come questa riaccenderebbe l’opposizione interna, specialmente in caso di perdite fra i civili.
Dopo mesi di incertezze, l’amministrazione Obama sta aumentando il suo impegno in Libia, pur nella certezza che il centro della battaglia contro Daesh, il sedicente Stato Islamico, resta fra Siria e Iraq. Il Pentagono vorrebbe anche una base in nord Africa, perché Sigonella non è considerata l’ideale: è molto vicina al teatro delle operazioni, ma le condizioni del tempo spesso impediscono il decollo dei droni. Un’altra base sarebbe necessaria soprattutto per le operazioni di sorveglianza, ma finora le nazioni del nord Africa hanno risposto negativamente. L’uso di basi lontane, a partire da quella di Gibuti, già impegnata per le operazioni in Somalia e Yemen, comporta voli più lunghi, minore autonomia e dunque inferiori capacità di controllo, visto che i droni da sorveglianza devono essere riforniti e controllati regolarmente.
Lo scarso entusiasmo dei Paesi africani di fronte alle richieste della Casa Bianca non permette grande ottimismo nemmeno sul prossimo intervento in Libia, prima con l’allargamento dell’operazione navale europea Eunavfor Med nelle acque territoriali libiche, poi con la presenza diretta sul terreno di truppe occidentali. Questa fase dovrebbe essere legata alla richiesta di un governo libico riconosciuto: oggi il Parlamento di Tobruk dovrebbe votare sul gabinetto formato da Fayez al Serraj, ma l’accordo politico ancora non c’è, e difficilmente verrà raggiunto a breve termine. In più, nei mesi scorsi Tobruk non è apparsa accondiscendente con l’Occidente: ha contestato presunte violazioni italiane delle acque territoriali libiche, e nei giorni scorsi Serraj ha condannato - almeno ufficialmente anche il raid Usa su Sabratha. Se l’invito libico tarderà ad arrivare, mentre Daesh continua a rafforzarsi in Libia, l’unica via percorribile per far partire l’intervento sarebbe cercare all’Onu un accordo non facile per una risoluzione del Consiglio di Sicurezza.
Ma non è escluso che i velivoli possano essere impegnati anche in altri teatri di operazione
LO STIVALE È UNA POSTAZIONE STRATEGICA
di Giuseppe Cucchi
Le basi americane in Italia, il cui comando rimane sempre in mani italiane , sono concesse per scopi concordati in sede Nato. Ogni volta che gli Usa desiderano utilizzarle per motivi non previsti dall’Alleanza Atlantica, sono obbligati a chiedere un’autorizzazione italiana, che deve essere esplicita e può essere rifiutata in presenza di forti motivi ostativi. Caso limite fu quello del 1986 proprio a Sigonella, dove l’intervento italiano dovette assumere forme particolarmente decise per reprimere una violazione statunitense della sovranità italiana considerata pericolosa per la nostra sicurezza. Il nostro territorio è una base indispensabile per chi voglia operare in Nord Africa , Medio Oriente o Balcani.
Se ne era già reso conto Mussolini, che definì l’Italia «Una grande portaerei ancorata nel Mediterraneo». In tempi successivi la dislocazione geografica ci ha dato una “rendita di posizione“, che ci costringeva ad accogliere truppe straniere sul nostro territorio consentendoci nel contempo di risparmiare sulle spese di difesa. Anche dopo la caduta del Muro di Berlino la nostra dislocazione geografica continua a essere un atout prezioso per una Nato che si confronta con due archi di instabilità , l’uno ad est e l’altro a sud. Ed è nelle nostre regioni adriatiche che le forze aeronavali dell’Alleanza si schierarono per fronteggiare i dieci anni di caos jugoslavo. Basi aeree e porti dell’Italia meridionale furono indispensabili per la campagna contro Gheddafi. Ruolo che sembrano destinati a riassumere ora , nella prospettiva della possibile apertura di una nuova fase della crisi libica.
 «La Corte europea dei diritti umani condanna lo stato italiano per il rapimento e la detenzione illegale dell'ex imam Abu Omar. Come fa oggi il governo italiano a chiedere all'Egitto quella "chiarezza che noi invece non abbiamo avuto"?». Articoli di Luca Fazio e Antonio Marchesi,
«La Corte europea dei diritti umani condanna lo stato italiano per il rapimento e la detenzione illegale dell'ex imam Abu Omar. Come fa oggi il governo italiano a chiedere all'Egitto quella "chiarezza che noi invece non abbiamo avuto"?». Articoli di Luca Fazio e Antonio Marchesi,
il manifesto, 24 febbraio 2016 (m.p.r.)
CASO ABU OMAR
STRASBURGO CONDANNA L'ITALIA
di Luca Fazio
La sentenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo è pesantissima, circostanziata e senza appello e condanna l’Italia per il rapimento e la detenzione illegale dell’ex imam Abu Omar (fu prelevato da un commando della Cia il 17 febbraio 2003, a Milano, davanti alla moschea di viale Jenner e poi trasferito in Egitto dove venne torturato). Secondo la Corte, l’Italia, applicando in modo improprio il segreto di stato - tra il 2005 e il 2013 lo hanno fatto i governi Prodi, Berlusconi, Monti e Letta - ha violato alcuni principi fondamentali della Convenzione europea per i diritti umani. In particolare, la proibizione di trattamenti disumani e degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto a ricorrere alla giustizia e il diritto al rispetto della vita familiare. I giudici di Strasburgo hanno anche stabilito che l’Italia deve risarcire Abu Omar con 70 mila euro e sua moglie con altri 15 mila euro per “danni morali” (risarcimento beffardo, secondo l’avvocato dell’ex imam). La sentenza diventerà definitiva a maggio se lo stato italiano non otterrà un riesame dalla Corte di Strasburgo. La condanna, ovviamente, chiama in causa anche questo governo e il nuovo presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Nella condanna, infatti, si fa riferimento anche alla grazia che due presidenti della Repubblica (Napolitano e appunto Mattarella) hanno accordato a tre agenti americani condannati per l’operazione di extraordinary rendition di Abu Omar: secondo i giudici nessun essere umano può essere sottoposto a tortura e maltrattamenti a causa “dell’impunità derivante dall’atteggiamento dell’esecutivo e del presidente della Repubblica”. I tre atti di clemenza sono stati concessi nell’aprile 2013 al colonello Joseph Romano (capo della base di Aviano da dove partì l’aereo con a bordo Abu Omar) e lo scorso 23 dicembre al capo della Cia di stanza a Milano - Robert Seldon Lady - e all’agente Betnie Medero. Quasi inutile aggiungere che i tre non sono mai stati arrestati e continuano a vivere da liberi cittadini negli Stati Uniti d’America. C’è voluta la Corte europea per ricordare che “in materia di tortura e maltrattamenti da agenti dello Stato l’azione penale non può esaurirsi per effetto della prescrizione, e che l’amnistia e la grazia non devono essere tollerati in questi casi”.
Claudio Fava, vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, chiama in causa il presidente del Consiglio Matteo «La sentenza sul rapimento di Abu Omar - spiega - conferma quello che denunciamo da anni: l’uso strumentale, illegittimo e improprio del segreto di stato su questa vicenda, una illegittimità sulla quale si sono impegnati tutti i governi in carica negli ultimi dodici anni, nessuno escluso. A questo punto chiediamo che Renzi venga a riferire in parlamento per dire come pensa di rivedere l’uso improprio del segreto di stato. Il segreto va immediatamente rimosso da tutti gli atti che riguardano questa vicenda».
La Corte di Strasburgo, tra le altre cose, ha anche riconosciuto il puntuale lavoro di inchiesta svolto dalla procura di Milano che per anni è stata ostacolata dalle più alte cariche dello stato. La “soddisfazione personale” però non compensa la “grande amarezza” di Ferdinando Pomarici, il pm di Milano che con Armando Spataro condusse le indagini sul caso. Le sue considerazioni sono pesanti: «Noi, che siamo la culla del diritto, ci troviamo schiaffeggiati brutalmente. E’ dovuta arrivare la Corte di Strasburgo a riprenderci col righello per dirci: bambino queste cose non si fanno. Io e Armando abbiamo sopportato in silenzio trattamenti difficilmente sopportabili, noi, che abbiamo fatto della lotta al terrorismo metà della nostra attività professionale, siamo stati accusati dai politici di aver protetto un terrorista». Pomarici azzarda un parallelo doloroso: «E’ un discorso ancora più amaro oggi, pretendiamo dal governo egiziano per la morte di Giulio Regeni di avere quella chiarezza che noi invece non abbiamo avuto. Mi aspetterei che il governo, se vuole essere autorevole agli occhi di Al Sisi, faccia luce ed elimini il segreto di stato». Spataro, oggi procuratore capo a Torino, aggiunge una semplice lezione, e cioè che «le democrazie devono assicurare a tutti gli imputati, anche ai presunti terroristi, la possibilità di piena difesa e dunque il rispetto dei loro diritti».
Per il presidente dell’Associazione Antigone, Patrizio Gonnella, questa sentenza dovrebbe spingere l’Italia a riconoscere il delitto di tortura. «La tortura - aggiunge - è un crimine contro l’umanità e lo stato non può rimanere indifferente o, in alcuni casi come quello oggetto della pronuncia di Strasburgo, rendersi complice di governi torturatori». Come l’Egitto.
ABU OMAR, UN'ITALIA D'EGITTO
di Antonio Marchesi
Extraordinary Rendition. I persecutori di un rifugiato politico
L’Italia ha collezionato un’altra - l’ennesima - condanna per violazione dell’art.3 della Convenzione europea dei diritti umani, che vieta la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Questa volta si tratta dell’annosa vicenda di Abu Omar, che le nostre autorità avrebbero senz’altro preferito chiudere senza questo fastidioso epilogo strasburghese. I fatti sono questi. Un cittadino egiziano, rifugiato politico, in Italia dal 1998, il 17 febbraio 2003 viene caricato su un furgone in una strada di Milano e trasferito nella base militare di Aviano. Da lì, passando per Ramstein, in Germania, viene portato al Cairo e consegnato alle autorità del suo paese. Rimane in carcere, con un breve intervallo di libertà, fino al 2007. Viene sottoposto ripetutamente a tortura - una pratica diffusa allora, in Egitto, così come lo è oggi (come gli Italiani hanno scoperto attraverso la triste storia di Giulio Regeni).
In Italia le indagini, avviate tempestivamente, si concludono con la richiesta di arrestare un cospicuo numero di cittadini americani, tutti operativi Cia, i quali, però, nel frattempo hanno lasciato il paese. Il Ministro della Giustizia decide di non chiederne l’estradizione. Quanto ai cittadini italiani coinvolti nell’indagine, sono agenti e alti funzionari del Sismi. Il Presidente del Consiglio decide di non togliere il segreto di stato sui documenti richiesti dalla procura e la Corte costituzionale conferma che imporre il segreto di stato rientra nei poteri discrezionali, non soggetti a controllo, del governo. Non si riesce quindi a condannarli. Gli americani (compreso un militare di stanza ad Aviano), invece sì, sono condannati a pene oscillanti tra i 6 e i 9 anni … che, però, non sconteranno. Dormono da tempo sonni tranquilli altrove. E neppure verseranno la cifra a cui vengono condannati a titolo di risarcimento dei danni. In breve: né i membri dei servizi segreti americani né quelli dei servizi italiani, per un motivo o per l’altro, vengono puniti.
Anche se hanno partecipato o reso possibile una «extraordinary rendition», un rapimento a scopo di tortura (sia pure «esternalizzata» in Egitto). La condanna di oggi è per violazione di tutta una serie di diritti, sia di Abu Omar sia della moglie.
La parte più significativa della condanna è però, ancora una volta, quella per la violazione dell’art.3. Una violazione sia «sostanziale» (per il contributo alla
rendition) che «procedurale» (per la mancata punizione dei responsabili). La violazione del primo tipo perché le autorità italiane erano a conoscenza del programma di «extraordinary renditions» della Cia e sapevano - o avrebbero quantomeno dovuto fare le dovute verifiche preventive - come sarebbe andata a finire. Sapevano che Abu Omar in Egitto sarebbe stato torturato e hanno, ciononostante, permesso il suo rapimento. La Corte ricorda peraltro che ad Abu Omar era stato riconosciuto lo status di rifugiato politico: il rischio di persecuzione che avrebbe corso nel suo paese di origine era dunque stato ufficialmente accertato dalle nostre autorità.
Passando a considerare la violazione «procedurale», invece, la Corte sottolinea come le informazioni relative al coinvolgimento di componenti del Sismi nell’episodio fossero già circolate sulla stampa. Ed essendo note, la Corte stessa è in condizione di stabilire che, qualora utilizzate, avrebbero potuto portare alla condanna degli interessati. La decisione del governo di escludere dal processo informazioni che erano già pubbliche ha avuto - scrivono i giudici - l’unico scopo di evitare la condanna dei funzionari del Sismi. Quanto agli americani, il fatto di non avere chiesto la loro estradizione - a cui si deve aggiungere la grazia concessa al capo degli operativi della Cia, Robert Lady, dal Presidente Napolitano - ha impedito che questi fossero chiamati a rispondere. Nel frattempo anche Mattarella ha dato la grazia ad altri cittadini americani condannati.
Al dunque, a fronte degli sforzi della magistratura di accertare ed eventualmente punire, il potere esecutivo tanto ha fatto che è riuscito a fare in modo che gli accertamenti e le punizioni non fossero effettivi. Così come in altri casi, ormai piuttosto numerosi, a impedire la punizione di atti di tortura in Italia è la prescrizione, in questa vicenda gli strumenti utilizzati sono altri: il segreto di stato, la mancata richiesta di estradizione, i provvedimenti di grazia. Il risultato però è sempre quello: l’impunità.
 «Egitto. L’Italia allenta la pressione, il boia no. Solo ieri 116 condannati, tra cui un bimbo di quattro anni (!). Agli arresti lo scrittore Ahmed Naji».
«Egitto. L’Italia allenta la pressione, il boia no. Solo ieri 116 condannati, tra cui un bimbo di quattro anni (!). Agli arresti lo scrittore Ahmed Naji».
Il manifesto, 23 febbraio 2016 (m.p.r.)
Tra i tavoli dei bar del Cairo, mentre fino a qualche giorno fa tutti gli avventori citavano Giulio e la necessità di fare chiarezza, ora il clima è cambiato. «L’Italia non fa la voce grossa», si sente ripetere.
In verità, due sono i motivi per cui il pressing del governo Renzi sul presidente al-Sisi non sembra affatto significativo. L’Italia è pronta a sostenere l’Egitto in caso di guerra in Libia. Questo è ormai uno dei punti più delicati della politica estera italiana dopo la formazione di un governo di unità nazionale che non accenna a decollare e i raid Usa su Sabrata. In secondo luogo, gli accordi economici per lo sfruttamento dei giacimenti di gas Eni, a largo di Port Said, sono tra le priorità in politica economica. Ieri il ministero del Petrolio egiziano ha dato il via libera definitivo ad Eni per lo sviluppo di Zohr XI, la storica scoperta dello scorso settembre che cambierà gli equilibri economici nel Mediterraneo orientale. Pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Giulio Regeni era prevista proprio la firma dei contratti attuativi per procedere con i lavori, che dovrebbero chiudersi entro il 2017, tra Eni e autorità egiziane.
Tutto questo rende la verità nel caso Regeni più difficile da esigere e nelle mani delle autorità egiziane che hanno tutto l’interesse a depistare e insabbiare il caso. Nei giorni scorsi, gli egiziani erano tornati a protestare proprio sulla scia dell’indignazione per la morte del giovane dottorando italiano. Dopo le richieste di fare chiarezza sulla vicenda, avanzate la scorsa domenica dal premier Renzi, il ministro dell’Interno, Abdel Ghaffar, ha fatto riferimento all’intesa con l’Italia e alla necessità di «arrestare i responsabili». Ma sembra che le autorità egiziane non vogliano collaborare davvero con il team di investigatori italiani (Ros, Sco e Interpol), che si trova ormai da quasi tre settimane al Cairo. Gli inquirenti resteranno ancora, come richiesto anche dalla famiglia del giovane friulano in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi.
L’Egitto è tornato ad alzare la voce per gli abusi compiuti dalla polizia. Decine di familiari di prigionieri politici e desaparecidos si sono radunati alle porte del Sindacato dei giornalisti per chiedere «processi giusti». Alcuni dei manifestanti tenevano tra le mani le foto dei loro familiari, detenuti nella prigione di al-Aqrab, quasi tutti processati da tribunali militari e condannati a morte. Non solo, i dirigenti del Centro per la riabilitazione delle vittime di Violenza e Tortura (Nadeem) hanno annunciato che resisteranno al provvedimento di chiusura della clinica, disposta direttamente dal governo.
Secondo Amnesty International sono 41mila i prigionieri politici in Egitto, circa 1500 i casi di sparizioni denunciate e migliaia le condanne a morte. Solo ieri il Tribunale del Cairo ha condannato a morte 116 persone per gli scontri del 3 gennaio 2014 tra sostenitori dei Fratelli musulmani e polizia che causarono 13 vittime. Tra i condannati a morte figurerebbe anche un bambino di quattro anni che all’epoca dei fatti ne aveva due. Questo dimostra ancora una volta che i giudici procedono a condanne sommarie senza neppure studiare i casi dei condannati o leggere i nomi degli imputati in aula.
In una lettera dal carcere, uno dei leader del movimento 6 aprile, Ahmed Maher, ha criticato la repressione che ha impedito migliaia di egiziani di tornare a protestare contro il regime militare lo scorso 25 gennaio. Nel giorno in cui Giulio Regeni è sparito, quinto anniversario dalle rivolte del 2011, non ci sono state significative manifestazioni di piazza.
E dopo le proteste dei giornalisti e gli arresti di comici e fumettisti, ieri lo scrittore Ahmed Naji è stato arrestato dopo aver subìto una condanna a due anni di prigione per linguaggio osceno. Le accuse si riferiscono al suo ultimo romanzo Istikhdam al-Hayah (Usando la vita) del 2014. Naji ha respinto le accuse. Secondo lo scrittore, autore di Rogers (2007), i giudici continuano a riferirsi al testo come a un articolo mentre si tratta di uno dei capitoli del suo libro. Anche il caporedattore del quotidiano Akhbar al-Adab, Tarek al-Taher, che lo ha pubblicato, dovrà pagare una multa di 1500 euro. Il sindacato dei giornalisti ha definito la sentenza un attacco all’«immaginazione degli scrittori».
«La Grecia rischia di diventare uno Stato abbandonato e chiuso dove i migranti in arrivo non trovano più possibilità di uscire In Siria milioni di persone sono intrappolate e vittime di violenze. Ma c’è di peggio, situazioni quasi invisibili: Sud Sudan e Centrafrica». La Repubblica, 23 febbraio 2016
«Nell’emergenza rifugiati l’Europa sta perdendo se stessa. I bambini morti nel mare Egeo sono uno scandalo che chiama in causa la mancanza di solidarietà di un continente intero, in cui crescono barriere ed egoismi». Filippo Grandi, 58enne milanese, da gennaio è il nuovo Alto commissario Onu per i rifugiati. Sul suo tavolo a Ginevra, giacciono i dossier più “caldi” dai fronti di crisi, a partire dalla Siria («Oggi una trappola dalla quale è quasi impossibile fuggire») e Turchia («paese in prima linea, che ospita oltre due milioni e mezzo di siriani»).
Commissario si aspettava di più dall’ultimo Consiglio europeo?
«L’Europa ha preso degli impegni che non sta mantenendo. Gli hotspot per l’identificazione di chi arriva non sono ancora pienamente in funzione. I ricollocamenti tra i vari paesi Ue dei rifugiati arrivati in Italia e Grecia sono ancora fermi. I rimpatri di chi non ha diritto all’asilo non funzionano. L’Europa è diventata un’autostrada e questo disordine allarma l’opinione pubblica ».
È preoccupato dal crescere dei muri alle frontiere dei paesi europei?
«Cominciamo a vedere sempre più sbarramenti che temiamo molto: l’Austria che fissa quote massime di ingressi, la Macedonia che respinge gli afghani. Sono cresciuto in un continente di frontiere chiuse, ora rischiamo di tornarci. L’Europa sta abdicando a un ruolo di guida internazionale e sta mettendo in discussione il suo stesso progetto originario. Invece nessuna guerra è troppo lontana da noi da non riguardarci. I rifugiati sono degli ambasciatori che stanno lì a ricordarcelo. I muri sono preoccupanti, anche perché rischiamo di isolare interi paesi».
Come Grecia e Italia?
«Soprattutto la Grecia. Domani (oggi, ndr) sarò ad Atene per una grossa operazione umanitaria dell’Unhcr. La Grecia rischia di diventare uno Stato isolato, in cui i rifugiati restano chiusi senza possibilità di uscire. L’Italia è un paese di frontiera: se riprenderà con forza la rotta del Mediterraneo centrale, il rischio è di diventare un “ricevitore” di migranti, senza grandi sbocchi esterni».
È giusto rivedere il trattato di Dublino?
«Che lo Stato competente alla domanda d’asilo sia quello in cui il rifugiato ha fatto il proprio ingresso nell’Unione europea è un modello vecchio che va indubbiamente superato».
Per arginare i flussi di migranti, la Ue fa bene a puntare sulla Turchia?
«La Turchia è una degli Stati chiave di questa crisi. Non a caso è il paese che oggi ospita il numero più alto di rifugiati al mondo: due milioni e mezzo di siriani, più qualche migliaio di afgani e iracheni. Insomma, Ankara sta facendo la sua parte. Il piano d’azione Ue concordato a novembre va nella direzione giusta: controllo delle coste e delle partenze verso la Grecia, in cambio di tre miliardi di euro di fondi da destinare a progetti d’accoglienza per i rifugiati. E poi nuove vie legali d’uscita dal paese».
Ci spieghi meglio.
«Bisogna prevedere la possibilità per migliaia di profughi di lasciare la Turchia, ma anche altri paesi di transito come la Giordania e il Libano, e raggiungere in sicurezza gli Stati Ue dove riceveranno asilo».
Che ne è di questo piano?
«Non è ancora stato attuato. È urgente accelerare, anche perché intanto la Turchia ha quasi chiuso la sua frontiera con la Siria ».
Qual è la situazione degli sfollati in Siria?
«Ci sono milioni di persone intrappolate. Certo le situazioni sono le più diverse, ma tutti sono ugualmente vittime di violenze inaudite. Le loro possibilità di fuggire sono minime. Senza un cessate il fuoco, poco si può fare. Ma c’è di peggio, ci sono situazioni quasi invisibili: parlo per esempio dei rifugiati della Repubblica Centrafricana o del Sud Sudan che neppure arrivano da noi, ma si fermano nei paesi limitrofi».
Questa ondata di migranti allarma l’opinione pubblica europea.
«Il disordine dell’attuale gestione giustifica questo allarme. La mancanza di coordinamento e solidarietà dà forza a chi vuole alzare le barriere».
C’è chi soffia sulle paure?
«In Europa ci sono parti politiche che stanno volutamente impaurendo i cittadini. E questo è gravemente irresponsabile. Altri per fortuna fanno il contrario ».
La Germania?
«Senza la leadership tedesca, oggi l’Europa sarebbe ancora più chiusa. L’ho detto al telefono ad Angela Merkel. Ho molta ammirazione per lei, anche perché rischia l’isolamento. E un paese non può fare tutto da solo ».
Cosa ha pensato quando ha letto del coinvolgimento di alcuni rifugiati nelle violenze di Colonia?
«Chiunque vive in un paese deve rispettarne le leggi, altrimenti deve essere perseguito, ma attenzione a generalizzare ».
Non c’è comunque un problema di integrazione di queste masse di rifugiati?
«Due giorni fa ero in Germania. I tedeschi fanno grandi sforzi, ma l’integrazione costa molto. Una cosa è certa: una gestione ordinata dei profughi è la migliore ricetta per rassicurare l’opinione pubblica».

«».Il Fatto Quotidiano, 22 febbraio 2016
Roma. Il “partito della cricca” è trasversale per vocazione. E infatti, se da un lato fa da stampella al governo Renzi, dall'altro rianima Silvio Berlusconi, offrendo il candidato per la corsa al Campidoglio. Il soccorso a Renzi è firmato Denis Verdini, quello all'ex Cavaliere è sulle spalle di Guido Bertolaso, e sia l'uno sia l'altro sono imputati nei processi sui Grandi Eventi e sugli appalti del G8. Entrambi accusati di concorso in corruzione.
Il “sistema gelatinoso” ricostruito in migliaia di pagine d'inchiesta - condotta dal Ros dei carabinieri guidati dal colonnello Domenico Strada e dalle procure di Firenze, Perugia e Roma - è ancora protagonista della politica. Verdini e Bertolaso sono soltanto imputati. Potrebbero essere assolti - entrambi ne sono convinti - e, comunque, risultano non colpevoli fino al terzo grado di giudizio. Ma il nodo, più che giudiziario, è politico. Anche se una sentenza definitiva c'è stata. Il 10 febbraio. La Cassazione ha confermato condanne piuttosto pesanti, per la “cricca” che lucrava sugli appalti del G8.
Le condanne per Balducci e De Santis
Angelo Balducci (l'ex presidente del provveditorato ai lavori pubblici) e Fabio De Santis (ex provveditore delle opere pubbliche della Toscana) dovranno scontare 3 anni e 8 mesi. Gli imprenditori Francesco De Vito Piscicelli e Riccardo Fusi, invece, rispettivamente 2 anni e 8 mesi e 2 anni, con sospensione della pena. L'accusa: concorso in corruzione aggravata per l'appalto della scuola Marescialli di Firenze. Parliamo dello stesso filone d'inchiesta che vede Verdini a processo dinanzi al tribunale di Roma. La storia è nota: Fusi, dopo un contenzioso con lo Stato, aveva perso l'appalto, ma riuscì a riconquistarlo con la mediazione del trio composto da De Vito Piscicelli, Balducci e De Santis. Nel merito del contenzioso con lo Stato, va detto, Fusi aveva persino ragione. Il punto è che per assicurarsi la partita la “cricca” non esitò a foraggiare De Santis con un Rolex. E nel frattempo Fusi chiedeva l'interessamento di Verdini.
«Ci hanno fatto uno scherzetto bruttino...», dice a Verdini nel 2008, «... ha chiesto lasospensiva ... e per quella cosa dei Marescialli … doveva essere una formalità ... il fatto che venisse respinta ... perché non c'era le condizioni … giovedì c'è stata la sentenza … gli hanno concesso la sospensiva ...». «Allora - risponde Verdini - guardo di fissare in settimana un appuntamento con il nostro ... vieni, così si va ...». Otto anni dopo - al di là dell'esito dei processi -Verdini è politicamente più forte che mai e con i suoi parlamentari di Ala sostiene il governo Renzi. Ma c'è di più. È lo stesso Verdini che, emerge dagli atti d'indagine sulla P3, in passato ha avuto prestiti per qualche milione di euro dal senatore di Forza Italia, re delle cliniche ed editore di Libero, Antonio Angelucci e dal faccendiere Flavio Carboni. Ma il Pd e Renzi non riscontrano alcun problema nell'accettare il suo sostegno.
Anemone, Zampolini e l’affitto a via Giulia
A Roma, invece, Guido Bertolaso tira la volata con la quale Berlusconi vuole risalire la china. È paradossale immaginare Bertolaso, che con gli affitti un problema l'ha avuto, argomentare con tutti i soggetti implicati in affittopoli. Certo, sostiene Bertolaso, l'affitto dell'appartamento in via Giulia, in quei pochi mesi, fu pagato dal re della “cricca”, l'imprenditore Diego Anemone, attraverso l'architetto Zampolini, completamente a sua insaputa. Lui immaginava che quella soluzione provvisoria - era andato via di casa per problemi familiari, dovuti all'eccessivo ritmo del suo lavoro - gliel'avesse trovata un comune amico del cardinale Crescenzio Sepe, che ha citato in tribunale, per scagionarlo dalle accuse. L'argomento - dipenderà dal convincimento del giudice - può avere una valenza processuale.
Ma restano agli atti le testimonianze di Zampolini e del proprietario di casa, Raffaele Curi. «Diego Anemone - dice Zampolini ai giudici - mi chiese negli anni 2002 2003 un appartamento in centro in via Giulia per un uso personale... non me lo chiese ai fini del dottor Bertolaso... Un piccolo appartamento in affitto…». Insomma, Anemone chiede a Zampolini di trovargli una casa in affitto per uso personale che, però, sarà poi abitata da Bertolaso. Dopo un primo anticipo, incassato da Anemone, il signor Curi non vede più un centesimo: «Il proprietario - continua Zampolini . però non percepiva più l'affitto... mi dispiaceva averlo messo in questa difficoltà...».
La situazione dell'inquilino Bertolaso diventa surreale. Dice Zampolini: «A Curi suggerii: ‘guarda, cambia la serratura della chiave, perché... sennò con questo non se ne esce’. E lui in quell'occasione mi disse: ‘Ah, perché sai ho visto due tre volte... il dottor Bertolaso che ha utilizzato l'appartamento’...». Curi peraltro, sostiene Zampolini, non firmò il contratto d'affitto con l'ex capo della Protezione civile, ma direttamente con Anemone. E i soldi dell'affitto non li incassava neanche da quest'ultimo, ma da Zampolini: «Ma i soldi che lei ha appena detto», chiede il pm, «fu lei a consegnarli a Curi?». «Sì», risponde Zampolini. «E chi glieli diede?», continua il pm. «Diego Anemone», è la risposta.
Inquilino a sua totale insaputa Bertolaso, di questa girandola di soldi e persone, impegnate a risolvere il suo problema abitativo, sostiene di non aver saputo mai nulla. E quindi: ha vissuto in una casa senza informarsi su chi gli pagasse l'affitto o, quanto meno, senza rendersene conto. Con quali argomenti potrà convincere l'esercito di inquilini dell'affittopoli romana che lui, proprio lui, l'ex inquilino di via Giulia, avrà il compito di far sloggiare? Bertolaso è convinto di poter dimostrare la propria innocenza, anche sugli altri episodi della presunta corruzione negli appalti del G8 e nella gestione dei Grandi Eventi, sia quello dei 50mila euro ricevuti da Anemone, sia quello dei massaggi erotici nel Salaria Sport Village.
«È come se avessimo guadagnato cinquecento punti», dice Anemone quando viene intercettato, mentre Bertolaso, all’interno del Salaria Sport Village, usufruisce dei massaggi della brasiliana Monica. E se non bastasse manda uno dei suoi uomini a cercare gli eventuali profilattici rimasti in stanza. Profilattici mai trovati, per quanto emerge dalle stesse intercettazioni e mai utilizzati, sostiene Bertolaso, perché i massaggi in questione non avevano nulla di erotico. Resta da capire, però, perché Anemone - che già gli pagava l'affitto a sua insaputa - era convinto di aver guadagnato “cinquecento punti”.
Il massaggio da “500 punti”
Ecco, se Bertolaso venisse condannato, sebbene in primo grado, sarebbe stato corrotto dalla cricca. Se venisse assolto, avrebbe comunque ricevuto dalla cricca un appartamento in affitto, pur non essendone cosciente, e massaggi da “cinquecento punti”. Tra Verdini e Bertolaso, insomma, il partito della “cricca” sembra più agguerrito che mai.
 «Cosmopolitica. Il comitatone, i referendum, le comunali. E dal 3 al 5 dicembre il congresso. Il gruppo centrale e i 60 delle regioni per decidere come eleggere il leader. E le regole delle assise». Riusciranno i nostri eroi a evitare di fare il novoSEL?
«Cosmopolitica. Il comitatone, i referendum, le comunali. E dal 3 al 5 dicembre il congresso. Il gruppo centrale e i 60 delle regioni per decidere come eleggere il leader. E le regole delle assise». Riusciranno i nostri eroi a evitare di fare il novoSEL?
Il manifesto, 23 febbraio 2016
La «sinistra massimalista» non vince «neanche le elezioni di condominio»; quelli che hanno vinto, come Alexis Tsipras in Grecia, «poi hanno assunto una posizione sanamente e pragmaticamente riformista». Davanti ai cronisti della sala stampa estera il presidente Renzi la prende la larga per dire quello che pensa di chi sta alla sua sinistra. Quelli fuori dal Pd sono «massimalisti», quelli dentro o si adeguano oppure «ciao», come ha spiegato domenica scorsa all’indirizzo della minoranza Pd.
Basterebbe questo per spiegare la mutazione che si è formalmente compiuta lo scorso week end al Palazzo dei Congressi di Roma in tre giorni fantasiosamente denominati «Cosmopolitica» che di fatto hanno consumato lo shackeraggio fra Sel, un gruppo di ex Pd con un tesoretto di militanti al seguito, alcune associazioni (Tilt, Act, Sinistra e lavoro), singole personalità, fra intellettuali ed ex social forum.
La giornata di domenica ha sancito il passaggio di testimone di Nichi Vendola, consegnato ad un video: «È tempo che una nuova generazione avanzi sulla prima linea». E il testimone sarebbe evidentemente destinato a Nicola Fratoianni, che ha fatto l’ultimo intervento (formalmente in quanto coordinatore della segreteria). Ma il leader in pectore della nuova formazione si è attenuto ai tempi stretti, come tutti gli altri, per dare l’idea che ancora niente è deciso. E comunque nella tre giorni è affiorata una trama di giovani leader già in prima linea, e infatti molto applauditi: da Marco Furfaro di Sel («Che bello vedere due sindaci come Zedda e Pisapia venire in un laboratorio tematico, ascoltare e poi portare il proprio contributo. La sinistra torna a vincere se va per aggregazione, non per sottrazione»), Claudio Riccio, Act («Vogliamo costruire una grande forza popolare, saremo impegnati per non fare la solita cosa, la solita sinistra», Mapi Pizzolante di Tilt («Non mi abituo alla sinistra del rancore, delle formule, degli uomini che se lo misurano, voglio costruire un’intelligenza collettiva in cui governa la solidarietà, la condivisione, il mutualismo»). Per non parlare dell’esplosiva sindaca di Molfetta Paola Natalicchio, un vero fenomeno dal palco. Ma l’assemblea è finita tutta in piedi per Luciana Castellina, fondatrice del manifesto e ormai un’icona di quest’area, che con ironia allegra elogiava i ragazzi e proponeva «una federazione dei vecchi». Prima aveva tributato applausi allo «zapatismo partenopeo» di Luigi De Magistris e a Leoluca Orlando. Più fredda l’accoglienza per un coraggioso Gianni Cuperlo venuto a offrire la sua mano per «continuare a costruire ponti». Il nuovo soggetto nasce dalla rottura del centrosinistra. Le comunali, il referendum sulle trivelle del 17 aprile e quello costituzionale — i primi tre appuntamenti del nuovo partito — non accorceranno le distanze.
Si vedrà al congresso che si terrà dal 3 al 5 dicembre. Da qui a quei giorni la platea di Cosmopolitica ha deciso un percorso, con inevitabili dosi di riunioni di backstage. La proposta accettata è quella di Peppe De Cristoforo, responsabile organizzazione di Sel, e discussa in due lunghe sessioni venerdì e sabato. A breve nascerà un comitatone promotore di 150 persone ripartito in tre «gambe». La prima è quella dei parlamentari di Sinistra italiana. Una quarantina ormai: oltre a quelli di Sel e agli ex pd fin qui già confluiti, hanno annunciato la loro adesione gli ex dem Giovanna Martelli e Corradino Mineo, gli ex 5 stelle Campanella e Bocchino (un altro ex grillino, Zaccagnini, aveva già aderito). Resta di sapere cosa decideranno i senatori Uras e Stefano, vendoliani ma contrari al nuovo corso. La seconda gamba sarà una delegazione ’centrale’ composta dalla segreteria nazionale di Sel e dai rappresentanti delle organizzazioni e associazioni fondatrici, insieme a singole personalità, in tutto una cinquantina di persone. La terza gamba verrà dai famosi «territori»: entro due mesi saranno saranno sce lti tre rappresentanti per ciascuna regione «su base consensuale». Tradotto: dovranno mettersi d’accordo evitando i litigi. Cosa non semplice soprattutto in alcune città, leggasi Roma e Milano, dove la scelta arriverà in piena campagna per le amministrative e costringerà alla conta le componenti favorevoli alla ricostruzione del centrosinistra. Non sarà un pranzo di gala, lo si è visto già nel corso della tre giorni del Palacongressi in cui non sono mancate le polemiche anche ruvide: Cofferati e Fassina da una parte, Pisapia, Zedda e Smeriglio dall’altra.
I 150 del comitatone (a occhio solo il 50 per cento proverrà da Sel) dovranno decidere le regole per il congresso e per il tesseramento (sia online, sulla piattaforma «Commo», che nei circoli). Ma è una partita tutta ancora aperta. Così come quella delicatissima della modalità dell’elezione del o dei leader, della scelta di un congresso per mozioni o per tesi, quella del nome. «Sinistra italiana», nome provvisorio deciso prima dell’assemblea romana non ha riscosso l’entusiasmo dei più giovani né del coté ambientalista di Sel, preoccupato per questioni anche di impianto culturale del nuovo soggetto. Il simbolo è piaciuto ancora meno.
Resta anche il nodo di chi non c’è. Non solo l’elettore della sinistra inseguito dal nuovo soggetto. ma anche i «compagni di strada» che per ora restano su un’altra strada. Ferrero del Prc, presente a Cosmopolitica, ha ripetuto la sua proposta di coalizione di sinistra. Marco Revelli, dell’Altra Europa, quella di una «vera costituente di un soggetto plurale, unitario, inclusivo, aperto». Pippo Civati invece non c’era. Una risposta più possibilista è arrivata dai candidati unitari (Fassina e Airaudo) ma per Nicola Fratoianni la condizione resta l’ingresso nel nuovo partito: «Con oggi chiudiamo la stagione degli accrocchi a sinistra».
--
 ». Pochi decenni dopo comincia la lunga discesa: Craxi, Berlusconi, Renzi. La Repubblica, 21 febbraio 2016
». Pochi decenni dopo comincia la lunga discesa: Craxi, Berlusconi, Renzi. La Repubblica, 21 febbraio 2016
Quel giorno le donne si svegliarono allegre. Qualcuna la notte prima non aveva chiuso occhio, perché si trattava di una prima volta, e chi può sapere cosa si prova davanti a una scheda bianca. Alba de Céspedes uscì di casa con il passo leggero, come di chi «si sente i capelli ben ravviati sulla fronte». Maria Bellonci provò anche una sorta di smarrimen-to, in fondo era il suo battesimo da cittadina, ma bastò riconoscerlo per riprendere la rotta. E Anna Banti fu la più spietata con se stessa, in un modo che solo le donne conoscono: e se sbaglio tra il segno della repubblica e quello della monarchia? Così settant’anni fa le italiane andarono al loro primo voto, quello che avrebbe segnato l’inizio della democrazia repubblicana.
E così ha inizio la lunga storia che Guido Crainz ha scritto per Donzelli, bruciando i tempi sull’anniversario della Repubblica che cade il prossimo giugno: una cavalcata di quattrocento pagine che dall’Italia devastata dalla guerra arriva alle “terre incognite” di questi giorni. Ma è possibile storicizzare l’oggi, riducendosi praticamente a zero la distanza tra lo storico e i tumultuosi accadimenti della contemporaneità? L’autore di ci ha provato con un ammirevole sforzo di sintesi che è difficile rintracciare nell’attuale produzione storiografica. E la chiave del felice esperimento va cercata nelle fonti predilette da Crainz, che sono prevalentemente romanzi e film, quotidiani e riviste, il variegato deposito dell’immaginario popolare capace di fotografare negli italiani umori e allergie, speranze e disillusioni più di quanto raccontino le aride statistiche.
È grazie ad Alberto Moravia che nel 1947 entriamo nella periferia degradata di Roma, «un campo di concentramento senza filo spinato e torri di guardia». Ed è con Anna Maria Ortese che ci si interroga in quegli stessi anni sulla strana convivenza dentro il Pci «tra spiriti profondamente liberali e altri incapaci di laica indipendenza». Senza l’ironia agra di Luciano Bianciardi sarebbe difficile mettere a fuoco il volto crudele della modernizzazione. E nel successivo decennio dei Settanta spetta ad Alberto Arbasino sancire «ascesa e caduta delle illusioni », con il tramonto dei «valori come lo Sviluppo e il Progresso e la Crescita». Gli scrittori assolvono con ostinazione al ruolo di coscienza critica. Nella bufera di Tangentopoli, con mezza classe politica in galera e la gente in piazza ad applaudire, Giovanni Raboni non riesce a scacciare «un pensiero sordo e odioso come certi dolori: e noi, nel frattempo, dove eravamo?».
Ecco, forse la domanda che corre lungo settant’anni è come sia stato possibile passare dalla “necessità dei partiti”, da una politica onnipresente con un tasso altissimo di partecipazione al voto, al trionfo del suo esatto contrario, tra astensionismo e trionfo dell’antipolitica. Domanda che potrebbe essere estesa a molti altri paesi ma che in Italia ha una sua particolare urgenza. E secondo Crainz vi si può rispondere solo risalendo ad alcuni vizi di origine del sistema politico, ossia la continuità con il fascismo che aveva segnato la presenza invasiva del partito-Stato dentro le vite degli italiani. E anche il concetto di democrazia, puntualizza lo storico, non appariva del tutto chiaro e scontato, «né per il partito comunista né per il mondo cattolico». Oggi possono sembrare fogli ingialliti d’un album rimosso, eppure colpiscono le ferite dell’amputazione democratica negli anni della guerra fredda: un centinaio di lavoratori uccisi dalle forze dell’ordine tra il 1947 e il 1950, schedature per centinaia di migliaia di cittadini sospetti di militanza comunista, ripetuti controlli sugli insegnanti con interrogatori ai colleghi e ai genitori degli alunni. Nella “democrazia congelata” di quella stagione i diritti esistono, ma non per tutti.
Un altro filo rosso che attraversa questi decenni è l’incapacità della politica di guidare i grandi cambiamenti del paese. La società appare sempre un passo avanti, dietro una classe politica perennemente in affanno. Accade in questi giorni con le unioni civili ma è un tratto costante, ripetitivo, che si manifesta sin dai tempi dell’«inattesa Belle époque» – come la chiama Italo Calvino – ossia il grande salto del miracolo economico, quando l’Italia conosce «un nuovo modo di produrre e consumare, di pensare e di sognare, di vivere il presente e progettare il futuro». A fronte di colossali rivolgimenti, continua a operare per tutti gli anni Cinquanta un sistema arcaico, «apparati, uomini e culture portati a considerare il mutamento come una minaccia mortale».
E anche «il più serio tentativo riformatore dell’Italia Repubblicana » – la stagione dei Lombardi e dei Giolitti – avrebbe visto presto all’opera forze contrarie, accompagnate da “un tintinnar di sciabole”. È in questo passaggio, nello sfumare «non tanto di una singola riforma ma del modello riformista in quanto tale», che secondo Crainz comincia la grande mutazione genetica, «la trasformazione di una società operosa in un verminaio dedito alla dilapidazione». E nella severa diagnosi coincidono le analisi di Pietro Scoppola e le riflessioni di Eugenio Scalfari che denuncia un mercato senza regole e rapporti ormai imbarbariti. Così come era stata cieca alla nascita dell’età dell’oro, la classe politica non si sarebbe accorta della sua fine, sancita dalla crisi petrolifera.
Siamo già nei Settanta, il decennio delle “occasioni mancate” o forse – come ipotizza Giorgio Bocca – delle “occasioni inesistenti”. Anni di piombo che però secondo lo storico non sono riducibili al solo dilagare di violenza e terrorismo ma anticipano culture e comportamenti di massa affiorati in superficie più tardi: il successo come valore assoluto, il disprezzo per le regole e i vincoli collettivi, l’ambizione mai frenata da scrupoli etici. Comportamenti che se prima vengono trattenuti da identità collettivi forti – leggi i partiti di massa – in assenza di anticorpi sono destinati a deflagrare. Una “diseducazione civica” che in Italia avrebbe trovato svariati “eroi”, con l’imperversare della corruzione nella politica e nella società.
Il sistema partitocratico sarebbe arrivato al capolinea negli anni Novanta, travolto dalla “grande slavina” di Tangentopoli. E ancora una volta è uno scrittore come Claudio Magris a dare voce al timore «che il paese si dissolva e tra breve l’Italia – nell’attuale forma politico statuale e dunque anche culturale – possa non esistere più». In questo clima da camposanto avanza con “il sorriso alla Fernandel” (copyright Cesare Garboli) un nuovo protagonista che riuscirà più volte a vincere le elezioni ma non a governare il paese. E suona profetico l’editoriale scritto da Norberto Bobbio nel 1991 per La Stampa, poi ritirato per eccesso di pessimismo: «La gestione della seconda Repubblica se dovesse nascere sarà lunga. Ma poiché se dovesse nascere... nascerebbe con gli stessi uomini che non solo sono falliti ma sono inconsapevoli del loro fallimento, non potrà che nascere male, malissimo, come male, malissimo è finita la prima». La seconda Repubblica non è mai nata, sancisce Crainz. Al suo posto un “lungo regno” berlusconiano su cui la sentenza degli storici appare unanime e inappellabile. E ancora si fanno i conti con la sua pesante eredità.
E oggi? La cavalcata di chiude con il premierato di Renzi in «un’Italia che ha difficoltà a invertire la rotta ». Un paese spaesato che continua a pagare cecità e sciupii di precedenti classi dirigenti. Il racconto dello storico mostra fatalmente un passo più affannato, in una inedita geografia devastata da terrorismo globale e apocalisse migratoria. E sempre più fioche risuonano le voci di quel ceto intellettuale che l’aveva accompagnato fin dal principio della storia (a proposito, dove sono finiti gli scrittori?). Così quelle donne che allegramente si affrettavano alle urne, la mattina del 2 giugno del 1946, nel disincanto di oggi sembrano ombre arrivate dalla luna.
 «Sinistra italiana. Scintille Pisapia-Cofferati. Il sindaco: Sel rispetti i patti e sostenga Sala. L'ex pd: no, è di centrodestra. Zedda si schiera con il collega. Primo sondaggio su Fratoianni, per il 23% il nuovo segretario sarà lui» Una domanda pertinente: si tratta di un nuovo"soggetto politico" o di una reincarnazione di SEL?
«Sinistra italiana. Scintille Pisapia-Cofferati. Il sindaco: Sel rispetti i patti e sostenga Sala. L'ex pd: no, è di centrodestra. Zedda si schiera con il collega. Primo sondaggio su Fratoianni, per il 23% il nuovo segretario sarà lui» Una domanda pertinente: si tratta di un nuovo"soggetto politico" o di una reincarnazione di SEL?
Il manifesto, 21 febbraio 2016
La prima standing ovation della platea di Sinistra italiana è per un uomo del partito democratico. Ma quello «del popolo»: è l’anziano Ertugul Kurkcu, già presidente dell’Hdp. Sale sul palco e porta i saluti «del popolo curdo e del popolo turco». A Palazzo dei Congressi spunta la lacrima.
La seconda giornata di Cosmopolitica è quella delle tremila presenze, dei 24 tavoli, del parterre de roi dei costituzionalisti, delle assemblee su democrazia, scuola, ambiente e lavoro. Dell’esordio di Commo, la piattaforma digitale su cui Sel ha investito 60mila euro perché il nuovo soggetto abbia una «casa online». E che ieri, dice Roberto Iovino, «ha fatto mille iscritti nelle sue prime otto ore di vita».
Ma è anche la giornata dei botta e risposta fra ’big’. In mattinata arriva Giuliano Pisapia, il sindaco di Milano. Partecipa ai tavoli, ma sul nuovo partito la prende larga: «Sel è una parte importante della mia storia politica, ma sono qui per affetto. Per i prossimi quattro mesi continuerò a fare il sindaco». Il fatto è che qui, in molti, gli chiedono di mollare Sala. Lo ha fatto a più riprese Sergio Cofferati, già sindaco di Bologna e ora padre nobile della sinistra-sinistra genovese. Lo ha fatto Stefano Fassina, candidato a Roma, che pur avendo non poche gatte da pelare nella Capitale dice che «la priorità a Milano è unire le forze e recuperare la parte della città che non si riconosce in Sala». Pisapia incontra l’ex segretario della Cgil in un corridoio elo abbraccia con affetto. Ma ai cronisti risponde secco: «Sel sta ragionando. Ma ha fatto un patto di lealtà per le primarie: ha vinto Sala e ora saremo tutti in campo per sostenerlo sapendo che deve continuare un’esperienza di centrosinistra. Spero, e ne sono convinto, che Sel sia accanto a me». Si schiera con lui Massimiliano Smeriglio, vice di Nicola Zingaretti alla regione Lazio: «A Milano abbiamo accettato la sfida del popolo che decide. E il popolo ha deciso in maniera interessante, perché per Majorino e Balzani hanno votato più di 30mila persone. Non dobbiamo mantenere un patto con Sala ma con il nostro popolo». Poi sbotta: «Bisognerebbe avere più aderenza alle proprie biografie. E parlo di certi ex Pd che considerano tutto il campo di centrosinistra come destra. È paradossale». Il riferimento è proprio a Fassina e a Cofferati che, una volta usciti dal Pd, sono diventati i più combattivi sostenitori della rottura delle alleanze. Cofferati replica: «Sala è di destra. Cioè, di centrodestra», quindi «è un dovere» sfidarlo con un nome di sinistra. Per esempio Pippo Civati? Civati non è qui ma manda a dire: «Io non sono candidato. In ogni caso sarebbe il caso che Sinistra italiana si mettesse d’ accordo su una posizione».
Intanto dal Pd arriva il missile del vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini: «Dopo aver fatto vincere la destra in Liguria, Cofferati ci prova anche a Milano… non ci riuscirà». Replica di Cofferati: «La verita’ e’ che il Pd ha sbagliato candidato, ha lasciato che si inquinassero le primarie ed alle urne ha pagato il prezzo di aver amministrato male la Regione Liguria. Guerini finge di non ricordare le ingerenze della destra nelle primarie, ingerenze che io gli ho segnalato puntualmente».
Dice la sua, per la verità costretto dai cronisti, anche il sindaco di Cagliari, l’enfant prodige Massimo Zedda, che è di Sel ma è stato confermato anche dall’alleato Pd per il voto di giugno. Si schiera con Pisapia: «Se vince Sala, vince il centrosinistra che dimostra così di non essere morto ma poter ripartire dalle città. Alle comunali non ci può essere un dogma nelle alleanze, ma c’è una realtà molto variabile, legata come sempre alle singole realtà locali». Zedda, a differenza del sindaco uscente di Milano, si dichiara convintamente dentro il ’percorso’ di Sinistra italiana. Ma le differenze interne già si misurano. E solo un patto stretto nel nucleo fondatore del nuova cosa alla vigilia della kermesse tiene a bada i fuochi. Infatti è Nicola Fratoianni, leader in pectore della nuova forza politica, a incaricarsi di buttare otri d’acqua: «Nessun dramma, il partito non esiste ancora». Per questa semplice ragione fisica ancora non può dividersi. L’invito è a guardare oltre le comunali, come pure fa Alfredo D’Attorre: presto sarà lanciata la raccolta firme per tre referendum contro Jobs act, riforma della scuola, Italicum. Il 17 aprile il referendum sulle trivelle, poi a ottobre la «grande prova» del referendum costituzionale. Il congresso del nuovo ’partito oltre il partito’ arriverà solo a dicembre, se tutto va bene.
Ieri Fratoianni viene gratificato di un sondaggio commissionato da Huffington post. Alla domanda ’chi vorrebbe come segretario di Si’ ha raccolto il 23,08% delle preferenze, seguito da Fassina con il 15,38, da D’Attore con il 13,46. A Vendola — che oggi ’parlerà’ attraverso un video che conterrà l’annuncio di «un passo a lato» — solo l’11,54. Un ragguardevole 29,8% per cento risponde «nessuno di questi».
Per il responsabile organizzazione di Sel, Peppe De Cristofaro, mettere in ordine l’elenco oratori per il gran finale di oggi è stata una faticaccia. Dal palco sono previsti trenta interventi, il video di Vendola e il saluto — scritto — di Maurizio Landini. Fra gli altri Luigi De Magistris e Leoluca Orlando, il segretario del Prc Ferrero. La deputata ex Pd Giovanna Martelli, già consigliera del governo per le pari opportunità, annuncerà un avvicinamento. Il senatore ex grillino Francesco Campanella, oggi nel misto con la casacca Altra Europa per Tsipras, l’ingresso in Sinistra italiana (malumori nell’Altra Europa che invece non entra nella nuova cosa). Annunci di adesione anche dall’ex grillino Fabrizio Bocchino e dall’ex Pd Corradino Mineo. Ci saranno Ilaria Cucchi e Luciana Castellina. E Gianni Cuperlo, che per essere qui si allontanerà dall’assemblea Pd: ma solo temporaneamente

Corriere della Sera, 22 febbraio 2016 (m.p.r.)
Papa Francesco lancia una proposta rilevante: «Propongo a quanti sono cattolici di compiere un gesto coraggioso ed esemplare: che nessuna condanna venga eseguita in questo Anno Santo della Misericordia». Mobilita autorevolmente i fedeli, i vescovi e i governanti cattolici per la moratoria delle esecuzioni. Quali reazioni positive o critiche ci saranno? Si pensi ai governatori americani. Bergoglio delegittima religiosamente la pena capitale: «Il criminale mantiene l’inviolabile diritto alla vita, dono di Dio».
La sua posizione ha innovato rispetto al passato. Wojtyla e Ratzinger avevano fatto passi in avanti, ma pesava l’ipoteca della continuità con l’insegnamento tradizionale. Si poteva smentire la storia della Chiesa? Ancora nel 1868, furono eseguite due condanne a morte (approvate da Pio IX) nella Roma papale. Francesco è consapevole di quanto lucidamente affermava papa Giovanni: «Non è il Vangelo che cambia: siamo noi che cominciamo a comprenderlo meglio». E il Vangelo narra dell’iniqua condanna alla croce dell’unico «giusto» per i cristiani.
La moratoria delle esecuzioni per il Giubileo è parte d’un disegno ambizioso del Papa: l’abolizione della pena di morte. Su questo la Chiesa dovrà dialogare anche con gli altri cristiani e le religioni. La posizione del Papa è però oggi di grande rilievo, quando vari governi pensano a reintrodurre la pena capitale, nella lotta al terrorismo e al narcotraffico. Francesco delegittima la pena di morte anche dal punto di vista dell’efficacia sociale: le società hanno altre possibilità «di reprimere il crimine». In Messico, il Papa ha incontrato un’escalation di violenza. Una società violenta non deve trascinare lo Stato ad altra violenza. La proposta del Giubileo della Misericordia è invece la realizzazione di un’inclusiva «salute sociale», che generi cultura, crei reti, prevenga il crimine e realizzi condizioni carcerarie mirate al recupero .
L'intervista di Emanuele Giordana e Alessandro Rocca allo storico Angelo Del Boca alla vigilia della presentazione di un documento di analisi della Tavola della pace. Il manifesto, 20 febbraio 2016
Questa video intervista è stata registrata alla vigilia del seminario nazionale “Conoscere e spiegare le guerre dei nostri giorni” - che si tiene sabato 20 febbraio al Centro di accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano (Udine) - in cui verrà presentato un documento di analisi sui rischi di un conflitto in Libia frutto della riflessione di un gruppo di lavoro. Nel video, lo storico Angelo Del Boca mette in guardia sul rischio di una “guerra a terra” per cui “non basterebbero 300mila soldati”.
La guerra aerea per altro - dice Del Boca - si racconta da sola ogni giorno per le vittime innocenti che comporta. Lo storico si augura che prevalga la cautela rispetto a quella che, nel caso di intervento unilaterale, si configurerebbe “come un’aggressione”. Quanto all’Italia, Roma dovrebbe astenersi dal conflitto e semmai sostenere la costruzione di un esercito e polizia nazionali: se ci dev’essere una guerra in Libia, “quella va fatta dai libici non da noi”. Senza contare il fatto che comporterebbe un “costo enorme di vite umane”.
Quanto al quadro politico, è difficile - sostiene lo storico che ha all’attivo 58 libri - che “anche in caso di un accordo tra Tobruk e Tripoli sul piano disegnato dall’Occidente” le cose restino in equilibrio. Nessuno infatti, come aveva fatto Gheddafi (“errore gravissimo abbatterlo”), riesce ora a “tenere unito un Paese con 140 tribù” che il regime tenne assieme per 42 anni. Del Boca ritiene infine che vada recuperato il ruolo del figlio di Gheddafi.
Al seminario di sabato 20 febbraio interverranno tra gli altri: il missionario comboniano p. Kizito Sesana, il generale Fabio Mini; lo storico Angelo Del Boca, i giornalisti Eric Salerno, Roberto Savio, Emanuele Giordana, Raffaele Crocco, Francesco Cavalli, don Pierluigi Di Piazza, Fondatore del Centro Ernesto Balducci di Zugliano; Flavio Lotti, Coordinatore Tavola della pace, Aluisi Tosolini, Coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace; Loredana Panariti, Assessore all’Istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia; Pietro Biasiol, Direttore Ufficio Scolastico Regionale FVG, Federico Pirone, Presidente del Coordinamento FVG Enti Locali per la pace e i diritti umani.
Qui il video dell'Intervista ad Angelo Del Boca

Il manifesto, 21 febbraio 2016 (m.p.r.)
Nella classica ottica nazionale, che sempre meno spiega e sempre più mistifica, si potrebbe sostenere che il Regno unito l’ha spuntata sull’Europa continentale, almeno su quella sua parte che ancora sventola, ormai più a parole che a fatti, la bandiera dell’integrazione. Non è così.
Quella a cui abbiamo assistito è l’ennesima vittoria delle élites finanziarie nel loro complesso su tutti i cittadini del Vecchio continente. O, per dirla in termini ormai messi al bando, dell’accumulazione di capitale sulla libertà della forza lavoro. Non si è trattato, insomma, di un poker diplomatico, o di una pura e semplice esibizione a beneficio delle opinioni pubbliche nazionali, ma di un esempio da manuale della lotta di classe. Quella condotta dall’alto, naturalmente. Ma procediamo con ordine.
Già da diverso tempo è stata coniata, e circola con sempre maggiore insistenza, l’orribile espressione di «turisti del welfare». Si intende con questa insolente definizione il nomadismo dei lavoratori precari attraverso i paesi dell’Unione alla ricerca di contesti, occasioni, diritti e livelli di vita più soddisfacenti. L’intermittenza e il nomadismo sono, a ben vedere, le caratteristiche più peculiari di una parte crescente della forza lavoro contemporanea che nessuna pianificazione nazionale potrà mai riassorbire. Sono l’espressione di modelli produttivi ormai affermati.
La mobilità è infatti un requisito professionale e, al tempo stesso, una delle risorse principali attraverso le quali, in assenza di diritti comunitari omogenei, i singoli possono tentare di costruirsi un habitat, sia pure provvisorio, che corrisponda in qualche modo alle loro aspettative. La pretesa britannica di negare o ridurre le prestazioni sociali per 13 anni (ne hanno ottenuti poi «solo» 7) ai lavoratori in provenienza da altri paesi dell’Unione è un attacco diretto alle condizioni di vita di questo precariato in movimento e un deciso passo avanti nell’organizzazione gerarchica della vita sociale.
Vi sono pochi dubbi che questa voce di «risparmio» possa far gola ad altri paesi con welfare molto sviluppato e forse non solo a quelli. Anzi, è quasi inevitabile che la discriminazione diventi una regola. Si assisterebbe così a una nobile gara a rendersi il più inappetibili possibile per il «turista del welfare», il parassita intracomunitario per antonomasia. Sull’esempio di analoghe politiche di deterrenza, teorizzate e praticate da paesi come la Danimarca e la Svezia nei confronti dei richiedenti asilo, ai quali si prospettano e poi si impongono condizioni di accesso sempre più proibitive e vessatorie. Il rapporto con i migranti, è bene tenerlo a mente, ci riguarda tutti molto da vicino. Il risvolto politico è immediato. La non discriminazione, quanto a diritti e garanzie, dei cittadini europei che risiedono e lavorano in un paese diverso da quello di origine era forse l’unico ambito in cui la cittadinanza europea risultasse davvero effettiva.
Tanto che paradossalmente solo spostandosi si poteva avere la percezione di goderne i vantaggi. La limitazione imposta da Londra (con il solito pretesto di una inesistente emergenza a cui metter freno) e le emulazioni che certamente ne seguiranno, assestano così, assieme al continuo ripristino dei controlli di frontiera, un colpo mortale alla già fragile cittadinanza europea. C’è poco da stupirsene visto che il Regno unito vede da sempre l’Europa politica come il fumo negli occhi. Ma anche da altri paesi del continente si levano voci di ringraziamento a David Cameron per aver contribuito ad allontanare l’incubo di una maggiore integrazione politica in Europa.
A tutti è chiaro, anche se nessuno vuole ammetterlo esplicitamente, che lo statuto particolare concesso al Regno Unito comporta riflessi assai rilevanti per tutta l’Unione, ben oltre i contenuti effettivi del “compromesso” raggiunto a Bruxelles. Tutti si sentiranno meno vincolati, tutti autorizzati a issare la bandiera della «priorità nazionale». Ma, soprattutto, la permanenza della Gran Bretagna nell’Unione, paese ritenuto il più squisitamente liberista e devoto al libero mercato, viene apprezzata come un antidoto a qualsiasi rischio di «deriva» sociale o solidaristica dell’assetto comunitario.
C’è infatti un «turismo» che, a differenza di quello del welfare, è decisamente più gradito. È il turismo delle condizioni fiscali migliori, della deregulation più permissiva, del costo del lavoro più basso e dei lavoratori più indifesi. Il turismo del capitale non prevede né visti né dilazioni e pretende sempre accoglienza trionfale. La City non intende affatto «armonizzarsi» con le regole bancarie dell’eurozona, ma non rinuncia a operare in piena libertà e senza impedimenti di sorta nello spazio del mercato comune. Il protezionismo applicato alla circolazione delle persone non si applica a quella dei capitali.
Certo, non sono mancate preoccupazioni e proteste per la concorrenza che istituti finanziari senza vincoli possono esercitare nei confronti di istituti sottoposti a regole, né riguardo a quanta voce in capitolo, senza alcuna contropartita in termini di obblighi, avrà effettivamente Londra sulle decisioni e gli orientamenti dell’Unione europea. Ma il sistema della competitività e la fede nel mercato sembrano avere prevalso su questo ordine di preoccupazioni. Alla spregiudicata compagnia della City non si vuole comunque rinunciare. Se qualcuno immaginava uno scontro aspro tra l’ordoliberalismo tedesco e il liberalismo anglosassone sarà rimasto deluso.
Inoltre, tutta questa faticosa messa in scena potrebbe non servire a nulla. Il 23 giugno i britannici voteranno sulla permanenza del loro paese nell’Unione e, tra nostalgici dell’impero, filoatlantici e nazionalisti xenofobi, il bottino di Cameron rischia fortemente di non bastare a evitare il Brexit. Del resto possiamo essere certi che il referendum in Gran Bretagna non farà la fine di quello di Atene. Ma, visto il ruolo che vi svolge e che le élites finanziarie le assegnano, dovremmo davvero disperarci per il commiato della Gran Bretagna dall’Unione? Dalla quale, per quel che ci preme, si può dire che sia già fuori.
 Brexit. Intervista di Massimo Sideri a Vittorio Colao. Europa politica:«Il sogno dei padri fondatori può rimanere ma bisogna modernizzarlo. Oggi è sul benessere, l’occupazione giovanile e il progresso scientifico e sociale che ci giochiamo il futuro dell’Europa».
Brexit. Intervista di Massimo Sideri a Vittorio Colao. Europa politica:«Il sogno dei padri fondatori può rimanere ma bisogna modernizzarlo. Oggi è sul benessere, l’occupazione giovanile e il progresso scientifico e sociale che ci giochiamo il futuro dell’Europa».
Corriere della Sera, 21 febbraio 2016 (m.p.r.)
Come voterà al referendum sulla Brexit Vittorio Colao, a capo di una delle più importanti multinazionali inglesi, il gruppo Vodafone?
«Io sono italiano, non voto in Gran Bretagna»
Allora come voterebbe?
«Quello che posso dire è che sono gli elettori che devono decidere. Come azienda non esprimiamo un giudizio politico, ma certo per i nostri i clienti, i nostri azionisti e anche i nostri dipendenti è molto meglio che la Gran Bretagna faccia parte dell’Europa».
Considera quello di Cameron un buon accordo?
«Penso che abbia portato a casa cose importanti per la Gran Bretagna: il controllo dei costi dei benefit e la clausola di salvaguardia dell’euro. Poi ci sono delle cose un po’ minori come la questione dei matrimoni. Tutto sommato ha ottenuto quello che cercava, ora deve convincere i britannici che gli conviene».
Qual è il clima nella City? Ve lo aspettavate?
«La maggioranza del mondo del business preferisce una Gran Bretagna dentro l’Ue. Nel caso di Vodafone poi è ovvio che sia così: si parla del mercato unico digitale e una frattura sarebbe un controsenso».
E l’umore per le strade?
«Credo che in generale ci sia una certa preoccupazione per la complessità e anche a volte la farraginosità dei meccanismi europei. Questo crea onestamente una frustrazione superiore al danno effettivo che l’Ue può fare ai britannici. Ora è il momento della razionalità e non delle frustrazioni».
In Gran Bretagna si respira più preoccupazione per la crisi o più ottimismo per la ripresa?
«Si respira aria di ripresa. La Gran Bretagna ha fatto un lavoro migliore sulla riduzione dei costi della macchina amministrativa. È un modello molto liberale e molto aperto: guardiamo ai numeri, i giovani europei vengono in gran numero a Londra e in Gran Bretagna. Questo modello sta pagando ed è questo che gli inglesi hanno paura di perdere».
Ipotesi uno: vince il no alla Brexit. Cosa vorrà dire avere uno «status speciale»?
«Sono un ottimista pro Europa ma sono anche molto pragmatico: la condizione speciale è riconoscere nei fatti quello che c’è già oggi e cioè una Gran Bretagna senza euro e che non vuole andare verso l’unione politica. Riconoscerlo è stato un atto di grande pragmatismo anche da parte di Juncker. Non cambia un granché».
Il governo inglese non si riuniva di sabato dalla guerra delle Falkland/Malvinas. Ma gli inglesi lavorano più o meno degli italiani?
«Gli italiani lavorano molto ma i britannici sono molto ben organizzati, non solo nel mondo della politica ma anche nelle aziende. L’organizzazione e il metodo di lavoro che arriva dal Commonwealth sono la grande eredità. Ma l’italiano che non lavora è uno stereotipo ed è falso».
Veniamo all’ipotesi due: il Regno Unito se ne va. Vede dei rischi?
«Penso che sarebbe per tutti molto complicato perché nessuno saprebbe esattamente quali meccanismi di uscita verrebbero adottati. Il cosiddetto modello Norvegia non dà grandi benefici e ci sarebbe una grande incertezza».
Tutti i grandi Paesi europei - penso anche alla locomotiva tedesca - hanno l’euro. Cosa rappresenta la sterlina per gli inglesi?
«Credo che grazie alla sterlina la Gran Bretagna abbia mantenuto una grande flessibilità e grande capacità di reazione nella gestione della politica economica che per uno Stato liberale e molto orientato al mercato ha avuto efficacia. La nostra cultura continentale, siamo anche confinanti, si è ben sposata invece con il concetto di moneta unica, ma dobbiamo completare alcuni passaggi. Io non sono tanto critico: la Bce ha lavorato bene e la leadership di Draghi ha stabilizzato i mercati. Ma mancano dei meccanismi».
Ne dica uno, fondamentale.
«Il completamento del mercato unico e l’eliminazione delle barriere burocratiche e regolamentari. Nel nostro settore, le telecomunicazioni, abbiamo mille regolatori, ognuno con la propria opinione. Abbiamo politiche locali invece che continentali. Parliamo di reti 5G quando ancora non ci sono le regole sugli spettri europei».
Ha detto che gli inglesi non vogliono l’Europa politica che era il sogno dei padri fondatori. Ma lei cosa ne pensa? La vorrebbe?
«Il sogno dei padri fondatori può rimanere ma bisogna modernizzarlo. Loro avevano in mente la guerra, i rischi di frattura Est-Ovest. Volevano evitare che ci fossero nuove guerre e quindi, giustamente, avevano una visione orientata alla coesione. Ma credo che nessuno oggi possa avere il minimo dubbio che ci debba essere la pace tra Germania, Italia e Francia. Oggi è sul benessere, l’occupazione giovanile e il progresso scientifico e sociale che ci giochiamo il futuro dell’Europa. In questo senso le tensioni che ci sono in Europa e che portano molti voti a chi offre demagogia e derive nazionalistiche ne sono una conferma».
Massimo Sideri
Sul voto inglese l'opinione di Timothy Garton Ash e l'intervista di Enrico Franceschini allo scrittore Alan Bennet.
La Repubblica, 21 febbraio 2016 (m.p.r.)
È IN GIOCO IL FUTURO
ECCO PERCHE TUTTI DEVONO
COMBATTERE LA“BATTAGLIA D'INGHILTERRA”
di Timothy Garton Ash
È iniziata una nuova Battaglia d’Inghilterra. Dal suo esito dipenderà il destino di due unioni, il Regno Unito e l’Unione Europea. Se gli inglesi voteranno per uscire dalla Ue, la Scozia voterà l’uscita dal Regno Unito. La Gran Bretagna non esisterà più. E lo shock della Brexit su un continente già scosso da altre crisi potrebbe essere l’inizio della fine dell’Unione Europea.
Se teneta alla Gran Bretagna o all’Europa, e meglio se tenete ad entrambi, impegnatevi in questa battaglia. L’accordo di Bruxelles non è l’ideale, ma la partita è ancora tutta da giocare. Gli europei del continente spesso considerano gli inglesi incorreggibilmente ostili all’Europa. Non è vero. Da decenni i sondaggi rilevano che esiste un’ampia parte di indecisi che possono spostarsi in una direzione o nell’altra. Accadde al referendum del 1975 quando si registrò un forte spostamento dal no al sì all’Europa: è possibile che si ripeta oggi. Il 42% di chi nei sondaggi ha dato un’indicazione di voto potrebbe cambiare idea. Particolarità di questo referendum, poi, è che ad avere diritto di voto sono i cittadini dei paesi del Commonwealth, mentre francesi, italiani, tedeschi che vivono da tempo in Gran Bretagna e ne subiranno le conseguenze, sono esclusi. Che abbiate diritto di voto, o meno, una voce l’avete. Fatela sentire. Vi suggerisco un paio di argomenti.
Innanzitutto il problema vero non sono i dettagli dell’accordo. Quando Cameron mesi fa rese nota l’agenda negoziale, era già chiaro che non saremmo arrivati a una ridefinizione del nostro rapporto con la Ue, né che ci saremmo ritrovati in un’Europa “riformata”. Su questo hanno ragione gli euroscettici: le istanze di Cameron erano più modeste di quanto le abbia fatte apparire e il risultato ottenuto è piccolo. Ma sarebbe folle far dipendere il futuro economico e politico della Gran Bretagna nei prossimi decenni da un dettaglio come il freno alle prestazioni di sicurezza sociale ai lavoratori immigrati. La Brexit è rischiosa. È indiscutibile. Come si sta dentro la Ue lo sappiamo, come si starebbe fuori, no.
Negoziare la Brexit sarebbe d’altronde impresa lunga e faticosa. Nigel Lawson e altri fautori dell’uscita sostengono che basta abrogare l’Atto unico europeo del 1972 e saremmo liberi. A loro avviso i nostri partner continentali ci concederebbero generoso accesso al mercato unico grazie a un accordo li libero scambio «più utile a loro che a noi». Bel sogno. Vi consiglio di leggere l’attenta analisi di Jean-Claude Piris, ex direttore dei servizi giuridici della Ue, per capire che incubo sarebbe districare quella matassa giuridica. Parlatene ai politici continentali. Quello che abbiamo visto a Bruxelles è il massimo che sono disposti a fare. Non ci farebbero favori in caso d’uscita. L’accordo di Bruxelles dimostra che i partner europei hanno accettato la volontà della Gran Bretagna di fermarsi all’attuale livello di integrazione. La situazione ottimale, se esiste, è quella odierna, non la Brexit. Fa freddo fuori.
Più guardiamo a Norvegia e Svizzera, meno la loro posizione appare attraente e molti imprenditoria e sindacati britannici non vogliono prendersi quel rischio. La Ue ha usato il potere d’attrazione del suo mercato unico di 500 milioni di consumatori per garantirsi vantaggiosi accordi di libero scambio con gran parte del mondo. È contro ogni logica pensare che la Gran Bretagna farebbe affari migliori da sola. Michael Froman, responsabile del Commercio Usa, lo scorso anno ha affermato che se la Gran Bretagna uscisse dalla Ue non sussisterebbe alcun accordo di libero scambio e gli Usa non avrebbero nessun interesse a negoziarlo. Non solo. L’adesione alla Ue ci pone al riparo da terrorismo e criminalità internazionale. Non sono io a dirlo, ma Theresa May, ministro degli interni conservatore. Per questo ha mantenuto la Gran Bretagna nella più importante rete europea di cooperazione giudiziaria e di polizia e si è schierata contro la Brexit.
Restare nella Ue è vitale per la sicurezza interna. Il feldmaresciallo Lord Bramall, non è certo un paladino entusiasta dell’Unione, fa notare che se ne uscissimo la nostra sicurezza sarebbe messa in pericolo da «un’Europa oltremanica piegata e demoralizzata». Se restiamo possiamo essere fautori di una politica estera europea che affronti la cause di problemi profondi come quello dei profughi. Vladimir Putin e Marine le Pen ci vogliono fuori. Barack Obama, Angela Merkel e tutti i nostri tradizionali amici, in Europa, Nord America e Commonwealth, ci vogliono dentro. Serve dire altro?
La Brexit sarebbe diastrosa per l’Irlanda. L’ex premier John Bruton sostiene che «annullerebbe l’opera di pacificazione, sollevando pesanti questioni sui confini e sull’accesso al mercato del lavoro». Da noi risiedono più di 380 mila irlandesi che hanno diritto di voto in questo referendum. Milioni di britannici (come me) hanno origini irlandesi. Se avete a cuore l’Irlanda, votate per restare nella Ue. La Scozia lascerebbe il Regno Unito. Se non volete, votate per l’Ue. La Ue si può cambiare. Le riforme ottenute da Cameron sono modeste, ma in paesi come la Germania molti credono che le riforme siano imprescindibili e non una scelta da fare obtorto collo per mantenere la Gran Bretagna nell’Unione. Se restiamo quella lobby di fautori di riforme si rafforza. Questi argomenti sono improntati alla cautela, non a un visionario ottimismo. Gli euroscettici li definiranno allarmistiche. Se si può definire allarmismo invitare qualcuno a non buttarsi da un transatlantico senza salvagente col mare forza nove. In realtà è solo semplice buon senso.
Traduzione di Emilia Benghi
“NON CHIUDIAMOCI NELLA NOSTRA ISOLA GRIGIA”
intervista di Enrico Franceschini
«Abbiamo radici comuni con Spagna, Francia e Italia: io voterò per restare»
Londra. «Noi inglesi abbiamo già fatto abbastanza stupidaggini a riportare al potere i conservatori, speriamo di non farne un’altra ancora più grossa portando questo paese fuori dall’Europa». Alan Bennett non ha dubbi su come votare nel referendum sull’Unione Europea che si terrà in giugno in Gran Bretagna: «Risolutamente sì alla Ue», dice l’81enne scrittore. E poi l’autore di
La sovrana lettrice e tanti altri romanzi e saggi (tutti tradotti in Italia da Adelphi) spiega perché.
Come le pare l’atmosfera politica, dopo l’annuncio dell’accordo fra Gran Bretagna e Ue?
«Indire il referendum è stata una pessima idea da parte di David Cameron, che avrebbe avuto problemi più importanti di cui occuparsi. Noi inglesi abbiamo sbagliato a riportare al potere il partito conservatore, speriamo di non sbagliare ancora portando il nostro paese fuori dall’Europa».
Il rischio esiste?
«Esiste di sicuro, perché in Inghilterra abbiamo tanti populisti ignoranti. Ma mi auguro che alla fine verrà scongiurato e che prevalga il buon senso. Io di sicuro voterò sì alla Ue».
Si sente più europeo o più inglese?
«Sono troppo vecchio per sentirmi qualcosa di diverso da un vecchio abitante di quest’isola, ma non ho dubbi che le generazioni più giovani si sentano europee. E anch’io, quando mi trovo al di là della Manica, in Francia, Italia, Spagna, gioisco all’idea di non avere più frontiere, di sentire che le nostre comuni radici culturali ci hanno portati a stare insieme in amicizia anziché dividerci o farci la guerra come in passato».
Non condivide la linea degli euroscettici, secondo cui ci sono troppi immigrati comunitari a Londra?
«Gli immigrati europei fanno un sacco di mestieri, dall’idraulico al medico, per i quali evidentemente non ci sono abbastanza inglesi. E poi ci portano soldi in tasse e dinamismo. Il problema del nostro paese non sono gli immigrati comunitari bensì le grandi
corporation americane, che non pagano le tasse grazie a scandalose scappatoie legali e trasmettono una cultura estranea alla nostra. L’Inghilterra è il paese che ha inventato il
welfare, l’idea che una società civile debba fornire a tutti un minimo di assistenza sociale, concetto che all’America, com’è noto, non piace affatto».
Allora è d’accordo con l’attrice Emma Thompson quando ha affermato che è meglio restare ancorati all’Europa che rinchiudersi in questa grigia, piovigginosa isoletta?
«Come darle torto? È difficile negare che la Gran Bretagna sia un’isola. E per accorgersi che è grigia e piovigginosa basta guardare fuori dalla finestra, in una giornata come quella di oggi».
 In ricordo di Umberto Eco. Articoli di Claudio Magris, Fabio Mussi, Ezio Mauro e l'intervista di Benedetto Vecchi ad Alberto Asor Rosa.
In ricordo di Umberto Eco. Articoli di Claudio Magris, Fabio Mussi, Ezio Mauro e l'intervista di Benedetto Vecchi ad Alberto Asor Rosa.
Corriere della Sera il manifesto, la Repubblica, 21 febbraio 2016 (m.p.r.)
Corriere della Sera
IL MIO OMAGGIO AL GENIO DI ECO
CHE SAPEVA CAMBIARE (E RIDERE)
di Claudio Magris
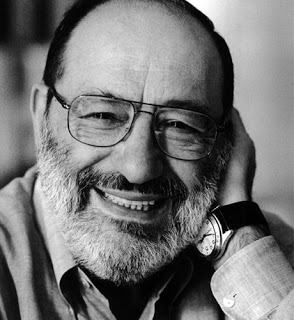
In questo momento non penso solo alla poliedrica genialità di Umberto Eco, ai suoi libri famosi in tutto il mondo, alla sua rara combinazione di creatività letteraria e acutezza analitica. Penso ai nostri incontri, soprattutto anche se non solo agli indimenticabili giorni passati insieme tanti anni fa nella devastata Romania di Ceausescu, alla nostra complicità affettuosamente gaglioffa, alla sua capacità di ricominciare, come stava accadendo con il suo impegno per la fondazione di una nuova casa editrice. Dei suoi libri vorrei ricordare uno che non è il più grande né il più famoso ma che mi ha segnato, Apocalittici e integrati – un libro scritto molti anni fa ma oggi più che mai attuale per affrontare le incredibili, sconvolgenti trasformazioni del mondo e della vita con libero spirito critico, senza ansiosi e ossessivi rifiuti, e senza servile e passiva acquiescenza. E penso a tante fraterne risate che aiutano a vivere meglio.
Il manifesto
RIDERE PER CONOSCERE:
LA RIVOLUZIONE DI ECO
di Fabio Mussi
L'eredità. L’ultima lezione: per una sinistra di alternativa e di governo, sapere è l’indispensabile
«E l’infame sorrise». È Franti, il cattivo di Cuore. Tra le figure della scuola lacrimosa, pia e bigotta del De Amicis a Umberto Eco piaceva Franti. Ha scritto un Elogio di Franti. Perché? Perché rideva. Eco sapeva ridere, Eco rideva. Se volessimo usare il suo fondamentale «Trattato di semiotica generale», e dare una «interpretazione» del «segno» di Eco, eccola: il riso. Nel Nome della rosa - ricorderete - Guglielmo di Baskerville indaga su una catena di delitti consumati in abbazia. I delitti servono a nascondere un documento su un indicibile segreto: Cristo aveva riso. Atto sovversivo, apocalittico, cioè rivelatore. Primo insegnamento da mandare a mente: si è seri solo se si è capaci di ridere, anche di noi stessi.
Ho avuto il piacere e l’onore di incontrarlo più volte. È impressionante quel che sapeva, i collegamenti e i nessi che era in grado di intrecciare. Un aggettivo per la sua cultura? Sterminata. Secondo insegnamento: studiate. Senza studiare la politica non può essere né buona né nuova. Si rafforza per esempio in me l’impressione che noi non sappiamo quasi nulla della ipertrofica macchina economica mondiale che governa gli umani. Esoterica, come la storia del Pendolo di Foucault. Eco si è letteralmente tuffato nel Medioevo. La sua non è stata una ricerca erudita su tempi lontani. Ha fatto scoccare piuttosto la scintilla tra Medioevo ed Evo moderno, nei labirinti di simboli, enigmi, mostruosità, occultismi. Gioco di ombre e di luci.
«Secoli bui» sono stati chiamati quelli antichi. Ma non c’è tanto buio anche nel Moderno? Forse che l’assolutismo del capitale finanziario non sta spingendo la società umana verso un medioevo a più alto livello tecnologico? Non c’è tribalismo, razzismo, antisemitismo, fondamentalismo religioso, fanatismo, pensiero magico, banalità e piacere dello strazio dei corpi che non trovi facile cittadinanza nel mondo globalizzato? Sapete che cosa mi meraviglia, mi sorprende, e mi convince, delle parole lette ed ascoltate da Eco? Il considerare la storia del mondo, almeno dalla scrittura in poi (e non dimenticate che tutto è cominciato in quelle terre che oggi chiamiamo Siria e Iraq), come contemporanea. Si può parlare con il vicino di casa come con Guglielmo di Occam. Lo cito perché è uno degli autori più amati da Eco, ed è noto per il famoso «rasoio».
Una teoria razionalista che qualcuno pone tra i fondamenti della scienza moderna. Dice in sostanza il «rasoio»: non bisogna formulare più ipotesi di quelle necessarie, non bisogna dire più del necessario. Il resto, si direbbe con la moderna teoria dell’informazione, è «rumore», che confonde e maschera l’informazione. Parlo con Guglielmo, e mi chiedo assai spesso quanto devo «tagliare» – faccio un esempio a caso - del diluvio di parole del Presidente del consiglio in carica in Italia per capire esattamente che cosa vuole dire e fare.
Ecco ancora Umberto Eco: Occam e Mike Buongiorno, il basso e l’alto, le profondità della grande cultura e la fenomenologia della vita quotidiana. Egli è stato tra i grandi studiosi della società di massa, e della comunicazione nella società di massa. Il suo Apocalittici ed Integrati è un pilastro. Da cui trarrei per farla breve la terza raccomandazione: se si vuol fare una sinistra che si rispetti non bisogna essere apocalittici. Ma non si può nemmeno essere integrati. E nella comunicazione, se il mezzo non è esattamente il messaggio, tuttavia lo influenza. Sono noti gli scritti di Eco sull’ambivalenza del Web. Ha detto: se un cretino va al bar e spara fesserie, gli astanti lo sfottono. Se va su Facebook, trova legioni di seguaci. Come il leone e la gazzella, intelligenza e stupidità ogni mattina si alzano e si mettono a correre.
Sulla rete circolano entrambe. Ma la stupidità parte con un vantaggio: la velocità. La verità è che l’intelligenza ha bisogno del dubbio, dell’approfondimento, del ripensamento: dell’esitazione. E c’è un Eco politico, impegnato e battagliero. Egli è stato fieramente antiberlusconiano, fino a rifiutare la collaborazione con l’oligopolio editoriale di «Mondazzoli», e aderire al progetto della neonata «nave di Teseo», per la quale - ahimé! - non ha avuto il tempo di scrivere nulla. E voglio dire che, nonostante tante chiacchiere, se nel ventennio di Benito non si poteva dirsi democratici senza essere antifascisti, nel ventennio di Silvio non ci si è potuti chiamare democratici senza essere antiberlusconiani. Sperando naturalmente anche che la serie dei ventenni sia esaurita.
E voglio ricordarlo anche in una particolare occasione: Castello di Gargonza, 1997, governo Prodi da poco costituito. Mi capitò di essere tra i relatori. A favore della coalizione di centrosinistra chiamata «Ulivo». Trovai Eco tra i più convinti sostenitori. Prevalsero i tagliatori d’alberi. Resta il ricordo di ore indimenticabili passate con lui. E il rammarico per una delle molte occasioni gettate al vento. Vediamo di non buttarle tutte al vento. Dipende dalla sinistra che saremo. Una sinistra di alternativa e di governo. Ricordando che, e per l’alternativa e per il governo - traggo quest’ultima raccomandazione dalla vita e dall’opera di Umberto Eco - una cosa è indispensabile: sapere.
La Repubblica
LO STUDIOSO
CHE VOLEVA DIVERTIRE
di Ezio Mauro
Era «una bella mattina di fine novembre, nella notte aveva nevicato un poco» quando frate Guglielmo da Baskerville allo spuntar del sole venne avanti nell’Italia confusa del 1980. Il Paese aveva appena vissuto lo shock del delitto Moro, il punto più temerario della sfida terroristica alla democrazia, e l’inizio della sua caduta. Come su un terreno prosciugato, ripiegavano le Brigate Rosse e si ritiravano le ideologie, e noi entravamo senza bussola in un territorio sconosciuto. Ed ecco quel frate, amico di Occam e di Marsilio da Padova, che si mette in cammino sette secoli fa, procede per sette giorni e 576 pagine insieme al novizio Adso da Melk, viaggia verso settentrione ma senza seguire una linea retta, tocca città famose e abbazie antichissime che incutono paura come fortezze di Dio inaccessibili, masticando le erbe misteriose che raccoglie nei boschi e scrutando di notte, dopo vespro e compieta, le magie stregonesche dell’orologio, dell’astrolabio e addirittura del magnete.
Davanti al successo mondiale del Nome della rosa, tradotto in quarantacinque lingue, Umberto Eco ebbe prima la ritrosia prudente dello studioso di fronte alla contaminazione mondana della scienza, poi seguì divertito il gioco delle sovra-interpretazioni, infine si dedicò alla teorizzazione a posteriori, smontando e rimontando sapere e consumo, letteratura e storia, il caso e il calcolo. Rivelò che tutto era nato da un’idea seminale, perché gli era venuta la strana voglia di avvelenare un monaco. Poi spiegò che scriveva con la pianta dell’abbazia sotto gli occhi, dando ai dialoghi il tempo necessario dei passi per andare dal refettorio al chiostro, perché occorre crearsi delle costrizioni per poter inventare liberamente. Quindi aggiunse che poiché scrivere un romanzo è una faccenda cosmogonica, il suo mondo naturale era la storia e il Medioevo, e questo ricreò nelle pagine. E infine disse l’ultima verità, intima come una confessione: volevo che il lettore si divertisse.
C’è quasi tutto Eco in questa spiegazione di un successo che è una mappa delle intenzioni, perché prima del successo c’è la sfida della grande divulgazione, la scommessa di non cedere alla banalizzazione del sapere ma nello stesso tempo la capacità di costruirsi lettori, accendendo una passione, portandosela dietro fino a scoprire l’eresia estrema, una risata come movente di un delitto. Eco c’è riuscito perché questo percorso rigorosamente controllato nella formazione del romanzo corrisponde perfettamente alla costruzione intellettuale di sé: dunque suona autentico, senza forzature.
Studioso fino alla fine, Eco infatti ha sovvertito l’ordine classico delle strutture accademiche con la nascita del Dams a Bologna, sperimentando sempre ma rimanendo in fondo fedele alla lezione di Pareyson, come se fosse giusto avere un solo maestro. Ma nel 1954 quella generazione un po’ speciale (pensiamo a lui, con Gianni Vattimo e Furio Colombo) ebbe la fortuna di incrociare la Rai nascente, per concorso e non per raccomandazione del sottobosco democristiano: fu naturale prolungare la propria analisi scientifica universitaria con la comunicazione di massa che si affacciava all’Italia, con i nuovi linguaggi, col visivo accanto al letterario, con il divismo sconosciuto del piccolo schermo, con la nuova tecnica che scusava l’ignoranza e la bypassava, fino a fare di Mike Bongiorno il modello perfetto dell’uomo televisivo, che creava per la prima volta un pubblico costituito, la grande tribù italiana del giovedì sera.
Era incominciato il grande incrocio che avrebbe fatto di Eco un personaggio unico, il primo scienziato capace di chinarsi sulla semiologia del quotidiano, curioso di tic e tabù individuali moltiplicati a fenomeni di massa dai nuovi strumenti di comunicazione, linguaggi e modi di dire, attraversati dal gioco di un calembour, riscattati da un paragone letterario sproporzionato perché ironico ma perfettamente coerente, come quando legava Franti con Bresci o portava Mickey Mouse a dormire a Mirafiori, parlando a Minnie in piemontese.
L’alto e il basso del post-moderno trovarono in lui non il primo interprete, ma il nucleo forte, che teneva insieme perfettamente i due registri e li legittimava a vicenda. Quel nucleo centrale, credo si possa nel suo caso riassumere in tre parole: cultura come passione. E il “libro” come strumento universale, il libro capace secondo lui di sfidare anche internet, perché il web in fondo - diceva - è un ritorno dalla civiltà delle immagini all’era alfabetica, alla galassia Gutenberg, all’obbligo di leggere, e non importa quale forma prenderà il supporto che continuiamo a chiamare “libro”.
Leggere «per il gusto di leggere» e non solo per sapere, come Eco scoprirà da bambino. E dietro i libri, borgesianamente e naturalmente, la biblioteca. Cinquantamila libri “moderni”, milleduecento volumi antichi di cui lo scrittore parlava con la passione di una scoperta continua. Senza un catalogo, mossi continuamente dalle emergenze del conoscere, dalla curiosità di un lavoro, dalla memoria che cerca conferma, sapendo che una biblioteca raccoglie i libri che possiamo leggere, e non solo che abbiamo letto, perché è la garanzia di un sapere. Col terrore antico degli organismi che divorano le pagine dei libri, e la vecchia ricetta che consisteva nel piazzare una sveglia negli scaffali, confidando nel rumore regolare e nelle vibrazioni per bloccare il pasto insano dei libri.
L’altro strumento indispensabile alla costruzione del fenomeno Eco sono i giornali, quotidiani e settimanali, mensili, riviste. Li ha criticati duramente, fino al suo ultimo romanzo, ma li ha sempre usati per indagare il quotidiano, per collegare gli scarti di costume della vicenda di ogni giorno con le categorie del suo sapere, capace di ordinare e battezzare i gesti minimi, inserendoli in una sorta di catalogo universale.
Si comincia dal 1959 con quei brevi saggi di costume parodistici pubblicati sul Verri che raccolti in volume daranno poi vita al famosissimo Diario minimo per arrivare finalmente alla Bustina di Minerva dell’Espresso. È come se il registro dell’attualità, grazie ai giornali, desse a Eco la possibilità di un controcanto, un suono appartato ma rivelatore, che scorre a fianco della grande vicenda nazionale ma la sa interpretare rovesciandola spesso nei suoi paradossi, svelandola nell’intimo dei suoi vizi o delle sue verità travestite da miserie del quotidiano.
Pastiches e parodie sono la recitazione in pubblico, ordinata letterariamente, del calembour privato, del motto di spirito che Eco ti diceva per prima cosa incontrandoti, sempre alla ricerca della rivelazione anagrammatica, della saggezza popolare che diventa enigmatica nel nonsense di un proverbio stravolto nel suo contrario, che continua beffardo a dirti qualcosa. Contraffazioni meravigliose, come i falsi rapporti di lettura dei redattori di un’immaginaria casa editrice che bocciano la lettura della Bibbia («un omnibus mostruoso, che rischia di non piacere a nessuno perché c’è di tutto»), di Torquato Tasso («mi chiedo come verranno accolte certe scene erotiche un po’ lascive») e dei Promessi sposi: «tant’è, non tutti hanno il dono di raccontare, e meno ancora hanno quello di scrivere in buon italiano».
Fuori dalla parodia, il sentimento dei giornali ha in realtà consentito a Eco di incrociare l’attualità e di decifrarla coi suoi strumenti, arrivando a un giudizio politico partendo da una notazione estetica, culturale, da un segnale del linguaggio individuale e collettivo. Gli ha consentito, a ben vedere, di prendere parte alla vicenda italiana negli anni più travagliati del Paese. Lo ha fatto senza badare al rischio (ben presente in molti altri intellettuali) di dividere con una presa di posizione politica il grande «fascio indistinto» dei suoi lettori, la somma trasversale della sua popolarità internazionale. Anche qui (e ricordo certe discussioni negli ultimi vent’anni) era come se fosse mosso semplicemente da un obbligo culturale, da un dovere intellettuale, perché la cultura, diceva Bobbio, «obbliga terribilmente ».
Naturalmente quando usò il paradosso, dicendo che la notte prima di addormentarsi preferiva Kafka piuttosto che rincretinirsi davanti alla tv, la muta dei critici di destra gli saltò al collo credendo di inchiodarlo alla sua caricatura. Ci vedemmo in quei giorni, ed era totalmente indifferente agli attacchi perché non lo toccavano, ma credo soprattutto perché quel che aveva detto come battuta, era in realtà profondamente vero. Era vero che i libri lo dominavano come «un vizio solitario». Ed era certo che anche Eco, come i suoi personaggi, diventava in Italia collettivamente “vero” perché la comunità dei lettori aveva fatto su di lui negli anni un investimento culturale e passionale, trasformandolo nell’Intellettuale italiano degli ultimi trent’anni.
Tutto questo lo ha portato all’ultimo atto, il riscatto di una parte del patrimonio di autori Bompiani - partendo da se stesso - dal gigante Mondazzoli per fondare con Elisabetta Sgarbi “La nave di Teseo”. Ne discutemmo a fine novembre, in un salone dell’Accademia dei Lincei. Umberto chiuse la porta e parlò sottovoce, perché confidava uno dei grandi segreti della sua vita, l’ultimo approdo della sua passione, o ancora una volta del suo “obbligo” culturale trasformato in avventura finale, a ottantaquattro anni.
Adesso la nave dovrà salpare da sola, senza il Capitano, ma con il suo nuovo libro
Pape Satan Aleppe, di cui proprio negli ultimi giorni aveva preso in mano la copertina, toccandola e accarezzandola come fa chi ama i libri. Gli avevamo chiesto in tanti che destino voleva avesse la sua biblioteca un giorno, dopo di lui. Adesso che il giorno è venuto, bisogna ricordare cosa rispondeva: non era sicuro che la sua biblioteca gli assomigliasse, perché la passione per i libri ti porta a conservare anche ciò in cui non credi. Tuttavia, non avrebbe voluto che i suoi libri fossero dispersi.
Forse, diceva, verranno comprati dai cinesi: se vorranno, dai miei libri «potranno capire tutte le follie dell’Occidente ».
Il manifesto
QUEL DISINCANTO IRONICO
IN DIFESA DELLA DEMOCRAZIA
intervista di Benedetto Vecchi ad Alberto Asor Rosa
Alberto Asor Rosa non nasconde l’emozione. «Ci ha unito la passione per la parola. Ognuno di noi, a proprio modo, ha cercato nella letteratura e nella comunicazione la chiave per accedere alla comprensione della realtà italiana. Abbiamo seguito sentieri diversi, ma ci siamo molte volte incontrati con la curiosità di capire a che punto eravamo giunti nei nostri percorsi di ricerca».
Raggiunto telefonicamente a Milano, Asor Rosa non si sottrae alle domande. Racconta di discussioni, di pagine scritte, di romanzi letti, di un clima culturale che sembra ormai appartenere a un passato remoto, anche se sono passati solo due, tre decenni. «Scrissi una recensione per la Repubblica a Il nome della rosa. Il libro mi piacque e ne scrissi un elogio. Molti, invece, puntarono l’indice contro il romanzo e Umberto Eco. Operazione decisa a tavolino, pianificata per avere il consenso del pubblico: erano queste le critiche frequenti. Il libro invece a me piacque molto. Ne scrissi citando anche un altro grande scrittore, Italo Calvino. Anche verso Calvino le critiche, siamo agli inizi degli anni Ottanta, non erano tenere. Per entrambi sostenni che si erano molto divertiti a scrivere quei romanzi indicati come mera operazione editoriale».
Già, gli anni Ottanta, il decennio degli integrati, dopo che i vent’anni precedenti avevano vissuto il conflitto con gli apocalittici. Sono gli anni che vedono giungere a maturazione quello che Umberto Eco aveva ipotizzato proprio in Apocalittici e integrati, dove analizzava attentamente il ruolo degli allora nuovi media - la televisione soprattutto - nella formazione dell’opinione pubblica. La pubblicazione de Il nome della rosa diede infatti il via a una polemica che ha visto impegnati lo stesso Eco, Franco Fortini, Asor Rosa, Gian Carlo Ferretti (a quest’ultimo si deve l’espressione di «best seller di qualità» per qualificare proprio libri come Il nome della rosa) e molti altri intellettuali. E come spesso accade, le recensioni furono l’occasione per fare il punto del rapporto tra «letteratura e vita nazionale» e sul ruolo dell’intellettuale in una realtà caratterizzata appunto da un ruolo preponderante della televisione, che dagli inizi degli anni Ottanta in poi, sarà il medium che plasmerà l’opinione pubblica, rispecchiandone e amplificandone i sentimenti più profondi e oscuri. Ed è dalla figura e del lascito intellettuale di Umberto Eco che prende il via l’intervista a Asor Rosa.
Qual è l’eredità intellettuale di Umberto Eco?
Difficile dare una risposta semplice, lineare. Eco è stata una personalità intellettuale complessa. Semiologo, filosofo, letterato, giornalista, appassionato docente. Se si guarda alla sua vita intellettuale e la si confronta con l’attuale povertà della ricerca italiana è difficile fare una sintesi. In lui hanno convissuto una dimensione creativa - i suoi romanzi - e una dimensione scientifica (il semiologo, il filosofo). È stata una personalità fuori dal comune. È il primo intellettuale, in Italia, che ha infranto il confine del consumo di massa. Sapeva produrre romanzi e saggi salutati sempre da alti numeri di vendite. Ed è stato uno dei pochi intellettuali italiani molto letto oltre i nostri confini nazionali. Un personaggio autorevole, dalla Francia agli Stati Uniti, per la sua indubbia capacità di dare voce a un «sentire» diffuso e mai acquiescente verso lo la realtà delle cose. Era già accaduto ad altri intellettuali italiani ma Eco è riuscito a essere intellettuale pubblico internazionale in un’epoca caratterizzata da media sempre più globali.
L’espressione presente in alcuni scritti di Eco è proprio intellettuale pubblico. Non intellettuale organico e neppure intellettuale militante. Ma non è mai stato un uomo di cultura che si è rifugiato dentro le stanze rassicuranti dell’Accademia....
È stato un intellettuale pubblico mai compiaciuto di se stesso e del suo ruolo. L’ho letto sin dai suoi esordi. Il libro che però mi ha colpito profondamente è stato Opera aperta, dove Eco affronta il complesso rapporto tra lettore e pubblico e dove si confronta con il nodo delle ricezioni molteplici dei lettori, che possono rendere un romanzo o un saggio cosa diversa da quella pensata dall’autore. Opera aperta è il libro che manifesta una capacità di innovazione unita a una erudizione massima e un distacco ironico dai cliché accademici dello studioso chiuso in una stanza che tiene fuori quanto accade nel mondo. Questo ironico distacco ha permesso a Umberto Eco di avere un pubblico di massa, facendo sbriciolare il muro dell’insofferenza e dell’indifferenza del pubblico verso temi e argomenti da sempre prerogativa dell’Accademia.
Umberto Eco commentava sempre divertito il fatto che i suoi romanzi fossero best seller. Che ne pensa di questa sua capacità di conquistare l’attenzione del pubblico?
Voglio ricordare un episodio del legame intellettuale che mi univa a lui. Quando uscì Il nome della rosa, le reazioni dei critici non furono generose. Scrissi per Repubblica una recensione dove elogiavo la sua capacità di tessere la trama di un romanzo che catturava l’attenzione senza mai essere banale nella definizione dei personaggi, nella ricostruzione storica del periodo e dei temi che affrontava, come la libertà di ricerca in un clima segnato da dogmatismo. Molti lo criticarono anche aspramente per come era stato prodotto e per l’implicita idea della necessaria indipendenza del letterato dalla contingenza politica. Replicai a molte delle critiche con un altro scritto. Erano due gli autori che erano criticati in quel periodo: Umberto Eco e Italo Calvino. Io sostenni che nello scrivere i loro romanzi si erano divertiti. Questo del divertimento non è una faccenda secondaria, perché denota passione, intenzionalità anche politica. Poi, certo, il divertimento può diventare un limite, diventando anch’esso un vincolo troppo forte, minando la qualità del lavoro di scrittura. Umberto Eco può essere stato discontinuo, ma sarebbe improvvido considerare negativamente i suoi romanzi. Come ho detto è stato una personalità complessa, difficile da definire in maniera tranchant.
Eppure la voce di Umberto Eco è stata meno presente nel corso degli anni. Non crede?
Non sono d’accordo. Ha sempre preso posizione per una difesa delle istituzioni democratiche. Senza nessuna indulgenza per il potere e senza derive populiste. Possiamo dire che è stato meno efficace, ma la perdita di efficacia riguarda tutti gli intellettuali di questo paese. Come non ricordare le settimanali «Bustine di Minerva» apparse su l’Espresso. Sono una vera e propria storia del presente dove non ha fatto sconti a nessuno. Potevi dissentire o esprimere consenso, ma sono comunque esempi di una sua presenza vitale nella vita culturale e politica italiana. L’ultima presa di posizione di Eco ha riguardato il processo di concentrazione editoriale che ha avuto nell’acquisto della divisione libri della Rcs da parte di Mondadori..... Mi sembra che la sua presa di posizione sia stata ammirevole. Si è impegnato in una avventura editoriale dagli esiti incerti quando era già ammalato. Mi sembra che questo riveli la sua coerenza di intellettuale libero, quale è stato per tutta la vita.
 «L’istituto nazionale di statistica ha presentato un dossier con gli “indicatori demografici” relativi all’Italia per l’anno 2015». Articoli di Mariolina Iossa e Roberto Ciccarelli,
«L’istituto nazionale di statistica ha presentato un dossier con gli “indicatori demografici” relativi all’Italia per l’anno 2015». Articoli di Mariolina Iossa e Roberto Ciccarelli,
Corriere della Sera il manifesto, 20 Febbraio, 2016 (m.p.r.)
Corriere della Sera
MAI COSÌ POCHE NASCITE DAL 1861
IN ITALIA È RECORD DI DECESSI
di Mariolina Iossa
Roma. Mai in Italia, dallo storico anno dell’Unità nazionale (1861) ad oggi, sono nati così pochi bambini. Mai, come nel 2015, le «culle sono state così vuote». È questo il dato più scoraggiante che spicca su tutti gli altri indicatori demografici diffusi ieri dall’Istat. Il crollo delle nascite - 488 mila lo scorso anno, 8 per mille, 15 mila neonati in meno rispetto al 2014 - significa che si è raggiunto un nuovo minimo storico di figli medi per donna: siamo a 1,35, ancora in discesa, per il 5° anno consecutivo. L’età media delle donne al primo parto è salita a 31,6 anni.
L’allarme è grande. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin parla di «emergenza demografica» e dell’arrivo di «misure per il sostegno alle donne che lavorano». Conferma «misure fiscali» il ministro Enrico Costa con delega alla Famiglia: «La prossima settimana alla Camera si discuteranno le mozioni a sostegno della famiglia; al Senato le unioni civili. Io sarò alla Camera». In concreto quest’anno il ministero della Salute si avvarrà dei 500 milioni del bonus bebè (fondi che nel 2015 non sono stati utilizzati del tutto) che potranno aiutare le famiglie con più figli ma anche a dotare Comuni e imprese di adeguate strutture ricettive.
Scorrendo i dati Istat c’è un altro numero che colpisce: nel 2015 si è registrato un picco di mortalità mai visto dal secondo dopoguerra, quindi da 70 anni: i morti sono stati 653 mila, 54 mila in più rispetto all’anno prima, letti in percentuale siamo al più 9,1 decessi. L’aumento della mortalità si è concentrato nelle classi di età molto anziane, dai 75 ai 95 anni, ma questo non ha frenato la crescita dell’invecchiamento della popolazione. Anche nel 2015 il Paese era ancora un po’ più vecchio dell’anno precedente. Sono 13 milioni e 400 mila gli ultrasessantacinquenni, il 22%. Diminuisce sia la popolazione in età attiva, quella che va dai 15 ai 64 anni (39 milioni, 64,3%), sia quella fino a 14 (8 milioni e 300 mila, il 13,7%). Si abbassa anche l’aspettativa di vita: scende a 80,1 per gli uomini (era 80,3 nel 2014), e a 84,7 per le donne (da 85).
Più morti, meno nascite, aumento della migrazione verso l’estero (100 mila italiani nel 2015 si sono cancellati dall’anagrafe per andare in un altro Paese), crescita, ma moderata, del numero degli stranieri residenti (5 milioni e 54 mila, 40 mila in più rispetto al 2014 ma molti di meno rispetto al balzo del 2007). Ed ecco il risultato: la popolazione residente diminuisce, siamo 60 milioni e 656 mila, gli italiani 55 milioni e 602 mila, 179 mila in meno in un anno. Insomma, un quadro poco esaltante. Diminuisce, invece, dopo 12 anni, la migrazione interna, siamo sotto il milione e 300 mila, 3% in meno sul 2014. Il saldo migratorio è positivo per il Nord (0,9 per mille abitanti) e Centro (più 0,6), negativo per le regioni del Sud: meno 2,5.
«Il crollo delle nascite è dovuto alla crisi economica, e al generale impoverimento delle famiglie italiane», ha commentato il presidente del Codacons Carlo Rienzi. «Gli italiani che emigrano all’estero, cresciuti del 12%, sono un grave segnale di disagio. Si rinuncia a costruire una famiglia e si va fuori, sono scelte dolorose e sofferte», sottolineano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, presidenti di Federconsumatori e Adusbef. Quanto al picco di mortalità, sia per la Coldiretti, sia per il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Walter Ricciardi, il caldo è tra i principali imputati. «Il 2015 è stato l’anno più caldo dal 1880», hanno ricordato alla Coldiretti. Ricciardi ha anche evidenziato il notevole «calo dei vaccini».
Il manifesto
NASCITE AL MINIMO STORICO, CRESCONO I RESIDENTI STRANIERI
di Roberto Ciccarelli
Un processo di inversione demografica descritto dal report dell’Istat sugli indicatori demografici del 2015: gli ultra 65enni sono il 22% della popolazione, mentre le nascite sono state 15 mila in meno rispetto al 2014: 488 mila, il minimo storico dall’unità del paese. La tendenza era già emersa nel 2014, quando il livello delle nascite si era fermato a una cifra superiore: 503 mila. Il processo ha un impatto sulla popolazione attiva tra i 15 e i 64 anni. La riduzione riguarda entrambi i poli: diminuiscono le persone attive sul mercato del lavoro adulte e quelle in attesa di entrarci (i quattordicenni). Le prime scendono a 39 milioni (64,3%), la seconda rappresenta il 13,7% (8,3 milioni).
Questa tendenza va considerata perché influisce sulla determinazione del tasso di occupazione e disoccupazione, oltre che su quella degli inattivi. La flessione registra l’incapacità di includere in un’attività retribuita regolarmente e riconosciuta ai fini previdenziali una crescente fetta della popolazione, espulsa verso la povertà assoluta e il lavoro nero. Le regioni più anziane sono Liguria (28,2% di ultra65enni), Friuli Venezia Giulia (25,4%) e Toscana (24,9%). Quella più giovane è la Sicilia (20,2%).
L’Istat registra un dato già registrato: i decessi sono maggiori delle nascite. Inevitabile che accada, considerata la composizione demografica di un paese - come molti altri europei, a cominciare dalla Germania - con un’età media alta. Nel 2015 i decessi sono stati superiori alle nascite: 54 mila in più rispetto al 2014 (+9,1%), in totale 653 mila. Le morti si sono concentrate nelle fasce di età più avanzata: 75-95 anni. Il saldo è di meno 165 mila. Il 2015 è stato il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità. La media italiana è di 1,35 figli per donna.
L’Istat registra anche la diminuzione di centomila cittadini italiani che nel 2015 si sono cancellati dall’anagrafe per trasferirsi all’estero: +12,4% rispetto a dodici mesi prima. I rientri in Italia dei residenti all’estero sono stati 28 mila. Aumentano le iscrizioni anagrafiche dei cittadini stranieri dall’estero: 245 mila. Un dato che va confrontato con quelli dell’immigrazione. Nel 2015 sono stati registrati 200 mila cittadini stranieri in più, a cui vanno aggiunti 63 mila nati in Italia. In questo bilancio in crescita vanno aggiunte 136 mila persone straniere, nate in Italia, a cui è stata riconosciuta la cittadinanza. Il numero sta crescendo anno dopo anno: erano 29 mila nel 2005, 66 mila nel 2010. Sono raddoppiate cinque anni dopo.
I «nuovi italiani» e la popolazione straniera residente stanno crescendo e si radicano in una società dove hanno pochi diritti e quelli ottenuti dalla legge sullo «ius soli temperato» sono ancora condizionati ad uno status economico della famiglia di provenienza. Il 59% della popolazione straniera risiede al Nord, oltre un quinto in Lombardia. Il 25% risiede nel Centro: 640 mila nel Lazio. Solo il 16% vive a Sud: 233 mila in Campania. Le motivazioni di questa riduzione demografica sono attribuite a fattori principalmente economici dalla politica e dai sindacati: la crisi economica, la mancanza di una politica industriale, il precariato, una scarsa ma tutta da dimostrare attenzione verso le politiche della famiglia. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha annunciato nuove misure a sostegno delle donne che lavorano e un rilancio del «bonus bebé». A suo avviso «le culle vuote sono il principale problema economico del paese».
I dati Istat hanno creato una nuova emergenza - non si può dire certo sconosciuta - che porterà il governo a presentare «mozioni a sostegno della famiglia», così ha promesso il ministro per gli affari regionali Enrico Costa, alfaniano dell’Ncd. Tra le sue deleghe c’è anche quella alla famiglia», com’è noto materia delle regioni. Considerate le misure analoghe già adottate dal governo, si preannunciano formule parziali estranee ad una chiara visione universalistica della mancanza di tutele - come il reddito minimo - ma organica a una visione frammentata della società. Il calo delle nascite e della riduzione della popolazione attiva può essere dovuta alla mancanza di un lavoro dignitoso. E anche alla pervicace mancanza di un welfare universale. ro. ci.
L'appello dei parlamentari europei, la cronaca di Giuseppe Acconcia sulle proteste spontanee contro i metodi della polizia egiziana, l'intervista di Viviana Mazza a David Runciman.
Il Fatto Quotidiano, il manifesto, Corriere della Sera, 20 febbraio 2016 (m.p.r.)
Il Fatto Quotidiano
“CASO REGENI
LA MOGHERINI INTERVENGA”
l'appello di Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat e altri 43 parlamentari europei
Il 2 febbraio 2016 il corpo di Giulio Regeni, il ricercatore italiano dell’Università di Cambridge scomparso al Cairo il 25 gennaio, è stato ritrovato in un fosso lungo una strada dei sobborghi del Cairo, con segni di orribili torture e di una morte violenta. Non è stato un semplice incidente, come affermato da un influente membro del Parlamento europeo nel corso di una visita ufficiale al Cairo. Regeni stava svolgendo una ricerca sullo sviluppo dei sindacati indipendenti nell’Egitto del dopo-Mubarak e del dopo-Morsi.
Questo ci rammenta che il governo militare egiziano non sta contrastando solo la minaccia terrorista ma, in parallelo, una vasta opposizione sociale, largamente negletta dai media e dai governi europei. Giulio Regeni non era un giornalista né un attivista. Era uno studioso entrato in contatto con persone e associazioni della società civile che erano oggetto della sua tesi di dottorato e della feroce repressione degli apparati di sicurezza nazionale. Dopo la sua morte, più di 4.600 accademici di tutto il mondo hanno firmato una lettera aperta chiedendo un’inchiesta sulla sua morte violenta e sul numero crescente di scomparse forzate in Egitto.
Solo nel 2015, la Commissione Egiziana per i Diritti e la Libertà (ECRF) ha denunciato la scomparsa di 1.700 cittadini. Il caso Regeni si aggiunge alla lista di sparizioni che si sono verificate in Egitto dopo l’elezione a Presidente di Abdel Fattah al-Sisi. Siamo consapevoli che l’inchiesta sulla morte di Regeni non è ancora conclusa, e che l’indipendenza delle indagini non è garantita, ma crediamo che quanto è accaduto a lui e a migliaia di vittime egiziane come lui non possa essere trattato alla stregua di un “incidente”.
Deve condurre a un ripensamento dell’appoggio fornito dall’Unione Europea al governo egiziano, assicurando che la questione dei diritti umani sia affrontata nella maniera più esplicita e in considerazione della loro sempre più palese violazione nel Paese, certificata da numerose Ong, da Human Rights Watch e da Amnesty International. Sottolineiamo la nostra preoccupazione per il ruolo che gli interessi economici e geostrategici degli Stati europei potrebbero assumere. Tale ruolo non deve portare a un abbassamento della nostra vigilanza sui diritti umani, sul pluralismo democratico, sulla libertà di parola, sul sindacalismo indipendente. È l’opposto che deve accadere.
Chiediamo a Federica Mogherini, come Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri, di agire con forza per ottenere un’indagine indipendente sull’assassinio di Regeni. I responsabili del suo brutale omicidio devono rispondere della loro azione, e la richiesta di verità e giustizia deve essere soddisfatta.
Il manifesto
REGENI, CRESCONO I SOSPETTI SULLA SICUREZZA DI STATO
di Giuseppe Acconcia
Egitto. Montano al Cairo le proteste contro la polizia. Due morti a Darb el-Ahmar e Assiut
Il nome di Giulio Regeni è sulla bocca di tutti al Cairo. Tra i tavoli dei bar di Sayeda Zeinab e nei caffè di Abdin, il centro antico della capitale egiziana, le responsabilità della polizia egiziana e più nello specifico della Sicurezza di Stato (Amn el-Dawla) sono evidenti. I segni sul corpo di Giulio parlano chiaro e rimandano alle pratiche dei torturatori per antonomasia che ogni giorno sconvolgono le vite di centinaia di giovani egiziani.
I primi a non poter più sopportare le pratiche arbitrarie degli scagnozzi del regime sono proprio gli egiziani. Se le proteste del 2011 sono iniziate per criticare i crimini dei poliziotti, per ricordare la morte di un giovane ad Alessandria, Khaled Said, ucciso proprio dalla polizia locale, le cose sono solo peggiorate negli ultimi anni. Tra il 25 e il 28 gennaio 2011 la polizia era quasi sparita dalle strade del Cairo. Finché non è stata chiara l’ondata controrivoluzionaria che ha rinvigorito il ministero dell’Interno. Proprio con l’accordo tra militari e polizia è stato possibile realizzare il golpe militare del 3 luglio 2013. Da quel giorno è iniziata la vendetta della polizia e dei magistrati contro i Fratelli musulmani: centinaia di condanne a morte, arresti sommari, omicidi di massa.
Ma la polizia nel regime militare di al-Sisi può fare davvero il bello e il cattivo tempo. Giovedì sera due uomini tra cui un poliziotto sono saliti su un taxi Suzuki nel quartiere di Darb el-Ahmar, nel centro antico del Cairo. Una volta raggiunta la loro destinazione si sono rifiutati di pagare il tassista: una pratica comune per i poliziotti che vivono di piccole tangenti, minacce e corruzione. Ne è nato un alterco e il tassista è stato ucciso. Le ricostruzioni si fanno sommarie ma sembra che il poliziotto sia stato aggredito dalla folla.
È subito iniziata una protesta spontanea nel quartiere contro la polizia. Un caso simile si è verificato lo scorso giovedì ad Assiut, città dell’Alto Egitto. Un altro dei quartieri cairoti dove gli scontri tra cittadini e polizia sono all’ordine del giorno è Matareya. La zona ha una forte maggioranza di Fratelli musulmani. Lì le pratiche della polizia sono sempre più dure e le torture contro gli islamisti moderati quotidiane. Proprio i medici degli ospedali di Matareya hanno protestato per la continua falsificazione dei report dei torturati, imposta con minacce dalla polizia locale.
Stavolta, con Giulio Regeni, la fabbricazione di prove false potrebbe non bastare per le autorità egiziane. Sebbene la stampa filo-governativa stia accreditando la pista dell’omicidio deciso dalla Fratellanza musulmana, nessuno crede a questa ricostruzione. Gli islamisti moderati hanno subìto la più dura repressione della loro storia. I loro leader sono in prigione, incluso l’ex presidente Morsi, con accuse vaghe e inconsistenti. Il partito, Libertà e giustizia, la confraternita e anche la Coalizione per la legittimità, nata per difendere l’ex presidente eletto, sono state dichiarate fuori legge dal 2014 in poi. Accusare quindi il primo partito di opposizione della morte del giovane dottorando italiano è davvero l’ultimo dei depistaggi per non risalire alle vere responsabilità.
Vari apparati potrebbero essere coinvolti nell’arresto, tortura e morte di Giulio. Prima di tutto il Mabahes (la polizia investigativa). È una polizia di primo livello impegnata a prelevare i sospettati di reati politici. Tra gli esponenti del Mabahes figura proprio Khaled Shalaby, detto «Erkab» (che in arabo vuol dire «sali in macchina»). Shalaby è un torturatore, condannato in primo grado dal tribunale di Alessandria, e a guida delle indagini nel caso Regeni. Dal Mabahes, Giulio Regeni potrebbe essere passato di mano in mano fino ad arrivare all’Amn el-Dawla dove sarebbe stato torturato per giorni. Non è ancora chiaro quanti giorni siano passati dal momento dell’arresto alla morte. Qui sono intervenuti anche tanti ritardi sia nella diffusione della notizia sia nell’attivazione delle autorità competenti da parte egiziana.
È possibile che nell’arresto di Giulio sia intervenuta anche l’Amn el-Markazi (Sicurezza centrale). Tuttavia, questo gruppo paramilitare è controllato dall’esercito e di solito non opera nella zona di Doqqi. Se però Giulio Regeni è stato arrestato nei pressi della metro Mohamed Naguib anche Amn el-Markazi potrebbe essere coinvolta nel prelevamento del giovane, mentre non sono impegnati in arresti le forze della polizia militare (shorta al-askareya) che di solito intervengono solo in caso di grandi manifestazioni ed erano molto impegnate in piazza Tahrir. Le lunghe torture sono spesso perpetrate anche dai baltagy (criminali) alle dipendenze degli uomini del ministero dell’Interno. Si tratta di malavitosi difficili da controllare e che spesso agiscono impunemente e dispongono di grandi somme di denaro che poi reinvestono in piccoli business e negozi nelle aree dove vivono.
Infine, sono state diffuse le immagini della decapitazione di due uomini in borghese da parte di Beit al-Mekdisi, gruppo attivo nel Sinai. I due sono presentati come delle spie dell’Intelligence militare. I jihadisti del Sinai rivendicano la loro affiliazione allo Stato islamico (Isis) e si sono resi responsabili di decine di arresti sommari, decapitazioni e attentati. Sono centinaia i soldati e i poliziotti uccisi nella regione dove vige ormai da mesi lo stato di emergenza.
Corriere della Sera
L’INTERVISTA
«REGENI NON FACEVA RICERCA POLITICA. STIAMO RIVEDENDO I CRITERI DI RISCHIO»
intervista di Viviana Mazza a David Runciman
Runciman, direttore del suo dipartimento a Cambridge: troppe speculazioni
Professor David Runciman, qual è il suo ruolo rispetto agli studi di Giulio Regeni a Cambridge?
«Io sono il capo del dipartimento di Politica e Studi internazionali e questo include il centro per gli Studi dello sviluppo dove lavorava Giulio. Ho la supervisione di tutti gli studenti che lavorano all’estero, sappiamo delle ricerche che conducono e ci assicuriamo che si tratti di lavoro accademico convenzionale, ho avuto questo ruolo con Giulio, ed eravamo consapevoli che stava lavorando anche con l’American University in Cairo».
Ha cominciato a settembre e la fine del lavoro sul campo era marzo. Doveva scrivere durante questo periodo?
«No, il punto del lavoro sul campo è di fare ricerca, lavoro d’archivio, interviste; e ci si aspetta che poi si finisca a Cambridge, non c’erano report che stava scrivendo per noi mentre era là».
Maha Abdelrahman era la sua unica supervisor a Cambridge?
«Maha era la sua supervisor e lo seguiva come seguiamo tutti gli studenti».
Gli investigatori dicono che sarebbe stato spinto a intensificare le sue ricerche in modo più partecipativo.
«Sono speculazioni senza base, e distraggono dalla questione centrale. Vogliamo sapere la verità su chi l’ha ucciso. Era un ricercatore accademico innocente ed è stato brutalmente assassinato».
Lei parla di ricerca mainstream ma altri ricercatori che trattano questi temi hanno avuto problemi con le autorità al Cairo. Non c’è una responsabilità dei docenti quando un ricercatore è mandato in un luogo potenzialmente rischioso?
«Riconosciamo di avere una responsabilità per tutti gli studenti. Giulio lavorava su un tema mainstream, cioè non un tema politico, si trattava di analisi su economia e sviluppo. Quello che gli è successo è completamente inspiegabile».
Una email di Giulio mostra che voleva fare domanda per un fondo di diecimila sterline della Antipode Foundation, un progetto tra attivismo e ricerca.
«Le ricerche che sappiamo stava conducendo non erano in un territorio opaco tra attivismo e ricerca, si trattava di ricerca accademica. Non ho visto quest’email e non commenterò».
La supervisor è stata sentita dalla Procura di Roma.
«Maha era al funerale di Giulio, è stata portata via dalla polizia e interrogata dal procuratore in circostanze che noi consideriamo estremamente insensibili, non le sono state date sufficienti spiegazioni e non parla italiano. Era in Italia per piangere Giulio, quello che è stato detto ai media italiani dopo quel colloquio non ha basi, sono state rivelate cose che si dichiara che avrebbe detto, ma lei non ha detto. Non era in grado di capire cosa veniva detto sul suo conto».
Il dipartimento ha un modulo di valutazione del rischio, un risk assessment form, quando gli studenti vanno all’estero?
«Sì, per Giulio l’ho firmato io. Abbiamo seguito i consigli del Foreign Office. Il Cairo era un posto del tutto sicuro secondo il British Foreign Office. Il fatto che qualcosa di terribile sia accaduto non invalida il fatto che quando è partito, era in linea con i criteri dei rischi».
Il risk assessment è cambiato per mandare altri studenti al Cairo?
«Lo stiamo rivedendo, anche se la valutazione del Foreign Office non è cambiata».
Cambridge avrebbe approvato il fatto che Giulio voleva scrivere per il manifesto?
«Il nostro lavoro era di approvare il suo lavoro accademico».


 «Questa legge è irricevibile. pensare che uno Stato in Europa possa fare una legge sulle unioni civili senza garantire i diritti dei bambini è inconcepibile». Ma ormai è una tattica consolidata:basta approvare una legge la cui etichetta possa essere venduta nella campagna elettorale: non fa nulla se dentro c'è solo veleno.
«Questa legge è irricevibile. pensare che uno Stato in Europa possa fare una legge sulle unioni civili senza garantire i diritti dei bambini è inconcepibile». Ma ormai è una tattica consolidata:basta approvare una legge la cui etichetta possa essere venduta nella campagna elettorale: non fa nulla se dentro c'è solo veleno.