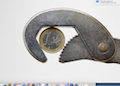«La stella rossa sovrastava una stazione ferroviaria della ex Jugoslavia è trasportata a Palazzo Madama, a Roma, dove è stata oggetto di un’esposizione insieme ad altre testimonianze della Storia dell’ultimo secolo».
«La stella rossa sovrastava una stazione ferroviaria della ex Jugoslavia è trasportata a Palazzo Madama, a Roma, dove è stata oggetto di un’esposizione insieme ad altre testimonianze della Storia dell’ultimo secolo».
La Repubblica 28 ottobre 2016 (c.m.c.)
«È finita la benzina, non ne abbiamo più per continuare il viaggio». Il militante socialista francese, al quartier generale, parla così della presidenza di Hollande e del suo partito davanti ai cronisti. E descrive le riunioni come un «funerale di famiglia». Ma questa cupa atmosfera tra i socialisti riguarda solo la Francia? A Parigi piangono, ma anche a Madrid, Londra e Berlino hanno poco da festeggiare. I momenti della sinistra “gloom and doom” — come li chiamava Eric Hobsbawm, avvilimento e senso di fosco destino — non sono nuovi, ma stavolta la speranza non trova varchi.
Nella capitale francese i sondaggi confermano il militante scoraggiato. Alle prossime presidenziali il leader socialista in carica non arriverebbe al ballottaggio, dietro a Le Pen e Juppé (o Sarkozy?) e forse persino a Mélenchon. Il suo indice di gradimento ha raggiunto il minimo depressionario del 4%. Altrove in Europa le percentuali sono più alte, ma nessuno appare in corsa per la vittoria, come accadeva non tanto tempo fa.
Pedro Sánchez si è dimesso dopo 9 mesi di tormentosa resistenza all’idea di appoggiare il governo Rajoy; ora il Psoe ne consentirà, con l’astensione, la nascita. Che sia o no una vera coalizione, sarà Podemos a trarne beneficio. E la sinistra aggraverà le sue divisioni.
La Spd di Sigmar Gabriel naviga anche lei con le vele ammosciate intorno al 20 per cento; il suo elettorato è saccheggiato dalla Linke e dai populisti, gli iscritti sono scesi da un milione a 400mila, ed è al governo, ma solo perché sta sulla scia della Merkel.
Il Labour di Jeremy Corbyn appare sempre più lontano dal governo. Il leader dell’opposizione britannica ha vinto il congresso nonostante lo scontro con il gruppo parlamentare e il gabinetto ombra. Ha potuto proclamare il suo come «il più grande partito socialista dell’Europa occidentale». Detto da lui sembra una buona notizia, che esalta il nucleo dei suoi sostenitori, ma quelle parole segnano anche un cambiamento radicale, la fine del New Labour inteso come grande partito di centrosinistra, capace di tenere i conservatori all’opposizione per tre mandati. Socialismo per Corbyn significa nazionalizzazioni e dunque rappresenta un’inversione di marcia che sta portando il gruppo dirigente fino al rischio di una scissione.
Questi quattro grandi partiti sono presi nella morsa degli interrogativi sulla propria identità: forze con un passato di governo, con un seguito e un’organizzazione imponente, e oggi assediate dal voto populista e ristrette in dimensioni e ruoli minori. Non hanno retto al cambio di paradigma dell’economia e della politica. La perdita di chiari connotati sociali o ideologici, la frammentazione sociale e comunicativa, l’aggregarsi del consenso in forme volatili intorno a leadership con poche, o senza, mediazioni organizzate, tutto questo scatena reazioni nostalgiche. E la sinistra italiana?
Se il Labour aveva fatto il salto nella nuova dimensione nel ‘98, il Partito democratico italiano l’ha cominciato 9 anni dopo, nel 2007, assumendo con Veltroni la forma attuale, disegnata per conquistare la maggioranza senza coalizione, e completandola con Renzi che ha allargato i consensi nel bacino elettorale del centro. Ma i laburisti hanno ora praticamente revocato l’innovazione e nei sondaggi stanno a distanze abissali dal governo.
Quanto al PD, invece, la difende ancora, anche se l’erosione populista e la minaccia permanente di una guerra civile interna ad opera della minoranza tendono a riportarlo al passato. Per aprire, nel 2013, con la vittoria di Renzi, la prospettiva di un partito piglia-tutto, sono state decisive le primarie aperte potenzialmente a tutto l’elettorato e non solo agli affiliati (come invece per il Labour). Non è un caso che siano proprio le primarie il punto di attacco della vecchia guardia, che vorrebbe ricondurre la scelta del segretario ai soli iscritti, per rimettere le cose “al loro posto” e ritornare nel vecchio alveo degli elettori d’antan (nel frattempo fisiologicamente diminuiti). Un ritorno alla “normalità’”, insomma, che viene implacabilmente desiderato, da alcuni, come un destino di ridimensionamento.
Per quanto strano, la struggente ambizione di evitare il governo può fiorire anche a sinistra, non solo tra i populisti dell’antipolitica (il sindaco di Roma ne sa qualcosa). E quando si perdono consensi ci si ritrova, come accade ora ai socialisti francesi, a desiderare di influire sulle primarie degli altri, cioè della destra, per poter votare Juppé, in modo da evitare di ritrovarsi al ballottaggio Sarkozy come unica alternativa a Marine Le Pen (e forse più facilmente con lei soccombente).
Anche l’economista Thomas Piketty, giunti a questo punto, come ha confessato al Nouvel Observateur, è pronto a firmare la carta dei valori della destra (condizione per partecipare alle primarie) pur di assicurarsi il meno peggio, per tutti.
 Disperante rendersi conto di quanto siano antiquati i residui della sinistra novecentesca, se ancora il discrimine è se allearsi o meno (e semmai quanto) con il capitalismo neoliberista rappresentato da Matteo Renzi...
Disperante rendersi conto di quanto siano antiquati i residui della sinistra novecentesca, se ancora il discrimine è se allearsi o meno (e semmai quanto) con il capitalismo neoliberista rappresentato da Matteo Renzi...
il manifesto, 28 ottobre 2016
Sel chiude i battenti. Entro fine anno la creatura politica nata nel 2009 da una scissione del Prc guidata da Nichi Vendola si scioglierà ufficialmente per confluire in Sinistra italiana. La morte del partito-movimento è annunciata, ma alle esequie la famiglia potrebbe presentarsi meno unita di quanto ci si augura in un’occasione del genere. Se n’è discusso in due tappe ieri e l’altro ieri a Montecitorio. L’appuntamento era riservato ai deputati e ai senatori della vecchia Sel, ed è stato concluso da Nichi Vendola, tutt’ora presidente del partito morituro benché da tempo assente dalla scena per note ragioni familiari (ha avuto un bambino e si è preso un periodo sabbatico dalla militanza).
Oggetto del confronto, che a sinistra finisce sempre per essere un eufemismo, è il modo con cui sarà sciolta Sel, «superata» o «liquidata» a seconda di chi parla. La liturgia dovrebbe essere breve, c’è chi sostiene anche troppo sbrigativa: una riunione di presidenza il 4 novembre, poi un’assemblea nazionale il 6 con la proposta da parte di Vendola di un documento di scioglimento che a stretto giro sarà sottoposto alla consultazione degli ex iscritti nelle assemblee provinciali.
Ma la road map ha raccolto dissensi prima in segreteria e poi anche fra i parlamentari. È pacifico lo scioglimento di un partito di fatto già inesistente (un po’ ovunque, ma non dappertutto, i militanti sono passati sotto le nuove insegne di Sinistra italiana). Non è pacifica invece la modalità del travaso o della «trasformazione» in Sinistra italiana, dove l’eredità di Sel – quella ideale ma anche quella materiale – dovrebbe riversarsi, in teoria, in un contenitore più ampio. Ma c’è chi si preoccupa delle defezioni di peso: dall’ex sindaco Pisapia a quasi tutto il partito sardo, Massimo Zedda in testa, fino alla presidente della camera Laura Boldrini, fredda forse non solo per motivi istituzionali. Uomini e donne della nouvelle vague vendoliana, quella dei tempi del movimento arancione e della coalizione Italia bene comune. Chi resta, chi va e perché: temi delicati da affrontare – altra critica avanzata – nel pieno della «battaglia della vita» e cioè la campagna referendaria il cui esito cambierà comunque tutto il quadro politico italiano. Differenze, «articolazioni», le chiama Nicola Fratoianni, coordinatore di Sel e front man di Si, rimandando tutto all’assemblea, e poi al congresso fondazione del nuovo soggetto, a febbraio.
Perché il vero busillis resta questo: se il nuovo partito debba essere uno dei soggetti della sinistra, magari per stringere poi un cartello elettorale con i compagni di questa strada (Prc, Possibile, Altra europa con Tsipras); o se debba invece tentare il «big bang», vecchio cavallo di battaglia vendoliano, con i militanti e gli elettori in fuga dal renzismo ma fin qui non attratti dalla nuova bandiera. Le due ipotesi vengono vissute in alternativa; non è detto che lo siano. Molto dipenderà dall’esito referendario e da quello che succede nell’adiacente campo del Pd.
Dove intanto qualcosa stavolta pare si muova davvero. Massimo D’Alema ormai parla esplicitamente di «nuovo soggetto di sinistra» e sarà ospite del battesimo a Roma dell’associazione Alternative, che nascerà il secondo week end di novembre dall’interno di Sel per «uscire fuori dal recinto». Il governatore Enrico Rossi, che vota sì «turandosi il naso», cerca sponde a sinistra oltre la Toscana, e infatti oggi a Roma presenterà il suo libro Rivoluzione socialista con Massimiliano Smeriglio (Sel-Si). E poi c’è Pisapia che tenta di «ricostruire un centro-sinistra, o magari una sinistra-centro». Con la benedizione del Pd, renziano e non, per una nuova formazione di sinistra ’alleabile’.
Noterelle sulle lacerazioni tra i diversi "socialismi" (se così si può dire) europei.
L'Espresso, blog "Piovono rane", 25 ottobre 2016
Mentre in Spagna il Psoe fa nascere un nuovo governo di centrodestra, in Belgio il partito socialista vallone inceppa la macchina del Ceta, l'accordo mercatista cugino del Ttip. È curioso che le due cose (Spagna e Belgio) avvengano negli stessi giorni, proprio a esemplificare la lacerante crisi d'identità del socialismo europeo: da un lato chi vuole proseguire sulla strada intrapresa ai tempi di Tony Blair (cioè l'emulazione del centrodestra liberista), dall'altra chi da questa strada vuole fuoriuscire, se non altro perché eccessive sono diventate le diseguaglianze create da quel modello e dalla sua tecno-finanziarizzazione.
Se guardate altri partiti socialisti europei (e non solo), vedete che la dinamica è spesso simile. Il Labour - quello che vent'anni fa ha aperto la strada alla "sinistra che fa cose di destra" - si è spaccato due volte sull'elezione di Corbyn, osteggiatissima dal suo gruppo parlamentare ma fortemente voluta dalla maggioranza dei suoi iscritti (61.8%). In Francia, François Hollande ha conquistato la leadership e l'Eliseo con un programma fortemente di sinistra, poi ha fatto tutto il contrario e oggi è in caduta libera nei sondaggi; alle primarie del Ps sarà sfidato dall'ex ministro dell'Economia Arnaud Montebourg, alfiere della lotta al capitalismo mondializzato e fatto fuori da Hollande proprio perché - secondo lui - troppo di sinistra. Negli Stati Uniti i socialisti come partito non esistono ma la dinamica delle primarie democratiche non è stata così lontana da quella europea: grossolanamente, con un candidato anti-establishment (Sanders) versus un candidato più centrista (Hillary). In Portogallo i socialisti di António Costa hanno scelto di governare con i due partiti della sinistra più radicale: un esecutivo che cammina in bilico tra gli obblighi imposti dalla Troika e il rispetto degli ideali ridistribuitivi della sinistra.
Sull'Italia non voglio dilungarmi troppo per non generare inutili flame su Renzi, cioè il Blair nostrano: basti ricordare che l'elettorato di sinistra è ormai diasporizzato tra l'astensione, il M5s, l'abbrivo affettivo al Pd e i cascami sparsi della cosiddetta sinistra radicale. E va aggiunto che anche dentro al Pd convivono anime blairiane e corbyniane, per capirci.
Più in generale, la situazione dei socialisti nel mondo è nota da tempo: la globalizzazione ne ha ridotto drasticamente i margini di azione, quindi il senso stesso, la ragione sociale. «Partigiani inflessibili del compromesso tra il capitale e il lavoro, i socialdemocratici non possono ritrovare la forza che avevano nel dopoguerra perché oggi i dipendenti non hanno più la possibilità di imporre concessioni sociali al capitale. Questo perché una nuova rivoluzione industriale ha smantellato le grandi fortezze operaie e perché la riduzione delle distanze permette al capitale di sfuggire alle leggi nazionali andando a cercare altrove terreno fertile per i suoi investimenti. L’unico modo che avrebbero i dipendenti e la socialdemocrazia per modificare questa situazione sarebbe quello di favorire l’emergere di una potenza pubblica europea, le cui dimensioni continentali potrebbero piegare anche le più grandi aziende» (Bernard Guetta).
Quello che dice Guetta (l'ultima parte qui citata, intendo) è un po' il tentativo che sta facendo Yanis Varoufakis, con Diem25, ma lo stesso Guetta ne mette in luce le difficoltà, perché oggi se dici "Europa" ai ceti popolari questi mettono mano alla pistola, pensando a Juncker e Merkel, e chi può dargli torto. Di qui comunque tutte le lacerazioni, le spaccature, le discrasie evidenti: come in Gran Bretagna. O come l'ultima, tra la decisione dei socialisti spagnoli e quella dei loro cugini francesi.
E insomma, certo, ha ragione Guetta: l'ipotesi di essere socialisti facendo i socialisti è faticosissima, irta di ostacoli immensi, a rischio di musate clamorose. E potrebbe finire male.
In alternativa c'è l'altra strada, quella assai più comoda percorsa negli ultimi vent'anni, cioè essere socialisti facendo i liberisti, con il plauso della finanza e dei mercati - e il graduale allontanamento dei cittadini. Ma in questo caso - lo insegna bene il Pasok - l'estinzione non è un rischio: è, sul lungo, quasi una certezza.

Il manifesto, 25 settembre 2016
Tra vecchi e nuovi iscritti, i seicentomila che hanno avuto fede in lui sono stati premiati: ieri a Liverpool la parusia – il secondo avvento – di Jeremy Corbyn si è finalmente compiuta. La conferenza di Liverpool ha tributato al leader una vittoria monumentale, col 61% del voto totale contro il flebile 38,2% di Owen Smith, un Giufà immolato all’ultimo momento dai centristi del partito alla forsennata ricerca di un inesistente supereroe moderato che non terrorizzasse gli amichetti della City.
Allo spoglio, con un’impressionante affluenza al voto del 77,6% su 640.500 tra iscritti al partito, al sindacato e sostenitori, Corbyn ha intascato 313.209 preferenze contro le 193.229 del rivale: un esito ampiamente atteso ma che nulla toglie al congresso più atteso della storia del partito laburista, che si apre ufficialmente oggi. Un mandato definitivo, che supera di gran lunga quello che già lo vide improbabile protagonista lo scorso settembre, quando surclassò gli altri tre candidati con un già assai ragguardevole 59,5% delle preferenze.
Nel suo secondo discorso d’insediamento, Corbyn ha fatto voto di rammendare lo strappo profondo confermato da questo suo bis vittorioso. Ha confermato la linea di questi ultimi giorni, aprendo ai dissidenti, sottolineando l’eredità comune che riguarda tutti i laburisti indipendentemente dalle correnti e dichiarandosi disposto a riaccogliere a braccia aperte i cospiratori. «Le elezioni sono una faccenda appassionante e partigiana, in cui a volte nella foga del dibattito da più parti si dicono cose di cui poi ci si pente. Ma ricordiamoci che nel nostro partito sono molte più le cose che abbiamo in comune di quelle che ci dividono. Per quanto mi riguarda, da oggi, voltiamo definitivamente pagina e facciamo assieme quello che dobbiamo fare come partito, tutti assieme».
Secondo Nina Power, senior lecturer in filosofia all’università di Roehampton, la sua travolgente vittoria tra i membri del partito dimostra, nonostante i continui attacchi nei media e le lotte intestine, «che Corbyn si batte per cose che la gente considera importanti: la lotta alla guerra, alle armi nucleari, per l’istruzione gratuita, anche quella superiore, per la sanità pubblica, per l’equa tassazione di coloro che la eludono, contro l’austerità e per il welfare, per la ri-nazionalizzazione delle ferrovie».
Il segretario ha poi affrontato direttamente l’antifona dell’ineleggibilità del partito sotto la sua guida, fino a ieri argomento principale dei suoi tanti detrattori. «Uniti verso il vero cambiamento che il paese necessita, non ho dubbi che questo partito possa vincere le prossime elezioni quando il primo ministro deciderà di convocarle e di formare il prossimo governo». E non si tratta solo di retorica sul filo dell’entusiasmo. I continui tentativi di sabotaggio e soprattutto la frenetica campagna di questi ultimi due mesi, lungi dal fiaccare quest’uomo di 67 anni, l’hanno reso più coriaceo, scaltro e lucido. Non potrebbe trattarsi di esito più crudele e beffardo per le truppe blairiane, ormai malconce e sbandate, che hanno temprato il nemico anziché sconfiggerlo.
L’aforismo nietzschiano «Quel che non mi uccide mi rafforza», gli si addice perfettamente.
Da oggi il sogno della base del partito (e l’incubo dei suoi deputati) si sono irrevocabilmente avverati: il partito laburista cessa di essere quello che era diventato ormai da un buon ventennio, ossia il consiglio di amministrazione di un bieco esistente, capace solo di riverniciarne le sozzerie anziché affrontarne veramente le cause. «È una storica sconfitta per la destra del partito, che lo ha dominato per quasi tutta la sua storia» commenta Jeremy Gilbert, professore di Cultural and Political Theory all’università di East London, «Ora un partito a guida Corbyn si trova di fronte sfide enormi: media ostili, un movimento operaio debole, una destra populista in ascesa, e un’enorme divisione alla base sulla questione dell’immigrazione. Ma sono sfide che si possono raccogliere. La questione è se la vasta maggioranza del partito parlamentare, aduso com’era a un’epoca d’inattaccabile consenso neoliberista, saprà scendere a patti con la nuova situazione, o se invece continueranno a comportarsi come bambini isterici, senza comprendere il danno che recano o la futilità della propria rabbia».
Il trionfo di ieri segna comunque un dato inoppugnabile: il ritorno in questa Gran Bretagna post-Brexit della politica intesa come prassi sul reale, non più dettata dagli uffici stampa e dei pr, capace di parlare non in soundbites o slogan pubblicitari. Come sottolinea Power, «L’era dello spin è finita, nessuno vuole più questi politici leccati, che paiono degli avvocati, non è vero che viviamo in un’epoca “post-verità”: le persone conoscono la differenza fra una persona integra e un bugiardo: e di bugiardi non ne vogliono».

(segue)
Che nella nostra epoca vada in scena, su scala mondiale, un declino della politica appare poco dubitabile. Politica, intendo, come capacità di governo degli uomini, secondo ordinamenti e scelte largamente condivisi dai governati, dunque con carattere egemonico, da parte dei ceti dominanti. E politica come capacità di conflitto organizzato, per rovesciare o comunque trasformare radicalmente l’ordine esistente, da parte della classe operaia e dei ceti popolari. Ambedue gli ambiti appaiono in rotta, e il loro degrado culturale e operativo è a mio avviso, intimamente connesso. Il sovrastante dominio dei ceti economici dominanti sulle classi popolari ha ridotto gravemente l’antagonismo storico che per tutta l’età contemporanea è stato il motore della modernizzazione capitalistica. Qui cercherò di individuare, in rapida sintesi, le ragioni più rilevanti che riguardano la fragilità dell’azione politica nel campo della sinistra.
1 La prima causa credo sia da individuare nello squilibrio tra la dimensione ancora nazionale, territoriale, della lotta popolare e di classe e la natura transnazionale del capitale, aterritoriale della finanza. La politica moderna nasce, per i ceti popolari, come conflitto contro il modo di produzione capitalistico, che ha, nei suoi caratteri genetici, la dimensione mondiale. Ricordano Marx ed Engels, nel Manifesto, che il capitale domina «l’intero globo della Terra» (die ganze Erdkugel). Perciò la scala della lotta contro di esso deve essere mondiale: «proletari di tutto il mondo unitevi». Se nel conflitto tra capitale e lavoro, nelle vertenze dentro la fabbrica, il capitale gode del vantaggio di poter fuggire, di trasferirsi altrove, per gli operai, che in questo altrove non hanno alcun rappresentante, la sconfitta è certa. La possibilità del conflitto è mutilata in partenza. Vero è che nelle società avanzate accanto alla classe operaia operano molti altri ceti e figure, ma a parte il fatto che anche questi sono spesso alle prese con una controparte mobile sul piano mondiale, l’impotenza che si è creata nel cuore originario dell’antagonismo anticapitalistico si riverbera su tutto il resto. Se il nemico scompare, la lotta non ha più direzione, la politica si spegne.
Una prima considerazione di natura propositiva. Il Forum mondiale nato a Seattle nel 1999, che ormai lavora un anno per organizzare un incontro di pochi giorni, mostra l’esaurimento della formula. I movimenti non durano a lungo se non si solidificano in istituzioni. Oggi occorrerebbe poter organizzare uno sciopero internazionale anche di una sola categoria di lavoratori. Oppure mobilitare il boicottaggio commerciale dei prodotti di una multinazionale con la quale si è aperta una vertenza. Se si riuscisse a colpirla sul piano delle vendite, creando allarme sul titolo in borsa, ecc. e infine si vincesse la vertenza , l’esito politico sarebbe immenso. L’esempio vittorioso diventerebbe contagioso. La mobilità mondiale del capitale apparirebbe vulnerabile, la lotta contro di esso premiata e incoraggiata.
Ricordo, a contrario, per limitarci al campo europeo, che i vari sindacati nazionali non hanno neppure provato a creare un coordinamento continentale della rappresentanza operaia. Perciò oggi costituisce un obiettivo di rilievo sostituire i vecchi gruppi dirigenti dei sindacati, eredi di una situazione storica tramontata.
2 A sinistra dimentichiamo facilmente l’evento che ha fatto epoca e il cui fragore non si è ancora spento nei nostri cieli. Il crollo dell’URSS, preceduto da un trentennio di immobilità autoritaria del potere sovietico, ha coperto di un’ ombra di fallimento il più grande progetto realizzato dalla politica nel XX secolo: la rivoluzione d’Ottobre. Quella sua vittoria è degradata in gestione illiberale del potere.
Le critiche di F. A.von Hayeck all’economia pianificata (The Road to the Serfdom, 1944) trovavano, a partire dagli anni ’80, una conferma travolgente. Da allora il pensiero neoliberista, intimamente antipolitico, dilaga. E’ stato agevole ai gruppi dirigenti capitalistici estendere gli attacchi anche ai governi socialdemocratici europei, alle prese con una crescente crisi fiscale dello Stato. Da quel momento si è aperta una divaricazione di valori tra Stato e impresa, politica ed economia. La politica (soprattutto grazie alle retoriche della Thatcher) è stata vestita coi panni del corporativismo sindacale, dell’assistenzialismo scroccone, dell’inefficienza burocratica, dell’incapacità della decisione, di nemica delle libere scelte dell’individuo. Con queste critiche si è affermata una nuova visione del mondo: gli uomini sono incapaci di altruismo e di operare per il bene comune. Solo se perseguono il loro privato interesse agiscono con efficacia e producono ricchezza. Il pessimismo ontologico del pensiero protestante ridava smalto a un Adam Smith ridotto a cantore del libero mercato fondato sugli egoismi umani. L’etica veniva fatta sparire dalle istituzioni pubbliche e dai partiti e fatta rinascere nei liberi appetiti del mercato. L’imprenditore diventa la nuova figura eroica nell’immaginario collettivo.
3 Siamo ancora dentro tale corrente spirituale, non solo per l’effetto perdurante del passato, ma perché essa ha trovato nuove fonti di alimentazione. Una di queste è la spinta del capitalismo finanziario a trasformare lo Stato in azienda. Le procedure di scelta e decisione dei parlamenti e dei governi appaiono troppo lente rispetto alla velocità dell’economia e della finanza. Se un operatore può spostare immense somme di danaro con un gesto che dura pochi secondi, all’interno di società capitalistiche in competizione su scala mondiale, è evidente che la struttura degli stati democratici appare ormai come un organismo arcaico.
4 Il deperimento dello Stato sociale, che non distribuisce più ricchezza, che non favorisce la mobilità sociale, ecc., svaluta agli occhi dei cittadini il valore delle istituzioni pubbliche, dei partiti, delle forze politiche, che appaiono impotenti, divise, litigiose.
5 Il declino e il disfacimento dei grandi partiti popolari, anche per effetto del venir meno degli antichi collanti ideologici, per la frammentazione sociale del post-fordismo, ha immesso dentro quel che è rimasto di questi organismi collettivi il virus della competizione individualistica. E’ indubbio che nel frattempo si è verificato un mutamento antropologico, come sappiamo da tanti studi, da Bauman ai teorici della biopolitica: l’ economia si è imposta alla società anche come una nuova soggettività che plasma il comportamento individuale. Non si crede più nella possibilità di cambiare il mondo ( se non altro per le grandi difficoltà da affrontare, visti i rapporti di forza dominanti) ma si crede nella possibilità del proprio personale successo. Occorrerebbe aggiungere anche che oggi l’individuo, oltre ad essere assorbito lungamente dall’orario di lavoro, è soggetto a una moltitudine di “offerte” pressioni quotidiane – dagli sms alla telefonate, dalle partite di calcio allo spettacolo televisivo, dagli acquisti (on line o al supermercato) ai giochi elettronici, dalla gestione della posta elettronica al disbrigo delle pratiche correnti per la gestione della casa. Il tempo della giornata dell’individuo adulto è frantumato e lo spazio per la politica, che comporta impegno e continuità diventa sempre più residuale.
6 La debolezza dei partiti - ad es. l’impossibilità di generare posti di lavoro attraverso l’azione pubblica - li spinge ad allontanarsi sempre di più dai ceti che prima rappresentavano e a guadagnarne il consenso attraendo investimenti con politiche di sostegno alle imprese. Per questa via la politica ratifica la sua definitiva subordinazione all’economia. Ma, se il successo dell’”imprenditore politico”, che non gode più di sostegni nel mondo popolare, è legato ai mezzi personali di cui dispone, è evidente che egli è esposto alla tentazione di usare a proprio vantaggio risorse pubbliche o illecite e quindi alla corruzione per vincere la competizione con i suoi colleghi.
7 La politica, ridottasi al “discorso” del ceto politico, appare gravemente impoverita rispetto alla ricchezza delle culture che la società oggi esprime. A fronte della multiformità di conoscenze che percorrono il corpo sociale, il sapere della politica - che non si nutre più di teoria e analisi sociale - degrada nella retorica pubblicitaria della società dello spettacolo. Un tempo la politica, la strategia dei partiti di massa sorti nel dopoguerra, era ispirata dall’analisi sociali, dalla conoscenza storica del passato, dall’indagine dei mutamenti economici e sociali. Molteplici discipline scientifiche conncorrevano al suo specifico sapere. I partiti della sinistra, sino a un certo momento, sono stati ispirati dalla teoria, vale a dire la creazione più geniale della politica moderna, che concepisce il corso storico come assoggettabile alla volontà umana attraverso un progetto. Oggi la cultura dei partiti si alimenta di sondaggi elettorali perché loro fine ultimo è l’affermazione nei luoghi del potere e della rappresentanza. La loro pratica intellettuale si riduce alla mera propaganda.
Qualche considerazione di proposta. La politica rinasce se sa pensare nuovi mondi possibili. L’idea della crescita infinita, in cui il capitale ci vuol trascinare, è un assurdo. Il pianeta trabocca di ricchezza in forma di merci ed è minacciato dal suo stesso incremento. Teoricamente, un accordo cooperativo mondiale tra i vari paesi frenerebbe il saccheggio delle risorse, consentirebbe una vita dignitosa a tutti i popoli, ridurrebbe la competizione a pochi ambiti, limiterebbe la corsa individuale di soggetti e forze dentro i capitalismi nazionali. Sotto il profilo culturale l’ipotesi apre un vasto orizzonte alla lotta politica, poggiante su drammatiche necessità ambientali. La sinistra ha a disposizione un nuovo universalismo, quello ecologico, di cui non è riuscita a fare materia di supremazia politica sull’avversario.
La lotta per salvare il pianeta può ricomporre un fronte sociale vastissimo. Infine i partiti. In Italia i tentativi di crearne nuovi sono stati, o sono diventati, progetti di ricostituzione di rappresentanze parlamentari. Purtroppo non sono sufficienti programmi e discorsi diversi dal conformismo dominante se si indossa la stessa divisa del medesimo ceto politico.Deve cambiare il comportamento, non solo il verbo. Il consenso da un popolo frustrato e deluso non viene. E invece occorre organizzare la società in frantumi, prima di tentare di rappresentarla. Poi regole, leggi, statuti per organizzare la volontà collettiva dentro nuovi organismi. Se non possediamo la sostanza ideale per tenere insieme il pluralismo competitivo dei soggetti, per imbrigliane la ricchezza inconcludente, non ci restano che i vincoli delle norme.
 «Nella città che esattamente un anno fa chiuse la stazione ferroviaria di Keleti per chiudere ai profughi di guerra le porte della fortezza Europa, si è discusso anche di migrazione denunciando i respingimenti».
«Nella città che esattamente un anno fa chiuse la stazione ferroviaria di Keleti per chiudere ai profughi di guerra le porte della fortezza Europa, si è discusso anche di migrazione denunciando i respingimenti». Il manifesto,
22 settembre 2016 (c.m.c.)
Articolo firmato da Silvio Cristiano (Università Iuav di Venezia), Viviana Asara (Vienna University of Economics and Business), Federico Demaria (Universitat Autonoma de Barcelona), Giacomo D’Alisa (Universitat Autonoma de Barcelona), Barbara Muraca (Oregon State University)
Si è conclusa con grande successo a Budapest la Quinta Conferenza Internazionale sulla Decrescita per la Sostenibilità Ecologica e l´Equità Sociale (LINK), finora ignorata dai quotidiani italiani. Spesso fraintesa e bistrattata in Italia, all’estero la decrescita è invece sempre più discussa come possibile alternativa a un modello economico in crisi.
Dalla Francia alla Catalogna, dalla Germania agli Stati Uniti, dal Canada all´India, chi parla di decrescita – né “felice” né “infelice” – invoca non il contrario della crescita del prodotto interno lordo, bensì un approccio completamente alternativo al dogma della crescita-ad-ogni-costo. Quella di Budapest è stata la quinta edizione di un ciclo di conferenze che dal 2008, dopo Parigi, Barcellona, Venezia, Montreal e Lipsia, offrono il contesto adatto per discutere e scambiare risultati scientifici ma anche “buone pratiche” all´interno di un movimento sociale-accademico che non smette di crescere.
Dal 30 agosto al 3 settembre, a Budapest sono affluiti oltre seicento tra accademici e attivisti provenienti da tutti i continenti, mentre in città in migliaia stavano animando la prima “Settimana della decrescita” per le strade, negli spazi sociali, culturali e di economia sociale che a Budapest hanno dato vita a una serie di esperienze umane e politiche basate sul vivere la società in un modo altro, al di fuori della logica del profitto. Perché uscendo dalla nostra penisola il concetto di decrescita è piuttosto e innanzitutto una proposta politica per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e della giustizia sociale e ambientale, ben diversa quindi da quell’attitudine più o meno naif con la quale viene spesso liquidata in Italia.
Nella cinque giorni ungherese è stato ribadito come la decrescita sia prima di tutto un tentativo di ri-politicizzare i discorsi sulla sostenibilità, concetto troppo spesso distorto nelle sue declinazioni di “crescita verde”, “economia verde” o “sviluppo sostenibile”, e affidato al mito di una maggiore efficienza tecnologica e mercificazione della natura, a mascherare il fatto che una crescita infinita, oltre che non sostenibile, non è neanche fisicamente possibile su un pianeta finito.
Nella sessione introduttiva della conferenza, Federico Demaria (ricercatore dell’Università Autonoma di Barcellona e del collettivo accademico catalano Research & Degrowth) ha domandato alla platea se la decrescita possa costituire “un progetto politico di sinistra per una trasformazione socio-ecologica della società”.
Come ha spiegato Barbara Muraca (professoressa all´Oregon State University), la crescita ha ormai esaurito la sua funzione di “stabilizzazione dinamica della societá” (concetto caro ai sociologi) o di “pacificatore sociale” che aveva un tempo nelle socialdemocrazie europee. La dipendenza della nostra società dalla crescita in quello che ormai anche il Fondo Monetario Internazionale ha dipinto come uno scenario di “stagnazione sistemica” sta minando le vere basi di riproduzione socio-economica, politica e culturale delle nostre società contemporanee. I limiti della crescita non sono solo di tipo ecologico, ma anche sociale e culturale.
La conferenza di Budapest ha affrontato un vasto spettro di tematiche: si è discusso di energia e di produzione alimentare, di stato sociale e di questioni di genere, di conflitti ambientali e di rapporti tra il nord e il sud del mondo, di urbanistica e di alternative post-capitaliste, di reddito minimo, di reddito massimo e di movimenti sociali. Nella città che esattamente un anno fa chiuse la stazione ferroviaria di Keleti per chiudere ai profughi di guerra le porte della fortezza Europa, si è discusso anche di migrazione denunciando i respingimenti.
Proprio sul manifesto, recensendo il saggio “Vie di fuga” di Paolo Cacciari, lo scorso anno Mauro Trotta ravvisava nei discorsi sulla decrescita una possibile strada verso il processo di ricomposizione della sinistra. Una strada che, per la sua storia e il suo presente, su queste pagine potrebbe effettivamente valere la pena se non altro di discutere.
Dopo il successo delle sue dieci edizioni, la pubblicazione in italiano del volume “Decrescita: vocabolario per una nuova era” (a cura di G. D’Alisa, F. Demaria e G. Kallis per Jaca Books) con contributi di più di cinquanta autori e la significativa prefazione di Luciana Castellina, potrebbe costituire un prezioso punto di partenza in questa direzione. La decrescita non significa recessione o stagnazione, ma il necessario progetto di riforma radicale delle nostre società contemporanee e delle loro istituzioni fondanti, che possa far fronte alla crisi multidimensionale (ambientale, politica e economica) che stiamo vivendo.
«Dove sta l’errore strategico che ha condotto il comunismo allo scacco dopo il crollo dell'Urss?» Una riflessione a due voci tra due autorevoli esponenti del versante politico e del versante sociale del mondo operaio del secolo scorso, che fornisce utili materiali al dibattito della sinistra oggi. il manifesto, 16 settembre 2016
«Ma dove sta, alla fine, il nodo irrisolto, il punto cruciale che ha portato non solo al crollo dell’Urss e del suo impero, ma più largamente a una sconfitta del movimento operaio mondiale nel chiudersi di questo secolo: insomma dove sta l’errore strategico che ha condotto il comunismo allo scacco? Sta nella linea della dittatura militare imboccata subito e fatalmente dai bolscevichi nel 1917? Oppure ha la sua fonte nello stesso marxismo e socialismo europeo, prima ancora di Lenin, facendo salva (ma non proprio tanto) la barba augusta di Karl Marx?».
Sono domande che si rivolge Pietro Ingrao nel quindicesimo (e penultimo) capitolo, «Liberazione e statalismo», di un volume inedito concluso nel luglio del 1998. Il libro, con il titolo «Promemoria», è in corso di stampa presso la casa editrice Ediesse nella collana Carte Pietro Ingrao.
Gli interrogativi che si pone Ingrao costituiscono il costante riferimento problematico che dà senso, ed orienta, le riflessioni sulle vicende e le scelte del Pci e della sinistra italiana negli anni della Repubblica, fino all’assassinio di Aldo Moro.
Ma, in questo capitolo finale, quelle domande e la tematica relativa alla ‘liberazione’ (così presente nell’impegno politico di Ingrao) sono mosse dalle argomentazioni che Bruno Trentin svolge ne «La città del lavoro», pubblicato da Feltrinelli nell’autunno del 1997: «La tesi centrale del libro, scrive Ingrao, è che, nella sinistra europea, già a partire dalla sua culla tedesca, c’è stata una lettura ‘statalista’ del processo di liberazione della classe operaia».
Una scelta che secondo Trentin, riassume Ingrao, «opacizza le nuove, radicali forme di alienazione del lavoro subordinato e che, alla fine, affida la fuoruscita dall’oppressione capitalistica e la transizione verso una società socialista alla conquista dello Stato. È così elusa e alla fine cancellata – sostiene Trentin – la questione essenziale della liberazione del lavoro subordinato, espropriato della sua creatività nel luogo della produzione, e quindi ferito nella sua identità umana, schiacciata dall’universo macchinale».
Ne «La città del lavoro» Trentin illustra bene la dinamica di quella che considera una fatale deriva. La sinistra ha spostato la ‘rivoluzione’ sociale dal cuore della ‘società civile’, ovvero dal conflitto nel luogo di produzione, alla conquista dello Stato.
Trentin, pertanto, contrappone nettamente la ‘società civile’ all’ambito e alla azione del potere politico statale. Ingrao ritiene che non corrisponda ai fatti descrivere, come fa Trentin, una ‘società civile’ che si possa affermare «a sé», distinta da «un potere pubblico che ha il volto (e la complessità articolata) che la sfera dello Stato è venuta via via assumendo nella modernità».
Il nesso tra ‘pubblico’ e ‘privato’ è destinato a dilatarsi. Così Ingrao ritiene necessaria, da parte degli attori sociali, «più politica, ma anche più connessioni fra iniziativa nell’intimo della produzione (per usare l’antico termine gramsciano) e un’immaginazione nuova (oggi quasi inesistente) di istituzioni».
Trentin vede nella ‘creatività’ del lavoro la fonte viva di una liberazione piena della ‘individualità’. Ingrao replica che il «tragico» Novecento ha svelato «una complicazione della soggettività umana».
Allora l’«individualità», «rimanda a un universo assai complesso e multiforme, radicalmente ambiguo ed oscillante: mescolare di più le sfere della vita e del produrre, se vogliamo fare i conti con queste complicazioni e oscurità e se non vogliamo che il nodo del lavoro resti drammaticamente isolato e frantumato, e alla fine perdente».
 Un giusto colpo di frusta da parte di chi aprì sul giornale comunista lil dibattito sulla "morte della politica" e sulla liquefazione della sinistra novecentesca , e insieme alcuni punti dai quali ripartire.
Un giusto colpo di frusta da parte di chi aprì sul giornale comunista lil dibattito sulla "morte della politica" e sulla liquefazione della sinistra novecentesca , e insieme alcuni punti dai quali ripartire.
Ilmanifesto, 14 settembre 2016
C’è un fatto curioso e significativo. Benché sia evidente e foriero di nuove disfatte, il vuoto desolante nel quale ci troviamo stenta a essere riconosciuto nella sua radicalità, per così dire epocale. Così il discorso sulla «morte della politica», che potrebbe e dovrebbe offrire le premesse per ripensare in tempo utile natura e funzioni delle soggettività della sinistra – compreso questo piccolo glorioso giornale – in un contesto totalmente mutato dagli anni della cosiddetta prima Repubblica e del bipolarismo mondiale della Guerra fredda, questo discorso è derubricato a faccenda di ordinaria amministrazione, quando non frainteso nel ricorso a puntualizzazioni fini a se stesse.
Queste ultime – la politica non muore perché tutto è politica – lasciano il tempo che trovano, e il tempo è prezioso.
Noi cerchiamo di correre contro di esso perché sentiamo che è in gioco anche una questione in senso largo generazionale. Chi non ha vissuto gli anni Sessanta e Settanta, chi è venuto all’età della ragione quando la politica era già, nel mondo, lo scatenamento neoliberale degli spiriti animali e, in Italia, la mercificazione berlusconica delle istituzioni – in una parola la post-democrazia – ha motivo oggi di identificare l’esistente con l’orizzonte del possibile o di scambiare tutt’al più le proprie aspirazioni soggettive per istanze critiche.
Ma in questa polverizzazione molecolare la sinistra evapora. E nella rassegnata introiezione del dato come unico quadro di senso, la politica – la politica come pratica storico-critica volta alla trasformazione – muore o si riduce a simulacro.
Non dovrebbe essere dunque difficile intendere che questa nostra discussione investe temi vitali. Che ne va, ormai a breve, della sopravvivenza dei residui della sinistra politica, al netto delle grottesche autoinvestiture renziane o bersaniane.
Negli Stati Uniti, che restano di fatto un modello trainante della società europea, la sinistra è da sempre «puro pensiero» critico per dir così disincarnato, annidato nelle Università e nei think tank, affidato paradossalmente al samisdat di ristrette élites intellettuali. È un eccesso preconizzare che nel giro di pochi anni anche in Europa e nella provincia italiana – finalmente normalizzata – sarà questo lo scenario, a meno di mutamenti oggi imprevedibili? Se non lo è, abbiamo dinanzi un destino ineluttabile o un terreno disponibile all’analisi e all’intervento pratico?
Benché la stessa resistenza a riconoscerla, prima ancora che a farsene carico, testimoni l’intensità della crisi, un minimo di lungimiranza consiglierebbe, a mio avviso, di assumere seriamente la questione, con tutto il suo portato quotidiano di frustranti evidenze.
Il punto è: da dove cominciare finalmente questo discorso, consapevoli della sua urgenza e della sua complessità? La crisi della sinistra italiana ed europea è – su questo in molti conveniamo – «organica». Cioè profonda, strutturale. E pervasiva: trasversale agli spazi della cultura e della moralità dei soggetti individuali e collettivi, oltre che incombente sul grado della loro efficacia materiale.
Forse, allora, è proprio da qui che conviene muovere: dalla qualità del «fattore soggettivo», che al dunque rappresenta sempre un aspetto decisivo nello sviluppo delle crisi.
Vorrei fare qualche nome, per entrare a questo punto in medias res. Proprio Gramsci, la cui lezione spesso ritualmente evochiamo; ma anche altri nostri maggiori a cavallo tra l’Otto e il Novecento (Lenin e Lukács, per esempio; e Antonio Labriola) insistettero sull’importanza dell’autonomia culturale e ideologica delle organizzazioni del movimento operaio. Scorgendovi non un corollario ma l’aspetto determinante la loro costituzione e capacità d’intervento.
Autonomia, per un verso, dall’ideologia (e dalla moralità) dominante. Costruzione autonoma, per altro verso, di strumenti concettuali e di criteri di giudizio per la determinazione delle finalità della prassi politica.
Quel che era indispensabile ieri lo è forse meno oggi? O oggi lo è semmai in maggior misura, dato che molto è mutato nel frattempo nelle coordinate di fondo della realtà economica, sociale e politica in cui si tratta di operare? Passaggi di alcuni interventi nella nostra discussione sembrano variamente convenirne.
Valentino Parlato muove dal silenzio assordante della cultura critica; Alfonso Gianni lamenta l’incapacità di leggere la crisi attuale; Stefano Fassina l’assenza di ragioni fondative in una riflessione stagnante. Da ultimo, per contrasto, Luciana Castellina rivendica la densità della presa di coscienza collettiva degli effetti perversi della modernizzazione capitalistica che, all’altezza del ’68-69 e nel decennio successivo, sorresse la sinistra di classe in Italia.
Mi pare che una diagnosi comune circoli in queste considerazioni e che da questa dovremmo partire, senza indulgenza.
Siamo oggi innegabilmente al cospetto di una pochezza disarmante di cui andrebbero individuate le cause. Il respiro corto della politica politicante non è innocuo né – suppongo – accidentale: risente di certo di una fase storica regressiva segnata dall’accentrarsi della sovranità presso oligarchie sottratte al controllo democratico e dal crollo delle grandi ipotesi trasformative; ma tradisce anche le motivazioni di buona parte di un ceto politico e sindacale balbettante e disorientato, sganciato dal conflitto, non di rado disponibile alle seduzioni dell’opportunismo.
Al tempo stesso il silenzio apolitico o il conformismo di quella che fu la cultura democratica impegnata al fianco delle lotte operaie e studentesche pongono un problema di prima grandezza, a meno di non assumere deterministicamente l’inerzia complice dell’intellettualità.
Insomma, forse è arrivato il momento di fare tesoro di un’intuizione che segnò secoli addietro la nascita dell’antropologia moderna: partire da noi senza vie di fuga ed esorcismi di comodo è indispensabile per comprendere le ragioni della crisi della sinistra e scongiurare la morte della grande politica.
 Se c’è uno spazio politico nel quale la sinistra può ritrovare la sua ragion d’essere è quello europeo. È lì che la politica può incidere sui grandi nodi strutturali del nostro tempo (disoccupazione, immigrazione, mobilità sociale, sfide ambientali e climatiche, terrorismo ecc.) e offrire proposte e visioni alternative».
Se c’è uno spazio politico nel quale la sinistra può ritrovare la sua ragion d’essere è quello europeo. È lì che la politica può incidere sui grandi nodi strutturali del nostro tempo (disoccupazione, immigrazione, mobilità sociale, sfide ambientali e climatiche, terrorismo ecc.) e offrire proposte e visioni alternative».
Il manifesto, 10 settembre 2016
Ho seguito con molto interesse, ma anche con altrettanto scetticismo, il dibattito sulla «morte della politica» ospitato dal manifesto. Confesso subito che la stessa espressione o «slogan» – come lo chiama Alberto Burgio – della «morte della politica» non mi convince affatto. Per almeno due ragioni.
La prima è che la politica non muore; al massimo, si indebolisce, si affievolisce, entra in un apparente letargo e finisce per essere temporaneamente confusa con l’amministrazione dell’esistente. Ma la politica rimane comunque al suo posto, seppure in forme meno visibili e appariscenti.
La seconda ragione è che mai come in questo momento, se allarghiamo i nostri orizzonti al di fuori della piccola Italia, la politica – quella «grande» a cui faceva riferimento Gramsci – torna a mostrarci la sua vera natura, che per molto tempo avevamo cercato di addomesticare. Nel corso degli ultimi anni, assistiamo quasi quotidianamente ad eventi eminentemente politici: Stati che reclamano la loro sovranità, militari che inscenano (maldestri) colpi di Stato, intere popolazioni costrette a fuggire dai loro territori per motivi etnici o religiosi, nazioni che intendono difendere i loro confini nazionali con chilometri di filo spinato o con muri faraonici. L’elenco può essere allungato a piacimento, ma credo sia più che sufficiente a mostrare che la «notte della politica» (se così era) è finita e siamo all’alba di un grande risveglio.
Finora, il dibattito dedicato alla «morte della politica» si è concentrato quasi esclusivamente – direi ossessivamente (ad eccezione degli interventi di Stefano Fassina e Yanis Varoufakis) – sul contesto italiano e sulle cause «domestiche» della crisi.
La mia impressione, invece, è che per capire lo stato attuale della politica (e della sinistra) serva una prospettiva esterna, internazionale. Mi spiego meglio. A mio avviso, quando oggi si discute di crisi della politica credo che, implicitamente o no, si faccia riferimento all’idea di uno «spazio politico», quello che gli inglesi chiamano polity per distinguerlo tanto dalla politics (il «gioco del potere») quanto dalla policy (l’ambito delle politiche pubbliche).
E mi pare evidente, al di là delle nostalgie nazionalistiche dello stesso Fassina, che lo spazio politico che oggi si trova maggiormente sotto stress è quello dello Stato-nazione, che non ha più la forza, gli strumenti, le capacità per fare fronte alle pressioni delle grandi multinazionali, alle dinamiche dei mercati finanziari internazionali, ai processi migratori di scala continentale, ai disastri climatici o ambientali che superano i confini dei singoli Stati.
In questo senso, la crisi della politica su cui ruota l’intero dibattito è, in realtà, una crisi dello spazio politico nazionale, il quale, da solo, non è più all’altezza delle sfide innescate da economie sempre più integrate a livello internazionale. È qui, su questo snodo, che la crisi della politica si riflette dentro la crisi della sinistra, non solo italiana.
E su questo ha pienamente ragione Burgio nel sottolineare che l’attuale crisi della sinistra è «una crisi organica, non episodica», e cioè molto più strutturale che congiunturale. Del resto, come potremmo spiegarci l’uscita – per così dire – a destra (con crescita dei partiti populisti, nazionalisti e xenofobi) dopo la più grave crisi economica che il mondo occidentale abbia sperimentato almeno negli ultimi due secoli? Una crisi – si badi bene – prodotta da un neo-liberismo senza freni, totalmente «sregolato», che ha drammaticamente fatto tornare a crescere le diseguaglianze sociali ed economiche dopo una lunga fase di riduzione.
In teoria, tra il fallimento della ricetta neo-liberale e l’esplosione delle (nuove) diseguaglianze esistevano praterie per la crescita delle forze di sinistra. E invece stanno regredendo un po’ dappertutto perché incapaci di, o impossibilitate a, offrire risposte adeguate alla crisi economica nella quale siamo ancora tutti intrappolati. Qui sta l’elemento strutturale dell’attuale debolezza della sinistra, legata a doppio filo con la crisi della dimensione politica nazionale.
Se questa diagnosi è corretta, mi pare chiaro che (soprattutto) i partiti di sinistra debbano incominciare seriamente a interrogarsi su quale sia il nuovo spazio politico idoneo alle sfide che ci troviamo di fronte. Per le forze politiche di destra o conservatrici, che hanno da sempre fatto leva su uno «Stato minimo», la debolezza della politica è un aspetto secondario, marginale. Ci penseranno altri fattori – gli animal spirits, i singoli individui, i gruppi di interesse ecc. – a fare i loro conti con l’economia e con i mercati. Ma per la sinistra la politica – intesa come spazio politico all’interno del quale poter governare e regolare anche i fenomeni economici – è fondamentale: simul stabunt, simul cadent, o stanno assieme o non staranno per nulla.
Se c’è uno spazio politico all’interno del quale la sinistra può ritrovare la sua ragion d’essere è sicuramente quello europeo. È lì che la politica può incidere sui grandi nodi strutturali del nostro tempo (disoccupazione, immigrazione, mobilità sociale, sfide ambientali e climatiche, terrorismo ecc.) e offrire proposte e visioni alternative ai cittadini.
Certo, non è questa Europa la soluzione, ma sicuramente è dentro l’Europa che va cercata. Per questo trovo sterili le proposte di Fassina, per il quale la risposta ad un «astratto e impolitico europeismo» sarebbe il semplice ritorno alle prerogative dello Stato-nazione, cercando di rimettere il dentifricio della globalizzazione dentro il tubetto nazionale: impossibile.
Ugualmente velleitarie, ma almeno indirizzate verso il giusto bersaglio, mi paiono le soluzioni «movimentiste» di Varoufakis, secondo cui la nuova Europa potrà nascere soltanto da forme diffuse di disobbedienza sociale e territoriale. Se però sono queste le uniche soluzioni sul tavolo, ho l’impressione che la «notte della sinistra» sarà ancora molto lunga.

«La sola ribellione non servì nel ’68 figuriamoci adesso. Reinventare «i disubbidienti» non è sufficiente, né qui e tanto meno in Europa. A Varoufakis dico: per restituire sovranità al popolo europeo servono invenzione, progetto, organizzazione, egemonia, le "casematte"». il manifesto, 9 settembre 2016
Ho visto e letto negli ultimi giorni due cose che mi hanno reso contenta, e tuttavia mi hanno anche indotto a riflessioni polemiche. Mi confesso in pubblico (quello dei lettori del
manifesto, si intende, in grado, forse, di condividere le mie soddisfazioni e pure i miei mugugni).
Comincio dal «visto»: Assalto al cielo, il film sul ’68 di Francesco Munzi, presentato fuori concorso al festival di Venezia e su cui ha scritto Silvana Silvestri. Sono andata a vederlo perché Munzi è un bravissimo regista, ha fatto bei film, specie l’ultimo, Anime nere. Insomma: una garanzia preziosa visto che la materia è stata fino ad oggi quanto mai maltrattata.
Penso all’orrenda celebrazione ufficiale del quarantesimo, otto anni fa, quando il movimento che pur con tutti i suoi errori e difetti ha segnato un cambiamento d’epoca è stato generalmente ridotto a «sesso droga e rock and roll».
Non mi sono sbagliata: il film è rispettoso della serietà dell’impegno e della passione politica che hanno animato una consistente parte della generazione arrivata alla maturità quasi mezzo secolo fa e le immagini - moltissime custodite dall’Archivio del movimento operaio e democratico, ma quasi mai arrivate ad un pubblico largo - sono bellissime. Inedita e straziante l’intervista ai genitori del brigatista Walter Alasia. E però. Munzi dice a Montini su Repubblica: «Non volevo che quel movimento restasse ostaggio della memoria di quelli che l’hanno vissuto», che fossero loro gli «unici titolati a parlarne». «Ho esposto i fatti - continua - perché i giovani sappiano dove stava andando l’Italia».
Il film glielo ha davvero fatto capire? Munzi stesso, che nel ’68 non era neppure nato, si è fatto un’idea di cosa è stato? Su questo ho molti dubbi e anche qualche preoccupazione. È vero che ognuno di noi - come giustamente scrive Silvana - avrà una diversa lettura del film a seconda della propria personale esperienza di quegli anni. Il ’68 - che in realtà in Italia durò dieci anni – ha del resto avuto molte anime ed è difficile ridurlo ad una unica espressione. Ma io credo che un dialogo con chi invece all’epoca era già nato non sarebbe operazione oziosa, perché dai frammenti di assemblee infuocate e di manifestazioni violente - che certo ci sono state - non si ricava il senso più profondo, e in questo senso comune, di quella sollevazione generazionale. Che non fu una reazione disperata e puramente utopica, ma la presa di coscienza - maturata dopo il ricco decennio dello sviluppo neocapitalista - dei limiti di un modello di modernizzazione che, se chiuso entro l’orizzonte capitalista, si sarebbe rovesciato in barbarie. Fu, insomma, una precoce critica della modernizzazione in un’epoca in cui buona parte della sinistra tradizionale partecipava al balletto Excelsior.
Fu, certo, anche un movimento antiautoritario, ma la sua specifica caratteristica, fu di aver capito che la libertà non è individuale ma fonda le sue vere radici nei rapporti sociali di produzione (fu questa la frase più popolare di Marcuse). Di qui la ricerca di un rapporto con la classe operaia, che, è vero, produsse anche scontri e incomprensioni, ma fu vitale per determinare un mutamento della lotta nella fabbrica, inizialmente indotto da minoranze, poi contagioso e infatti alla fine veicolato dallo stesso sindacato, che ne garantì l’estensione. Fu merito della Cgil e della Fim-Cisl aprirsi al movimento, sia pure non senza scontri durissimi, al movimento, cosa che non avvenne che in Italia. Gli anni ’70 furono infatti ricchi di conquiste e non solo di disastri.
Poi abbiamo perso. Non solo per i nostri errori, ma anche per quelli di una sinistra tradizionale che stentò a capire. E iniziò una tragica involuzione. Il sistema operò, come così spesso nella storia, una rivoluzione passiva: assunse le istanze libertarie individuali che non mettevano in discussione il potere, e espulse quanto invece dava fastidio. Se insisto a difendere il nucleo comune e vero della memoria sessantottina non è per autodifesa, ma proprio per stabilire un dialogo critico (e autocritico) con quelli nati nei ’90.
Per quanto ho letto invece, mi riferisco all’articolo di Yanis Varoufakis sul manifesto di martedì 6. Sono contenta, perché chiarisce nuovamente e con più chiarezza di quanto aveva fatto in una assemblea a Roma qualche mese fa di essere contrario ad abbandonare il campo di battaglia europeo e a ripiegare su impossibili soluzioni nazionali. Così come auspica il gruppo che fa capo a Lexit, la sinistra pronta ad abbandonare l’Unione europea. I miei dubbi nascono dalla strategia proposta: se vogliamo restituire sovranità al popolo europeo e togliere il diritto di deliberare ai poteri extrapolitici, estranei al sistema democratico, cui il liberismo l’ha affidato, basta la ribellione? Ribellarsi è giusto e utile, ma non mi pare che reinventare «i disubbidienti» sia sufficiente, né qui e tanto meno in Europa. Proprio perché il demos europeo va costruito, decisivo è costruire quegli organismi intermedi che collegano i cittadini con le istituzioni e che possono incidere sulle decisioni riappropriandosi del diritto a deliberare che gli è stato espropriato. Voglio dire costruire un vero sindacato europeo dotato dei diritti di cui è dotato a livello nazionale; reti fra le città per progetti comuni che ripensino il modo di vivere (quanta ispirazione dalla bellissima Biennale di architettura di quest’anno, intitolata significativamente «Siamo al fronte»); rete di organismi consolidati che comincino a gestire direttamente pezzi della società; media comuni sì da evitare la frammentazione dell’opinione pubblica europea su cui gioca il potere. Anche partiti europei veri.
Ma allora non basta disubbidire, occorre invenzione, progetto, organizzazione, egemonia. Senza casematte, ci diceva Gramsci, il campo di battaglia è pericoloso.
 Un contributo rigoroso al lavoro di chi cerca di ricostruire la politica a partire dallo studio delle condizioni reali degli sfruttati (sul mercato del lavoro, nella città e nella società), e abbia imparato che in Italia una sinistra non c'è.
Un contributo rigoroso al lavoro di chi cerca di ricostruire la politica a partire dallo studio delle condizioni reali degli sfruttati (sul mercato del lavoro, nella città e nella società), e abbia imparato che in Italia una sinistra non c'è.
Il manifesto, 7 settembre 2016
Tutto è politico, anche il terremoto, come è visibile ora, dopo i giorni di silenzio e di lutto dovuti al dolore e alla tragedia. Sono politiche le scelte, le prospettive, i progetti realizzati e quelli mai iniziati, le speranze e perfino la corruzione. Per questo mi lascia perplessa parlare di morte della politica.
Mentre certamente è stata consumata una fine, la fine di una forma politica che a lungo abbiamo chiamato sinistra, e che comprende un insieme variegato di organizzazioni, sigle, pratiche, anche movimenti, oltre che un linguaggio e una visione del mondo. Una fine non riconosciuta, continuamente rinviata e posticipata, e per questo sì, trasformata in una cristallizzazione di parole, di pratiche che non dicono più nulla, neanche a chi le perpetua con ostinazione.
Peggio di una morte, per essere chiara, perché ci si è incaponiti a non nominarla, non vederla, e senza riconoscimento non si può elaborare il lutto, tutto si è trascina con sempre minore slancio, con nulli o quasi effetti visibili. Rimangono il rancore, le infinite accuse reciproche, la ripetizione di riti e comportamenti vuoti, parodie del potere che non c’è.
La novità è che ora, forse perché non c’è più nulla da smuovere, non ci sono più obiezioni e resistenze. Il rischio caso mai è il contrario. Confondere questa fine con la fine di tutto, della politica tout court. In un certo senso l’operazione opposta a quelle di Francis Fukuyama, quando nel 1992 proclamava la fine della Storia a fronte della caduta del muro di Berlino e della conseguente vittoria del capitalismo. Perché ha senso contemplare una fine, se si sposta lo sguardo su ciò che può cominciare. Altrimenti si tratta di una resa senza condizioni. E si lascia il campo a chi della cecità, e della confusione che ne è derivata, ha tratto il massimo profitto. In tutti sensi possibili. Economico e politico.
Un aspetto della complessità è che il fantasma della sinistra continua ad esistere, nello scenario politico italiano. Viene identificato con il Pd che pure, fin dalla sua nascita, da quando fu detto che lavoratori e imprenditori ne erano referenti allo stesso titolo, ha abbandonato la ragion d’essere di un partito di sinistra, anche moderato. La difesa della parte più debole della società, la lotta contro le ingiustizie. L’insieme del corpo politico di quel partito, e della società, in prima linea il sistema dei media, hanno assecondato il rovesciamento del campo del riformismo, bandiera nobile di una delle forme della sinistra. Altro che difesa dei deboli.
L’efficienza, la redditività assunte come valori unici hanno aperto la strada a politiche a sostegno delle esigenze di multinazionali e banche. Le riforme sono diventate ciò che favorisce il potere, l’establishment. L’inquinamento del linguaggio è una malattia grave: parole, idee, cose non dicono più ciò che dicevano. È in questa battaglia che la sinistra alternativa/radicale è stata spazzata via, una vicenda che andrebbe ripensata con attenzione e che non è solo il risultato di un’operazione mediatica.
Nel contesto di un cambiamento di segno che ha investito le socialdemocrazie europee. Senza dimenticare i segni di inversione, basti pensare alle tensioni del Labour Party, con Corbyn corpo estraneo all’establishment blairiano, o alle scelte di rottura dei partiti socialisti rispetto alle grandi alleanze in Portogallo e Spagna, quest’ultima una partita tuttora aperta. In Italia Renzi ha radicalizzato la fisionomia del Pd, con una significativa torsione verso il centro, unita a una tensione al potere personale. Molto in sintonia con i progetti dell’establishment internazionale, come è evidente nell’intreccio tra Italicum e la de-forma costituzionale.
Qui si colloca la fine della sinistra. Quella popolare, di massa, quella alternativa, che pur divise anche ferocemente, hanno una lunga storia comune di scambi vitali che hanno segnato la società, hanno portato i risultati che hanno cambiato la vita dei lavoratori, delle donne, dei più poveri. Quei risultati che ora sono attaccati uno ad uno. A cominciare dalle condizioni di vita dei più giovani. La domanda è questa. Perché le sofferenze sociali, sempre più estese e insostenibili, non trovano una voce adeguata? Perché gli 11 milioni di italiani che hanno deciso di rinunciare a curarsi, di fronte a un sistema sanitario sempre più costoso, non sono al centro delle nostre battaglie? Perché il Jobs Act, che pure è stato ampiamente criticato, è passato nel sostanziale silenzio sociale?
Una prima risposta, dolorosa, ritengo sia in quella fine non consumata, che ha reso teatrali e sempre più vuote le proteste. Non conflitto reale, ma messa in scena del conflitto. E forse per quel punto di cui ha scritto Enzo Scandurra su questo giornale: che si è finito per assomigliare, nei comportamenti e nei pensieri, a quel potere a cui ci si opponeva. Non bastano l’invocazione della legalità, la lotta anti-casta, le idee che guidano il Movimento 5stelle, a dare una visione del mondo. Movimento che occupa lo spazio dell’opposizione, e che viene votato da chi ancora va a votare, perché ha una forza ritenuta comunque utile.
Con onestà va detto che una visione non è a portata di mano. E non ci sono ricette taumaturgiche. Non c’è un re che possa imporre la mano e guarire il popolo malato. Due punti mi sembrano chiari. Occorre comprendere, conoscere, interpretare lo stato delle cose. Quello attuale, in tutte le sue dinamiche. Cioè occorre studiare, riflettere, pensare. Lo so, sembra assurdo quando ciò che urge è l’azione. Ma su cosa agire, e come? Al di là delle denunce, delle polemiche ci siamo chiesti, per esempio, perché il corpo delle donne si trova al centro dello scontro politico internazionale? Quale rovesciamento, del progressismo e dei femminismi, è in corso? A quale lavoro, quale rendimento, sono chiamati i corpi, le relazioni affettive, compresi piaceri e depressioni? Insomma, sappiamo a quale disegno sociale ci si oppone? Abbiamo gli attrezzi giusti? L’altro punto è praticare il realismo e la generosità delle battaglie. Uno dei modi per ostinarsi a non riconoscere la fine, e quindi occultare la decomposizione in corso, è rinchiudersi nei propri ambiti.
Movimenti, associazioni, gruppi. Donne, uomini, generi diversi. Un passo necessario è uscire da sé, guardarsi intorno. E scegliere insieme. Penso al referendum costituzionale. La vittoria del No non risolve i problemi specifici, è ovvio. Ma permetterà di affrontare con forza, e quadro istituzionale non compromesso, ogni battaglia
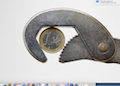 «Unione europea e euro. Priva di una cultura politica aggiornata alle contraddizioni del liberismo, la sinistra rimane ai margini della storia e diventa complice di una spirale distruttiva della Ue, oltre che della moneta unica».
«Unione europea e euro. Priva di una cultura politica aggiornata alle contraddizioni del liberismo, la sinistra rimane ai margini della storia e diventa complice di una spirale distruttiva della Ue, oltre che della moneta unica».
Il manifesto, 3 settembre 2016
Una serie di interventi ospitati da
il manifesto nel mese scorso (da Ciocca a Lunghini) è ruotata intorno a un punto efficacemente sintetizzato da Valentino Parlato (11 Agosto): «l’attuale crisi, a differenza di quella del ’29, non scuote la cultura: stagnazione dell’economia e stagnazione della cultura … Dobbiamo renderci conto, ed sotto i nostri occhi, che senza cultura la politica – come scrive Alberto Burgio – muore». È una valutazione valida per tutte le sinistre al di qua e al di là dell’Atlantico, dentro e fuori il perimetro della esangue famiglia socialista europea. È utile, in particolare, per noi, Sinistra Italiana, avviati inerzialmente verso un congresso rituale, senza ragioni fondative adeguate.
Eppure sono evidenti le discontinuità di fase. Le elezioni regionali in Francia, le presidenziali in Austria, le amministrative in Italia, i successi anti-establishment di Trump e Sanders e la virata a manca di Hillary Clinton negli Usa e, infine, la Brexit indicano l’insostenibilità economica, sociale e democratica del capitalismo liberista. Un fatto enorme. A guardar bene, la Brexit nel 2016 potrebbe rappresentare per il liberismo reale quello che il crollo del Muro di Berlino ha rappresentato nel 1989 per il socialismo reale.
Per noi, nell’euro-zona, l’insostenibilità del liberismo reale è un dato politico ancora più rilevante poiché abbiamo «costituzionalizzato» la versione più estrema del paradigma oramai alle corde: lo statuto della Bce da un lato e il fiscal compact dall’altro, nel quadro delle politiche di svalutazione del lavoro iniziate in Germania dalle «riforme Hartz», l’atto di gran lunga più anti-europeo compiuto nella Ue nel secondo dopo guerra.
Nonostante i caratteri di fondo dei trattati europei e dell’unione monetaria, nella sinistra storica europea, riformista o critica, e nei giovani movimenti genericamente anti-establishment, la discussione rimane prigioniera di un astratto e impolitico europeismo alternativo. La «stagnazione della cultura» a sinistra oggi è il principale ostacolo all’affermazione di movimenti, sindacati e partiti orientati a ricostruire soggettività sociale e politica del lavoro, condizione necessaria per rivitalizzare la democrazia, ridurre le diseguaglianze e riavviare l’economia all’insegna della riconversione ambientale.
Per aprire una discussione utile, in particolare per chi è in fase costituente, l’ultimo saggio di Joseph Stglitz, premio Nobel nell’economia e icona della sinistra, offre una preziosa opportunità. Il professore della Columbia University, difficile da scomunicare con l’accusa di moda di sovranismo o neo-nazionalismo, nel suo «The Euro. How a common currency threatens the future of Europe», ripropone un’analisi consolidata, da tempo espressa da tanti economisti eterodossi e mainstream, anche in Italia: l’ordine economico e sociale dell’euro è insostenibile poiché determina dinamiche divergenti tra i paesi partecipanti, genera stagnazione e nel migliore dei casi, grazie a una politica monetaria disperata, equilibri sempre più arretrati di sotto-occupazione.
In altri termini, l’assenza o la prolungata anemia dell’economia non è soltanto conseguenza di risposte sbagliate a incidenti esogeni. La «stagnazione secolare» è la fisiologia del sistema euro in quanto fondato sulla svalutazione del lavoro e sulla marginalizzazione delle classi medie. Il problema dell’euro-zona non è l’austerità, ma l’impianto dei trattati e la politica economica mercantilista praticata con largo consenso bipartisan dal paese leader. In sintesi, l’euro è stato un errore politico di portata storica.
In astratto, le soluzioni esistono per orientare in senso pro-labour la moneta unica. Nel testo di Stiglitz si ritrova una rubrica di «riforme strutturali». Il problema, chiaro al prof Stiglitz ma inavvertito dai nostri spinelliani senza se e senza ma, è l’assenza del consenso minimo richiesto nei contesti nazionali per approvare le correzioni necessarie. Purtroppo, il demos europeo non esiste. Il demos è nazionale per radici culturali, storiche e sociali. La democrazia o è nazionale o non è.
In tale quadro, data l’impraticabilità politica del Piano A, Stiglitz propone il «suo» Piano B: il superamento cooperativo dell’euro («amicable divorce») per arrivare a un euro del Nord e un euro del Sud o, scenario preferibile, all’uscita della Germania dalla moneta unica.
Alle medesime conclusioni di Stiglitz, sebbene con argomenti di superficie, era arrivata un’altra icona della sinistra critica italiana, Luciano Gallino, nel suo testamento politico, rimosso anche dai discepoli più intimi: «Come (e perchè) uscire dall’euro ma non dall’Unione europea».
Allora, che fare per salvare l’Unione europea dall’euro? Innanzitutto, una lettura fondata della fase, l’abbandono del miraggio degli Stati Uniti d’Europa e l’archiviazione della richiesta del Ministro del Tesoro dell’Euro-zona (a trattati vigenti, sarebbe ulteriormente regressivo sul piano democratico e recessivo sul versante economico). Quindi, l’avvio di una discussione ordinata, protetta dalla Bce, per un Piano B sulle linee raccomandate da Stiglitz. Immediatamente, l’innalzamento delle retribuzioni in Germania per consentire un significativo aumento degli investimenti pubblici nei paesi più in difficoltà dell’eurozona senza effetti dirompenti sulle loro bilance commerciali.
Invece, come fossimo negli anni ’90, il governo, supportato dall’establishment, ripropone ulteriori misure supply-side: tagli al welfare per ridurre le tasse sulle imprese e smantellamento del contratto nazionale di lavoro. Svalutazione del lavoro per ridurre il gap di competitività e puntare alla domanda interna di qualcun altro. Una ricetta seguita da tutti i Paesi euro. Quindi, inutile a migliorare la posizione relativa della singola economia ma efficacissima a deprimere la domanda interna dell’eurozona, a incancrenire la stagnazione e spingere le classi medie verso la chiusura nazionalista.
Priva di una cultura politica aggiornata alle contraddizioni del liberismo reale e della sua versione estrema incarnata dall’europeismo reale, la sinistra qui e oltre confine rimane al margine della storia e si fa involontariamente complice di una spirale distruttiva dell’Unione europea, oltre che della moneta unica. Il dibattito su il manifesto è una preziosa occasione per recuperare.

La destra è riuscita a trasformare il mondo rendendolo omogeneo ai suoi interessi dei poteri che rappresenta, la sinistra tentenna nella ricerca di una direzione e un metodo pe ripartire. Alcune indicazioni positive già emergono. La ricerca continua. Il manifesto, 1° settembre 2016
Quando si sente parlare di «morte della politica», senza altra specificazione, è difficile non preoccuparsi di venire trascinati in un equivoco di senso che potrebbe rivelarsi fatale. Certo l’asserzione ha il suo fascino e la sua potenza, come conviene a una sentenza espressa in modo aforistico, un apoftegma potremmo dire in linguaggio paludato. Questi a loro volta derivano dal fatto che con quell’espressione si colgono innegabili elementi di verità. Ma non tutti. E sappiamo bene cosa poi diventano le verità parziali.
Riparto allora da un esempio dall’attualità. Sergio Marchionne, nel suo endorsement a favore della «deforma» costituzionale, così si è espresso : «Non voglio giudicare se la soluzione è perfetta, ma è una mossa nella direzione giusta e io sono a livello personale per il Sì, serve stabilità». A lui quindi non interessano i dettagli e neppure gli strumenti con cui affermare l’obiettivo che gli sta a cuore, ovvero quella stabilità del sistema politico che coincide con il rigor mortis della democrazia ma assicura libertà di manovra al mercato.
Si tratta di un obiettivo politico ambizioso, per il quale le classi dirigenti stanno lavorando da decenni, dal primo proclama della Mont Pelerin Society nell’immediato dopoguerra, passando poi attraverso i vari Gruppo Bilderberg, la Trilateral Commission, la Loggia P2, versione nostrana e un po’ maccaronica di quello stesso progetto fino al berlusconismo dal lungo corso e via dicendo.
Strada facendo quel disegno a-democratico e oligarchico si è fatto sempre più spavaldo. Ha avuto sempre meno bisogno di esprimersi all’interno di think tank, più o meno segreti o aperti a giornalisti embedded, e si è manifestato direttamente, attraverso la voce diretta degli attori economici dominanti e dei poteri finanziari. Così siamo giunti al famoso documento della JP Morgan del giugno 2013, vera matrice della «deforma» costituzionale portata avanti con intemerata energia dal governo Renzi.
Ma ciò non toglie che siamo di fronte a una potente e tenace costruzione politica, a un pensiero che si è fatto interprete degli spiriti animali del capitalismo nell’epoca della globalizzazione e del dominio della finanza.
Non si è trattato di semplice conservazione, ma di una rivoluzione restauratrice. Ovvero la categoria più alta della politica, cioè la rivoluzione, è stata curvata verso fini ad essa contrari. Di conseguenza il riformismo è diventato la foglia di fico di corpose controriforme.Ben scavato, vecchia talpa! Ci tocca riconoscere.
Il neoliberismo non si è mai privato, anche nei suoi momenti di massimo fulgore e non solo nella crisi attuale, dell’aiuto determinante dello stato. Le logiche di mercato da sole non ce l’avrebbero fatta. La prova sta proprio nel fatto che per prevalere esse hanno bisogno di smontare Costituzioni, violentare leggi elettorali, strozzare canali democratici, cancellare spazi giuridici internazionali e crearne dei propri (come si tenta di fare con il Ttip, oggi per fortuna ad una battuta d’arresto).
Senza rinunciare a colpi di stato, a dittature, a populismi rivoluzionari manipolati dall’alto nelle zone del mondo di maggiore frizione, tutto ciò viene fatto – almeno nei paesi a capitalismo maturo – prevalentemente con le armi della politica, solidamente fondata su una disgregazione del fronte sociale avverso, attraverso le modificazioni dell’organizzazione del lavoro e conseguentemente della società. Una politica da cui è stata espunta qualunque forma di dialettica, che quindi si pone l’obiettivo della distruzione della democrazia nella teoria e nella prassi.
Naturalmente questa politica subisce anche i suoi rovesci. Si scontra contro resistenze e resilienze. Non c’è un deserto pacificato. La stabilità si trasforma spesso in cronica instabilità, a tutti i livelli. Gli status e i confini delle e fra le cose si confondono o spariscono. Persino quelli tra la guerra e la pace. Metaforicamente si può dire che il mondo viva oggi in uno stato «quantico».
È a sinistra che invece si può parlare di morte della politica. Il che ha permesso alle destre, nelle loro variegate versioni, di affondare i propri colpi in un ventre molle.
Questo è accaduto per una sorta di rovesciamento delle parti. Mentre la destra pensava a come travolgere le regole e i confini di quel mondo che gli era stato consegnato dagli esiti della seconda guerra mondiale, la sinistra, non senza lodevoli e significative eccezioni, si prometteva di conservarlo, al massimo di fare opera di manutenzione, in qualche caso di troppo timida e fragile trasformazione.
Una costruzione troppo debole per reggere l’offensiva avversaria. Per di più minata dal frantumarsi di un modello di riferimento con la crisi autodistruttiva del cd. socialismo reale e contemporaneamente da una letale separazione della cultura dalla politica che ha costituito una versione capovolta di quel «tradimento dei chierici» di cui scriveva Julien Benda alla fine degli anni venti.
Se per cultura si intende ciò che una generazione storica trasmette all’altra come risultato della sua autoproduzione umana e che la seconda modifica e prosegue secondo le nuove condizioni, si avverte un vero e proprio iato attorno alla fine degli anni settanta. I nodi sono venuti al pettine alla fine dei «trenta anni gloriosi», che colsero la sinistra nella sua parte preponderante priva di strumenti analitici per comprendere il significato di quel periodo.
In Italia qualcosa si avvertì – si ricordino i convegni dell’istituto Gramsci sulle tendenze del capitalismo italiano e europeo – ma troppo poco e non furono le analisi e le tesi migliori a prevalere. Non parliamo poi dell’incapacità di leggere la crisi attuale, sia nel suo sopraggiungere che nel suo svilupparsi.
Ora non si tratta di stringere i bulloni sulle vecchie viti. C’è un «a capo» da cui dobbiamo ricominciare. Ed è l’analisi concreta della situazione concreta a livello mondiale. L’elenco fatto da Burgio sarà parziale, ma è già prezioso. Il capitalismo galleggia – che altro è la stagnazione secolare di cui si parla? – sul fallimento del suo modello di società. Se sprofonda, in assenza di alternativa, trascina tutti con sé. Non possiamo quindi accontentarci di una «terza via» fra il pessimismo di un Robert J. Gordon, di cui ha parlato PierLuigi Ciocca, e la ripetitiva fiducia nelle «magnifiche e progressive sorti» dell’innovazione di un Alec Ross, consigliere della Clinton. Né possiamo farci imbrigliare da polemiche un po’ nominalistiche a proposito del carattere postcapitalistico (Paul Mason) o precapitalistico (Evgenji Morozov) di alcune esperienze produttive autonome e dal basso.
L’alternativa non può essere cercata solo nel campo della politica e una certa sperimentazione di nuovi rapporti sociali e produttivi va iniziata da subito. La politica ci è appunto indispensabile per legare nuove esperienze pratiche alla delineazione di una idea modello produttivo e di società.
Quando era ufficiale, Tolstoj ammonì un graduato che fustigava un sottoposto che non teneva la fila: «Non si vergogna a trattare così un suo simile? Non conosce il Vangelo?» E l’altro: «E lei, non ha letto i regolamenti militari?». Ma di «regolamenti» a sinistra si muore.
Gli altri articoli del dibattito:
- Alberto Burgio (4/8)
- Valentino Parlato (11/8)
- Pierluigi Ciocca (10/8)
- Giorgio Lunghini (13/8)
- Marco Almagisti, Paolo Graziano (20/8);
- Enzo Scandurra (24/8)
- Alberto Burgio (26/8)
 «Non è forse questo il dramma della sinistra? L’aver pensato che, una volta occupato il Palazzo, quello stesso linguaggio usato dagli avversari avrebbe assunto un significato diverso. Bastava, in una parola, prendere il potere e il mondo sarebbe cambiato».
«Non è forse questo il dramma della sinistra? L’aver pensato che, una volta occupato il Palazzo, quello stesso linguaggio usato dagli avversari avrebbe assunto un significato diverso. Bastava, in una parola, prendere il potere e il mondo sarebbe cambiato».
Il manifesto, 24 agosto 2016, con postilla
L’articolo-appello di Valentino Parlato (Economia e politica, una crisi mai vista, il manifesto dell’11 agosto), è un grido di appassionata disperazione (mi si consenta il termine in una accezione non disfattista) contro la «morte della politica, ridotta a (mala) amministrazione dell’esistente». Un pur fugace raffronto con altri tempi (quello dei Togliatti, Nenni, La Malfa e perfino De Gasperi), appare impietoso, fuori misura – sostiene Parlato -, tanto quella attuale è un’epoca di tristi ed effimere passioni, oltre che mediocri figure.
L’articolo denuncia la crisi culturale che accompagna la morte della politica, quasi non si riuscisse più a rappresentarla con la letteratura, l’arte, la poesia, la musica, i linguaggi con i quali, in passato, sono state raccontati periodi di crisi (si cita, ad esempio, Furore di Steinbeck, a proposito della Grande Crisi del Ventinove). Come ci rappresentiamo oggi? In che modo raccontiamo noi stessi e l’epoca che attraversiamo?
Solo raramente la letteratura, il cinema, l’arte in generale, riescono oggi a raccontare o rappresentare con efficacia vissuti di fragilità, storie minori di comunità accoglienti, piccoli (ma importanti) episodi di solidarietà. Queste narrazioni svolgono una funzione sociale salutare, restando però minoritarie, frammentarie, così che solo in qualche caso sono capaci di indicare, indirettamente, altre strade che la politica potrebbe percorrere, fuori dal rumore delle grandi ideologie, dei dibattiti estenuanti sulla sinistra che non c’è ma che vorremmo.
Nel frattempo, le casematte gramsciane del pensiero critico – scuola e università – venivano occupate, smantellate, convertendole alla più perversa delle ideologie liberiste: quella della valutazione di qualità, del cosiddetto merito individuale misurato a suon di indicatori partoriti da fantomatiche agenzie private.
Non furono i rappresentanti del pensiero liberista a compiere questi misfatti: l’iniziativa fu intrapresa ad opera di politici della sinistra che in un sol colpo cancellarono l’eredita di don Milani, a dimostrazione che l’avversario non veniva da lontano; nasceva e cresceva nel solco della stessa cultura di sinistra.
Fare politica in modo nuovo significa allora rifiutare innanzitutto di assumere le stesse modalità di ciò che si vuole combattere, dice Michela Murgia nel suo ultimo libro dal titolo polemico Futuro interiore. Rifiutare quella logica stringente e perversa del fare, altrimenti il rischio è quello di ritrovarsi nei luoghi in cui si deve decidere facendolo nell’unico linguaggio che sarà rimasto per farlo e che è quello stesso da cui ci si voleva liberare.
Non è forse questo il dramma della sinistra? L’aver pensato furbescamente, ad esempio, di condizionare i “miracoli” dell’economia finanziaria usandola a proprio vantaggio o l’aver pensato che, una volta occupato il Palazzo, quello stesso linguaggio usato dagli avversari avrebbe assunto un significato diverso. Bastava, in una parola, prendere il potere e il mondo sarebbe cambiato.
Non è ancora questo che si pensa delle Olimpiadi? A sinistra si dice che sono quasi sempre gestite male, ma che se a farlo fosse la sinistra diventerebbero un’opportunità eccezionale; ecco il miracolo! Di più, basta assistere a una qualche discussione politica di qualche nuova sinistra nascente in occasione di elezioni politiche, per capire subito quanto il linguaggio, i metodi e le astuzie usate appartengono al passato respingendo chi si avvicinasse con curiosità e magari speranza.
Questo delirio di onnipotenza e di supponenza ha avuto come esito lo sradicamento totale dell’idea stessa di un’altra possibile via; vale per la l’idea di crescita, di sviluppo, per la globalizzazione e perfino per l’idea di progresso. Miti e riti che rimbalzano da sinistra a destra e viceversa, con gli stessi contenuti, come se a cambiare loro il segno spettasse al Conduttore.
E così la vulgata machiavellica del fine che giustifica i mezzi ha scatenato la ricerca del compromesso ad ogni costo fino alla perversione della sinistra stritolata dalla sua stessa misera furbizia.
Un delitto perfetto dal momento che omicida e vittima sono la stessa persona. Così oggi scopriamo che tanti compagni non nutrono simpatie per i migranti, che condividono l’idea di supremazia dell’Occidente, che hanno una cultura sessista, che sono fiancheggiatori del Mercato, del Privato, che ci hanno concesso la libertà assoluta di avere tutto ciò che desideriamo, che, ancora, tanti compagni mandano i figli a studiare alla Bocconi, mentre con l’altra mano firmano petizioni a favore dell’università pubblica.
E’ mancata una rivoluzione culturale all’altezza della crisi né se ne intravedono segnali. Tanto più allora è da prendere in considerazione la proposta di Parlato quando, dalle pagine di questo giornale, sollecita «una discussione che mobiliti e apra una battaglia culturale e politica». Quali che siano state le colpe e gli errori del passato e quali che siano le difficoltà del presente, esse non ci possono esimere dal prenderci le responsabilità di sognare un futuro diverso.
Ma, per farlo, sforziamoci di utilizzare un linguaggio nuovo, nuovi modi di dialogare tra noi; utilizziamo il linguaggio della tolleranza e della pazienza, considerato che all’orizzonte non si intravedono nuovi profeti che ci salvino dal naufragio in corso.
postilla
L'errore di puntare al potere per il potere è cominciato con D'Alema ed è giunto al punto terminale con Renzi; più giù c'è solo il fascismo. Per costruire una realtà politica e sociale che svolga nel XXI secolo un ruolo simile a ciò che fu la sinistra dei secoli sorsi (cioè una forza antagonista al sistema dominante) occorre saper affrontare problemi nuovi (dall'equilibrio tra uomo e ambiente all'esodo dai Sud ai Nord del mondo) e occorre insieme individuare (e saper mobilitare) una nuova base sociale di riferimento. Il mondo degli sfruttati è oggi diverso da quello dei secoli passati. Hic Rhodus, hic salta .
 Morte della politica e crisi dei partiti. Da dove partire per ricominciare a sperare? un utile intervento nel dibattito in corso. Un inizio di risposta alla domanda: quale parte della società di oggi può costituire la base sociale per una politica alternativa?.
Morte della politica e crisi dei partiti. Da dove partire per ricominciare a sperare? un utile intervento nel dibattito in corso. Un inizio di risposta alla domanda: quale parte della società di oggi può costituire la base sociale per una politica alternativa?.
Il manifesto, 20 agosto 2016
L’
articolo di Valentino Parlato pubblicato su questo giornale giovedì 11 agosto solleva alcune questioni sostanziali riguardo alle categorie con cui proviamo a leggere il nostro tempo, caratterizzato dalla crisi dei partiti e da fenomeni molto preoccupanti di disaffezione democratica. A differenza del passato, sottolinea Parlato, la crisi non produce quella «straordinaria vivacità culturale che nasceva dalla crisi e ne approfondiva le cause». Come non essere d’accordo?
Chiedersi come oltrepassare la “morte della politica” (l’espressione, di Alberto Burgio, è stata evocata sempre su questo giornale il 4 agosto) e ripensare la politica quale spazio di speranza per il miglioramento della vita di milioni di persone significa in primo luogo sottrarla al provincialismo del tempo presente che spesso troviamo in molte narrazioni dominanti.
E’ necessario far emergere le connessioni fra gli l’attualità e la continuità di filoni culturali che riteniamo tutt’altro che esauriti. Ad esempio, se condividiamo la diagnosi relativa alla crisi dei partiti, chiediamoci quali rapporti essi oggi abbiano con i soggetti sociali che dovrebbero rappresentare. Sappiamo che la storia del movimento operaio è connotata dalla dialettica a volte difficile, ma feconda, fra partiti e altre espressioni di soggettività politica, quali i movimenti e gruppi di pressione. Forse oggi la percezione della crisi dei partiti origina anche dalla convinzione diffusa che essi siano o debbano essere i monopolisti della soggettività politica. Noi siamo di diverso avviso.
Prendiamo ad esempio le insorgenze di movimenti critici nei confronti della globalizzazione neo-liberista. Se rimaniamo sul piano delle ‘narrazioni’ dominanti, questi fenomeni meritano una citazione solo se e quando infrangono palesemente le regole dell’ordine costituito e sono presentati quali insorgenze sporadiche e improvvise senza storia e, pertanto, senza futuro. In realtà, tali movimenti non sono affatto sporadici, bensì si innestano in filoni di cultura politica molto rilevanti nella storia delle democrazie occidentali, avendo le proprie radici nei processi di emancipazione e di ampliamento della cittadinanza che hanno caratterizzato i decenni passati.
A loro volta, i movimenti degli anni Sessanta e Settanta non nascevano dal nulla, bensì affondavano le proprie radici in fermenti, pacifisti, ambientalisti e femministi, presenti già negli anni Quaranta del Novecento, sviluppati sovente nel grembo degli stessi partiti della sinistra o, comunque, non in opposizione ad essi (si veda Marica Tolomelli, L’Italia dei movimenti, Carocci, 2015). Osservando la realtà dei nostri giorni, sembra che dopo il grande ciclo delle mobilitazioni ‘altermondialiste’ che connotarono il cambio di secolo, la ribalta politica sia stata sostanzialmente desertificata dalle politiche repressive dei governi. Eppure, la realtà sociale è connotata anche dalla presenza di molte persone che danno vita ad un agire sociale politicamente orientato di cui i media danno pochissimo conto.
Possiamo scegliere, quale esempio fra i diversi possibili, il fenomeno del ‘consumerismo politico’ attraverso il quale gruppi di cittadini hanno deciso di spostare la lotta politica dalle strade ai negozi, puntando a fare politica attraverso strategie di boicottaggio e acquisti mirati. Sono fenomeni dotati di un proprio spessore storico e politico: la repressione dei movimenti di inizio millennio (che, come è noto, ha visto a Genova nel 2001 una gravissima violazione dei diritti) non ha comportato solo ripiego nel privato.
Fra le possibili risposte adattive dei cittadini attivi c’è stato anche l’incremento di pratiche sociali diffuse, come, ad esempio, quelle incentrate su scelte di consumo, mosse dall’assunto secondo cui “ogni volta che si acquista qualcosa, si vota”. I Gruppi di acquisto solidale (GAS), che negli anni Novanta erano una decina, oggi sono un migliaio in tutta Italia, solo per rimanere a quelli censiti formalmente, creano solidarietà fra i membri dei gruppi di acquisto che condividono criteri etici, sociali ed ambientali legati alla produzione e al consumo di beni (si veda Paolo Graziano e Francesca Forno, Il consumo critico, Il Mulino, 2016). Questi gruppi agiscono sulla base di una cultura politica e, in un’epoca di rimozione del conflitto e di narrazione del mercato quale spazio naturale, hanno l’indubbio merito di identificare il mercato stesso come luogo di lotta politica, oltre che di scambio sociale. Sono gruppi che fanno politica, quotidianamente.
Molti altri sono gli ambiti in cui oggi si articolano preziose iniziative di cittadinanza attiva (per una panoramica, vedi Giovanni Moro, Cittadinanza attiva e qualità della democrazia, Carocci, 2013): si tratta di preziosi “mondi vitali” senza i quali la nostra società sarebbe più povera, vulnerabile e insicura. In altri paesi, Grecia e Spagna, ad esempio, tali iniziative hanno trovato alcuni canali di azione politica significativa anche dal punto di vista elettorale, dando linfa a nuove formazioni partitiche.
In Italia, a parte alcune liste civiche e l’attenzione del Movimento Cinque Stelle, non è (ancora) successo. Eppure, come dare rappresentanza politica nazionale a questo capitale sociale – ed espanderlo ulteriormente – dovrebbe essere il nostro rovello quotidiano. Anche, o forse soprattutto, da qui si deve partire per ispirare un cambiamento radicale alle politiche neoliberiste e far rinascere la politica.
Una posizione del tutto ragionevole e condivisibile, con un solo errore, ricorrente in questo e in altri dibattiti: ritenere che il PS di Renzi abbia alcunché di "sinistra". L'ideologia del partito renziano è, in modo un po' pasticciato, quella nel più classico neoliberismo.
La Repubblica, 14 agosto 2016
Caro direttore, si è aperto nelle ultime settimane sulle pagine di
Repubblica un importante dibattito sul rapporto tra sinistra e immigrazione. Lo spunto è venuto da una
lettera di Francesco Ronchi, dirigente del Pd Emiliano, pubblicata il 29 luglio scorso, in cui si sostiene che le sinistre europee stiano perdendo il sostegno del loro elettorato storico — le classi popolari — a causa di un rifiuto di affrontare il “tabù” dell’immigrazione, che avrebbe consegnato il monopolio di questo tema alle destre populiste. Ne nasce una proposta: che la sinistra abbia il “coraggio” di riconoscere la «tensione tra immigrati e nativi», e quindi di ripartire da una visione della «comunità che protegge», invece dell’«esaltazione retorica del multiculturalismo».
Quest’ultimo termine — multiculturalismo — sembra essere usato in Italia solo da chi vuole criticarlo. Vale quindi forse la pena ritornare sul suo significato, a partire dall’esperienza di un paese che invece ne ha fatto un’identità. Negli Stati Uniti essere a favore del multiculturalismo non è un insulto, ma una bandiera. Significa non solo riconoscere che la società è “multietnica di fatto”, ma anche che questa diversità è un valore, cioè una ricchezza per il paese. Il suo opposto è quindi il “monoculturalismo”, inteso come tentativo di imporre una cultura unica a una società per sua natura eterogenea.
Sarebbe un errore pensare che questo faccia parte del Dna degli Stati Uniti, in quanto paese fondato sull’immigrazione. Anche lì, si tratta di una conquista storica, identificata in particolare con una parte politica. Quando gli immigrati negli Stati Uniti eravamo principalmente noi italiani, erano in molti “nativi” a preoccuparsi che le nostre tradizioni e soprattutto la nostra religione (cattolica) non ci avrebbero consentito di integrarci nel melting pot americano. «I tedeschi, gli inglesi e gli altri» si legge ad esempio su un editoriale del New Orleans Times del 17 Ottobre 1890 «vengono in questo paese, adottano i suoi costumi, imparano la sua lingua e si identificano col suo destino… Gli italiani, mai. Rimangono isolati dalle comunità in cui vivono, non imparano la nostra lingua e non hanno alcun rispetto per le nostre leggi e la nostra forma di governo. Rimarranno per sempre stranieri». Oggi gli stranieri considerati “inassimilabili” dalla destra populista americana sono altri: i messicani, i cinesi e soprattutto i musulmani. Ma la retorica di fondo è rimasta la stessa.
Se ora vogliamo, come sinistra italiana ed europea, imparare qualcosa da un paese che vive dell’immigrazione da più di un secolo, perché ricalcare il discorso della sua destra populista? Quando la sinistra imita la destra non va mai molto lontano, in primo luogo perché l’elettorato sembra (comprensibilmente) preferire l’originale, ma anche perché vincere con le posizioni dell’avversario non è veramente vincere. Non sarebbe invece più sensato ispirarsi alla corrente più “progressista” della politica americana, cioè a quel Partito Democratico che oggi difende il multiculturalismo come “vera” identità degli Stati Uniti, contro la bolsa retorica di un’America bianca e omogenea di Donald Trump? Alla convention del Partito Democratico ha per esempio avuto enorme risonanza l’intervento di un cittadino di origine pachistana che ha perso un figlio durante la guerra in Iraq e che, sventolando una copia della costituzione americana, chiedeva a Trump cosa avesse sacrificato, lui, per il paese. Ecco una bella immagine del multiculturalismo americano. La costituzione rappresenta i valori condivisi, e nella nostra come in quella americana c’è scritto che tutti i cittadini sono uguali, indipendentemente dalle origini sociali, culturali e religiose. Il multiculturalismo quindi non nega che serva una base di valori condivisi, espressi nella costituzione e nel diritto (uguali per tutti), ma afferma che questi valori sono compatibili — e nutriti — da una molteplicità di culture diverse. Prendiamo due esempi più concreti: negli Stati Uniti è possibile per i cittadini adempire ad alcune pratiche ufficiali — come ad esempio sposarsi — nella lingua che preferiscono, attraverso l’uso di traduttori. Non si capisce perché un simile principio di multilinguismo non potrebbe essere adottato anche in Italia. Senza far torto alla nostra lingua ufficiale, ma affiancandola ad altre, si darebbe un segnale concreto di apertura e accoglienza verso chi si trasferisce nel nostro paese. D’altra parte, nel caso di conflitti evidenti con i valori fondanti del nostro sistema di governo, le autorità possono sempre intervenire per vietare pratiche specifiche, come ha fatto ad esempio il parlamento nel 2006, vietando la mutilazione genitale femminile in quanto «violazione dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne». Credere che l’elettorato storico della sinistra non possa essere ricettivo a un messaggio di questo tipo significa sottovalutarlo, perché la sinistra si è sempre identificata con i principi di uguaglianza e universalismo. Invece di un passo indietro alla rincorsa del suo avversario, converrebbe quindi che nel parlare di immigrazione la sinistra si distinguesse dalle destre conservatrici e protezioniste, coniugando i principi di uguaglianza e universalismo con una difesa del multiculturalismo.
James Fontanella- Khan è corrispondente dagli Stati Uniti per il Financial Times Carlo Invernizzi- Accetti è Assistant Professor di Scienze Politiche alla City University of New York

Una storia europea, un controcanto alla Turchia che piace alla NATO. «Oppositore del regime, cantore dell’impegno come dei sentimenti, l’autore delle “Poesie d’amore” incarna ancora lo spirito di Istanbul». La Repubblica, 12 agosto 2016
Continuano a scandire, agitare la loro bandiere rosse. La cosa che più colpisce nella Istanbul del dopo golpe è il permanente susseguirsi di manifestazioni, slogan, canti. Yenikapi a sostegno di Erdogan sembrava Tiananmen ai tempi di Mao. A piazza Taksim non succedeva da anni che potesse riunirsi tanta gente. E di tante parti politiche diverse e contrapposte. E non si canta solo in piazza. Tra i tavoli dei ristoranti, strapieni, che si affacciano sul mare a Büyükada, la maggiore delle isole dei Principi, continuano ad intrecciarsi duelli canori: canti patriottici da una parte, cui rispondono vecchi canti della sinistra da un’altra parte. Monta irresistibile l’allegria col raki, cominciano le danze. Si mangia e ci si diverte.
Come se niente fosse successo. Anzi, no, forse proprio per reagire a quel che sta succedendo.
«Goccia a goccia... il suo sangue fino a quando non verrà in piazza il mio popolo, con le sue canzoni». Questi i versi di una delle ultime poesie di Nazim Hikmet, dedicata a uno studente diciannovenne ucciso a Istanbul nel 1960. Il poeta era in esilio a Mosca. Del golpe del 1960 si è ormai persa la memoria. Del “Morto in piazza Beyazit”, non sappiamo nulla. Nei versi di Hikmet è una sorta di “militante ignoto”, simbolo di un grande massacro che proseguì nei decenni successivi. Ma non credo che sognasse questo tipo di piazze il vecchio comunista, eternamente innamorato della rivoluzione, così come di un numero sterminato di donne (“ce n’era sempre un’altra”, ha riassunto Piraye, quella a cui aveva dedicato le sue poesie dal carcere, e che fu solo una dello sterminato catalogo). Anche se è meglio degli scontri armati. È una tradizione locale confrontarsi a slogan scanditi e canti negli stadi. Fece scandalo quando interruppero il minuto di silenzio per i morti di Parigi scandendo Allah Akbar. L’ultimo slogan portato lontano dal vento che avevo udito scandire dagli spalti del nuovissimo stadio suonava: “La Turchia è laica e laica resterà”. Ora bisognerà attendere la nuova stagione calcistica.
Di Nazim Hikmet raccontano che gli piacesse cantare, ridere, scherzare, raccontare barzellette anche nei momenti peggiori, anche in carcere, anche quando al processo a porte chiuse fu chiesta la condanna a morte per impiccagione. Anche quando aveva già scontato 14 anni e gliene restavano da scontare altri 17. L’avevano condannato per incitamento all’ammutinamento nelle forze armate. Poi per ammutinamento nella marina per conto di una potenza straniera. Questo perché lui era comunista e dei giovani ufficiali leggevano le sue poesie. Lo rinchiusero in una nave trasformata in prigione, in un locale sommerso da mezzo metro di escrementi. Spellarono a bastonate le piante dei piedi ai militari suoi “complici”. Era negli anni ’30. Un capo di Stato maggiore che spingeva perché la Turchia entrasse in guerra a fianco di Hitler voleva una punizione esemplare. Quel generale fu poi licenziato, la Turchia dichiarò invece guerra, in extremis, a metà 1945, alla Germania. In Turchia ci sono cose che non cambiano anche quando cambia tutto. Continuavano a liberarlo e incarcerarlo di nuovo. Tornò libero, per una riduzione della pena, nel ‘50. E, all’età di 50 anni, con un infarto alle spalle, lo richiamarono alle armi per mandarlo a combattere contro i comunisti in Corea. Lui fuggì avventurosamente in barca, fu raccolto nel Mar Nero da un mercantile battente bandiera romena. A Mosca fu accolto con tutti gli onori, poi Stalin decise qualcosa che neanche i turchi avevano osato: di ammazzarlo. Una sera l’autista che gli avevano assegnato irruppe ubriaco nella dacia a Predelkino e confessò singhiozzando che l’ordine di fingere un incidente gli era stato dato direttamente da Beria. Così racconta il suo collega poeta Evtushenko.
A Hikmet mi accomuna l’essere nato a Istanbul (in realtà lui era nato a Salonicco), l’essere stato comunista, essere renitenti alla leva, l’essere stato privato della nazionalità turca per decreto del consiglio dei ministri e pure (quand’ero più giovane), l’essermi innamorato più spesso del dovuto. Tra le differenze: che il turco l’ho dimenticato e che non ho mai saputo cantare e soprattutto il fatto che, almeno nei suoi versi, lui è sempre ottimista, anche nelle circostanze più disperate, mentre col passare degli anni io tendo ad essere pessimista. «Uno scrittore che non offre speranze non ha il diritto di fare lo scrittore… Ci possono essere ragioni per essere tristi, sconsolati, amareggiati, ma non ce n’è alcuna per essere senza speranza», scriveva a Orhan Kemal ( In jail with Nazim Hikmet, 2010). E in effetti l’idea del suicidio gli passò per la mente solo per pene d’amore. E probabilmente era solo per finta. Consiglio di rileggere Hikmet quest’estate, e non solo le sue (nel corso della mia vita ne ho regalate tante copie, a tante ragazze, che Mondadori dovrebbe darmi un premio). Anche Paesaggi umani, o In quest’anno 1941 dicono della sua Turchia, dell’umanità, del coraggio, e insieme della ferocia, delle viltà, dei fanatismi contrapposti, delle “stranezze” del suo popolo molto più che un’intera biblioteca sulla Turchia. Del resto non c’è autore turco contemporaneo che non abbia un debito con Hikmet, compreso l’Orhan Pamuk dell’ultimo romanzo La stranezza che ho nella testa. È uscito in traduzione italiana anche il romanzo su Hikmet di Nedim Gürsel, L’angelo rosso (Ponte alle Grazie). Peccato che il titolo scimmiotti quello della traduzione francese, mentre l’originale turco è Seytan, Melek ve Komünist, “Demonio, Angelo e Comunista”, e rende assai meglio la complessità e le contraddizioni del personaggio, di un secolo, di un Paese (la Turchia) e di un continente (la nostra Europa). Mi è incomprensibile invece perché non sia ancora disponibile in italiano la straordinaria, bella e ricca biografia su Hikmet di Saime Göksu ed Eward Timms, Romantic Communist, pubblicata nel 1999.
 «C’è una domanda che bisognerebbe porsi, una domanda di ordine storico, che chiama fatalmente in causa le culture politiche dei gruppi dirigenti di quella che in tempi ormai lontani fu, almeno in Europa, una sinistra sociale di massa. Perché questa metamorfosi delle sinistre socialiste?».
«C’è una domanda che bisognerebbe porsi, una domanda di ordine storico, che chiama fatalmente in causa le culture politiche dei gruppi dirigenti di quella che in tempi ormai lontani fu, almeno in Europa, una sinistra sociale di massa. Perché questa metamorfosi delle sinistre socialiste?».
Il manifesto, 11 agosto 2016
È sempre più insistente la sensazione che la politica sia morta, ridotta a (mala) amministrazione dell’esistente.
Sono tante le possibili ragioni: la deprimente ripetitività delle cronache; la desolante modestia dei politicanti; l’assenza, soprattutto, di prospettive di là dalla dittatura dei mercati, dallo stillicidio degli attentati e delle stragi di migranti e, chez nous, dal dilagante malaffare, dalla cronica indigenza delle finanze pubbliche e dall’inesorabile immiserimento del mondo del lavoro. Naturalmente «morte della politica» non è che uno slogan. Eppure questa formula suggestiva contiene una verità interna sulla quale vale la pena di ragionare.
Partiamo dal dato più vistoso. Da decenni ormai nel cuore del mondo capitalistico la sinistra ha abbandonato le classi lavoratrici, spingendole alla protesta qualunquistica o tra le braccia delle destre nazionaliste e xenofobe.
Oggi questo processo è persino plateale.
I democratici americani non trovano di meglio che un’indomita paladina del potere finanziario. I socialisti francesi mettono un paese a ferro e fuoco pur di cancellare i diritti del lavoro dipendente. I laburisti inglesi si industriano per sbarazzarsi del loro unico dirigente radicale e il nostro Pd, votato ormai soltanto dalla buona borghesia delle città, non fa che studiare il modo per blindare il sistema pur di regalare ricchezza e potere alle oligarchie.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Milioni di americani poveri voteranno un miliardario invasato e irresponsabile. Milioni di operai francesi si riconoscono nella Le Pen. Milioni di proletari inglesi hanno dato retta a Farage e Johnson. Milioni di italiani prendono sul serio addirittura Salvini e Di Maio.
Definire questo fenomeno diffusione dei populismi è solo un modo per tranquillizzarsi, descrivendo le destre come banche cattive zeppe di spazzatura. Ma quando si giudica senza capire, il giudizio è per forza viziato.
C’è una domanda che bisognerebbe porsi prima di precipitarsi a dare i voti, una domanda di ordine storico, che chiama fatalmente in causa le culture politiche dei gruppi dirigenti di quella che in tempi ormai lontani fu, almeno in Europa, una sinistra sociale di massa. Perché questa metamorfosi delle sinistre socialiste?
Perché, soprattutto, in concomitanza dello sfondamento neoliberale che in Europa si verifica dagli anni Ottanta e che aggredisce la sovranità democratica dei corpi sociali, riduce al minimo diritti e redditi del lavoro salariato, impone politiche economiche incentrate sul dominio degli oligopoli industriali e dei potentati finanziari?
Il neoliberismo di Reagan e Thatcher era evidentemente un programma di destra: perché diviene subito – con Clinton e Blair – la stella polare della controparte, e come mai, soprattutto, lo rimane nei decenni di poi, nonostante l’evidenza dei suoi effetti rovinosi?
Sembra che porsi questi interrogativi mentre affondiamo impotenti nella miseria materiale e morale significhi rimuovere i problemi più urgenti, e invece è l’esatto contrario.
Potremo tentare di uscire da questa morta gora solo se finalmente capiremo le ragioni della mutazione che ha trasformato in radice la parte politica che nel suo complesso, con le sue molteplici articolazioni, nei trent’anni successivi alla guerra mondiale aveva fatto valere le ragioni del mondo del lavoro e difeso gli interessi delle classi subalterne.
Ottant’anni fa Gramsci si fece una domanda simile di fronte agli entusiasmi liberisti di alcuni dirigenti anarco-sindacalisti. E si rispose evocando il primitivismo ideologico («corporativo») di quanti ignorano le connessioni che legano l’economia alla politica.
Ci si può innamorare del libero mercato, a sinistra, solo se non si intende che dietro questa quinta si staglia un determinato assetto dei poteri e dei rapporti di forza tra le classi. Ma nel frattempo è successo di tutto, il fascismo è imploso, c’è stata un’altra guerra mondiale, la guerra fredda, il crollo del socialismo reale, una nuova mondializzazione: possibile che questa risposta, sempre che fosse giusta per quei tempi, valga ancora nei nostri?
Non si tratta di improvvisare soluzioni pur di mettersi l’animo in pace.
Lo ripetiamo: non muoveremo un passo fuori dalla palude (il che non ci impedirà di spedire qualche comparsa nel teatrino di Montecitorio) finché non avremo capito davvero le ragioni dell’eclissi della sinistra in tutto l’Occidente.
Si tratta quindi di lavorare, di studiare, di cercare seriamente. Qui, in linea d’ipotesi, è possibile tutt’al più segnalare una coincidenza, tautologica solo in apparenza. I partiti socialisti (e in Italia lo stesso partito comunista, maturata la decisione di dissolversi) si sono consegnati al neoliberismo quando hanno dismesso ogni intenzione critica nei confronti del sistema capitalistico, quando, ripudiata l’idea stessa di lotta di classe, hanno accettato di concepirsi come variabili interne del sistema, votate a ottimizzarne la riproduzione.
Ma si è trattato di una causa, o di una conseguenza? E, in questo caso, da dove nacque il mutamento, visto che precedette nel tempo anche il crollo dell’Unione sovietica?
Sembra comunque chiaro che è stato un gravissimo errore politico e storico e un disastro di immense proporzioni. Margini di evoluzione riformatrice del capitalismo sussistono nelle fasi espansive, mentre il neoliberismo fu ed è la risposta a una crisi strutturale di redditività del capitale industriale.
Avere rinunciato a qualsiasi azione di resistenza attiva ed essersi anzi trasformati in forze organiche al sistema in una fase storica che ne precludeva l’evoluzione «progressiva» ha comportato, inevitabilmente, il suicidio della sinistra socialista, laburista e liberal in tutta Europa e nel mondo anglosassone.
Oggi siamo alle prese, giorno per giorno, con le conseguenze di questa vicenda. Che va indagata in ogni suo passaggio e criticamente compresa, a meno di rassegnarci a quella che ci appare come la morte della politica.

. Il manifesto, 11 agosto 2016 (p.d.)
Vorrei raccomandare ai compagni lettori di questo testardo quotidiano di leggere quanto ha scritto Alberto Burgio in una recente riflessione sulla situazione presente (il manifesto del 4 agosto). In quell’articolo Burgio pone con forza il problema, grave e attuale, della crisi della politica, attraverso la quale, bene o male, agiscono i nostri cittadini. L’autore è molto secco: «E’ sempre più insistente – scrive – la sensazione che la politica sia morta, ridotta a (mala) amministrazione dell’esistente». D’accordo.
E’ la realtà di questi tempi, confermata ovviamente dalla clamorosa crisi dei partiti, che non è solo italiana, ma investe gli Stati uniti, dove i cittadini voteranno per una rappresentante della finanza o per il grottesco miliardario Trump e anche l’Inghilterra, come si è potuto constatare con la Brexit, la Francia dove cresce la leader del Front National, Marine Le Pen, la Spagna, e anche l’Italia come hanno confermato le ultime elezioni amministrative, e dove crescono l’astensionismo e l’antipartito dei 5 Stelle. Il confronto con i tempi nei quali c’erano il Pci di Togliatti, il Psi di Nenni, il Pri di La Malfa e anche la Dc di De Gasperi deprime assai. Aggiungo che l’attuale crisi investe anche Tv, stampa quotidiana e pure l’editoria che in passato non poco hanno contribuito alla vitalità della politica.
Bisognerebbe concentrarsi sulle cause e la dinamica di questa “morte della politica”: chiedersi, per esempio, come è cambiato in questi ultimi tre decenni il rapporto – anche il rapporto di forze – tra politica (istituzioni, rappresentanza, democrazia) ed economia (produzione, finanza, proprietà). Dovremmo di conseguenza chiederci anche dove risiede la sovranità in un paese come l’Italia e chi effettivamente la eserciti. Se le leggi vigenti (a cominciare dalla Costituzione, che l’attuale governo intende stravolgere) garantiscono ancora che siano i cittadini ad assumere le scelte fondamentali.
Se non ci rassegniamo a subire la “morte della politica”, studiare la situazione, individuare le cause. Il comune buon senso ci dice che senza una seria diagnosi non si cura nessuna malattia. Parliamo tanto di sinistra – della sinistra che non c’è, della sinistra che vorremmo – ma poi non ci impegniamo a mettere in cantiere riflessioni collettive che per la sinistra sarebbero davvero indispensabili.
Noi del manifesto avevamo pubblicato, insieme a Massimo Loche, nel novembre del 2014, un librino dal titolo Una crisi mai vista. Suggerimenti per una sinistra cieca con interventi di Burgio, Ciocca, Ferrajoli, Indovina, Katrougalos, Lunghini, Mazzetti, Pugliese, Ridao. Quello scritto si occupava di economia. Ma ora è evidente che il cattivo andamento della produzione e dell’occupazione (e forse un’insufficiente volontà di conflitto del sindacato) hanno fortemente indebolito i lavoratori e i sindacati e, soprattutto, tolto dalla scena quel fattore che si chiama speranza che è stato sempre decisivo per i movimenti e le lotte sociali e politiche: «Il sole dell’avvenire» appartiene al futuro, ma agisce sul presente.
E’ in corso – come titola il libro di Erik Brynjofasson e Andrei McAfee La nuova rivoluzione delle macchine che si differenzia dalla nostra era industriale, come quest’ultima si differenziava dall’agricoltura e che secondo il Nobel Leontief dovrebbe ridurre il ruolo delle persone come era stato per i cavalli in agricoltura, quando entrò in campo il trattore. Forse un eccesso di pessimismo contro il quale altri accademici hanno sostenuto che nel prossimo futuro la sicura perdita di peso del lavoro vivo per unità di prodotto sarà compensata dalla crescita della produzione globale. Insomma, grandi cambiamenti in arrivo e di incerto esito, ma dei quali la nostra attuale politica non si occupa affatto.
E ancora, c’è e incombe una storica crisi economica come è largamente sostenuto e come ben ci spiega Pierluigi Ciocca (il manifesto 10 agosto) e come scrivono giornali e riviste, che dovremmo leggere con più attenzione. Aggiungo che l’attuale crisi, a differenza di quella storica del 1929, non scuote la cultura: stagnazione dell’economia e stagnazione della cultura. Un circolo vizioso. Nel nostro passato non sono mancate crisi economiche, ma contemporaneamente quella crisi provocava una straordinaria vivacità culturale che nasceva dalla crisi e ne approfondiva le cause: impegnati saggi di analisi economica e sociale e anche quei romanzi (basta pensare a di Steinbeck) e quei film che fino a dopo la seconda guerra mondiale hanno animato la nostra giovinezza e la lotta politica. Dobbiamo renderci conto, ed è sotto i nostri occhi, che senza cultura la politica – come scrive Alberto Burgio – muore. Il manifesto può offrire gli strumenti per uscire dalla attuale passività sollecitando una discussione che mobiliti e apra una battaglia culturale e politica. Proviamoci.
 Oh com'è sbiadito il rosso dell'Emilia-RomagnaOrmai anche in questa regione, come in tutt'Italia (e in Europa) il colore dominante della "sinistra" vira dal rosso al rosa, dal rosa al bianco e, per finire, al grigio sporco dell'altra sponda.
Oh com'è sbiadito il rosso dell'Emilia-RomagnaOrmai anche in questa regione, come in tutt'Italia (e in Europa) il colore dominante della "sinistra" vira dal rosso al rosa, dal rosa al bianco e, per finire, al grigio sporco dell'altra sponda.
La Repubblica, 31 luglio 2016
I sindaci Pd dell’Emilia-Romagna alzano la voce contro il governo Renzi sul fronte accoglienza. «I migranti in arrivo sono in crescita, i posti ormai esauriti e la situazione rischia di diventare ingestibile» dicono in coro i primi cittadini, da Modena a Reggio Emilia a Ravenna.
Il fronte dei democratici è compatto e per la prima volta esprime il malessere degli amministratori in una regione, l’Emilia-Romagna “rossa”, da mesi in prima fila nel gestire gli arrivi dei richiedenti asilo ma ormai a corto di mezzi e posti davanti all’ennesima emergenza estiva. I sindaci rivendicano di aver fatto più dei loro colleghi del Nord e ora si ribellano. Il modenese Gian Carlo Muzzarelli è il capofila. Ha preso carta e penna e ha scritto al ministro dell’Interno Angelino Alfano: «Occorre garantire un equilibrio a livello nazionale e regionale delle quote di assegnazione che tenga conto delle realtà, come la nostra, che hanno già fatto ampiamente la propria parte e che sono arrivate al limite delle capacità di accoglienza». Non si tratta di uno stop («non intendiamo sottrarci alle nostre responsabilità » premettono i sindaci dem), ma il messaggio che parte dalla roccaforte emiliana è chiaro: «L’assegnazione di profughi nelle diverse realtà non sembra gestita con criteri distributivi all’insegna dell’equilibrio». Nel Modenese, ad esempio, sono quasi 1.100 i profughi ospitati in questo momento. E Muzzarelli denuncia «difficoltà crescenti in termini di gestione e tenuta del tessuto sociale».
A sentire i sindaci, c’è chi non fa fino in fondo il proprio dovere per coprire le quote assegnate dalle prefetture. I conflitti, ora sotterranei ma pronti a esplodere, sono tra gli stessi enti locali: «Sui posti siamo ormai vicini al limite, serve una più equa distribuzione dei flussi» incalza il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, che mette nel mirino gli amministratori delle altre Regioni: «L’Emilia-Romagna ha dato più di quanto richiesto. Non so se tutti abbiano fatto lo stesso. Noi non possiamo accogliere all’infinito».
Anche a Bologna, dove c’è il centro d’accoglienza regionale che smista i profughi nelle diverse province, la giunta è sulle spine: «Si devono introdurre dei limiti per garantire una buona accoglienza, altrimenti il sistema delle città non regge». In questi due anni, da quando è scoppiata l’emergenza, la struttura bolognese ha accolto oltre 16mila migranti. I primi cittadini tirano in ballo prefetture, governatori e, soprattutto, Palazzo Chigi. È il caso del nuovo sindaco di Ravenna, Michele De Pascale: «Da parte del governo Renzi ci aspettiamo una soluzione forte, perché non sappiamo se riusciremo a gestire l’accoglienza con la stessa efficacia avuta fino a oggi ».
La vicepresidente dell’Emilia Romagna, la renziana Elisabetta Gualmini, dice di «comprendere il dolore dei sindaci» ma chiede di evitare conflitti nei confronti del governo: «La contrapposizione con Roma — avverte — non porta da nessuna parte. Dobbiamo però risolvere il ruolo ambiguo delle Regioni, perché noi non abbiamo competenze nell’assegnazione delle richieste di asilo che sono in mano alle prefetture. Questo ci lega le mani e, quando ci sono i picchi, la situazione è ingestibile».

Il manifesto, 21 luglio 2016
Nella conversazione che segue la parola chiave è «instabilità», la «cifra che rimane sempre dentro», dice Fausto Bertinotti, o «La scintilla che può incendiare la prateria» come ha intitolato il suo editoriale nell’ultimo numero della rivista Alternative per il socialismo. A pensar male l’instabilità potrebbe essere la cifra della sua vita politica, date le indimenticabili rotture di cui ancora oggi si professa «orgoglioso». Ma non è di Prodi che parliamo stavolta. Parliamo di Renzi. Che per Bertinotti non è neanche un caso speciale: «È un po’ più o un po’ meno ma tutto sommato come gli altri che governano l’Europa. Sarebbe meglio che cadessero tutti, provocherebbe instabilità. Ma se non si ricostruisce la democrazia, va via lui ma viene avanti un altro uguale».
Un passo alla volta. Renzi ha perso la spinta propulsiva?
La sua ipotesi, dopo un inizio di successo, ora ha elementi di crisi. Il suo compito era dare una forma stabile alla governabilità, cosa in cui non erano riusciti i predecessori. Prima sul terreno sociale, come gli chiedevano i padroni del vapore attraverso Draghi: ha risposto ’obbedisco’. Ed ecco il jobs act e la controriforma della scuola.
Chi sono i padroni del vapore?
Il capitalismo globale finanziario. Le grandi multinazionali. Le banche centrali. Il governo sovranazionale chiamato Troika. Renzi poi, secondo passo, doveva realizzare la governabilità rendendo le istituzioni stabili anche in presenza di uno scarso consenso popolare. Ed ecco la riforma costituzionale, fine di un lungo ciclo per mettere in mora le assemblee elettive e sostituirle con la centralità del governo. All’inizio un parte del mondo politico era attratta da Renzi, anche i grandi facitori di opinione. Ma l’assolutizzazione della governabilità produce instabilità.
È un paradosso.
Sì. La rana vuole farsi mucca ma non ce la fa e scoppia. Il conflitto, domato in termini di alternativa politica, destra-sinistra, con il suicidio della sinistra, ritorna in termini di alto-basso e lotta contro le élite. Il partito unico del governo non ce la fa, le politiche reali producono crisi della coesione sociale. È successo a Valls, a Cameron, a Rajoy. E l’irresistibile ascesa va in crisi.
In tutto questo il referendum che ruolo ha?
«È un appuntamento importante, carico di significati non iscritti nella contesa. Questo è stata la Brexit: ormai la percezione ha preso il posto del programma. L’evocata volontà popolare diventa un giudizio di dio sulle classi dirigenti: fra chi vuole che continuino a guidare il convoglio e chi invece dice: ci portano verso il baratro, fermiamo il convoglio.
Lei voterà no, dunque.
Ma con un voto smagato. Voterò no per contribuire a fermare il convoglio. Anche se poi, fermate le macchine, resteremo in un regime neoautoritario dove la sovranità popolare è sospesa. Bisognerebbe che, scesi dal convoglio, ci rimettessimo in marcia per la conquista della democrazia. Non per la difesa: cosa difendi se la democrazia non c’è più? Come disse Togliatti, con solita perfidia, ai comunisti francesi che si opponevano alla riforma di De Gaulle: non si può difendere con efficacia la democrazia quando è già ridotta a un simulacro. Ma insomma: gli Indignados, la Nuit debut, sono tutti già scesi dal convoglio.
Qui in Italia ci sono i 5 stelle.
Loro sono ’antisistema’ però solo sul versante ’politico’. Ma il sistema è quello capitalistico. In ogni caso: a loro sono interessato perché contribuiscono a battere il partito della stabilità. Scriverò l’elogio dell’instabilità. La stabilità è il nostro nemico, batterla è la condizione per tornare a respirare. E del resto la loro stabilità non governa niente: né i treni di Andria, né la Promenade des Anglais, né la Brexit. Diceva Mao : grande è il disordine, la situazione è eccellente. Non sarà eccellente, ma meglio che niente.
Ma l’instabilità non è un programma. E una volta destabilizzato il governo?Per imparare a nuotare bisogna buttarsi in acqua. L’instabilità costringe a mettere al primo posto la pratica sociale.
Comunque Pd e 5 stelle pari non sono?
No, non sono pari. Il Pd è il sacerdote della stabilità, il M5S si è costruito all’opposizione del sistema politico, introduce contraddizioni. E se cambiassero linea sui migranti passerei a un atteggiamento anche più coinvolto. Perché loro sono in conflitto con le élite, basso contro alto, esattamente il terreno che dovrebbe praticare la sinistra. Alle sindache Raggi e Appendino direi: fate una passeggiata a Barcellona e Madrid per discutere con le due colleghe sindache l’idea di ’città nuova’ come parte di una nuova Europa.
A suo parere Sinistra italiana va nella direzione giusta? I leader sono quasi tutti suoi allievi, la generazione di Genova 2001.
Non voglio entrare nei conflitti interni di una forza nascente. Ma a mio parere non nascerà nessuna sinistra se non fuoriesce dall’involucro dell’istituzione partito per andare verso le pratiche sociali. A Genova sbagliammo a non accettare fino in fondo la sfida di assumere la testa del movimento sciogliendo l’ultimo partito del 900. Diceva un insigne teologo: solo dall’imprevisto può venire la salvezza. La spagnola Podemos e la greca Syriza vengono da Genova e nascono dalla piazza.
Tsipras un partito l’ha costruito, eccome.
In Syriza sono approdati esponenti del vecchio Synaspismós, ma resta che è stata la piazza greca a far nascere la Coalizione. Anche in Italia il processo costituente deve nascere dalla piazza. Non per partenogenesi.
E se in Italia la piazza non c’è?
E allora si adoperino a costruirla. Bisogna costruire un popolo, scomparso al pari dei partiti. E non lo reinventeranno con una costruzione politica, ennesima prigione, ma con una pratica sociale. La sinistra non ha neanche la mappa di tutte le forme di partecipazione, associazione, autogoverno. E perché? Perché le interessa un altro terreno, quello dell’istituzione-partito. Così la diaspora del suo voto approda altrove, ai 5 stelle.

Il manifesto, 19 luglio 2016
Il 17 luglio di ottanta anni fa, un «pronunciamiento» militare prese le mosse dal Marocco, estendendosi il giorno successivo in tutta la Spagna, secondo un piano da tempo preparato da alcuni generali spagnoli. L’intento dei cospiratori era quello di provocare la caduta del governo repubblicano e di imporre un regime autoritario.
Dopo tre giorni, il golpe poteva considerarsi parzialmente fallito: la spontanea reazione da parte delle masse popolari, che risposero all’appello per una difesa in armi della Repubblica lanciato dai partiti vincitori delle elezioni nel febbraio dello stesso anno e dai sindacati, diede vita una guerra che, seppur combattuta solamente sul suolo iberico, coinvolse tutto il mondo e, in modo particolare, l’Italia. Non solo perché i golpisti ottennero il sostegno di Mussolini, che inviò oltre a un ingente quantitativo di materiale bellico un corpo di spedizione di circa cinquantamila soldati, ma anche perché a fianco del legittimo governo accorsero circa quattromila volontari antifascisti. Combattere in Spagna fu un’esperienza coinvolgente e drammatica per molti giovani italiani, convinti fascisti seppure di sinistra che, in quell’estate del 1936, videro cambiare la propria vita.
Ripensamenti politici
La scelta di appoggiare la lotta dei repubblicani spagnoli – e come testimoniò Romano Bilenchi «scoppiò la guerra di Spagna; e noi trepidammo per ’i rossi’ e soffrimmo il soffribile» – li indirizzò verso (non è dato sapere fino a che punto) una consapevole scelta di campo antifascista, aprendo la strada a un profondo cambiamento, perché, come notò lo scrittore inglese Stephen Spender, in poche settimane, la Spagna era diventata il simbolo della speranza per tutti gli antifascisti. Offriva al Ventesimo secolo un nuovo 1848 e cioè un tempo e un luogo nel quale una causa che rappresenta un grado di libertà e giustizia più alto di quella reazionaria, che gli si oppone, riusciva ad ottenere vittorie. Divenne possibile vedere la lotta tra fascismo e antifascismo come un reale conflitto di idee e non solo come la vicenda di dittatori che strappano il potere a deboli oppositori.
Tra coloro che iniziarono un sofferto ripensamento sull’essere giovani intellettuali fascisti, alcuni svolgeranno in seguito un ruolo importante nello scenario politico e culturale del secondo dopoguerra italiano e citiamo, solo per indicare i più noti, Pietro Ingrao, Elio Vittorini, Vasco Pratolini, Mario Alicata, Antonio Amendola, Paolo Bufalini, Antonio Giolitti, Renato Guttuso, Lucio Lombardo Radice e Aldo Natoli.
La presenza di futuri dirigenti del Pci e di «intellettuali organici» a partire dal 1945 non significa, come ha fatto notare Claudio Pavone, che sia esistita una continuità tra l’esperienza politica dei giovani fascisti di «sinistra» e il loro diventare comunisti. Non vi era dunque un universo giovanile fascista, predestinato a muoversi, fatalmente, verso lidi antifascisti e prioritariamente comunisti, essendo essi, come ebbe a definirli Togliatti, «comunisti che si ignoravano».
Colui che testimoniò con forza e più volte questo percorso fu Vittorini, che nel 1945 sul primo numero de Il Politecnico non solo rendeva un omaggio al martoriato popolo spagnolo ma, ricordando quei giorni, tracciava un bilancio delle proprie scelte politiche e umane. «La guerra civile di Spagna – affermava lo scrittore siracusano – ha una grande importanza nella storia italiana. Tutta la gioventù italiana era senza contatto, prima del luglio 1936, con il mondo della democrazia progressiva. Dobbiamo dirlo: l’antifascismo italiano risultava morto per gli italiani; era tutto all’estero, emigrato, o era in prigione, era al confino, chiuso in se stesso e molti di noi non l’avevano mai conosciuto. Madrid, Barcellona… Ogni operaio che non fosse un ubriacone e ogni intellettuale che avesse le scarpe rotte, passarono curvi sulla radio a galena ogni loro sera, cercando nella pioggia che cadeva sull’Italia, ogni notte dopo ogni sera, le colline illuminate di quei due nomi. Ora sentivamo che nell’offeso mondo si poteva essere fuori della servitù e in armi contro di essa».
L’altro cammino
Appare significativo come Vittorini abbia sentito il bisogno di ricollegarsi alla guerra di Spagna, ai suoi valori e ai suoi miti proprio nel primo numero del settimanale che, a liberazione avvenuta, espresse il pensiero di una nuova élite culturale. Quasi mezzo secolo dopo Ingrao gli fece eco nella sua autobiografia, affermando che per lui «il punto discriminante ha proprio una data precisa: è la guerra di Spagna. Con una frase un po’ retorica direi che la guerra di Spagna, proprio, è una data che spacca la mia vita: da allora comincia un altro cammino».
Non fu un percorso facile e neppure lineare. Come ha giustamente sottolineato Emilio Gentile, il paradigma mussoliniano appariva con un futuro entusiasmante per le nuove generazioni, soprattutto per quelle cresciute culturalmente nel contesto totalitario dove la percezione della realtà era condizionata dalla propaganda fascista che, come sottolineò Vittorini, era riuscita a instillare «nei giovani l’illusione di essere rivoluzionari ad esser fascisti».
Sia che fossero già delusi dal fascismo dopo una giovanile e convinta adesione, sia che lo fossero diventati dopo l’appoggio del regime ai nazionalisti spagnoli che si presentava davanti ai loro occhi come un atto antirivoluzionario, la tragedia spagnola rappresentò una svolta esistenziale, portandoli verso una dura e sofferta autocritica che li rese consapevoli di come avrebbero potuto riacquistare la dignità soltanto dotandosi di un nuovo codice comportamentale.
La reazione del proletariato spagnolo segnava un nuovo inizio, mentre, contemporaneamente, con l’aiuto ai generali golpisti, il fascismo, fino a quel momento difeso nonostante tutto, gettava la sua maschera mostrando il proprio fallimento. Ma le notizie giunte attraverso le radio a galena, non dimostravano solo questo.
Per alcuni la guerra civile spagnola non rappresentò soltanto un esempio concreto di lotta antifascista ma – grazie all’influenza dei movimenti letterari e artistici europei, idealmente partecipi a fianco della repubblica spagnola – si inserì in un più ampio paradigma di sprovincializzazione della cultura italiana. Se in un primo tempo i temi della discussione si ispiravano alla vecchia tradizione antifascista, la guerra civile di Spagna – con l’aggressione da parte dell’oligarchia terriera, di buona parte dell’esercito e dei vertici della Chiesa cattolica a quanti si battevano per una democratica modernizzazione del paese – poneva di fronte i più giovani a una nuova realtà.
Dopo l’estate del 1936 non si sentirono più isolati dal resto del mondo, perché attraverso le notizie che filtravano tra le maglie della censura avevano capito di essere in sintonia con le forze migliori della cultura europea e americana, da Hemingway a Orwell, passando per Malraux, ovvero intellettuali che si stavano battendo a fianco dei repubblicani spagnoli. Un elemento che non rappresentava solo un fatto d’armi e una solidarietà politica militante, ma una esaltante novità culturale. Attraverso la fucilazione di Garcia Lorca, l’Italia scoprì come il mondo culturale spagnolo non si fosse fermato a Miguel De Unamuno, ma esistessero anche Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez e Rafael Alberti. Parimenti, comprese come le ragioni dell’antifascismo potessero trionfare non solo grazie alla lotta della classe operaia in armi, ma anche attraverso il linguaggio rivoluzionario del cubismo, adottando il rinnovamento narrativo espresso da Hemingway, oppure ascoltando le nuove espressioni musicali. In questo clima, maturarono consapevolezze che resero ineluttabile l’esigenza di fare i conti anche con una tradizione culturale italiana, fino a quel momento inadeguata non solo a resistere al fascismo, ma soprattutto a fornire, una volta resasi chiara la sua natura totalitaria, gli strumenti per combatterlo.
Nel suo libro, tuttora attuale, sugli intellettuali e la guerra di Spagna, Aldo Garosci affermava che il dramma della Spagna simboleggiò, per una parte della giovane generazione intellettuale italiana alla vigilia e durante la lotta della liberazione, il ritorno del problema etico nella politica.
Nuovi sentimenti
Nacque da un impulso di dare vita a un «nuovo antifascismo», anche se non contrapposto o in concorrenza con quello fino a quel momento operante in Italia e soprattutto all’estero. Ma, proprio come accadde al fascismo «di sinistra» che mai si trasformò in un progetto politico e organizzativo, anche il «nuovo antifascismo» rimase un sentimento individuale, seppur condiviso, all’interno di ambienti culturali ben definiti, che preconizzava come a fianco della tradizionale opposizione al regime dei settori del proletariato più politicizzato si sviluppasse un impegno militante di giovani studenti, intellettuali e artisti.
Non importa se si trattò di un’esperienza minoritaria debole e confusa, che agiva da una parte all’interno di un mondo dominato dalla «fabbrica del consenso totalitario» tutta protesa alla creazione di un «mondo» e un «uomo nuovo», e dall’altra dalla mancanza di contatti con l’antifascismo tradizionale, trovatosi, dopo la guerra d’Etiopia, in una condizione di crisi e disorganizzazione. Era la prima volta che nel soffocante controllo culturale imposto dal regime, si prendeva coscienza di come nella realtà della vita quotidiana, l’intellettuale italiano potesse e dovesse recitare il proprio ruolo, facendo confluire il suo impegno culturale, per utilizzare un termine coniato da Vittorini, nella «ragione antifascista». Una ragione che si formò «non per trasmissione di esperienza da padri a figli e da vecchi a giovani, ma per dure, brutali lezioni avute direttamente dalle cose e dentro le cose, per lente maturazioni individuali, per faticose scoperte di verità, tutta auto-educazione, e tutta tra il luglio del ’36 e il maggio del ’39».
 Qualche speranza dall'area che tenta di far nascere una formazione di sinistra all'altezza dei tempi partendo ciò che resta della sinistra novecentesca. Reste una domanda: qual'è oggi il mondo dello sfruttamento?
Qualche speranza dall'area che tenta di far nascere una formazione di sinistra all'altezza dei tempi partendo ciò che resta della sinistra novecentesca. Reste una domanda: qual'è oggi il mondo dello sfruttamento?
Il manifesto, 19 luglio 2016
Scrivo per dire ai lettori de manifesto interessati alle sorti del costruendo nuovo soggetto di sinistra, provvisoriamente chiamato SI – e che tengono in qualche conto l’ opinione di una ottuagenaria – che, secondo me, l’assemblea di sabato nella Sala di via dei Frentani è stata positiva. Anche più di quanto prevedevo. Non solo per il numero dei partecipanti, ma anche per la loro qualità: quasi tutti più giovani (e più equilibrati per genere) degli abituali frequentatori degli innumerevoli appuntamenti della sinistra; e perciò meno oppressi dai rancori prodotti dalla sua frantumata storia.
E tuttavia, incoraggiata dalla introduzione di Alfredo D’Attorre che non ha risparmiato l’autocritica sul nostro comune vissuto di questi ultimi mesi, vorrei dire anche io cosa mi sembra ancora non vada. Estraggo solo un paio di cose fra i molti temi di cui vorrei si discutesse seriamente già nella fase di preparazione del congresso. (Se si mette al mondo un partito si può anche accettare che non tutti siano d’accordo su tutto, ma occorre almeno che le diversità siano rese esplicite per poterle superare).
Comincio dall’alternativa. Nicola Fratoianni ha risposto con efficacia nel suo intervento alla denuncia dei compagni sardi (francamente un po’ rozza: chiedere di andarsene al gruppo dirigente di Sel perché non avrebbe vinto, presentando invece vincente la carta del centro sinistra, è davvero un po’ troppo ).
Né ha qualche fondamento l’ipotesi di un centro sinistra che rinascerebbe dalle ceneri solo che Renzi fosse sconfitto, perché oramai il Pd riflette un altro blocco sociale, un’altra cultura, altri valori;e perché Renzi non è un marziano, ma il rappresentante locale di una potente corrente mondiale, e specificamente europea, che considera la democrazia quale la abbiamo conosciuta un impiccio ormai non sopportabile per il sistema; che dunque va sostituita con la governance, e cioè sottraendo il potere deliberante alla sovranità popolare per affidarlo a esecutivi simili ai Consigli d’amministrazione delle imprese. (Altra cosa è quanto resta del vecchio corpaccio comunista, portatore di una memoria importante, e però incapace di accettare il dovere di un nuovo inizio. In quel pezzo di popolo ci sono naturalmente tutt’ora interlocutori per noi decisivi).
La parvenza di realismo della posizione dei nostalgici del centrosinistra sta nel dire: un altro schieramento governativo oggi non c’è. Il che è assolutamente vero. Le nostre liste alle elezioni amministrative non hanno avuto successo – molti l’hanno detto – proprio per questo. A differenza dei 5 Stelle, che un’alternativa l’hanno rappresentata in alcune importanti metropoli. Almeno nominalmente, poi vedremo.
Prendere d’atto che per ora non esiste una formula sostitutiva del defunto centrosinistra a livello nazionale – altra cosa sono le istituzioni locali, perché il territorio sta già dando prova di essere ricco di energie e formule inedite di rappresentanza – non rende tuttavia affatto meno credibile il nostro discorso. A condizione si renda chiaro che la premessa di ogni seria alternativa è la ricostruzione di un tessuto democratico pesantemente slabbrato, capace di ricreare le condizioni affinché la politica torni ad avere un ruolo. Senza la paziente e difficile ricostruzione di forme di partecipazione e di assunzione di responsabilità collettiva, vince l’idea della efficienza manageriale (Renzi) o la comunicazione mediatica che crea il mito di individui onesti in virtù dello spirito santo. O, peggio, il disincanto. Quando chiediamo voti è intanto per dar forza a questo progetto immediato ed urgente.
Non vuol dire ignorare la necessità di conquistare un ruolo istituzionale e rifugiarsi nella cuccia dell’extraparlamento. Anche questa battaglia può portare frutti corposi: basta con questa ossessione “governista” che delega i risultati solo e sempre a quanto potrebbe fare un governo. (Se combattiamo contro lo stravolgimento costituzionale minacciato da Renzi non è del resto proprio perché il suo nocciolo consiste nel voler consegnare il potere di deliberare tutto e solo nelle mani dell’esecutivo, nel ridurre la democrazia alla tutela del monopolio della maggioranza, alla c.d.”governabilità”?)
Il vecchio Pci al governo non c’è stato mai, ma sappiamo che quasi tutto quanto di buono abbiamo conquistato è stato merito della sua azione. Anche allora non c’era una prospettiva immediata di governo, ma quel partito è stato efficace perché ha saputo conservare un’ottica di governo ( che è altra cosa), senza chiudersi in sterili minoritarismi.
Attrezziamoci a creare le condizioni per ottenere altrettanto, nelle forme adeguate ai tempi presenti. Il che vuol dire dar vita non solo al Partito che vogliamo far nascere, ma contemporaneamente essere l’anima, lo stimolo, per la crescita non solo di movimenti di protesta, ma di una rete di più consolidati organismi che si assumono sul territorio, e laddove c’è lavoro sfruttato, la responsabilità di gestire la collettività e di dar luce e prospettiva alla sua conflittualità. Da questo punto di vista le coalizioni che si sono costituite in molte città per le elezioni amministrative possono essere una risorsa preziosa ed è nostro interesse tenerle in vita. (Del resto il solo modo per impedire che un partito diventi autoreferenziale è mantenere vivo un rapporto dialettico con quanto si muove al di fuori, nella società. (Non averlo fatto, dal ’68 in poi, è stato il mortale errore del Pci).
È difficile un simile discorso, poco “popolare”? Sì, lo è.
Ma difficilissimo – dobbiamo saperlo – è fare un partito, tanto più in un tempo in cui la bussola non è più offerta, linearmente, da un soggetto socialmente omogeneo come era la classe operaia novecentesca. All’assemblea di via dei Frentani si è sentita molto spesso l’eco, soprattutto negli interventi dei più giovani, del dibattito che è riemerso sul populismo di sinistra, reintrodotto da Laclau tramite Pablo Iglesias. Anche questo mi pare un tema da affrontare. Capisco la preoccupazione di chi teme un distacco dalle masse popolari, l’intellettualismo di certo sinistrese, il timore che suscita vedere la sinistra vincere solo fra i ceti medi colti e non più nelle periferie. Ma non semplifichiamo troppo questo discorso.
Ernesto Laclau, al di là di qualche stravolgimento interpretativo che c’è stato, intendeva in realtà riproporre (e lo ha fatto un po’ confusamente) la tesi gramsciana sulla necessità di costruire anche in Italia un popolo-nazione. Ma Gramsci voleva sottolineare l’importanza a questo fine del momento soggettivo, contro ogni spontaneità elementare. Credeva al ruolo degli intellettuali, non come detentori di uno specialismo e come esponenti di una professionalizzazione della politica, bensì, tutt’al contrario, al loro diventare “organici”, per superare la loro separazione e colmare la distanza fra governanti e governati, sola base reale della democrazia. Nella società e nei partiti. Solo i populisti veri sono quelli che hanno interesse a lasciare il popolo preda di una cultura primitiva, che riflette solo quella del potere, laddove l’obiettivo – certo ambizioso – è rendere possibile un progresso intellettuale di massa e non di ridotte elites. Il famoso “intellettuale collettivo”.
Non vorrei che il sacrosanto accento sulla necessità di recuperare un rapporto con il popolo fosse immeschinito. Proprio oggi quando anche solo immaginare un mondo che produca, consumi, viva in modo diverso richiede una eccezionale capacità innovativa. Se poi invece questo richiamo è lanciato nell’intento di recuperare anche quel rapporto fisico che un tempo c’è stato nella sinistra – qualcuno ha detto “mischiarsi”- allora ben venga. Perché tornare a vivere e a far politica in luoghi comuni è essenziale: voglio ricordare la più proficua esperienza, ancora una volta del vecchio Pci, quando segretari delle sezioni più periferiche sono stati i più importanti intellettuali comunisti.
Giulia Merlo intervista Luciana Castellina, limpida voce della migliore sinistra novecentesca e della speranza di un futuro alla sua altezza. «Il Partito comunista ha realizzato le cose migliori per questo paese. Ora c’è la morte: le periferie prima erano dense di vita collettiva e politica, oggi sono luoghi dove non c’è nulla». Il Dubbio, 11 luglio 2016
«Sinistra significa cercare ciò che nessuna rivoluzione è ancora riuscita a ottenere: coniugarel’uguaglianza con la libertà. Un obiettivo non ancora raggiunto, ma non vedo perché dovremmo rinunciare». E Luciana Castellina rinunciare non intende di certo. Figlia della generazione “giovane e bella” che ha visto sbocciare l’Italia repubblicana, è stata una protagonista della sinistra in tutte le sue forme: da politica come dirigente del Partito comunista, da intellettuale quando fondò Il manifesto, uscendo traumaticamente da quello che ancora oggi considera il suo partito, e ora da memoria storica, che guarda con disincanto dalla sua casa di Roma le macerie di una politica da rifondare.
Cominciamo dall’oggi. Guardando alla sinistra italiana, nel Partito Democratico di oggi vede una qualche eredità del suo Partito comunista?Il Partito Democratico non è l’eredità del Pci, è l’aborto. Pur con tutta la buona volontà, non vedo nulla di quella storia. Certo, quando giro per l’Italia incontro tanti bravi compagni, che sono rimasti uniti per quello che loro considerano ancora “il partito”, ma io mi chiedo quale partito. Il Pd non esiste come struttura partitica viva nel Paese.
Quella del Pci è una tradizione che è andata dispersa, quindi?
Il Partito comunista italiano è un cadavere che giace abbandonato. Con la costituzione del Pd è stata spezzata una storia, un orgoglio e una soggettività, e lo si è fatto in modo mortificante. Anche questo ha contribuito a far germinare la cultura dell’antipolitica e dell’individualismo, che stanno distruggendo l’idea stessa di democrazia.
L’ultimo portatore della tradizione comunista, forse, è Massimo D’Alema.
Mah. D’Alema è una figura bizzarra, perché non è parte del Partito Democratico ma continua a dimenarsi al suo interno, combinandone di ogni genere. Lo considero una persona intelligente, ma politicamente le ha sbagliate tutte.
Eppure il suo leader, il premier Matteo Renzi, è indubbiamente una figura carismatica che ha riportato il centro-sinistra alla guida del Paese.
Mi viene difficile definire di sinistra un Governo che sostiene che il Parlamento debba intralciare il meno possibile, che i sindacati siano da ammazzare e che la governance vada affidata a tecnici e a fantomatici “esperti”. Per quel che riguarda la leadership, un leader non può esistere senza un partito. La politica di oggi è uguale ai programmi televisivi, che ragionano solo in termini di auditel e che cambiano per incontrare il gradimento del pubblico. E’ un gioco di specchi: la politica coincide con l’opinione pubblica, che segue ciò che il potere costituito le induce.
Come dovrebbe essere, invece?
La politica è costruzione di senso, di un progetto e dunque di un soggetto consapevole. E qui incontriamo il problema sociale dei nostri tempi: la collettività, che non riesce a ritrovare il proprio protagonismo.
Lei ha vissuto gli anni più intensi della storia del Partito comunista e della sinistra italiana. Che cosa ricorda di quegli anni?
Il Partito ha vissuto una storia più ortodossa e una più eretica, che poi è stata la mia. Nell’insieme, però, tutto ciò che di buono si è ottenuto in questo paese viene dal Partito comunista italiano. Ricordo gli anni Cinquanta, difficilissimi e con lotte terribili, ma anche anni di costruzione e di grande entusiasmo. Poi gli anni Sessanta, in cui la sinistra italiana si è aperta alle correnti politiche e culturali internazionali, generando un dibattito vivace, sfociato poi nella bellissima stagione del 1968. In questi anni abbiamo combattuto per impedire il degrado del Pci, che si stava burocratizzando e arroccando nelle istituzioni e nei poteri locali, perdendo contatto con le lotte. Gli anni Settanta sono stati invece l’inizio della fine.
Ricorda quando ha preso la prima tessera del Pci?
Io mi sono iscritta nel novembre 1947, l’anno delle elezioni amministrative a Roma. Venivo dalle battaglie del partito a livello giovanile con il Fronte della gioventù, e a spingermi a prendere la tessera è stato un episodio di cronaca. In quell’anno un militante della Democrazia Cristiana venne ammazzato a piazza Vittorio, mentre attaccava dei manifesti. Dell’omicidio furono accusati tre ragazzi comunisti, arrestati e poi scarcerati, e fu forse la prima delle provocazioni di quel periodo di grandi contrasti. Non si scoprì mai chi uccise quel giovane, ma per me quello fu il segnale che i tempi belli del Dopoguerra e delle speranze erano finiti e che cominciava un periodo duro, di scontro anticomunista. Lì ho capito che non si poteva più solo simpatizzare ma bisognava impegnarsi completamente.
Quella è stata anche la stagione dei grandi leader di partito. Chi ricorda con più nostalgia?
Sicuramente Palmiro Togliatti. Fu un personaggio di statura straordinaria, di cui oggi non si parla più. Io l’ho conosciuto: parlava come un professore di liceo e scriveva in modo molto difficile, portava sempre un vestito blu a righe con il doppio petto e gli occhiali. Aveva tutto tranne che l’aspetto di un leader carismatico come lo intendiamo oggi, eppure la sua morte ha provocato il primo vero moto spontaneo e nemmeno previsto dei militanti del Pci. Un milione di persone si riversò a Roma per il suo funerale, una mobilitazione immensa che non si era mai vista, vent’anni prima di Berlinguer.
Un nome, quello di Enrico Berlinguer, che più di Togliatti è rimasto nella memoria collettiva della sinistra di oggi.
Berlinguer è stato fatto passare per una sorta di zio buono e un po’ scemo. In questo senso, l’informazione ha fatto un servizio terribile alla sua memoria. Per ciò che posso dire io, il giudizio migliore su di lui me lo diede una militante, che mi disse: «Parla così male che è assolutamente certo che dica la verità». Questo per dire come non era certo l’arruffapopoli che ad alcuni piace descrivere.
Com’è stato essere donna in un partito come il Pci?
Quando ferveva il dibattito sul voto femminile, la parte più retrograda del partito era contraria perché temeva che, dando il voto alle donne, queste avrebbero ascoltato il parroco e votato per la Democrazia Cristiana. Fu Togliatti ad imporsi, rivendicando il protagonismo politico femminile: il Pci ha consapevolmente costruito una soggettività delle donne, pur scontando un’origine culturale profondamente contadina.
Il Pci ha anche dato al Parlamento la prima donna Presidente della Camera...
Io ho apprezzato Nilde Iotti soprattutto nella sua fase politica precedente, perché poi la retorica l’ha trasformata in una specie di busto marmoreo. Lei invece ha diretto con grande intelligenza la sezione femminile del Pci e il suo merito è stato di avere il coraggio di essere una donna normale, senza travestirsi né da guerrigliera né da suora missionaria.
Lei però il Pci lo ha abbandonato, quando fondò Il manifesto insieme a Pintor, Rossanda e Parlato.
E’ stata una scelta drammatica per me, che ero iscritta al partito da 25 anni. Il nostro però non è stato lo strappo con un mondo, perché il nostro obiettivo era quello di rifondare il Partito comunista. Ricordo ancora lo slogan: volevamo «scioglierci in un rigenerato comunismo italiano».
Anche l’informazione, in Italia, è cambiata molto da quel 1971.
Sicuramente oggi i quotidiani mi annoiano molto più di allora. Oggi i giornali dovrebbero essere più difficili, non rincorrere facilonerie. Per le cose facili c’è internet, se compro un giornale vorrei che qualcuno mi spiegasse ciò che non capisco, invece di infarcire le pagine di banalità.
Tornando a parlare dell’oggi, Roma ha appena eletto la prima sindaca donnadel Movimento 5 Stelle e le periferie hanno definitivamente abbandonato lasinistra. Se lo aspettava?
Non mi ha meravigliato. Non nutro speranze su Virginia Raggi, ma del restonemmeno Gesù Cristo potrebbe risollevare Roma. Basta andare a vederle, quelleperiferie: prima erano dense di vita collettiva e politica, oggi sono luoghidove non c’è nulla. Questa città è cambiata in modo tremendo: se penso acom’erano le mie borgate, dove andavo a lavorare per il partito negli anniCinquanta! Erano luoghi tremendi, pieni di profughi, ladri, prostitute,affamati e analfabeti, ma fremevano di uno straordinario protagonismo che oggisi è completamente perso.
Eppure alcuni analisti vedono qualcosa del vecchio Pci nella struttura delMovimento 5 Stelle.
Falso, non bisogna confondere un partito di massa con il populismo. Il Pci eraun partito del popolo che riusciva a interpretare la propria storia per darleun senso popolare e non d’élite. I 5 Stelle, invece, credono che il popolosiano le poche manciate di persone che rispondono ai loro sondaggi su internet.
E nella sinistra italiana qualcosa si sta muovendo?
La società italiana è dinamica, i movimenti stanno riprendendo forza,soprattutto quelli che si occupano di immigrazione, e anche la rete deglistudenti di sinistra è una realtà meravigliosa. Si tratta, però, di unadimensione frantumata che va ricostruita, soprattutto dal punto di vista dellacomunicazione e della visibilità. Il vero obiettivo, però, rimane quello diriportare la gente ad amare la democrazia, ricominciando dall’Abc e riportandoi giovani alla politica, che significa prima di tutto pensare il mondo inrelazione all’altro e non a se stessi.
A proposito di democrazia, andrà a votare al referendum costituzionale diottobre?
Assolutamente sì. Andrò a votare, parteciperò ai comitati e voterò no, proprioin nome della cultura democratica di cui abbiamo parlato.
L’Europa è il tema del suo ultimo libro, Manuale antiretorico dell’UnioneEuropea, in cui analizza le origini ma soprattutto il futuro di questaistituzione. Lei che giudizio dà?
Anzitutto io credo sia necessario sciogliere un equivoco. L’Europa e la suaistituzione - prima la Cee e oggi l’Unione Europea- sono due cose moltodiverse. Si può amare molto l’Europa e detestarne invece l’istituzione. Delresto, che l’Ue fosse detestabile si vedeva già dalla sua costituzione, bastipensare che gli stessi federalisti della scuola di Altiero Spinelli ladisconobbero subito come loro creatura. L’Unione nasceva con l’ideale diimpedire le guerre nel continente, ma poi nel concreto divenne da subito partein campo della Guerra Fredda, coincise con la Nato e con l’armarsidell’Occidente. Per quanto riguarda un giudizio sull’oggi, l’Europa deltrattato di Maastricht e Lisbona è se possibile anche peggiore di quellainiziale.
La risposta è la Brexit, allora?
Certo che no. La Brexit nasce da una pulsione diversa, lo scetticismobritannico verso un’istituzione che viveva come riduttiva del suo ruolostorico. Inoltre in Gran Bretagna c’è stata una fortissima polemica delsindacato operaio contro un’Europa che avvertiva come responsabile di unattacco al welfare, cosa per altro storicamente falsa perché è stata MargaretThatcher a smantellarlo. Io credo che, nonostante tutto, una forma diistituzione europea vada mantenuta, perché necessaria come strutturapolitico-democratica che prenda le decisioni in un mondo sempre piùglobalizzato. In questo senso considero il ritorno alla sovranità nazionalecome una pura follia, e chi crede il contrario non sa di che parla. Rimaneresoli come stati nazionali significa cadere nell’oceano della globalizzazione evenire risucchiati.
E dunque che direzione dovrebbe prendere quest’Europa?
Io sono convinta però che la strada sia quella di creare macroregioni in cuiricostruire un meccanismo di controllo politico sull’Unione, il cui malemaggiore è che lascia le decisioni fondamentali agli accordi tra capitaleprivato e multinazionali, mentre gli stati sovrani si occupano solo di regolamentiapplicativi.
C’è un problema di democrazia, quindi.
Certo, e la Gran Bretagna ne è stata esempio. Lì abbiamo assistito a un votoantiestablishment e l’errore di chi governa è stato fare un referendum su untema assolutamente complesso, su cui si sono scaricate l’emotività e la nonconoscenza. La democrazia, però, non è questo: la democrazia deve essere colta,una struttura che nutre le articolazioni sociali e collettive e che dà aicittadini gli strumenti per capire che cosa sta votando.
Potrebbe essere questo il ruolo della sinistra europea, di cui da anni siparla come cuore di una futura forza riformista?
Willy Brandt diceva che il Partito socialista europeo è il miglior posto doveandare a leggere i giornali dei propri paesi. In pratica non conta nulla,perché è una formazione puramente formale. La vera responsabilità dellasinistra, però, è un’altra: non aver mai lavorato per una vera costruzione diun demos europeo. Per incidere sulle decisioni, infatti, sarebbe statonecessario costituire un soggetto politico-sociale, un’opinione pubblica chevalicasse i confini nazionali dei singoli stati.
 «Nella città che esattamente un anno fa chiuse la stazione ferroviaria di Keleti per chiudere ai profughi di guerra le porte della fortezza Europa, si è discusso anche di migrazione denunciando i respingimenti». Il manifesto, 22 settembre 2016 (c.m.c.)
«Nella città che esattamente un anno fa chiuse la stazione ferroviaria di Keleti per chiudere ai profughi di guerra le porte della fortezza Europa, si è discusso anche di migrazione denunciando i respingimenti». Il manifesto, 22 settembre 2016 (c.m.c.)







 Se c’è uno spazio politico nel quale la sinistra può ritrovare la sua ragion d’essere è quello europeo. È lì che la politica può incidere sui grandi nodi strutturali del nostro tempo (disoccupazione, immigrazione, mobilità sociale, sfide ambientali e climatiche, terrorismo ecc.) e offrire proposte e visioni alternative».
Se c’è uno spazio politico nel quale la sinistra può ritrovare la sua ragion d’essere è quello europeo. È lì che la politica può incidere sui grandi nodi strutturali del nostro tempo (disoccupazione, immigrazione, mobilità sociale, sfide ambientali e climatiche, terrorismo ecc.) e offrire proposte e visioni alternative».