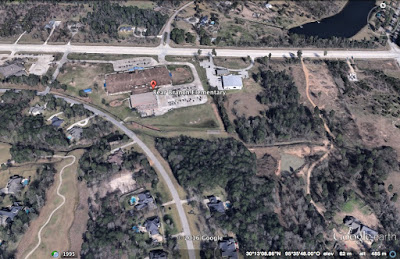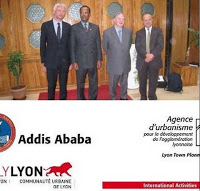«Città&campagna. Si aprirà il 20, al Lingotto di Torino, il 53/mo Congresso mondiale dell’International Federation of Landscape Architects. Un'intervista con Anna Letizia Monti, alla guida dell'Associazione italiana di settore».
«Città&campagna. Si aprirà il 20, al Lingotto di Torino, il 53/mo Congresso mondiale dell’International Federation of Landscape Architects. Un'intervista con Anna Letizia Monti, alla guida dell'Associazione italiana di settore». Il manifesto
, 16 aprile 2016 (c.m.c.)
Nella dichiarazione programmatica del 53/mo Congresso mondiale dell’International Federation of Landscape Architects, organizzato dall’Associazione italiana di architettura del paesaggio, la presidente Anna Letizia Monti si dice certa che «anche a livello nazionale i politici, gli amministratori, l’opinione pubblica stiano finalmente riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante per la qualità della vita delle popolazioni». Le abbiamo rivolto qualche domanda nei giorni che precedono l’arrivo a Torino di oltre mille specialisti del settore.
Il paesaggio è spesso considerato soltanto come qualcosa da ammirare e tutelare. L’incontro torinese pone l’accento su un progetto che lo collochi operativamente al centro delle attività di crescita e sviluppo del paese. Come si conciliano questi diversi punti di vista?
Non è più il tempo di pensare al paesaggio come elemento iconico e celebrativo. È una realtà dinamica, che si evolve, muta e si trasforma. È parte integrante della vita quotidiana dei paesi e delle popolazioni e partecipa con essi al mutare delle necessità, ai nuovi usi. Il paesaggio si fruisce in molteplici modi e funzioni, si può declinare come spazio urbano e periurbano per favorire rapporti e relazioni; area cittadina e rurale con impianti arborei finalizzati alle attività ricreative e al miglioramento della qualità dell’aria; sito denso di stratificazioni e destinazioni passate che si rinnovano per produzioni alimentari di contiguità o per poetiche partecipative. L’Italia è in ritardo su molti di questi temi, ma è giunto il tempo di (re)agire. Il Congresso ha anche questo obiettivo: evidenziare le necessità, risvegliare gli animi, suggerire soluzioni per poter avviare coscientemente e sistematicamente realizzazioni paesaggistiche che siano parte integrante delle politiche di questo paese che – purtroppo – è in ritardo di decenni sulla realizzazione di normali progetti di paesaggio, reali e possibili.
In questo tipo di consessi c’è spesso il rischio di parlare a se stessi invece di assumersi il rischio di dettare, quasi imporre al dibattito, alcuni temi forti. Quali sono le ragioni della scelta di un titolo come «Tasting the Landscape»?
Si è scelto di indagare gli ambiti del progetto di paesaggio a tutto tondo: la risignificazione sensibile dei luoghi, le criticità delle aree marginali, le coltivazioni di prossimità, i paesaggi stratificati, le poetiche del vivere quotidiano. A Torino si ragiona sui «paesaggi condivisi»: le aree fra città e campagna, residenza e coltivazione agricola, produzione industriale e abbandono. Sono paesaggi che possono e devono creare legami e riconsegnare valore a luoghi, persone, idee e produzioni; sono le aree per l’agricoltura urbana, sono i periurbani non più in attesa di essere urbanizzati ma che risorgono a vita nuova.
Ci confrontiamo sui «paesaggi connessi»: quelle infrastrutture verdi e blu, che servono per creare connessioni, unioni, continuità fra territori e persone contigue. Territori in cui coesistono produzioni e attività sportive, resilienza e turismi. Si affronta poi il tema dei «paesaggi stratificati»: il dialogo delle storie e le mutazioni dei siti. Quelli in cui passato e presente hanno codici di relazione precari e per i quali il paesaggista deve individuare semantiche per la complementarietà e la coesione. Si studiano infine i «paesaggi d’ispirazione»: aree dove si concretizza una risignificazione dell’esistente o si declinano nuove poetiche per il vivere.
Vista la pluralità degli interventi e dei progetti che verranno presentati, può descrivere alcuni casi concreti dai quali vi attendete suggestioni, soluzioni tendenze per il futuro?
I lavori vedranno l’intervento di figure di primo piano del dibattito internazionale come Raffaele Milani, docente di estetica e filosofia del paesaggio; Henri Bava, paesaggista francese che ha all’attivo numerosi piani di riqualificazione di paesaggi degradati; Saskia Sassen sociologa ed economista statunitense che indaga da anni il tema della città globale. La novità, se tale la vogliamo considerare, è che non sono ormai soltanto i paesi europei e gli Stati Uniti ad avere politiche e consuetudini attuative per il progetto di paesaggio. A Torino verrà presentato un «programma» di mille ettari di agricoltura urbana a Pechino, ci saranno contributi dell’università di Teheran, piani di valorizzazione dei paesaggi turchi nell’entroterra di Mersin, piuttosto che del sud ovest della Nigeria: è lampante la sensibilità e la determinazione di molti paesi a realizzare politiche paesaggistiche cogenti, con finalità strettamente economiche e/o turistiche o per fare proprie le suggestioni e gli stimoli che provengono dai cittadini.
Qual è in Italia lo stato dell’arte e il destino attuativo del progetto di paesaggio? Si può rilevare l’attenzione delle istituzioni e dei rappresentanti del potere politico?
Esempi virtuosi ci sono in tutto il territorio nazionale. Ma non fanno sistema. Non ci sono politiche stringenti e iter procedurali semplici per proporre e realizzare progetti di paesaggio. Si parla molto, ma sempre in maniera generica. Non si realizzano cose elementari, come la detraibilità fiscale per le opere a verde: un sistema adottato per caldaie, infissi, acquisto dei mobili e che non è riuscito a rientrare nella legge di stabilità di quest’anno, nonostante la mobilitazione coesa di tutta la filiera di settore: vivaisti, progettisti, aziende di opere a verde.
I politici di ogni schieramento discettano di paesaggio, ecologia, sostenibilità, promozione turistica del patrimonio paesaggistico, ma le azioni si limitano a pianificare e al «racconto», senza passare alla realizzazione. I progetti di paesaggio implicano investimenti di denaro esigui, a volta addirittura minimali rispetto alla maggior parte delle opere pubbliche. Occorre poco per fare molto: si investe in idee, alberi, arbusti, semi e terra e si ottengono ossigeno, benessere, turismo e presidio del territorio. È una situazione quantomeno paradossale che non si riescano a realizzare opere che hanno queste caratteristiche ma forse è proprio per i tempi lunghi che la natura richiede (che sono più lunghi di un mandato elettorale) e la minimalità economica di queste opere che a nessuno interessa sviluppare e promuovere un settore che – evidentemente – ha budget troppo esigui per essere interessanti, soprattutto per coloro che mirano a far girare molti denari. È un’affermazione grave la mia, ma Aiapp non ha paura a gridare che, in Italia, da troppi anni il re è nudo.
Si parla di un documento conclusivo di sintesi che va in direzione di una complessiva maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti protagonisti? Può anticipare i suoi termini?
Il manifesto focalizza in pochi punti le questioni salienti: qualità dei paesaggi e qualità progettuale, necessità di politiche di governo del paesaggio cogenti, formazione adeguata a tutti i livelli: dall’università, all’aggiornamento professionale a tutte le scale, dai tecnici delle amministrazioni pubbliche ai liberi professionisti, dall’operatore al dirigente.

(continua la lettura)
Una delle ragioni addotte dai sostenitori del no al prossimo referendum del 17 aprile è quella nobile della difesa dei posti di lavoro. Costoro danno a intendere che, in caso di vittoria del si, verrebbe aperta una pratica di licenziamenti di massa, destinata a gettare sul lastrico migliaia di famiglie. Ora, a parte i reali esiti referendari, mirati a porre un termine definito allo sfruttamento dei nostri mari, e non certo a mettere in atto le regole di libertà di licenziamento introdotte dal governo Renzi con il Jobs act...
Occorre entrare nel merito dell'obiezione, sia in termini specifici che generali. Già su questo giornale [il manifesto -ndr] il 10 aprile, Davide Bubbico - che non scrive per sentito dire, avendo dedicato al tema un ponderoso volume, L'economia del petrolio e il lavoro, Ediesse 2016) ha messo in evidenza come l'industria degli idrocarburi sia una tipica economia capital intensive, caratterizzata cioé da grandi investimenti in capitale fisso (macchinari e strutture ), ma con ridotte ricadute sull'occupazione. Dopo decenni di sfruttamento dei territori della Basilicata oggi si possono contare poche migliaia di occupati, comprese le figure dell'indotto. Naturalmente non si vogliono sottovalutare neppure questi esiti ridotti sull'economia della regione, che andrebbero tuttavia comparati con l'ampiezza dei territori occupati dall'ENI, con le risorse locali consumate, con il vasto impatto ambientale e con gli esiti sulla salute dei cittadini, che si potrà misurare solo nel lungo termine.
Ma quello che appare oggi intollerabile è il motivo della “difesa del posto del lavoro” qualunque sia l'attività produttiva che rende possibile l'occupazione. E questo è un punto su cui occorre soffermarsi. La disoccupazione di massa dei nostri anni, non è solo un dato strutturale del modello di accumulazione capitalistica dominante. E' ormai diventata una pratica di controllo sociale, che produce senso comune diffuso. Agli occhi di una massa crescente di uomini e donne disperati, chi investe in attività produttive appare come un benefattore. Lo sfruttamento del lavoro altrui e i profitti che ne conseguono scompaiono. Allo stesso modo, chi è già occupato non può lamentarsi dei ritmi di lavoro cui è sottoposto, dei turni, degli straordinari necessari per arrotondare, della sua penosa fatica quotidiana. Deve considerarsi fortunato, perché è al sicuro, mentre fuori dalla sua fabbrica o dal suo ufficio infuria la tempesta.
Ma la scarsità di lavoro, diventata una convenienza strategica per il capitale, non è solo una immensa fonte di nuova legittimazione del suo dominio, è anche l'origine di un progressivo arretramento della nostra civiltà. Siamo al punto che ormai esaltiamo senza nessun pudore i nostri successi industriali anche quando sono finalizzati alla guerra, a portare morte e distruzioni presso altri popoli. Finmeccannica firma un maxicontratto per la fornitura di 28 Eurofighter Typhoon al Kuwait, titolava trionfante Il Sole 24 ore il 4 aprile e ripetevano con pari giubilo gli altri grandi quotidiani nazionali. Ma l'inglese dei termini usati non può cambiare la natura criminale dei prodotti. Fighter significa combattente, e quell'euro che lo precede serve solo a camuffare e nobilitare il termine, quasi si trattasse di un computer di nuova generazione, mentre è invece un aereo, un areo Typhoon, cioé uragano, che genera una tempesta di morte. Plaudiamo a Finmeccanica che crea occupazione costruendo aerei da combattimento, destinati ad alimentare le guerre che infuriano in Medio Oriente?
Certo, lo sfruttamento del mare non è paragonabile all'industria degli armamenti. Sono due cose molto distanti tra loro. In un caso – ma solo quale esito indiretto o incidentale – si uccidono pesci e si distrugge l'habitat marino, e per lo meno si produce petrolio, nell'altro si producono armi per uccidere espressamente uomini e donne. Ma chi difende le ragioni del no a tutela dei posti di lavoro deve essere portato a riflettere su un altro aspetto. La convenienza a sfruttare le vecchie economie comporta un rallentamento degli investimenti nelle nuove. E questo è storicamente provato.Quando nel 1972, il Club di Roma pubblicò il Rapporto sui limiti dello sviluppo, circolato poi in piena crisi petrolifera, si aprì una vasta discussione sulla ricerca di energie alternative. Un dibattito destinato ben presto a esaurirsi quando si scopri che di petrolio ce n' era ancora tanto, nella pancia della Terra, insieme a veri e propri oceani di gas. E per i decenni successivi gli investimenti di ricerca, nel solare e nell'eolico, divennero diletti per hobbisti solitari.Quanti investimenti e ci ha fatto perdere lo sfuttamento degli idrocarburi? Quanto gas serra avremmo potuto risparmiare al nostro clima?
Ma c'è un'altra ragione ancora più importante da considerare. Già in passato nel nostro paese è stato commesso un grave errore di strategia industriale. Quando, tramite gli investimenti della Cassa per il Mezzogiorno, si occuparono tanti siti costieri del nostro Sud, da Brindisi fino a Priolo, venne adottata una politica non dissimile da quella dell'ENI in Basilicata. Grandi strutture industriali calate dall'alto, che non generarono nuove economie, non stimolarono una ulteriore crescita del territorio, perché estranee ad esso, alla sua storia, alle sue vocazioni, ai saperi delle genti che lo abitano. Anche allora territori di altissima qualità (mica i deserti dell'Arabia Saudita) furono letteralmente “svenduti” all'industria, in gran parte pubblica. Si trattava e si tratta di industrie che potremmo definire nature intensive, che consumano risorse naturali (immense quantità d'acqua) inquinando suoli, strati aerei, fondali marini. Ma almeno allora, nell'errore, quegli interventi erano interni a un progetto generale di sviluppo del nostro Mezzogiorno. Si pensava di generare posti di lavoro investendo in attività industriali che peraltro non si esaurivano nell'insediamento dei petrolchimici. Ma oggi? Dobbiamo continuare a difendere attività residuali? Dobbiamo conservare i pochi posti di lavoro gentilmente concessi dalla Total e da Shell, senza badare alla nostra industria turistica, alla vita dei nostri mari, al riscaldamento climatico che incombe, alimentato in misura così rilevante dal consumo di petrolio?
Questo articolo è inviato contemporaneamente al manifesto

. O più esattamente perché non lo state accompagnando a scuola secondo i criteri didattico-pedagogici prescritti dalla massima autorità locale in materia, che prevedono una modalità sola: Pierino deve rigorosamente scendere dal sedile della vostra auto davanti al cancello, non arrivarci a piedi. Così stabilisce una delibera della Bear Branch Elementary School di Magnolia, nell'area metropolitana di Houston, in vigore da quest'anno scolastico e recepita in quanto tale dall'ufficio dello sceriffo della Montgomery County, pronto a intervenire nella spietata repressione dei trasgressori.
Secondo le dichiarazioni di alcuni infuriati genitori residenti piuttosto vicino alla scuola, e che hanno ritirato i figli iscrivendoli ad altri istituti, la dirigente che ha scritto quella delibera «evidentemente è convinta che noi non si sia in grado di comprendere e decidere cosa è o meno sicuro per i ragazzi, e che spetta all'amministrazione scolastica stabilirlo». Tornano in mente le sequenze iniziali di First Blood, l'episodio che inaugura la fortunata serie di Rambo, in cui il reduce dalla guerra in Vietnam cammina sul ciglio della strada tallonato dallo sceriffo, che senza mai scendere dall'auto gli spiega che così lui è fuori posto, fuori contesto, in pratica fuori legge anche senza aver fatto nulla. Deve essere qualcosa di simile ad aver ispirato la delibera della dirigente scolastica, di cui ovviamente non possiamo conoscere gli orientamenti politici e culturali, mentre invece in fondo capiamo benissimo e chiaramente il contesto spaziale, sociale, comportamentale e di immaginario.
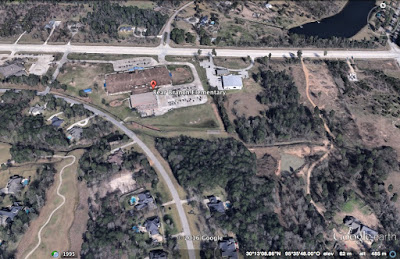
C'è il suburbio disperso senza centro, dove tutto ruota attorno a pochissimi luoghi di riferimento diversi dalle abitazioni private, in genere connessi in rete esclusivamente dalla grande viabilità stradale, spesso senza neppure il complemento di una viabilità minore storica a sezioni ridotte e con qualche orientamento residuo vagamente pedonale o ciclabile (cosa che avviene invece là dove l'espansione delle nuove residenze si appoggia a qualche nucleo pre-automobilistico di massa). Dentro quel sistema composto di baccelli a fondo cieco, è piuttosto raro e fortuito che esista qualche tipo di accessibilità pedonale diretta e sicura dalla residenza a un'attività diversa, commerciale o di servizio, perché tutta l'organizzazione urbanistica non prevede affatto che ce ne sia la necessità o l'opportunità. Sezione delle carreggiate, separazioni rigide di corsie, arretramenti degli edifici e distinzioni di livello, tutto converge nell'imporre l'uso di un'auto, o di qualche autobus navetta dove ce ne sono disponibili, per ogni spostamento diverso da quelli strettamente interni. Unico interfaccia pedoni-veicoli resta il parcheggio, in forma di piazzale, silo, corsia per la sosta temporanea davanti a un ingresso.
Nessuna sorpresa, se questo modo di spostarsi, addirittura questo modo di concepire e vivere lo spazio, sia stato considerato dalla dirigente scolastica l'unico socialmente accettabile e garantito sicuro per raggiungere la sua scuola. Convinzione rafforzata dalla disponibilità dell'ufficio dello sceriffo di contea a reprimere i trasgressori di quello che, alla fin fine, altro non è che un codice della strada diventato regola di convivenza e organizzazione della vita quotidiana. Basta un'occhiata a volo d'uccello da Google Earth, alla Bear Branch Elementary School di Magnolia, a confermare quanto banale e routinaria possa essere sembrata alla preside signora Ray quella delibera sulla sicurezza dell'accesso alunni all'edificio. Pochissime – vista l'organizzazione a bassissima densità e a abitazioni unifamiliari - le case a distanza pedonale dal complesso, pare ovvio che tutto il traffico in entrata e uscita debba per forza passare dall'arteria principale su cui si affaccia l'ingresso al parcheggio (l'edificio vero e proprio è, da manuale, molto arretrato). I genitori che, vuoi per motivi molto pratici, vuoi per scelte specifiche di comportamento o ambientali, pretendevano di far camminare fin lì i figli, in fondo sono dei rompiscatole stravaganti, che mettono a rischio l'ordine costituito. Difficile, da questo punto di vista, dar torto alla signora Ray. A meno, naturalmente, di dar torto a mezzo secolo abbondante di norme, regole, culture, che hanno prodotto quell'universo claustrofobico. E che in tutto il mondo le amministrazioni locali spesso fanno di tutto per scimmiottare.
La notizia sul sito Fox 26 Houston

nel nostro Paese. Un conflitto per così dire fondativo ha contrapposto il lavoro alla natura... (continua la lettura)
nel nostro Paese. Un conflitto per così dire fondativo ha contrapposto il lavoro alla natura, l'umana operosità alle ragioni del mondo vivente, il movimento operaio agli equilibri degli habitat naturali. E per ragioni che hanno a che fare innanzi tutto con la dottrina. A partire da Marx. E' vero, egli dichiara, sin dal Primo libro del Capitale: «Il lavoro è prima di tutto un processo fra uomo e natura, un processo nel quale l'uomo, attraverso la propria attività procura, regola e controlla il suo scambio materiale con la natura». Scambio materiale o organico, il famoso Stoffwechsel. Un riconoscimento importante del ruolo della natura, nella produzione della ricchezza. Ma tale visione rimane confinata sullo sfondo, perché nel pensiero di Marx ha poi il sopravvento la teoria del valore-lavoro. È la scoperta di Adam Smith ( peraltro non del tutto sua) secondo cui il lavoro è la fonte di ogni valore:«l'originaria moneta d'acquisto con cui si pagano tutte le cose», come scrive nella Inquiry sulla ricchezza delle nazioni. A cui Marx aggiungerà il disvelamento rivoluzionario della creazione del plusvalore, l'origine dell'accumulazione della ricchezza in poche mani, fondata sullo sfruttamento operaio, e la riproduzione del capitalismo e della società divisa in classi.
Ma questa scoperta, che orienterà le lotte di tutti i movimenti di ispirazione marxista, e del movimento operaio in generale, dimenticherà le ragioni della natura. La centralità del lavoro e dei suoi interessi prevarranno su quelle del mondo vivente in cui questo pur si svolge.Non voglio ridurre il pensiero di Marx, capace ancora oggi di illuminarci, al marxismo. Questo è ovvio, le dottrine finiscono colo vivere di vita propria. Ma è importante osservare che tale curvatura così esclusivamente antropocentrica del marxismo diventerà ancora più rigida e dottrinaria nella sua trasmigrazione nella Russia preindustriale della Rivoluzione bolscevica. Esso diventerà, inevitabilmente una “teoria dello sviluppo industriale” dal punto di vista operaio. Non per niente Lenin poté definire il comunismo come « l potere sovietico più l'elettrificazione di tutto il paese.« Che cosa poteva importare del territorio, delle foreste, delle acque dei fiumi, dei grandi laghi della Russia di fronte alla necessità di costruire una nuova società attraverso l'espansione dell'industria? L'uomo nuovo sovietico era un lavoratore-titano che plasmava a sua immagine il mondo intorno a sé. Non ci dovremmo perciò stupire se in Unione Sovietica – come ha ricordato lo storico John MacNeil – nella seconda metà del '900 furono utilizzate piccole bombe atomiche per sventrare montagne ed aprire miniere. In Cina da decenni vanno costruendo il comunismo provocando catastrofi ambientali.
Neppure miglior fortuna ha avuto il mondo naturale nel pensiero rivoluzionario italiano.Nel nostro teorico più grande, Gramsci, non c'è posto per le sorti della natura. Anche in lui il processo storico è pensato secondo la curvatura dello sviluppo industriale, leva dell'umana emancipazione. In uno dei suoi Quaderni più anticipatori, Americanismo e fordismo, di fronte all'organizzazione tayloristica del lavoro Gramsci ha uno sguardo di sconcertante provvidenzialità teleologica. «La storia dell'industrialismo - scrive - è sempre stata ( e lo diventa oggi in una forma più accentuata e rigorosa) una continua lotta contro l'elemento “animalità” dell'uomo, un progresso ininterrotto, spesso doloroso e sanguinoso, di soggiogamento degli istinti ( naturali, cioé animaleschi e primitivi ) a sempre nuove, più complesse e rigide norme e abitudini di ordine, di esattezza, di precisione che rendano possibili le forme sempre più complesse di vita collettiva che sono la conseguenza necessaria dello sviluppo dell'industrialismo».
D'altra parte l'Italia, Penisola di antichissima antropizzazione non ha una tradizione culturale favorevole allo sviluppo di una narrazione naturistica dell'umana vicenda. Dominata da mille città, che hanno assoggettato per millenni i loro contadi, non poteva certo generare élites sensibili ai problemi degli equilibri degli habitat, se non per fini di sfruttamento economico. Come è accaduto con le bonifiche. L'avvento delle società industriali - la fase storica a partire dalla quale è legittimo e non anacronistico aspettarsi sensibilità ambientale - non produce in Italia le reazioni protoambientalistiche che si verificano ad es. negli USA. Qui nell' 800 sterminati lembi di wilderness, di natura incontaminata apparvero minacciati dallo sviluppo industriale. In Germania i piccoli villaggi circondati da boschi – modello prevalente degli insediamenti umani in quel paese– furono sconvolti in pochi decenni alla fine dell' 800, generando una vasta opposizione destinata a grande influenza sul pensiero politico ed ecologico tedesco. E non meno cura per il mondo naturale creò, per contrasto, la rivoluzione industriale nelle élites inglesi, a partire da quel secolo. Niente di tutto questo in Italia, che arriva tardi all'industrializzazione Uno sviluppo concentrato peraltro, nel Triangolo Milano-Torino-Genova, in gran parte manifatturiero e perciò di limitato impatto ambientale. Si comprende allora come sia potuto accadere che nel corso del '900 è sorto accanto al fragile gioiello di Venezia, il Petrolchimico di Porto Marghera; in uno dei siti più incantevoli del Belpaese , a Bagnoli, l'Italsider, e poi l'Ilva nei due mari di Taranto, i vari stabilimenti petrolchimici a Brindisi, Gela, Priolo, ecc. cioé in località marittime con habitat delicati e ad alta vocazione turistica. E non stupisce, peraltro, che in un paese afflitto da disoccupazione endemica, le posizioni ambientaliste siano state minoritarie nel PCI e nel sindacato.
Solo dopo Cernobyl, non solo il ceto politico, ma anche gli italiani scoprono la fragilità della natura in quanto minacciata dall'inquinamento. E solo negli ultimi decenni, l'ambientalismo è diventato di massa (con le lotte contro gli inceneritori, le discariche, le centrali a carbone, ecc) allorché le popolazioni hanno scoperto, tramite i danni prodotti dall'inquinamento alla salute, quella natura insuperabile che è in ognuno di noi. La natura è stata scoperta nel corpo vulnerabile degli uomini. E' stata la malattia a mandare gambe all'aria il vecchio storicismo antropocentirico. Grandi masse di cittadini hanno scoperto che la storia ha cambiato il suo corso e la crescita economica non genera di per sé benessere e progresso. Il nuovo ambientalismo italiano oggi parla un linguaggio che non è più “sviluppista”, scopre il valore storico dei territori, della natura antropizzata e trasformata in paesaggio e bellezza, e il ceto politico stenta a comprenderlo.

(continua la lettura)
Alcune settimane fa è morto a Gerusalemme, all’età di 98 anni, Harry Tabor, al cui instancabile lavoro, negli ultimi settanta anni, si devono i principali progressi nell’utilizzazione dell’energia solare. Tabor era nato a Londra nel 1917 e, dopo la laurea in ingegneria, nel 1947 fu impegnato nel lavoro di trasformazione delle navi mercantili, residuati bellici, in navi passeggeri per l’immigrazione clandestina degli Ebrei in Palestina (un episodio del genere è raccontato nel film Exodus del 1960, con Paul Newman). Conoscendo le sue capacità, Ben-Gurion, il primo ministro del nuovo stato di Israele, nato nel 1948, lo chiamò in Israele per creare e dirigere l’Istituto Nazionale di Fisica che, sul modello di quello britannico, affiancò il governo per le informazioni di carattere tecnico-scientifico. Scarsità di acqua e di energia erano i fattori limitanti dello sviluppo del nuovo stato e il Sole poteva contribuire a soddisfare queste due necessità.
La prima impresa di Tabor fu la progettazione di scaldacqua solari: una lamiera sulla quale sono saldate delle serpentine è coperta da una lastra di vetro e poggia su uno strato di materiale isolante che evita la dispersione del calore. L’acqua fredda entra dal basso e si scalda passando nelle serpentine del pannello esposto al Sole; l’acqua calda sale spontaneamente, senza bisogno di motori, in un serbatoio isolato da cui viene prelevata ed entra nella casa. Gli scaldacqua solari erano stati inventati molti decenni prima, ma Tabor ne aumentò l’efficienza usando lastre metalliche da lui studiate, rese “selettive” con uno speciale trattamento di cromatura che ne faceva aumentare la capacità di assorbire la radiazione solare rendendo minime le perdite di calore. Il successo commerciale degli scaldacqua solari, oggi diffusissimi in Israele, è stato possibile perché possono essere venduti soltanto se rispettavano certi standard di qualità, proposti proprio da Tabor, che ne assicurano la durata e l’efficacia. Lo scarso successo degli scaldacqua solari in Italia è stato in gran parte dovuto proprio alla mancanza di una standardizzazione e di controlli di qualità.
Il secondo passo del lavoro di Tabor fu dedicato alla progettazione di un motore, funzionante con un ciclo termico inventato dall’ingegnere scozzese William Rankine (1820-1870), basato sull’evaporazione e la condensazione di un fluido organico come la benzina, scaldato a temperatura abbastanza bassa, come quella ottenibile nei pannelli solari. Il primo motore solare, costruito in collaborazione con Lucien Bronicki, fu presentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sulle nuove fonti di fonti di energia che si tenne a Roma nel 1961. La radiazione solare era raccolta da un ingegnoso pannello contenuto in un tubo trasparente di plastica gonfiabile. Bronicki creò in Israele una società Ormat per la costruzione di motori Rankine che sono venduti in tutto il mondo per lo sfruttamento di fonti di calore a bassa temperatura come quelle geotermiche o quelle che si creano negli “stagni solari”.
Gli stagni solari, inventati anch’essi da Tabor, consistono in vasche profonde pochi metri, contenenti acqua dolce, sul cui fondo viene creato un sottile strato di acqua ad alta concentrazione salina. La radiazione solare attraversa l’acqua superficiale e scalda l’acqua salina sul fondo; questa non si miscela con quella sovrastante e si comporta come un vero e proprio semplicissimo collettore di calore raggiungendo temperature di alcune diecine di gradi, sufficienti per azionare un motore e produrre elettricità. Gli “stagni solari” attrassero grande curiosità e attenzione; uno di questi fu costruito nella saline di Margherita di Savoia negli anni ottanta del Novecento, ma fu poi abbandonato dopo un paio di anni; gli stagni solari in Israele funzionano ancora oggi.
Il lavoro di Tabor nel campo solare fu sempre rivolto alla ricerca di soluzioni semplici per i bisogni di paesi emergenti, al servizio delle necessità umane. In questa direzione si possono ricordare i progetti di fornelli per la cottura di alimenti con il calore solare concentrato da piccoli semplici specchi fatti con pezzi di lamiera e i distillatori per trasformare, col calore solare, l’acqua di mare in acqua potabile. Semplici soluzioni furono progettate per il funzionamento di frigoriferi solari “da villaggio” e per la progettazione di case raffreddate e ventilate senza bisogno di macchine. Tabor propose perfezionamenti delle celle fotovoltaiche e studiò la teoria dei concentratori a specchi stazionari, che non hanno bisogno di essere continuamente orientati verso il Sole.
Ciascuna iniziativa stimolava imprese commerciali e creava occupazione. A un intervistatore che gli chiedeva quali cose “non avesse fatto”, Tabor rispose: “i soldi”. Viveva infatti in una modesta casa di Gerusalemme con la moglie Vivienne che aveva sposato nel 1947. Una risposta su cui riflettere in questo momento in cui sembra che il fine delle energie rinnovabili in Italia sia soltanto quello di “fare soldi” per i costruttori, i venditori e anche per gli acquirenti.
Nel suo impegno civile Tabor fu determinante per la istituzione del centro di ricerche solari presso l’Università Ben-Gurion di Bersheba nel deserto del Negev. Le principali pubblicazioni di Harry Tabor sono state raccolte in un libro pubblicato, in occasione del suo ottantesimo compleanno, dalla International Solar Energy Society di Friburgo, in Germania; ne raccomando la lettura soprattutto a chi cerca stimoli per le molte altre cose che il Sole può fare per il progresso umano.
L'articolo è inviato contemporaneamente a La Gazzetta del Mezzogiorno

(continua la lettura)
Il 23 marzo di ogni anno si celebra la giornata mondiale dell’acqua per ricordare l’importanza di questa sostanza, che è risorsa naturale, alimento, mezzo di produzione, e da cui tutto dipende. Non a caso è la ventunesima parola che figura nel primo libro della Bibbia, quello della creazione di tutte le cose. L’acqua occorre per togliere la sete a uomini e animali, per fare crescere le piante; per gli esseri umani, poi, l’acqua, visibile ed invisibile, è presente dovunque, è indispensabile per fini igienici, è necessaria per il funzionamento delle fabbriche e delle centrali elettriche e delle raffinerie di petrolio, eccetera.
La giornata dell’acqua è anche un’occasione per conoscere meglio il ciclo di una sostanza che non sta mai ferma: evapora dai mari, ricade al suolo sotto forma di neve e di pioggia, passa attraverso i campi, le città, le valli. Sulla superficie dell’Italia cadono ogni anno circa 250 miliardi di metri cubi di acqua; circa il 60 percento di questa evapora dalla superficie e dalla vegetazione e circa 120 miliardi di metri cubi di acqua ogni anno scorrono, instancabili, nei fossi, torrenti, fiumi e tornano al mare dopo aver raccolto sali e rocce del terreno e rifiuti, incontrati nel loro cammino. Ogni anno in Italia circa 20 miliardi di metri cubi di acqua sono prelevati dalle sorgenti, dal sottosuolo o dai fiumi per irrigare i campi, circa 5 per usi industriali e circa 10 per il rifornimento delle famiglie, ma di questi ultimi soltanto poco più di 5 miliardi di metri cubi all’anno arrivano nelle nostre abitazioni, venduti da circa 3000 aziende; una perdita altissima di acqua e troppi gestori che non riescono ad assicurare una distribuzione adeguata. Prima di arrivare nel nostro rubinetto l'acqua viene analizzata e subisce vari trattamenti, imposti da severe norme europee che prescrivono, a fini igienici, quali sostanze possono essere presenti nell'acqua potabile e quali sono rigorosamente vietate.
Quale uso fa ciascuno di noi di questi cinquemila milioni di metri cubi di preziosa acqua potabile ? La beviamo, prima di tutto, in ragione di circa un metro cubo all’anno per persona, circa 60 milioni di metri cubi all’anno. Una accorta propaganda ha diffuso l'idea che l'acqua del rubinetto “non è buona" e che è meglio bere l’acqua in bottiglia, per la maggior gloria di quelli che la vendono, assicurandosi alti profitti. “Grazie” a questo incantamento gli italiani consumano ogni anno 12 milioni di metri cubi di acqua in bottiglia che costano alle famiglie circa tre miliardi di euro all’anno; così va questo mondo. L'acqua del rubinetto viene impiegata per cuocere la minestra o gli alimenti (ma conosco dei furbi che cuociono anche la pasta con acqua in bottiglia), e poi viene usata per lavare il corpo, magari solo per una sciacquatina delle mani, per pulire gli utensili di cucina, gli indumenti, per scaricare i rifiuti giù dal gabinetto, per annaffiare strade e terrazze o lavare le automobili. Acqua preziosa, ad elevato grado di purezza, che viene così buttata via, sprecata.
Adesso immaginiamo di fare un viaggio accompagnando i 5000 milioni di metri cubi di acqua usata dalle famiglie, giù dal lavandino o dagli scarichi dei gabinetti. Viaggio sgradevole ma utile perché ci porta a verificare lo stato della fognature - se ci sono - e a conoscere i depuratori. In Italia ce ne sono circa 10.000, ma soltanto la metà di questi depuratori pratica un trattamento appena soddisfacente e soltanto 2000 trattano le acque usate con un processo ”avanzato” che assicura una buona eliminazione delle principali impurità; anche questo mostra l’irrazionalità e la frammentazione di questo delicato sistema, essenziale per la difesa dell’ambiente e della salute. Alla fine del viaggio fra fogne e depuratori troviamo un fango maleodorante e dell'acqua usata che, in genere, viene gettata in qualche fiume o nel mare; eppure molte acque usate, se depurate in maniera efficace, potrebbero essere utilizzate in agricoltura.
La legge dice che tutte le acque, superficiali e sotterranee, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da salvaguardare e utilizzare secondo criteri di solidarietà, anche tenendo conto delle aspettative e dei diritti delle generazioni future. Dopo parole così belle e nobili, la legge consente che delle acque “pubbliche” possano appropriarsi imprese nelle quali sono presenti ingenti capitali privati, che le vendono ai cittadini, secondo criteri di profitto finanziario, per cui l'acqua costa di meno dove è più abbondante e facile da ottenere e costa di più dove è scarsa: bella solidarietà! La legge dice che occorre risparmiare acqua, ma ben poco viene fatto per spiegare ai cittadini che l'acqua è scarsa in assoluto e lo diventerà anche dove oggi apparentemente è abbondante, a causa dei cambiamenti climatici che stanno alterando vistosamente la circolazione dell’acqua sia a livello planetario, sia a livello di singoli paesi.
Eppure i consumi di acqua potrebbero diminuire con una adeguata riprogettazione delle lavatrici, dei rubinetti, dei macchinari industriali, dei gabinetti, in modo da ottenere lo stesso effetto e servizio con meno acqua. Le scuole - è da lì che comincia l’informazione delle persone che saranno destinate a vivere in città assetate - sono la prima frontiera per far conoscere il problema, ma anche il fascino della circolazione e dell’uso dell’acqua, la più indispensabile fonte di benessere della vita individuale e urbana.
L'articolo è inviato contemporaneamente a La Gazzetta del Mezzogiorno
 (continua la lettura)
(continua la lettura)
La perdita
La figurazione e l’ironia di "la paura fa (quasi) 90" come a tombola. Anni però. Guardo o riguardo indietro nel tempo, guardo la consolidata cultura di eddyburg, guardo certe scarse note per il confronto, quella di Fabrizio Bottini reclamante «una seria interdisciplinarietà» nel commento critico al Vittorio Gregotti di Periferie: una rinascita senza ghetti (5 gennaio 2015), e il mio successivo Pensieri indisciplinati e no (9 gennaio 2015). Non possiamo più girare intorno al formaggio come fanno i topi e poi appena tentano un piccolo morso l’arco dentato li acchiappa e gli affonda le punte nella carne. Volevamo il dialogo fra le discipline, il superamento della cieca specializzazione (tipo eccessi della matematica a Oxford per selezionare la razza); volevamo onorare la vecchia battaglia di un Edgar Percy Snow affinché le due culture, l’umanistica e la scientifica, almeno si parlassero[i]; chiedevamo di riconoscere le conquiste a scuola (rare ma rivoluzionarie) nel campo della reciprocità (intra-bisogno) fra le cinque componenti della famiglia architetturale, di confermare e aumentare la capacità dell’urbanistica di introiettare l’essenziale delle scienze umane; soprattutto volevamo l’urbanistica e l’architettura, differenti ma non divergenti nella storia della città e dello spazio aperto, laboriose su cattedre e tavoli vicini, unite e compartecipanti nel fissare e perseguire gli obiettivi del progetto (del piano). Appunto, i topi intrappolati.
L’urbanistica e l’architettura sono entrambe, da una parte, nettamente staccate dalle nostre concezioni e dalle coerenti concrete prove, da un’altra «godono» quanto mai di una separatezza assoluta, un’intolleranza cruda quando gli capitasse di sfiorarsi. I campi recinti, d’altronde, non contemplano la vita. La loro divisione ha contribuito al fallimento della città e del fuori. Non interessa qui discutere la negazione di Franco La Cecla[ii] o l’ottimismo di Stefano Moroni[iii]. È la perdita dell’unità, il rifiuto del retaggio storico (una sola arte, come l’artifex dei latini) la causa dello stato attuale: l’urbanistica esiste come il cavaliere inesistente che esiste ma è un magatello; l’architettura ha surclassato la realtà come non-architettura, quella di autori che, attenti a nient’altro che a se stessi (e, horribile dictu, alla massima resa finanziaria per l’imprenditore) commettono clamorosi falli culturali e professionali pur di realizzare violente testimonianze del proprio protagonismo: cose e cosi sprezzanti i contesti storici e sociali, ostili alla città e alla comunità; forme per lo più astruse, talora contro-statiche in veste di grattacielo; contenuto? irrilevante. Ai cittadini col naso all’aria (non molti, la «classe media» potrebbe agire come l’io narrante in La vita agra di Luciano Bianciardi[iv]) basta meravigliarsi per l’imponenza vetrosa dai riflessi abbaglianti. Quando esistessero per il dato luogo, grazie a strana sopravvivenza della vecchia maniera, chiare definizioni e norme attuative, quei King Kong, succubi alla volontà del domatore padrone, le stritolerebbero, proprio come il gran scimmione stava per fare con la bella ragazza tenuta in una sola mano.
Forse l’ottica che adottiamo è deformata dalla taratura dell’obiettivo sul caso milanese? Come altre vicende in altri momenti[v], il «rito ambrosiano» (Vezio De Lucia), ossia la manipolazione delle regole, ha indicato al paese la melodia e l’armonia del corale che celebra lo sbaraglio dei difensori della legalità e dell’onesta verità storica della nostra cultura. Ne è il compendio assordante, altra volta descritto, la «Nuova Milano» di Garibaldi-Repubblica-Isola, terra straniera giacché è per intero proprietà qatarina: giustamente, vorremmo dire, dal momento che il paesaggio urbano sembra importato pari pari da quello del noto emirato[vi]: orrori, orrori disumani, un marchio mortale che distingue tutti gli emirati della penisola arabica.
La memoria


 |
| L’interno della Borsa di Amsterdam |
 |
| Particolare di Amsterdam Zuid |
Un metodo di progettazione in cui il tutto sia presente nelle parti e le parti nel tutto, un punto di vista univoco circa l’urbanistica e l’architettura: questo ci ha insegnato Hendrik Petrus Berlage, il maestro che tuttavia lega l’obiettivo di costruire la città nuova all’esistenza di un ideale di vita, di una larga cooperazione per obiettivi comuni; ma, infine, anche alla lotta politica contro la potenza del capitalismo. Ad ogni modo il piano per Amsterdam Zuid rappresenta in sé, a quella data, il miglior risultato rispetto alla coerenza dei principi: fedeltà alla storia della città (il demanio della terra, l’esproprio, l’isolato); affermazione e rilancio della socialità (la tradizione cooperativistica); piena applicazione della legge sulle abitazioni del 1901 (regolamentazione promotrice dell’edificazione per blocchi). Il progetto d’insieme fortemente unitario nella successione degli isolati, crea un più alto livello di unità attraverso i fabbricati ai margini e i giardini interni, luogo decisivo dove l’architettura mostra indubitabilmente, se così si può dire, la propria funzione urbanistica unita al riconoscimento dei valori cooperativistici, infatti il numero degli alloggi corrisponde a quello di una cooperativa di media dimensione. La realizzazione avverrà con gli architetti della Scuola di Amsterdam. I De Klerk, i Kramer, le Kropholler… Espressionismo, moderno romanticismo, alcune mirabolanti mostre delle risorse laterizie nell’esclusivo impiego del mattone… L’effetto è di una inflessibile coerenza dell’insieme e dei particolari, in armonia con lo spirito e l’arte del maestro. Conosciamo le critiche di Giedion (che sarà alfiere del razionalismo) al piano: le soluzioni proposte sono ancora legate a certa urbanistica ottocentesca. Ma a noi la «vecchia» Amsterdam Zuid basta ora: come preferiremmo, ora, una «Nuova Milano» tutta berutiana.
Bruno Taut, dopo una visita nel 1929, definì l’addizione meridionale un contributo eccezionale all’architettura moderna: «… è avvenuto il prodigio, la creazione di un’architettura collettiva, dove non è più la singola casa ad essere di particolare importanza, ma le lunghe schiere di case lungo le strade e ancor più l’aggregazione di molte strade in una unità complessa, anche quando in queste strade hanno lavorato architetti diversi».[vii]


 |
| La Hufeisensiedlug della Groβsiedlug Britz |
 |
| Case a schiera con diversificazione della tinteggiatura |
A questo punto sembra pura fortuna (invece è ricerca) poter introdurre la figura di Bruno Taut, da subito scelta insieme a quella di Berlage per far comprendere la superiorità del ricordo, tramite un suo alto apprezzamento dell’opera del maestro olandese. Pochi, forse nessun altro protagonista del Moderno può vantare, come Taut, una tanto ricca dotazione culturale fra idealità filosofica e politica, passione progettuale, capacità realizzativa. L’unità in Berlage fra architettura e urbanistica sovrintesa socialmente dalla cooperazione è naturale obbligazione in Taut. Ma esiste una più complessa relazione fra critica della città esistente e modelli deliberatamente utopici come in Die Stadtkrone e Alpine Architektur, o storico-idealistici come in Die Auflösung der Städte (Kropotkin evidente riferimento). Dobbiamo interpretarli quali potenti metafore della sua visione della società: ossia del rapporto fra società e città-territorio, dell’organizzazione degli spazi e dell’architettura. La definizione di Erdstadt per il progetto urbanistico e la precisazione con Die Erde eine gute Wohnung dicono quanta importanza Taut attribuisse alla terra, alla campagna: che all’interno della nuova città, le Siedlung, significherà anche grandi parchi, giardini, orti intanto che l’eine gute Wohnung realizza magnifiche soluzioni d’insieme urbano e di architettura di case per il popolo studiata a fondo secondo pochi tipi (fu Taut a ritenere che l’uomo trova un facile rapporto immediato con la sua abitazione fino al limite di tre piani. Superatolo comincia il momento dello straniamento che costringe a ricorrere a qualche accorgimento distraente).
Bruno Taut accettò doverosamente importanti compiti in cariche pubbliche per realizzare il suo programma, dimostrando come l’intero presupposto teorico e ideale fosse pronto a precipitare in una grande intrapresa di realtà. Da Stadbaurat a Magdeburgo lavorava da un lato per il progetto e la costruzione di alloggi popolari, dall’altro per il rinnovamento urbano attraverso la tinteggiatura policroma delle facciate attuata da artisti: «Magdeburgo colorata» si dice e si legge. A Berlino, invece, direttore dei programmi residenziali della GEHAG[viii] disegnò il piano di diverse Siedlung, talvolta con Martin Wagner, e progettò come altri noti colleghi (il fratello Max, Ludwing, Scheiderei, Häring, Poelzig…) l’architettura degli edifici. Così prima della crisi per l’avvento di Hitler decine di migliaia di alloggi furono assicurati alle classi lavoratrici. Fra i diversi e bei luoghi, il primato spetta alla Gossiedlung Britz, con la grande corte denominata Hufeisensiedlung (Hufeisen = Ferro di cavallo) altrimenti detta Lowise Reuter-Ring (Ring=Anello).
Note
[i] E. P. Snow, Le due culture, orig. 1959 e 1963, Feltrinelli 1964, Marsilio 2005.
[ii] F. La Cecla, Contro l’urbanistica, Einaudi 2015.
[iii] S. Moroni, Libertà e innovazione nella città sostenibile, Carocci 2015.
[iv] Vedi in eddyburg l’ultimo capoverso di L. Meneghetti, Migrazioni passato e presente. Seconda parte, 10 gennaio 2016, e la relativa nota 7.
[v] Vedi in eddyburg-archivio in data 11 settembre 2006 (quasi dieci anni fa!) L. Meneghetti, Falsificazione dell’architettura e privazione dell’urbanistica, poi in L. M., L’opinione contraria, Libreria CLup, dicembre 2006, p.189-196.
[vi] Vedi in eddyburg L. Meneghetti, Dov’è la bellezza di Milano? 10 gennaio 2016.
[vii] Citazione in M. Casciato (a cura di), La Scuola di Amsterdam, Feltrinelli 1987, p. 23, da B. Taut, Die neue Baukunst in Europa und Amerika, Stutttgart 1929, p. 41.
[viii] Gemeinützige Heimstätten Aktien Geselschaft = Società anonima per residenze di pubblica utilità.
Una primavera, quella di trent’anni fa, segnata da un gran numero di guai che, se non altro, servirono, se così si può dire, a migliorare le leggi e i controlli sulla salute e sull’ambiente. L’anno era cominciato con la pubblicazione dell’elenco delle industrie “a rischio” di incidenti; una direttiva della Comunità Europea aveva stabilito che tutti i paesi membri avrebbero dovuto fare un inventario delle industrie in cui avrebbero potuto verificarsi incidenti rilevanti, come quelli di Meda/Seveso in Lombardia, di Manfredonia in Puglia, di Bhopal in India.
Erano definite “a rischio” le fabbriche che al loro interno contenevano sostanze tossiche o esplosive in quantità superiori a certi limiti; un primo elenco delle industrie a rischio italiane fu redatto all’inizio di quel 1986 e, benché il governo lo avesse tenuto segreto, divenne presto pubblico e mostrò che l’Italia era piena di fabbriche pericolose di cui le popolazioni non sapevano niente. Cominciò allora una battaglia perché le autorità sanitarie e ambientali (era stato da poco istituito il primo ministero dell’ambiente) provvedessero a imporre procedure e controlli per una maggiore sicurezza e informazione dei lavoratori e degli abitanti del territorio circostante.
Nel marzo dello stesso anno fu scoperta una frode del vino che costò la vita a molte persone. Nel vino, come tutti sanno, è presente, in concentrazione fra 8 e 15 percento, alcol etilico che si forma dagli zuccheri dell’uva durante la fermentazione, quel delicato processo che assicura la qualità del vino il cui prezzo dipende, fra l’altro, proprio dalla quantità di alcol presente. Una delle frodi consisteva nel sottoporre a fermentazione uve scadenti aumentando artificialmente la gradazione alcolica o per aggiunta di zucchero al mosto o per aggiunta di alcol etilico.
Nel passato era stata anche praticata la frode di aggiungere al vino alcol metilico sintetico, una sostanza simile all’alcol etilico, ma tossica, e il cui prezzo era inferiore a quello dell’alcol etilico; per evitare questa frode, sull’alcol metilico era applicata una imposta che ne faceva aumentare il prezzo. Per qualche motivo tale imposta era stata annullata nel 1984 e un produttore di vino pensò di approfittarne facendo aumentare fraudolentemente la gradazione alcolico del suo vino con l’aggiunta del velenoso alcol metilico. Alcuni consumatori morirono, altri divennero ciechi. La frode ebbe grande effetto sull’opinione pubblica che si rese conto delle sofisticazioni a cui era esposta e pretese nuove più severe leggi e più diffusi controlli merceologici.
Proprio negli stessi giorni fu scoperto un diffuso inquinamento delle acque sotterranee che finiva per interessare anche l’acqua potabile distribuita dagli acquedotti. In varie città dell’Italia settentrionale i laboratori di analisi rilevarono che l’acqua che arrivava nelle case era contaminata da rifiuti industriali tossici provenienti da fusti presenti nel sottosuolo; i fusti col tempo si erano corrosi e il contenuto si era disperso nel terreno fino a raggiungere le falde idriche sotterranee. L’opinione pubblica cominciò a chiedersi quante altre discariche abusive esistessero in Italia, quali pericoli ci fossero bevendo l’acqua che usciva dal rubinetto e ci si accorse che effettivamente era pratica abbastanza diffusa disfarsi dei rifiuti tossici e pericolosi seppellendoli nel terreno; era appena l’inizio della scoperta delle discariche abusive di rifiuti tossici di cui ancora adesso stiamo verificando la diffusione e la pericolosità.
Era anche un periodo in cui il diserbo del mais era praticato su larga scala con vari erbicidi fra cui l’atrazina e quello del riso con bentazone, molto efficaci ma tossici; queste sostanze, dopo essere state sparse nei campi, finivano nel sottosuolo e raggiungevano e inquinavano i pozzi da cui veniva prelevata l’acqua potabile.
In quel marzo 1986 una direttiva della Comunità Europea sulla qualità dell’acqua potabile aveva stabilito che la concentrazione degli erbicidi nell’acqua non avrebbe dovuto superare 0,1 microgrammi per litro; se la concentrazione fosse stata superiore, l’acqua non avrebbe potuto essere distribuita dagli acquedotti. Finalmente i laboratori addetti ai controlli ambientali in tutta Italia cominciarono ad analizzare nelle acque anche sostanze che fino allora erano state trascurate.
Ma il peggio stava per arrivare: mentre era vivace la contestazione dei programmi governativi di costruzione di centrali nucleari nel Mantovano, in Puglia, in Piemonte, nel Lazio, il 26 aprile 1986 in un reattore nucleare di uno sconosciuto paese dell’Ucraina (allora parte dell’Unione Sovietica), chiamato Chernobyl, si verificò un incidente che provocò un incendio e poi un’esplosione. Il reattore si scoperchiò e ne uscì una nube che disperse nell’atmosfera una grande quantità di elementi radioattivi, con una radioattività equivalente a quella di mezzo milione di chilogrammi di radio, che ricaddero nelle zone vicine e in parte, trascinati dal vento, raggiunsero la Germania e l’Italia settentrionale. Le autorità persero la testa: occorreva o no vietare l’uso di verdure, latticini e carne ottenuti in zone su cui erano ricadute le sostanze radioattive ? Ancora più disorientata l’opinione pubblica: come faceva una massaia a sapere che cosa poteva o non doveva comprare per non essere contaminata dai misteriosi atomi provenienti da migliaia di chilometri di distanza ?
Vale la pena ricordare gli eventi di quei lontani anni perché fecero aumentare la consapevolezza nei confronti dell’ambiente e della salute, due beni che possono essere difesi soltanto migliorando le strutture pubbliche di controllo ma soprattutto la conoscenza, da parte dei cittadini, di quello che succede intorno a loro.
Questo articolo è inviato contemporaneamente alla Gazzetta del Mezzogiorno
Un significativo episodio di lotta per la riconquista della città: atti di resistenza contro la gentrificazione e contro l'appropriazione mercsntile di un'arte pensata e realizzata per tutti. Articoli di A. Di Genova,A. Del Lago, G. Stinco, R. Ciccarelli e un filmato di Wu Ming. Il manifesto, 13 marzo 2016
QUELLO DI BLU
È UN GESTO POLITICO
di Arianna di Genova
La street art nasce in strada, è pubblica, democratica, allegra, provocatoria, ribelle, clandestina, fruibile in ogni momento senza bisogno di pagare nessun biglietto «d’entrata». A volte, anzi spesso, è pure anonima. È questo, d’altronde, il suo Dna.
Un murales è di tutti, della città stessa, neanche dei proprietari delle mura e dei palazzi dove appare. Un graffito poi non è un affresco medievale che va conservato altrove per evitare che l’umidità mangi e polverizzi il colore. Esporlo nei musei significa negare la sua stessa storia e renderlo esangue, normalizzare la sua dirompenza delle origini. E tirarlo via dai muri, dalle periferie anche degradate dove è nato (non a caso) è una sottrazione indebita nei confronti di una comunità che può goderne ogni giorno.
Il gesto di Blu è politico, si fa così la politica vera: richiama alle origini di una forma d’arte e neguna qualsiasi appropriazione altrui. E cosa dire poi dell’ipocrisia dei vari governi? Che prima condannano un writer per atti vandalici e, secondo convenienza, trasformano quegli stessi atti vandalici in capolavori, da far circolare nel mercato. È importante che l’azione radicale e dolorosa di Blu venga seguita anche da altri street artisti. Sarebbe una lezione di civiltà per tutti.
BOLOGNA
SEMPRE MENO ROSSA
E SENZA BLU
di Giovanni Stinco
Lo street artist cancella le sue opere dai muri di Bologna. Una protesta contro una mostra in cui verranno esposti disegnai staccati dai muri delle case. «Così si privatizza l’arte»
«A Bologna non c’è più Blu e non ci sarà più finché i magnati magneranno. Per ringraziamenti o lamentele sapete a chi rivolgervi». Non scrive o aggiunge altro lo street artist Blu, che ieri ha cancellato tutte le sue opere in città. Conosciuto e celebrato in tutto il mondo, Blu aveva già in passato cancellato una sua opera a Berlino, ma questa volta l’azione è stata sistematica. Sotto le Due Torri ogni traccia dell’artista è stata fatta scomparire da decine di attivisti e volontari, organizzati in squadre e armati di rulli, spatole e martelli.
L’ultima pennellata di grigio alla sua opera forse più conosciuta in città, il grande murales sulla facciata del centro sociale Xm24, è stata data nel pomeriggio. E così in poche ora l’epico affresco dal sapore tolkeniano è sparito, sparite le bici della Critical mass, gli attivisti, i contadini armati di zappe e gli studenti del book bloc che si scontravano alle porte di Bologna con bottegai, politici corrotti, banchieri e poliziotti a cavallo di draghi. Tutto è stato ricoperto da uno strato di vernice grigia. Resta solamente, e non è un caso, il frammento di città in fiamme col Cassero di Porta Santo Stefano, la sede dei collettivi punk e lgbt di Atlantide sgomberati nell’ottobre 2015 per volontà del sindaco Merola.
Le spiegazioni di un’azione così eclatante Blu le affida al collettivo di scrittori Wu Ming. «Il 18 marzo – si legge sul sito del collettivo – si inaugura a Bologna la mostra Street Art. Banksy & Co. Tra le opere esposte ce ne saranno alcune staccate dai muri della città, con l’obiettivo dichiarato di ’salvarle dalla demolizione e preservarle dall’ingiuria del tempo’, trasformandole in pezzi da museo». Una mostra che nasce per volontà di uno dei potenti per eccellenza della città, l’ex rettore ed ex numero uno della Fondazione Carisbo Fabio Roversi Monaco. «Ho un’età venerabile e non penso di poter fare molte altre cose, voglio salvare i graffitti dall’abbandono e dalla distruzione», aveva spiegato il diretto interessato.
«Non stupisce – si legge sul sito dei Wu Ming – che ci sia l’ex-presidente della più potente Fondazione bancaria cittadina dietro l’ennesima privatizzazione di un pezzo di città. Questa mostra sdogana e imbelletta l’accaparramento dei disegni degli street artist, con grande gioia dei collezionisti senza scrupoli e dei commercianti di opere rubate alle strade. Non stupisce che sia l’amico del centrodestra e del centrosinistra a pretendere di ricomporre le contraddizioni di una città che da un lato criminalizza i graffiti, processa writer sedicenni, invoca il decoro urbano, mentre dall’altra si autocelebra come culla della street art e pretende di recuperarla per il mercato dell’arte. Tutto questo meritava una risposta». E la risposta è arrivata «per sottrazione», perché «di fronte alla tracotanza da governatore coloniale, di chi si sente libero di prendere perfino i disegni dai muri, non resta che fare sparire i disegni» e «rendere impossibile l’accaparramento».
Così è sparito il murales dell’Xm24, sotto gli occhi spesso increduli dei passanti. Se le squadre di cancellatori hanno deciso di non rilasciare dichiarazioni lasciando parlare i fatti, c’è stato chi ha discusso lungamente con amici e sconosciuti incontrati sul posto. «Mi chiedo se quell’opera sia ancora nella disponibilità dell’artista, una volta che la regali alla città poi puoi decidere di cancellarla?», si è chiesta una signora dispiaciuta per quel che stava accadendo. Poi i tanti solidali con l’operazione: «Blu ha fatto la cosa giusta, adesso nei musei ci mettano questo bel muro grigio».
Di sicuro l’azione di Blu, allo stesso tempo performance e atto politico, è stata uno schiaffo alla mostra e nello stesso un modo di ricordare che la street art per sua natura è mutevole come lo è il panorama urbano, e non si fa ingabbiare nelle sale di un museo. «Un atto forte che farà riaprire il dibattito in una città che però ora si ritrova più povera», dice a caldo l’assessore alla cultura Davide Conte. Quel che è certo è che la politica locale non potrà più dirsi orgogliosa, come spesso ha fatto, per le opere che hanno fatto parlare di Bologna in tutto il mondo. Tenta di restare sopra le parti il sindaco, secondo cui «le scelte che riguardano l’arte non possono essere divise a priori tra giuste e sbagliate. Cercare la ragione e il torto in questi casi è un esercizio inutile e non mi interessa schierarmi con nessuno».
La risposta alla mostra sulla Street Art non ha riguardato solo il murales di Xm 24. In via Capo di Lucca sono spariti gli inquietanti animali che Ericailcane, Dem e Will Barras realizzarono nel 2009 per sostenere l’occupazione dell’ormai defunto collettivo universitario Bartleby. Sparito anche l’elefante giallo dipinto da Blu in via Zanardi, all’interno degli spazi allora occupati nel 2008 dai militanti del collettivo Crash. Proprio in via Zanardi tre militanti di Crash sono stati identificati e denunciati per invasione di terreni e imbrattamento mentre stavano cancellando l’opera di Blu. Secco il commento del collettivo: «Quanto sa essere sciocco il potere quando ci si impegna? Con questa ci conquistiamo la denuncia più stravagante e imbecille dell’anno».
BLU RIVOLTA
di Alessandro Dal Lago
Blu a Bologna. Cancellando le sue opere, Blu ha risposto che la città appartiene anche e soprattutto agli artisti e ai soggetti anonimi che modificano l’estetica urbana indipendentemente dal profitto, dal potere e dalle burocrazie urbane
Dietro il conflitto sulle opere di Blu a Bologna c’è un problema enorme, che non riguarda soltanto il writing o la street art, ma l’estetica urbana come fatto politico e oggetto di scontro sociale. Anzi, il diritto di espressione, artistica e non, contrapposto alla cultura degli assessori e al gigantismo spesso trombonesco e manipolatorio degli eventi sponsorizzati. Da un anno circa sui muri delle città tedesche si può leggere la scritta: Wem gehört die Stadt? («A chi appartiene la città»?).
Ai grandi interessi immobiliari? Alle amministrazioni elette magari da maggioranza di sinistra –e immediatamente impegnate a ripulire le città in nome del decoro urbano, come a Milano? Alle associazioni dei commercianti che cacciano gli ambulanti dai marciapiedi? Alle banche che deturpano le facciate di palazzi quattrocenteschi con insegne enormi? O magari ad associazioni di maggiorenti o critici che fiutano l’affare dei graffiti?
Cancellando le sue opere, Blu ha risposto che la città appartiene anche e soprattutto agli artisti e ai soggetti anonimi che modificano l’estetica urbana indipendentemente dal profitto, dal potere e dalle burocrazie urbane. E poiché le ha realizzate lui, a suo rischio e pericolo, è suo pieno diritto impedire che finiscano nelle mani di qualche mercante che sa guardare al di là del proprio naso. L’aspetto inquietante – agli occhi dei poteri locali – dell’arte di strada (graffiti, murali, stencil ecc.) è che non è in vendita, che la sua grazia risiede nella gratuità, e persino nel gioco a rimpiattino dei writer con le autorità e la polizia, che inevitabilmente li scambiano per teppisti, trattandoli di conseguenza. Miseria delle categorie ingessate del controllo sociale che vede infrazioni, deturpamenti e violazioni dei codici in un gesto, il dono di un’opera alla città, che evade dalla cultura del profitto. Così Blu può essere denunciato per aver realizzato un graffito oppure per averlo cancellato.
Un’altra writer di fama mondiale, ALICè, è condannata a 800 Euro di multa per un’opera murale che altrove sarebbe vanto di una città. E così via, in una sequela di schizofrenie giudiziarie, corteggiamenti estetici, burocratismi comunali, strepitii di risibili associazioni anti-graffiti, che spediscono ragazzini innocenti a imbiancare i muri – salvo scoprire che magari quello che ricoprono potrebbe valere milioni, come è avvenuto al celebre Banksy.
Che poi un writer come Blu esponga alla Tate, come ipocritamente gli ha rinfacciato qualcuno, non cambia la sostanza del problema. E non solo perché sono fatti suoi. Da che parte si sta? Da quella di chi deturpa per mesi la facciata di una cattedrale con una pubblicità di dieci metri per dieci? O da quella di chi dice la sua, con una bomboletta, sull’ordine che ci circonda?
Ma forse è più onesto chi reprime i writer apertamente, alla luce del sole, di chi strappa un’opera al suo luogo naturale, l’aria aperta, per trascinarla nell’aria stantia di un museo.
BLU, LA RIVOLTA CONTRO
LE CITTÀ ZOMBIE
di Roberto Ciccarelli
Street art. Ritratto di un artista anonimo conosciuto da Los Angeles a Berlino. La battaglia contro la gentrificazione e il diritto alla città. Quelle di Blu non sono «opere», ma atti di cittadinanza: popolano lo spazio, creano immaginario, fanno movimento. La storia di Kreuzberg, quando decise con Lutz Henke di cancellare i murali visitati in processione dai turisti-hipster
Di sé, Blu, non parla. Parlano le sue opere super-iconiche, affreschi colossali, concepiti per proteggere da uno sgombero l’ex magazzino dell’Aeronautica militare in via del Porto Fluviale a Roma, occupato da 450 persone in emergenza abitativa o l’ex mercato ortofrutticolo occupato dal centro sociale Xm24 a Bologna, una delle opere cancellate ieri per protestare contro la mostra «Street Art. Banksy & Co» dove Blu è stato esposto. E museificato nel mercato dell’arte che ha coniato un termine specifico, «muralismo», per indicare una pratica pacificata, una professione rispettabile.
I suoi sono invece atti di cittadinanza, non opere da esporre in vetrina, quelle di un museo o sulla superficie legalmente autorizzata. L’ultima moda della «gentrificazione»: decorare lo spazio urbano come un salotto con le foto di famiglia in cornici argentate.
Blu rivolta Bologna
Tre le righe dedicate sul suo sito da Blu agli organizzatori della mostra: «A Bologna non c’è più Blu e non ci sarà più finché i magnati magneranno per ringraziamenti o lamentele sapete a chi rivolgervi». Laconico, questo è lo stile dell’artista nato a Senigallia, cresciuto artisticamente a Bologna, street artist di fama mondiale.
La cancellazione dei murali bolognesi non va intesa solo come una difesa dell’indipendenza dell’artista o una protesta contro la riduzione della street art a arte decorativa. Ieri si è risvegliato un conflitto sociale sul futuro delle città. Era tutto rappresentato nel murale all’Xm24 che, ormai postuma, è diventata famosa.
Rappresentava il colossale scontro tra la città opulenta contro la città che lotta contro l’ingiustizia. Le munizioni: da un lato, enormi tranci di mortadella; dall’altro, cocomeri e zucche. L’affresco di una guerra contadina, una jacquerie combattuta con armi alimentari. Uno scontro epico, chiaramente dualistico, dal sapore tolkeniano. Si guerreggia per conquistare un anello, posto al centro dell’affresco. A Blu non manca l’umorismo.
Le parti in gioco sono chiare: da un lato c’è l’ideologia del decoro urbano che trasforma i quartieri in salotti ed eventifici; dall’altro lato, i movimenti sociali dal G8 di Genova ai No Tav; il gigantesco biker che schiaccia le automobili a Lambrate, la battaglia quotidiana contro la gentrificazione e per l’autorecupero urbano.
Wu Ming racconta Blu. #OccupyMordor
Berlino, la città dei non-morti
Non è la prima volta che questo artista anonimo decide di cancellare un’opera, trasformandola in evento di un arte che concepisce come politica. Lutz Henke, co-autore nel 2008 del secondo muro in Cuvrystrasse a Kreuzberg, ha raccontato come un murales può diventare un’attrazione turistica contro lo stesso parere degli artisti.
È successo a Berlino dove l’affresco del manager con i polsi incatenati che mostrano un orologio d’oro e quello delle figure rovesciate che si smascherano sono diventate l’attrazione della città «povera e sexy» visitata da torme di turisti e hipster. Lo scontro sociale è diventato un’estetica della resistenza per le campagne di marketing territoriale.
Blu e Henke hanno deciso di cancellare gli affreschi, oggi sostituiti da un altro con un gigantesco dito medio: «Fuck You Gentrification». «Senza volerlo – ha scritto Henke in un’articolo sul Guardian nel 2014 – abbiamo creato una rappresentazione visiva ideale per una città che offre spazi giganteschi abbandonati per una vita a basso costo e una sperimentazione creativa tra le rovine della sua storia. Gli artisti scoprono di essere i loro principali nemici». Il vicinato protestò contro il turismo che è il primo passo della gentrificazione.
Gli artisti capirono: «Berlino ha bisogno del suo brand artistico per restare attraente, tende a rianimare la creatività che disperde, producendo una città non morta». Henke parla di una «zombificazione» che rischia di trasformare Berlino in una città riverniciata.
Il punto è un altro: «Reclaim your city», rivendica la tua città.L’evocazione di un diritto alla città era scritta a caratteri cubitali accanto a una delle teste delle sagome in Cuvrystrasse. Non lasciare, invece, senza risposte la domanda che molte volte è stata ripetuta in questi anni: «Chi governa questa città? Di chi credi che sia?»
Un’arte fugace
Ieri abbiamo compreso che la duplicazione di un’opera di Blu in una mostra a Bologna rischia di negare il senso di un altro spazio vissuto e recuperato, fuori dal suo centro-vetrina. La cancellazione è un atto che rafforza la funzione sociale di un intervento artistico sulla città, lì dove altre forme di azione politica si rivelano poco efficaci.
«Sin dal primo momento i murali di Blu sono destinati a scomparire – sostiene Henke – è la natura della street art occupare spazio per celebrare la sua incertezza, cosciente della sua esistenza fugace». È anche accaduto che un’opera di Blu sia stata cancellata dal suo committente.
È accaduto al museo d’arte contemporanea di Los Angeles – il Moca – nel 2010. Il direttore Jeffrey Deitch non gradì il pezzo pacifista che rappresentava le bare dei soldati caduti in una guerra americana rivestite di dollari e non con la bandiera Usa. Vicino al museo c’era un ospedale per veterani di guerra e un monumenti ai caduti nippo-americani.
La reazione di Blu fu determinata, ma serena. Parlò di «censura» e disse: «Mi capita spesso di dipingere soggetti forti – scrisse Blu – ma lascio sempre l’interpretazione aperta allo spettatore. La reazione delle persone è la cosa più interessante. Alcuni veterani hanno gradito il murale, trovandolo veritiero. La mia posizione è fare un passo indietro e guardare le reazioni».
Blu: street art globale
Sul sito del manifessto trovare altri filmati e immagini che non sappiamo inserire qui. Chi si contenta gode, e chi vuole godere di piu si abbona al manifesto online.

Prosegue il tentativo del governo Renzi di rendere vano il referendum indetto da cinque regioni per dare un segnale forte nella direzione giusta sulla difesa dell'ambiente e del nostro futuro. Il Fatto quotidiano, 12 marzo 2016
Vietato parlare di referendum sulle trivellazioni in Consiglio comunale. Quando a Menfi cinque consiglieri hanno avanzato la proposta di ordine del giorno sono rimasti di sale: la prefettura di Agrigento, che riprende una circolare del ministerodell’Interno, dice no. E pensare che a Menfi, Sciacca, Porto Empedocle, insomma, in quella Sicilia che teme di vedere l’orizzonte costellato di trivelle, se ne parla eccome. Ma nelle aule della politica non si può. Tanto che i sindaci, lasciata magari per un attimo la fascia tricolore, hanno deciso di riunirsi. Di studiare forme di mobilitazione prima del 17 aprile.
“Non è una censura sulle trivelle. Succede così prima di tutte le consultazioni elettorali”, giurano dalla prefettura di Agrigento. E ti mostrano la circolare del ministero dell’Interno: “È fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Ma poche righe dopo ecco si apre lo spiraglio in cui vogliono infilarsi i sindaci siciliani: “Si precisa che l’espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale... e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda”.
Insomma, fatta la legge trovato l’inganno. Anzi, è lo stesso ministero che te lo indica. Anche perché in Sicilia quasi tutti i sindaci sono contrari alle trivellazioni. A cominciare da Vincenzo Lotà di Menfi: “Ci stiamo organizzando. Qui siamo tutti preoccupati, i comuni costieri e quelli dell’entroterra. Ci sono comuni come Sciacca che sorgono in zona vulcanica”. Gente combattiva, qui a Menfi. Come racconta Vito Clemente, il presidente del Consiglio Comunale: “Ho dovuto dire di no al consiglio dedicato alle trivelle, perché me lo imponeva la legge. Ma io sono per il “Sì”, cioè per l’abrogazione della legge che proroga le concessioni”. Tipico dell’Italia, bisogna dire “Sì” per dire “No” alle trivelle. Ma Clemente aggiunge: “Qui ci siamo già battuti contro chi voleva portarci via l’acqua; contro chi sperava di costruire una centrale a biomasse; per non dire delle pale eoliche e ora delle trivelle. Ma noi puntiamo su uno sviluppo che rispetta l’ambiente”.
I Comuni e sindaci non possono parlare di referendum. Nel Municipio, perché basta varcare la porta e tutto cambia. Vale per Menfi, ma anche per altri comuni no-trivelle. Per esempio Frisa (Chieti), in Abruzzo. Racconta il sindaco Rocco Di Battista: “La battaglia è partita anche da qui. Noi abbiamo votato contro le trivelle mesi fa. Ma anche adesso, come privato cittadino, continuerò a schierarmi per il “Sì”. Evidentemente si vuole impedire ai cittadini di esprimere la propria volontà”. Comune che vai, usanza che trovi. Racconta Andrea Quattrini (consigliere M5S ad Ancona): “Lunedì in consiglio comunale è in calendario una mozione per impegnare il Comune a ribadire la propria contrarietà alle trivelle e invitare i cittadini a votare “Sì”. Vorremmo che il Comune aderisse come sostenitore al coordinamento anti-trivelle”. Chissà se anche ad Ancona interverrà il prefetto.
Non è la so-la anomalia
un po’ italia
na: le Regioni,
infatti, non
sono sottopo
ste al divieto. “Non si poteva impedire alle Regioni di fare la campagna per il “Sì” – ha spiegato al Fatto Quotidiano Piero Lacorazza, presidente del consiglio regionale della Basilicata – visto che siamo gli unici comitati promotori”.
Ma il referendum sulle trivelle rischia di scavare una voragine anche nel sindacato, aprendo la questione ambientale. Due giorni fa Emilio Miceli, segretario Chimici Cgil, si era schierato apertamente contro il referendum e a fianco delle trivelle: siamo ancora lontani, aveva detto, da un “superamento dell’energia da fonte fossile”. Ma nella Cgil si stanno confrontando diverse anime. “Quattrocento dirigenti di diversi settori hanno firmato un appello a favore del ‘Sì’”, racconta Simona Fabiani della Cgil Ambiente.
Legge nel documento: “Come sindacalisti siamo convinti della necessità e dell’urgenza della transizione a un nuovo modello energetico, democratico e decentrato, con il 100 per cento di efficienza energetica e di rinnovabili, con grande opportunità di crescita economica e di nuova e qualificata occupazione per il nostro Paese” è scritto nell’appello. Che aggiunge: “Le trivellazioni, il petrolio, le fonti fossili rappresentano un passato fatto di inquinamento, dipendenza energetica, interessi e pressioni decisionali delle lobby, conflitti, devastazione ambientale e della salute, cambiamenti climatici”.

Qualche giorno fa si è ricordato su questo sito quanto sia importante, per governi e imprese, guardare al futuro e chiedersi quali conseguenze potrebbero avere le decisioni che prendiamo oggi. Tale importanza appare ancora più grande alla luce di uno degli eventi più disastrosi della storia, l’incidente alla centrale nucleare giapponese di Fukushima, avvenuto cinque anni fa. E’ stato scritto e sarà scritto molto, articoli, ricerche sperimentali, volumi, sopra le cause e lo svolgimento dell’evento; un terremoto di anomala intensità, in fondo al mare al largo della costa nord orientale del Giappone, ha provocato un’onda marina di molti metri di altezza che ha invaso la costa arrivando fino ai quattro reattori nucleari che azionavano una grande centrale elettrica; una interruzione dell’erogazione dell’elettricità ha impedito il flusso dell’acqua di raffreddamento delle barre contenenti l’uranio e il plutonio che, esposti ad un flusso di neutroni, stavano trasformandosi lentamente liberando grandissime quantità di calore. Il calore, a sua volta, generava il vapore che azionava le turbine e gli alternatori della centrale elettrica.
Nel momento in cui è cessato il raffreddamento delle barre di tre dei reattori (il quarto era inattivo), la temperatura di queste barre metalliche è aumentata in maniera incontrollata, la reazione fra metalli incandescenti e acqua ha provocato la formazione di idrogeno, un gas combustibile che si è incendiato in forma esplosiva; altre parti metalliche sono fuse e parte degli elementi radioattivi si sono sparse all’interno dei reattori continuando a liberare calore. Dei coraggiosi lavoratori, alcuni pagando con la vita il proprio impegno, sono riusciti a isolare la materia incandescente e a diminuire almeno la diffusione nell’ambiente delle sostanze radioattive; comunque è risultata contaminata e inabitabile una vasta superficie intorno ai ruderi della centrale nucleare, fino a poco prima orgoglio della tecnologia. In questi anni grandi quantità di acqua, prelevata dal mare, sono state restituita al mare inquinate con elementi radioattivi e si sono disperse nell’Oceano Pacifico; grandi quantità di acqua radioattiva sono ancora contenute in serbatoi; grandi quantità di rottami altamente radioattivi sono ancora all’interno dei reattori e continuano ad emanare radioattività e calore e continueranno ad emanare radioattività e calore per secoli e, in qualche caso, per millenni, in attesa di una qualche “sepoltura”.
L’incidente di Fukushima segnò l’inizio della fine delle centrali nucleari commerciali; furono cancellati in fretta e furia i progetti di costruzione di quattro centrali nucleari che il governo italiano aveva previsto qualche mese prima; furono fermate molte centrali nucleari in funzione nel mondo. I volonterosi sostenitori dell’energia nucleare continuano aa affermare che è un errore abbandonare questa fonte di energia che fornisce elettricità senza immettere gas serra nell’atmosfera; che appropriate innovazioni tecniche potranno ridurre i rischi di futuri incidenti simili a quelli che si sono già verificati a Three Mile Island negli Stati Uniti nel 1979, a Chernobyl in Ucraina nel 1996 e a Fukushima in Giappone nel 2011. A parte considerazioni ambientali, per restare soltanto alla questione dei soldi, pochi conti mostrano però che i perfezionamenti nelle centrali nucleari faranno aumentare il costo dell’elettricità a livelli insopportabili, e superiori a quelli dell’elettricità fornita perfino dalle centrali fotovoltaiche solari.
L’evento di Fukushima induce però a interrogarci sul problema più generale della fragilità della tecnologia e dei suoi affetti sulla vita umana. Gli esseri umani hanno bisogno di “cose” materiali, che sia cibo, o lavatrici, o scarpe o edifici; ciascuna di queste ”cose” (vogliamo chiamarle “merci” ?) deve essere progettata e fabbricata prima di arrivare a chi la dovrà usare. Il progetto deve prevedere, con uno sguardo al futuro, quanta materia occorre nella fabbricazione, e quali effetti la fabbricazione ha sui lavoratori e sull’ambiente, quali effetti l’uso avrà sugli acquirenti, e quali effetti lo smaltimento dopo l’uso avrà sull’ambiente. Attenzione al “futuro”, qualità delle ”cose”, benessere umano e ambiente sono i fattori che stanno alla base del “progetto”. C’entrano poi anche i soldi; quali processi costano meno soldi, quali possono produrre “cose” vendibili a più basso prezzo e quali assicurano maggiori profitti ai fabbricanti. Il lettore avrà notato che non ho usato la comune parola “consumatore” perché l’acquirente delle merci non le consuma, ma trasforma le molecole delle varie componenti in altre molecole e sostanze che finiscono, prima o, poi, nell’”ambiente” naturale, nell’aria, nelle acque, sul suolo.
Il fallimento dell’energia nucleare sta proprio nel fatto che le centrali nucleari sono state progettate senza tenere adeguatamente conto di ciò che avrebbe potuto avvenire non solo nei reattori, ma nei reattori collocati in quel particolare luogo; senza tenere conto che le sostanze radioattive che si formano sono una fonte di inquinamento durante il funzionamento e soprattutto dopo la fine della vita delle centrali. L’Italia sta per essere investita dal dibattito su dove sistemare le scorie radioattive, rimaste dopo i pur pochi anni di durata dell’avventura nucleare italiana ma sufficienti per costringere governi e cittadini a chiedersi come progettare dei cimiteri capaci di contenerle senza danni “per il futuro”, un futuro di secoli e millenni. Il grande pensatore Albert Schweitzer (1875-1965), premio Nobel, per la Pace 1952, scrisse una volta che la sopravvivenza umana dipende dalla capacità di “prevedere e prevenire”: queste parole dovrebbero essere tenute presenti ogni volta che governi e imprese fanno baldanzosamente scelte tecnologiche che avranno effetti sulla vita e sull’ambiente. E tutte ne avranno.
Si veda anche, di Giorgio Nebbia, L'uomo ha perso la capacità di prevedere
Occorrerà conservare in una cineteca speciale, in un archivio dell'orrore, i filmati che i nostri telegiornali fanno entrare tutti i giorni nelle nostre case: le immagini delle barriere ...(continua la lettura)
Occorrerà conservare in una una cineteca speciale, in un archivio dell'orrore, i filmati che i nostri telegiornali fanno entrare tutti i giorni nelle nostre case: le immagini delle barriere e dei fili spinati, i fotogrammi di una guerra inimmaginabile fino a poco tempo fa e forse unica nella nostra storia. Quella che varie polizie delle vecchie frontiere d'Europa combattono contro donne, bambini, anziani, giovani, scampati alle guerre innescate dall'Occidente nelle periferie del mondo. Occorrerà conservare questi documenti di ottusa e primitiva malvagità alle generazioni che verranno perché - se i Paesi del Vecchio Continente non saranno definitivamente inghiottiti dalla barbarie - possano osservare, in tempi meno oscuri dei nostri, di che cosa sono stati capaci i loro padri e nonni.
Ma forse occorre uscire dall' immagine indefinita che assegna a popolazioni indistinte il marchio di una così ottusa e ostinata ferocia.La notte in cui tutte le vacche sono nere non ha mai fatto comprendere niente a nessuno. Se guardiamo ad alcuni paesi dell'Europa occidentale, come la Francia, l'indistinto di una umanità genericamente ostile e senza misericordia si scioglie. Il grande paese che ha fondato la modernità della politica, innalzando il vessillo della libertà, dell'uguaglianza, della fraternità, il paese governato dai socialisti del presidente Hollande, muove oggi a Calais una sua abietta guerra contro una massa di disperati, a cui toglie perfino le misere baracche e le tende in cui era da mesi accampata. Com'è possibile, come si sia arrivati fin qui? Questa domanda non ci pone solo davanti a un generico arretramento di civiltà che oggi colpisce indistintamente “l'Europa”. Essa ci squaderna un fenomeno politico di prima grandezza che già la vicenda greca dello scorso anno ci aveva illustrato con desolante chiarezza. I vecchi partiti socialisti e socialdemocratici europei, quello tedesco come quello britannico, sono stati intimamente ripuliti di ogni contenuto ideale e di valore. Le loro dirigenze hanno gettato via come vecchio tutto l'antico bagaglio di solidarietà che ha segnato la loro storia e sono diventati moderni, come vuole il capitalismo attuale e la sua razionalità neoliberista. E' una perdita gigantesca alla quale addebitare non poco dell' arretramento del processo di unificazione dell'Europa.
Ma non ci si può fermare alla recriminazione e allo sdegno. Occorre capire con freddezza e lucidità che cosa è accaduto e accade, tentare delle contromisure. Che cosa vuol dire per i partiti politici diventare moderni, come vuole il linguaggio pubblicitario corrente ? Moderni vuol dire essere competitivi nel mercato politico, attenti al mutare degli umori della “gente”, vale a dire i cittadini ormai interamente assimilati agli elettori quali meri consumatori di messaggi. Moderni significa cercare di vincere, contro gli avversari competitori, il campionato pluriennale delle elezioni politiche e amministrative. Per questa via una democrazia interpretata come passiva adesione agli umori del momento, diventa una sua perversione perniciosa. E' una novità storica rilevantissima. Un tempo i socialisti francesi – come gli altri partiti popolari- avrebbero combattuto a muso duro contro le posizioni xenofobe dei loro avversari, non solo senza cedimenti di fatto alle loro pretese, ma mettendo in atto quella pedagogia di massa che i grandi partiti popolari e di sinistra hanno esercitato per oltre un secolo. I partiti non ancora trasformati in ristretti club dominati dal ceto politico, avrebbero combattuto contro le destre xenofobe rassicurando le popolazioni, disinnescando i meccanismi della paura, mostrando perfino l'utilità economica di un ingresso rilevante di popolazione giovane nei loro vasti territori. La Francia è uno dei paesi a più bassa densità demografica d'Europa. Ma i partiti non sono più portatori e divulgatori di conoscenze dei reali fenomeni sociali e quindi non sono più guide, ispiratori di orientamento, elaboratori di orizzonti più avanzati di civiltà. Essi corrono dietro agli imprenditori della paura, cercano di non farsi battere nella competizione messa in atto dai partiti della destra, cedendo alla loro visione generale non solo perché non hanno più alcuna visione, ma perché è mutato il fine del loro stesso agire.Questo fine – ciò è ormai chiaro sino all'ovvietà – è la loro affermazione, il loro successo e la loro sopravvivenza e riproduzione di ceto.
Come può dunque, una sinistra che non vuole arrendersi a questa disfatta storica, porre in atto forme di resistenza, allestire contromisure? Immenso problema, come sappiamo.Ma qualche strada da percorrere è già stata esplorata e occorrerebbe percorrerla con più determinazione. Oggi appare velleitario e ingenuo richiamare i vecchi partiti ai grandi valori del loro passato. La morale non si insuffla con le esortazioni e con le prediche. Ma dove vien meno la sostanza morale, il diritto è capace, se non di surrogarla, di porre qualche argine. E quel che il diritto può fare è impedire (o limitare fortemente) che la militanza politica diventi una carriera. Non potremo mai, almeno in un prevedibile futuro, imporre a chi opera sulla scena politica di rappresentare e promuovere esclusivamente l'interesse generale, se non faremo in modo che egli sia, per legge, impossibilitato a costruire sulla politica le proprie personali fortune. Occorre limitare drasticamente la durata delle cariche pubbliche, separare queste ultime da quelle di partito, sottoporre a trasparente monitoraggio il bilancio dei rappresentanti e quello della formazione politica a cui appartengono. E cosi via. Non c'è altro modo, per sottrarre il ceto politico alla tentazione di cedere alla vie più facili per ottenere consenso e quindi di inseguire i populismi. E costituisce una strada importante per sottrarlo alle sirene del potere economico e finanziario. Occorre spezzare alla radice questo legame, che alla fine condanna la politica all'impotenza. Chi fa politica deve rispondere alle domande dei cittadini e ridiventare cittadino dopo pochi anni di impegno pubblico.
In Italia la sinistra ha compiuto su tale terreno uno sforzo di elaborazione importante negli ultimi mesi, grazie all'iniziativa di Luigi Ferrajoli e della Fondazione Basso. Occorrerebbe che queste elaborazioni trovassero una più ampia circolazione e visibilità, perché diventino un patrimonio comune, un marchio di innovazione reale del nostro schieramento.
(continua la lettura)
L’Università delle Nazioni Unite di Tokyo e altre associazioni scientifiche hanno deciso di proclamare il primo marzo, “Giornata mondiale del futuro”. Tutte le persone e le società umane si sono sempre interrogate sul “futuro”: che cosa succederà “domani”, “fra un anno”; gli agricoltori si chiedono se pioverà, i negozianti si chiedono se venderanno le loro merci; ogni persona si chiede se sarà ricca, o felice e quanto a lungo vivrà. La saggezza popolare suggerisce che “il futuro è nelle mani di Dio”, però qualche tentativo di previsioni va fatto non tanto su quello che succederà quanto piuttosto su quello che potrebbe avvenire in futuro, sui futuri possibili e sulle relative conseguenze positive o negative. A partire dall’Ottocento ogni notizia di qualche nuova invenzione o scoperta scientifica ha stimolato gli scrittori a immaginare quali effetti avrebbero potuto avere “in futuro”, previsioni più meno fondate o affidate alla fantasia ad alimentare la fortunata corrente delle opere di “fantascienza”.
Una delle più importanti correnti di studi sul futuro ha riguardato la crescita della popolazione di un paese, un problema che interessa le compagnie di assicurazione e che ha dato vita alla “matematica attuariale”, disciplina che ha avuto famosi docenti anche nell’Università di Bari. Si è poi visto che le stesse “leggi” che descrivono l’andamento delle popolazioni umane sono in grado di descrivere la nascita, crescita, declino e scomparsa delle popolazioni di tutti gli animali e ne è nata, negli anni trenta del Novecento, una fiorente corrente di “ecologia matematica”, che avrebbe fornito gli strumenti di previsione per i successivi “studi sul futuro”.
A poco a poco alcuni governi hanno cominciato a organizzare degli uffici per decidere le proprie politiche economiche sulla base di previsioni: di quante case o patate o trattori o automobili avrà bisogno il paese ? Il primo esempio fu offerto dal governo bolscevico che, appena insediato in Russia, organizzò l’ufficio dei piani quinquennali, il Gosplan, il grande centro di studi sul futuro che ispirò simili iniziative negli Stati Uniti e anche ricerche in Italia: Giorgio Mortara, dell’Università Bocconi di Milano, pubblicò, dal 1921 al 1937, quindici volumi, uno all’anno, di “Prospettive economiche”. Solo con qualche forma di previsione è possibile rendersi conto in tempo dei mutamenti in atto, in modo da correggere le previsioni successive.
Ma una vera attenzione “scientifica” per immaginare il futuro, anzi i futuri possibili, è cominciata dagli anni cinquanta del secolo scorso con la scoperta dell’energia atomica, la tensione fra paesi capitalisti e comunisti, la diffusione delle bombe nucleari, la rapidissima espansione della produzione industriale e dei consumi. In questo periodo il francese Bertrand de Jouvenel (1903-1987), uomo politico ed economista, ha creato un centro di ricerche sul futuro chiamato, appunto, “Futuribles”, futuri possibili, che ha stimolato studiosi di molti paese al punto che gli “studi sul futuro” hanno trovato accoglienza anche in alcune università.
Negli anni settanta il famoso libro
I limiti alla crescita del Club di Roma, è stato il più discusso esercizio di analisi del futuro; il libro conteneva delle previsioni, basate su analisi statistiche e matematiche, di quello che avrebbe potuto succedere se fosse continuata la “crescita” della popolazione mondiale, della produzione industriale e dei conseguenti inquinamenti e impoverimento delle risorse naturali, al ritmo che aveva caratterizzato i decenni precedenti. Il libro prevedeva un peggioramento delle condizioni di vita di un pianeta sovraffollato e suggeriva di ripensare l’ideologia “della crescita”. Quasi contemporaneamente fu costituita la Federazione Mondiale per gli Studi sul Futuro, presieduta per molti anni dalla più importante scienziata italiana in questo campo, Eleonora Masini, che organizzò la prima conferenza mondiale sul Futuro a Frascati nel 1973 (i preziosi atti sono ormai purtroppo introvabili), e ha insegnato per molti anni “Previsioni sociali” all’Università Gregoriana di Roma.
La distensione internazionale, il miglioramento delle condizioni di vita e degli affari, hanno poi fatto accantonare per anni l’interesse per gli studi sul futuro che sta risorgendo un po’ adesso anche perché i cambiamenti climatici hanno spinto a chiedersi che cosa “può succedere” se continuerà il lento progressivo aumento della temperatura terrestre. Qualcosa sembra muoversi anche in Italia dove è stato creato da qualche anno a Napoli un “Istituto Italiano per il Futuro”.
A ben pensare ogni governo, ogni impresa dovrebbero cercare di capire le tendenze future dei fenomeni da cui dipendono le loro decisioni; un lavoro difficile perché “esplodono” continuamente nuovi fenomeni imprevisti. Mezzo secolo fa si prevedeva una rapida crescita della popolazione mondiale; oggi stiamo assistendo, in molti paesi, ad una diminuzione delle nascite, ad un aumento degli anziani, alla necessità di “importare” lavoratori stranieri. Quaranta anni fa il governo italiano aveva previsto di costruire sessanta centrali nucleari e adesso non ce ne è neanche una. Le compagnie petrolifere continuano a estrarre petrolio i cui consumi sono rallentati. Venti anni fa la transizione dal comunismo ad un capitalismo di stato ha trasformato la Cina in un gigante che invade col suo acciaio e i suoi pannelli solari tutto il mondo e costringe alla chiusura le fabbriche europee. Perché non sono stati capiti in tempo i segni di tali mutamenti ?
A mio modesto parere gli “studi sul futuro” dovrebbero diventare disciplina di insegnamento e oggetto di ricerca in tutte le università; ne trarrebbero vantaggio governi e imprese, nell’insieme tutta la società e anche l’ambiente naturale.
L'articolo è stato inviato contemporaneamente a La Gazzetta del Mezzogiono
«Aravena viene da un mondo in cui «si lavora con scarsità di mezzi e non si può fare quel che si vuole, ma bisogna sempre spiegare perché lo si fa. È un importante filtro contro l’arbitrarietà.Vivere e lavorare in città che si espandono slums dopo slums, deve aiutare a cercare soluzioni, progetti, dispositivi fisici che attenuino la sofferenza». La Repubblica, 23 febbraio 2016
Venezia. È una Biennale che non espone. Propone domande e fa sfilare esperimenti e soluzioni possibili. È la Biennale architettura firmata da Alejandro Aravena, la quindicesima della serie. Durerà sei mesi, dalla fine di maggio alla fine di novembre e non sarà una rassegna di soluzioni formali prodotte da architetti e destinate ad architetti. «Dalla corte degli architetti al pubblico», sintetizza Paolo Baratta, presidente della Biennale. Cambia lo statuto. Da una disciplina che ambisce a realizzare oggetti singoli, stupefacenti e spiazzanti, a un’altra che si misura con una quindicina di espressioni chiave. Fra le altre: disuguaglianze, periferie, disastri naturali, emergenza abitativa, migrazioni, trasporto pubblico, spreco... Sono le questioni che da una quindicina d’anni impegnano Aravena. Cileno, quarantanove anni, camicia bianca fuori dai pantaloni, capigliatura arruffata ma con cura, Aravena viene da un mondo in cui «si lavora con scarsità di mezzi e non si può fare quel che si vuole, ma bisogna sempre spiegare perché lo si fa».
E aggiunge: «È un importante filtro contro l’arbitrarietà». Ma vivere e lavorare in città che si espandono slums dopo slums, deve aiutare a cercare soluzioni, progetti, dispositivi fisici che attenuino la sofferenza. E ad essi Aravena dedica gli sforzi che lo hanno portato, nel gennaio scorso, a vincere il premio Pritzker, il nobel dell’architettura, completando con il proprio nome una galleria di luccicanti archistar. Anche qui un cambio di statuto.

Reporting from the front - questo il titolo della prossima Biennale - chiama a raccolta una novantina di espositori, un terzo dei quali sotto i quarant’anni. Mostreranno come hanno interpretato le espressioni chiave indicate da Aravena. Non ci sono immagini che anticipino i progetti. Salvo una, introduttiva: una foto scattata da Bruce Chatwin che ritrae un’archeologa tedesca, Maria Reiche, sopra una scala d’alluminio che osserva i tracciati di pietre del deserto peruviano di Nazca raffiguranti uccelli, giaguari, alberi e fiori. Spiega Aravena: «Nessuno di noi stando a terra vede altro che pietre, ma da lassù le figure appaiono evidenti: ecco cosa chiediamo a chi espone alla Biennale, chiediamo di fornire proposte, interpretazioni che non riusciamo a percepire ». Saranno presenti molti giovani (fra i quali anche il gruppo inglese Assemble e l’indiana Anupama Kundoo) e anche i più smaglianti Peter Zumthor, David Chipperfield, Herzog & de Meuron, Kazuyo Sejima, Kengo Kuma, Norman Foster, Rem Koolhaas, Richard Rogers, Eduardo Souto de Moura, Tadao Ando e poi Renzo Piano con il gruppo G124, i giovani professionisti che Piano finanzia con lo stipendio di senatore a vita.
Una concessione allo star system?
«No - replica Aravena - non tutto delle cose che questi progettisti realizzano c’interessa, ma perché non mettere a disposizione la loro creatività quando si confronta con i temi che abbiamo scelto?».
E il pensiero corre a Piano e al lavoro nelle periferie di alcune città italiane. Le periferie sono il suo humus culturale. Le periferie di una città e anche la periferia latinoamericana.
«Vivere ai margini rispetto ai grandi flussi consente di non avere un padre da uccidere, un’ombra che sovrasta ogni passo. Però incombe il rischio di accettare tutto quel che arriva da fuori senza dare valore a ciò che è più prossimo. Il luogo di margine impone di essere molto informati su quel che accade al centro del mondo e contemporaneamente di capire le pratiche virtuose che lì e non altrove si attuano. La periferia non è il luogo dove il mondo finisce, diceva Iosif Brodskij».
L’altra costrizione da cui proviene la sua architettura è la dittatura di Augusto Pinochet.
«L’ho vissuta da studente universitario, quando si forma il carattere e si è ribelli per natura. Noi dovevamo essere doppiamente ribelli».
Una volta laureato, è venuto in Italia. Perché?
«Sono venuto a Venezia. Era il 1992. Volevo conoscere le architetture che avevo studiato solo in fotografia. Volevo andare alle fonti. Camminavo per le calli e misuravo edifici. E la stessa curiosità mi ha spinto in Sicilia e in Puglia».
Quindi è tornato in Cile.
«Sì e ho iniziato a lavorare. Ma ho incontrato solo clienti orribili. Per due anni ho lasciato i tavoli da disegno e ho fatto il barista. Poi di nuovo la passione mi ha catturato. Ma stavolta la direzione di marcia era tutt’altra. All’inizio del Duemila ho fondato Elemental, uno studio dedicato all’edilizia sociale. Il primo progetto rilevante è un complesso per un centinaio di famiglie a Iquique. La dotazione pubblica copriva spese per 7.200 dollari. Trecento dovevano metterli le famiglie. Si poteva fare solo una piccola, disagiata e miserevole abitazione. Invece abbiamo progettato metà di un appartamento, l’altra metà era a carico dei residenti. Quando ho vinto il Pritzker è venuta a trovarmi una donna che era stata fra le prime abitanti di Iquique. Mi ha raccontato che alcuni di loro avevano venduto. Ho chiesto a quanto. A sessantacinquemila dollari, mi ha risposto».
Che seguito ha avuto quell’esperienza?
«Quel progetto, che risale al 2003, è stato replicato decine e decine di volte. L’ultimo risale al 2010 ed è stato realizzato a Constitucion, dopo il terribile tsunami. Non venne fornito solo un alloggio, venne data l’occasione per generare una ricchezza che avrebbe consentito ai figli di quei pionieri di studiare e di avviare un’attività. Iquique è l’esempio di un luogo che produce comunità, lo spazio pubblico è curato come un bene prezioso che dà altro valore alle case. Elemento centrale è stata la partecipazione: tante domande, tanti bisogni espressi e un architetto che con carta e matita offre una sintesi».
Quali altri strumenti ha l’architettura per attenuare le disuguaglianze?
«Può progettare un buon sistema di trasporto pubblico. L’America Latina mostra esperimenti encomiabili. A Bogotà e a Medellín si è drasticamente ridotto il tasso di criminalità giovanile perché le immense favelas sono state meglio collegate fra loro e con il centro da sistemi di funicolari e di tram. Quel che genera i conflitti e la rabbia non è la povertà in sé quanto la disuguaglianza. La povertà è ridotta nel mondo, è peggiorata la disuguaglianza. La redistribuzione non basta a colmarla. Perché sia efficace ci vuole molto tempo. La città offre occasioni per diminuire le disuguaglianze se fornisce un trasporto pubblico efficiente e di qualità. Come l’investimento in spazio pubblico. Sono interventi in cui l’architettura ha un ruolo decisivo».
L’OPERA
Qui accanto l’Innovation Center dell’Università Cattolica di Santiago del Cile realizzato da Alejandro Aravena ( nella foto in alto)
(continua a leggere)
Qualche giorno fa un gruppo di miserabili baracche (ghetto, lo chiamavano) abusive occupate da molti anni da lavoratori stagionali a Rignano Garganico (vicino a Foggia), è stato distrutto dal fuoco con tutte le poche miserabili cose degli occupanti. Per loro sembra che la Regine Puglia avesse in programma una qualche diversa sistemazione che comunque è arrivata tardi. Quello di Rignano è solo uno delle centinaia di rifugi precari per lavoratori che si spostano da un luogo all’altro per la raccolta di prodotti agricoli, con miserabili paghe, esposti al ricatto dei “caporali”. Non ci sono dati statistici sul numero di lavoratori extracomunitari, ma anche comunitari, che vengono o vivono nel nostro paese, alcuni regolari, altri clandestini, e sulle loro abitazioni, talvolta rifugi precari, talvolta case sovraffollate, affittate a prezzi esosi. Gli italiani hanno bisogno di questi lavoratori ma li detestano se addirittura non li odiano, e manca una politica che renda meno disumana la situazione di questo nostro “prossimo”.
Si tratta di persone che abbandonano i loro paesi e le loro famiglie a causa dell’impoverimento delle loro terre, talvolta per colpa dei mutamenti climatici, che fuggono dalla miseria, talvolta dai conflitti o dalle persecuzioni etniche, o dalla mancanza di lavoro per la chiusura di fabbriche o miniere. Poveri che premono ai confini dei paesi nei quali sperano di avere occupazione e che li respingono e costringono a vivere in ghetti, appunto come quello di Rignano. Storie di miseri che hanno segnato tutto il Novecento e questo secolo e che sono sommerse, non hanno voce.
Una qualche mobilitazione di intellettuali in loro difesa si ebbe ottanta anni fa negli Stati Uniti, durante la grande crisi iniziata nel 1929. Negli anni venti del Novecento si era verificata una grande tragedia ecologica; le terre, una volta fertili, degli stati centrali, Oklahoma, Arkansas, Texas, del grande paese, erano state sottoposte a eccessivo sfruttamento; tempeste di vento asportavano la poca terra fertile ancora rimasta, i piccoli agricoltori non potevano più pagare i debiti e le banche si appropriavano della loro terre per destinarle a colture intensive. Milioni di famiglie furono gettate nella miseria e costrette ad emigrare ad ovest verso la fertile California, dove speravano di trovare lavoro. Qui i grandi proprietari terrieri si servivano di “caporali”, proprio come da noi oggi, per reclutare operai disposti a lavorare alle paghe più basse, senza sicurezza, in ricoveri di fortuna.
Nel 1933 gli americani elessero alla presidenza degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), un anziano signore colpito in giovane età dalla poliomielite, ridotto a muoversi in carrozzella, ma determinato a far uscire il suo paese dalla crisi con un nuovo patto sociale, il “New Deal”. Per affrontare il problema dei migranti Roosevelt, poche settimane dopo l’insediamento, nominò Rexford Tugwell (1891-1979), professore di economia alla Columbia University, una eccezionale figura di difensore dei diritti civili, a capo della “Rural Resettlement Administration”, l’agenzia federale col compito di creare dei villaggi di accoglienza dei lavoratori immigrati in California e di aiutarli a ottenere lavoro sfuggendo al ricatto dei proprietari terrieri e dei loro sgherri.
Una testimonianza di questa impresa è stata data da John Steinbeck (1902-1968), giornalista del
San Francisco News, che aveva lavorato come contadino insieme ai migranti e ne conosceva quindi dolori e difficoltà. Il suo giornale pubblicò nel 1936 una serie di articoli di denuncia col titolo:
Gli zingari dei campi (
Harvest Gypsies), che furono poi trasformati nel romanzo
Furore (1939) da cui fu tratto l’omonimo film del 1940 con la regia di John Ford e l’interpretazione di Henry Fonda.
E’ la storia della famiglia Joad costretta ad abbandonare la piccola fattoria dell’Oklahoma e ad affrontare, su uno scalcinato furgoncino, carico delle poche masserizie, la lunga strada verso ovest; dopo varie peripezie e dopo aver attraversato l’ostile deserto dell’Arizona, all’arrivo in California gli Joad si scontrano con la dura realtà: i “caporali”, le basse paghe, l’ostilità degli abitanti e della polizia, passando da un ghetto all’altro alla ricerca di un ricovero. Finalmente la famiglia raggiunge uno dei campi della Resettlement Administration dove sembra trovino un momento di quiete, acqua corrente, gabinetti e delle docce con acqua calda. I proprietari terrieri mandano dei provocatori per creare disordini nella speranza di far intervenire la polizia per cercare di smantellare quel campo che faceva sfuggire gli immigrati allo sfruttamento. La Rural Resettlement Admninistration fu da molti considerata una iniziativa “comunista” che Roosevelt però difese con coraggio
Le disavventure della famiglia Joad sono fin toppo simili a quelle che abbiamo sotto gli occhi, facendo finta di non vedere. Poveretti che cercano rifugio in Europa, lavoratori clandestini che affollano le nostre campagne, specialmente nel Mezzogiorno, esposti a ricatti e costretti in rifugi che sono adatti più a bestie che ad esseri umani, in una società incapace di indignarsi benché sia grazie a loro che possiamo avere cibo abbondante sulle nostre tavole. La lotta al caporalato e alla precarietà del lavoro dovrebbe essere la bandiera di qualsiasi governo civile e non è questione di soldi ma di visione sociale della politica. Partirà in Italia, in Puglia, un “New Deal” come quello rooseveltiano con iniziative saldamente ispirate alla soluzione di concreti problemi, insieme, di occupazione e umani e ambientali?
L'articolo è stato inviato contemporaneamente a la Gazzetta del Mezzoggiorno
Riferimenti
La rinuncia da parte della società irlandese Petroceltic... (continua la lettura)
La rinuncia da parte della società irlandese Petroceltic alla concessione ottenuta dal governo italiano per prospezioni petrolifere al largo delle Tremiti e la rinuncia del miliardario neozelandese Michael Harte, manager di Barclays Bank, all’acquisto dell’isola di Budelli nell’arcipelago della Maddalena per farne “un museo all’aperto”, sono state accolte come due buone notizie da chi cerca di opporsi alla privatizzazione e alla devastazione ambientale del nostro mare.
Ma sono le isole veramente salve? Qualche dubbio sorge, se pensiamo che in entrambi i casi i progetti di sfruttamento sono stati accantonati per una unilaterale decisione degli investitori, che non giudicano più abbastanza attraente l’affare, e non per un atto di resipiscenza delle autorità italiane. Queste ultime, anzi, si sono dichiarate dispiaciute e accoglierebbero con favore un ripensamento dei privati.
Sembra che la Petrolceltic, che avrebbe dovuto pagare 1925 euro all’anno (pressappoco l’IMU di una seconda casa al mare) come “canone demaniale” per utilizzare “a scopo di ricerca”, cioè per “esplorare” con la devastante tecnica dell’air-gun una porzione di mare di 373 chilometri quadrati (vale a dire al costo di 5,16 euro per chilometro quadrato), si sia ritirata a causa della sua disastrosa situazione finanziaria. La ministra Federica Guidi ha espresso “rispetto per il passo indietro che risponde ad esigenze industriali strategiche della società”. Comunque, la Petroceltic non ci abbandona del tutto, perché manterrà gli altri titoli minerari che ha nell’Adriatico e in Valpadana, in un’ottica di “ottimizzazione strategica dell’intero portafoglio italiano”.
Non ci sono difficoltà finanziarie, invece, all’origine del ritiro di Harte che, nel 2013, si era aggiudicato Budelli per 2 milioni e novecentomila euro (160 ettari e 12 chilometri di costa) ad un’asta, dove la sua era stata l’unica offerta. Allora il governo Monti aveva rinunciato al diritto di prelazione e poi l’Ente Parco della Maddalena aveva tentato di subentrare al privato. Ne sono seguite una serie di vertenze legali, al termine delle quali il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto di Harte all’acquisizione della proprietà. Subito dopo la sentenza a lui favorevole, però, il miliardario ha rinunciato a perfezionare l’acquisto, non ravvisando “le condizioni per redigere il piano di conservazione e ricerca ambientale da lui auspicato”. L’attuazione del suo piano, in particolare, sarebbe ostacolata dal fatto che l’isola è una riserva “integrale”, mentre l’investitore chiede/pretende che il vincolo venga ridotto a quello di tutela “parziale”.
Con toni molto concilianti, il sindaco della Maddalena ha detto di voler tenere le «porte aperte a progetti di riqualificazione, valorizzazione e conservazione, perché il privato non va fatto scappare per principio, ma accompagnato all’interno delle norme» e di augurarsi che Harte “ritorni” per discutere “nuovi” progetti ambientali. Il progetto, ora sospeso, prevedeva la realizzazione di un ingresso, un’area di accesso, una rete di sentieri e camminamenti e un approdo per i barconi che portano i turisti al “museo”. Inoltre, prevedeva nuove costruzioni per ospitare un “centro di ricerca scientifica”, gestito da una apposita fondazione a partnership pubblico e privato, secondo un “modello di business” che, dice Harte, all’estero sta dando “grossi risultati”.
Nella non improbabile eventualità che il ricatto dell’investitore funzioni, può essere utile documentarsi sul modello di business a cui Harte si ispira.
Ocean Cay, nell’arcipelago delle Bahamas, a meno di 60 miglia da Miami, è uno dei molti esempi di isole non solo interamente cedute a privati, ma le cui successive trasformazioni sono tutte state decise da imprese straniere, che ne hanno incorporato i profitti lasciando alle popolazioni locali royalties ridicole e rilevanti esternalità negative.

Si tratta di un’isola artificiale, costruita negli anni ’70 e data in concessione all’americana Dillingham corporation come base per l’estrazione e lo stoccaggio di aragonite, un tipo di sabbia abbondante nelle acque delle Bahamas e particolarmente adatto “al mercato della Florida”. Nel 2000 la concessione è passata alla AES, un’altra società americana che intendeva installarvi un terminal per il trasporto di gas liquido e un rigassificatore. Infine, nel dicembre 2015, i diritti sull’isola, 38 ettari di superficie e 3 chilometri e mezzo di spiaggia, sono stati ceduti per 100 anni alla MSC Mediterranean Shipping Company che vi realizzerà un progetto per offrire ai suoi crocieristi “l’esperienza esclusiva di una riserva marina”.

Il programma di “riassetto naturalistico” di quella che si chiamerà Riserva Marina Ocean Cay MSC prevede la piantagione di 80 specie di piante indigene e la costruzione di un villaggio “architettonicamente fedele alle tradizioni bahamiane”, con bar e ristoranti che servono specialità locali, molti negozi, una struttura per matrimoni e ricevimenti, un’arena di 2000 posti per eventi musicali e spettacoli. Sarà creata una rete di sentieri per muoversi in bicicletta, mentre una teleferica consentirà di attraversare l’isola in “maniera emozionante”. Per i clienti delle crociere premium (per le quali si paga di più) sarà riservata una zona speciale, con cabine massaggio, bungalow privati e una beauty farm.

Nel ribadire la forte vocazione ambientalista della compagnia (la stessa le cui grandi navi infestano la laguna di Venezia) i rappresentanti della MSC hanno dichiarato di voler lavorare in contatto con il governo e le associazioni locali nel “rispetto della cultura e della tradizione delle Bahamas”. Il governo è d’accordo e molto soddisfatto, perché stima che la MSC porterà ogni anno almeno 500 mila turisti aggiuntivi alle Bahamas e che la Riserva creerà 600 posti di lavoro nella fase di costruzione e 250, che saranno addestrati dalla stessa MSC, quando le attività turistiche saranno a regime.
La costruzione di un molo esclusivo, al quale le navi rimarranno attraccate durante l’intera sosta, oltre che rispondere a una necessità funzionale intende sottolineare che l’isola è “un’estensione della crociera”, “un’integrazione dell’esperienza a bordo con un’esperienza autenticamente naturale a terra”.
Di fronte a questi “grossi risultati” si possono solo rileggere i versi di Derek Walcott, che nella poesia “Le acacie”, così esprime la sua angoscia di fronte alla valorizzazione dell’isola dei Caraibi dove è nato:
“guardavo gli ettari condannati dove costruiranno l’ennesimo hotel elitario con la gente comune sbarrata fuori. I nuovi artefici della nostra storia si arricchiscono senza rimorso e sono, in effetti, i profeti di una politica che farà dell’isola un centro commerciale, con i frangenti che sorridono come camerieri e tassisti, in queste nuove piantagioni sul mare; una schiavitù senza catene, senza sangue sparso- solo recinti metallici e cartelli, la nuova degradazione.
Addis Abbeba. Almeno 140 morti, centinaia di feriti e ... (continua)
Almeno 140 morti, centinaia di feriti e un numero imprecisato di arresti. E’ questo il bilancio di alcuni mesi di proteste popolari contro il piano regolatore di Addis Abeba e della brutale repressione messa in atto dal governo etiope. Le cifre del massacro sono riportate da molti organi di stampa internazionale che hanno seguito gli scontri tra polizia e manifestanti, ma non hanno suscitato l’interesse dei mezzi di informazione italiani. Peccato, perché dal perverso intreccio tra pianificazione del suolo, discriminazione sociale, affari e corruzione politica che connota la vicenda dell’Addis Abeba Integral Regional Development Plan avremmo molto da imparare.
L’Etiopia, uno dei paesi più poveri del mondo, è uno stato federale, suddiviso in nove regioni delimitate secondo criteri etnici e linguistici. La capitale Addis Abeba è anche la capitale di Oromia, il territorio storicamente abitato dagli Oromo, il gruppo etnico più numeroso (40% della popolazione) e in gran parte dedito all’agricoltura. Negli ultimi anni la città è cresciuta enormemente, ma allo stesso tempo si è verificata una costante diminuzione/espulsione degli abitanti Oromo.
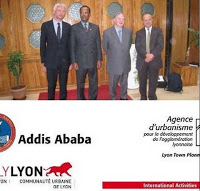
Come molte città africane per le quali gli investitori internazionali hanno grandi visioni e appetiti, Addis Abeba è oggetto di esercizi di pianificazione da parte della Banca Mondiale e di consulenti europei (Agenzia di urbanistica per lo sviluppo dell’agglomerazione di Lione) che hanno aiutato il governo etiope a predisporre un piano per far diventare “la capitale diplomatica dell’Africa” una metropoli “resiliente e competitiva a scala globale”. Tra gli obiettivi dichiarati ci sono, ovviamente, quelli di migliorare le condizioni di vita, garantire l’accesso ai servizi essenziali, connettere gli abitanti con le opportunità di sviluppo. Per raggiungerli, oltre ad una massiccia espansione edilizia e alla costruzione di infrastrutture di trasporto, da attuare con investimenti pubblici, il piano prevede un allargamento dei confini amministrativi della città, in conseguenza del quale il suo territorio si estenderebbe per 1 milione e centomila ettari, cioè venti volte la superficie attuale.
Ed è soprattutto questa decisione che ha scatenato la protesta, dapprima degli studenti universitari e poi di gruppi sempre più numerosi di Oromo, che hanno capito come l’ampliamento di Addis Abeba e la incorporazione nel suo territorio di città e distretti che ora fanno parte di Oromia non sia una scelta tecnica, fondata sulla ragionevole esigenza di una pianificazione territoriale a scala metropolitana, ma una scelta politica contro di loro e contro la Costituzione, che esplicitamente riconosce e tutela i diretti dei vari gruppi etnici, dalla libertà di insediamento all’uso della lingua nelle scuole. Per comprendere i verosimili effetti del piano regolatore, infatti, bisogna tener conto di alcuni elementi:
- dal 1975 la terra è stata nazionalizzata ed è di proprietà dello stato,
- da 22 anni sono al governo esponenti dell’etnia Tigrina che, malgrado sia minoritaria dal punto di vista numerico (4 milioni su 94 milioni di abitanti), alle ultime elezioni ha conquistato il 100% dei seggi in Parlamento, ed ha quindi un fortissimo potere politico e militare,
- l’espulsione e la cacciata dei contadini e l’appropriazione delle terre da loro coltivate da parte delle élites al potere o il loro trasferimento ad investitori stranieri è una pratica sempre più diffusa e ampiamente documentata da organizzazioni internazionali.
Già in passato, i tentativi degli Oromo di opporsi alla cacciata dai loro insediamenti e al ricollocamento forzato sono stati domati con violenza. Lo stesso è avvenuto quando una serie di incendi, si dice attizzati dallo stesso governo, hanno distrutto ampie porzioni di foresta, che sono poi state usate per installarvi attività inquinanti, discariche e impianti per la produzione di fertilizzanti. Ma quella ora in corso non è più solo una protesta per l’ennesimo episodio di land grabbing.
Anche grazie alla risonanza internazionale che la vicenda ha avuto- manifestazioni si sono svolte nel centro di Londra e di Washington- è diventata una lotta di resistenza contro la marginalizzazione economica, sociale, culturale e politica degli Oromo. E che si tratti di una vera e propria guerra lo conferma il fatto che solo in seguito ad una nota dell’ambasciata degli Stati Uniti, che ha invitato le autorità a sospendere l’attuazione del piano regolatore finché non sia stato raggiunto un accordo tra le parti, gli scontri sono temporaneamente cessati. Anche l’Unione Europea ha auspicato “un dialogo costruttivo”. Il governo etiope, quindi, si è dichiarato dispiaciuto perché ci sono state delle incomprensioni e si è impegnato a lavorare per “allargare il consenso” sul piano. In attesa delle prossime battaglie, gli Oromo seppelliscono i loro morti.
(continua a leggere)
Le lunghe settimane di caldo di questo inverno hanno riportato all’attenzione dei cittadini e dei governanti, nazionali e locali, il problema dell’inquinamento dell’aria delle città. In questi ultimi anni molte città si sono dotate di centraline in grado di misurare la concentrazione di alcune delle sostanze presenti nell’atmosfera e possono controllare se tali concentrazioni superano i limiti al di là dei quali gli inquinanti possono essere dannosi alla salute degli abitanti. Si è così visto che in un numero crescente di città, grandi e piccole, la concentrazione delle PM10, le “particelle” con diametro inferiore a 10 millesimi di millimetro, supera per molte settimane il limite massimo giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo di aria. Le principali fonti di PM10 sono state riconosciute nella combustione dei carburanti nei mezzi di trasporto e negli impianti di riscaldamento degli edifici: come rimedio è stato necessario imporre un qualche limite (sia pure molto modesto) alla circolazione di auto e camion in alcune ore e in alcuni giorni, e alla temperatura degli edifici.
Sono le leggi dell’ecologia a spiegare che dei limiti esistono nel funzionamento degli ecosistemi e anche la città è un ecosistema, sia pure artificiale, un organismo, con un suo metabolismo, che “vive” in uno spazio limitato. Nella città entrano materiali ed energia: acqua, alimenti (verdura, carne, cereali, cibo in scatola, eccetera), carta, materie plastiche, carburanti, materiali da costruzione; una parte di tali materiali resta "immobilizzata" entro la città: mobili, libri, i mattoni e il cemento negli edifici: la maggior parte dei materiali e dell'energia in entrata viene però rapidamente "consumata", cioè rielaborata --- per questo parlavo di “metabolismo urbano” --- e perciò trasformata in varie sostanze di rifiuto: quelle gassose come anidride carbonica, ossido di carbonio, polveri, anidride solforosa e altre, finiscono nell'atmosfera; i rifiuti organici e inorganici finiscono nelle fogne e vengono "esportati" fuori dalla città; i rifiuti solidi sono portati agli inceneritori e alle discariche, generalmente esterni alla città. Le scorie delle attività urbane --- a differenza di quelle che si formano negli ecosistemi naturali --- sono per lo più costituite da sostanze estranee ai cicli naturali e peggiorano la qualità dell'aria, delle acque, del suolo in cui vanno a finire.
In quanto ecosistema la città ha una sua popolazione, di esseri umani e di mezzi di trasporto, che cambia nelle varie ore del giorno; la mattina la città comincia a gonfiarsi di vita e di attività umane che aumentano col passare delle ore mentre la sua atmosfera si riempie di gas nocivi e le fogne di liquami, fino alla sera quando la città si sgonfia e raggiunge uno stato di quiete, per poche ore, per ricominciare la mattina dopo. La popolazione e le attività e le funzioni vitali di una città variano nei differenti mesi dell'anno. A causa del suo spazio limitato la città ha una “capacità ricettiva” di presenze umane, di traffico, di attività e di rifiuti; se questi superano certi valori la città non sa più dove mettere automobili, case e rifiuti e si verificano malattie e caos.
Per restare al caso dell’inquinamento dell’aria, se la quantità delle sostanze inquinanti che escono dai tubi di scappamento delle auto e dai camini degli impianti di riscaldamento supera quella che la massa di aria è in grado di disperdere o diluire, in particolari condizioni climatiche, la loro concentrazione diventa così alta da arrecare danno agli abitanti, proprio come sta avvenendo adesso per le PM10 in molte città dove circolano “troppi” autoveicoli rispetto a quelli che la città può sopportare. La quantità e il tipo di agenti inquinanti, a loro volta, dipendono dalla qualità delle materie usate. Ad esempio i diversi tipi di carburanti per autoveicoli --- benzina o diesel --- bruciando immettono nell'atmosfera composti molto diversi; le massime emissioni di agenti inquinanti per ciascun autoveicolo sono fissate dalle norme EURO, anche se la scoperta di recenti frodi ha mostrato che le quantità di inquinanti effettivamente immessi nell’aria da alcuni carburanti e autoveicoli può essere superiore a quanto dichiarato dai fabbricanti.
La vera soluzione delle crisi urbane, di inquinamento e di congestione del traffico, va cercata in un rilancio della cultura urbanistica, nella progettazione delle città tenendo conto dei bisogni di spazio, di mobilità e di salute dei cittadini e non del profitto dei proprietari dei suoli. I centri storici delle nostre città non sono in grado di sopportare il carico di traffico e inquinamento a cui sono sottoposti perché occupano lo stesso spazio di quando sono nati nel Medioevo o nell’Ottocento. Una moderna pianificazione urbana deve prevedere una diversa distribuzione nel territorio di abitazioni, uffici, scuole, centri commerciali, parcheggi e la riprogettazione dei trasporti pubblici. Certi servizi possono essere svolti lontano dai centri urbani, così come certi lavori possono essere svolti in uffici decentrati nelle zone abitative di periferia. Un alleggerimento dell’inquinamento dell’aria dovuto al traffico sarebbe realizzabile incentivando più lavoratori o studenti che fanno lo stesso percorso ad usare lo stesso mezzo di trasporto non solo per risparmiare qualche soldo, ma come contributo alla difesa della salute del prossimo. Insomma l’inquinamento urbano si sconfigge più con la capacità degli amministratori di conoscere, prevedere e prevenire il funzionamento delle loro città che con l’attesa di piogge che puliscano l’aria dalle polveri.
L'articolo è stato inviato contemporaneamente a La Gazzetta del Mezzogiorno
(continua a leggere)
«Vedo tanta fame d’Italia» ha dichiarato Matteo Renzi per magnificare i risultati del suo operato e le sue intenzioni per il futuro. E in effetti, non si può negare che molto abbia fatto e si accinga a fare per dar da mangiare agli affamati, che non sono, però, i poveri di cui parlano i gufi che vedono “tanta fame IN Italia”, ma gli investitori ed i gruppi finanziari dei quali si preoccupa di intercettare gli appetiti.
Fame d’Italia
Mentre la lista di fabbriche e di marchi ceduti all’estero continua ad allungarsi, sul fronte immobiliare non ha freni la gigantesca espropriazione ai danni degli italiani, affidata alla Cassa depositi e prestiti e ai vari organismi creati affinché operino come intermediari e facilitatori delle svendite di Stato. Le lussuose brochures pubblicitarie, con le quali promuovono le loro offerte, vengono riprodotte, e sempre favorevolmente commentate, dai principali mezzi di comunicazione.
Tra questi, particolarmente attento è il Sole 24 Ore, che dedica al settore “edilizia e territorio” articoli informati e in totale sintonia con le politiche urbane e territoriali del governo. Per limitarsi a pochi recenti esempi, nel pezzo Il resort nella centrale, dedicato alla riqualificazione delle centrali dell’Enel, si legge che quella di Porto Tolle potrà diventare uno «splendido resort di lusso con un ristorante sulla ciminiera alta 250 metri, più alta dei grattacieli di Milano, dalla quale nelle giornate terse si distingue di là dell’Adriatico il profilo dell’Istria» (10 dicembre 2015). «La città rinasce sui binari dismessi» annuncia con entusiasmo che nelle città italiane c’è «un tesoro nascosto di 6,6 milioni di metri quadri di aree o strutture ferroviarie dismesse pronte alla riqualificazione urbana» (16 dicembre 2015). Il Poligrafico dello Stato diventa un albergo cinese parla del radioso futuro del «bellissimo e gigantesco palazzo in posizione strategica per soggiornare, visitare, fare business nella capitale» (25 novembre 2015). Ma, più che singolarmente, è nel loro insieme che le analisi e le proposte del Sole sono interessanti, perché compongono un quadro unitario che difficilmente si trova nelle riviste d’architettura e d’urbanistica italiane che, spesso, tendono ad appassionarsi di fasulle polemiche estetiche e dei capricci delle archistar. Il quotidiano di Confindustria, invece, si concentra sul rapporto tra uso del suolo e denaro, nei suoi molteplici intrecci e nelle sue molteplici manifestazioni.
Un contributo che bene sintetizza il paradigma interpretativo adottato dal giornale e il modello operativo auspicato per aiutare «il comparto immobiliare ancora alle prese con una crisi lunga e grave, in un contesto in cui la carenza di risorse pubbliche si aggiunge alla paralisi amministrativa e all’ostinazione del popolo dei NO» è Territorio nuova ricchezza d’Italia di Francesco Prisco (5 ottobre 2015). Se il titolo può sembrare una banale ripetizione dell’abusato slogan “cultura petrolio della nazione”, in realtà l’autore ha la giusta consapevolezza che favorire un significativo salto di scala rispetto alla tradizionale speculazione immobiliare sia uno degli obiettivi perseguiti dal governo. Scrive, infatti, che non solo ora la grande sfida è «passare dal modello di valorizzazione dei singoli edifici alla valorizzazione di interi quartieri», ma tale sfida potrà essere vinta grazie allo Sblocca Italia.
Il giornalista non è l’unico a individuare “la chiave di volta per riqualificare interi quartieri” nel combinato disposto dell’articolo 24 («i comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da valorizzare») e dell’articolo 26 («per contribuire alla stabilità finanziaria nazionale e promuovere iniziative di rivalutazione del patrimonio volte allo sviluppo economico e sociale … si riconosce all’accordo di programma che si occupa del recupero di immobili pubblici non utilizzati il valore di variante urbanistica»).
In un altro articolo dello stesso 5 ottobre, simili considerazioni sono espresse da Alfredo Romeo, potente avvocato e immobiliarista napoletano, presidente dell’omonimo gruppo di “facility management” (gestione integrata dei servizi di complessi edilizi o di vere e proprie parti della città) che tra i suoi molti successi può vantare l’appalto per riscuotere i tributi per i comuni. Nell’intervista, pubblicata con l’eloquente titolo Patrimonio da valorizzare. I beni pubblici vadano a chi ha progetti migliori e offre nuovi servizi, Romeo, condannato, nel 2013, a due anni per corruzione e poi prosciolto in Cassazione, si dichiara convinto che «di fronte al campo d’azione sterminato dei quartieri e delle periferie degradate che non riescono ad esprimere il potenziale valore immobiliare …. tocca a noi operatori fornire proposte».
Il Manifesto di Romeo
Nel 2015 Romeo ha fondato ORP Osservatorio risorsa patrimonio Italia e stilato un Manifesto per diffondere «un nuovo pensiero sulla rigenerazione urbana e sulla gestione dei territori di particolare interesse per i decisori pubblici” che “circola nel mondo del real estate e delle amministrazioni pubbliche e sta raccogliendo adesioni e contributi accademici».
Il Sole 24 Ore ha accolto con favore il progetto (Nasce l’osservatorio risorsa patrimonio Italia per rilanciare gli investimenti nelle città, 29 luglio 2015) e, per divulgarlo, ha organizzato un seminario, “Gestire le città. La risorsa territorio per un new deal italiano”, i cui lavori sono stati moderati dal suo direttore, Roberto Napoletano (La chance della gestione delle città, 27 novembre 2015).
Sul concetto che sia arrivato il momento per «un new deal del real estate», ribadito da Romeo nel suo intervento introduttivo, e sulla vision a cui si ispira il manifesto - «se il comune non riesce a gestire facciamo in modo di coinvolgere il privato» - si sono dichiarati d’accordo tutti i relatori, che rappresentavano i principali attori in grado di influenzare, se non di dettare, le politiche urbane in Italia (Assoimmobiliare, Cresme, Nomisma, Anci, CNR, commissione ambiente e territorio della Camera) nonché il sindaco di Firenze, Dario Nardella e Roberto Reggi, direttore generale dell'Agenzia del Demanio. Quest’ultimo ha spiegato come l’agenzia miri a «promuovere progetti di sviluppo immobiliari, supportando gli enti locali in termini know-how per la realizzazione concreta di tali iniziative grazie al coinvolgimento di investitori». Tra gli oratori figurava anche Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, con una relazione intitolata “Rispetto delle regole o regole da cambiare? Il diritto come motore o freno dell'economia” (Cantone: rilancio appalti solo con regole chiare, 28 novembre 2015).
Unanime è stato il plauso dei partecipanti a proposito degli strumenti individuati da Romeo per dare concretezza alla mission di “valorizzare pezzi di città”: “recuperare risorse, ad esempio, tributi, all’interno di un’area, e usarle all’interno dell’area stessa o creare vantaggi fiscali dove scattano accordi tra cittadini e investitori privati per progetti di riqualificazione … trattare il cambio d’uso non come una concessione burocratica, ma come provvedimento coerente e funzionale allo sviluppo del territorio … far si che la tutela del patrimonio storico e architettonico non significhi interdizione della fruizione”.
Il modello Insula
Al seminario è stata distribuita una pubblicazione delle Edizioni del Sole, Patrimonio Italia. La risorsa, nella quale si illustrano «modelli e prassi per riqualificare e valorizzare città e territori con una moderna partnership pubblico-privato» e si indicano come esempi di best practice l’Expo di Milano e Insula di Napoli. (Valorizzare i territori: i modelli da replicare, 27 novembre 2015).
Anche Insula è una creatura di Romeo, una tappa importante nei suoi complessi e controversi rapporti con il comune di Napoli dal quale aveva ottenuto, nel 1998, la gestione del patrimonio immobiliare, inclusa la manutenzione e la riscossione degli affitti. Nel 2012, alla scadenza del contratto, e non avendo il comune i soldi per pagare i “debiti” con l’imprenditore, Romeo si offrì di riqualificare, in cambio della gestione, il borgo dell’antica dogana, un’area fronte mare accanto al terminal crociere, nella quale sorge il grande albergo che possiede Romeo. Già allora la sua ricetta per riqualificare «un quartiere centrale che versa in condizioni di obsolescenza e per questo non può giovarsi delle sue enormi opportunità turistiche insite nella sua prossimità al centro città» era che le tasse pagate dai residenti di un’area venissero spese per i servizi all’interno della stessa. Il sindaco de Magistris è stato sul punto di accettare l’accordo, ma ha dovuto rinunciare per l’ostilità di gran parte dei cittadini alla privatizzazione, di fatto, di un pezzo di città.
Ora Romeo, oltre a rivendicare il merito di aver anticipato il “baratto fiscale” reso possibile dall’articolo 24 dello Sblocca Italia, ripropone l’intenzione di «intervenire su insule urbane delimitate, con caratteri omogenei o con una identificazione naturale nella percezione dei cittadini ed utenti, usando le entrate fiscali all’interno delle singole aree». Il valore attuale di Insula sarebbe di 390 milioni, ed il suo potenziale 580 milioni. Secondo Romeo, il beneficio economico della riqualificazione non deriverebbe solo dall’aumento del valore patrimoniale, ma da quello delle entrate fiscali che renderebbero l’area “autosufficiente” e in grado di migliorare i servizi dentro i propri confini. E’ una posizione che sembra destinata a vincere, perché ritagliare isole appetibili per gli investitori è la strategia urbana su cui puntano il governo e gli imprenditori che lo fiancheggiano (o viceversa). Anche il Sole approva «il modello insula: dove il quartiere è un condominio» (5 ottobre 2015).
Riferimenti
Sulla vicenda napoletana si vedano il commento di Antonio di Gennaro, la postilla
di Edoardo Salzano, gli articoli di Marco Demarco, Luigi De Falco, Antonio Tricomi e la lettera al direttore di Alfredo Romeo, raggiungibili QUI. Si veda inoltre Giunta De Magistris. Quel patto col diavolo che fa discutere Napoli di Andrea Fabozzi con le interviste al Sindaco Luigi De Magistris e a Vezio De Lucia. Numerosi altri articoli nell'archivio di eddyburg
...(continua a leggere)
La seconda ondata di riforma del Mibact ha sinora ottenuto l'insospettato risultato di mettere d’accordo fautori e critici su di un aspetto determinante: considerati nel loro insieme, il precedente decreto del luglio scorso e l’attuale, configurano non un semplice adeguamento a precedenti provvedimenti legislativi di altro soggetto (spending review, riforma della PA, legge di stabilità), ma un vero e proprio stravolgimento del Ministero creato da Giovanni Spadolini nel suo assetto generale e del sistema della tutela in Italia. È chiaro a tutti, dunque, che siamo di fronte ad un'operazione strutturale, che, per quanto attuata con strumenti legislativi e amministrativi impropri, poco coerenti nel loro insieme, e a forte rischio di anticostituzionalità, persegue obiettivi non di semplice aggiustamento - ammodernamento di un sistema, ma di un suo radicale ridimensionamento-mutazione.
In estrema sintesi, questi obiettivi possono essere riassunti come: la definitiva cesura fra tutela e valorizzazione, a tutto vantaggio di quest'ultima in termini di risorse di ogni livello; la gerarchizzazione del sistema, finalizzata ad un più facile controllo politico del processo decisionale; la compressione dei residui meccanismi di controllo e monitoraggio sul territorio, tale da comprometterne radicalmente l'efficacia nel contrasto allo sfruttamento speculativo del paesaggio.
In questa direzione vanno dunque interpretati, sia la nuova ondata di supermusei, cui si affiancano ora anche alcune preziosissime aree archeologiche, sia la soppressione delle stesse Soprintendenze Archeologiche che seguono la sorte di quelle storico artistiche. Si ritorna così alle Soprintendenze miste, di sabauda memoria, in cui un solo dirigente dovrà occuparsi dell'intero patrimonio culturale e paesaggistico dell'area assegnata (pari almeno al territorio di due o più province).
Lo immmaginereste mai? La giustificazione politica - per questa seconda tranche della riforma - è la "semplificazione", la parola d'ordine che scandisce almeno da vent'anni lo smontaggio sistematico dell'apparato statale e la distruzione delle sue capacità di riequilibrio sociale e di regolazione democratica. Le nuove Soprintendenze "olistiche" dovrebbero in sostanza meglio sostenere la pressione del silenzio - assenso e dell'incardinamento all'interno delle prefetture: misure entrambe partorite dallo stesso Governo che ora si inventa questi contrappesi.
Viene ripresa, a sostegno dell'unificazione, la tesi tanto cara a politici, stampa ed amministratori locali, secondo la quale gli organi di tutela sarebbero spesso in contrasto l'uno con l'altro, portatori, insomma di istanze diverse e per questo causa di ritardi incompatibili con le superiori ragioni dello sviluppo territoriale. Che si tratti di competenze diverse e che la stessa area-monumento, addirittura oggetto possa avere esigenze diverse a seconda di queste competenze, non è frutto del relativismo soggettivistico di singoli Soprintendenti o funzionari, ma semplice dato di fatto oggettivo. Altrettanto semplice - e rapidissima - la soluzione: laddove esistano dei contrasti di fronte a richieste di trasformazioni territoriali di ogni tipo, deve prevalere l'istanza di tutela più ampia e quindi il parere conformato al principio di massima precauzione.
Con questa riforma, invece, a decidere su queste richieste - qualunque sia il monumento /area interessata - sarà un unico Soprintendente di competenze fatalmente non adeguate alla complessità dei casi e, nella totalità delle situazioni territoriali attuali, privo di idonei strumenti, in termini di personale, archivi, laboratori, risorse economiche. E, per sovrannumero, a sua volta dipendente da un'autorità superiore - il Prefetto - del tutto ignaro dei contenuti tecnico scientifici e dei meccanismi che governano l'esercizio della tutela.
Il risultato finale sarà - inesorabilmente - quello di un appiattimento verso il basso del livello della tutela, con una inevitabile evoluzione della figura del Soprintendente Unico in quella di un mediatore fra le diverse esigenze e pressioni politiche del territorio di competenza. E ogni "mediazione" fatta sulla pelle del territorio è una mediazione al ribasso. Ed è anticostituzionale, come ci ha spiegato attraverso innumerevoli sentenze la Corte Costituzionale, ribadendo come il paesaggio costituisca un "valore primario e assoluto", la cui tutela "precede e comunque costituisce un limite agli altri interessi pubblici" (sentenza n. 367/2007).
Lungi dal porre un argine al silenzio-assenso e alla subordinazione delle Soprintendenze alle Prefetture - i nuovi Uffici Territoriali Unici - questa seconda fase delle riforma rischia di condannare alla definitiva paralisi strutture che da mesi - dall'entrata in vigore del DPCM 171/2014 - si dibattono in difficoltà gestionali drammatiche: senza alcuna chiarezza quanto ad organici, suddivisione di competenze e di risorse. L'entrata in vigore della prima fase della riforma, infatti, è avvenuta nel segno dell'improvvisazione e della mancanza di regole chiare e univoche ed ha mostrato, da subito, gravi carenze d'impianto. Invece di procedere ad una revisione - correzione di rotta, con questo nuovo decreto, si accelera verso l'entropia.
L'archeologia, in particolare, è, in questa seconda fase, il settore maggiormente interessato dai cambiamenti: non solo per la soppressione delle Soprintendenze archeologiche, ma per lo smembramento della più importante (e ricca) Soprintendenza Archeologica italiana, quella di Roma, ridotta ad uno spezzatino (progetto che meriterà un'analisi specifica). Non è tutto: a dir poco inquietante è la notizia, riportata da più fonti, secondo la quale nella nuova versione del Codice sugli appalti che si sta mettendo a punto, sarebbero eliminati gli articoli relativi all'archeologia preventiva, il ridotto apparato normativo che a tutt'oggi regola oltre 6000 cantieri di scavo all'anno. Già ultimi, fra i paesi europei, per quanto riguarda la legislazione di questo settore cruciale, unici ad averne limitato la validità alle sole opere pubbliche, arrivati, con 24 anni di ritardo, ad una ratifica della Convenzione di Malta di pura facciata, ci ritroveremmo, in questo caso, in una situazione di totale deregulation.
D'altro canto, anticipando, nell'agosto 2014, il famoso SbloccaItalia, il premier l'aveva annunciato col seguente slogan: "Mai più cantieri fermi per ritrovamenti archeologici" (La Repubblica, 15 agosto 2014). Quest'accanimento verso l'ultimo, seppur debole, ostacolo alle mani libere sul territorio, sarebbe dunque di diretta ispirazione renziana, come vociferano i rumors di Palazzo.
Se davvero il Ministro Franceschini ha “subito” questa riforma ha ora l'occasione -l'ultima – di dimostrare quanto davvero abbia a cuore la tutela del patrimonio e la difesa delle prerogative del suo Ministero. Blocchi quest'ultimo decreto, se non altro in nome della necessità di un confronto allargato con chi, negli ultimi decenni, ha retto sul campo - con pochi mezzi e ancor meno riconoscimenti - le sorti del nostro patrimonio culturale.
E magari - in quest'operazione di ascolto - sia affiancato da un Consiglio Superiore dei Beni Culturali, conscio del proprio ruolo.
In alternativa, ai membri del Consiglio, non rimarrebbe che una sola via d'uscita. E non sarebbe nemmeno difficile trovare modelli di riferimento, che, ad ogni buon conto, richiamiamo come ausilio alla memoria:
"Onorevole Signor Ministro,
[...] Le mie dimissioni sono dovute, in effetti, al disgusto per il modo come il Consiglio Superiore, che nel linguaggio burocratico è tuttavia designato come "Alto Consesso", viene fatto funzionare, con discredito per questo organo; e alla volontà di non condividere più oltre, anche in parte minima, la responsabilità che l'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti è costretta ad assumersi, e si assume, nella progressiva distruzione delle caratteristiche della civiltà artistica italiana. [...] Ma anche con l'attuale legislazione si potrebbe ottenere una salvaguardia molto più efficace, ove da parte della Direzione Generale e del Gabinetto vi fosse la effettiva e costante volontà di opporsi agli attentati che da tante parti vengono portati alle caratteristiche delle nostre città e del paesaggio italiano.
[...] Conosco perciò le pressioni che da parte di tutte le autorità della classe dirigente italiana (gruppi finanziari, autorità ecclesiastiche, prefetti, sindaci e parlamentari) vengono esercitate sui locali uffici e sul Ministero, sempre in un solo senso: perché, cioè, si deroghi alle leggi predisposte per la tutela artistica, storica e panoramica; so che i funzionari regionali delle nostre Soprintendenze conducono con tenacia e coscienza una lotta impari contro le pressioni e che la Direzione Generale potrebbe trovare il più valido appoggio nel Consiglio Superiore. Ma [...] il Consiglio Superiore è oggi tenuto [...] quale strumento per avallare e coprire decisioni già prese, spesso provocate da pressioni che possono dirsi politiche solo nel senso deteriore del termine, cioè del tutto particolaristico e clientelistico. L'esperienza , sempre più aggravata negli ultimi dieci anni, ha mostrato che nessuna seria garanzia è data ai componenti del Consiglio Superiore di trovare nell'autorità ministeriale la massima tutelatrice e interprete della legge nell'interesse comune.
[...] si pone il Consiglio Superiore dinanzi a decisioni già prese e a impegni già assunti nello stesso momento nel quale al Consiglio viene richiesto di pronunziarsi in merito. I casi del villaggio CEP di Sorgane e del cosiddetto Parco della CIA Appia sono, di tale prassi, solo gli esempi più clamorosi; [...]
Ma tutti coloro che hanno sensibilità storica e artistica e senso della decenza e che si preoccupano anche dell'importanza che nel nostro Paese assume l'elemento turistico, sanno, in Italia e ormai purtroppo anche fuori d'Italia, che l'Italia si sta distruggendo giorno per giorno, e che tale distruzione solo in casi isolatissimi è inevitabile conseguenza dei mutamenti tecnici, economici, e strutturali della civiltà moderna: nella maggior parte dei casi è conseguenza del prevalere degli interessi della speculazione privata e della grossolanità culturale della attuale classe dirigente italiana.
I due anni di appartenenza al Consiglio, mi hanno convinto della assoluta inefficacia della mia appartenenza a tale organismo e quindi ne traggo le logiche e oneste conseguenze."
Queste righe di inalterata attualità, quasi alla lettera, risalgono al 28 maggio 1960. Ed era un archeologo.
Ma soprattutto, era Ranuccio Bianchi Bandinelli.

Una sacrosanta risposta alla proposta del ministro renziano ai beni e alle attività culutrali di tagliare i monumenti dalle città e dai territori mercificandoli: "Quod non fecit Bondi fecit Franceschini". La Repubblica, 24 gennaio 2016
La domanda: ci conviene mettere a biglietto tutto il Patrimonio storico e artistico della Nazione?(articolo 9 della Costituzione) é saggio far pagare chi desidera andare a deporre una rosa sulla tomba di Raffaello, o un pensiero su quella di Vittorio Emanuele II, entrambi sepolti nel Pantheon di Roma, che contemporaneamente un monumento archeologico, una chiesa consacrata, un sacrario civile? La modernizzazione comporta necessariamente biglietterie all’ingresso di tutte le chiese storiche, dei conventi, delle biblioteche, degli archivi, degli ospedali monumentali, e domani magari alle porte di intere città, come Venezia?
I dubbi sono leciti. Perchè così facendo rischieremmo di spingere ancor di più l’economia culturale verso la passività della rendita.
Forse sarebbe preferibile fare esattamente il contrario, rendendo gratuito l’accesso ai grandi musei statali. Nel 2013 il gettito di questi ultimi è stato pari a 125.826.333 euro, ma allo Stato ne sono arrivati 104.333.063 (la differenza è andata agli oligopolisti delle concessioni): che è il costo di un singolo bombardiere F35. Il presidente del Consiglio ha giustamente detto di voler allineare la spesa militare e quella culturale: con meno di un terzo di quanto destinato all’assegno indiscriminato per il consumo culturale dei neo diciottenni, potremmo far entrare tutti gratis nei nostri musei. E l’economia indotta da un aumento del movimento dei cittadini verso il patrimonio darebbe frutti, anche fiscali, assai superiori al gettito dei biglietti.
Ma, soprattutto, nel nostro Paese come in nessun altro, il patrimonio culturale è fuso con lo spazio pubblico. Non c’è un vero confine tra il Pantheon e la sua piazza, ed eè vitale che si possa continuare a varcare liberamente quella porta bronzea: anche solo per continuare a passeggiare al coperto, anche solo per cinque minuti. Dobbiamo poter respirare liberamente la nostra storia: non possiamo spezzare questa quotidiana intimità diventando clienti anche nel cuore della nostra casa.
È difficile capirlo in un momento in cui l’unica bussola delle riforme dei Beni culturali, che si accavallano senza il tempo per valutarle, sembra l’espansione della valorizzazione, a spese della tutela e dell’educazione. Ma in gioco c’è l’idea stessa di cittadinanza: rendere più difficile l’accesso dei cittadini a un monumento identitario significa in qualche modo annullarne la forza.
Quando Urbano VIII Barberini portò via il bronzo dal tetto del Pantheon per farci cannoni (1625), disse che era “un tesoro nascosto, senza utile e senza uso”. Il popolo di Roma, visceralmente legato al monumento, si oppose alla messa a reddito, esclamando che quel che non fecero i barbari, avevano fatto i Barberini. Credo che oggi ci convenga pensare non come il papa, ma come il popolo: che g

Tra "devono" e "possono":ecco la differenza. «Secondo la norma varata dal governo, nel 2016 e 2017 tutta la liquidità incassata dagli enti locali attraverso gli oneri di urbanizzazione potrà essere spesa al di fuori dell’ambito di intervento edilizio relativo». Sbilanciamoci.info, 18 gennaio 2016
All’interno della legge “omnibus” di Stabilità, il governo Renzi si è occupato del tema degli oneri di urbanizzazione e del loro utilizzo da parte dei nostri Comuni. Il 31 dicembre scadeva l’ennesima proroga e ci attendevamo un decreto che andasse, finalmente, ad annullare la possibilità di destinare le somme versate da chi realizza un intervento edilizio per sostenere la spesa corrente delle magre casse comunali (anzichè essere correttamente riservate alle sole effettive opere di urbanizzazione). Il Governo ci ha regalato una bizzarra “polpetta avvelenata” da cui traiamo la consapevolezza che gli oneri di urbanizzazione non potranno più essere utilizzati per la “spesa corrente” del Comune, ma solo per “spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per le spese di progettazione delle opere pubbliche”.
Sembrerebbe la norma che tutti desideravamo. Ma, a ben leggere il testo della legge di Stabilità, la nostra gioia dura pochi istanti, in virtù anche di questa affermazione, discretamente sibillina, presente all’interno dei suoi 999 commi (ci riferiamo al comma 737 dell’art. 1 della L. 28/12/2015 n. 208): “… possono essere utilizzati per una quota pari al 100 % per le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per le spese di progettazione delle opere pubbliche”.
La nuova disposizione prevede, insomma, che i proventi “possano essere utilizzati”, ma non necessariamente che “debbono essere utilizzati” per gli scopi indicati.
In parole semplici, significa che lo Stato centrale ha deciso di non decidere e di lasciare ai Comuni il potere di stabilire come e dove utilizzare i denari freschi che chi intende costruire verserà nelle casse comunali. Fino, addirittura, al 100 % della somma incassata con gli oneri di urbanizzazione mentre, attualmente, vi era un limite al 75% del totale, che per i due terzi (il 50% del totale) potevano coprire in maniera indistinta le spese correnti del Comune e per il restante 25% le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
In virtù di questa decisione, nel 2016 e 2017 tutta la liquidità incassata dagli enti locali attraverso gli oneri di urbanizzazione potrà quindi essere spesa al di fuori dell’ambito di intervento edilizio relativo.
Facile prevedere che un nuovo quartiere, una nuova lottizzazione, un nuovo centro residenziale non vedranno interventi da parte dei Comuni, poiché le somme incassate potranno essere utilizzate per altro, anche se non più per il funzionamento dell’intera macchina comunale (ad esempio stipendi e servizi primari ai cittadini).
Per “l\e spese di progettazione delle opere pubbliche“, invece, sì! Dunque in maniera diretta per la realizzazione di infrastrutture, nuovi interventi sulla viabilità, tangenziali e chi più ne ha più ne metta.
Il Sole 24 Ore” così commenta: «Di certo non sarà difficile trovare la richiesta corrispondenza tra entrate e uscite, perché sotto la voce “manutenzioni del patrimonio” vi può rientrare pressoché tutto, dall’illuminazione pubblica all’edilizia scolastica, dagli automezzi agli edifici in genere»
Resta per noi positivo, certamente, il fatto che gli Enti locali non potranno più finanziare l’intera “macchina comunale” con il denaro fresco incassato attraverso gli oneri di urbanizzazione. Ma lo spazio decisionale lasciato ora in mano ai Comuni è pericoloso, sbagliato, pura eutanasia. Che provocherà enormi guai e non intacca il vero nodo del problema: il flusso di cassa fa (ancora e sempre) “gola” ai Comuni, che continueranno ad essere “costretti” a svendere ulteriori porzioni di territorio libero pur di finanziarsi. E gli enormi stock di edifici vuoti, sfitti, non utilizzati resteranno – immobili … – a puntellare le nostre sempre più desolate città.
Nei prossimi anni, quindi, sarà ancora più necessario che in ogni Comune i cittadini si impegnino a “decifrare” i bilanci consuntivi e previsionali del loro ente locale e ingaggino una concreta battaglia o una vera alleanza finalizzata ad azzerare preventivamente costi inutili, sprechi, disutilità, proponendo alternative.
Il nostro tossicodipendente ci aveva giurato che quello di ieri sarebbe stato il suo ultimo “buco”. In realtà ha solo smesso di prepararsi la siringa con la sua solita “roba”, sostituendola con un’altra sostanza. Probabilmente ancora più micidiale.
Il pusher è sempre lo stesso: lo Stato/Parlamento che mette a disposizione del tossicodipendente (il nostro Comune) norme che gli consentono di drogarsi ed acquistare la “roba” (risorse finanziarie da mettere in circolo per alimentare e sostenere la spesa corrente, svendendo il territorio …).
E il Comune ha ora una nuova norma dietro cui salvaguardarsi per evitare guai.
(Per chi volesse conoscere un po’ meglio la “storia” dell’utilizzo degli oneri di urbanizzazione, rimandiamo a questa sintetica traccia:http://www.altritasti.it/index.php/archivio/ambiente-e-territori-mainmenu-45/1257-le-casse-dei-comuni-gli-oneri-di-urbanizzazione-e-la-legge-bucalossi).
(continua a leggere)
150 anni fa il naturalista tedesco Ernst Haeckel (1834-1919) “inventò” il nome “ecologia” (dalle parole greche ecos, casa, comunità, ambiente e logos, descrizione) per indicare lo studio e la conoscenza dei rapporti fra gli esseri viventi e l’ambiente circostante. Ad ispirarlo era stata l’avventura umana e scientifica dell’inglese Charles Darwin (1809-1882); appassionato di biologia fin da ragazzo, dopo gli studi universitari, Darwin ebbe la fortuna di essere assunto, nel 1831, a ventidue anni, come assistente scientifico del capitano della nave Beagle che il ministero della marina britannico aveva incaricato di un viaggio lungo le coste dell’America meridionale e nelle isole del Pacifico, per conoscere risorse naturali vegetali, animali e minerali, e luoghi importanti per i futuri commerci del paese. In tale lungo viaggio, terminato nel 1836, Darwin ebbe modo di osservare i caratteri di specie vegetali e animali, molte fino allora sconosciute, e come i loro caratteri fossero influenzati dall’ambiente, dal clima e dalle risorse fisiche e biologiche disponibili.
Il nome ecologia ebbe fortuna fra i biologi ma restò poco diffuso nel grande pubblico. Nei decenni successivi furono approfonditi gli studi su numerosi ecosistemi, ma l’ecologia ebbe una “età dell’oro” (come l’ha chiamata l’ecologo italiano Franco Scudo (1935-1998)) negli anni venti e trenta del Novecento, dall’incontro fra biologi e matematici. Una multinazionale di scienziati, l’americano Alfred Lotka (1880-1949), l’italiano Vito Volterra (1860-1940), il sovietico Giorgi Gause (1910-1986), il russo-francese Vladimir Kostitzin (1883-1963), descrisse le “leggi” che regolano i rapporti fra diverse specie e popolazioni e il cibo e lo spazio disponibile.
Secondo l’adagio popolare che i pesci grandi mangiano i pesci piccoli, effettivamente nel mare i pesci di alcune specie (predatori) si nutrono di quelli di altre specie (prede); quando le prede sono abbondanti aumentano anche i predatori, ma se i predatori mangiano troppe prede, il numero delle prede diminuisce e diminuiscono anche i predatori che trovano meno cibo, con cicli di oscillazioni delle rispettive popolazioni. In altri casi gli organismi di due specie “collaborano” in “simbiosi” scambiandosi cibo e sostanze utili; oppure convivono facendosi concorrenza (proprio come le imprese in un mercato “economico”) per nutrirsi dello stesso cibo limitato; oppure una specie, quella dei parassiti, si nutre a spese di un’altra che ne soffre.
L’ecologia spiega anche perché una popolazione che vive in uno spazio e con cibo limitati, cresce fino a un certo ”limite” e poi decresce; e descrive i flussi di materia e di energia con cui i vegetali sono capaci di nutrirsi da soli (autotrofi) usando i gas dell’atmosfera e l’energia solare; come gli animali (eterotrofi) vivono soltanto nutrendosi di vegetali o anche di altri animali, e come, infine, le spoglie di vegetali e animali vengono rielaborate da organismi decompositori che liberano sostanze utili ad altra vita, tutti protagonisti dell’affascinante e terribile dramma della vita. In quello stesso periodo, nel 1924, fu creata anche la prima (rimasta unica fino al 1970) cattedra italiana di ecologia nell’Università di Perugia.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale l’ecologia aiutò a interpretare nuovi fenomeni: ci si chiese se la popolazione umana avrebbe potuto continuare a crescere rapidamente in un pianeta di dimensioni limitate; i rifiuti dei crescenti consumi umani stavano intossicando la natura; nuovi prodotti, come i pesticidi e le scorie nucleari, mettevano in pericolo la vita sull’intera Terra.
La generazione del “Sessantotto” scoprì nell’ecologia la bandiera di una contestazione della società dei consumi e del relativo inquinamento, della congestione delle megalopoli, dei nuovi veleni. L’apice dell’attenzione per l’ecologia si ebbe nel 1970 e la nuova parola significò aspirazione a “cose buone”, pulite. I venditori non persero tempo ad appiccicare il nome “ecologia”, ai detersivi, alla benzina, ai tessuti. Diecine di cattedre universitarie cambiarono nome e presero il nome di “ecologia”. L’ecologia entrò in Parlamento e ci fu perfino un breve “Ministero dell’ecologia”, ben presto soppresso; solo dopo vari anni sarebbe stato istituito un ministero ma questa volta “dell’ambiente”. Una rivista critica Ecologia sopravvisse solo due anni. Ben presto il potere economico riconobbe che questa gran passione per l’ecologia li costringeva a cambiare i cicli produttivi, a depurare i rifiuti, e a guadagnare di meno e la nuova parola fu bollata come ”sovversiva”. L’attenzione per l’ecologia declinò presto e nuovi aggettivi più accattivanti comparvero come “verde”, “sostenibile” e, più recentemente “biologico”, da associare al nome di prodotti commerciali che un venditore vuole dimostrare “buoni”.
E la povera ecologia che fine ha fatto, in questi anni in cui proprio le conoscenze ecologiche sarebbero in grado di suggerire azioni per contrastare l’erosione del suolo e i danni degli inquinamenti, per il corretto smaltimento dei rifiuti, nell’interesse del principale animale della Terra, l’”uomo” ? Ci voleva Papa Francesco per ricordare l’importanza dell’ecologia, come “ecologia umana”, nella sua enciclica Laudato si’. Io spero che gli ecologi, quelli veri, ritrovino la passione di far conoscere ad alta voce il contenuto e gli avvertimenti della loro disciplina la cui conoscenza, soltanto, offre le ricette per rallentare i guasti ambientali, a cominciare dagli inarrestabili mutamenti climatici. Dalla cultura ecologica trarrebbero stimolo e beneficio i legislatori, i governanti e anche gli economisti dal momento che i soldi si muovono soltanto accompagnando il flusso, ecologico, appunto, di materie prime, di merci e di rifiuti, attraverso l’ambente naturale abitato dall’uomo.
L'articolo è stato inviato contemporaneamente a La Gazzetta del Mezzogiorno

Intervista con Salvatore Settis di Valentina Porcheddu. «Si spazia dai benidel demanio in offerta alle ricostruzioni di Palmira in Trafalgar Square, a Londra.“Il rischio delle vendite? È che si pensi che lo Stato stia battendo in ritirata”». Il manifesto, 12 gennaio 2016 (m.p.r.)
È stato annunciato in questi giorni sulla stampa l’accordo per il riuso di beni pubblici mirato alla valorizzazione turistico-culturale e sottoscritto tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini, assieme al Presidente Anas Gianni Vittorio Armani e al Direttore dell’Agenzia del Demanio Roberto Reggi. Il programma di riqualificazione riguarda, oltre le 1.244 Case Cantoniere che l’Anas possiede su tutto il territorio nazionale, anche immobili di particolare interesse situati in prossimità di circuiti quali la Via Francigena o l’Appia antica. In attesa di poter valutare se il «formidabile brand» delle Case Cantoniere – così lo definisce Franceschini – si rivelerà una reale opportunità di sviluppo sociale, economico e culturale, ne abbiamo parlato con Salvatore Settis. L’archeologo e storico dell’arte, ex direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, ha partecipato l’8 gennaio a Roma ad un incontro a Palazzo Altemps per la presentazione del libro Villes en ruine: images, mémoires, métamorphoses (Éditions Hazan 2015), curato dallo stesso Settis e Monica Preti.
Centinaia di beni del demanio verranno progressivamente messi in vendita. Pensa che nell’elenco degli immobili possano esser inclusi anche edifici di valore storico artistico?
Moltissimi monumenti e persino giganteschi musei come la Galleria Doria Pamphili a Roma, sono già in mano ai privati. Occorrerà valutare di volta in volta se la privatizzazione può avere un effetto positivo sulla destinazione d’uso di un determinato edificio. Il Palazzo Serra di Cassano - uno dei palazzi più insigni della città di Napoli - deve la sua sopravvivenza all’Istituto di Studi Filosofici fondato da Gerardo Marotta, un istituto benemerito la cui presenza virtuosa ha dato negli ultimi dieci anni al palazzo Serra di Cassano una nuova funzione. Il rischio che c’è dietro a quest’operazione, lanciandola nel modo in cui è stato fatto, è che si radichi nell’opinione pubblica l’idea che lo Stato è in ritirata e che via via tutto quello che è pubblico possa diventare privato. Non credo che questa sia l’intenzione attuale di chi governa il demanio ma andrebbe precisato che mentre alcuni edifici possono essere dati in concessione con determinate regole, la gran parte degli edifici di proprietà pubblica devono restare tali e essere impiegati per il pubblico bene.
Il progetto lanciato dall’Agenzia del Demanio partirà dalle case cantoniere. Come reputa il loro uso a scopo turistico?
Avendo ormai perso la loro funzione, la trasformazione delle Case Cantoniere in infrastrutture di servizio o agriturismi, non può che esser positiva. D’altra parte, non possiamo immaginare che ognuna di esse diventi un museo, perché l’Italia ridotta a museo muore.
Così come gli stessi musei possono morire. Con la mostra «Serial Classic» - una delle dodici mostre del 2015 da ricordare secondo Forbes - allestita alla Fondazione Prada di Milano, lei ha dimostrato che l’arte antica è in grado di dialogare con l’arte contemporanea e, in un certo senso, anche con la moda. Iniziative meno raffinate della rassegna che ha curato con Anna Anguissola rischiano però, di far prevalere la creazione contemporanea, arrivando a snaturare l’opera antica. Qual è il confine da non superare per mantenere saldo il valore dell’arte del passato pur facendola rivivere nelle diverse forme del presente?
Le mostre di arte antica devono essere rigorosamente scientifiche, devono saper parlare agli specialisti e avere inoltre una capacità narrativa che si rivolge a un pubblico più ampio. Nella mostra Serial Classic ho cercato di seguire questi princìpi che per me sono regola assoluta. L’esposizione non aveva nulla a che vedere con la moda se non per il fatto che la Fondazione Prada esiste perché esiste la ditta Prada. Non sarebbe mai venuto in mente a me o a Miuccia Prada di realizzare una sfilata di moda in mezzo alle statue classiche. La rassegna ha riscosso successo perché le opere esposte sono state cucite fra loro secondo un filo narrativo intriso di storia e non solo di un’ammirazione iconica per una bellezza astratta.
A proposito di «bellezza iconica», in una recente campagna pubblicitaria sul web, divinità e personaggi mitologici rappresentati nei fregi del Partenone sono diventati «modelli» per Gucci. Lo considera un abuso?
Purché non danneggino le opere, non considero gravi questo genere di pratiche. Ma certamente non è questo il modo per dare all’arte antica un ruolo nella cultura contemporanea. Le opere d’arte, antiche o contemporanee, sono una sfida a capire e a pensare. Il compito dello storico o del curatore è di aiutare a raggiungere quest’obiettivo e non di incuriosire con delle stravaganze. Mettere dei boa di piume - com’è accaduto per i Bronzi di Riace fotografati da Gerald Bruneau al Museo di Reggio Calabria - attorno a una statua antica lo trovo frivolo, inutile e stolto.
Nel libro Sul buono e sul cattivo uso dei Bronzi di Riace (Donzelli 2015), ha usato i bronzi di Riace come paradigma dell’incapacità degli operatori culturali - primi fra tutti gli archeologi - a valorizzare le opere antiche inserendole in contesti che producano emozioni e, allo stesso tempo, consapevolezze. Anche gli ultimi grandi progetti pompeiani sembrano dimostrare che l’apparenza conti sempre più dei contenuti, tanto che il sito campano si è trasformato in scenografia per tribune politiche mentre altrove imperversano degrado e indifferenza. Come uscire da questo impasse che caratterizza tutto il patrimonio italiano, dalla gestione dei siti a quella dei musei?
Il caso di Pompei è emblematico. È chiaro che non si può risistemare un sito di enorme importanza e dimensioni in poco tempo ed è ovvio che man mano che si procede con i lavori ci siano delle inaugurazioni. Come diceva Ennio Flaiano, l’Italia è il paese delle inaugurazioni e succede che le autostrade siciliane - inaugurate sei volte - siano ancora chiuse. È inoltre una pessima abitudine della politica usare ogni circostanza per delle photo opportunities. Io credo che la vera sfida del progetto Pompei - ma ciò compete non tanto ai politici quanto al Soprintendente, che d’altra parte è archeologo di vaglia - sia di far capire che l’obiettivo a cui si mira è il restauro dell’intera città. Soltanto rendendo fruibile un pezzo di città e non un numero limitato di domus fotogeniche, si potrà contrastare il sospetto che i grandi progetti a Pompei siano un’operazione di facciata.
Come possono convivere il piano estetico e il piano della politica?
La tendenza a estetizzare l’arte antica o le rovine può indurre a vedere la bellezza anche nella distruzione. Qualcuno arrivò persino a considerare il crollo delle Torri Gemelle come una performance di terribile bellezza. Estetizzare la distruzione e, in generale, l’arte antica significa rinunciare alla responsabilità. Bisogna intendere la funzione intimamente politica dell’arte e delle immagini non nel senso del significato che la parola politica ha finito per assumere e dunque del mestiere di chi siede alla camera o al senato o nei governi regionali, ma intendendo la politica secondo la sua etimologia e genealogia culturale vale a dire il discorso dei cittadini all’interno della polis.
Non c’è nulla di più politico della rovina perché essa esprime una tensione fra chi l’ha voluta e chi l’ha fatta, fra chi ha voluto il monumento intero e chi l’ha distrutto. Un uso politico della rovina e dell’arte - ciò che ho tentato di evidenziare nella mostra Serial Classic - vuol dire collegare la percezione della rovina a un orizzonte di cittadinanza e diritti. Non farlo e trasformare tutto in icona, si tratti dei Bronzi di Riace o delle rovine di Palmira, vuol dire rinunciare alla responsabilità intellettuale sia dello specialista che del cittadino.
A Trafalgar Square verrà esposta una copia della porta del Tempio di Bêl di Palmira, l’unico elemento architettonico che ha resistito all’esplosione. Diverse università al mondo hanno progetti di restituzione in 3d della Città carovaniera e non è escluso che un giorno i monumenti distrutti dall’Isis vengano ricostruiti «in situ». È questo un modo «lecito» o utile per perpetuare una memoria o si tratta di una sorta di giustificazione, un modo per dire che tutto è ripetibile? Insomma, il «falso» può colmare la nostalgia e la perdita?
Credo che nulla possa sostituire un monumento importante che è andato perduto. A volte, però, ricostruirlo nel luogo in cui è stato distrutto ha un valore, per così dire, contestuale. Il campanile di San Marco a Venezia cadde nel 1902 senza fare vittime. Dopo una lunga discussione fu deciso di ricostruirlo com’era e dov’era non tanto per il campanile stesso ma perché l’immagine della piazza San Marco aveva bisogno di quell’elemento. Un altro esempio, che si avvicina maggiormente al caso di Palmira, è il ponte della Santa Trinità a Firenze, abbattuto durante la seconda guerra mondiale. Anche in questa circostanza, il ponte venne ricostruito non tanto per la sua architettura - per quanto essa fosse particolarmente sofisticata - ma piuttosto per ricucire il legame con la città. Riproporre un pezzo di Palmira a Trafalgar Square la vedo come un’installazione artistica e simbolica, una dichiarazione di principio che condanna la distruzione ma non pretende di sostituire l’originale.
 «Città&campagna. Si aprirà il 20, al Lingotto di Torino, il 53/mo Congresso mondiale dell’International Federation of Landscape Architects. Un'intervista con Anna Letizia Monti, alla guida dell'Associazione italiana di settore». Il manifesto, 16 aprile 2016 (c.m.c.)
«Città&campagna. Si aprirà il 20, al Lingotto di Torino, il 53/mo Congresso mondiale dell’International Federation of Landscape Architects. Un'intervista con Anna Letizia Monti, alla guida dell'Associazione italiana di settore». Il manifesto, 16 aprile 2016 (c.m.c.)