

Il manifesto, 15 gennaio 2016,
Il progetto di costruire un nuovo partito della sinistra italiana procede faticosamente; da una parte, c’è un’attesa diffusa, che rischia di essere frustrata: dall’altra, le cronache politiche si soffermano sulle schermaglie tra i vari gruppi che dovrebbero dar vita al processo costituente. Un osservatore esterno, per quanto partecipe, non può che restare perplesso; e così pure le migliaia di potenziali aderenti. Beninteso, i problemi da risolvere sono obiettivamente tanti e complessi, ma non si può pensare di risolverli tutti e subito: un concreto avvio del processo costituente del partito (un partito, non una qualche altra vaga formula) appare urgente, se si vogliono incanalare e valorizzare energie e volontà.Tra le questioni da affrontare, ancora largamente irrisolta è quella della cultura politica del nuovo soggetto, ossia di quell’insieme di idee e di principi, schemi interpretativi e modelli valutativi, che costituiscano una cornice condivisa e riconoscibile, sia per chi che al partito aderisce, sia per coloro che ad esso possono guardare con interesse. Il richiamo alle ragioni della sinistra, per quanto necessario, non è sufficiente: che tipo di partito si vuole? Posto che un partito di mera testimonianza, per quanto nobile, oggi non ha alcuna potenzialità espansiva, quale potrebbe essere il profilo ideale, politico e programmatico, del nuovo soggetto?
Per cominciare ad abbozzare una risposta, forse è opportuno, anche in modo provocatorio, dare qualche modesto consiglio. Intanto, si lasci da parte la «carta dei valori»: la si scriva pure, se si vuole, ma sapendo che serve a poco. In genere, non la legge nessuno (qualcuno si ricorda la carta dei valori del Pd, faticosamente elaborata nel 2006–7?). Si può anche scrivere di riconoscersi nei valori della «libertà, dell’uguaglianza e della fraternità», o nel «valore del lavoro»… già, e poi? «Libertà» e «uguaglianza» sono parole terribili, che riempiono intere biblioteche, ma resta per intero il problema di capire in che modo, ad esempio, un ideale egualitario si possa tradurre in un determinato programma politico.
Un partito non è una creatura effimera se è in grado di proporre un proprio discorso pubblico, ossia un insieme di idee capaci di orientare e formare l’opinione pubblica, di farsi «senso comune», e di misurarsi efficacemente con altre idee. E il discorso pubblico di un partito si articola attraverso tre livelli, tra loro strettamente legati:
1 Il primo è quello che possiamo definire una «filosofia pubblica»: non un ideale, o un modello astratto della società futura, ma un insieme di idee e di schemi interpretativi sulla società presente, sui suoi conflitti, sui potenziali mutamenti. Un partito si radica e ha una funzione se riesce ad alimentare un dibattito politico e culturale che faccia emergere visioni alternative e diverse del «bene comune» o dell’«interesse generale», diversi sistemi di idee e di immagini della società e delle finalità del suo possibile sviluppo, a cui una comunità politica può ispirarsi.
2 Il secondo è quello che possiamo definire il «profilo programmatico», su grandi questioni e grandi aree di problemi: ad esempio, un’idea del welfare, dei suoi principi, di come concepire e orientare le sue finalità e la sua gestione.
3 Il terzo livello è quello delle «politiche», cioè delle specifiche proposte con cui si articolano una «filosofia pubblica» e un «programma».
Ebbene, il nuovo partito sarà in grado di dire qualcosa su ciascuno di questi livelli? Certo, è un compito di lunga lena, non si può essere troppo esigenti nell’immediato. E non bisogna cedere alla demagogia imperante della comunicazione facile: per rispondere adeguatamente occorrono studi, analisi, documenti anche ponderosi e faticosi. Occorre partire da un documento politico, articolato e ben strutturato, sulle cui singole tesi o formulazioni si possa discutere, nero su bianco, proporre modifiche, facendo anche emergere le differenze che certo si può facilmente prevedere esistano, ma che è bene circoscrivere dentro una cornice condivisa.
 Ripresentiamo un testo su Pietro Ingrao scritto per questo sito il 6 aprile 2005. Già allora eravamo nella fase in cui molti - troppi - faticavano a credere che la politica sia un'attività nobile.
Ripresentiamo un testo su Pietro Ingrao scritto per questo sito il 6 aprile 2005. Già allora eravamo nella fase in cui molti - troppi - faticavano a credere che la politica sia un'attività nobile.
eddyburg, 28 settembre 2015 (reprint)
Pietro Ingrao significa politica come mestiere nobile. Politica aperta, perciò, su tre versanti.
Sul versante del forte radicamento a ideali di miglioramento delle condizioni della vita, materiale e morale, dell’umanità. Lavori per il tuo vicino, ma lavori insieme per il mandarino lontano del quale non ti è affatto indifferente la morte; lavori per l’uomo di oggi, e lavori per l’uomo di domani, dei “domani che cantano”. Pietro Ingrao è infatti comunista, e italiano. Di quei comunisti italiano che furono così profondamente diversi da moltissimi altri comunisti, e da moltissimi altri italiani, come Enrico Berlinguer orgogliosamente rivendicò. Di quelli che maturarono la propria coscienza morale, e fecero il loro apprendistato politico, negli anni della lotta clandestina, della Resistenza, della costruzione della democrazia in Italia.
Sul versante della capacità di parlare ai suoi simili, agli uomini e alle donne ai quali sa trasmettere, insieme alle idee, l’entusiasmo per esse, e su questa base l’impegno per la loro diffusione, per il loro trionfo. Sul versante, quindi, del dare mani e piedi alle idee. Ricordo un comizio con lui a Roma, Centocelle, nel 1966. Ero un giovane e sconosciuto candidato come indipendente per le comunali; per farmi conoscere mi facevano partecipare a qualche comizio con i compagni più amati: Giancarlo Pajetta, Giorgio Amendola, e lui, Ingrao. Ricordo il suo discorso, trascinante sugli ideali dell’internazionalismo e la solidarietà con i popoli oppressi; e ricordo come poi i compagni più giovani, alla fine, lo presero in spalla dal palco, lo portarono in trionfo mentre lui tentava di schivarsi.
E sul versante dell’analisi, dell’apprendimento, dell’ascolto. Anche qui, un altro ricordo. Nel 1969, alla vigilia del grande sciopero generale su quei medesimi temi, un convegno del PCI su casa, urbanistica, servizi, al Teatro Centrale a Roma, organizzato dal suo vice, il bravo Alarico Carrassi. Ero tra i relatori, Ingrao presiedeva; seduto ad un angolo del lungo tavolo sul podio prendeva diligentemente appunto di tutti gli interventi, su un grande quaderno formato protocollo. Le conclusioni furono assolutamente di merito, entrando in ciascuna delle questioni che erano state sollevate, delle proposte che erano state formulate, degli interventi che erano stati pronunciati. Il merito delle cose: al di là delle etichette, degli schieramenti, dello slogan facile, era questo che contava. Con la pazienza, l’attenzione ai linguaggi diversi da quelli a lui consueti, la capacità di ascoltare, di comprendere, di proporre una sintesi.
Si può essere d’accordo con lui o no, nelle singole scelte e posizioni (per esempio, non ero d’accordo con una certa sua resistenza alla linea di Berlinguer alla fine degli anni Settanta), ma è certamente un esempio per chiunque creda che la politica serve agli uomini, e perciò bisogna essere uomini compiuti per esercitare questo difficile mestiere: utile come pochi altri. (E aggiungo in limine: nel Partito comunista italiano un esempio, non un’eccezione).
Proviamo a metterci nei panni dei profughi e a ragionare con rigore e immaginazione; potremo finalmente comprendere quale potrebbe essere un futuro positivo per l'Europa. L'autore ci riesce. Il manifesto, 7 agosto 2015
Immaginate di essere uno dei profughi accatastati a Calais, all’ingresso dell’Eurotunnel, e che ogni notte cercate di attraversarlo infilandovi sotto il rimorchio di un camion, per venirne ogni volta respinti. Oppure un migrante imboscato ai confini di Melilla in attesa di trovare il modo di scavalcare la rete che vi impedisce di entrare in Spagna. O un profugo siriano o afghano in marcia attraverso le strade secondarie della Serbia con quel che resta della sua famiglia che non sa ancora che ai confini con l’Ungheria troverà una rete a impedirgli di varcare il confine. O un eritreo imbarcato a forza, dopo mesi di attesa e violenze, nella stiva di una carretta del mare, che sa già che forse affonderà con quella, ma non ha altra scelta. O una donna aggrappata con i suoi figli agli scogli di Ventimiglia.
E’ un esercizio dell’immaginazione difficile e i risultati sono comunque parziali. Ma bisogna cercare lo stesso di farlo, perché “mettersi nei panni degli altri” serve sia a dare basi concrete a solidarietà e convivenza, sia a capire un po’ meglio dove va il mondo. Per lo stesso motivo è utile provare a immaginare che cosa passa nella testa (vuota) di uno come Dijsselblöm o in quella (troppo piena) di uno come Schäuble per cercare di “comprendere” meglio dove va l’Europa. Non che, in entrambi i casi, questo esercizio sia di per sé sufficiente; ma è anche vero che nelle cose di cui parliamo o scriviamo è troppo spesso assente questo risvolto, questo lavorìo dell’immaginazione.
 Cambiare il mondo non è facile. «La sfida più grande: come fare procedere le cose dopo la fine della prima fase di entusiasmo, come fare il prossimo passo senza soccombere alla catastrofe della tentazione “totalitaria”. In breve, come superare Mandela senza diventare Mugabe».
Cambiare il mondo non è facile. «La sfida più grande: come fare procedere le cose dopo la fine della prima fase di entusiasmo, come fare il prossimo passo senza soccombere alla catastrofe della tentazione “totalitaria”. In breve, come superare Mandela senza diventare Mugabe».
Prima le persone online, 31 agosto 2015
«Sembrerebbe difficile nascondere un’organizzazione così grande come il Partito Comunista Cinese, ma questo coltiva con gran cura il suo ruolo dietro le quinte. Il personale di controllo dei dipartimenti del grande partito e i media mantengono volutamente un basso profilo pubblico. I comitati del partito (noti come ‘piccoli gruppi guida’) che indirizzano e dettano le politiche ai ministeri, che a loro volta hanno il compito di eseguirle, lavorano non visti, dietro le quinte. Nei media controllati dallo Stato si fa raramente riferimento alla composizione di tutti questi comitati e in molti casi perfino alla loro esistenza, men che meno alla discussione su come arrivano alle decisioni».
 «I giudici di Strasburgo hanno esplicitamente ricordato le loro precedenti decisioni sul riconoscimento delle unioni civili, sì che nessun potrà dirsi colto di sorpresa o invocare la necessità di un adeguato tempo di riflessione».
«I giudici di Strasburgo hanno esplicitamente ricordato le loro precedenti decisioni sul riconoscimento delle unioni civili, sì che nessun potrà dirsi colto di sorpresa o invocare la necessità di un adeguato tempo di riflessione».
La Repubblica, 22 luglio 2015 (m.p.r.)
La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo sui diritti da riconoscere alle unioni tra persone dello stesso sesso, che già suscita polemiche, era prevedibile per chi conosce la giurisprudenza di quella Corte, la sua evoluzione, le novità introdotte proprio in questa materia anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Interviene in un momento in cui la discussione si è fatta sempre più accesa dopo l’annuncio del Presidente del Consiglio di arrivare prima delle ferie parlamentari all’approvazione, almeno da parte di una delle Camere, di una legge in materia. Siamo di fronte ad un invito esplicito al legislatore italiano, con indicazioni importanti e che non possono essere trascurate.

Gli scorsi giorni hanno visto in Italia l’asfittico ripetersi del ciclo monotono «emergenza migranti», guerra fra poveri, strumentalizzazioni delle destre, nella fattispecie, Lega, Casa Pound, Fratelli d’Italia. Il ciclo ricalca uno schema che ha già dato ampie prove di sé nel corso di tutto il Novecento. Questo schema si nutre sempre dello stesso veleno: negativizzazione e criminalizzazione dell’altro in quanto tale.
Questo risultato si ottiene attraverso meccanismi retorici di falsificazione, di generalizzazione, attraverso la dilatazione e la manipolazione strumentale di dati statistici, attraverso la propagazione di allarmi sociali, l’evocazione di paure irrazionali e la contrapposizione ancestrale fra il noi e il loro come antagonismo fra il legittimo e l’illegittimo, fra la titolarità e la clandestinità. Da questo schema è espunto lo statuto universale di dignità dell’essere umano. La politica sta all’interno di questo circuito perverso o per sopravvivere alla prossima cosiddetta emergenza o per parassitare qualche vantaggio elettorale con la pretesa di ergersi a paladina degli autoctoni assediati dagli invasori.
Coloro che per origine ideale dovrebbero opporsi allo squallido trantran della politichetta come mestiere non hanno nessuna autorevolezza o credibilità per farlo, non sanno ergersi oltre lo status quo, oltre la routine mediatica. Alzare lo sguardo significa ricordare che solo quarant’anni fa, nelle terre del nord, gli «altri» erano i nostri cittadini meridionali, i terroni, ricordare che nel corso di cento anni (1870–1970) gli «altri» sono stati gli italiani, 30 milioni di emigranti (molti clandestini) nelle Americhe, in Europa e in Australia.
È necessario ricordare che cittadini autoctoni simili in tutto e per tutto a quelli che oggi nel Veneto e alle porte di Roma non vogliono nel loro quartiere un pugno di migranti africani, allora, con la stessa attitudine intollerante, non volevano gli italiani, li descrivevano come pericolosi, sporchi, violenti, criminali.
Chi oggi vuole respingere i migranti è portatore della stessa patologica mentalità di chi allora calunniava, insultava e voleva ricacciare in mare i nostri concittadini che non sfuggivano alle guerre ma alla fame endemica, alla disperazione sociale, alla mancanza di futuro.
Nell’alluvione di retorica e falsità che accompagnano il pensiero reazionario sulla «questione migranti» emerge come apoteosi del raggiro lo slogan frusto e truffaldino: «Aiutiamoli a casa loro». Ma certo! Aiutiamoli a casa loro. Allora c’è un solo modo per farlo: espellere dall’Africa ogni interesse colonialista.
Il colonialismo è stato, al di là di ogni possibile dubbio, il più vasto e perdurante crimine della storia dell’umanità. Il primo e più efferato criminale anche se non il solo è stato l’Occidente e, per nulla pentito persiste. Il crimine è perdurante e prosegue nel nostro tempo con le guerre «umanitarie» o preventive, con l’azione delle multinazionali, con la sottrazione delle risorse più preziose ai legittimi titolari, impedisce la sovranità alimentare, idrica, arraffa terre ed è in combutta con i governanti più corrotti e tirannici. Vediamo questi politicastri da quattro soldi se sono capaci di aiutarli a casa loro. Vediamo sotto i nostri occhi come sono capaci di contrastare la schiavizzazione dei lavoratori stranieri nei nostri campi di pomodori e nei nostri frutteti. Ma fra le devastazioni più imperdonabili con le quali la mentalità colonialista ha inquinato il rapporto fra uomini di culture diverse c’è la concezione dell’altro visto come minore, sottomettibile, diseguale.
Prima l’ideologia colonialista si è auto assegnata il compito di civilizzazione di altre culture definite unilateralmente come incivili, oggi che le conseguenze dell’infestazione coloniale portano grandi flussi migratori verso l’Europa, l’altro diventa indesiderabile, minaccioso, da respingere. Ovviamente colui che maggiormente viene ostracizzato è il più povero, il più disperato, mentre, per confondere le acque, ci si mostra disponibili ad accogliere colui che è provvisto di attributi accettabili. Il razzista e lo xenofobo odierni non vogliono essere definiti come tali, fingono di risentirsi contro chi li apostrofa con l’epiteto che danno mostra di ritenere insultante.
Ma oggi il vero spartiacque fra chi, diciamo, crede nella piena dignità ed integrità dell’essere umano e chi con variegate motivazioni, non lo crede risiede nelle contrapposte concezioni dell’emigrazione. Per chi accoglie in sé la dignità dell’altro come bene supremo, l’emigrazione è progetto di trasformazione per la costruzione di una società di giustizia e solidarietà. Per coloro che non percepiscono in sé l’accoglienza dell’altro come orizzonte verso cui mettersi in cammino l’emigrazione è problema, emergenza, turbativa, invasione.
Chi, individuo, associazione, partito o movimento sostiene la piena dignità dell’altro e prende sul serio la «Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo» ha il dovere di radicalizzare la propria perorazione chiedendo subito, come da tempo suggerisce il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l’abolizione universale del permesso di soggiorno. Il cammino sarà certo lungo ma è tempo di iniziarlo con decisione.
 Il testo di una nobile lettera, contro i respingimenti dei rifugiati alla frontiera con l’Italia, del principale sindacato dei ferrovieri francesi, scelta e tradotta da Maria Cristina Gibelli
Il testo di una nobile lettera, contro i respingimenti dei rifugiati alla frontiera con l’Italia, del principale sindacato dei ferrovieri francesi, scelta e tradotta da Maria Cristina Gibelli
Il principale sindacato dei ferrovieri francesi si ribella alla politica di respingimento dei rifugiati in atto alla frontiera con l’Italia e scrive una lettera al Presidente della SNCF (l’azienda nazionale delle ferrovie francesi), ricordando a lui, e quindi anche a Hollande e al ministro dell’Interno Bernard Cazeneuve, che fra il 1942 e il 1944, durante il governo di Vichy, 76.000 ebrei francesi furono deportati nei campi di sterminio nazisti utilizzando i treni merci delle ferrovie dello stato; e ricordando altresì che molti furono gli episodi di eroismo dei ferrovieri in difesa dei deportati. Ieri si era costretti a viaggiare verso la morte, oggi si impedisce di viaggiare verso la vita (m.c.g.).
Signor Presidente,
la Federazione CGT dei ferrovieri le ha scritto per esprimere la sua ira quando lei è andato a presentare le sue scuse negli Stati Uniti presso le lobby americane a proposito del ruolo giocato dalle ferrovie francesi durante la seconda guerra mondiale. Abbiamo detto che certamente la SNCF ha partecipato al trasporto dei deportati verso i campi di concentramento per ordine del governo di Vichy, ma sarebbe stato opportuno ricordare anche quanti ferrovieri, in maggioranza militanti della CGT, sono stati uccisi, feriti o internati per aver opposto resistenza.
Il governo francese si è impegnato per un rimborso rilevante (a priori, 60 milioni di euro) nei confronti dei deportati ebrei, o dei loro discendenti residenti negli Stati Uniti. Fino ad allora, la direzione della Ferrovie dello stato si era difesa sulla base del principio della requisizione obbligatoria imposta dallo Stato francese in quel periodo oscuro della nostra storia. Ma non dimentichiamoci che dei ferrovieri sono stati mandati a morte per aver rifiutato di obbedire, altri hanno svolto questo ignobile compito sotto la minaccia delle armi, altri ancora hanno organizzato l’evasione dei deportati a rischio della loro vita e hanno ottenuto la qualifica di “Giusti”.
Oggi si stanno costituendo delle associazioni per portare aiuto ai migranti che arrivano dall’Africa o dal Medio Oriente. E anche in queste organizzazioni sono impegnati dei ferrovieri per lo più aderenti alla CGT. Queste donne, questi bambini, questi uomini, spesso giovani, fuggono la guerra, la carestia e la morte; vanno in esilio perché braccati in quanto oppositori politici di dittature.
Sappiamo tutti che la situazione catastrofica dalla quale fuggono i migranti ha la sua origine nel capitalismo mondializzato e nella avidità delle grandi multinazionali. Sappiamo tutti che le potenze economiche del “mondo dei ricchi”, per lo più occidentali, obbediscono ciecamente alle imprese transnazionali che commerciano con dittatori e oppressori. Anche la stessa SNCF non firma forse contratti con alcune monarchie del Golfo o con lo Stato di Israele malgrado la sorte che esso riserva al popolo palestinese violando le convenzioni dell’ONU?
Ecco perché, e con estrema urgenza, occorre accogliere questi migranti, garantire loro sicurezza, cura e asilo in Europa; perché anche noi francesi abbiamo delle responsabilità nei confronti della politica internazionale portata avanti dal nostro governo e da alcune imprese nazionali.
Contemporaneamente, apprendiamo che la stazione ferroviaria di Menton Garavan, alla frontiera italiana, funziona come un “parco dei migranti” controllato dalle forze dell’ordine, per organizzare il respingimento di questi poveretti. Apprendiamo che i dirigenti locali della SNCF si nascondono dietro le ordinanze della prefettura per mettere questo luogo sotto il controllo della polizia, tutto come 70 anni fa. Forse può apparire aneddotico, ma apprendiamo che queste persone sono in regola con la SNCF perché sono titolari di un biglietto ferroviario che non gli è neppure stato rimborsato, mentre il prezzo di un biglietto costituisce per loro un impegno enorme data la situazione di estrema precarietà.
Signor Presidente, fra qualche anno uno dei vostri successori andrà a presentare le sue scuse sul suolo africano? O il principio di requisizione verrà di nuovo utilizzato per coprire fatti ignobili? Vi poniamo solennemente questa domanda e vi chiediamo di porla ai signori Hollande, Valls e Cazeneuve, Fabius e Macron nei loro rispettivi ruoli.
Ci auguriamo che lei si ribelli e faccia rapidamente opposizione a queste procedure riprovevoli e che la nostra Società porti soccorso e assistenza ai migranti e dia loro il diritto di viaggiare, piuttosto che servire una politica europea e francese che non si assume le sue responsabilità e non trova risposte altro che la repressione e la chiusura delle frontiere.
In certi casi, la disobbedienza è un dovere.
 «Non votano più. Perché non solo vanno trovate parole che scaldino il cuore e la mente, che dicano di mondi da cambiare, di giustizia da rivendicare, di lotte da sostenere. Servono volti che quelle parole, quei mondi, quelle lotte le rendano riconoscibili».
«Non votano più. Perché non solo vanno trovate parole che scaldino il cuore e la mente, che dicano di mondi da cambiare, di giustizia da rivendicare, di lotte da sostenere. Servono volti che quelle parole, quei mondi, quelle lotte le rendano riconoscibili».
Il manifesto, 21 giugno 2015
Un messaggio che va oltre il tracollo del Pd, travalica la baldanza della destra con la faccia feroce di Salvini e della Lega, il consolidamento nei territori dei M5S, proiettati su una dimensione di governo. Preferiscono di no, gli elettori e le elettrici di sinistra. Preferiscono non votare, e se votano, allora scelgono M5S. Almeno sembra utile.
È la fine non della storia, ma di una storia, proprio come se fosse una storia d’amore. E come nella fine degli amori quello che si perde sono le parole, i luoghi, i riti. Quello che aveva un senso unico e speciale, e brillava di una chiarezza luminosa di immediata comprensione, d’improvviso si spegne, ritorna parola e luogo anonimo, indistinguibile tra gli altri. Si scioglie il legame stringente, sembra che nulla riesca più ad accendere la passione. Rimangono ricordi, memorie, a volte brevi fiammate.
Il linguaggio amoroso restituisce e chiarisce più di altri, a me sembra, quanto avviene. E ben di più dell’uso indiscriminato della categoria dell’antipolitica rende ragione della fine dell’avventura. Non siamo negli anni Novanta, e neppure nel primo decennio del Duemila. Non è solo né principalmente il rancore, che tanto si è analizzato in passato, il motore della nuova astensione e dei nuovi flussi di voto. Gli elettori e le elettrici che hanno preferito di no, in questa tornata elettorale, quelli con radicate scelte di sinistra, come già si era visto in Emilia Romagna lo hanno fatto per scelta politica. Quasi un atto estremo, disperato, forse, ma l’unico possibile. Per dire che non ci credono più. Non credono più all’insieme di sigle che a ogni competizione elettorale si presentano a garantire con i loro richiami al passato comune la continuità di una storia. Perché in realtà non garantiscono nulla. Da tempo. Perché quella storia non c’è più.
È un punto di non ritorno, in cui è essenziale la comprensione di quanto avviene, nel gioco delle forze come nel dispiegarsi dei sentimenti. Per questo non è il momento di rinvii o indugi. Bisogna buttarsi nell’impresa, dove si è, come si è.
Non ci sono trucchi, formule magiche, autorità esterne che possano garantire alcunché. È l’atto di coraggio che il presente richiede. Quale impresa? Entrare con molta attenzione nello spazio vuoto che gli elettori hanno creato. Con l’atto netto, autorevole e umile di aprire ora, adesso un processo costituente, in un’assemblea entro luglio. Indetta da parte di chi c’è, ora, adesso: forze politiche, gruppi, associazioni, chi si muove nell’area aperta alla sinistra del Pd. Con la consapevolezza che il gesto – necessario – non è per nulla sufficiente. Per questo, tra le virtù richieste, l’umiltà è indispensabile. L’impresa più difficile è essere credibili e convincenti, mostrare nelle pratiche che non ci si muove in una logica pattizia, che non si tratta di manovre in vista di nuovi cartelli elettorali, per esempio per le elezioni della prossima primavera in comuni importanti come Milano e Napoli. Insomma, occorre un passo indietro. Bisogna agire il paradosso attuale, oggi assumersi responsabilità politica significa fare spazio, allargare, aprire. Non solo perché gli elettori non perdonano, quindi una scelta adottata per necessità tattica. Ma per convinzione intima, autentica. È la parte più difficile.
Perché non solo vanno trovate parole che scaldino il cuore e la mente, che dicano di mondi da cambiare, di giustizia da rivendicare, di lotte da sostenere. Servono volti che quelle parole, quei mondi, quelle lotte le rendano riconoscibili. Come in un romanzo, o in un film, o in una serie tv, sono i personaggi che danno gambe alla storia che si racconta. Che la rendono vera e potente, viva nella mente di chi partecipa. E visto che non scriviamo un romanzo, ma parliamo di vite, di dolori, di rabbia reale, sono le lotte in corso, i protagonisti e le protagoniste sociali a interpretare questa storia.
Tutto il movimento intorno alla scuola, compreso il sommovimento intorno alla pretesa «ideologia di genere», le lotte per la casa, la nuova attenzione ai beni comuni, il lavoro sempre più svalorizzato. Che qui, in Italia, si faccia fatica a fare spazio alle donne, che pure esistono, attive e autorevoli, fa parte del problema. Che sia così arduo creare una mobilitazione convinta intorno alla tragedia della migrazione dice fino a che punto sono logori i legami, i vincoli, perfino le scelte ideali. È tempo di un nuovo amore.
Non ho usato volutamente termini come coalizione sociale e coalizione politica, non ho parlato d’altro. Ciò che importa è lo spazio che si apre, in queste azioni che non possono che intrecciarsi. Da cui possono passare soggetti, movimenti, persone che da troppo tempo vivono altrove e altrimenti. Fino a quando si potrà dire: preferisco di sì.

Quale sarà il grave pericolo per i bambini che ieri ha fatto scendere in piazza decine di migliaia di persone al grido di “salviamo i nostri figli”?
A sentir loro è l’indistinzione dei sessi, che sarebbe la conseguenza sia di una educazione che insegni a maschi e femmine a rispettarsi reciprocamente e a non chiudersi (e non chiudere l’altra/o) in ruoli stereotipici e rigidi, sia del riconoscimento della omosessualità come un modo in cui può esprimersi la sessualità, della legittimità dei rapporti di amore e solidarietà tra persone dello stesso sesso e della loro capacità genitoriale. Stravolgendo le riflessioni di sociologhe/i, filosofe/ i, antropologhe/i, persino teologhe/i sul genere come costruzione storico-sociale che attribuisce ai due sessi capacità, destini (e poteri) diversi e spesso asimmetrici, attribuiscono ad una fantomatica “teoria del genere” e alla sua imposizione nelle scuole - e la parola gender spiccava ieri sui cartelloni innalzati in piazza - la negazione di ogni distinzione tra i sessi e la volontà di indirizzare i bambini e i ragazzi verso l’omosessualità o la transessualità, quasi che l’orientamento sessuale sia esito di scelte intenzionali e possa essere orientato dall’educazione.
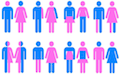 «Una manifestazione così massiccia come si è vista ieri a Roma contro «l’ideologia
«Una manifestazione così massiccia come si è vista ieri a Roma contro «l’ideologia
gender», ha fatto esplodere un sentimento covato da una parte consistente del mondo cattolico, ma senza input dall’alto, senza la mobilitazione partita dai pulpiti». Ne siamo proprio sicuri? Corriere della Sera, 21 giugno 2015 (m.p.r.)
Parte del mondo cattolico ha manifestato la sua disperazione culturale per un modo di vedere le cose, il demonizzato «gender», che sradica l’umanità da se stessa. È stata fornita un’immagine implicitamente polemica verso l’atteggiamento «accomodante» del Papa.
 «Con questa enciclica il gioco di far finta di non capire non sarà più possibile. Bisognerà stare o dalla parte di Francesco o contro di lui, perché sta chiedendo una scelta. E questo vale non solo per i politici, per gli opinionisti, per i giornali, vale anche per i vescovi, per i cardinali. E vale anche per i semplici fedeli».
«Con questa enciclica il gioco di far finta di non capire non sarà più possibile. Bisognerà stare o dalla parte di Francesco o contro di lui, perché sta chiedendo una scelta. E questo vale non solo per i politici, per gli opinionisti, per i giornali, vale anche per i vescovi, per i cardinali. E vale anche per i semplici fedeli».
Il manifesto, 19 giugno 2015 (m.p.r.)
C’è un debito estero dei Paesi poveri che non viene condonato, e anzi si è trasformato in uno strumento di controllo mediante cui i Paesi ricchi continuano a depredare e a tenere sotto scacco i Paesi impoveriti, dice il papa (e la Grecia è lì a testimoniare per lui). Ma il “debito ecologico” che il Nord ricco e dissipatore ha contratto nel tempo e soprattutto negli ultimi due secoli nei confronti del Sud che è stato spogliato, nei confronti dei poveri cui è negata perfino l’acqua per bere e nei confronti dell’intero pianeta avviato sempre più rapidamente al disastro ecologico, all’inabissamento delle città costiere, alla devastazione delle biodiversità, non viene pagato, dice il papa (e non c’è Troika o Eurozona o Banca Mondiale che muova un dito per esigerlo).
La denuncia del papa («il mio appello», dice Francesco) non è generica e rituale, come quella di una certa ecologia “superficiale ed apparente” che si limita a drammatizzare alcuni segni visibili di inquinamento e di degrado e magari si lancia nei nuovi affari dell’economia “verde”, ma è estremamente circostanziata e precisa: essa arriva a lamentare che la desertificazione delle terre del Sud causata dal vecchio colonialismo e dalle nuove multinazionali, provocando migrazioni di animali e vegetali necessari al nutrimento, costringe all’esodo anche le popolazioni ivi residenti; e questi migranti, in quanto vittime non di persecuzioni e guerre ma di una miseria aggravata dal degrado ambientale, non sono riconosciuti e accolti come rifugiati, ma sbattuti sugli scogli di Ventimiglia o al di là di muri che il mondo anche da poco approdato al privilegio si affretta ad alzare, come sta facendo l’Ungheria. L’«appello» del papa giunge poi fino ad accusare che lo sfruttamento delle risorse dei Paesi colonizzati o abusati è stato tale che dalle loro miniere d’oro e di rame sono state prelevate le ricchezze e in cambio si è lasciato loro l’inquinamento da mercurio e da diossido di zolfo serviti per l’estrazione.
Questa enciclica rappresenta un salto di qualità nella riflessione sull’ambiente, si potrebbe dire che apre una seconda fase nella elaborazione del discorso ecologico, così come accadde nel costituzionalismo quando dalla prima generazione dei diritti, quelli relativi alle libertà civili e politiche, si passò alla considerazione dei diritti di seconda e terza generazione, sociali, economici, ambientali, e cambiò il concetto stesso di democrazia.
Ora il discorso della giustizia sociale e della condizione dei poveri, a cui nei Paesi del Sud «l’accesso alla proprietà dei beni e delle risorse per soddisfare le proprie necessità vitali è vietato da un sistema di rapporti commerciali e di proprietà strutturalmente perversi», viene introdotto organicamente da papa Francesco nella questione ecologica, sicché essa non riguarda più semplicemente l’ambiente fisico, il suolo, l’aria, l’acqua, le foreste, le altre specie viventi, ma assume la vita e il destino di tutti gli esseri umani sulla terra, diventa un’«ecologia integrale», a cui è dedicato l’intero capitolo quarto dell’enciclica: «Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale», dice il papa; e la prima cosa da sapere, come dicono i vescovi boliviani ma anche molte altre Chiese, è che i primi a essere colpiti da «quello che sta succedendo alla nostra casa comune» sono i poveri. E il salto di qualità è anche nel rigore dell’analisi, nella cura con cui vengono ricercate tutte le connessioni tra i diversi fenomeni ed ecosistemi, e anche nell’onestà con cui si dice che non tutto possiamo sapere, che la scienza deve fare ancora un grande cammino, e che non si può presumere di prevedere gli sviluppi futuri, sicché il principio di precauzione diventa un obbligo di saggezza e di rispetto per l’umanità di domani, contro l’ideologia della ricerca immediata del profitto e dell’egoismo realizzato.
Si può capire allora come con questa enciclica che comincia con un cantico di san Francesco e finisce con una preghiera in forma di poesia, l’idillio del mondo ricco con papa Francesco sia finito. «Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra», dice il papa nella sua preghiera. «Non occuparti di politica, perché l’ambiente è politica», gli dicono i ricchi. E mentre da un lato quello che negli Stati Uniti non si fa chiamare Bush per riprendersi in famiglia il governo dell’America dice che non si farà dettare la sua agenda dal papa, dall’altro quello che da noi pubblica sulle sue felpe messaggi di razzismo e di guerra dice che non c’è proprio di che essere perdonati per le porte chiuse in faccia ai profughi e tutti i «clandestini» vorrebbe metterli a Santa Marta.
«Questo papa piace troppo» diceva la destra più zelante, allarmata al vedere masse intere di persone in tutto il mondo affascinate da un pensiero diverso dal pensiero unico. Però si faceva finta di niente, sperando che la gente non capisse. Il papa diceva che l’attuale sistema non ha volto e fini veramente umani, e stavano zitti. Diceva che questa economia uccide, e stavano zitti. Diceva che l’attuale società, in cui il denaro governa (Marx diceva «il capitale») è fondata sull’esclusione e lo scarto di milioni di persone, e stavano zitti. Diceva ai politici che erano corrotti, e stavano zitti. Diceva ai disoccupati di lottare per il lavoro e ai poveri di lottare contro l’ingiustizia, e facevano il Jobs Act.
Ma con questa enciclica il gioco di far finta di non capire non sarà più possibile. Bisognerà stare o dalla parte di Francesco o contro di lui, perché non sta facendo una predica, sta chiedendo una scelta. E questo vale non solo per i politici, per gli opinionisti, per i giornali, vale anche per i vescovi, per i cardinali. E vale anche per i semplici fedeli perché, scrive Francesco «dobbiamo riconoscere che alcuni cristiani impegnati e dediti alla preghiera, con il pretesto del realismo e della pragmaticità, spesso si fanno beffe delle preoccupazioni per l’ambiente».
Quello che infatti da Francesco è posto davanti al mondo è il problema vero: «il grido della terra» è anche il «grido dei poveri», ma nel monito che si leva dai poveri perché la loro vita non vada perduta, c’è un monito che riguarda tutti, perché senza un rimedio, senza un cambiamento, senza un’assunzione di responsabilità universale la vita di tutti sarà perduta.
Ed è per questo che l’enciclica di papa Francesco è rivolta a «ogni persona che abita questo pianeta»: non ai cattolici, e nemmeno agli «uomini di buona volontà», come faceva la «Pacem in terris» di Giovanni XXIII, in cui si poteva sospettare ancora un residuo di esclusione, nei confronti di qualcuno che eventualmente fosse di volontà non buona. Qui papa Francesco abbraccia veramente tutti (come ne sono figura essenzialissima per il cristiano le braccia di Cristo aperte sulla croce) e si pone non come capo di una Chiesa, e nemmeno come profeta dei credenti, ma come padre della intera umanità. Perché il messaggio è il seguente: non questa o quella Potenza o Istituzione, non questo o quello Stato, non quel partito o movimento, ma solo l’unità umana, solo la intera famiglia umana giuridicamente costituita e agente come soggetto politico può prendere in mano la terra e assicurarne la vita per l’attuale e le prossime generazioni.
 «Con la morte della discussione politica è morta per asfissia anche la mente collettiva, come soggetto critico». L'accettazione dello slogan della politica come cosa sporca e l'indifferenza nei coinfronti del genocidio dei profughi dalla misera e dalla guerra sono due facce della stessa medaglia.
«Con la morte della discussione politica è morta per asfissia anche la mente collettiva, come soggetto critico». L'accettazione dello slogan della politica come cosa sporca e l'indifferenza nei coinfronti del genocidio dei profughi dalla misera e dalla guerra sono due facce della stessa medaglia.
Il manifesto, 14 giugno 2015
Qualche giorno fa sul Corriere della sera è apparso un articolo che si interrogava sulle radici della corruzione dilagante in Italia. Giovanni Belardelli invitava a considerare le finalità perseguite da uomini politici «spinti in via esclusiva da miserabili aspirazioni di arricchimento personale» e puntava il dito sulla scadente qualità di una classe dirigente «priva di ogni aspirazione od obiettivo di natura politica, come non era invece nella Prima Repubblica». L’ascesa di una razza padrona del tutto indifferente alle sorti della cosa pubblica era indicata tra le cause principali del verminaio scoperchiato ogni giorno dalle cronache politico-giudiziarie.
In questo argomento c’è indubbiamente del vero, ma è probabile che esso vada sviluppato sino a coinvolgere gli stessi corpi sociali. Forse il tramonto della politica aiuta a comprendere un fenomeno tra i più allarmanti: che il paese convive pacificamente con quella cloaca a cielo aperto che in molti territori (a cominciare dalla capitale) e in tanti gangli dello Stato centrale ha di fatto sostituito le istituzioni della politica e dell’amministrazione pubblica. Certo non tutti appaiono cinicamente indifferenti. Ma anche la reazione antipolitica converge nella passività, tradendo un radicale disincanto. La politica appare ai più una «cosa sporca» con la quale il paese è costretto a convivere. Se pensiamo al trauma che fu, venti e rotti anni fa, la scoperta di Tangentopoli, non c’è paragone. Non solo la piaga della corruzione è oggi ben più vasta e infetta. Non c’è neppure l’ombra dell’indignazione che allora scosse l’opinione pubblica.
Il fatto è che se non c’è più la politica – il confronto tra culture, modelli di società, progetti, concezioni diverse dei valori e dei fini della convivenza civile – subentra il naturalismo. Ci si identifica immediatamente con l’esistente senza nemmeno immaginare la possibilità di un’alternativa. Magari si mugugna e si protesta, ciascuno nel suo piccolo. Ma intanto, forse inconsapevolmente, ci si rassegna, perché così va il mondo. Il tramonto della politica è la morte della critica, o nel silenzio del risentimento o nelle grida della deprecazione fine a se stessa.
Tutto ciò aiuta a spiegare anche un’altra vicenda sconvolgente all’ordine del giorno: la risposta vergognosa, inaudita delle leadership europee (a cominciare dai principali paesi dell’Unione) alla drammatica emergenza umanitaria costituita dall’arrivo in massa dei profughi dall’Africa. Che i Cameron, i Merkel, gli Hollande e i Rajoy, per non parlare dei commissari europei e degli altri capi di Stato e di governo, non siano dei giganti, non c’è dubbio. Ma bisogna riconoscere che essi non millantano affermando che, ove decidessero di coinvolgere i propri paesi in questa tragedia, rischierebbero di perdere buona parte del consenso di cui ancora godono, e farebbero per di più il gioco degli imprenditori politici del razzismo, del nazionalismo e della xenofobia.
Piaccia o meno, si tratta di un timore fondato e ciò dà la misura della gravità del problema con il quale si tratta di fare i conti. La fuga in massa dalla guerra, dal terrore, dalla miseria e dalla fame non si arresterà. L’Europa rimarrà a lungo per decine di milioni di persone una meta irrinunciabile. Il diritto di chi chiede asilo non è negoziabile, ma l’ipotesi di un’immigrazione illimitata non è realistica e il rischio di una reazione di stampo razzista e fascistoide in gran parte dei paesi europei appare concreto. Si può discutere fin che si vuole sulle responsabilità di questo stato di cose. Chiamare in causa chi nell’ultimo quarto di secolo ha contribuito a scatenare una guerra dopo l’altra tra Corno d’Africa e Asia centrale, passando per l’Iraq, i Balcani, la Libia e la Siria. Denunciare l’insipienza delle élite politiche europee che hanno sempre sottovalutato il problema, illudendosi di governarlo con misure di tamponamento. Resta che oggi nessuno sa come risolverlo senza violare i diritti dei migranti e al tempo stesso evitando in Europa terremoti sociali e politici che potrebbero resuscitare gli spettri più inquietanti del nostro passato.
L’Europa si è illusa di essersi liberata dal fardello della propria storia dopo la Seconda guerra mondiale. In realtà le ceneri dalle quali è rinata non contenevano soltanto la coscienza democratica e l’universalismo, l’illuminismo e la cultura dei diritti individuali e sociali, ma anche il colonialismo, il razzismo e la xenofobia, il nazionalismo e il comunitarismo. Nella tensione tra queste componenti dell’identità europea la rivoluzione neoliberale ha influito in modo decisivo. Non governati, gli spiriti animali hanno imposto un fine indiscutibile nell’impiego delle enormi risorse materiali e umane disponibili nel Vecchio continente. Hanno decretato il ridursi della politica ad amministrazione, asservendola alla sovranità del capitale privato. Come mostra da ultimo la guerra della troika contro la Grecia, hanno criminalizzato e messo al bando il confronto critico sui valori, i criteri di giudizio e i modelli sociali. Ma l’avvento della postdemocrazia tecnocratica ha comportato un prezzo elevatissimo in termini di consapevolezza e di responsabilità – di qualità etica – delle popolazioni.
Con la morte della discussione politica è morta per asfissia anche la mente collettiva, come soggetto critico. Le società europee ristagnano ormai da decenni in una morta gora e nei corpi sociali, terrorizzati dalla crisi e consegnati alla ripetizione di un eterno presente, dilagano le ansie e il rancore, e ferve una ricerca mal orientata di sicurezza. Ci si rinchiude ciascuno nel proprio micromondo privato. Il fuori inquieta, l’importante è non esserne sfiorati. A chi comanda – non importa se incapace o corrotto – non si chiede che di essere lasciati in pace. Ma così non solo la corruzione straripa, non solo l’umana pietà dilegua. Rischia di tornare anche la rimossa fascinazione di un’Europa fatta di caste e gerarchie e di comunità chiuse agli stranieri e ai diversi.
 «Un forte richiamo a non dimenticare il senso della parola "politica" e a comprendere qual'è il focus di una nuova sinistra: a uperare le contraddizioni che dividono le sinistre non può che essere la lotta contro l’incarnazione attuale del capitalismo, il neoliberismo
«Un forte richiamo a non dimenticare il senso della parola "politica" e a comprendere qual'è il focus di una nuova sinistra: a uperare le contraddizioni che dividono le sinistre non può che essere la lotta contro l’incarnazione attuale del capitalismo, il neoliberismo
». Il manifesto, 2 aprile 2015
Dalla polemica aperta su che cosa dovesse essere la “coalizione sociale” e che cosa non dovesse essere o diventare è emersa una questione che è di fondo. Nientemeno che quella di … che cosa sia la politica, fin dove si estenda, chi debba farla e chi no. Ed è sconfortante che sul significato, la portata, il denotato del termine la sinistra si possa dividere.
Sconfortante perché rivela che si è lasciata pervadere da una grossa mistificazione Quella che ritaglia la politica, la spezza, ne recinge l’estensione, il campo, ne limita l’oggetto per ridefinire il soggetto. E, conseguentemente, ne sceglie i contenuti definendoli leciti e li separa da quelli che condanna come illeciti, per poi dettare le forme attraverso cui solo la politica può dispiegarsi, selezionando in tal modo gli attori. Li divide, li separa, e, separandoli, fraziona insieme l’oggetto e il soggetto della politica. Soggetto ed oggetto che da Aristotele a Gramsci cento volte è mutato nei modi di configurarsi, mai nella sua essenza di pluralità umana accomunata da una storia e da un destino. La cui composizione ed il modo come si configura è l’oggetto della politica così come il suo soggetto. È chi, con chi e per chi e come gestisce, riproduce o modifica la configurazione di tale oggetto.
Sminuzzata, neutralizzata, liquidata e dissolta è oggi la soggettività popolare in Italia. Le leggi elettorali vigenti da venti anni (e con esse quella che Renzi sta imponendo all’Italia) non soltanto hanno distorto la rappresentanza, hanno dissolto il “rappresentato”. La trasformazione è stata duplice. Da strumento di espressione dei bisogni, delle aspettative, dei progetti di vita delle donne e degli uomini, la rappresentanza è stata convertita in dispositivo di appropriazione del potere di governo per uno uomo solo. Ne è derivata irrimediabilmente la dispersione del rappresentato e la sua condanna alla solitudine nel subire o il ricatto nelle fabbriche, o la degradazione nel precariato, o la disperazione nella disoccupazione permanente.
La solitudine ha prodotto la rottura del legame sociale. Il ricatto ha neutralizzato l’istanza a rivendicare nel luogo di lavoro condizioni di dignità. La degradazione e la disperazione hanno generato o rassegnazione e rinunzia a lottare per una prospettiva di uscita dallo stadio di depressione o concorrenza tra i degradati e i disperati nell’offrire forza-lavoro al prezzo più basso.
È questo lo stadio di regressione della condizione umana in Italia. Si sa che a determinarla contribuisce enormemente l’Europa della sovranità dei mercati. Ma è dal soggetto della politica e perciò della democrazia che bisogna partire ricostruendolo nella sua autenticità plurale e rifondandolo alla base della società come titolare di una rappresentanza che si imponga nel quotidiano della politica, rappresentandosi dove si decide. Ad unire, a superare le contraddizioni che dividono le sinistre non può che essere la lotta contro l’incarnazione attuale del capitalismo, il neoliberismo, dominante in Europa ed attuato in Italia. Il compito, la ragion d’essere della coalizione sociale dovrebbe essere proprio questo, la rifondazione nella società del soggetto che si oppone al capitalismo neoliberista e lo sfida
 «E sarà stridente ascoltare, dopo questa vicenda, le retoriche invocazioni sull’Europa di pace e prosperità. Anche questa è una guerra. Con vittime umane». Non una guerra, un suicidio collettivo.
«E sarà stridente ascoltare, dopo questa vicenda, le retoriche invocazioni sull’Europa di pace e prosperità. Anche questa è una guerra. Con vittime umane». Non una guerra, un suicidio collettivo.
Il manifesto, 13 marzo 2015
«Gliela faremo pagare». In questa frase che le cronache sull’ultima riunione dell’Eurogruppo ci rimandano c’è tutto il caso greco. Al di là di ogni questione di merito, è evidente che a Bruxelles si sta giocando una partita politica di massima importanza e che ci riguarda: bisogna punire chi, per la prima volta in 58 anni di storia, ha osato sfidare i vertici dell’Unione europea e ha messo in discussione i criteri di conduzione di quella che dovrebbe essere una comunità. Questo è quel che conta: non deve più accadere, chi ci ha provato deve essere punito. Guai se si aprisse un varco alla politica. Cioè alla condivisione.
Perciò il signor Jeroen Dijssebloem ha alzato il ditino per dire no, sette riforme non ci bastano, ne vogliamo venti. La prossima volta diranno 25, chissà. Contro Varoufakis ci sono diciassette robot che continuano a chiedere al governo Tsipras, forte di un appoggio popolare senza precedenti, di pagare per le malefatte accumulate da chi sarà pur greco, ma è compagno di partito, e di casta, proprio di chi vorrebbe impartire lezioni di moralità: i ministri del governo Samaras. Proprio nelle stesse ore in cui questa scena andava in onda uno di loro, anzi il più importante perché l’ex ministro delle Finanze, Gikas Hardouvelis, veniva accusato di aver esportato illegalmente 450 mila euro in un paradiso fiscale inglese. «Volevo mettere al sicuro il capitale per i miei figli», si è scusato. Poveretto.
Non sono passati neppure due mesi da quando inediti personaggi, diversissimi da chi da sempre aveva comandato il paese, hanno preso le redini della Grecia, trovandosi a dover gestire un immane disastro economico e ormai umanitario. Ma la meravigliosa Europa non è disponibile a dargli tempo affinché possano riparare e riavviare lo sviluppo del paese, nonostante sempre più numerosi siano gli avvertimenti di economisti europei ed americani, che invitano Bruxelles a ragionare anziché ad emettere editti imperiali.
La partita in atto è durissima. Del resto sapevamo che così sarebbe stato. Ma è stato fondamentale avere accettato la sfida. Per la Grecia e per tutti noi che vorremmo un’altra Europa. Finalmente la grande questione di cosa voglia dire essere una comunità, che è cosa diversa da un mercato, è stata posta sul tappeto. Non si potrà più nasconderla sotto. E sarà stridente ascoltare, dopo questa vicenda, ripetere le retoriche invocazioni sull’Europa che ha portato pace e prosperità. Anche questa in corso è una guerra. Con le sue vittime umane.
Ci sono perplessità, e anche critiche per come Varoufakis e Tsipras hanno condotto le cose? Sì, certo. Provenienti dal loro stesso partito e Consiglio dei ministri. È comprensibile. Credo però che esse siano ingiuste. Si tratta di una guerra di lunga durata, non di una rapida e conclusiva battaglia, destinata a conoscere arretramenti e passi in avanti, per molti versi una vera guerriglia. Ma bisogna tenere i nervi saldi: i risultati non possono esser misurati nell’immediato, è già una vittoria aver imposto un nuovo discorso, aver aperto contraddizioni (che nonostante l’apparente unità del fronte di Bruxelles già emergono), aver forse, anche questo per la prima volta, animato un movimento popolare davvero europeo in solidarietà con Syriza, su un tema che riguarda tutti. È già molto. Ha dato coraggio a tutti. Per questo ringraziamo i compagni di Syriza e li invitiamo a continuare.

Anche se posso sembrare grillino, che non sono, penso che poco a poco stia venendo fuori che le polemiche che ogni tanto Forza Italia fa con il governo è pura manfrina e che, come ho già scritto, se Renzi fa il “bravo” e attua il “programma”, il padrone di quel partito è disposto anche a sacrificare la sua creatura consentendo un travaso di voti al nuovo Pd.
L’attuale capo del governo e segretario del Pd dà sempre più l’impressione di essere etero diretto, di attuare un programma per conto di qualcuno, non sembra che porti avanti idee proprie, anche perché non so se sarebbe all’altezza di elaborarle.
Egli, e il suo principale antagonista attuale Salvini, sono cresciuti e si sono formati nell’epoca d’oro della Tv spazzatura. Se non erro, i giornali hanno riportato che entrambi hanno partecipato a quei programmi presi in giro da Arbore, dove rispondendo a domande come “quanto fa due più due” si potevano vincere milioni (“E’ così che si fanno i milioni, evviva le televisioni”, faceva cantare al coro il presentatore pugliese).
Berlusconi, grazie a quel tipo di Tv, ha costruito il suo impero economico e politico; poi, stanco, ha fatto andare avanti i suoi discepoli. Per chi ha avuto come mentore quella televisione, l’importante è avere sempre lo slogan giusto a portata di mano, tanto chi lo segue non andrà mai ad aprire un libro per documentarsi da sé, non andrà mai a verificare di persona se certe affermazioni corrispondono al vero, basta che la frase sintetica (il twitter) sia quella giusta.
E così Renzi può dire che la sua politica è a favore dei giovani, pur prendendo provvedimenti opposti, e i giovani gli credono. Salvini può dire che uscendo dall’Unione Europea staremo meglio e la gente gli crede. D’altro canto anche Mussolini diceva “spezzeremo i reni alla Grecia” o che “l’ora delle decisioni irrevocabili è giunta”, e la gente andava in estasi credendo che ci saremmo divisi il mondo noi e la Germania, salvo poi mandare in Russia soldati con le scarpe di cartone e con la raccomandazione di “portarsi una coperta da casa”.
A volte mi chiedo se ci sia una maledizione sulla testa di noi italiani: Crispi, Mussolini, Giannini, Craxi, Berlusconi, Renzi, Salvini. Politici che risolvono tutto nella parola che infatua le folle. Si dice: è il popolo italiano che è immaturo. Ma no! Il popolo è più o meno uguale dappertutto, quello che da noi è diversa è la cosiddetta classe dirigente, è questa che dovrebbe imprimere la svolta perché ne ha il potere e i mezzi. Ma purtroppo alla nostra borghesia danarosa, alla maggior parte dei nostri intellettuali, questa società, queste istituzioni, questi politici, vanno più che bene.
E i giovani continueranno a emigrare.

LE RECENTI vicissitudini del fondamentalismo islamico confermano la vecchia intuizione di Walter Benjamin, e cioè che «ogni ascesa del fascismo testimonia di una rivoluzione fallita»: l’ascesa del fascismo rappresenta il fallimento della sinistra, ma al contempo testimonia di un potenziale rivoluzionario, un malcontento che la sinistra non è stata in grado di mobilitare. Non vale lo stesso per il cosiddetto «islamofascismo» di oggi? L’ascesa dell’islamismo radicale non è forse in perfetta correlazione con la scomparsa della sinistra laica nei paesi musulmani? Quando, nella primavera del 2009, i Taliban si impadronirono della valle dello Swat in Pakistan, il New York Times riferì che essi avevano architettato «una rivolta di classe sfruttando le profonde divisioni tra un gruppo ristretto di ricchi proprietari terrieri e i loro fittavoli senza terra».
È un’osservazione di senso comune che lo Stato Islamico sia solo l’ultimo capitolo di una lunga storia di risvegli anticoloniali (stiamo assistendo alla riconfigurazione dei confini tracciati arbitrariamente dalle grandi potenze dopo la Prima guerra mondiale), e allo stesso tempo un nuovo capitolo della resistenza ai tentativi del capitale globale di minare il potere degli Statinazione. A provocare tanto timore e sgomento è invece un altro tratto del regime dello Stato Islamico: le dichiarazioni delle autorità dell’Is indicano chiaramente che, a loro giudizio, l’obiettivo principale del potere statale non è il benessere della popolazione (sanità, lotta alla denutrizione ecc.) — ciò che realmente conta è la vita religiosa, che ogni aspetto della vita pubblica si conformi ai precetti religiosi. È per questo che l’Is rimane più o meno indifferente alle catastrofi umanitarie che avvengono all’interno dei suoi confini — il suo motto è «occupati della religione e il benessere provvederà a sé stesso». Qui appare lo scarto tra l’idea di potere praticato dall’Is e il concetto, occidentale e moderno, di «biopotere», di potere che regola la vita: il califfato dell’Is rifiuta totalmente la nozione di biopotere.
 «Sembra che il decreto faccia proprio un sentimento fortemente radicato in alcuni strati (minoritari, ma influenti) della opinione pubblica in base al quale l’evasione fiscale può anche essere perseguita, ma comunque non può essere considerata un reato, la vittima è lo Stato, che diamine!».
«Sembra che il decreto faccia proprio un sentimento fortemente radicato in alcuni strati (minoritari, ma influenti) della opinione pubblica in base al quale l’evasione fiscale può anche essere perseguita, ma comunque non può essere considerata un reato, la vittima è lo Stato, che diamine!».
Lavoce.info, 7 gennaio 2015 (m.p.r.)
Il decreto sul penale tributario
Il decreto legislativo sul diritto penale tributario ha suscitato forti polemiche, tanto che il Consiglio dei ministri sarà chiamato a una nuova deliberazione. Tuttavia, al di là delle polemiche, sembra utile ragionare sulla ratio del provvedimento e sulle sue possibili conseguenze economiche. Secondo la teoria di base sull’evasione fiscale, l’entità e la certezza delle pene rappresentano un importante, anzi irrinunciabile, elemento di deterrenza nei confronti dei potenziali evasori. Se la sanzione, anziché solo pecuniaria, è anche penale e detentiva, l’effetto di deterrenza è ovviamente maggiore.
Nella situazione italiana attuale la percezione del cittadino comune nei confronti della normativa penale tributaria non è certo quella di un eccesso di severità; i detenuti per evasione fiscale (se esistono) non sono certo tanti da contribuire all’affollamento delle carceri. Quindi, l’attesa del cittadino comune non appare certo a favore di una generale depenalizzazione. È vero che in un paese ad alto tasso di illegalità fiscale bisogna evitare il rischio di ingolfare i tribunali con decine di migliaia di processi per evasione fiscale anche di modeste dimensioni, ma a questo fine è sufficiente prevedere limiti di punibilità adeguati e differenziati in base alla gravità del comportamento.
Comunque, è evidente che in questa materia sarebbe auspicabile una certa severità che, a rigor di logica, non dovrebbe essere inferiore a quella che si applica in altri paesi.
Depenalizzazione generalizzata
Il decreto nella formulazione uscita dal Consiglio dei ministri prevede invece una generale depenalizzazione di tutti i reati tributari. La prima questione che viene affrontata è quella del cosiddetto abuso del diritto, cioè dell’elusione fiscale, che viene totalmente depenalizzato (e a furor di popolo!). Se si guarda ai modelli degli economisti, in verità non è possibile riscontrare una differenza analitica tra evasione ed elusione fiscale: in ambedue i casi il contribuente evita di pagare le imposte dovute o violando direttamente la legge o schivandone sapientemente l’applicabilità. La sostanza non cambia; e infatti, non a caso, l’elusione viene definita “l’evasione dei ricchi”.
Naturalmente da un punto di vista giuridico si può sostenere che l’evasione è illegale e l’elusione no, ma questo è proprio l’argomento utilizzato dalle grandi multinazionali di internet nelle audizioni presso il Congresso americano per giustificare il fatto di non pagare praticamente imposte: “noi facciamo quello che le leggi dei diversi paesi ci consentono.”. Vi è quindi una certa contraddizione tra la decisione di depenalizzare tali comportamenti e al tempo stesso sostenere gli sforzi dell’Ocse e del G20 per venire a capo dell’elusione fiscale internazionale.
Le misure discutibili
Ma al di là dell’abuso del diritto che si esprime compiutamente nella eliminazione della “falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie” come fattispecie di reato, vi sono numerose altre misure inquietanti nel decreto:
1) Viene introdotto il limite di 1000 euro per la punibilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture false o simili, come se da un punto di vista logico in una ipotesi del genere l’ammontare potesse avere una qualche rilevanza.
2) Si depenalizzano tutte le operazioni di simulazione, interposizione di persona (giuridica) e frodi finanziarie, mediante uso di derivati, strumenti finanziari ibridi, eccetera, richiedendo a questo fine che esse abbiano dato luogo “a flussi finanziari annotati nelle strutture contabili”. Cioè sempre. Si vanificano quindi gli effetti penali di molte operazioni poste in essere dalle banche negli anni passati.
3) Si alzano le soglie di non punibilità da 50 a150mila euro con finalità deflattive dei processi, ma depenalizzando di fatto evasioni fino a 3-400mila euro di base imponibile, il che sembra eccessivo.
4) Si stabilisce la non punibilità della dichiarazione di costi non inerenti alla attività dell’impresa, e cioè della pratica molto diffusa di imputare come costi consumi personali o familiari del contribuente.
5) Ci si dimentica di inserire tra i reati punibili l’ipotesi di omessa dichiarazione da parte dei sostituti di imposta.
6) Si introduce una franchigia del 3 per cento del reddito dichiarato (e analogo limite per l’Iva) per la punibilità di tutti i reati, vanificando l’intero sistema delle soglie di esclusione su cui è costruito il decreto che così diventano inutili e di fatto variabili in base al reddito dei contribuenti (maggior reddito, maggiore possibilità di evasione).
7) Si elimina la possibilità del raddoppio dei termini di accertamento per i casi di frode fiscale, con il rischio di una perdita di gettito immediata (e poi permanente) di molti miliardi in quanto verrebbero vanificati moltissimi accertamenti.
In sostanza, sembra che il decreto faccia proprio un sentimento fortemente radicato in alcuni strati (minoritari, ma influenti) della opinione pubblica in base al quale l’evasione fiscale può anche essere perseguita, ma comunque non può essere considerata un reato, e non può essere equiparata ai comportamenti lesivi della proprietà privata (furto, rapina, eccetera): la vittima è lo Stato, che diamine!
Il rimpallo di responsabilità
Infine, è inquietante il fatto che la responsabilità delle modifiche al testo originario preparato da una Commissione presieduta da Franco Gallo, rimbalzi tra il Tesoro e Palazzo Chigi. Il ministero responsabile della formulazione del provvedimento e della sua presentazione al Consiglio dei ministri è infatti quello dell’Economia e delle finanze (di concerto con la Giustizia). Se il testo uscito dal Consiglio dei ministri è stato modificato, delle due l’una: o il ministro dell’Economia era d’accordo, o (ipotesi più grave) né lui né i suoi collaboratori si sono accorti che il testo era stato cambiato.
In conclusione, speriamo che superato lo sconcerto attuale si possa tornare a una soluzione equilibrata. Infatti non va dimenticato che la reputazione del nostro paese e del nostro sistema economico all’estero non dipende soltanto dalla maggiore o minore flessibilità del mercato del lavoro, ma anche, e soprattutto, dal grado di legalità (o illegalità) prevalente nel sistema: evasione fiscale, corruzione, bilanci falsi, malavita organizzata rappresentano handicap molto gravi per l’Italia. Dare l’impressione di allentare le misure di controllo anziché inasprirle è molto pericoloso.
 C'è qualcuno, in Italia, che vuole recuperare il ritardo della cultura nostrana rispetto a quella degli altri paesi del Primo e del Terzo mondo, nella ricerca sul lascito del grande intellettuale comunista. Si comincia dalle parole chiave. "egemonico/subalterno", "ideologia/egemonia", "società civile". Auguri di buon lavoro. Un articolo di Paolo Ercolani e un'intervista a Gianni Francioni.
C'è qualcuno, in Italia, che vuole recuperare il ritardo della cultura nostrana rispetto a quella degli altri paesi del Primo e del Terzo mondo, nella ricerca sul lascito del grande intellettuale comunista. Si comincia dalle parole chiave. "egemonico/subalterno", "ideologia/egemonia", "società civile". Auguri di buon lavoro. Un articolo di Paolo Ercolani e un'intervista a Gianni Francioni.
Il manifesto, 9 settembre 2014
«Paul Krugman ha parlato di «mezzogiornificazione» delle periferie continentali. Sarebbe utile ristudiare cosa è accaduto in Italia quando i governi incitavano a emigrare, esattamente come oggi nel sud Europa». Il manifesto, 18 aprile 2014 (m.p.r.)
Rispetto a questa unificazione europea, noi italiani abbiamo la dura e storica esperienza della nostra unificazione nazionale e dell’ormai famosa “questione meridionale”. Oggi siamo di fronte alla questione meridionale europea e questo giudizio non è solo mio ma, molto più autorevolmente, di Paul Krugman, premio Nobel per l’economia, che già nel 1991 ha messo in evidenza la «mezzogiornificazione» delle periferie europee, dimostrando che con la moneta unica l’Europa sarebbe stata investita da intensi processi di concentrazione della produzione e dell’occupazione nei paesi economicamente più forti, mentre le aree periferiche del continente europeo sarebbero state colpite da fenomeni di desertificazione produttiva e di migrazione verso l’estero.
La nostra questione meridionale nell’attuale situazione va ristudiata. Prima della nostra unità nazionale le regioni del sud, benché non come la Lombardia, non stavano tanto male: avevano la loro moneta e si proteggevano con le dogane e altro. Vale ricordare che il Regno di Napoli aveva un suo splendore e che in Italia la prima linea ferroviaria vide la luce in Campania, tra Napoli e Portici e che la città di Napoli aveva un prestigio internazionale. È con l’unità nazionale che le regioni del Sud vedono chiudere le industrie e vengono investite dalla fuga nell’emigrazione nelle Americhe e nel nord Europa. Una fuga migratoria – non va dimenticato — che si è ripetuta subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, prima che si pensasse a una pur modesta riforma agraria e alla Cassa del Mezzogiorno. «Imparate le lingue» consigliavano i ministri di allora quando si recavano nel sud, per incoraggiare i meridionali ad emigrare, ad andare a far funzionare le industrie del nord Italia, e del nord Europa. Ed è lo stesso fenomeno di oggi che coinvolge i cittadini dei Pigs. Per gli spagnoli e i portoghesi le vie dell’emigrazione sono le ex colonie, l’Angola, il Mozambico, il Brasile e i paesi latino-americani (non hanno nemmeno bisogno di imparare le lingue!). Per gli italiani e i greci resta il nord Europa, con il risultato che così si allarga il gap tra Mezzogiorno d’Europa e Nord.
Insomma l’unificazione europea non è ancora compiuta e già si è aperta una questione meridionale a livello continentale e molto più grave e pericolosa di quella italiana. E non dimentichiamo che non solo in Italia, ma anche in Spagna, Portogallo e Grecia ci sono stati governi fascisti. In Italia la questione meridionale si è aperta con uno stato unitario, con eguali diritti e doveri per tutti i cittadini e anche per tutte le banche. Uno stato unitario che produsse anche la Cassa del Mezzogiorno. Pensate se in Italia (come oggi in Europa) ci fosse stata solo l’unificazione monetaria: la lira valida in tutte le regioni, ma con l’autonomia legislativa di ciascuna regione. In questa ipotesi le regioni autonome del Mezzogiorno sarebbero state ancora di più condannate alla miseria. L’unificazione è solo monetaria, e quindi disastrosa, e al contrario di quel che ci insegnavano a scuola, non è più il sovrano che batte moneta, ma ormai sovrana è la moneta.
Si parla da alcuni anni di una trasformazione molecolare del modo di essere della politica e dell’etica pubblica nel nostro paese. La diagnosi si basa su alcuni segni distintivi riscontrabili all’interno dell’intero spettro politico e che appartengono al modo di operare in pubblico dei leader, allo stile del discorso dentro i partiti e nei media, alle pratiche di intervento nella sfera di formazione dell’opinione politica. Una trasformazione assai radicale della cui portata non ci rendiamo spesso conto perché è avvenuta gradualmente, in sordina. Essa si manifesta tra le altre cose nell’emergere di nuovi criteri generali nella valutazione dei fatti e nella scelta delle priorità politiche. Lo scontro di queste ore tra Matteo Renzi e Stefano Fassina è un episodio di questa più generale trasformazione. La più importante indicazione della quale è senza dubbio la pratica dirigenziale nell’uso degli organi della sfera pubblica, e cioè dei “corpi intermedi” del governo rappresentativo: i media e i partiti politici.
Chi voglia ricostruirne la genealogia dovrà partire ça va sans dire dalla rivoluzione berlusconiana, che consistette nella costruzione simultanea dell’impero mediatico e del partito-azienda. Al di là dell’unicità dell’impresa di Silvio Berlusconi, che rimane ineguagliata, resta il fatto che il modus operandi da essa inaugurato è diventato col tempo parte del comportamento pubblico: il successo politico gestito con uso dirigenziale dei corpi intermedi. Il modello privatistico dei comportamenti pubblici è la madre di una trasformazione che è diventata così profonda da essere quasi la nostra seconda natura, un costume normale che guida le azioni e le valutazioni politiche. Un modus operandi appunto, e che si avvale della democrazia dell’audience.
La democrazia dell’audience, cioè del pubblico che assiste allo spettacolo della politica, ha a poco a poco sostituito quella dell’identità di partito. Poco male, si dirà, anzi un segno di avanzamento democratico perché ha dimostrato che l’opinione della gente conta più di quella delle oligarchie di partito. Sennonché, l’idea che questo gentismo significhi più democrazia potrebbe valere al massimo nel mondo astratto della teoria. Nella realtà concreta, l’abito dirigistico che conquista l’audience può avere spiacevolissimi esiti se non incanalato da pratiche e regole virtuose che garantiscano sempre il pluralismo, il quale è l’anima della leadership, non il suo ostacolo. La vicenda italiana (che fa testo nei manuali universitari) parla per default di come la democrazia del pubblico rischi di trasformarsi in una mono-archia dell’opinione vincente nella gara del consenso mediatico
se non viene praticata l’arte del pluralismo, che è il bene primario da difendere affinché la democrazia sia “del” pubblico: questo è il primo comandamento del buon governo rappresentativo. Il pluralismo dei media e quello dei e nei partiti stanno insieme; essi corrispondono a un modus operandi che è diverso da quello dirigistico.
Ora, la creazione del partito-azienda, l’opera forse più rivoluzionaria nella storia della democrazia dei partiti, fu accompagnata da pratiche e comportamenti conseguenti, che inizialmente fecero scandalo e che si sono col tempo sedimentati nell’immaginario pubblico. Come per esempio il fatto che il capo di Forza Italia riunisse il partito in casa propria, ad Arcore prima e poi a Palazzo Grazioli, tanto che è probabile che pochi italiani sappiano dove si trovi la sede nazionale dei partiti gemmazione di Forza Italia. Un simile abito emerge nel Pd, la cui segreteria nazionale sente di potersi riunire nella sede dove il leader ha iniziato la sua corsa alla leadership del partito. Non si tratta questa volta di una sede privata. Ma è una sede comunque identificata con la dirigenza del leader.
Dirigere il partito è diventato col tempo simile a “tenere” il partito, non diversamente da come un bravo amministratore delegato “tiene” l’azienda che rappresenta (pur senza possedere): che significa, in senso classico, avere il controllo personale nel dettare l’agenda e nel selezionare il team più adatto a realizzarla. Il successo è più importante del modo in cui lo si ottiene; anzi liberare l’operato dagli orpelli delle regole di accountability appare come uno snellimento delle procedure per giungere a decisioni spedite. Abbiamo per anni denunziato il decisionismo dirigistico perché implicava prima di tutto la svalutazione del controllo, della dialettica interna al partito, della partecipazione delle varie opinioni alla costruzione della linea generale. Sono stati versati fiumi di inchiostro per sostenere la specificità della leadership politica rispetto ad altre. Una caratteristica di questa specificità sta nella libera discussione, che significa che il partito è luogo comune nel quale tutti, maggioranza e minoranza, possono sentirsi a casa propria (cosa non assimilabile al correntismo). Non è una questione di buonismo ma di logica della buona pratica, perché debilitare l’opposizione comporta inevitabilmente allentare il controllo sulla dirigenza che non essendo più incalzata e stimolata può perdere in energia innovativa. La trasformazione del partito per pratica dirigistica può rischiare di diventare un problema proprio per la leadership, poiché debilitare la critica indebolisce anche i vincitori più pugnaci.
Articolo tratto da "la Repubblica delle idee" qui raggiungibile in originale
 «Un'antica possibilità di difesa individuale e collettiva dal potere costituito contemplata sin dal medioevo che sempre più viene evocata nell'azione politica in un mondo dove poche istituzioni e imprese globali hanno messo all'angolo la sovranità nazionale».
«Un'antica possibilità di difesa individuale e collettiva dal potere costituito contemplata sin dal medioevo che sempre più viene evocata nell'azione politica in un mondo dove poche istituzioni e imprese globali hanno messo all'angolo la sovranità nazionale».
Il manifesto, 15 novembre 2013
Che cos'è il diritto di resistenza? Qual è il suo senso oggi? Esiste una interpretazione canonica di questo antico istituto avente per sua natura vocazione costituente? È possibile invocarlo oggi in modo rilevante, in via offensiva o difensiva, di fronte al protrarsi dell' illegalità costituzionale in tanti paesi europei incluso il nostro?
La ragione per aprire un dibattito su questo tema oggi è più profonda rispetto al fatto che episodi di ribellione «costituente» si stanno verificando un po' ovunque in Italia e che la magistratura e l'amministrazione stentano ad immaginare risposte diverse rispetto alla repressione penale. Infatti, da più parti è stato osservato che la crisi della sovranità statale ha determinato il risorgere di condizioni istituzionali «neo-medievali» nell'ambito delle quali si sta svolgendo un processo globale di concentrazione del potere dotato di valenza costituente. Proprio come nel corso della prima modernità gli Stati nazionali, pur con notevoli differenze l'uno rispetto l'altro, subivamo dall'alto la sfida dell'Impero e della Chiesa e dal basso quella delle rivolte contadine incentrate sui beni comuni, anche oggi, in piena postmodernità, la sovranità è contesa. I termini della contesa sono ovviamente diversi perché a metà del diciassettesimo secolo il capitalismo era nella sua fase nascente, mentre oggi è in una fase di tarda maturità in gran parte del mondo.
Tradizioni divergenti
La partita dunque è la concentrazione del potere in dimensioni più ampie rispetto alla statualità. Le soggettività sovranazionali in lotta, pubbliche o private, sono oggi immensamente più potenti in rapporto ai sovrani statali del Sacro Romano Impero, della Chiesa di Roma o delle Compagnie delle Indie. Quanto alle sfide «dal basso» è interessante domandarsi se la lunga stagione dei diritti e del costituzionalismo borghese le abbia rafforzate o piuttosto indebolite. È difficile negare che alcune garanzie costituzionali ed alcune innovazioni tecnologiche, prima fra tutti Internet, abbiano reso, almeno in certi contesti, la resistenza al potere costituito meno rischiosa di quanto non fosse un tempo. I contadini guidati da Thomas Muntzer e i Comuneros rivoltosi in Spagna nella prima parte del sedicesimo secolo, i Diggers e Levellers inglesi ai tempi dell'esercito di Cromwell oltre un secolo dopo e i Comunardi parigini rischiarono e subirono repressioni di durezza inaudita. Allo stesso tempo, però, l'appropriazione ideologica dell'illuminismo da parte del capitalismo realizzato e dei suoi cantori ha portato al trionfo ideologie individualizzanti che sono proprio quelle che hanno finito per depotenziare lo stesso senso del diritto di resistenza.
Vale perciò la pena di far tesoro delle conseguenze dell'apparente processo di democratizzazione del diritto di resistenza il quale fu teorizzato dal giusnaturalismo spagnolo, dalla tradizione calvinista e dalla distorsione interpretativa del pensiero luterano, nell'ambito di una visione dello Stato, della sovranità e del popolo molto diversa da quella moderna. Bisognerebbe tener presente che il filosofo e giurista francese Jean Bodin, arruolato fra gli inventori della sovranità moderna, considerava il corpo sociale non già come un aggregato di individui (come fece invece Thomas Hobbes) ma come un aggregato di «famiglie, collegi e corporazioni». In Spagna la stessa visione, condivisa dal giurista Francisco de Vitoria e dal gesuita Francisco Suarez (che da giurista cattolico invocò la resistenza anche armata contro Giacomo I d'Inghilterra che rivendicava sovranità divina) era quella neotomistica dello Stato come un corpo, unità organica.
Tale visione era accompagnata da una nozione trascendente di bene comune come qualcosa di diverso e superiore del semplice aggregato del bene individuale delle sue parti, portatrici di interessi divergenti che necessitavano di una sintesi. Il popolo, il cui governo era basato su leggi civili frutto di una cessione eterna di diritti naturali individuali al governante (era questa dell'irrevocabilità del consenso una visione condivisa dallo stesso Thomas Hobbes ma non da John Locke), era un corpo immortale superiore allo stesso Re. Gli individui muoiono ma il popolo come comunità rimane. Questa concezione del popolo rese possibile la convivenza di diritti naturali individuali con nozioni di sovranità assoluta, accompagnata tuttavia da un diritto di resistenza in casi estremi in cui il sovrano violasse profondamente le stesse ragioni che ne giustificavano il potere.
Durante la prima modernità questa concezione dello Stato, frutto di una visione medievale di diversi corpi politici in vario modo in conflitto per la sovranità, era ancora alla base tanto dei Cahiers de Doleance con cui gli avvocati del Terzo Stato rivendicavano sul finire del sedicesimo secolo di riequilibrare le disarmonie create dai privilegi eccessivi di clero e nobiltà, quanto delle stesse teoriche della resistenza, elaborate in Francia dai costituzionalisti ugonotti Francois Hotman, Theodore Beza (successore di Calvino a Ginevra) e Philippe Du Plessis Mornay, ai tempi delle guerre di religione esplose nel 1562. In tutte queste concezioni - spesso indicate come antenate del costituzionalismo borghese e che che affondavano le radici nella teorica di Niccolò Machiavelli - il diritto di resistenza non poteva configurarsi come individuale ma poteva soltanto appartenere a «magistrature inferiori» o «corpi collettivi» dotati di una pretesa di giurisdizione. Suarez per esempio riteneva necessaria l'autorizzazione del Papa per esercitare il diritto di resistenza; in ogni caso esso era riconosciuto con riluttanza estrema (da Lutero e fra i giuristi da Grotius); non era mai assegnato alla moltitudine popolare. La necessità di sterminare i ribelli, «come cani arrabbiati» secondo Lutero qualora questi si facessero portatori di istanze dal basso (come nel caso delle ribellioni contadine), pareva mettere d'accordo tutti. Fu la struttura istituzionale dell'Inghilterra a modificare in senso moderno il diritto di resistenza producendone quell'individualizzazione che soltanto superficialmente può considerarsi come una sua democratizzazione.
L'emancipazionismo liberale
In Inghilterra infatti la costruzione di uno Stato unitario fu compiuta molto presto e a differenza che in Spagna e Francia fu raggiunto fin dalla Magna Charta un accordo all'interno delle strutture dello Stato fra proprietà terriera e monarchia (naturalmente a spese dei beni comuni). La guerra civile e la Rivoluzione di Cromwell non furono dunque contese per definire quale fosse il luogo della sovranità (e dunque scontri costituenti) ma furono conflitti di potere anche molto aspri ma interni allo Stato costituito. Fu questa essenzialmente la ragione per cui nel sedicesimo secolo si sviluppò una tradizione di pensiero politico nell'ambito del quale gli individui senza mediazioni di corpi intermedi, potevano essere visti come parti costitutive della comunità statale (Commonwealth). Fu Sir Thomas Smith, ambasciatore di Elisabetta in Francia, in un libro pensato anche per il pubblico francese a definire il commonwealth o societé civil come «una società o un agire comune di una moltitudine di uomini liberi legati insieme da un comune accordo per la propria conservazione tanto in pace quanto in guerra», in contrasto chiarissimo con la visione di Bodin fondata sulle corporazioni.
Naturalmente, prima di salutare con il solito entusiasmo acritico le radici emancipative del pensiero liberale, occorre osservare come Smith mettesse in chiaro subito che ci sono uomini liberi che non contano, non governano, non votano, ma possono solo essere governati. Fra questi: «i lavoratori giornalieri, i mercanti e i commercianti che non hanno terra, gli artigiani e i contadini piccoli proprietari, i sarti, i calzolai, i carpentieri i muratori, i produttori di mattoni ecc.. questi non hanno né voce né autorità nel nostro commonwealth».
Nella gabbia dello Stato
È noto che fu l'individuo proprietario, principalmente il protocapitalista agrario, il protagonista vero della rivoluzione inglese, del protettorato di Cromwell e di quel grande compromesso del 1688 fra proprietà privata e sovranità pubblica «divisa» celebrato come rule of law. Il diritto di resistenza proprietario, mai proletario, venne mobilitato nel corso delle rivoluzioni del diciottesimo secolo e quando il suffragio elettorale fu finalmente esteso, a capitalismo ormai realizzato, la rule of law è stata guardiana, allora come oggi, di ogni ripensamento profondo dell'accumulo proprietario individuale. Doveva infine essere più di ogni altro John Locke a depotenziare attraverso un capolavoro di ipocrisia politica che gli fruttò fama eterna, ogni pretesa dei levellers (che comunque in gran parte non mettevano in discussione la proprietà privata ma lottavano per il suffragio elettorale) dei diggers e di ogni altra anelito di emancipazione dei subordinati. Egli chiuse così definitivamente, in solo apparente contrasto con Hobbes, la tenaglia dello stato e della proprietà privata su ogni istituzione del comune.
L'appropriazione capitalistica dell'illuminismo e la grossolanità di certa sua critica postmoderna, capace di appiattire luoghi e protagonisti quanto mai diversi, fece il resto fino a giustificare oggi visioni caricaturali dei beni comuni. In ogni caso adesso, quando non mi par tempo di moderazione, la sola politica degna di esser vissuta deve articolare nella teoria e nella prassi un diritto di resistenza collettivo che si emancipi dall'illusione individualistica e sappia interpretare la comunità come libertà.
 «In Italia esiste una messinscena della politica. Politica e' confronto tra idee e progetti. Oggi mancano le idee e i progetti, e a maggior ragione manca il confronto. Dunque, manca la politica». Un’intervista di Luana Milella a uno dei promotori del 12 ottobre prossimo.
«In Italia esiste una messinscena della politica. Politica e' confronto tra idee e progetti. Oggi mancano le idee e i progetti, e a maggior ragione manca il confronto. Dunque, manca la politica». Un’intervista di Luana Milella a uno dei promotori del 12 ottobre prossimo.
L’Unità, 6 ottobre 2013
Letta e la fine del ventennio? «Un’affermazione valida per la messinscena della politica». Lo scontro dentro il Pdl? «Vedo un tentativo di eliminare gli “incommoda”». Si va verso una nuova Repubblica? «Non vedo né la prima né la seconda né la terza». Berlusconi è finito? «Non mi interessa lui, ma i problemi che lui ha contribuito a creare». Il professor Gustavo Zagrebelsky non si smentisce. Caustico. Netto nel non assolvere “questa” politica. Ma pronto a negare la prospettiva di una prossima avventura nella politica.
Lei, Rodotà, don Ciotti, Landini e Carlassare. Nomi che fanno rumore se si ritrovano assieme. Come succede il 12 ottobre. Che accade, alla fine voi di Libertà e giustizia vi siete decisi a far nascere un nuovo partito?
«Sgomberiamo il campo fin da subito. La risposta è no e aggiungo, siccome da diverse parti si è fatto credere il contrario, che è un “no” evangelico: Quel che è sì è sì, quel che no è no, e tutto è opera del maligno ».
Però il Vangelo non mette mai un limite alla provvidenza...
«Se fosse sì, non sarebbe la provvidenza, ma la “sprovvidenza”. Ci mancherebbe solo che si pensasse di fare un nuovo, ulteriore, partitino».
Però... però... mi lasci dire, quando il manifesto dell’incontro, che non a caso si intitola “La via maestra”, parla di «miserie, ambizioni personali, rivalità di gruppi spacciate per affari di Stato» non può che venire in mente il rifiuto di “questa” politica. Che ne richiama una nuova.
«Certamente. Ma per operare un rinnovamento o addirittura un ribaltamento delle pratiche politiche e sociali che ci affliggono in questi anni non c’è bisogno “di nuovi soggetti politici” - espressione, tra le tante, che io odio -. C’è bisogno invece, secondo noi, che ciascuno, quale che sia il suo impegno nella società, faccia valere nelle sedi che gli sono proprie (politica, sindacato, cultura, scuola, tutto insomma ciò che ha riguardo con la vita civile) l’esigenza del rinnovamento. Comprenda e faccia comprendere che, continuando così, il nostro Paese si mette su un binario morto».
Lei, come sempre, è bravissimo nello scegliere espressioni e concetti forbiti, ma parliamo politichese: ci giura che un partito nuovo non nascerà?
«Nessuno di noi è profeta. Ma il 12 ottobre non c’è la fondazione di alcun partito. Anzi, il nostro intento è quello di raccogliere le preoccupazioni e le forze, non di dividerle ulteriormente».
Scusi se insisto, ma mi pare che qualcuno sia convinto che state proprio lavorando verso quell’approdo.
«Ribadisco, il nostro è un intento politico, ma non nel senso dei partiti. Se si può dir così, è un intento anche più ambizioso: lavorare alla rinascita di una politica, nel senso autentico della parola».
Lei non vede la politica “giusta” in Italia?
«In Italia esiste solo una messinscena della politica. La politica comporta il confronto tra idee e progetti. Oggi mancano le idee e i progetti, e a maggior ragione manca il confronto. Dunque, manca la politica. Venendo meno la politica, la democrazia stessa deperisce. Perché mai i cittadini si dovrebbero impegnare, anche solo nella cabina elettorale, se tanto tutto è destinato a restare quello che è? Viviamo da alcuni anni in stato di necessità. Ma la democrazia è lo stato della libertà».
Come mai, però, associazioni che pur avrebbero potuto rispondere al vostro appello solo rimaste silenti?
«L’adesione è larghissima. Chi si è tenuto in disparte, l’ha fatto, mi sia permesso di osservare, perché è caduto nell’equivoco del “nuovo soggetto politico”. Chiarito il quale, mi auguro che ci siano ripensamenti».
La nostra Costituzione. Lei torna lì, alla Carta del ‘48. Contestata, e che si cerca di riscrivere. Perché va tenuta ferma?
«C’è un paradosso. Tutti o quasi rendono omaggio alla prima parte della Costituzione, quella che tratta dei diritti, dei doveri, della giustizia, del lavoro, della libertà, della solidarietà. Quella parte descrive un tipo di società, molto lontana da quella in cui viviamo, che a noi invece pare tuttora di vivissima attualità. Proprio questa parte della Carta, però, è quella più largamente inattuata o violata. Le si può rendere omaggio in astratto perché ce ne si può dimenticare in concreto. C’è poi la seconda parte, che riguarda l’organizzazione della politica, e quindi i mezzi necessari per promuovere quel tipo di società. Oggi la discussione riguarda la riforma di questa seconda parte. Ma prima e seconda parte sono collegate e alcune delle modifiche che si prospettano, modifiche che definirei oligarchiche, si muovono nella direzione opposta all’attuazione della prima parte».
Costituzione e costituzionalisti. La Moralità pubblica. Che pensare quando si legge dello scandalo dei professori sotto accusa per i concorsi truccati?
«Nel campo universitario c’è un ineliminabile aspetto di cooptazione. Naturalmente, quella che dovrebbe essere cooptazione dei migliori può degenerare in corruzione. La linea di confine è labilissima. Anche se, oltre un certo limite, lo scandalo diventa evidente. Mi auguro che si chiarisca che quella linea di confine non è stata superata».
Letta ha detto che mercoledì «si è chiuso un ventennio». Alfano ha vinto su Berlusconi, il Parlamento ha confermato il governo. Davvero un ventennio è finito?«Chi e come lo si può dire?».
Letta lo dice.
«Temo che sia un’affermazione valida per la messinscena, quello che volgarmente si definisce il teatrino della politica. Quando evochiamo “ventenni” che si chiudono, credo che si debba pensare a quel rinnovamento profondo della politica di cui dicevo prima. Qualcuno potrebbe ipotizzare che si tratti solo di una razionalizzazione di ciò che ci sta appena alle spalle e che sta cercando di mettere ai margini gli “incommoda”».
A proposito di “incommoda”, guardiamo all’estate di Berlusconi, al disperato tentativo di evitare la condanna, una politica concentrata su questo mentre la gente è sempre più povera. Lei pensa davvero che si possa tornare indietro? Non c’è troppa prima repubblica, addirittura peggio della prima, in questa seconda?
«È difficile non vedere una profonda continuità nelle strutture e nelle concezioni profonde del potere politico, economico e sociale, e perfino criminale, della nostra società. Da questo punto di vista non c’è stata né una prima, né una seconda, né una terza Repubblica. Sono mutate le forme esteriori. Il 12 ottobre ci interrogheremo non sulle forme, ma sulla sostanza. E ci auguriamo che da qui possa nascere un vero rinnovamento».
Un giudizio flash su Berlusconi. È ancora “vivo” politicamente, ha ancora appeal da spendere o è politicamente già in archivio?
«A me non interessa tanto questo; mi interessa piuttosto che, Berlusconi o non Berlusconi, ci si occupi dei problemi del nostro Paese, la cui gravità Berlusconi ha contribuito ad accentuare e che rimarranno tali e quali davanti a noi, anche senza di lui».
Lo spauracchio delle elezioni. Minacciato da mesi. Che vantaggi avrebbero gli italiani da un nuovo voto?
«Un voto che riproduca la situazione attuale non serve a niente. Un voto che rimetta in moto il confronto politico sarebbe invece essenziale. Ma per questo occorrerebbe un’altra legge elettorale».
 Il mistero avvolge l’assenza del gesuita Paolo Dall’Oglio. Ne pubblichiamo un testo recente, parole difficili di un prete schierato a difesa del suo popolo, drammatico equilibrio tra partecipazione alla lotta armata e ricerca della pace sconfiggendo i fanatismi.
Il mistero avvolge l’assenza del gesuita Paolo Dall’Oglio. Ne pubblichiamo un testo recente, parole difficili di un prete schierato a difesa del suo popolo, drammatico equilibrio tra partecipazione alla lotta armata e ricerca della pace sconfiggendo i fanatismi.
Huffington post, 28 luglio 2013
(Padre Paolo Dall’Oglio, Huffington Post Italia). Un lettore desidera “la risposta del prete” alla questione sulla legittimità dell’uso della forza da parte della comunità internazionale per favorire il successo della rivoluzione democratica e islamista siriana.
Comincerò da prete e finirò da siriano. Nel mio cuore non c’è contraddizione.
La Chiesa conosce per esperienza dolorosa bimillenaria la debolezza del suo insegnamento sulla guerra giusta e la legittima difesa. Tuttavia, nonostante le riflessioni forti e utili in senso opposto, l’Autorità magisteriale ecclesiale ha sempre ritenuto di dover reinterpretare i versetti biblici che sembrerebbero consigliare ai cristiani di sottomettersi inermi e miti a mafie, regimi, imperi, colonie, feudalesimi, sistemi razzisti e via spadroneggiando. La Bibbia, di per sé ben contraddittoria, è letta in modo compatibile con il riconosciuto diritto-dovere di favorire la giustizia e, al limite, difenderla e promuoverla con le armi, per evitare la vittoria duratura del sopruso istituzionalizzato.
Con inspiegabile ritardo, la Chiesa si è ormai convinta che la democrazia faccia parte dei diritti inalienabili delle persone umane e che quindi, se da un lato è sicuramente meglio quando la si può difendere e ottenere in modo non violento, resta d’altro canto vero che l’uso della forza per difendere una democrazia in grave pericolo o liberarsi dalla dittatura è legittimo nel quadro dell’insegnamento cattolico. Esistono tuttavia delle condizioni da rispettare perché l’uso della forza resti legittimo… e questo da spazio a utili discussioni. Nel frattempo però vige il dovere per ciascuno nella situazione particolare di giudicare e di agire.
Quando dieci mesi fa il Papa Benedetto visitò il Libano disse, sicuramente per effetto delle opinioni dei prelati mediorientali favorevoli al regime del clan Assad, che era peccato mortale vendere le armi ai contendenti nella guerra intestina siriana. In quell’occasione twittai che se era peccato vendercele, allora bisognava darcele gratis! Visto che il regime torturatore, e distruttore del popolo con ogni mezzo, di armi ne ha più che abbastanza, per non parlare degli amici pronti a donargliele.
Sono sempre stato a favore delle azioni non violente per la rivendicazione e la promozione della giustizia. Tuttavia ciò non può giustificare una condanna della lotta dei siriani per la loro libertà, autodeterminazione e dignità umana. L’azione non violenta ha un significato ugualmente valido di accompagnamento, di correzione e di orizzonte prospettico per rompere il ciclo maledetto dell’odio armato.
Si registrano, è vero, delle derive criminali abominevoli in alcuni gruppi della rivoluzione siriana. Il fatto che siano probabilmente teleguidati dal regime non risolve il problema. È preciso dovere della comunità internazionale d’istituire fin d’ora una corte di giustizia per i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra in Siria. Essa sarà indipendente e perseguirà i crimini di tutti. Ciò che oggi ipocritamente e stupidamente si fa è il giustificare i crimini sistematici e istituzionali del regime con quelli episodici di gruppi e persone del campo rivoluzionario, commessi contro le stesse regole che il popolo insorto si è dato.
È lecito chiedersi se, vista l’orribile efficacia della repressione del regime siriano, nell’ambito dell’ignavia internazionale, non fosse più morale arrendersi al regime stesso per evitare il peggio. Certo questo corrisponderebbe eventualmente all’insegnamento etico ecclesiale sulla proporzionalità dell’uso della violenza, anche calcolato sulle possibilità ragionevoli di successo. Molti di noi si erano chiesti fin dall’inizio se fosse realistico insorgere in modo non violento contro un simile regime, ben conoscendone la crudeltà e mancanza di scrupoli. La deriva violenta poi, conseguenza della repressione, appariva come una prospettiva infinitamente dolorosa e pericolosa. In questo, certo, la mancanza di chiarezza dei democratici occidentali è stata una vera trappola. Ci hanno spinto a muoverci promettendoci protezione e solidarietà e ci hanno vigliaccamente abbandonato; poi ci giudicano se ci siamo rivolti malvolentieri ai loro nemici per salvarci dal genocidio promessoci dagli Assad.
L’eroismo dei siriani è ragionevole e dunque morale perché proporzionale alla mostruosità e durevole caparbietà del regime baathista-alawita. Inoltre, tale eroismo è ormai adeguato alla prospettiva di farci ammazzare in massa qualora rinunciassimo a proseguire la lotta fino ad una sostanziale vittoria. Ciò non significa che non vi sia il dovere di trovare vie negoziali per salvare l’essenziale della rivoluzione, senza finire in una guerra interminabile che comunque perderebbe il paese. Anche la determinazione sanguinaria del regime rappresenta qualcosa sul piano dell’autodeterminazione dei siriani, di un certo numero di siriani, di alcuni gruppi rilevanti di siriani… e dunque vige il dovere di pensare a delle soluzioni politiche negoziali, senza aspettare solo di vincere con le armi.
Infine uno sforzo di riflessione morale va fatto sull’uso del chimico in Siria. Che il regime degli Assad disponesse di armi chimiche è noto a tutti. Se avesse potuto dotarsi dell’atomica, o almeno di testate armate con materiale nucleare di scarto, non avrebbe mancato di farlo. Israele glielo ha impedito fisicamente. Quando il Presidente Obama ha fissato la linea rossa delle armi chimiche, ha di fatto consentito di utilizzare impunemente tutte le altre contro il popolo siriano. Infatti non si è battuto ciglio quando si sono spediti i missili balistici contro i nostri quartieri residenziali e zone industriali.
In diverse occasioni si è capito che la preoccupazione principe dell’Occidente non fosse di natura morale ma strategica. Si temeva infatti che le armi chimiche finissero in mano agli insorti e si diffidava il regime da un uso irresponsabile di tale arsenale. Si è detto senza peli sulla lingua che la priorità era quella di assicurare innanzi tutto la sicurezza dell’alleato israeliano.
Forse si temeva che, per agitare più efficacemente lo spauracchio terrorista islamico, il regime fosse tentato di farsi rubare un po’ di materiale pericoloso. E ciò affinché, una volta usato (come si pretende da parte dei Russi a gran voce sia avvenuto a Khan al-Asal ad Aleppo) si potesse dimostrare che il virtuoso regime siriano era il vero baluardo della civiltà di fronte alla barbarie terrorista islamista. Forse una simile linea rossa c’era, ma non tanto pubblicizzata, fin da quando i siriani inviavano i terroristi islamici in Iraq a farsi esplodere contro gli americani e i loro alleati…
Ma guardiamo alla cosa dal punto di vista etico della rivoluzione siriana. Ammettiamo per un istante che ci fossimo appropriati di armi chimiche sottratte agli arsenali di regime conquistati eroicamente. Immaginiamo di avere la capacità di usarle contro le forze armate del regime per risolvere il conflitto a nostro favore e salvare il nostro popolo da morte certa. Cosa ci sarebbe d’immorale? Tutte le armi possibili sono usate contro di noi. È ampiamente dimostrato che il regime fa esperimenti micidiali d’uso delle armi chimiche contro i partigiani rivoluzionari e la popolazione civile, proprio per vedere di superare quella maledetta linea rossa impunemente.
Chi volesse profittare della scusa dell’arma chimica usata da noi (noi, si fa per dire!) una volta (e non è affatto dimostrato) contro il regime, dovrà riconoscere di usare un argomento del tutto insostenibile e che gli si rivolge contro. Tutti questi che ci danno lezione di morale militare hanno gli arsenali pieni di nucleare, chimico, biologico e via ammazzando!
Se avete paura, giustamente intendiamoci, per la sicurezza dello stato di Israele, allora siate bravi, intervenite a pacificare la Siria, distruggete l’arsenale chimico, restituiteci il diritto all’autodeterminazione democratica e poi mettete alla giovane democrazia siriana quelle linee rosse che riterrete necessarie. In fondo per voi non cambia nulla sul piano della sicurezza se come partner regionale avete un regime assassino o una baldanzosa Siria democratica!
Invece se ci lasciate sbranare dal regime assassino, allora, ve lo promettiamo, la necessaria doverosa e disperata autodifesa ci consiglierà, ci obbligherà a costituire un tale micidiale pericolo alla sicurezza regionale da obbligarvi ad assumervi comunque le vostre responsabilità. Siete di fronte a gente che ha perso tutto, gli occhi sono accecati dalle croste delle troppe lacrime, i nostri figli sono crocefissi nelle galere del vostro alleato oggettivo. Abbiamo anche vissuto una guerra così sporca che i ragionamenti morali del Padre Paolo ci lasciano alla fine indifferenti. Solo un minimo di giustizia ci farà rinsavire. Solo un minimo di sincera autocritica da parte vostra ci permetterà di pensare a quel negoziato… che sappiamo in fondo necessario. Non è per minacciare, è invece per allarmare riguardo ad un pericolo oggettivo e già reale che mi lascio andare a propositi così drammatici. Ogni giorno, dei giovani rivoluzionari democratici, male armati e affamati, passano ai gruppi islamisti meglio organizzati, più motivati, meno digiuni, più addestrati e più garantiti di vita eterna in caso ci si debba sacrificare.
Per noi siriani della rivoluzione, la riconciliazione tra forze islamiste radicali e forze democratiche è una necessità strategica. Le scaramucce dolorose e i crimini insopportabili avvenuti tra noi devono trovare soluzione, essere riassorbiti, per presentarci uniti di fronte al pericolo totale rappresentato dal regime, appoggiato direttamente o indirettamente da troppi. Il tentativo di seminare guerra intestina tra le forze anti-Assad (a prescindere dal necessario intercettamento e disinnesco delle derive criminali) deve fallire. Questo gli agenti e i consiglieri militari americani farebbero bene a capirlo subito. Favorire i partner più affidabili, incoraggiare le evoluzioni più auspicabili è buono. Spingerci ad ammazzarci tra di noi non può esserlo.
Allorché l’Occidente, ma anche Russia e Iran, e l’Onu nel suo insieme, si pentiranno del crimine di complice irresponsabilità da loro commesso ai danni dei siriani, allora provvederanno a che Bashar al-Assad lasci Damasco e si ritiri coi suoi sulle montagne ancestrali, consegni i pieni poteri a un governo transitorio che prepari il vero passaggio democratico.
Le grandi potenze metteranno in grado le comunità locali siriane di assicurare la propria sicurezza, instaureranno efficacemente una corte internazionale di giustizia per la Siria, separeranno temporaneamente i contendenti del conflitto civile sulla base delle linee geografiche di appartenenza comunitaria, in vista d’una Siria unitaria confederale, assisteranno la massa dei civili diseredati e ridotti in miseria disperata, favoriranno l’evoluzione dell’islamismo politico nel suo plurale desiderio di democrazia musulmana, incoraggeranno le minoranze (proteggendole pure, è ovvio) a reinvestirsi nella cosa pubblica comune.
Quando questo succederà, allora noi vi promettiamo di fare di tutto per riassorbire la deriva violenta, radicale, islamista, qaedista! È nel nostro interesse. Essa infatti costituisce una non soluzione proprio per i ragazzi che vi ci sono arruolati. Sono nostri figli e non ci interessa perderli. Nessuna soluzione alla Tora Bora, neanche per i jihadisti stranieri!
La Siria sarà capace di elaborare una strategia pedagogica islamica di riassorbimento dell’estremismo. Non è la prima volta nella storia. Abbiamo la teoria e conosciamo la pratica. Non si può giocare il futuro del mondo sull’ipotesi islamo-pessimista. Lo sanno anche i politici che si fanno pubblicità a forza di xenofobia. Se non si vuole essere morali almeno si cerchi d’esser pratici. Razionalità sincera e moralità concreta vanno finalmente a braccetto.

Joe Stack, chi era costui? Cresciuto in un orfanatrofio nel vecchio quartiere industriale di Harrisburg, in Pennsylvania, dove ha visto intorno a sé l'impoverimento di quella che era la «classe operaia privilegiata», ha trascorso una vita travagliata tra debiti e tentativi falliti di autoimprenditorialità. Finché ha espresso il suo odio per il governo e i politici, per il salvataggio delle istituzioni finanziarie, per le multinazionali e le compagnie di assicurazione, in un suo «manifesto», consegnato ai posteri prima di lanciarsi nel febbraio 2010 con un piccolo aereo contro il palazzo dell'agenzia federale delle entrate ad Austin, in Texas. Per Noam Chomsky (intervistato da David Bersamian in Sistemi di potere. Conversazioni sulle nuove sfide globali, Ponte alle Grazie, pp. 185, euro 15) quella di Stack è «un'analisi profonda e convincente della società americana».
Non è facile inquadrare con precisione Chomsky. I suoi riferimenti intellettuali e politici, come bene emerge da queste conversazioni realizzate tra il 2010 e il 2012, vanno cercati soprattutto nella tradizione giuridica della Magna Carta e nell'orizzonte morale dell'illuminismo. Nelle sue analisi c'è tanto Dewey e poco materialismo, più Bakunin che Marx: l'attenzione è rivolta ai lati oscuri dei «sistemi di potere», come recita in modo azzeccato il titolo, mentre il capitalismo è tenuto sullo sfondo. Forse potrebbe essere definito un fustigatore della cattiva coscienza liberal americana, sempre pronto a denunciare l'incoerenza tra gli ideali propugnati dalla società a stelle e strisce e la realtà di oppressione che storicamente ne contraddistingue lo sviluppo. Da questo punto di vista, l'analisi di Chomsky è inequivocabile: a differenza delle altre nazioni, quella americana si ammanta di una missione «trascendente», da imporre con le armi e la conquista. È questa la teologia politica su cui poggia l'imperialismo degli Stati Uniti, a cui nessuno dei diversi governi si è sottratto. Vanno così in pezzi tutti i miti dei liberal americani: da John Kennedy allo stesso George Washington.
Chomsky invita alla prudenza nel parlare di declino americano: concede che ci siano state delle trasformazioni, ammette che si possa parlare di un indebolimento della capacità di attuare una politica egemonica (come il fallimento della guerra in Iraq dimostra), ma vede tutto sommato una continuità nelle forme del dominio imperialista. Insomma, i «sistemi di potere» emergono da queste pagine come immutabili e comunque invincibili.
Sono note le tesi chomskyane sul linguaggio, a cui è dedicato un capitolo specifico delle conversazioni: esiste nel cervello umano una facoltà innata che consente all'essere umano di apprendere il linguaggio, la cui acquisizione è dunque un fattore biologico. Non è questo il luogo per discutere tali tesi; va tuttavia segnalato l'apparente contraddizione tra lo scrupoloso impegno nello studio del linguaggio e il quasi completo disinteresse per la rete e i social media, liquidati come semplici sistemi dottrinari del potere volti a ridurre le persone alla passività e all'atomizzazione. I concetti dovrebbero essere strappati dall'empireo dell'astrazione indeterminata e immersi nella verifica dei processi materiali. Ma qui il discorso riguarderebbe i vizi del ruolo dell'intellettuale sopravvissuti all'esaurimento della sua funzione storica, e ci condurrebbe lontano.
Per restare sul punto, non si può dire che sia la produzione di soggettività al centro degli interessi di Chomsky. Il soggetto è sempre quello che ha in mano le leve del potere, così come la lotta di classe è esclusivamente quella condotta dai padroni. Chomsky è sicuramente attento ai movimenti, come le «primavere arabe» o Occupy Wall Street. E tuttavia, nel rimarcare la sostanziale caducità dei movimenti in termini di durata, Chomsky sottolinea a più riprese come a mancare siano il partito e il sindacato; solo questi possono restaurare un rapporto lineare tra lotte e sviluppo del welfare, come fu negli anni '30 con il New Deal.