


. la Repubblica, 23 luglio 2017
In questo torrido e arido mese di luglio, i capi di stato del gruppo di Visegrad — la città ungherese dove nel 1991 si sono riuniti per la prima volta i rappresentanti dei paesi del centro ed est Europa — si sono incontrati a Budapest e hanno indirizzato una lettera-documento in tema di immigrazione al nostro governo. L’Italia, che si trova a presidiare molti chilometri di confini del territorio europeo, si è vista calare per bocca del leader ungherese Viktor Orbán, questo suggerimento che ha l’arroganza del comando: chiudere i porti e accettare le proposte dei paesi frondisti, che prevedono la gestione, con il sostegno dell’Ue, della politica di “protezione” dei confini europei, l’addestramento della guardia costiera libica, e nuovi codici di condotta delle Ong.
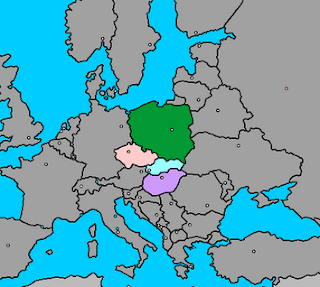 |
| Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia |
I nuovi nazionalisti non sono così anacronistici da rivendicare nazioni isolazioniste. E per questo, Orbán, il primo leader di una democrazia populista sul territorio europeo, si candida a paladino dell’Europa: i confini dell’Ungheria sono, lo ha più volte detto, i sacri confini dell’Europa cristiana.
 Ridurre le tasse e appiattirle non significa solo tradire il principio costituzionale della proporzionalità tra reddito e contributo alla spesa pubblica, ma provocherebbe riduzione della spesa sociale e indebolimento del potere pubblico di influire sulla direzione degli investimenti.
Ridurre le tasse e appiattirle non significa solo tradire il principio costituzionale della proporzionalità tra reddito e contributo alla spesa pubblica, ma provocherebbe riduzione della spesa sociale e indebolimento del potere pubblico di influire sulla direzione degli investimenti.
il manifesto, 22 luglio 2017
In barba a tutte le nuovistiche pretese rottamatrici, ormai è chiaro che nella politica italiana a difettare sono proprio i progetti e che la prossima campagna elettorale sarà dominata da una idea vecchia come il cucco, quale il mantra della riduzione indiscriminata delle tasse.
Riproposto nelle forme più demagogiche anche sotto le vesti di ricorso alla flat tax, un’idea che nasce dal cuore della destra ma a cui ha occhieggiato lo stesso Renzi. Questo deficit di pensiero e di ideazione è tanto più grave a sinistra, dove esso spiega ciò che altrimenti rimarrebbe inspiegabile: il cinismo con cui da tutte le parti – sia nel Pd di Renzi, sia nei fuoriusciti di Mdp, sia nella sinistra estrema – si rinunzia a costruire una coalizione larga di centrosinistra e si punta solo a strappare qualche voto all’immediato vicino dando per scontato che le elezioni siano già perse, bastonandosi di santa ragione tra più affini invece di combattere soprattutto sul piano ideale e programmatico la destra e il movimento 5Stelle (non a caso sostenente una bandiera – il «reddito di cittadinanza», che è un sussidio flat – speculare a quella della destra).
Eppure non è in alcun modo sottovalutabile la pericolosità di una proposta come la flat tax, nell’ipotesi dell’Istituto Bruno Leoni un’aliquota unica del 25% per Irpef, Ires, Iva, sostitutive ecc, associata a un trasferimento monetario agli incapienti. Perseguire una simile ipotesi porta a due esiti entrambi estremamente negativi. Il primo è una drammatica alterazione della distribuzione del reddito, già tanto disegualitaria e squilibrata, a ulteriore favore dei ricchi e a danno dei ceti medi: Baldini e Giannini su Info La voce segnalano che una coppia di dipendenti del Nord con due figli con 40 mila euro di reddito guadagnerebbe 268 euro, mentre la stessa famiglia con reddito più che doppio (80 mila) ne guadagnerebbe quasi 9 mila.
Il secondo esito negativo è una perdita di gettito (le entrate pubbliche complessive si ridurrebbero di più di 95 miliardi di euro l’anno, lo spazio di quattro-cinque finanziarie!) di tale entità da restituire attualità al motto starving the beast, «affamare la bestia governativa», sottraendogli le risorse necessarie a finanziare servizi pubblici e prestazioni sociali. Non si deve dimenticare che l’espressione entrò in auge all’epoca di Reagan, quando nella cerchia dei consiglieri repubblicani nessuno credeva che i tagli fiscali del 1981 potessero essere finanziariamente sostenibili (e in effetti non lo furono), ma si consideravano i tagli stessi come mezzi per formare disavanzi tali da affamare il bilancio pubblico, utilizzando l’«affamamento» come leva per abbattere la spesa. Il tutto nella più classica logica ostile all’esercizio della responsabilità collettiva incarnata dalle istituzioni pubbliche: «meno tasse, meno regole, meno stato, più mercato», associando l’idea che la tassazione sia intrinsecamente dannosa alla volontà di ridurre al «minimo» il ruolo degli stati e dei governi (nella proposta dell’Istituto Leoni la perdita di gettito sarebbe finanziata per due terzi con l’abolizione delle prestazioni assistenziali esistenti – assegni familiari, indennità di accompagnamento, integrazione al minimo, pensione sociale, ecc. -, per un terzo con altri tagli di funzioni pubbliche).
Dunque, le critiche che dipingono la flat tax come «ambiziosissima» ma irrealistica o intempestiva, perché troppo costosa, sono assolutamente insufficienti e non colgono nel segno. Perché non è solo questione di promesse demagogiche irrealizzabili, né è solo questione delle risorse mancanti con cui finanziare le politiche di tagli fiscali. In gioco c’è molto di più: queste politiche sono profondamente sbagliate e tali rimarrebbero anche se ci fossero le risorse per realizzarle, sia sotto il profilo redistributivo, sia sotto il profilo dell’impatto ipotizzabile sull’economia e sulla società. In primo luogo per il disorientamento culturale che ne scaturisce: le visioni neoliberiste, di cui è figlia la flat tax, infatti, hanno fatto sì che un dibattito meditato sulla tassazione scomparisse dalla scena pubblica. L’inerzia di una riflessione pubblica sulla tassazione ha prodotto quel fenomeno generalizzato per cui le scelte di politica fiscale non sembrano più appartenere alla discriminante destra/sinistra: da entrambi i lati appare dominante un unico slogan, diminuire le tasse. Così si perde di vista che il significato e il ruolo della tassazione non sono valutabili in se stessi, ma si commisurano anche e soprattutto al livello e alla qualità dei servizi di cui una società desidera disporre, i quali a loro volta, esprimono la qualità e la natura dei «beni collettivi» e dei «legami di cittadinanza» propri di quella stessa società.
Poiché, però, il dibattito sul livello e la struttura della tassazione è centrale per il processo democratico, l’accettazione della ridefinizione della questione fiscale nei termini angusti imposti dai conservatori è particolarmente dannosa per le forze di centro-sinistra. Esse, infatti, hanno bisogno per definizione di politiche attive e di offrire servizi di alta qualità e basano la loro forza sull’estensione della cittadinanza e sull’approfondimento dei legami coesivi tra cittadini e dei legami di fiducia tra cittadini e stato, l’indebolimento dei quali è, invece, provocato dalla delegittimazione della tassazione. Se ne vedono le conseguenze, in vari paesi europei, nello scatenamento di populismi che trovano impreparate le forze di sinistra e di centrosinistra.
Queste ultimi confermano la loro vitale necessità di essere e di essere percepite, agli occhi del loro elettorato, al tempo stesso più efficienti, più eque e più capaci di sollecitare il potenziale dinamico e coesivo di una società. In definitiva, Renzi non va criticato per aver conquistato «margini di flessibilità« e voler oggi rimettere in discussione il Fiscal Compact. Va criticato per aver dissipato quei margini di flessibilità (che concretamente vogliono dire finanziamento in deficit) finanziando non spesa in investimenti produttivi ma spesa corrente, fatta di tagli fiscali, decontribuzione, regalie varie. Al contrario, quello che oggi urge è un rovesciamento di lessico, di paradigma culturale, di etica pubblica che sposti il focus – dagli incentivi indiretti, i bonus, i trasferimenti monetari quali sono anche i benefici fiscali – a un grande Piano di investimenti pubblici per un nuovo modello di sviluppo di elevata qualità e ad alta intensità di lavoro, soprattutto per i giovani la cui disoccupazione rimane scandalosamente vicina al 40%.
Vocidall'estero online, 6 luglio 2017 (c.m.c.)
Pubblichiamo oggi la traduzione di un altro articolo della rivista European House of Cards. Joachim Starbatty dà una lettura keynesiana dell’eurocrisi. Secondo Keynes, per paesi come quelli dell’europeriferia, la soluzione è semplice: stimolare la domanda con spesa governativa e svalutare la moneta per recuperare competitività. Il problema è che questo è impossibile, perché il “core” dell’eurozona li ha legati con un cambio fisso. È il cambio fisso il vero ostacolo alla ripresa economica in Europa. Purtroppo, nonostante questo semplice dato sia sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori, continua a essere negato per non turbare il “sogno di un’Unione Europea sempre più stretta”.
La soluzione di J.M. Keynes – un aumento della spesa governativa in grado di stimolare la ripresa economica durante una recessione – viene spesso proposta come soluzione per i paesi troppo indebitati del Sud dell’eurozona. Ma per i paesi della periferia dell’eurozona, questo approccio non rappresenta un cammino credibile verso la ripresa economica.
Nel suo libro epocale La teoria generale dell’occupazione, degli interessi e della moneta (1936) Keynes dimostrò che la capacità produttiva inutilizzata e i lavoratori potrebbero essere rimessi in opera grazie alla spesa del governo. Quello che non discuteva era la competitività, che è al cuore del problema che devono affrontare le economie dei paesi dell’eurozona in crisi. La spesa a deficit deve essere intesa come un ponte: Keynes offre una soluzione per sfruttare le risorse inutilizzate fino a quando la domanda del mercato non si riprende.
Tuttavia, la spesa governativa non produrrà un’efficiente allocazione dei fattori di produzione, quando non ce ne era fin dal principio. In altre parole, non può risolvere il problema della mancanza di competitività economica di base. Inoltre, una spesa pubblica su larga scala richiederebbe altro debito pubblico, che per molti paesi sarebbe insostenibile. Nella Teoria generale di Keynes, tuttavia, troviamo un suggerimento: un’economia può uscire dal suo problema di disoccupazione manipolando il tasso di cambio. Un governo che deve affrontare un’alta disoccupazione può stimolare l’occupazione svalutando la moneta, cosa che si traduce in esportare più beni e importare occupazione.
Di conseguenza, i suoi partner commerciali importeranno più beni ed esporteranno occupazione. È la strategia indicata come “Beggar-my-neighbour (Frega il vicino)”. Ed è quello che sta avvenendo nell’eurozona. Il principale problema dell’unione monetaria è un rapporto di prezzi relativi falsato: il valore dell’euro è troppo basso per la Germania e troppo alto per i paesi della periferia, In Germania, il surplus della bilancia di pagamenti è aumentato dall’1% del 2000 all’oltre 8% attuale e la disoccupazione è scesa dall’11% del 2005 al 5% attuale, mentre la disoccupazione della periferia del Sud è quasi raddoppiata. Questa è una chiara prova empirica della politica “frega il vicino”. È comprensibile che gli esportatori tedeschi siano soddisfatti dell’euro-regime; ma è incomprensibile che i governi della periferia europea aderiscano a un sistema monetario che sta distruggendo i loro Paesi.Per loro c’è una sola possibilità di tornare alla prosperità economica: una consistente svalutazione di una nuova valuta nazionale.
In alcuni casi, sarà necessaria una ristrutturazione del debito. Il governo tedesco naturalmente è consapevole dei prezzi relativi truccati e impone ai governi della periferia europea una svalutazione interna, basata su un abbassamento dei salari guidato dall’alta disoccupazione, dalle politiche di austerità e dall’import in caduta. Possiamo imparare in dettaglio da Keynes quello che succede ai governi che seguono le ricette della cancelliera Angela Merkel. Nel suo Trattato sulla riforma monetaria (1923), Keynes criticava aspramente le politiche deflazionistiche della Francia, messe in atto per difendere un Franco sopravvalutato. Dopo la Grande Depressione, l’Inghilterra e gli USA seguirono i suoi consigli e abbandonarono il Gold Standard: la sterlina inglese e il dollaro americano si svalutarono, e i due Paesi divennero più competitivi della Francia.
Il governo francese dovette decidere se svalutare a sua volta, o perseguire una politica deflazionistica di tagli alla spesa per riottenere competitività. Keynes osservò che «nemmeno un politico completamente incosciente applicherebbe una politica finalizzata al dimezzamento dei salari, al raddoppio del debito pubblico e alla riduzione drastica dei prezzi delle esportazioni». Vi suona familiare? La Troika e i politici dei Paesi creditori europei hanno adottato proprio questa politica, per sei anni. E così, anche se un aumento della spesa governativa non può risolvere la crisi, il taglio della spesa, delle pensioni e dei salari non farà altro che aggravarla.
Keynes ha dedicato un intero capitolo del suo Trattato a questo problema: se una nazione debba perseguire politiche deflazionistiche o svalutare la sua moneta. Ed è giunto a una chiara conclusione: la politica giusta per le nazioni è svalutare, e raggiungere un valore della moneta adeguato al commercio e ai salari. Di conseguenza i Paesi dovrebbero perseguire una svalutazione esterna, cioè un adeguamento del loro tasso di cambio, anziché una svalutazione interna, realizzata attraverso tagli salariali. Se Keynes fosse vissuto oggi, raccomanderebbe la Grexit e l’uscita dall’euro degli altri paesi che si trovano in crisi economica. Il ritorno alle valute nazionali restituirebbe ai singoli paesi il Controllo della loro politica monetaria, che potrebbe finalmente allinearsi alle esigenze di ciascuna economia nazionale. Era fatale che intrappolare Germania e Grecia insieme in un’unica politica monetaria avrebbe avuto conseguenze disastrose. La situazione attuale non è una sorpresa, ma una conseguenza logica dell’Unione Monetaria Europea.
Perché l’élite politica dell’Unione europea rifiuta perfino di prendere in considerazione anche solo la possibilità che un paese esca dall’eurozona, per non parlare di sviluppare un quadro giuridico – di cui ci sarebbe bisogno già da molto tempo – per un simile evento? L’unica risposta è che l’euro è ormai una questione ideologica. L’euro è il simbolo di un’unione sempre più stretta. Per questo è considerato “politicamente scorretto” nel giro delle istituzioni europee mettere in discussione la forma attuale dell’Euro, nonostante gli enormi costi sociali che infligge all’Europa meridionale.
comune-info, 2 luglio 2017 (c.m.c.)
Sono decenni che i governi italiani dichiarano con solennità di voler abbattere il debito. Poi però, con puntualità svizzera, si tolgono di mezzo lasciando un debito più alto. Questa bizzarra consuetudine non si verifica perché la gente scialacqua, come ci fanno credere, ma perché siamo divorati dagli interessi. Lo Stato ha rinunciato al potere di stampare moneta, così ogni volta che deve spendere più di quel che incassa chiede denaro al sistema finanziario privato. Diventiamo sempre più poveri mentre banche, assicurazioni e fondi di investimento ingrassano con un debito che diventa cattivo quanto il colesterolo che devasta le coronarie. Nel 2016 abbiamo risparmiato 25 miliardi di euro ma il debito pubblico è cresciuto di altri 40 miliardi perché il risparmio non arrivava a coprire la spesa per interessi. La storia si ripete dal 1992, da allora il debito è passato da 850 a 2270 miliardi di euro nonostante 768 miliardi di risparmi. Su una somma complessiva di 2038 miliardi di interessi, 1270 sono stati pagati a debito. Per cambiare davvero non ci sarebbe che la pressione popolare, peccato che ai governi e ai media che contano non sia affatto simpatica.
È possibile combattere la miseria senza combattere i meccanismi che la producono? La domanda è retorica: non esiste altra risposta che no. Eppure è ciò che facciamo se non affrontiamo il tema del debito pubblico. A onor del vero, va detto che il debito pubblico è come il colesterolo. C’è quello buono che rappresenta ricchezza e quello cattivo che rappresenta miseria. Il debito è buono quando la moneta è gestita direttamente dallo Stato in un’ottica di piena occupazione. In tale contesto la spesa in deficit si trasforma in ricchezza perché l’ammanco è finanziato con moneta stampata di fresco che entrando nel circuito economico stimola l’economia con effetti positivi su produzione, occupazione, consumi e risparmi. Il debito è cattivo quando lo Stato si priva volutamente di sovranità monetaria, ossia del potere di stampare moneta. In tal caso ogni volta che decide di spendere più di quanto incassa deve chiedere un prestito al sistema finanziario privato. Che lo darà solo in cambio di un tasso di interesse. Così il popolo si impoverisce a vantaggio di banche, assicurazioni, fondi di investimento e ogni altra struttura finanziaria che di mestiere presta denaro.
Purtroppo da una trentina di anni, già prima di entrare nell’euro, lo Stato italiano si è ridotto al pari di una qualsiasi famiglia o azienda che dipende dalle banche per qualsiasi spesa supplementare. Il suo debito nei confronti dei privati oggi ha raggiunto 2270 miliardi di euro[1] e si comporta come una zecca che affonda l’arpione nelle casse pubbliche per sottrarre denaro in base al livello dei tassi di interesse esistenti. Nel 2016 i soldi sottratti sono stati 68 miliardi di euro, nel 2012 addirittura 87 per un semplice capriccio della speculazione. Soldi di tutti, che invece di andare a finanziare asili, ospedali, scuole al servizio della collettività, vanno ad ingrassare gli azionisti delle grandi strutture finanziarie. In effetti solo il 5,4% del debito pubblico italiano è detenuto dalle famiglie. Tutto il resto è nelle mani di banche, assicurazioni, fondi d’investimento, sia italiani che esteri. Più precisamente le strutture finanziarie italiane detengono il 63,1 per cento del debito pubblico italiano, quelle estere il 31,5 per cento.[2]
Si può senz’altro affermare che il debito cattivo è un meccanismo di redistribuzione alla rovescia: prende a tutti per dare ai più ricchi. Perché solo i ricchi hanno risparmi da investire in titoli di Stato. E i risultati si vedono: l’Italia è sempre più disuguale. Da società a uovo si sta trasformando in società a piramide. Prima c’era un piccolo numero di famiglie con redditi bassi, un piccolo numero con redditi molto alti e nel mezzo un gran numero di famiglie con redditi medi. Oggi molte famiglie di mezzo stanno migrando verso il basso mentre quelle di cima sono sempre più esigue e naturalmente più ricche.
Da un punto di vista patrimoniale, ossia della ricchezza posseduta sotto forma di case, terreni, auto, gioielli, titoli, depositi, le famiglie italiane possono essere divise in tre fasce. Quelle di cima, pari al 10 per cento, che detengono il 46 per cento dell’intera ricchezza privata. Quelle di mezzo, equivalenti al 40 per cento che controllano il 44 per cento della ricchezza. Quelle di fondo, che pur rappresentando il 50 per cento delle famiglie italiane, si aggiudicano appena il 9,4 per cento della ricchezza privata. [3] Mediamente la ricchezza delle famiglie appartenenti al 10 per cento più ricco è 22 volte più alta di quelle appartenenti al 50 per cento più povero. Ma se possibile la realtà è anche peggiore. Uno studio del Censis certifica che i 10 individui più ricchi d’Italia dispongono di un patrimonio di circa 75 miliardi di euro, pari a quello di quasi 500mila famiglie operaie messe insieme. Poco meno di 2mila italiani, appartenenti al club mondiale degli ultraricchi, dispongono di un patrimonio complessivo superiore a 169 miliardi di euro e non è conteggiato il valore degli immobili. In altre parole lo 0,003 per cento della popolazione italiana possiede una ricchezza pari a quella detenuta dal 4,5 per cento.[4]
I segni di un’Italia sempre più disuguale si ritrovano anche nella distribuzione del reddito. Il 10 per cento più ricco della popolazione intasca il 25,3 per cento del reddito disponibile, il 10 per cento più povero solo il 2,1 per cento. In termini monetari ogni individuo del 10% più ricco dispone di 77.189 euro all’anno. Quelli del 10% più povero si fermano a 6.521 euro.[5] Un divario di quasi 12 a 1. Situazione peggiore di metà degli anni ottanta quando il rapporto era 8 a 1.
Il sottoprodotto dell’ingiustizia è la miseria che il debito aggrava tramite l’austerità, scelta classica di uno Stato totalmente asservito alle banche. Al pari di una famiglia, quando uno Stato senza sovranità monetaria si accorge di non avere abbastanza soldi per pagare interessi e capitale, cerca di raggranellare il dovuto aumentando le entrate e riducendo le spese. Due mosse che hanno ambedue conseguenze gravissime perché se lo Stato smette di offrire servizi, le famiglie debbono rivolgersi al mercato che nel frattempo si è impossessato di servizi primari come l’acqua, i trasporti, la scuola, la sanità. Con la differenza che prima erano gratuiti, mentre ora sono a pagamento. Così le famiglie italiane, già tartassate dal carico fiscale, sono sempre più salassate dalle imprese private per il godimento di bisogni fondamentali. Basti dire che in ambito sanitario la spesa privata è salita, anno 2015, a 34,5 miliardi di euro, il 3,2 per cento in più rispetto al 2013. In totale gli italiani che si rivolgono alla sanità privata, spinti da ticket sempre più alti e da liste di attesa sempre più lunghe, sono oltre 10 milioni. Ma contemporaneamente sono cresciuti anche quelli che rinunciano a qualsiasi tipo di cura perché non hanno soldi né per pagare i ticket, né le parcelle. Nel 2016 gli italiani rinunciatari sono stati 11 milioni confermando che lo spostamento dalla sanità pubblica alla sanità privata si accompagna alla sanità negata.[6]
Che il binomio più tasse, meno servizi, impoverisca gli italiani, lo dicono i numeri. La forma più grave di povertà è quella di chi è in arretrato con le bollette, di chi non riesce a scaldare adeguatamente la casa, di chi non può permettersi un pasto appropriato almeno una volta ogni due giorni. Le persone in questo grave stato di deprivazione materiale sono 7 milioni, 11,6% della popolazione. Ma se allarghiamo lo sguardo a chi vive in bilico a causa del suo stato di precarietà e di incertezza, troviamo che le persone a rischio povertà, o esclusione sociale, sono 17 milioni e mezzo, il 28,7 per cento della popolazione italiana, il 3 per cento in più del 2004.[7] Persone a cui basta un dente da riparare, una batteria di esami sanitari imprevisti, una riparazione d’auto fuori programma, per mandarle sott’acqua e costringerle ad arrangiarsi chiedendo un prestito o rinunciando ad altre spese importanti.
L’assurdo della situazione è che ora neanche i creditori sono più così sicuri di voler spingere lo Stato debitore a pagare. La loro paura è di finire come quei bombaroli che non avendo calcolato bene la lunghezza della miccia sono colpiti anche loro dalla deflagrazione. Fuori di metafora, la paura è che a forza di estrarre ricchezza, il sistema possa impoverirsi a tal punto da entrare in una spirale di crisi che trascina tutti verso il fondo. Il punto delicato è la domanda, perché viviamo in un sistema che si regge sulle vendite. Solo se c’è un livello di domanda pari, o addirittura superiore, alla capacità produttiva, tutto funziona regolarmente e possono addirittura aprirsi prospettive di crescita come tutti invocano. Se invece la domanda si contrae, le imprese entrano in crisi e licenziano in una spirale sempre più ampia. Esattamente come succede nelle economie ad alto debito pubblico, dove i cittadini hanno meno soldi da spendere a causa dell’elevato livello di tassazione e lo Stato stesso spende meno per risparmiare risorse da destinare agli interessi. Tanto più che neanche i ricchi aiutano. Benché con più soldi, in virtù degli interessi intascati, la loro spesa non cresce. Non spendono in consumi perché tutti i loro bisogni sono già stati soddisfatti e non spendono in investimenti perché non sono così stupidi da avviare nuove attività produttive quando non ci sono prospettive di vendita. L’unica strada che imboccano è quella della finanza che si espande sempre di più.
Negli ultimi dieci anni, complice la crisi bancaria, l’austerità e la concentrazione della ricchezza, in Italia la domanda complessiva si è ridotta ai minimi storici facendo salire la disoccupazione alle stelle. Nel 2016 i disoccupati erano 3 milioni pari all’11,7 per cento della forza lavoro. Ma il dato si riferisce solo a chi cerca attivamente lavoro. Se si includesse nel conteggio anche quelli che un lavoro salariato lo vorrebbero, ma non lo cercano perché scoraggiati, il numero dei disoccupati salirebbe a 5 milioni e mezzo, il 21,6 per cento della forza lavoro.[8] Purtroppo anche la pubblica amministrazione contribuisce al problema dal momento che fra il 2013 e il 2016, ha perso 84mila unità.[9] La disoccupazione colpisce in maniera particolare i giovani fra 15 e 29 anni. Nel 2016 i giovani disoccupati sono 960mila pari al 44 per cento della forza lavoro giovanile. In pratica ogni 10 giovani disposti a lavorare, 4 non lo trovano. Ed ecco la crescita dei Neet, giovani stanchi e sfiduciati che né lavorano né studiano secondo la definizione inglese Not in education or in employment training. Nel 2016 i giovani nullafacenti fra i 15 e i 29 anni ammontano a più di 2 milioni, il 24 per cento del totale.[10]
Da oltre trent’anni, ogni governo dichiara di porsi come priorità l’abbattimento del debito, ma se ne va lasciandosi dietro un debito ancora più alto. E non perché viviamo al di sopra delle nostre possibilità, come qualcuno vorrebbe farci credere, ma perché non ce la facciamo a tenere la corsa con gli interessi. L’esame dei bilanci pubblici dimostra che siamo dei risparmiatori, non degli scialacquatori. Ad esempio nel 2016 abbiamo risparmiato 25 miliardi di euro perché a tanto ammonta la differenza, in negativo, fra ciò che abbiamo versato allo Stato e ciò che abbiamo ricevuto indietro sotto forma di servizi, investimenti, previdenza sociale. Ciò nonostante nel 2016 il debito pubblico è cresciuto di altri 40 miliardi perché il risparmio accumulato non è stato sufficiente a coprire tutta la spesa per interessi. Questa storia si ripete dal 1992 e ciò spiega perché da allora il nostro debito è passato da 850 a 2270 miliardi di euro nonostante 768 miliardi di risparmi. È semplicemente successo che su una somma complessiva di 2038 miliardi di interessi, 1270 sono stati pagati a debito.[11]
Il debito che si autoalimenta attraverso la via degli interessi è una delle forme più odiose di sottomissione e strangolamento di un popolo. Ogni anno avvolge attorno al suo collo un nuovo giro di catena per tenerlo sempre più stretto e succhiargli sempre più sangue. Fuori di metafora è un’organizzazione perfetta di latrocinio per travasare quote crescenti di ricchezza dalle tasche di tutti a quelle dei ricchi. Ma ora è arrivato il tempo di alzarci in piedi e rivendicare il diritto di sottrarci a questo meccanismo perverso. Gli strumenti per farlo ci sono: vanno dal congelamento del pagamento degli interessi al ripudio del debito illegittimo; dall’imposizione di un prestito forzoso a carico dei cittadini più ricchi ad una tassazione progressiva di reddito e patrimonio; dall’introduzione di una moneta complementare nazionale alla riforma della Banca Centrale Europea, dal controllo della fuga di capitali alla regolamentazione della speculazione sui titoli del debito pubblico. Il problema non sono gli strumenti, ma la volontà. Purtroppo neanche i politici più progressisti hanno messo a fuoco la gravità della situazione ed hanno posto al centro del proprio programma politico la gestione alternativa del debito.
L’unica forza che può indurre al cambiamento è la pressione popolare. Ma i cittadini si attivano solo se si rendono conto dei danni provocati dal debito pubblico. Di qui il ruolo cruciale dell’informazione. Ma chi la darà? Non c’è da aspettarsi, né sarebbe auspicabile, che la dia chi ha interesse a mantenere lo status quo, l’unica opzione possibile è che questo compito venga assunto dalla società civile che lotta contro il disagio sociale. Associazioni e cooperative, fondazioni e sindacati, realtà laiche e religiose, tutti insieme dovremmo organizzare una grande campagna di informazione pubblica finalizzata a tre obiettivi: creare consapevolezza nei cittadini sui nessi esistenti fra debito pubblico e disagio sociale; obbligare i media ad accendere i riflettori sulle conseguenze sociali del debito, suscitare un grande dibattito pubblico sulle soluzioni alternative al solo pagare.
La storia ci insegna che i cambiamenti sono possibili, ma solo se si infervorano gli animi. E gli animi si infervorano se scatta l’indignazione che deriva dalla consapevolezza. Nessuno meglio di noi può assumersi il compito di fare sapere. Possiamo e dobbiamo farlo. Ma dobbiamo unire le nostre forze.
[1] Banca d’Italia, Finanza pubblica: fabbisogno e debito, 14 aprile 2017
[2] Elaborazione dati, Banca d’Italia, Finanza pubblica: fabbisogno e debito, 14 aprile 2017
[3] Banca d’Italia, La ricchezza delle famiglie italiane, Bollettino n.65 del 13 dicembre 2012
[4] Censis, Crescono le diseguaglianze sociali: il vero male che corrode l’Italia, 3 maggio 2014
[5] Banca d’Italia, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2014, 3 dicembre 2015
[6] Censis, Dalla fotografia dell’evoluzione della sanità italiana alle soluzioni in campo, 8 giugno 2016
[7] Istat, Condizioni di vita e reddito, 6 dicembre 2016
[8] Istat, Rapporto annuale 2017
[9] Marco Rogari, Nel 2017 «effetto spending» da 30 miliard, Il sole 24 ore, 20 giugno 2017
[10] Istat, Rapporto annuale 2017
[11] Elaborazione dati Centro Nuovo Modello di Sviluppo su serie storiche Istat e Corte dei Conti
». la Repubblica, 27 giugno 2017 (c.m.c.)
Il passaggio elettorale di giugno annuncia una stagione politica particolarmente calda. Perché i risultati hanno delineato uno scenario instabile. Per molti versi, in-definito. Con alcuni aspetti di continuità e altri di novità rispetto agli ultimi anni. Aspetti, peraltro, che coincidono largamente. Perché la novità maggiore è il ritorno del bipolarismo fra centro-sinistra e centro-destra.
Sembrava incrinato, se non destrutturato, dopo l’affermazione del M5s, annunciata giusto alle precedenti amministrative, cinque anni fa, con la conquista di Parma ad opera di Federico Pizzarotti. Che domenica è stato rieletto, con una maggioranza chiara. Ma con una lista nuova. Personalizzata. Creata da lui. Intorno a sé. Ma l’Italia dei sindaci uscita dal voto di domenica mostra un profilo più tradizionale. È un’Italia bi-polare, dove 117 dei 159 eletti sono espressi dalle due coalizioni maggiori. Centrodestra e centrosinistra.
La maggiore novità è, però, costituita dalla forte crescita del centrodestra, che sale da 44 a 59 città (maggiori) amministrate. Mentre il centrosinistra (se si considerano anche gli “altri candidati di sinistra”) perde oltre venti sindaci. E scende da 81 a 58. Per cui ha ragione Renzi quando afferma di avere vinto. Ma ha anche perso. Molti sindaci. Il M5s, infine, allarga la sua presenza nei governi locali: da tre a otto. Ma si conferma fluido, proiettato sull’arena nazionale ma scarsamente consolidato nel territorio. Tuttavia, fluido appare l’assetto politico del Paese, nell’insieme. È, infatti, difficile individuare in Italia zone specifiche, per concentrazione e continuità del voto. Com’è avvenuto fino a quasi dieci anni fa. Oggi quelle Italie non si riconoscono più. L’intero territorio sembra aver perduto i colori e gli orientamenti tradizionali.
Il centrosinistra. Era radicato nelle regioni dell’Italia centrale. Definite, per questo, “zone rosse”. Ma oggi non sembrano più nemmeno “rosa pallido”. Il centrosinistra, prima, in quest’area amministrava 13 comuni maggiori.
Oggi ne governa otto. Ha perduto, fra l’altro, Pistoia e Piacenza. Nelle regioni del Nord-ovest, peraltro, è più che dimezzato: da 29 a 14 città. Superato dal centrodestra, che oggi ne governa 24. Fra queste, alcune città particolarmente importanti. Per prima: Genova. Ma anche La Spezia e Monza. Oltre a un luogo mitico, come Sesto San Giovanni. Perduto dopo settant’anni di governo.
Il centrosinistra, per contro, si è meridionalizzato. Nel Mezzogiorno e nelle Isole la sua presenza nei governi locali si è allargata: da 24 a 26. Mentre il peso del centrodestra è sceso da 21 a 14. Il mutamento delle zone geopolitiche in Italia ha interessato anche il Nord-est. Tradizionale zona “bianca”. Prima democristiana, in seguito forza-leghista. In questa occasione è stato teatro di una rimonta del centrosinistra. Che si è affermato, fra l’altro, a Padova. Si disegna, così, una mappa dai colori incerti. Che riflettono l’incertezza e il distacco degli elettori. L’astensione, infatti, è risultata ampia come poche altre volte, in passato.
Ai ballottaggi, infatti, ha votato circa il 46% degli elettori, 12 punti in meno rispetto al primo turno. E il calo è apparso particolarmente sensibile nel Sud: circa venti punti. Quasi 25 anni dopo la riforma della legge elettorale relativa alle amministrazioni delle città, la stagione dei sindaci è in declino. L’elezione diretta alle amministrative appariva in origine una via per superare il vecchio sistema politico, travolto da Tangentopoli. Le persone al posto dei partiti. La soluzione individuata per restituire fiducia nelle istituzioni. Ma oggi quel modello mostra i suoi limiti. Anche perché, senza partiti, il legame tra politica, amministrazione e società si indebolisce.
Così, sul territorio si riproducono i vizi e i contrasti che si osservano sul piano nazionale. I cattivi risultati del centrosinistra nelle città, infatti, riflettono le divisioni fra il Pd e i gruppi politici alla sua sinistra. In parte ispirati dai soggetti scissionisti. Ai quali, peraltro, fanno riferimento molti dei candidati nelle maggiori città. Dall’altra parte, il centrodestra “unito” appare in grado di competere e di vincere in molte zone e in molti contesti. Il problema, semmai, è quando si passa all’ambito nazionale.
Allora le divisioni riemergono, acute. Sul piano personale, oltre che politico. Perché Berlusconi (rieccolo…) non ha alcuna intenzione di cedere lo scettro della coalizione a Salvini. Il quale ambisce ad esserne la guida. Anche se non è legittimato a “governare”, senza l’appoggio e la mediazione di Berlusconi e di Forza Italia. Soprattutto per ragioni internazionali. Per il rapporto con la Ue. Il principale “avversario” della Lega e dei suoi alleati. I populisti (anti)europei. Per primo, il Front National di Marine Le Pen. La Ue. Contro la quale il M5s costruisce la propria identità. Così, passate le amministrative, l’attenzione politica si proietta altrove. Dalla dimensione locale verso l’Europa. L’orizzonte, ma anche la vera “frattura” che delimita lo spazio politico del prossimo futuro. Anzitutto: del prossimo anno.

«vocidall'estero, 20 giugno 2017 (c.m.c.)
Il consolidarsi dei risultati del secondo turno delle elezioni legislative mostra ancora di più l’ampiezza con cui si è manifestato il rifiuto del voto. Se si sommano astensione, schede bianche e schede nulle – voti, questi ultimi, in forte aumento dal primo al secondo turno (da 500.000 a 2 milioni) – si supera il 61,5%, cifra data dal 57,36% delle astensioni più il 4,20% di schede bianche o nulle. Questo significa che appena il 38,5% degli elettori aventi diritto (ossia 18,31 milioni su 47,58 milioni) ha espresso effettivamente un voto al secondo turno. L’ampiezza del rifiuto del voto, a prescindere da quale forma abbia assunto, spinge a porsi alcune domande sul senso stesso di queste elezioni.
Paese “legale” contro paese “reale”?
Se non avessimo già abusato della contrapposizione maraussiana tra “paese legale” e “paese reale”, dovremmo utilizzarla proprio per descrivere la situazione attuale. Certo, la situazione non è assimilabile a quella in cui Charles Maurras aveva espresso questa dicotomia. Essa indicava aspetti diversi e non può essere ridotta alla sola cifra dei non-votanti. Eppure oggi abbiamo un “paese legale” nel quale il movimento “Republique en Marche” ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi all’Assemblea Nazionale tramite l’ultima tornata di elezioni, di cui nessuno contesta la legalità, ma questa maggioranza assoluta di deputati non può far dimenticare la maggioranza, questa volta davvero schiacciante al confronto, di francesi che non hanno votato o che hanno rifiutato di esprimere una scelta nel momento in cui hanno compilato la scheda di voto. È questa la discrepanza che giustifica, nonostante le remore storiche e politiche, il riutilizzo della dicotomia tra “paese legale” e “paese reale”. L’Assemblea Nazionale, per quanto sia legalmente autorizzata, ha un enorme problema di legittimità.
Una conseguenza di questo è che non c’è alcuna onda di consensi dietro al presidente e al suo partito. Il sistema elettorale francese, come sappiamo e abbiamo ripetuto a sufficienza, non fa altro che amplificare i risultati di una singola elezione. Tuttavia, nel 1981, durante la famosa “onda rosa”, l’astensione era stata solo del 24,9% (al secondo turno). Analogamente, nel 1993 durante “l’onda blu” ci fu un’astensione del 32,4%. Ora siamo in una situazione ben diversa. Ed è questa la situazione che dobbiamo considerare, al di là dei successi degli uni e dei fallimenti degli altri.
Crisi di legittimità e fratture politiche
Se anche – per miracolo – l’elezione fosse avvenuta secondo le regole del sistema proporzionale, – e allora, vorrei ricordare, “France Insoumise” avrebbe ottenuto 84 deputati (anziché solo 19) e il “Front National” ne avrebbe ottenuti 80 (anziché appena 8) – la legittimità dell’Assemblea Nazionale sarebbe stata comunque fragile. Naturalmente si può sempre dire che, in caso di rappresentanza proporzionale, l’astensione sarebbe stata meno marcata. Questo è possibile, ma è da dimostrare. È quindi necessario distinguere il problema della rappresentanza delle forze politiche all’interno dell’Assemblea Nazionale -problema che riguarda ovviamente la rappresentanza delle due forze di opposizione reale, e che potrebbe essere ridotto da un sistema elettorale un po’ diverso – dal problema della legittimità complessiva dell’Assemblea Nazionale, che deriva dall’ampiezza dell’effettivo “sciopero del voto” a cui abbiamo assistito da parte degli elettori francesi.
Questo “sciopero del voto”, che ha coinvolto il 61,5% degli iscritti, dimostra che la crisi politica in Francia, crisi che covava già dal 2012 e dalla rinnegazione europeista di François Hollande, e poi diventata crisi aperta dal 2013, non è ancora terminata. Gli incensatori di Emmanuel Macron e i propagandisti al soldo di “Republique en Marche” possono pure strombazzare in giro che con questa elezione si apre una nuova era. Ma sappiamo tutti che non è così. La società francese resta ancora spaccata in modo duraturo, a causa della disoccupazione, della disuguaglianza, del peso degli interessi delle grandi imprese e delle banche sugli ambienti politici e mediatici, ma anche a causa della crisi della scuola repubblicana, del modello di integrazione francese e del rischio terroristico. Di queste fratture ci ha dato un quadro più attendibile il primo turno delle elezioni presidenziali, che ha dimostrato come di fronte al campo del capitale – un campo che oggi si confonde con quello degli interessi “europeisti” – le diverse forze sovraniste nell’insieme potevano fare il loro gioco e ottenere la maggioranza.
Che futuro si prospetta?
Il grande rischio è di vedere il “paese legale” convincersi di avere tutti i diritti, e mettere in atto le riforme e le misure che aggraverebbero le fratture della società francese. Nei fatti questo rischio può assumere forme concrete differenti. La prima riguarda l’anomia, con una società che si disferebbe progressivamente sotto i colpi sempre più violenti che le vengono inferti, e frammenti di questa società che ricorrono alla violenza per cercare di far valere i propri diritti. Entreremmo allora in un mondo come quello di cui parla Hobbes, il mondo di una “guerra di tutti contro tutti”, con il più grande vantaggio – e la più grande felicità, si è costretti ad aggiungere – di quell’1% che ci comanda. La seconda strada, decisamente preferibile, vedrebbe i francesi unire le proprie forze contro le istituzioni occupate da una minoranza priva di legittimità, per far valere le proprie richieste. È stato questo l’appello rivolto domenica sera ai francesi da Jean-Luc Mélenchon.
Verso quale delle due forme di reazione penderà la bilancia è della più grande importanza. Ciò determinerà il nostro futuro. Bisogna quindi che le forze di opposizione, nel loro insieme, capiscano che non c’è soluzione possibile alla crisi politica se non nelle lotte collettive all’interno delle quali dovrà emergere, ancora una volta, l’idea del bene comune. Perché, e questo deve essere compreso da tutti, il “bene comune” non esiste al di sopra e al di là delle lotte sociali. Il bene comune va costruito all’interno di esse. Pertanto la nostra partecipazione alle lotte collettive sarà importante per definire il futuro che ci attende.
Allora e solo allora potrà essere trovata una soluzione alternativa a quello che alcuni colleghi hanno chiamato giustamente il “blocco borghese” o, più precisamente, il “blocco liberale”. Queste forze, senza rinunciare a ciò che costituisce la loro identità politica, dovranno capire che forme di unità sono necessarie, se un giorno vogliono veder trionfare le proprie idee.
Articolare “il” politico e “la” politica.
Questo implica una riflessione seria sui campi del politico e della politica. Il politico, come sappiamo, si definisce attraverso la contrapposizione tra amico e nemico. È lo spazio dei confronti antagonistici. Ma avere più avversari alla volta implica assumersi il rischio di essere sconfitti, soprattutto quando gli avversari sono a conoscenza del problema. La politica è invece lo spazio dei conflitti non-antagonistici, delle opposizioni e delle divergenze che possono legittimamente emergere tra le forze politiche, e che ad un certo punto dovranno essere risolte, ma la cui soluzione può passare temporaneamente in secondo piano rispetto ai confronti antagonistici prima menzionati. Chantal Mouffe ha definito questo lo spazio del “confronto agonistico”, secondo una distinzione che molti di quelli che si riferiscono al suo pensiero, ma evidentemente non lo hanno letto, farebbero bene a meditare.
Così, ci sono differenze importanti, persino radicali, tra i vari sovranisti, ma questo non dovrebbe impedire ai sovranisti di formare un fronte comune contro lo stesso avversario. È comprensibile che ci siano molti punti che in questi anni hanno contrapposto i militanti del Front National agli attivisti saldamente radicati nella sinistra di France Insoumise. Ci sono differenze nei punti di vista e nell’identità politica. Queste differenze continueranno a esserci anche nelle battaglie che si dovranno condurre. Ma gli uni e gli altri devono capire che queste differenze potranno essere espresse solo quando la sovranità del popolo, cioè la sovranità della Francia, sarà stata ripristinata. Ciò non implica affatto che le contrapposizioni che ci sono tra loro siano superficiali o poco importanti. Non lo sono, se si considera il campo economico, per esempio la questione fiscale.
Queste contrapposizioni ci sono, devono essere rispettate e sono legittime, in quanto rappresentano posizioni sociali differenti. Ma queste contrapposizioni non devono oscurare quella, al contrario irriducibile, tra i sovranisti e i loro avversari. Questo lo aveva capito Eric Dillies, candidato perdente del Front National per la circoscrizione Nord, dove è stato recentemente eletto Adrien Quatennens, candidato di France Insoumise. Eric Dillies aveva dichiarato a un giornale locale, la “Voce del Nord”: “Voterò per lui e ho invitato i miei elettori a seguire il mio esempio (…). Ho incontrato Adrien Quatennens ed è una brava persona. Di fronte a una maggioranza strabordante lui difenderà il popolo, non sarà uno yes-man” [1]. Eric Dillies è stato ascoltato dai suoi elettori e questo può aver contribuito al successo di Quatennens. Questo è un esempio di realizzazione della distinzione tra “il politico” e “la politica”, che i sovranisti dovranno imperativamente mettere in atto in futuro, se vorranno sperare di prevalere.
doppiozero, 11giugno 2017 (c.m.c.)
Dunque alla fine appena un pugno di voti (13,6 milioni contro 12,8) e un paio di punti percentuali (42,4 a 40) separano i Conservatives dal Labour. Anzi Theresa May da Jeremy Corbyn, perché nel bene (il secondo) e nel male (la prima) sono stati loro due a giocarsi la partita. Nemmeno lo sciagurato maggioritario secco inglese, che allunga in modo sproporzionato le distanze in termini di seggi (una sessantina in più al partito “maggiore” anche se di poco) stravolgendo il principio di rappresentanza, assicura una governabilità certa (mito di tutti gli aspiranti oligarchi). Il parlamento britannico rimane hang, “appeso” come si dice in gergo: in questo caso appeso all’alleanza con gli unionisti irlandesi del DUP (Democratic Unionist Party), che – se la May sopravviverà al voto di fiducia - sosterranno (“caso per caso”) il futuro governo conservatore come la corda sostiene l’impiccato, garantendogli con i loro 10 seggi una risicatissima maggioranza (di 2 voti).
Sono fondamentalisti protestanti, ultrareazionari, antiabortisti, omofobi (“right-populists” sono definiti), nemici degli human rights, secondo l’imprinting impostogli negli anni settanta dal fascistoide reverendo Paisley, che lo fondò (insieme alla propria milizia paramilitare) per opporsi strenuamente a ogni tentativo di soluzione concordata della questione irlandese. Non i migliori compagni di strada sul difficile sentiero della Brexit.
Ma quello che colpisce, della straordinaria giornata elettorale inglese, e soprattutto della notte che ne è seguita, è il generale rovesciamento di tutte le premesse (e di tutte le promesse). Nulla è andato come previsto all’inizio della campagna. Theresa May le ha “chiamate”, queste elezioni “fuori tempo” e non dovute, senza in realtà averne alcun bisogno. Stava seduta su una propria maggioranza - 330 seggi -, ma per un attacco di bulimia parlamentare ne voleva di più, “voleva tutto”, convinta di poter banchettare con i resti di un’UKIP a cui aveva rubato la bandiera e di poter sfondare su un Labour messo fuori gioco dall’"ingenua” leadership di un uomo considerato anacronistico. È finita a gambe all’aria, perdendo 12 seggi, la maggioranza parlamentare e anche la faccia. Si era giocata la campagna elettorale sullo slogan STRONG AND STABLE: è finita debolissima e totalmente instabile. Voleva affrontare gli “euro-oligarchi senza popolo” di Bruxelles armata di un plebiscitario mandato popolare per imporre manu militari la propria hard brexit. Si trova azzoppata, sola e soprattutto male accompagnata a dover affrontare i sorrisini ironici nelle stanze europee, e le andrà bene se alla trattativa ci arriverà, o se non verrà sostituita durante il suo corso.
Dall’altra parte Jeremy Corbin “il rosso”. Il vincitore morale. L’uomo “del miracolo”. Quello che all’inizio, quando il Labour era dato nei sondaggi sotto di 20-25 punti, tutti guardavano con neanche malcelato scherno, l’ "inadeguato”, il “perdente per vocazione”, l’"obsoleto” – magari simpatico nella sua innocenza ma votato irrimediabilmente al disastro suo e del partito che irresponsabilmente era stato chiamato a guidare -, e che invece li ha stupiti (e dimostrato stupidi) tutti. Ha guidato, in meno di due mesi, una rimonta che non ha precedenti nella storia elettorale, ricuperando giorno dopo giorno punti percentuali, a catena, fino a sfiorare il pareggio se non il sorpasso (cosa sarebbe successo se avesse avuto a disposizione un altro paio di settimane, visto il ritmo assunto dalla rincorsa negli ultimi giorni: in fine velocior). Ha guadagnato al suo partito 3 milioni e mezzo di voti in più rispetto alle elezioni del 2015 (Ed Miliband ne aveva presi 9,3 milioni). Ne ha aumentato il peso di 10 punti percentuali (dal 30% del 2015 al 40%, appunto: uno scatto in avanti paragonabile a quello compiuto nel 1945 dal Labour di Attlee). Ha riconquistato 30 seggi, salvando il posto in parlamento anche a un bel po’ di notabili del suo partito che l’avevano considerato con sufficienza e qualcuno anche tentato di sfiduciarlo per nostalgia blairiana.
E quanto a Tony Blair è bene ricordare (soprattutto ai suoi nostalgici, quelli che pensano che se ci fosse “ancora Lui” sì che le cose andrebbero diversamente…), che al suo ultimo mandato, nel 2005, non andò oltre i 9 milioni e mezzo di voti (3 milioni e passa meno di Corbyn) e vinse solo perché il suo competitor conservatore Michael Howard era peggio di lui e convinse solo 8,7 milioni di elettori (partecipò al voto allora solo il 61% degli aventi diritto, contro quasi il 70% di oggi).
Tra le tante possibili, due chiavi di lettura mi sembrano, a caldo, prioritarie. La prima è la “questione sociale”. O meglio la questione della società. Margaret Thatcher – la vera lady di ferro a cui la May si ispira – aveva dichiarato che “la società non esiste. Esistono solo gli individui”. Jeremy Corbyn, oggi, la smentisce. Rianimando, con il proprio programma aggressivamente “sociale”, una società non estinta ma costretta al mutismo dall’assenza di politiche adeguate, la rimette al centro della scena. Cambia il volto – o meglio lo scenario – della politica britannica. Riconfigura il discorso politico intorno ai suoi “fondamentali”, alla materialità dei suoi processi, anziché alla sua dimensione mediatico-virtuale.
La cifra del suo “inimmaginabile” successo (inimmaginabile per chi vive dentro la bolla virtuale del racconto prevalente) sta nella centralità assegnata nell’ordine del suo discorso ai bisogni, alle domande, al disagio diffuso della “propria gente” e di una parte ampia del proprio “popolo”. Nel suo ritorno a un’origine della sinistra moderna che non si è del tutto estinta ma solo atrofizzata: la vocazione a rappresentare la parte non privilegiata della piramide sociale, il mondo del lavoro e le classi medio-basse: la parte che ha subito il trentennio neo-liberale, che non è più stata né vista né raccontata e tantomeno rappresentata da nessuno in queste “trenta ingloriose”, e che ora ha ritrovato una voce e un “padre”. E’ rientrata, come espressione sociale, in gioco. E insieme ai “bisognosi” il vecchio Corbyn ha riportato in campo i giovani: sta al 66% dei consensi tra quelli sotto i 34 anni (quelli di classe media, acculturati e addottorati, ma anche quelli di periferia, di slum), parlando loro col linguaggio dei rapper arrabbiati, apparendo finalmente “vero” tra tanti avatar che popolano la terra straniera della politica per chi vive tra le pieghe e le piaghe del quotidiano.
Se è vero che il neo-populismo che si aggira come il vecchio spettro per l’Europa (e non solo), è la “forma informe del vuoto lasciato dalla sinistra nel passaggio oltre il Novecento” (e io credo che sia vero: è la tesi centrale del mio ultimo libro), allora bisogna dire che l’operazione inglese di Jeremy il rosso ne è il principale antidoto. È il fattore che può riportare la dialettica politica a un suo ordine conflittuale razionale, prosciugando quell’immenso serbatoio di un’ira non dilazionabile né riconducibile a costruzione di un’alternativa (tale è la sindrome populista, dall’incubo americano con Trump alla parabola dell’UKIP inglese fino al nazionalismo sovranista lepeniano in Francia).
Corbyn si prende quasi tutta Londra, l’area metropolitana dove il Remain aveva stravinto, le constituencies dei quartieri centrali (tranne quelli degli straricchi, soldi e status, come la City) e quelle dei sobborghi, compresi i più problematici dove la rabbia urbana si era orientata sul Leave). Vince nei distretti industriali del Galles, old working class anch’essa schierata per la Brexit, e a macchia di leopardo nelle midlands, tagliando a metà gli schieramenti referendari grazie al nuovo cleavage sociale chiamato a incrociare e neutralizzare quello neonazionalistico e identitario.
È quanto non ha capito la May, la quale invece ha fatto un mortale errore di calcolo quando ha voluto anticipare il voto pensando di potersi aggregare così, grazie alla sua linea hard sulla Brexit, tutto il voto Ukip, considerato espressione di un neo-nazionalismo asociale, o di una vocazione identitaria nazionale e neo-imperiale priva di radici e di motivazioni nell’assetto della società e nelle sue contraddizioni. Non è stato così: la radice “sociale” – il radicamento nel disagio e nella protesta per le proprie “condizioni materiali” del voto per il Leave – è riemersa e si è presa la propria rivincita distribuendo i voti in uscita dall’UKIP lungo la loro discriminante profonda, materiale, e convergendo non solo su un partito conservatore ultra-nazionalista ma anche su un partito laburista di nuovo socialmente rappresentativo e conflittuale.
Il che ci porta alla seconda chiave. Meno nettamente definibile, ma non per questo meno visibile. Non so bene come chiamarla: “Cognitiva”? “Intellettiva”? “Mentale”? Mi viene in mente un passaggio dell’ultimo libro di Luciano Gallino – un testamento, per certi versi – che mi colpì molto quando lo lessi: si riferiva ai due crucci che, in quel suo ultimo tratto di vita, lo tormentavano e che indicava come il “trionfo della stupidità” e la fine dello “spirito critico”. Il primo, soprattutto mi è tornato in mente, nella giornata e nella serata di giovedì 8 giugno, seguendo sulla BBC lo spoglio in diretta da Londra, ma anche sulla stessa rete l’interrogatorio di Comey a Washington, e – si parva licet – l’esito caotico del voto sulla legge elettorale a Montecitorio. Ovunque messaggi da “teoria del caos”. Perdita di controllo sugli eventi. Tendenziale entropia. E su tutto l’insufficienza – meglio, l’"inadeguatezza” – delle classi dirigenti, spinta fino all’autolesionismo.
Al suicidio neppur troppo assistito. Verrebbe da dire la “stupidità” delle classi dirigenti. Stupidità non in senso letterale, come deficit di QI (in qualche caso anche questo), ma in senso funzionale. Incapacità di comprensione strategica. Di misurazione delle conseguenze del proprio operare se non nel tempo brevissimo o istantaneo. Di previsione sistemica. Così è stato per Theresa May, ma allo stesso modo era stato per David Cameron, che aveva lui stesso indetto il referendum sulla permanenza in Europa che ha decretato la sua rovina; e per Matteo Renzi con la riforma costituzionale e il referendum che allo stesso modo di Cameron l’ha travolto (anche se lui a differenza dell’altro non è sparito dalla scena politica come aveva invece annunciato e promesso).
E così sta avvenendo con Donald Trump negli Usa, che prometteva un’America Great Again e che la sta portando nella peggior crisi istituzionale della sua storia. O per Hollande, che in cinque anni di Presidenza (apparentemente un punto di forza per un politico di mestiere) è riuscito a distruggere il proprio partito conducendolo all’irrilevanza. E l’elenco potrebbe allungarsi. In tutti questi casi quella che sembra prevalere è la figura che Alain Deneault (filosofo canadese dalla penna tagliente) ha definito lo “stupido funzionale” o come sintetizza nel titolo il “mediocre”: uno che fa tutto quello che sembra al momento giusto, perché così è richiesto dai suoi pari, e che però produce come risultato disastri (per sé e per gli altri).
“Non c’è stata nessuna presa della Bastiglia – scrive Deneault -, niente di paragonabile all’incendio del Reichstadt, e l’incrociatore Aurora non ha ancora sparato un sol colpo di cannone. Eppure di fatto l’assalto è avvenuto, ed è stato coronato da successo: i mediocri hanno preso il potere”. E quando parla di potere pensa a quello economico, banca e finanza soprattutto; a quello universitario (le pagine sulla degenerazione dell’universo accademico sono tanto più feroci quanto più espressione di un’esperienza vissuta); a quello giornalistico ed editoriale; oltre naturalmente a quello politico.
L’ambito in cui l’impatto della mediocrità in quanto “stupidità funzionale” è più devastante. Ed è il prodotto temo “sistemico” – dunque scarsamente contrastabile con misure di semplice restyling istituzionale o con settoriali “riforme” – di un fondamentale meccanismo della nostra vita pubblica: la sconnessione drammatica tra livello istituzionale e livello sociale. Per dirla con Carlo Galli, nel suo ultimo interessantissimo libro sulla Democrazia senza popolo, il fatto – terminale – che “le istituzioni stanno funzionando senza saper analizzare la realtà sociale (e quindi senza saperne risolvere i problemi) e anzi respingendola come un fattore di disturbo e cercando di sopperire con ‘narrazioni’ agli esiti disastrosi delle politiche che impongono”.
Si spiega solo così, con questa secessione dell’"alto” e del “dentro” (all’interno delle casematte del potere istituzionale ma anche mediatico) rispetto a tutto ciò che sta in “basso” e nel “fuori” (da quei cerchi magici che sembrano possedere il monopolio della validazione sociale), da una parte l’ostilità senza risposta, spesso il rancore, il deficit di rappresentanza che produce le tante “insorgenze” cosiddette populiste. E dall’altra parte la vacuità, l’inefficacia, la contraddittorietà e l’insensatezza del discorso “ufficiale”, delle “verità sistemiche” assunte dalle “sedi autorevoli” e propagate dai media mainstream ma puntualmente smentite dall’evolversi dei fatti.
La nostra memoria pubblica è corta, effimera, ma non più di un paio di anni fa, quando l’ondata giovane alle primarie del Labour aveva portato alla leadership Corbyn, il coro degli autorevoli si era scatenato, nelle forme più pittoresche: si andava dal “Corbyn … perderà a manetta” (Gianni Riotta) a “Al Labour piace perdere” (Matteo Renzi) fino al “Chi sarà più felice, Ken Loach o Cameron?” (Sergio Staino)… Tutti chiusi nel proprio involucro stagno, impegnati a confermarsi a vicenda nella damnatio imaginis dell’unico che da quella loro bolla stava fuori, e per questo poteva indicare una via diversa. Difficilmente rinunceranno a pontificare ancora. Ma più difficilmente potranno continuare a monopolizzare la comunicazione pubblica e impedire di “cercare ancora” uno spiraglio di alternativa.
Perché elezioni anticipate? E chi decide che debbano essere anticipate? È paradossale che non appena i maggiori partiti si sono accordati per darci una legge elettorale si sentono legittimati a mettere in circolo l’idea di andare a elezioni anticipate subito, appena dopo l’estate. Perché non aspettare la fine naturale della legislatura? Ha una qualche giustificazione questo anticipo? Ha la stessa giustificazione, di quella di colei che, comprando un cappotto in estate per approfittare dei saldi lo voglia indossare subito, proprio perché appena comprato.
Vannino Chiti su Huffington Post ha scritto con molta ragione a proposito della poca cultura costituzionale che anima gli attuali partiti. «Può darsi che sia fuori moda – scrive Chiti – ma per me il rispetto delle regole e della Costituzione resta fondamentale: non si può ridurre, in un accordo tra partiti, a quello di semplice notaio il ruolo del presidente della Repubblica. Spetta a lui fissare la data delle elezioni! Non si può, in incontri tra Forza Italia e Pd, stabilire il giorno di conclusione per l’approvazione della legge elettorale, dimenticando che spetta farlo alla Conferenza dei capigruppo convocata e diretta dal presidente del Senato. Oltre al 7 di luglio, è stata decisa anche l’ora?».
Gli attori politici di questa fase storica sono mediocri e deludenti, e la causa non è l’esito del referendum del 4 dicembre. Se fosse passato il Sì, i partiti non sarebbero per incanto diventati “partiti politici” propositivi e di buon conio; sarebbe restati esattamente gli stessi ma così ingombranti (quelli al governo, soprattutto) da poter permettersi di essere mediocri con protervia.
Oggi, che devono dimostrare sul terreno di essere forze politiche capaci nella loro diversità di avanzare proposte che siano diverse e capaci di produrre risultato, oggi, i partiti mostrano la loro pochezza, che cercavano di nascondere scaricando i problemi sulla Costituzione. Sono partiti “cartello” – cioè tutti loro prima di tutto istituzionali ed essenzialmente parlamentari – con addentellati sociali labili e spesso assenti, e con uno sforzo che è solo volto ad avere pubblicità, ma senza lasciar intendere ai cittadini-elettori quale prodotto offrono che non sia anche offerto dagli altri.
Il mainstreamismo è la malattia dei partiti apparato elettorale: loghi (non luoghi) simbolici e strutturalmente quasi inesistenti e leggerissimi, vuoti di idee-principi portanti che riescano a dare visibilità non solo ai loro leader e leaderini.
Nave dei folli, la Stultifera navis di Sebastian Brant. Sono stipati in uno spazio stretto, non sanno dove vanno; chi indica avanti, chi guarda indietro e chi a destra o a sinistra; altri sono inebetiti». la Repubblica, 6 giugno 2017 (c.m.c.)
Chi sa perché si debba chiudere la legislatura qualche mese prima della normale scadenza e votare in autunno? Se ce lo chiediamo, non sappiamo rispondere. Se lo chiedessimo, non avremmo chiare risposte. Infatti, non ci sono ragioni evidenti e, in mancanza, la stragrande maggioranza dei cittadini interpellati è per la prosecuzione fino alla scadenza naturale: c’è un governo, ci sono leggi importanti da approvare definitivamente, ci sono scadenze legislative importantissime da rispettare in materia finanziaria, ci sono rischi per la tenuta dei conti pubblici, ci sono apprensioni per le conseguenze di possibili violazioni dei parametri europei di stabilità finanziaria, per non parlare dei rischi della speculazione internazionale.
Vorremmo una risposta che riguardi non gli interessi di questo o quel partito in Parlamento e nemmeno di tutti o della maggior parte dei partiti, ma il bene del nostro Paese, quello che si chiama il “bene comune”. Nel nostro sistema costituzionale, a differenza di altri, non è previsto l’auto-scioglimento deciso dai partiti per propri interessi o timori. La durata prefissata e normale della legislatura (cinque anni) è una garanzia di ordinato e stabile sviluppo della vita politica.
La stabilità è stato il Leitmotiv invocato quando faceva comodo, anche quando si sono rese evidenti ragioni oggettive di scioglimento delle Camere, come dopo la dichiarazione d’incostituzionalità della legge elettorale, all’inizio dell’anno 2014.
Una risposta istituzionale non c’è. Ci sono anzi molta ipocrisia e reticenza che nascondono ragioni che sono, infatti, di mero interesse partitico. Da parte del maggior partito di maggioranza, il Partito democratico, si dice che votare in autunno o alla scadenza normale nella primavera dell’anno venturo non fa una grande differenza, ma poi si lavora forsennatamente a una legge elettorale nuova per andare al voto il più presto possibile.
Lo muove il desiderio del suo segretario e della cerchia che gli sta intorno di una rivincita dopo la sconfitta nel referendum del 4 dicembre? Oppure, il desiderio di fare piazza pulita degli oppositori interni, privandoli della candidatura alle elezioni? Oppure, la volontà di ostacolare, strozzando i tempi, l’organizzazione di forze concorrenziali a sinistra? Oppure, il timore di dover sostenere misure impopolari da “lacrime e sangue” in autunno, che farebbero perdere consenso e voti alle elezioni a scadenza normale? Oppure, perfino la volontà di non dover sostenere riforme importanti e da lungo tempo attese su diritti fondamentali, come quelle che questo giornale ha segnalato e continua a segnalare, riforme che potrebbero essere in dirittura d’arrivo ma col rischio di far perdere consensi tra porzioni dei suoi elettori (misure antimafia, riforme della giustizia, lo ius soli al posto dello ius sanguinis per la cittadinanza, il cosiddetto testamento biologico, il delitto di tortura, ecc.)? Dal Pd viene la spinta e gli altri partiti pro-elezioni anticipate si accodano per loro ragioni: chi perché pensa di poter subito incassare successi (M5Stelle, Lega), chi per rientrare in gioco (Forza Italia).
C’è pervicacia, ma se le ragioni sono quelle anzidette le si dovrebbe definire “interessi di bottega”. Al di sopra, ci dovrebbe essere l’interesse nazionale di cui custodi sono il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica. Né l’uno né l’altro hanno il potere di costringere qualcuno, se non vuole più, a sostenere il governo in carica, ma entrambi hanno almeno il potere di promuovere un chiarimento in Parlamento, prima di qualunque crisi di governo e di scioglimento delle Camere, e di chiamare i partiti ad assumere esplicitamente le loro responsabilità di fronte al Paese: “esplicitamente”, cosa in questa fase non facile per assenza di argomenti degni della posta in gioco ma, proprio per questo, doverosa.
Il voto anticipato s’intreccia con la nuova legge elettorale senza la quale, si dice, non si può votare. Poiché il voto è urgente, la legge è urgentissima. Tralascio le assurdità contenute nel testo iniziale, spiegabili in parte col voler continuare con i “nominati” e non con gli “eletti”, in parte con la cementificazione degli oligarchi di partito, in parte con la sfrenata fantasia creativa degli autori. Di questo s’è ampiamente scritto e detto e, del resto, ad alcuni dei macroscopici abusi sembra che qualche volenteroso voglia porre rimedio. Ciò che colpisce, sopra tutto, è che, pur di avere una legge, si rinnegano tante cose dette centinaia di volte nel passato recente: che non ci sarebbero più stati compromessi dopo le elezioni (gli “inciuci”); che “la sera stessa” si sarebbe saputo chi avrebbe vinto e governato per cinque anni, che il bipolarismo e l’alternanza erano dati acquisiti e che mai e poi mai si sarebbe ritornati agli obbrobri della prima repubblica.
Tutto questo era diventato quasi una questione di fede, ma in un lampo s’è dileguato. Anzi, si sente il contrario. Certo, proporzionale o maggioritario è questione opinabile e, infatti, le opinioni divergono. Ma, che si sia passati da un momento all’altro, senza una riflessione di merito, da ballottaggi e premi di maggioranza, cioè dalla logica maggioritaria, alla proporzionale, questo è piuttosto sconcertante e si spiega con la voglia di voto anticipato. Che cosa potrà accadere, se si potranno formare maggioranze e quali, se si dovrà tornare a rivotare, se si dovrà rimettere mano, ancora una volta, alla legge elettorale, tutto questo sembra interessare poco o nulla i partiti che chiedono elezioni subito. Vogliono cogliere il loro frutto. Poi si vedrà.
E pure, la legge elettorale non è solo un mezzo di realizzazione d’interessi immediati, ma è una prefigurazione del sistema delle relazioni politiche a venire e di questo si tace. Che cosa s’immagina? Di poter governare da soli? Se non da soli, con chi? Il dopo, naturalmente, è nelle mani degli elettori, ma questi avranno pure il diritto di sapere prima come sarà poi utilizzato il loro voto! Ma, sul dopo esistono sospetti, reticenze e, sulle ipotesi meno presentabili ai propri elettori, silenzi o tiepide smentite. Come potranno orientarsi gli elettori? Non è la stessa cosa se il Pd si prepara a una coalizione con Forza Italia, oppure con una qualche formazione alla sua sinistra; non è la stessa cosa se il M5Stelle è o non è disposto a collaborare con la Lega. Non si può trattare gli elettori come burini e considerare i loro voti come “bottino” o massa di manovra. Meritano altro. L’astensione diffusa dovrebbe essere presa in considerazione come un segnale di secessione interiore: un segnale ancora più forte a sentire i tanti, sempre di più, che dicono che a queste condizioni non sono disposti a votare ancora.
Sia consentito un accenno personale, che forse rispecchia uno stato d’animo anche d’altri. Guardo le convulsioni di questa fine-legislatura e non posso fare a meno di pensare alla Nave dei folli, la Stultifera navis di Sebastian Brant. Potrebbe essere istruttiva l’immagine che ne diede Albrecht Dürer per l’edizione del 1494. Sono stipati in uno spazio stretto, non sanno dove vanno; chi indica avanti, chi guarda indietro e chi a destra o a sinistra; altri sono inebetiti; uno è colpito da un pugno e cade in mare. Tutti hanno le classiche orecchie d’asino. Non c’è allegria. È un triste carnevale. L’unico che sembra divertirsi sta attaccato alla fiaschetta. La pazzia, però, è generale. Nessuno si preoccupa di dirigere la nave. Non c’è segno di consapevolezza del pericolo che incombe. Che un minuto dopo si possa affondare tutti insieme, non interessa a nessuno. Questa è la pazzia: stare o agitarsi ciascuno per proprio conto, girare in tondo, ciechi, senza connessioni, senza futuro. Credere di poter sopravvivere solo sopravvivendo.
S’avvicinano le elezioni e la frenesia sulla nave impazza. Nella poesia di Rimbaud, il Bateau ivre danza sui flutti, leggero come un tappo, ed è abbandonato alle correnti. Noi, invece, l’abbiamo tra noi e danziamo con lui.
 ».
».
il manifesto, 18 aprile 2017 (c.m.c.)
L’elezione di Donald Trump potrebbe costituire l’avvio di una profonda ristrutturazione degli schieramenti in campo: di quelli politici e di quelli dei loro supporters, che agiscono al di fuori della sfera politico-elettorale, ma che con i partiti in senso proprio hanno legami strettissimi: marciano divisi, per colpire uniti. Da un lato c’è uno schieramento che potremmo chiamare «globalista». Per esso la consegna del pianeta al mercato è giusta e inevitabile. In linea di massima questo è lo schieramento che al momento prevale alla guida delle democrazie sviluppate. Salvo aver alfine trovato un rivale assai temibile.
È ancora un’ipotesi: grazie a Trump di schieramenti se ne potrebbe costituire un altro, che potremmo denominare «sovranista», la cui struttura portante sarebbe fatta di quei partiti che ordinariamente vengono classificati come populisti. Secondo questo secondo schieramento il rimedio ai danni prodotti dai globalisti non consiste nel sottrarre spazi al mercato, ma nel restringere il mercato entro i confini nazionali, dandogli lì piena libertà di manovra. L’altra caratteristica dello schieramento sovranista sta nella sua capacità di strumentalizzare le sofferenze e le paure di una parte delle vittime dei globalisti, da esse traendo parte non secondaria del suo seguito elettorale.
Tra i due rivali, uno ben solido, l’altro in via di consolidamento, c’è più accordo che contrasto. Wall street non ha manifestato sofferenza dopo la vittoria di Trump. La Brexit non ha prodotto effetti sconvolgenti, e la borsa di Londra se la cava egregiamente. Se così fosse, sarebbe un’invenzione straordinaria: il capitalismo fa opposizione al capitalismo. Evviva il capitalismo! Divergono sui mezzi: l’uno considera lo Stato un ingombro, l’altro uno strumento. Forse è un conflitto ciclico nella storia del capitalismo. Quello che è verosimile è che i sovranisti non riusciranno a sfuggire dal labirinto di vincoli in cui i globalisti hanno cacciato le società occidentali e proveranno a mascherare il loro fallimento con un po’ di misure illiberali, antidemocratiche, razziste. Trump ha già cominciato. Anzi, ha fatto di meglio. Ha ripreso a bombardare, con tanto di motivazioni umanitarie. Non senza ottenere il plauso dei globalisti-liberali.
C’è forse qualche somiglianza con i contrasti che divisero negli anni 20-30 dello scorso secolo i fascisti da una parte dei liberali. Poi, allora, le cose evolvettero. I liberali presero le distanze, rinunciarono al liberismo, inventarono il New Deal, si appropriarono dell’interventismo statale fascista, ma lo rinnovarono radicalmente in senso democratico. Le analogie sono intriganti, ma non sono mai perfette e non vanno esagerate. Non sappiamo nemmeno come il contrasto tra globalisti e sovranisti evolverà. Potrebbe anche evolversi positivamente. I globalisti potrebbero, almeno alcuni, scoprire di aver esagerato e che l’involuzione autoritaria è troppo rischiosa. Vedremo. Come tutte le trasformazioni, anche questa è incerta.
Anche perché le resistenze non mancano. Negli anni 20-30 c’erano grandi partiti socialisti e comunisti, a volte brutalmente repressi, ma che rappresentavano un principio di resistenza. Oggi c’è resistenza, ma ha altre forme, giacché quei partiti hanno deciso di confondersi nello schieramento globalista. La resistenza attuale è spesso molecolare, disordinata, a volte apolitica: è disagio sociale, protesta locale, aggregazioni di corto raggio e breve durata, disordine d’ogni sorta.
Tra le forme più paradossali c’è persino il voto per i partiti populisti: che se per alcuni implica adesione, per altri è un voto di «odio». Li si vota perché non c’è di meglio, perché è il voto che reca più disturbo.
La resistenza dispersa non è una condizione inedita. Prima che nascessero i grandi partiti di massa, gli strati popolari erano classificati come classes dangereuses: erano le folle del 1789 del 1848, che i partiti socialisti promossero a classes laborieuses, dotate di un’identità e una soggettività collettiva, protagoniste di grandi cambiamenti.
È immaginabile un riorientamento analogo delle resistenze che caoticamente si manifestano di questi tempi? Non è facile. Una cosa era contrastare lo Stato e le imprese, un’altra rovesciare il mercato globale, gli evanescenti labirinti della governance sovranazionale e i bit della speculazione finanziaria. Eppure, vi sono segnali che lasciano margini di speranza. Il nemico è possente, globalista o sovranista che sia. Ma è possente perché i suoi avversari sono deboli. Ma fino a un certo punto.
Le grandi mobilitazioni sociali di carattere «universalistico» apparse dal 2011 non sono un incidente. Sono manifestazioni di una rivolta collettiva che ha indossato prima le vesti degli Indignados spagnoli e greci, di Occupy, di Gezi Park, della francese Nuit Debout e che poi ha avuto qualche non secondario sbocco elettorale. La rivolta movimentista e l’esodo elettorale dai partiti tradizionali sono a volte riusciti a intrecciare protesta politica e protesta sociale. Tra le vittime del nuovo ordine (o disordine) e le oligarchie cova un conflitto che evoca le grandi retoriche rivoluzionarie: la virtù contro la corruzione, il basso contro l’alto, i produttori contro i parassiti, il «popolo» contro la «corte» (oggi la «casta»). Va da sé che è tutt’altro modo di interpretare il conflitto «basso contro alto» rispetto a quello dei populisti-sovranisti. Nessuno che abbia seguito agisce oggi al di fuori di questa frattura.
Negli Usa la campagna di Sanders è stata fatta in gran parte da attivisti di Occupy, così come la campagna pro-Corbyn nel Labour. Podemos non sarebbe nato senza gli Indignados. Syriza ha vinto le elezioni dopo un lungo ciclo di mobilitazione sociale. Il governo più progressista d’Europa, quello portoghese, è una coalizione tra il partito socialista e partiti della sinistra radicale, resa possibile da un intenso ciclo di mobilitazione anti-austerity. In Francia Mélenchon cresce nei sondaggi anche sull’onda della Nuit Debout. Altre nuove forze di sinistra avanzano in Olanda e in Belgio. La resistenza molecolare prova a coagularsi. Non ci sono quindi alibi per la sinistra italiana: non è vero che nella crisi cresce solo la destra.
Forse il problema italiano è che questo spazio è stato occupato dai grillini, o è stato loro consegnato. Oppure che l’equivoco del Pd si è dissolto solo di recente.
Ma bisogna anche imparare dagli altri. Le nuove forze di sinistra, dove conquistano consensi importanti, non sono stanchi mosaici di ceti politici di lungo corso. Spiazzano, disorientano, agiscono come outsiders, quasi come alieni. Inventano nuove forme organizzative. E soprattutto ci credono, e spiegano a coloro cui si rivolgono che le attuali ingiustizie non solo non hanno niente di naturale e di obbligato, ma sono pure superabili. Purché lo si voglia.
comune.info, 10 aprile 2017 (c.m.c.)
La forma del discorso capitalista di Trump non dovrebbe sorprenderci. La novità è che rende palese ciò che normalmente il capitale occulta, mentre nasconde ciò che di solito viene esibito. Ma non ci sono novità di alcun genere nei fenomeni e nelle tendenze molto generali che affronta.
Il muro è un esempio calzante. Dal 1994 gli Stati Uniti hanno cominciato la costruzione di quello che si suppone li dovrebbe proteggerli dal Messico. Il progetto attuale di rinforzarlo e prolungarlo è soltanto un esempio suggestivo e folle della tendenza a costruire muri difensivi che costituisce una delle condizioni del mondo presente. Fino al 1989, quando cadde il muro di Berlino, c’erano solo 11 muri. Oggi sono 70, alcuni lunghi come quello fra gli Stati Uniti e il Messico: quelli che separano l’India dal Bangladesh e dal Pakistan sono rispettivamente di 3283 e 2900 chilometri. I muri europei sono più corti ma più efficaci. La barriera di sabbia nel Sahara Occidentale è il muro più lungo del mondo, dopo la Grande Muraglia cinese. Il muro più aggressivo e arbitrario è sicuramente quello di Israele. [ma la Grande muraglia è una strada prima di essere un muro- n.d.r]
La costruzione dei muri è una tendenza mondiale consolidata, che adotta diverse modalità fisiche e burocratiche. Definirà sempre più le modalità di relazione tra i paesi e al loro interno; la costruzione di muri all’interno delle città, che è iniziata da tempo, continuerà a estendersi. Certi muri, come quello della Corea o quelli dell’India, sono nati in circostanze particolari. La maggior parte di quelli costruiti di recente, tuttavia, ha un segno comune: si costruisce per proteggere i ricchi dai poveri. Si vorrebbe giustificare quei muri come si trattasse di barriere contro i migranti o protezioni contro il crimine, ma la loro ragion d’essere ha poco a che vedere con quei pretesti.
Negli anni Novanta, l’impoverimento continuo di settori sempre più ampi di popolazione che perdevano il lavoro o vedevano ridursi il salario, accentuò la contrazione dei mercati di prodotti e servizi. Per stimolarli di nuovo, il capitale fece ricorso a un sistema di credito impazzito, che condusse a livelli senza precedenti l’individualismo consumista e narcisistico già sviluppato in precedenza e sfociò nella crisi dell’autunno del 2008.
Anselm Jappe ha analizzato il fenomeno cinque anni fa in Credito a morte: la decomposizione del capitalismo e le voci critiche. Secondo Jappe, la tecnologia sta erodendo la base dell’esistenza stessa del capitalismo, cioè la perpetua trasformazione del lavoro in capitale e del capitale in lavoro: il consumo produttivo di forza lavoro e la valorizzazione del capitale, che definiscono la logica del modo capitalistico di produzione, si trovano in caduta libera verso il nulla come conseguenza inevitabile della trasformazione tecnologica.
Riflettendo su quel limite interno della produzione capitalista, i saggi contenuti nel libro parlano «dell’autodistruzione del capitalismo e del suo scivolamento verso la barbarie», così come delle reazioni ugualmente distruttive e barbare che tale decomposizione suscita. Secondo Jappe, l’evidenza del declino del capitalismo non conferma le critiche dei suoi avversari tradizionali. Al contrario, gli sembra che «gli antagonisti di una volta vadano a braccetto verso la stessa discarica della storia».
E’ necessario porsi per questo la questione dell’emancipazione sociale in un altro modo. Questa osservazione è forse la migliore negli scritti di Jappe, Kurz e Postone. Essi non prendono maggiormente in considerazione questo nuovo cammino verso l’emancipazione, ma dimostrano con chiarezza l’inettitudine dei modi tradizionali di analizzare, criticare e scontrarsi con il capitalismo. La maggior parte delle reazioni di fronte al discorso del capitale nella forma Trump, in Messico come in altre parti del mondo, illustra bene questa inettitudine.
L’altra faccia del muro è, paradossalmente, il “libero commercio”. La sua modalità attuale ha poco a che vedere con la tesi di David Ricardo che lo invocava in nome dei vantaggi comparativi, con il presupposto di una perfetta mobilità di tutti i fattori della produzione. Il suo obiettivo principale oggi è regolare il movimento delle merci e delle persone in funzione delle necessità del capitale. Per questa ragione il muro e il TLCAN (Trattato di Libero Commercio dell’America del Nord) sono le due parti della tenaglia che definisce la relazione tra gli Stati Uniti e il Messico. Come si è ripetuto per decenni, il TLCAN si è rivelato atroce per la maggioranza dei messicani, particolarmente nelle campagne. Non avremmo mai dovuto sottoscriverlo e da tempo avremmo dovuto abbandonarlo. Invece di approfittare della congiuntura per uscirne, con un gesto dignitoso, le classi politiche messicane si preparano a un nuovo disastroso negoziato che manterrà aperta la via alla barbarie, il che porta a muri e distruzioni.
Messo alle strette, il capitale non può far altro che ricorrere alla spoliazione continua e alla barbara distruzione sociale e della natura. Per questa operazione, ciò che resta della democrazia, quella forma politica del capitalismo, deve essere rimosso: l’unico modo di governare dall’alto, nelle condizioni attuali, è con una combinazione di paura e autoritarismo. E così, in modo cieco e criminale, classi politiche di ogni colore ideologico continuano a condurci verso la barbarie.
Si litigano tra loro il controllo relativo che ancora hanno sui dispositivi dell’oppressione e cercano di seminare l’illusione che la sostituzione di coloro che attualmente li guidano possa dar loro un altro senso. Lungi dal condurci all’emancipazione, prendere questa direzione ci condurrebbe ancora più a fondo nella barbarie attuale. Per questo sta diventando chiaro che la nostra speranza non può arrivare dall’alto. E per questa stessa ragione, aumenta ogni giorno il numero di quanti custodiscono questa speranza, perché non si raffreddi, nutrendola dal basso.
Fonte: la Jornada, Traduzione a cura di Camminar Domandando
la Repubblica, 3 aprile 2017 (c.m.c.)
Non è tutto immobile sotto il cielo riformista. Anzi. Il Pd sarà pure indietro nei sondaggi, porta al voto metà degli iscritti. Ma bisogna riconoscere che il dibattito fra i candidati copre un ventaglio di visioni ideali, e opzioni strategiche, che di per sé rappresenta una bella novità per la sinistra italiana: Renzi liberal-democratico che guarda a Macron, Orlando social-democratico rivolto a Martin Schulz, Emiliano che sembra prendere a riferimento i movimenti del Sud Europa, da Podemos a Syriza. Peccato per gli scissionisti, verrebbe da dire, si sono persi il meglio.
E tuttavia, rispetto a quei modelli, i nostri leader sembrano figli di un dio minore. Tutti e tre azzoppati in qualche modo. Per la Francia Macron incarna il nuovo (anche se è stato ministro dell’Economia), un’opzione liberale che la sinistra d’Oltralpe non ha mai conosciuto. Renzi l’Italia l’ha governata per tre anni: ha dispiegato un’azione riformatrice ampia e ambiziosa, ma non priva di tratti demagogici, e non è riuscito a tirar fuori il Paese dal declino; per giunta le riforme su cui maggiormente puntava sono state bocciate dagli elettori.
Anche se ha stravinto nei circoli, rispetto a Macron incarna qualcosa di già visto e già sentito. E uno sguardo alla sua mozione conferma quest’impressione: non ci sono novità dirompenti, se non un tentativo di inseguire i Cinque Stelle sui temi dell’identità nazionale o sul reddito di cittadinanza. Persino nella narrazione personale si avverte un po’ di stanchezza (il frequente richiamo alle cicatrici). E in quanto alle linee di continuità con il passato, dalla politica fiscale alla riforma amministrativa fino agli interventi per la scuola, dovrebbe spiegare l’ex premier perché dovrebbe riuscirgli di correggere domani — in uno scenario che si può immaginare assai più complicato — quel che non è riuscito a fare bene ieri.
Rispetto ai grandi movimenti popolari di Grecia e Spagna, che pure hanno contribuito a rinnovare la sinistra e a frenare — per davvero — il populismo di destra, a Emiliano manca la spinta della base. La sua è la mossa di un politico navigato, presidente di Regione, che dall’alto fiuta uno spazio di consenso: ma non incontra i movimenti, che da tempo guardano altrove. E non li incontra anche perché difetta pure, ammettiamolo, di credibilità personale: non intende rinunciare al posto sicuro di magistrato, come dovrebbe (il Csm ha aperto un fascicolo); dà l’impressione di lanciarsi con la rete di salvataggio e forzando pure un po’ le regole. Non proprio un buon viatico, per chi si erge a difensore della moralità pubblica.
Ma neppure Orlando ha la forza di Martin Schulz. Non tanto per demeriti, quanto per ragioni oggettive. Schulz si candida a correggere la politica di austerità della Merkel: quando propone un grande piano di ammodernamento infrastrutturale della Germania, si può ragionevolmente pensare che, se vincerà, manterrà la promessa. Orlando presenta una piattaforma socialdemocratica molto simile, probabilmente utile all’Italia: portare l’alta velocità al Sud, ad esempio; o interventi contro la povertà più incisivi di quelli pensati da Renzi (e comunque meglio calibrati delle proposte pentastellate). E tuttavia, non sappiamo se vi saranno soldi in cassa. Forse no, se da qui a un anno Draghi deciderà di rialzare i tassi. O magari sì, se in Germania dovesse vincere Schulz. Ma nessuno dei due scenari dipende da noi. Nell’attuale incertezza, i programmi di spesa — di tutti e tre i candidati — sono scritti sull’acqua. Meglio concentrarsi su altri interventi, ugualmente importanti per dare un senso della direzione di marcia, ma a costo zero. Sui temi europei Renzi e Orlando paiono in realtà equivalenti, al di là di qualche accento, come pure sulla formazione della classe dirigente (e questo è un miglioramento per Renzi).
Spetta però a Orlando la proposta più interessante per contrastare il declino: una «Iri della conoscenza», cioè un’agenzia sul modello tedesco che, mettendo a sistema le esperienze a oggi disperse, favorisca il trasferimento di ricerca e innovazione al mondo delle imprese, e promuova lo sviluppo di una cultura tecnologica in Italia. Può essere una buona idea, per un Paese che ha disperato bisogno di specializzarsi in settori più innovativi, se vuole mantenere i livelli di prosperità raggiunti.
Contrasta con una diffusa retorica, di matrice grillina o leghista ma che qua e là affiora anche nella mozione di Renzi, a favore di settori tradizionali e a più basso reddito, o di una vaga quanto mitologica genialità italica. La proposta è stata accolta da unanime disinteresse: forse il deficit, culturale e di classe dirigente, del nostro Paese va ben oltre il dibattito interno al Pd.
 ».
».
il manifesto, 2 aprile 2017 (c.m.c.)
La sicurezza non è di sinistra caro ministro Minniti. La sicurezza non è neanche di destra. Comunque non è questo il terreno su cui ragionare. Le Corti Supreme, italiana, tedesca, statunitense, ma anche la Corte europea dei diritti umani, hanno affermato come sia improprio un bilanciamento tra sicurezza e libertà.
La dignità umana, quale fondamento di tutti i diritti umani, è la chiave di soluzione di questa opposizione tra istanze di sicurezza e di libertà. Libertà, fraternità, uguaglianza, dignità umana, al limite felicità: sono queste le premesse fondative del vivere sociale. La sicurezza è l’esito naturale del pieno soddisfacimento dei diritti individuali, sia quelli sociali ed economici che quelli civili e politici. Il grande studioso Alessandro Baratta, i cui scritti sono certo che il Ministro Minniti ben conosce, affermava che al diritto alla sicurezza vada contrapposta la sicurezza dei diritti. L’indivisibilità e l’interdipendenza dei diritti umani non è soltanto un quadro teorico di riferimento ma è un programma di governo, anche in questi tempi difficili.
Ma sono veramente difficili questi tempi dal punto di vista della sicurezza? La sicurezza, vorrei ricordare al ministro degli Interni e a chiunque legifera senza tenere conto di dati veri e di statistiche vere, è comunque qualcosa di ben diverso dalla percezione di insicurezza.
Prima vicenda. Ristoratore spara al ladro che entra nel suo esercizio commerciale e lo uccide. Parte un dibattito folle intorno alla legittima difesa, causa scriminante prevista nel codice penale. Non ci interessano le strumentalizzazioni e le magliette di Salvini, scontate nella loro cattiveria. Ci interessa il dibattito più ampio, quello avvenuto sui media e nelle aule parlamentari. Va ricordato che la legittima difesa era sufficientemente ben definita nel codice Rocco di era fascista. La legittima difesa ha quale presupposto il principio sacrosanto di proporzionalità tra azione e reazione. La destra al governo, Lega compresa, modificò l’articolo 52 del codice penale nel 2006 poco prima delle elezioni che perderà. Venne così allargata la possibilità di reazione legittima ai casi di pericolo di aggressione. Oggi non si vede che altro possa fare il legislatore se non liberalizzare l’omicidio.
Avremmo auspicato che per la nostra sicurezza il Ministro avesse con nettezza interrotto questo dibattito affermando in modo categorico quanto segue: a) vanno cestinate tutte le proposte di modifica ulteriore della legittima difesa compresa quella in discussione del suo collega di partito Ermini che vuole allargare l’area della non responsabilità a ogni caso in cui si spara e ammazza «per errore di percezione a causa di turbamento psichico»; b) nel nome della sicurezza meno armi girano meglio è per tutti, ristoratori compresi. È compito del decisore politico con chiarezza e onestà intellettuale decostruire le paure e non assecondarle o alimentarle in modo strumentale e pericoloso; c) spetta allo Stato il monopolio della forza.
Nell’ultimo Rapporto sulla criminalità del Ministero degli Interni si legge che in Italia vi è stato un calo incredibile degli omicidi. Nel 1991 erano stati ben 1901. Tre omicidi ogni 100 mila abitanti. Nel 2015 sono stati 469, ovvero 0,8 ogni 100 mila abitanti. Lo stesso ministero degli Interni in modo onesto rileva che il top degli omicidi in Italia è stato nel 2013 a causa dei 366 immigrati morti in mare nel naufragio di quel tragico 3 ottobre. Dunque la vera emergenza sicurezza è quella legata alla vita dei migranti in mare, affrontata invece con norme di tutt’altro respiro dal ministro Minniti ovvero con la detenzione per stranieri irregolari e colpendo quelli che chiedono elemosina. In conclusione nessun attore istituzionale ricorda all’opinione pubblica che gli omicidi sono in calo e che negli Usa, dove si può comprare un’arma al supermercato e si può sparare facilmente, il tasso di omicidi è ben sei volte superiore a quello italiano.
Seconda vicenda. Un gruppo di ragazzi ammazza brutalmente un coetaneo ad Alatri. Si minacciano vendette, si intimidiscono gli avvocati difensori tanto da indurli a lasciare l’incarico. Si da la colpa al Gip che aveva scarcerato uno dei presunti responsabili per altri fatti legati alla violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti. Quel giudice in realtà aveva semplicemente e giustamente rispettato la legge. In questa vicenda tragica avremmo voluto che il ministro degli Interni avesse detto che: a) la legge sulle droghe è già fin troppo severa visto che un terzo dei detenuti in Italia è composto da persone che l’hanno violata; b) la custodia cautelare deve essere eccezionale; c) farsi vendetta da soli è brutale; d) chi minaccia un avvocato deve essere severamente perseguito; e) la difesa è un diritto sacrosanto; f) ad Alatri è scoppiata una grande questione sociale, esito di disastri prodotti anche da una progressiva dismissione pedagogica da parte delle nostre agenzie educative, compresi i partiti.
In questi giorni i talk show della Rai, di Mediaset e La7 si sono scatenati nel dare parola a finti esperti, urlatori professionisti, giornalisti che non conoscono la legge e le statistiche, demagoghi che ci fanno credere che viviamo in un paese invaso da criminali, spesso stranieri. Così abbiamo sentito dire da Gianluigi Nuzzi a Piazzapulita, a proposito dell’omicidio di Alatri, che a Tirana a 18 anni ti regalano una pistola. Bah!!!! Che c’entra Tirana con i ragazzi italiani accusati dell’assassinio? Sarà vero che a Tirana regalano la pistola? O è più vero che la pistola ti viene regalata nella provincia americana. Il conduttore di Piazzapulita (un titolo che non aiuta a rasserenare gli animi e a infondere dolcezza nella società) non fa fact checking ma lascia parlare Nuzzi come se fosse un esperto di politiche criminali.
Infine quando un magistrato come Angelo Mascolo di Treviso afferma (sempre che sia vero che lo abbia detto) che lo Stato non c’è più, e che lui darebbe la pistola pure a sua figlia, perché di fronte a una così grave delegittimazione delle forze di Polizia e della sicurezza il ministro Minniti non ha chiesto al suo collega Orlando di mandare gli ispettori in quel Tribunale affinché quel giudice sia sanzionato disciplinarmente?
 «Decreto sicurezza. Dietro il provvedimento, l'idea che la marginalità sociale presente nello spazio pubblico deturpi il decoro». il manifesto, 17 marzo 2017 (c.m.c.)
«Decreto sicurezza. Dietro il provvedimento, l'idea che la marginalità sociale presente nello spazio pubblico deturpi il decoro». il manifesto, 17 marzo 2017 (c.m.c.)
Il decreto Minniti, approvato ieri alla Camera e che di qui a breve sarà convertito in legge, propone un’idea di sicurezza secondo cui la marginalità sociale presente nello spazio pubblico deturpa il «decoro», disturba la «quiete pubblica» e attenta alla «moralità».
Di conseguenza, contro elemosinanti, clochard, venditori abusivi e consimili si decide di abbattere una scure di sanzioni molto aspre. Il provvedimento rilancia lo spirito del decreto Maroni del 2008, quando in nome di una guerra senza quartiere ai marginali d’ogni risma si tirarono fuori i sindaci sceriffi. Come già all’epoca, si agisce con decreto, ritenendo che sussistano i requisiti di necessità e urgenza. Al contempo però, con una certa schizofrenia governativa, lo stesso ministro Minniti, rispondendo al question time della Camera, dichiarava ieri un calo del 9,4% dei reati nel corso dell’ultimo anno. Tuttavia, aggiungeva il ministro, la percezione di insicurezza è aumentata. È alla percezione, ovvero alla pancia del paese, che risponde questo decreto. Il governo volta così le spalle al garantismo e prende la strada del populismo penale.
Come già per il decreto Maroni, è verosimile che la Corte Costituzionale dichiari illegittime numerose parti del provvedimento. Alcuni punti sono in effetti particolarmente critici: il potere dei sindaci, benché più contingentato di allora, appare ancora troppo ampio; e il cosiddetto Daspo cittadino prevede disuguaglianze nel trattamento. In sostanza il decreto dice, all’articolo 13, che il questore – il questore, si badi bene, e non il giudice – può vietare l’accesso a una serie di luoghi pubblici a chi negli ultimi tre anni è stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per spaccio; e si sa che spaccio è una categoria giuridica che nella realtà comprende molti semplici consumatori.
Qualora questo divieto fosse infranto, si potrebbero comminare multe che vanno dai 10 ai 40mila euro. Poi magari si verrà assolti in terzo grado, ma le sanzioni per essere andati laddove non si poteva e quando non si poteva resteranno sul groppone del malcapitato.
Il decreto, fra le tante cose, prevede che vengano multati e allontanati anche coloro che impediscono la libera fruizione delle stazioni, ovvero barboni e senzatetto, che proprio nelle stazioni usano chiedere l’elemosina e ripararsi dalle intemperie, poiché lì circola tanta gente e si può racimolare qualche soldo in più. Per questi si prevedono multe dai 100 ai 300 euro, che com’è noto non verranno mai pagate. Laddove poi queste persone non ottemperino all’ordine dell’autorità, come farebbe un barbone cacciato dalla stazione il giorno prima e tornatoci quello dopo, secondo l’articolo 650 del codice penale potrebbero essere portate in carcere.
Sulla scia di una cultura forcaiola propria della Lega, che infatti in commissione ha applaudito il decreto, il governo sembra mandare un messaggio alle forze dell’ordine, incoraggiandole ad adottare un approccio repressivo nei confronti di categorie già vulnerabili, ora anche indesiderabili.
* Associazione Antigone
« esce rassicurata dal voto olandese. Ma non del tutto». la Repubblica,
La diga olandese ha funzionato. Ha tenuto. La temuta ondata populista, islamofoba ed euroscettica, non si è abbattuta sui Paesi Bassi, rimasti fedeli alla tradizione cosmopolita e permissiva. I partiti democratici hanno conquistato la stragrande maggioranza dei 150 seggi del Parlamento. Ma la viscerale avversione per lo straniero non è stata estirpata del tutto dal voto di ieri.
Serpeggia nelle vecchie Province Unite, come nel resto dell’Europa. Il sentimento xenofobo non ha prevalso, ma non è diminuito. Anzi è cresciuto, sia pure leggermente e non come sperava Geert Wilders. Il quale sarà deluso dopo le tante promesse dei sondaggi. Il tribuno xenofobo avrà più deputati, 19 invece di 15. Il suo partito (della Libertà) ne ha guadagnati un numero troppo sparuto per alimentare sogni di governo. Il suo avversario, il liberal-consevatore, Mark Rutte, lo ha sconfitto perché il suo partito sarà più presente in Parlamento. Ma dei 41 seggi che aveva nella precedente assemblea ne ha conservati soltanto 31. La distanza tra Rutte e Wilders si è accorciata.
Wilders non parteciperà comunque al futuro governo, poiché nessuno lo vuole come partner, dovrà accontentarsi di vantare un più consistente numero di elettori. Non un successo, dunque, ma una speranza rivelatasi un’illusione. Per l’Olanda europeista è invece un segno di stabilità, perché i partiti che la difendono possono creare un loro governo. L’avanzata della sinistra ecologista contrapposta al modesto risultato dell’estrema destra è stato un fatto rilevante per l’Olanda e per l’Europa. Come è stata importante la grande affluenza, l’82 per cento, che non ha favorito come si pensava l’estrema destra.
Il biondo Geert Wilders, che nasconde sotto la capigliatura tinta i lineamenti ereditati da un’ascendenza indonesiana (da cui non sono escluse tracce musulmane) ha conservato, anzi rafforzato una base da cui difendere quella che chiama l’identità europea e cristiana. I forse vaghi legami con l’Asia non appartengono più alla sua memoria. L’Olanda è ospitale con gli uomini e con le idee. Ha accolto la Ragione: quando era perseguitata altrove. Le eccentricità non la turbano. La posizione di Wilders andrebbe riconosciuta come una libertà, se chi l’incarna non volesse chiudere le moschee, proibire il Corano e non chiamasse “canaglie “ gli immigrati marocchini.
Sull’elezione di ieri ha pesato la controversia tra l’Aia e Ankara. Il presidente turco prepara per il sedici aprile un referendum che dovrebbe conferirgli più poteri, e per questo ha bisogno anche dei suffragi dei turchi residenti all’estero. A questo fine ha mandato dei suoi ministri a tenere comizi nelle comunità turche in Europa. Il premier Mark Rutte ha impedito agli inviati di Erdogan di adempiere alla loro missione. Gli ha chiuso la porta in faccia. E Ankara ha reagito con una collera tale da far apparire il governo olandese un difensore della inviolabilità nazionale di fronte alla prepotenza dei turchi. Rutte ha svolto un compito gradito agli elettori sensibili ai richiami islamofobi di Wilders. Ed è probabile che gli abbia sottratto dei consensi.
L’ Europa esce rassicurata dal voto olandese. Ma non del tutto. L’ elezione di ieri ha rinviato la partita ai prossimi appuntamenti. Il populismo non è dilagato nelle pettinate pianure strappate al mare per ospitarvi quanto di meglio la nostra civiltà europea abbia saputo dare. Ma l’elezione di metà marzo ha rivelato quanto esso sia radicato in un paese in cui tanti profughi hanno trovato una patria. L’affluenza alle urne, a Rotterdam, a Amsterdam, all’Aia, a Utrecht, nella ricamata Delft, doveva darci un segnale. Dopo un 2016 con forti accenti populisti, prima la Brexit e poi l’avvento di Donald Trump alla Casa Bianca, volevamo sapere quel che ci riserva l’anno in corso, durante il quale sono in programma elezioni sia in Francia sia in Germania. La Francia vota tra poco più di un mese e le elezioni olandesi dovevano servire per misurare il livello populista in Europa. Ma Parigi non è l’Aia. Né è Berlino. L’esperienza populista continua.
 La nuova legge elettorale porrà alle vaganti sinistre problemi nuovi: è necessaria la ricerca non solo di identità ma anche di alleanze.
La nuova legge elettorale porrà alle vaganti sinistre problemi nuovi: è necessaria la ricerca non solo di identità ma anche di alleanze.
il manifesto, 16 marzo 2017
Molti protagonisti della scena pubblica stentano ancora a comprendere quanto profondamente cambierà lo scenario competitivo con l’adozione di un sistema proporzionale (quali che siano le varianti che potranno essere introdotte).
Cambia innanzi tutto il modo stesso con cui ciascuna forza si rivolge agli elettori. Agli elettori si dovrà dire: «Dateci più forza per sostenere le nostre idee», ma anche – ecco il punto – «per poter meglio contrattare un programma di governo», qualora – come è fisiologico che accada in una democrazia parlamentare – fosse necessaria una trattativa per la formazione di una maggioranza.
Un approccio totalmente diverso da quello del passato, che può modificare i comportamenti degli elettori rispetto a quelli attesi.
Ma anche una logica che potrebbe avere alcuni benefici effetti sulla qualità stessa del dibattito politico, permettendo che si torni a discutere nel merito delle scelte programmatiche e sulla loro compatibilità (così come comincia ad accadere in Germania, dove le posizioni di Schulz stanno aprendo nuove possibilità di dialogo con Die Linke).
Tutto ciò emerge chiaramente se guardiamo a quanto accade nell’area del centrosinistra. Dalle giornate del Lingotto, nulla è emerso circa la strategia del Pd: diverse ipotesi sono state fatte balenare, dalla coalizione “anti-populistica” aperta alle forze moderate fino ad alcune più o meno vaghe ipotesi di rilancio del centrosinistra.
Fallita la via del partito auto-referenziale che, grazie all’Italicum, poteva sperare di concentrare tutto nelle proprie mani, rimane un vuoto strategico: il Pd è privo di una qualsivoglia strategia coalizionale.
Lo schema di gioco neocentrista immaginato mesi fa (il corpaccione del Pd con due appendici a destra e sinistra) è saltato, grazie alla meritoria separazione della sinistra del Pd e grazie anche alle precisazioni che Pisapia ha introdotto nelle sue posizioni.
Questo vuoto strategico del Pd viene alimentato dall’incertezza sulla possibile riforma elettorale: si proverà a estendere alla Camera la possibilità di coalizioni, attualmente prevista solo al Senato?
E’ possibile che prevalga questa idea, così come è probabile che il Pd si batta per conservare la soglia del 40% per l’assegnazione del premio di maggioranza. Ma questa regola assumerà più che altro il valore di un possibile incentivo al “voto utile”: nessuno pensa che sia un tetto realisticamente raggiungibile. E molte cose potranno ancora accadere, nel Pd o intorno al Pd.
Se anche si tornasse alle coalizioni, come pensa il Pd di potersi attrezzare: inventandosi forse una “copertura” di comodo a sinistra? E non potrebbe invece accadere che debba essere superata quella identificazione tra segretario e premier, che Renzi, come se nulla fosse, ha presuntuosamente rilanciato?
Questo diverso scenario pone molti problemi anche per tutta la galassia a sinistra del Pd.
Sarebbe letale, per queste forze, se si pensasse che il “proporzionale” garantisca a tutti la coltivazione tranquilla del proprio spazio e che si possa fare a meno di costruire una qualche offerta politica unitaria e credibile.
Intanto perché superare una soglia d’accesso al 3% (o più alta, come attualmente quella del Senato) non è facile. Ma soprattutto perché anche con un “proporzionale” scattano particolari meccanismi che agiscono sul voto degli elettori. Solo una piccola parte di questi si accontenta di un voto di pura testimonianza: si vota molto più volentieri per una forza che sia consistente e, soprattutto, che possa “contare” nella dinamica parlamentare.
Se l’elettore di sinistra si troverà di fronte ad una sconfortante scelta tra tre o quattro liste diverse, è molto probabile che non ne scelga nessuna…; e anche quella quota di elettori del M5S che si dichiarano di sinistra saranno ben poco incoraggiati a cambiare opzione.
E’ bene, dunque, mettersi subito al lavoro: le elezioni non sono poi lontane, e i cartelli elettorali improvvisati all’ultimo momento sono poco credibili.
Occorre impiegare i prossimi mesi per costruire una strategia unitaria, coinvolgendo tutte le forze che stentano a riconoscersi in questa o quella sigla, e valorizzando le energie emerse durante la campagna referendaria.
Lo spazio per una forza ampia e radicata, “a doppia cifra”, c’è tutto. Ma, per questo, occorre anche un discorso politico netto: occorre proporsi come una forza che ridia voce ai valori della sinistra, che non si inchiodi a qualche formula astratta di coalizione, ma che non abbia alcun timore di proporsi come forza di governo; e che si metta in gioco, con le proprie idee e la propria autonomia, forte del consenso che gli elettori potranno dargli.
Non è più tempo per le battaglie di bandiera, o per la difesa di alcune ridotte di frontiera

Sbilanciamoci, 10 marzo 2017 (c.m.c.)
Festa grande alla fine del Carnevale. Razzi, scoppi e mortaretti per la clamorosa notizia: il Pil del 2016 è cresciuto non dello 0,8%, secondo le ultime previsioni del governo (dopo varie revisioni al ribasso), ma addirittura dello 0,9%. Un trionfo. E per quest’anno forse si potrebbe persino raggiungere l’1%, un altro decimale in più (ma mica è scontato). Avanti così, e forse tra un’altra decina d’anni riusciremo a tornare dove eravamo prima del 2008, sempre se non arrivano altre crisi. Insomma, un futuro luminoso.
Ma anche sul breve termine il governo non ha tanto da stare allegro. Non tanto per i 3,4 miliardi che la Commissione Ue ci ha imposto di trovare subito come condizione per approvare i conti di quest’anno: quello è solo l’antipasto, perché per il 2018 c’è da coprire un’altra di quelle clausole di salvaguardia che vengono dalle manovre passate, e lì son dolori, perché si tratta di quasi 20 miliardi. Per la precisione, secondo i calcoli di Nens, sono 19,571 miliardi, e per coprirli, se non si provvede altrimenti, aumenterà l’Iva di tre punti - dal 10 al 13 e dal 22 al 25% - diventando la più alta in Europa.
L’aumento dell’Iva è sempre stato paventato come una catastrofe quasi pari a un terremoto o un’inondazione. Certo, non è una bella cosa. Certo, sarebbe un nuovo aumento del prelievo fiscale, per giunta con un’imposta regressiva, cioè che colpisce tutti indistintamente. Certo, non farebbe bene ai consumi, che “fanno” due terzi del Pil. E però ha anche l’effetto di favorire i prodotti nazionali, perché colpisce le importazioni e non le esportazioni. Se proprio bisogna trovare quei soldi, meglio l’aumento dell’Iva o meglio altri tagli al welfare o agli investimenti, quei pochi che sono previsti? Uno potrebbe dire: meglio tassare i ricchi. Ma – a parte che la cifra è cospicua – chi lo dicesse sarebbe subito tacciato di populismo, se non di bolscevismo fuori tempo. Renzi, peraltro, aveva detto che nel 2018 le tasse le voleva ridurre: francamente non sembra aria.
Comunque una manovra da 20 miliardi, che siano tagli o nuove tasse, peserà in ogni caso sulla nostra già anemica crescita, mettendo a rischio persino quel già misero 1%, che infatti alcuni previsori – da ultimo il rapporto di Standard & Poor’s – giudicano un obiettivo difficile. E però lasciar correre il deficit non si può: la Commissione ci ha appena contestato uno sforamento dello 0,2%, figuriamoci uno di quasi l’1,2%, al di fuori di qualsiasi ipotetica “flessibilità” delle regole, che peraltro ci hanno già detto che abbiamo sfruttato al massimo possibile.
Ci avviamo dunque verso la fine del quantitative easing, che tiene a bada tassi e spread facendoci risparmiare bei soldoni di interessi sul debito, con questo peso da sopportare, e non è il solo: non possiamo certo dimenticare il problema delle sofferenze bancarie, tutt’altro che risolto. Il tutto in una situazione politica quanto mai incerta, con all’orizzonte elezioni che – anche se si arriverà alla scadenza naturale della legislatura – potrebbero provocare una situazione in cui sarà problematico formare una maggioranza di governo.
Ma chi ci ha ficcato in guai così grossi? La maggior parte delle persone, come spesso accade, si divide in due partiti. I Guelfi, quelli che sono contro l’impero, non hanno dubbi: la colpa è dell’Europa egemonizzata dalla Germania, della politica di austerità, dell’euro che ci impone una moneta sopravvalutata. I Ghibellini, quelli che stanno con la Svevia (antica regione tedesca), alzano gli occhi al cielo con aria di rancoroso compatimento: niente affatto, la colpa è dei governi italiani, che non hanno sfruttato il lungo periodo di bonaccia dall’inizio dell’euro allo scoppio della crisi per aggiustare i conti (e questo è vero: grazie Berlusconi) e poi non hanno fatto le riforme (mitiche!), o non ne hanno fatte abbastanza. Chi ha ragione? Purtroppo, entrambi i partiti.
Cominciamo dall’Europa. Se ne può dire tutto il male possibile, e ancora non basta. Tralasciamo il problema di fondo, cioè che è stata costruita male, che non è certo un dettaglio. Ma oltre a questo, fin dallo scoppio della crisi si è fatto di tutto per non risolverla, e anzi aggravarla. Ricordiamo che all’esplosione del caso greco la Germania ha impedito che fosse affrontato tempestivamente, perché il suo obiettivo – riuscito – era mettere in piedi quel meccanismo che ha trasformato i debiti greci con le banche tedesche e francesi in crediti verso la Grecia di tutti i paesi Ue, (http://clericetti.blogautore.repubblica.it/2015/02/23/i-furbetti-del-salvataggio/ ) che hanno così contribuito – mentre la situazione si incancreniva e si scatenava la speculazione sui debiti pubblici – a salvare quelle banche. Poi l’imposizione della politica di austerità mentre la congiuntura recessiva avrebbe richiesto il contrario, cioè stimoli fiscali all’economia, e l’uso delle aggravate difficoltà dei paesi del Sud Europa per imporre riforme (http://nuke.carloclericetti.it/AlsosprachMerkel/tabid/340/Default.aspx ) che riducessero le garanzie dei lavoratori. In piena recessione venivano varati il Six pack, il Two pack, il Fiscal compact, che imponevano un sentiero di consolidamento dei conti pubblici che avrebbe perpetuato la politica di austerità (il cosiddetto “pilota automatico”, teso a ridurre al minimo la discrezionalità delle scelte dei governi).
Non basta. Le verifiche sul rispetto del percorso di consolidamento della finanza pubblica sono fatte dai tecnocrati della Commissione con una metodologia assurda (http://nuke.carloclericetti.it/LinkClick.aspx?link=501&tabid=36 ) e ideologicamente orientata, basata su una grandezza che è frutto di stime arbitrarie, il “Pil potenziale”, che si potrebbe descrivere con la filastrocca dedicata all’Araba fenice: «Che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa». E in base a questa metodologia fantasiosa, che l’Italia ha contestato (http://clericetti.blogautore.repubblica.it/2014/10/17/finalmente-litalia-contesta-un-po-la-ue/ ) – troppo tardi – senza ottenere il minimo risultato, si chiedono ogni anno sacrifici veri, tagli di spesa o aumenti di tasse.
L’elenco potrebbe continuare con i tanti “no” che rendono la costruzione europea ancor più sbilenca che negli anni passati. “No” alle tante proposte per risolvere la questione dei debiti pubblici, anche a quelle che non prevedono trasferimenti di risorse tra paesi (http://nuke.carloclericetti.it/IlPADRE/tabid/348/Default.aspx ); “no” alla garanzia comune sui depositi, che pure era nei patti dell’unione bancaria; “no” ai limitati interventi statali per le nostre banche, dopo che gli altri (Germania in testa) hanno salvato le loro con miliardi pubblici a palate; “no” a una politica europea di investimenti, a meno di non voler considerare tale il ridicolo Piano Juncker (http://nuke.carloclericetti.it/Junckerunannodopo/tabid/410/Default.aspx ), di cui si sono ormai perse le tracce. Gli ultimi anni dell’Unione, dal 2008 in poi, sono un vero e proprio racconto dell’orrore.
Non spendiamo altre parole sulle infinite colpe dell’Europa a guida tedesca. Ma veniamo alle nostre, di colpe, che non sono poche. La più grande è stata quella di accettare tutto, la gestione della crisi, i trattati sulla finanza pubblica, i metodi di calcolo, il tipo di riforme che ci sono state chieste, le norme sul bail-in. A volte con entusiasmo, come per la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio che non era obbligatoria (e infatti quasi nessun altro l’ha fatto); a volte senza fiatare; altre volte, infine, con proteste o tanto flebili da non essere prese in considerazione (la metodologia del Pil potenziale, l’entrata in vigore immediata del bail-in) o rumorose ma di facciata, come quelle dell’ultimo periodo di Renzi, e per giunta su obiettivi il più delle volte sbagliati: pietire la “flessibilità” per il bilancio significa accettare implicitamente tutto lo schema entro cui questa “concessione” si colloca, quello schema che appunto andrebbe invece contestato con tutti i mezzi politici e procedurali disponibili.
Quel poco di gestione discrezionale della politica economica che ci è rimasta, poi, non è andata meglio. Sorvoliamo sui governi Monti e Letta, fedeli esecutori della linea di Berlino-Bruxelles. Renzi, invece, con l’idea di assicurarsi un consenso plebiscitario, quella linea l’ha stirata per tutto quel che ha potuto, e dall’Europa ha ottenuto margini non indifferenti, 19 miliardi di “sforamenti” rispetto ai conteggi “ortodossi”. Fra il 2014 e il 17 – ha calcolato il Rapporto sulla finanza pubblica del Mulino – ha speso 50 miliardi (10 finanziati con nuove tasse).
Una cifra ancora non sufficiente per un vero rilancio della nostra economia, ma che avrebbe potuto dare risultati ben più apprezzabili se fosse stata impiegata bene (http://nuke.carloclericetti.it/Flessibilit%C3%A0Nograzie/tabid/478/Default.aspx ). Invece ha dato risultati miseri perché si è seguito il pensiero economico dominante: non investimenti pubblici, perché lo Stato deve tenersi alla larga da interventi diretti: ma tanti soldi alle imprese (i due terzi del totale) perché così avrebbero ricominciato ad investire, e il resto in tasca ai consumatori (gli 80 euro, la girandola dei bonus) che così si sarebbero gettati a comprare svuotando i magazzini delle aziende. Naturalmente nulla di tutto questo è accaduto: le imprese non investono quando la domanda è stagnante, i consumatori spendono poco quando i salari sono bassi, la disoccupazione alta, il futuro incerto. Ed eccoci ancora con la crescita allo zero-virgola, fanalino di coda in Europa.
Insomma, l’Europa ci è matrigna, e noi ci abbiamo messo del nostro. Il quadro è disperante, il futuro non promette niente di buono. Soprattutto, non si vede una classe dirigente capace di prendere in mano la situazione e imprimere la sterzata che sarebbe necessaria. Forse è un discorso da gufi, ma doverlo fare non è certo una soddisfazione.
 «Nel Libro Bianco del presidente della Commissione europea per la prima volta viene avanzata l’idea che in tema di costruzione europea l’Unione possa anche fare dei passi indietro».
«Nel Libro Bianco del presidente della Commissione europea per la prima volta viene avanzata l’idea che in tema di costruzione europea l’Unione possa anche fare dei passi indietro».
Sbilanciamoci.info, 9 marzo 2017 (c.m.c.)
Che il progetto dell’Unione Europea sia da tempo in una crisi profonda non è certo una questione controversa. I sintomi del male sono chiari: basti ricordare il crescente euroscetticismo che si va diffondendo dovunque e l’attacco quasi quotidiano, da parte dei rappresentati politici di molti paesi, verso Bruxelles.
Per parte nostra, su di un piano politico, ricordiamo come l’Europa si sia intrappolata in una deriva tecnocratica e neo-liberista, con la corsa all’austerità, le svalutazioni “interne” e le cosiddette riforme “strutturali”, i favori ai paradisi fiscali, il taglio dei bilanci comunitari, l’assenza di politiche di sviluppo.Semmai oggi le incertezze planano sul che fare di fronte a tali minacce e a tali problemi.
Alcuni progetti di riforma
Negli ultimi mesi si vanno elaborando da diverse parti dei progetti di riforma su tutta o su una qualche parte della costruzione europea. Meraviglia semmai che esse non siano poi troppo numerosi, né che il dibattito in merito si presenti come molto vivace, o di livello adeguato, sintomi forse anche questi di una crisi profonda del progetto europeo.
Intanto c’è questa proposta della Merkel mirante ad un’Europa a più velocità, idea sufficientemente vaga per dare adito a diverse possibili interpretazioni; sempre in Germania, invece, Schultz, che comunque è d’accordo su questa ipotesi della cancelliera, vuole peraltro chiudere con la politica di austerità, da lui considerata come una delle cause fondamentali della crisi e vuole invece introdurre gli eurobond per migliorare le prospettive delle economie indebitate.
Ad un summit tenutosi a Versailles il 6 marzo, anche Francia, Italia e Spagna si sono dichiarate d’accordo con l’idea della Merkel, anche se temiamo che ogni paese, utilizzando l’espressione, pensi a cose almeno in parte diverse da quelle degli altri.
D’altra parte, si va discutendo di portare avanti la costruzione europea mettendo in comune in tutto o in parte il settore della difesa; ma non ci sembra poi una grande idea quella di rilanciare il progetto cominciando proprio da lì. Eccellono nell’esercizio pan-militare i governi italiano e francese.
Va ancora segnalato che il parlamento olandese sta avviando una commissione di inchiesta per valutare i pro ed i contro del mantenimento del paese nell’eurozona (Barber, 2017). Trattandosi di uno dei sei paesi fondatori della costruzione europea questo non appare certo un bel segnale.
Per quanto riguarda l’Italia, hanno destato un certo clamore le conclusioni a cui è giunta una ricerca della società Macrogeo, una creatura di Carlo De Benedetti, che da per scontata una chiusura dell’esperimento europeo e l’emergere invece di un polo mega-tedesco, cui farebbero capo paesi quali l’Olanda, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, alcune realtà scandinave ed eventualmente il Nord dell’Italia, che così si staccherebbe dal resto del paese.Come si vede il livello di confusione appare piuttosto elevato.
Le dimissioni di Juncker
Juncker aveva già fatto parlare di se qualche settimana fa, quando sembrava che egli fosse sul punto di presentare le dimissioni dalla carica, essendo la Commissione al crocevia di una serie di contraddizioni difficilmente sanabili. Egli ha apparentemente poi cambiato idea. Ricordiamo, a proposito dei problemi che egli può avere incontrato a Bruxelles negli ultimi tempi, solo un episodio che riguarda il nostro paese. La Commissione, ponendo molte speranze nelle promesse di rinnovamento del governo Renzi, aveva allentato le briglie sui conti dell’Italia per ben 19 miliardi di euro; col risultato di ricevere in cambio degli insulti dal capo del governo della penisola, che voleva ottenere ancora di più, ma contemporaneamente anche gli attacchi della Merkel, che gli ricordava come lo stesso Renzi avesse poi utilizzato le concessioni della Commissione per il varo di misure quali l’abolizione dell’Imu sulla prima casa e il versamento di denaro ai giovani per permettere loro di comprare i biglietti per il cinema.
Il libro bianco
In questo clima si colloca il cosiddetto “libro bianco” del presidente della Commissione, reso pubblico ai primi di marzo e presentato come un contributo della stessa Commissione al dibattito sull’avvenire dell’Unione. Il testo dovrebbe essere dibattuto al summit di Roma del 25 sempre di questo mese, quando sarà celebrato il 60° anniversario del trattato di fondazione dell’Unione.
Ricordiamo che il testo sarà completato da qui all’estate da cinque rapporti specifici, che esploreranno “l’avvenire dell’Europa sociale”, “le risposte alla globalizzazione”, “le vie per l’approfondimento dell’unione economica e monetaria”, “la difesa” e “la finanza”.
Le trenta pagine del fascicolo appena pubblicato presentano cinque possibili scenari.
Il primo è quello che l’Unione si limiti al solo mercato unico. Il libro bianco sottolinea i lati negativi dell’ipotesi, quali la perdita della libertà di circolazione, i pericoli per la stabilità finanziaria, la riduzione di status e di peso internazionale dei vari paesi europei e di tutto il continente.
Lo scenario più ambizioso propone invece un’Europa federale. Ma l’ipotesi non appare in sintonia con l’aria del tempo ed essa viene valutata come oggi politicamente non credibile.
Il terzo scenario è quello dello status quo, linea chiaramente aperta a grandi criticità, gran parte delle quali conosciamo bene già adesso, ma che sarebbero presumibilmente destinate ad aggravarsi nel tempo.
Restano i due ultimi scenari.
Il primo rilancia l’idea della Merkel, ormai appoggiata dagli altri grandi paesi dell’Unione, di un’Europa a più velocità. Le politiche comuni attuali e qualcuna di quelle future rimarrebbero per tutti i paesi, ma alcuni di essi potrebbero decidere di andare più avanti, caso per caso, come nella difesa, nella giustizia, nel diritto commerciale, nell’armonizzazione fiscale.
L’ultimo scenario, possibilmente complementare a quello precedente, vedrebbe l’Unione restituire ai singoli Stati alcune competenze oggi collocate a Bruxelles. Si tratterebbe di “fare meno ma meglio”, in tema ad esempio di politiche regionali, nonché di parte delle politiche sociali e dell’occupazione, delineando anche soltanto degli standard minimi su altri soggetti, come ad esempio la protezione dei consumatori e gli standard sanitari.
Va in proposito segnalato che è la prima volta che qualcuno suggerisce il principio che in tema di costruzione europea si può anche arretrare.
Parallelamente, invece, si dovrebbe andare più avanti su alcuni grandi dossier politici ed economici, quali la politica dell’innovazione, il commercio estero, i migranti e il diritto d’asilo, la protezione dei confini, la difesa. Ai maggiori poteri in alcune aree dovrebbe poi anche corrispondere il potere di implementare direttamente da parte di Bruxelles le decisioni collettive una volta prese.
Pur senza avanzare preferenze nette, comunque il documento suggerisce che sarebbero le due ultime opzioni quelle preferite.
Conclusioni
Come capo della Commissione, in presenza dei gravi problemi già prima ricordati, nonché della scadenza del 60° anniversario dell’Unione, della pendenza della Brexit e infine delle supposte minacce che pongono oggi gli Usa di Trump e la Russia di Putin, Juncker non poteva certo mancare di fare il punto sulla situazione e di aprire ufficialmente il dibattito.
Peraltro il suo approccio, pur con qualche spunto positivo, non ci appare complessivamente molto convincente e comunque esso fa intravedere una risposta molto debole di fronte ai problemi che si pongono.
Si può ricordare, tra l’altro, che negli ultimi anni molti studiosi ed operatori hanno elaborato delle idee e pubblicato delle ricerche che affrontano il problema in maniera anche molto approfondita. Di tutte queste analisi nel libro bianco ci sembra che non ci sia sostanzialmente traccia.
E’ vero che come presidente della Commissione Juncker non può imporre ai vari Stati le sue idee, ma comunque uno sforzo maggiore poteva, a nostro parere, essere fatto non solo a livello di analisi, ma anche di proposte.
Al di là di questo, entrando brevemente nel merito di quello che nel documento manca, ci sarebbe, tra l’altro, bisogno di attenzione ad una maggiore giustizia sociale ed economica, di andare inoltre verso la cancellazione delle politiche di austerità, di avviare grandi investimenti pubblici verso l’economia verde, le nuove tecnologie e la riduzione delle diseguaglianze tra paesi, in vista anche della messa a punto di un modello sociale europeo. Per non parlare della necessità di rinnovare la macchina organizzativa di Bruxelles, oggi tra l’altro facile preda di tutte le lobbies, come mostra in questi giorni il caso dei glifosfati e di cambiare alcuni principi di funzionamento, come quello dell’unanimità.
Ma di tutto questo nel documento non c’è traccia. Il progetto europeo, se si baserà sulle sole ipotesi del libro bianco, non sembra presentare motivi di entusiasmo.
Più in dettaglio, ad esempio sul piano sociale Juncker aveva dichiarato nel 2014 «…io vorrei che l’Europa avesse la “tripla A” sociale, altrettanto importante della “tripla A” economica e finanziaria…» (Ducourtieux, 2017). Ma la realtà non appare certo in linea con tali dichiarazioni. Per il vero, l’8 di marzo si è tenuto un “vertice sociale tripartito”, tra i dirigenti dell’Unione, i rappresentanti del padronato e quelli dei sindacati europei. Ma si è trattato, come al solito, di un dialogo tra sordi. La Commissione prepara inoltre per il 26 aprile la pubblicazione di una piattaforma europea dei diritti sociali, ma sono in pochi ad aspettarsi qualcosa da tali sforzi (Ducourtieux, 2017).
Testi citati nell’articolo
-Barber T., Europe starts to think the untinkable : breaking up, www.ft.com, 2 marzo 2017
-Ducourtieux C., L’Europe a bien du mal à prendre l’accent social, Le Monde, 8 marzo 2017
 A proposito della difesa della lingua italiana e di alcuni casi recenti. Una cosa è combattere l'imperialismo linguistico (strumento d'un più sostanziale imperialismo politico), altra cosa è difendere la coesistenza di lingue e culture diverse. Con riferimenti
A proposito della difesa della lingua italiana e di alcuni casi recenti. Una cosa è combattere l'imperialismo linguistico (strumento d'un più sostanziale imperialismo politico), altra cosa è difendere la coesistenza di lingue e culture diverse. Con riferimenti
Ci sembra che la questione posta dal recente articolo di Ainis (la Repubblica, 8 marzo) , e da altri difensori della lingua italiana, vada inquadrata in un panorama un po' più ampio, tenendo conto che la questione linguistica è sempre collegata molto strettamente a quella del potere. I due episodi citati da Ainis (quello milanese e quello altoatesino) esprimono situazioni e suscitano riflessioni molto diverse, sebbene anche legate tra loro.
Il primo episodio, quello del Politecnico di Milano è sintomo e conseguenza del sistema di potere che il mondo anglosassone (ma in particolare gli Stati uniti d'America), ha costruito da molti decenni. Precisamente da quando la “Dottrina Truman” (1947), proclamata in coincidenza con la rottura dell’unità antifascista, trasformò rapidamente Washington nella capitale di un Impero mondiale.
Il consolidamento della lingua anglosassone come dominante nell’economia capitalistica fu una delle tante conseguenze del nuovo assetto dei poteri nel pianeta. Esso si sviluppò poderosamente con la nuova forma del regime economico, ideologico e sociale del capitalismo: il neoliberisno (o, nell’accezione anglosassone del termine, il “neoliberalism”). Noti sono ai nostri lettori i momenti e gli strumenti rilevanti nel percorso impresso alla globalizzazione dal potere dominante, sa sul piano della teoria che su quello delle azioni concrete nei gangli del potere reale.
Si tratta delle teorie elaborate e delle azioni condotte dalla della Mont Pèlerin Society (1947) e dalla Trilateral Commission (1973). Si tratta, sul piano gli eventi storici, dell’allineamento della Cina di Deng Xiaoping alle pratiche del capitalismo (1982), e del crollo del capitalismo di Stato dell’Unione sovietica, simbolicamente espresso dall’abbattimento, da parte del governo comunista, del Muro di Berlino (1989). Tutto ciò contribuì a realizzare un modello di società nella quale - in tutte le sfere in cui si dovevano o volevano scambiare nozioni e azioni in aree non localistiche - il trionfo della lingua anglosassone era l’inevitabile conseguenza.
Bolzano e il Sudtirolo
Un’altra storia è quella raccontata dall’esperienza bolzanina. Molti hanno dimenticati come si giunse all’assetto politico-amministrativo dell’attuale regione a statuto speciale denominata Trentino - Alto Adige/Südtirol. La storia iniziò alla fine della Prima guerra mondiale quando gli accordi di pace attribuirono all’Italia una regione austriaca originariamente denominata Südtirol (Tirolo del sud). Dopo la seconda guerra mondiale gli accordi di pace si conclusero con la formazione della regione italiana denominata, appunto, Trentino-Alto Adige/Südtirol. L’accordo fu raggiunto con il cosiddetto lodo De Gasperi-Gruber, attraverso una serie di tappe e di reciproche concessioni. Una regione italiana si, ma costituita da due province: una di popolazione e storia prevalentemente italiana, quella di Trento, e una a predominanza austriaco-ladina, Bolzano. Ma a differenza delle altre ragioni italiane, quella “mista” non è la sede del potere legislativo: legiferano i due consigli provinciali. E il consiglio regionale è semplicemente la somma dei due consigli provinciali Perciò appunto quando nelle normative italiane ci si riferisce alle regioni si adopera la dizione: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
In quell’area si parlano tre lingue: l’austro-tedesco, l’italiano e il ladino . Nel regime austroungarico le minoranze linguistiche erano generalmente rispettate, ai tempi della dominazione austroungarica toponimi tedeschi e ladini convivevano tranquillamente. Ainis, critica l'azione della "commissione paritetica Stato-Provincia autonoma di Bolzano la quale ha annunziato una riforma della toponomastica, per cancellare il 60% delle denominazioni geografiche in lingua italiana. Nell'articolo si ricorda, giustamente, che, mentre nel trentino la lingua ufficiale è l'italiano, in quella sudtirolese vige il bilinguismo. Ainis rimpiange, giustamente, che «la Vetta d’Italia, il punto più a nord della penisola, d’ora in poi si chiamerebbe Glockenkarkopf», cancellando la doppia dizione in vigore oggi. Ma non ricorda ai lettori che la Vetta d’Italia, era stata così ribattezzata dall’irredentista italiano Tolomei già nel 1904, mentre la popolazione locale continuava a nominarla con il tradizionale toponimo austriaco.
Tornando al Sudtirolo, l’avvento in Italia del regime fascista provocò un’italianizzazione forzata dell’intera area. I cognomi furono italianizzati (a partire da quelli dei dipendenti pubblici), e così la toponomastica. La popolazione di lingua germanica venne invitata a trasferirsi nelle limitrofe province austriache e popolazione di origine italiana a impiantarsi nella provincia di Bolzano. Come del reso era avvenuto in Slovenia, nel breve periodo dell'occupazione italiana. Nella Repubblica italiana succeduta alla sconfitta del nazifascismo si raggiunse un equilibrio nelle regioni di confine si era trovato: il lodo De Gasperi-Gruber e il bilinguismo della provincia/regione al confine con l’Austria lo testimonia.
Oggi la ventata nazionalistica che soffia gelida su tutto il mondo fa riemergere antiche rivendicazioni, ed è giusto segnalarlo. Ma non è giusto ignorare che gli italiani non si comportarono sempre da “brava gente” .
Ancora oggi, del resto, le reazioni di gran parte degli italiani all’arrivo di persone che vengono da altre terre e altre storie, praticano diverse religioni e parlano diverse lingue genera reazioni che, nei casi più favorevoli (dove cioè si sia superato positivamente la soglia della ”prima accoglienza”) si concretano nella pretesa di operare una italianizzazione forzata della lingua e dei costumi dei migranti, al di là dell’apprendimento necessario a chiunque viva in un paese in cui la maggioranza degli abitanti parli una lingua diversa.
Per superare gli sbarramenti e non alimentare i nazionalismi occorre praticare, nell’esperienza quotidiana, la consapevolezza che viviamo in un mondo di diversi, e che anche le diversità linguistiche e culturali (come quelle della botanica e della natura) non sono una minaccia ma una ricchezza. La condizione iniziale è che ci sia il rispetto del diverso; il percorso virtuoso è che dal rispetto di passi alla curiosità, e infine alla conoscenza. Impieghiamo tanto tempo a imparare l’uso di ogni nuovo gadget elettronico; non sarebbe meglio impiegarne un po' per conoscere lo swahili o l'arabo, lo svedese o lo slavo?
Riferimenti
Si veda in proposito, su eddyburg, l'articolo di Michele Ainis Se tocca al giudice difendere l'italiano, la lettera di Giorgio Pagano a nome di un gruppo di docenti del Polimi No all'inglesizzazione degli atenei
». Sbilanciamoci info, 2 marzo 2017 (c.m.c.)
La crisi del processo di integrazione europeo ha molte sfaccettature e si è aggravata negli ultimi anni. Il sintomo più visibile è stato il referendum britannico sull’uscita dalla Ue, ma questo non è certo l’unico indicatore del diffondersi delle tendenze disgregatrici e delle crescenti contestazioni alle politiche europee.
Brexit
La disintegrazione dell’Unione è stata introdotta esplicitamente nell’agenda politica dal referendum britannico. Si può inquadrare il risultato del referendum nel contesto globale delle rivolte contro le élite politiche. La crescita delle diseguaglianze, l’insicurezza economica, la stagnazione o diminuzione del reddito subita da larghi strati di popolazione, insieme alla riduzione dei servizi pubblici, sono i fattori alla base di questo malcontento, le cui espressioni politiche variano enormemente.
In Gran Bretagna, come in molte altre nazioni, gli immigrati sono diventati i capri espiatori, accusati di aver causato problemi economici, quando in realtà la mobilità dei capitali, non del lavoro, è stata una delle principali cause della riduzione degli standard di vita medi e dell’erosione dei diritti dei lavoratori e della protezione sociale. In Gran Bretagna un altro capro espiatorio è stato trovato nei più bisognosi e sia i conservatori che i laburisti, prima del cambio nella leadership del partito, hanno invocato un’ulteriore riduzione dei già inadeguati livelli di protezione sociale.
Durante la coalizione tra conservatori e liberal-democratici, nel 2010-2015, i demagoghi dell’Independence Party britannico (Ukip), sono riusciti a indirizzare il malcontento popolare contro la Ue e a fomentare un nazionalismo xenofobo, che individua i nemici nei lavoratori provenienti dagli altri Paesi dell’Unione. La crescente forza dell’Ukip ha allarmato i partiti tradizionali. Ciò che ne è seguito è stato, almeno in parte, guidato dal caso.
Per cercare di fermare l’avanzata politica dell’Ukip, il primo ministro britannico David Cameron ha promesso un referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione, in un momento nel quale la coalizione al governo sembrava destinata a continuare a governare il Paese; poiché i liberal-democratici non avrebbero mai potuto condividere la decisione di tenere il referendum, i conservatori erano sicuri che tale promessa non avrebbe potuto realizzarsi nella pratica. Tuttavia, l’inaspettata vittoria di una maggioranza conservatrice alle elezioni ha costretto Cameron a rispettare l’impegno preso.
Il trionfo della campagna del leave (uscire dalla Ue) ha coinvolto due grandi correnti politiche: da una parte il nazionalismo xenofobo promosso dall’Ukip; dall’altra la corrente ultra-liberale interna ai conservatori. Michael Gove e John Redwood, due conservatori membri del parlamento britannico, hanno visto l’Europa come un ostacolo al capitalismo globale deregolamentato di cui sono promotori. Nigel Lawson, ministro dell’economia britannico negli anni ottanta, sostenitore di questa corrente scrisse “la Brexit completerà la rivoluzione economica iniziata da Margaret Thatcher”.
Queste due correnti sono potenzialmente in conflitto, poiché la radicale deregolamentazione proposta dai conservatori porterebbe, con molta probabilità, ad accrescere la precarietà economica della maggior parte della popolazione. Sino a oggi tale conflitto è, tuttavia, rimasto sopito. D’altra parte, però, è già scoppiato un aperto conflitto all’interno del governo post-Brexit di Theresa May. Alcuni ministri, influenzati da potenti gruppi di interesse – quelli finanziari innanzitutto – sono preoccupati per le possibili conseguenze dell’uscita del Regno Unito dal Mercato Unico e dai rischi di instabilità economica, che hanno portato a un forte deprezzamento della sterlina. Essi stanno adoperandosi per una ligth-Brexit, una interpretazione minimalista dell’uscita dall’Unione, che preservi il più possibile lo status quo. Altri, invece, sono determinati nel dare seguito alle richieste populiste di controlli sull’immigrazione, anche a costo di distruggere i rapporti con la Ue. Non è ancora chiaro quale delle due strade verrà seguita.
Le posizioni e le argomentazioni del movimento laburista sono state quasi ininfluenti nel dibattito referendario. La posizione accettata quasi unanimemente dal partito è stata che l’Europa, per come è adesso, non fa gli interessi dei lavoratori, ma un’uscita dall’Unione associata a un programma politico xenofobo e a un’agenda che punta alla deregolamentazione non può certo migliorare la situazione. Nonostante questa posizione fosse più che ragionevole, la debolezza del partito laburista, unita alla posizione pro-Brexit della stampa di destra, ha fatto sì che essa risultasse marginale nel dibattito.
La Brexit ha reso concreta la minaccia che forze centrifughe possano erodere, o forse addirittura distruggere, il progetto europeo. In particolare, il trionfo, con la Brexit, di due portati della destra radicale – liberismo economico estremo e nazionalismo xenofobo – rafforzano le tendenze disgregatrici in tutta Europa. Il fallimento dei leader europei nel rispondere al malessere sociale, che trova invece una distorta espressione in queste forze distruttrici, aumenta certamente le minacce per l’Unione. La passività con cui essa sta affrontando l’avanzata delle forze nazionaliste in tutta Europa è in evidentemente contrasto con la durezza e determinazione con le quali è stata schiacciata la proposta, razionale e pro-europea, di superamento dell’austerità in Grecia.
La divisione Nord e Sud nell’area euro
Non è stato solo il primo ministro britannico Cameron a spargere il seme della discordia in Europa. A suo modo, il ministro delle finanze tedesco, Wolfgang Schäuble, ha fatto lo stesso quando, a luglio dello scorso anno, confrontandosi con il governo greco, non ha dato alternative se non accettare l’austerità e le riforme strutturali richieste o lasciare l’area euro. Schäuble, che già nel 1994 aveva proposto un’Europa caratterizzata da un nucleo centrale, ha chiarito che l’appartenenza all’Unione dei Paesi (quelli periferici!) è reversibile, se questi non si adeguano ai cambiamenti strutturali e all’austerità fiscale e salariale.
Il governo guidato da Syriza non era pronto ad affrontare l’uscita dall’euro e, sotto fortissima pressione, ha accettato le condizioni imposte dagli altri Stati membri dell’area euro, guidati dalla Germania. A causa della continua contrazione della domanda interna, nel 2015 il Pil greco è diminuito ancora dello 0.2%, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto attorno al 25%. Se le politiche restrittive hanno abbassato il deficit della bilancia commerciale, senza peraltro affrontarne le cause, hanno però peggiorato i problemi legati al debito greco. Negli ultimi mesi, il conflitto tra Europa e Fondo Monetario Internazionale sulla sostenibilità del debito pubblico greco e la necessità di un suo taglio si è intensificato. I Paesi dell’Europa centrale, tra cui la Germania, sono particolarmente riluttanti all’idea di tagliare il debito greco, nonostante i loro governi siano pienamente coscienti del fatto che ciò sarà inevitabile.
I programmi di adeguamento strutturale sostenuti dalla Commissione Europea e dai governi del nucleo centrale europeo, non hanno affrontato la profonda divisione che corre tra Nord e Sud, né il problema della debolezza delle strutture produttive e della deindustrializzazione nella periferia Ue. Il deprezzamento dell’euro, unito al trasferimento del turismo di massa da Egitto, Turchia e Tunisia ai Paesi dell’ovest del Mediterraneo, ha alleviato la situazione di Spagna e Portogallo.
Analogamente, la riduzione del grado di restrittività delle politiche macro deciso sia dal governo provvisorio della destra in Spagna, sia dal neo eletto governo progressista portoghese, con la sua aperta politica anti austerità, hanno contribuito a una qualche, lieve ripresa economica. Nonostante i due governi non abbiano rispettato le regole di bilancio imposte dalla Commissione Europea, in autunno 2016 non sono stati sanzionati. Anche il governo tedesco ha sostenuto questa decisione, il che ha lasciato margine di manovra al partito popolare spagnolo, importante alleato del tedesco Cdu/Csu, in uno scenario politico particolarmente incerto. Tuttavia la flessibilità concessa non deve essere interpretata come un cambio di direzione generale.
Sebbene i Paesi del nord Europa godano di un tasso di disoccupazione più basso rispetto a quelli del sud, sono anche loro esposti ai pericoli causati dagli squilibri presenti nell’economia europea. Ad esempio, essi sono, data la loro apertura economica e commerciale, particolarmente vulnerabili all’eventualità di una recessione indotta dalla Brexit in Gran Bretagna e nei maggiori Paesi europei. La crescita delle esportazioni (misurate in valore per includere il petrolio norvegese), dopo una lieve ripresa successiva alla crisi, è stata bassa in tutti i Paesi del nord (con l’eccezione dell’Islanda).
La situazione in Svezia e Norvegia è stata in qualche modo alleggerita grazie alla variabilità del tasso di cambio delle rispettive monete, mentre la Finlandia, facendo parte anche dell’Unione Monetaria, non ha potuto far fronte con il deprezzamento della moneta agli specifici shock che l’hanno colpita – i problemi della Nokia e le sanzioni alla Russia in particolare –, la qual cosa sarebbe stata particolarmente necessaria per sostenere l’industria del legno e dell’acciaio.
Analogamente, in Danimarca l’ancoraggio della moneta all’euro ha contribuito alla stagnazione delle esportazioni, sin dal 2010. Sebbene il flusso dei migranti abbia causato una crescita della spesa pubblica in Svezia, tale politica attiva discrezionale non è stata usata per aumentare l’occupazione; in Finlandia, invece, la crisi è stata ulteriormente aggravata dalle politiche di correzione fiscale mirate a soddisfare le richieste europee. In generale, l’ortodossia economica non ha permesso politiche di bilancio attive e solo la politica monetaria fortemente espansiva della Bce e delle banche centrali svedesi e norvegesi, con il loro pericoloso impatto sui prezzi delle case, ha permesso alla spesa interna di compensare, almeno parzialmente, la bassa domanda di esportazioni.
I rifugiati e la rottura dell’area Shengen
L’arrivo di un gran numero di rifugiati dal Medio Oriente e dai Paesi africani nel 2015 e a inizio 2016 ha evidenziato le spaccature interne alla Ue. Mentre le procedure non formalizzate utilizzate per gestire la crisi hanno portato a scaricare il peso sui Paesi periferici, la regolamentazione Ue sui rifugiati – derivante dalla Convenzione di Dublino – indica esplicitamente che a farsi carico dei migranti devono essere i Paesi di primo ingresso nell’Unione, tipicamente i più poveri. Nel 2015 questa scelta ha messo particolarmente in difficoltà la Grecia. Nell’estate del 2015 è apparso evidente che il governo greco – già affamato dalle politiche di austerità – era ormai sopraffatto dall’emergenza.
La decisione del governo tedesco di accogliere i rifugiati di guerra, particolarmente siriani, ha aiutato la Grecia, ma ha comportato problemi con altri governi, dall’Ungheria alla Svezia. Essa, assunta senza previa consultazione degli altri Paesi, ha riconosciuto implicitamente il fallimento degli accordi di Dublino. Da settembre 2015 a marzo 2016 sono state adottate soluzioni temporanee, non previste dalla normativa in vigore, come quella dei corridoi umanitari tra Germania e Croazia, attraverso i quali ai rifugiati è stato consentito di raggiungere l’Europa centrale.
Queste misure sono state, però, fortemente avversate da forze nazionaliste conservatrici come il governo di Fidesz in Ungheria. Esse si sono fortemente mobilitate per chiudere le frontiere agli immigrati e costruire muri. Queste istanze hanno trovato risonanza nei partiti cristiano-democratici e, addirittura, in alcuni partiti social-democratici. Rappresentanti di alto rango di governi come quello ungherese e austriaco sono andati in visita in Macedonia – Paese candidato a entrare nell’Unione – elogiando come questa stesse difendendo i confini “europei”. Implicitamente, hanno così mostrato come ci sia un Paese considerato “ridondante” nell’area Shengen – ancora una volta la Grecia.
I Paesi Ue si sono dimostrati incapaci di trovare una nuova formula per distribuire gli oneri associati alla crisi dei migranti. Invece di un più che giustificato approccio umanitario associato a circostanze eccezionali, hanno optato per esternalizzare la gestione del problema. A tal fine, il 10 marzo 2016 è stato siglato un accordo con la Turchia, che prevede che essa accetti i rifugiati in cambio di soldi, mentre la Ue si impegna a ricevere un numero limitato di rifugiati siriani provenienti dalla Turchia; inoltre, è prevista l’accelerazione dei negoziati di accesso della Turchia all’Unione e l’abolizione del visto per l’ingresso nella Ue dei cittadini turchi. In pratica, il governo turco ha bloccato i rifugiati in Turchia, impedendogli di raggiungere la Ue, in cambio dell’acquiescenza europea rispetto al carattere sempre più repressivo del regime che governa quel Paese.
L’imposizione del Comprehensive Trade and Economic Agreement col Canada (Ceta)
Alla fine di ottobre 2016 la Commissione e, più in generale, tutte le forze liberiste hanno utilizzato tutti gli strumenti a loro disposizione per far sottoscrivere a tutti gli Stati membri il trattato Ceta con il Canada. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha elogiato questo accordo di libero scambio come “il più progressivo” mai siglato dall’Unione. Forti correnti interne ai partiti di sinistra, ai sindacati e ai movimenti sociali hanno, però, visto in questo accordo molti elementi regressivi dal punto di vista della democrazia e dello stato di diritto.
Una delle clausole più controverse riguarda la creazione di un tribunale che permetterebbe agli “investitori” (le grandi multinazionali) di citare in giudizio i governi per ottenere compensazioni economiche nei casi in cui ritengano che la regolamentazione nazionale leda i loro diritti, così precostituendo un privilegio legale per le imprese multinazionali. Altri elementi di preoccupazione riguardano, fra gli altri, i servizi pubblici e gli standard sanitari. Accordi commerciali come il Ceta scolpiscono nella roccia le regole liberiste, riducendo grandemente lo spazio per una ri-regolamentazione democratica. Le negoziazioni per il Ceta sono rimaste riservate a lungo, nascoste all’ombra delle trattative per la Transatlantic Trade and Investment Partnership (il Ttip), basata sulla stessa filosofia.
Quando le negoziazioni per il Ttip sono saltate, viste le forti resistenze, le forze del libero mercato hanno messo l’approvazione del Ceta fra le loro priorità. Di fatto, molte società americane hanno sedi in Canada e possono, perciò, comunque avvalersi del Ceta. In un certo senso, il Ceta è un sotterfugio per imporre comunque le regole del Ttip. Sebbene in Germania le proteste contro il Ttip e il Ceta siano state particolarmente accese, i social-democratici hanno ceduto alle pressioni dei conservatori loro alleati, del mondo degli affari e di Bruxelles.
Il partito social-democratico austriaco ha negoziato una dichiarazione interpretativa di alcuni punti critici, che verrà allegata al trattato. L’ultimo ostacolo alla firma è venuto dalle regioni belghe della Vallonia e di Bruxelles. La Vallonia, in particolare, aveva evidenziato già un anno prima le sue obiezioni alla Commissione ma, ciononostante, quest’ultima ha scelto di fissare comunque la data della cerimonia per la firma. Ciò si è rivelato in parte un errore di calcolo, in quanto il governo regionale ha fatto slittare la data prevista, cedendo, infine, solo dopo aver negoziato una dichiarazione speciale.
Il commissario europeo Günther Oettinger ha reagito alle controversie sul Ceta chiedendo che i governi nazionali non interferiscano con le politiche commerciali europee. L’intento di questa dichiarazione è, evidentemente, quello di contrastare l’opposizione al trattato tramite la centralizzazione. Il percorso di ratifica del Ceta da parte dei parlamenti nazionali si preannuncia, tuttavia, accidentato. Di fatto, il modo in cui l’Europa ha insistito per l’approvazione del Ceta aggrava la crisi di legittimità europea e fomenta le tendenze disgregatrici.
Le relazioni Ue-Usa dopo l’elezione di Trump
L’ascesa dei partiti nazionalisti di estrema destra non è rimasta confinata all’Europa. Negli Usa, l’oligarca Donald Trump ha vinto con un margine ristrettissimo le elezioni presidenziali, grazie al supporto di varie forze di destra. Gli elementi chiave della sua campagna sono stati un’aggressiva retorica anti-immigrati, la promessa di abbassare le tasse e la fine di trattati commerciali come il Ttip. Se realizzate, le promesse di interrompere le negoziazioni per il Ttip e di ridurre le spese americane a sostegno della Nato cambieranno significativamente le relazioni tra Usa e Ue.
Dopo l’elezione di Trump, si è riacceso il dibattito sulla formazione di una “difesa comune”. In un contesto di “cooperazione strutturale permanente”, la cooperazione militare tra gli Stati membri non può che aumentare. In effetti, sia i deputati europei cristiano-democratici che quelli social-democratici hanno chiesto un aumento della spesa militare da parte dei singoli Paesi: in un contesto dove molteplici sono gli elementi di crisi, emerge dunque un ampio consenso, che va dai social-democratici alle destre nazionaliste, per una maggiore militarizzazione dell’Unione e una politica estera più aggressiva. Questa spinta militarista deve essere contrastata con decisione dalle forze di sinistra e dai movimenti per la pace.
Idee e strategie per leggere le tendenze disgregative
L’ampio consenso tra i cristiano-democratici, i social-democratici e i nazionalisti di destra non va oltre la militarizzazione della politica estera. Le élite europee hanno intrapreso percorsi differenziati per fronteggiare le molteplici crisi e le tendenze disgregative. Queste strategie sono strettamente legate ai differenti scenari futuri considerati e ai diversi modi di guardare all’Europa. Come nel caso della Brexit in Gran Bretagna , anche in Europa sono le forze di destra che dominano il dibattito sul futuro dell’Unione.
Cercare di sopravvivere in qualche modo: questo è il modo prevalente di gestione delle molte crisi che affliggono l’Europa. È l’approccio privilegiato dalla maggior parte dei cristiano-democratici, come dei social-democratici e dei liberali. Si tratta di una strategia che punta a proseguire nell’attuazione del modello neoliberista di integrazione e a preservare l’attuale configurazione geografica dell’Unione Monetaria e dell’area Shengen. È un approccio che ottiene il supporto delle maggiori multinazionali, ma che non fa in alcun modo i conti né con le divisioni tra centro e periferia dell’Unione, né con la sua perdita di legittimazione agli occhi delle classi popolari. Nonostante questa strategia abbia la pretesa di preservare il processo di integrazione europeo e i suoi confini geografici, la mancanza di elementi di promozione della coesione non potrà che accelerare il processo di disgregazione europeo.
Vanno anche evidenziate due sotto-varianti di questa strategia.
Cercare di sopravvivere con un po’ più di flessibilità fiscale e maggiori investimenti pubblici. È la strategia perseguita principalmente dai social-democratici e, in parte, dalle forze di sinistra in Francia e nei Paesi mediterranei. Essa punta a integrare l’approccio sopra descritto con una combinazione di flessibilità fiscale e investimenti pubblici. Si cerca di ampliare lo spazio per gli interventi di politica economica alleggerendo le regole fiscali. Questa strategia è caratterizzata da una qualche maggiore attenzione ai problemi di coesione dell’Unione rispetto alla variante principale.
Cercare di sopravvivere restringendo e rendendo più rigida l’area Schengen. Questa variante invoca il ritorno temporaneo dei controlli alle frontiere nell’area Schengen e vuole escludere dall’area i Paesi che non sono disposti a tenere rifugiati e migranti “indesiderati” fuori dai confini nazionali. Quest’approccio è perseguito soprattutto dalle correnti nazionaliste interne ai partiti cristiano-democratici dei Paesi del nucleo centrale europeo e dei Paesi più orientali dell’Europa centrale, ma esso gode del sostegno anche di alcuni partiti social-democratici. De facto questa strategia sta già prendendo piede, come dimostrato, ad esempio, dalla reintroduzione di controlli temporanei alle frontiere e dalla costruzione di barriere fisiche di confine all’interno della stessa area Schengen.
Core Europe: la costruzione di un nucleo centrale europeo. L’Europa è già caratterizzata da differenti gradi di integrazione. Tradizionalmente, il concetto di Europa core è stato finalizzato a intensificare l’integrazione neoliberista tra i Paesi che ne dovrebbero farne parte. Per questo come area di riferimento si guarda a un insieme di Paesi più ristretto e omogeneo all’interno dell’area euro. Questa visione è stata ampiamente dibattuta all’interno dei circoli cristiano-democratici dei Paesi interessati. I partiti della destra nazionalista che propongono questa visione, come Freiheitliche Partei Osterreichs (Fpö) o Alternative fur Deutschland (AfD), puntano soprattutto a rendere l’Unione più piccola e omogenea, vogliono liberarsi dei Paesi periferici che ritengono un peso. Le proposte delle forze di destra dei Paesi periferici, come in Italia la Lega Nord o, in modo più lieve, il Movimento 5 Stelle, puntano ad abbandonare l’eurozona e sono dunque complementari a quelle che mirano alla costruzione del nucleo centrale.
L’Europa delle nazioni. Alcuni partiti della destra nazionalista sostengono che il processo di integrazione europeo debba focalizzarsi sul Mercato Unico e la relativa regolazione economica. I partiti della destra nazionalista nell’Europa dell’est, come Fidesz in Ungheria o Prawo i Sprawiedliwość (PiS), in Polonia ritengono, invece, fondamentali anche gli apporti dei fondi europei per lo sviluppo regionale. Tuttavia, essi invocano negli altri campi più libertà per gli Stati nazionali, in parte per realizzare strategie competitive, in parte per promuovere un’agenda politica nazionalista e conservatrice (ad esempio, in ambiti quali l’identità sessuale o le politiche sociali). Alcune forze della destra nazionalista, come il Front National in Francia, hanno formulato vaghe idee di “un’altra Europa”, tanto poco definite da non apparire sostanzialmente distinte da quelle che mirano alla completa dissoluzione dell’Unione.
Idee e strategie per la sinistra
Un’altra Europa: un federalismo europeo di sinistra: il concetto di un’altra Europa è stato usato anche da alcune forze di sinistra, ma con un significato completamente diverso. Il fine è quello di rifondare democraticamente la Ue, gettando le basi per un federalismo democratico europeo e per un’integrazione più equilibrata. Il punto è che i presupposti politici per l’attuazione di questa agenda sono particolarmente difficili da realizzare, sarebbe necessario un largo consenso generale e tra gli Stati membri, un contesto, insomma, opposto a quello che sembra prevalere attualmente.
A fronte del manifestarsi di forti disequilibri di potere fra i Paesi Ue e dopo l’esperienza greca, un crescente numero di forze di sinistra chiede ora l’attuazione di esplicite politiche di promozione sociale, che contemplino il non rispetto delle regole europee e, laddove necessario per intraprendere politiche progressiste, anche l’abbandono della moneta unica.
I due differenti approcci della sinistra differiscono principalmente nel giudizio su cosa sia politicamente realizzabile all’interno dell’Unione e su cosa potrebbe essere realizzato attraverso le singole politiche economiche nazionali.
Entrambe le prospettive appaiono di difficile realizzazione senza una maggiore unità politica e un maggiore incidenza elettorale della sinistra rispetto all’attuale. Malgrado contestazioni radicate negli specifici contesti nazionali costituiscano la più immediata forma di sfida alle politiche attuali, EuroMemo continua a ritenere indispensabile una prospettiva internazionale e a sostenere la necessità di un approccio coordinato a livello europeo per promuovere la ripresa economica e la giustizia sociale.
 Ripresentiamo, nella povera Italia del 2017, l'analisi di un politico che seppe scorgere nell'oggi i germi e i virus del futuro. Intervista a Enrico Berlinguer di Eugenio Scalfari,
Ripresentiamo, nella povera Italia del 2017, l'analisi di un politico che seppe scorgere nell'oggi i germi e i virus del futuro. Intervista a Enrico Berlinguer di Eugenio Scalfari,
La Repubblica, 28 luglio 1981. «I partiti sono diventati macchine di potere»
«I partiti non fanno più politica», dice Enrico Berlinguer. «I partiti hanno degenerato e questa è l'origine dei malanni d'Italia».
La passione è finita?
«Per noi comunisti la passione non è finita. Ma per gli altri? Non voglio dar giudizi e mettere il piede in casa altrui, ma i fatti ci sono e sono sotto gli occhi di tutti. I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela: scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune. La loro stessa struttura organizzativa si è ormai conformata su questo modello, e non sono più organizzatori del popolo, formazioni che ne promuovono la maturazione civile e l'iniziativa: sono piuttosto federazioni di correnti, di camarille, ciascuna con un "boss" e dei "sotto-boss". La carta geopolitica dei partiti è fatta di nomi e di luoghi. Per la DC: Bisaglia in Veneto, Gava in Campania, Lattanzio in Puglia, Andreotti nel Lazio, De Mita ad Avellino, Gaspari in Abruzzo, Forlani nelle Marche e così via. Ma per i socialisti, più o meno, è lo stesso e per i socialdemocratici peggio ancora...»
Lei mi ha detto poco fa che la degenerazione dei partiti è il punto essenziale della crisi italiana.
«È quello che io penso».
Per quale motivo?
«I partiti hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni, a partire dal governo. Hanno occupato gli enti locali, gli enti di previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la Rai TV, alcuni grandi giornali. Per esempio, oggi c'è il pericolo che il maggior quotidiano italiano, il Corriere della Sera, cada in mano di questo o quel partito o di una sua corrente, ma noi impediremo che un grande organo di stampa come il Corriere faccia una così brutta fine. Insomma, tutto è già lottizzato e spartito o si vorrebbe lottizzare e spartire. E il risultato è drammatico. Tutte le "operazioni" che le diverse istituzioni e i loro attuali dirigenti sono chiamati a compiere vengono viste prevalentemente in funzione dell'interesse del partito o della corrente o del clan cui si deve la carica. Un credito bancario viene concesso se è utile a questo fine, se procura vantaggi e rapporti di clientela; un'autorizzazione amministrativa viene data, un appalto viene aggiudicato, una cattedra viene assegnata, un'attrezzatura di laboratorio viene finanziata, se i beneficiari fanno atto di fedeltà al partito che procura quei vantaggi, anche quando si tratta soltanto di riconoscimenti dovuti».
Lei fa un quadro della realtà italiana da far accapponare la pelle.
«E secondo lei non corrisponde alla situazione?»
Debbo riconoscere, signor Segretario, che in gran parte è un quadro realistico. Ma vorrei chiederle: se gli italiani sopportano questo stato di cose è segno che lo accettano o che non se ne accorgono. Altrimenti voi avreste conquistato la guida del paese da un pezzo.
«La domanda è complessa. Mi consentirà di risponderle ordinatamente. Anzitutto: molti italiani, secondo me, si accorgono benissimo del mercimonio che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, dei favoritismi, delle discriminazioni. Ma gran parte di loro è sotto ricatto. Hanno ricevuto vantaggi (magari dovuti, ma ottenuti solo attraverso i canali dei partiti e delle loro correnti) o sperano di riceverne, o temono di non riceverne più.
Veniamo all'altra mia domanda, se permette, signor Segretario: dovreste aver vinto da un pezzo, se le cose stanno come lei descrive.
In un certo senso, al contrario, può apparire persino straordinario che un partito come il nostro, che va così decisamente contro l'andazzo corrente, conservi tanti consensi e persino li accresca. Ma io credo di sapere a che cosa lei pensa: poiché noi dichiariamo di essere un partito "diverso" dagli altri, lei pensa che gli italiani abbiano timore di questa diversità.
Sì, è così, penso proprio a questa vostra conclamata diversità. A volte ne parlate come se foste dei marziani, oppure dei missionari in terra d'infedeli: e la gente diffida. Vuole spiegarmi con chiarezza in che consiste la vostra diversità? C'è da averne paura?
«Qualcuno, sì, ha ragione di temerne, e lei capisce subito chi intendo. Per una risposta chiara alla sua domanda, elencherò per punti molto semplici in che consiste il nostro essere diversi, così spero non ci sarà più margine all'equivoco. Dunque: primo, noi vogliamo che i partiti cessino di occupare lo Stato. I partiti debbono, come dice la nostra Costituzione, concorrere alla formazione della volontà politica della nazione; e ciò possono farlo non occupando pezzi sempre più larghi di Stato, sempre più numerosi centri di potere in ogni campo, ma interpretando le grandi correnti di opinione, organizzando le aspirazioni del popolo, controllando democraticamente l'operato delle istituzioni. Ecco la prima ragione della nostra diversità. Le sembra che debba incutere tanta paura agli italiani?»
Veniamo alla seconda diversità.
«Noi pensiamo che il privilegio vada combattuto e distrutto ovunque si annidi, che i poveri e gli emarginati, gli svantaggiati, vadano difesi, e gli vada data voce e possibilità concreta di contare nelle decisioni e di cambiare le proprie condizioni, che certi bisogni sociali e umani oggi ignorati vadano soddisfatti con priorità rispetto ad altri, che la professionalità e il merito vadano premiati, che la partecipazione di ogni cittadino e di ogni cittadina alla cosa pubblica debba essere assicurata».
Onorevole Berlinguer, queste cose le dicono tutti.
«Già, ma nessuno dei partiti governativi le fa. Noi comunisti abbiamo sessant'anni di storia alle spalle e abbiamo dimostrato di perseguirle e di farle sul serio. In galera con gli operai ci siamo stati noi; sui monti con i partigiani ci siamo stati noi; nelle borgate con i disoccupati ci siamo stati noi; con le donne, con il proletariato emarginato, con i giovani ci siamo stati noi; alla direzione di certi comuni, di certe regioni, amministrate con onestà, ci siamo stati noi».
Non voi soltanto.
«È vero, ma noi soprattutto. E passiamo al terzo punto di diversità. Noi pensiamo che il tipo di sviluppo economico e sociale capitalistico sia causa di gravi distorsioni, di immensi costi e disparità sociali, di enormi sprechi di ricchezza. Non vogliamo seguire i modelli di socialismo che si sono finora realizzati, rifiutiamo una rigida e centralizzata pianificazione dell'economia, pensiamo che il mercato possa mantenere una funzione essenziale, che l'iniziativa individuale sia insostituibile, che l'impresa privata abbia un suo spazio e conservi un suo ruolo importante. Ma siamo convinti che tutte queste realtà, dentro le forme capitalistiche -e soprattutto, oggi, sotto la cappa di piombo del sistema imperniato sulla DC- non funzionano più, e che quindi si possa e si debba discutere in qual modo superare il capitalismo inteso come meccanismo, come sistema, giacché esso, oggi, sta creando masse crescenti di disoccupati, di emarginati, di sfruttati. Sta qui, al fondo, la causa non solo dell'attuale crisi economica, ma di fenomeni di barbarie, del diffondersi della droga, del rifiuto del lavoro, della sfiducia, della noia, della disperazione. È un delitto avere queste idee?»
Non trovo grandi differenze rispetto a quanto può pensare un convinto socialdemocratico europeo. Però a lei sembra un'offesa essere paragonato ad un socialdemocratico.
«Bè, una differenza sostanziale esiste. La socialdemocrazia (parlo di quella seria, s'intende) si è sempre molto preoccupata degli operai, dei lavoratori sindacalmente organizzati e poco o nulla degli emarginati, dei sottoproletari, delle donne. Infatti, ora che si sono esauriti gli antichi margini di uno sviluppo capitalistico che consentivano una politica socialdemocratica, ora che i problemi che io prima ricordavo sono scoppiati in tutto l'occidente capitalistico, vi sono segni di crisi anche nella socialdemocrazia tedesca e nel laburismo inglese, proprio perché i partiti socialdemocratici si trovano di fronte a realtà per essi finora ignote o da essi ignorate».
Dunque, siete un partito socialista serio...
«...nel senso che vogliamo costruire sul serio il socialismo...»
Le dispiace, la preoccupa che il PSI lanci segnali verso strati borghesi della società?
«No, non mi preoccupa. Ceti medi, borghesia produttiva sono strati importanti del paese e i loro interessi politici ed economici, quando sono legittimi, devono essere adeguatamente difesi e rappresentati. Anche noi lo facciamo. Se questi gruppi sociali trasferiscono una parte dei loro voti verso i partiti laici e verso il PSI, abbandonando la tradizionale tutela democristiana, non c'è che da esserne soddisfatti: ma a una condizione. La condizione è che, con questi nuovi voti, il PSI e i partiti laici dimostrino di saper fare una politica e di attuare un programma che davvero siano di effettivo e profondo mutamento rispetto al passato e rispetto al presente. Se invece si trattasse di un semplice trasferimento di clientele per consolidare, sotto nuove etichette, i vecchi e attuali rapporti tra partiti e Stato, partiti e governo, partiti e società, con i deleteri modi di governare e di amministrare che ne conseguono, allora non vedo di che cosa dovremmo dirci soddisfatti noi e il paese».
Secondo lei, quel mutamento di metodi e di politica c'è o no?
«Francamente, no. Lei forse lo vede? La gente se ne accorge? Vada in giro per la Sicilia, ad esempio: vedrà che in gran parte c'è stato un trasferimento di clientele. Non voglio affermare che sempre e dovunque sia così. Ma affermo che socialisti e socialdemocratici non hanno finora dato alcun segno di voler iniziare quella riforma del rapporto tra partiti e istituzioni -che poi non è altro che un corretto ripristino del dettato costituzionale- senza la quale non può cominciare alcun rinnovamento e sanza la quale la questione morale resterà del tutto insoluta».
Lei ha detto varie volte che la questione morale oggi è al centro della questione italiana. Perché?
«La questione morale non si esaurisce nel fatto che, essendoci dei ladri, dei corrotti, dei concussori in alte sfere della politica e dell'amministrazione, bisogna scovarli, bisogna denunciarli e bisogna metterli in galera. La questione morale, nell'Italia d'oggi, fa tutt'uno con l'occupazione dello stato da parte dei partiti governativi e delle loro correnti, fa tutt'uno con la guerra per bande, fa tutt'uno con la concezione della politica e con i metodi di governo di costoro, che vanno semmplicemente abbandonati e superati. Ecco perché dico che la questione morale è il centro del problema italiano. Ecco perché gli altri partiti possono profare d'essere forze di serio rinnovamento soltanto se aggrediscono in pieno la questione morale andando alle sue cause politiche. [...] Quel che deve interessare veramente è la sorte del paese. Se si continua in questo modo, in Italia la democrazia rischia di restringersi, non di allargarsi e svilupparsi; rischia di soffocare in una palude».
Signor Segretario, in tutto il mondo occidentale si è d'accordo sul fatto che il nemico principale da battere in questo momento sia l'inflazione, e difatti le politiche economiche di tutti i paesi industrializzati puntano a realizzare quell'obiettivo. È anche lei del medesimo parere?
«Risponderò nello stesso modo di Mitterand: il principale malanno delle società occidentali è la disoccupazione. I due mali non vanno visti separatamente. L'inflazione è -se vogliamo- l'altro rovescio della medaglia. Bisogna impegnarsi a fondo contro l'una e contro l'altra. Guai a dissociare questa battaglia, guai a pensare, per esempio, che pur di domare l'inflazione si debba pagare il prezzo d'una recessione massiccia e d'una disoccupazione, come già in larga misura sta avvenendo. Ci ritroveremmo tutti in mezzo ad una catastrofe sociale di proporzioni impensabili».
Il PCI, agli inizi del 1977, lanciò la linea dell' "austerità". Non mi pare che il suo appello sia stato accolto con favore dalla classe operaia, dai lavoratori, dagli stessi militanti del partito...
«Noi sostenemmo che il consumismo individuale esasperato produce non solo dissipazione di ricchezza e storture produttive, ma anche insoddisfazione, smarrimento, infelicità e che, comunque, la situazione economica dei paesi industializzati -di fronte all'aggravamento del divario, al loro interno, tra zone sviluppate e zone arretrate, e di fronte al risveglio e all'avanzata dei popoli dei paesi ex-coloniali e della loro indipendenza- non consentiva più di assicurare uno sviluppo economico e sociale conservando la "civiltà dei consumi", con tutti i guasti, anche morali, che sono intrinseci ad essa. La diffusione della droga, per esempio, tra i giovani è uno dei segni più gravi di tutto ciò e nessuno se ne dà realmente carico. Ma dicevamo dell'austerità. Fummo i soli a sottolineare la necessità di combattere gli sprechi, accrescere il risparmio, contenere i consumi privati superflui, rallentare la dinamica perversa della spesa pubblica, formare nuove risorse e nuove fonti di lavoro. Dicemmo che anche i lavoratori avrebbero dovuto contribuire per la loro parte a questo sforzo di raddrizzamento dell'economia, ma che l'insieme dei sacrifici doveva essere fatto applicando un principio di rigorosa equità e che avrebbe dovuto avere come obiettivo quello di dare l'avvio ad un diverso tipo di sviluppo e a diversi modi di vita (più parsimoniosi, ma anche più umani). Questo fu il nostro modo di porre il problema dell'austerità e della contemporanea lotta all'inflazione e alla recessione, cioè alla disoccupazione. Precisammo e sviluppammo queste posizioni al nostro XV Congresso del marzo 1979: non fummo ascoltati».
E il costo del lavoro? Le sembra un tema da dimenticare?
«Il costo del lavoro va anch'esso affrontato e, nel complesso, contenuto, operando soprattutto sul fronte dell'aumento della produttività. Voglio dirle però con tutta franchezza che quando si chiedono sacrifici al paese e si comincia con il chiederli -come al solito- ai lavoratori, mentre si ha alle spalle una questione come la P2, è assai difficile ricevere ascolto ed essere credibili. Quando si chiedono sacrifici alla gente che lavora ci vuole un grande consenso, una grande credibilità politica e la capacità di colpire esosi e intollerabili privilegi. Se questi elementi non ci sono, l'operazione non può riuscire».
 In realtà l'autore afferma due cose importanti: l'ideologia è una base essenziale per qualsiasi politica: non è vero che le ideologie sono morte, invece una ideologia (quella del neoliberalismo, (prodotta dalla Trilateral Commission e dalla Mont Pàlerin Society) hanno cacciato le altre.
In realtà l'autore afferma due cose importanti: l'ideologia è una base essenziale per qualsiasi politica: non è vero che le ideologie sono morte, invece una ideologia (quella del neoliberalismo, (prodotta dalla Trilateral Commission e dalla Mont Pàlerin Society) hanno cacciato le altre.
la Repubblica, 25 febbraio 2017
CARO direttore, commentando le vicende del Pd, Michele Serra ha rilevato come la fine dell’ideologia rischi di tradursi in quel partito nella fine della stessa politica.
Dopo la caduta del Muro di Berlino, in effetti si brindò non solo alla fine dell’ideologia comunista ma di tutte le ideologie, considerandole camicie di forza del pensiero, strumenti di autoritarismo culturale e politico. Molti liberali non consideravano la loro come una ideologia: la intendevano piuttosto come l’unica concezione del mondo possibile per chi avesse a cuore la libertà.
In quegli stessi anni, però, nell’establishment occidentale si andava affermando una variante radicale del liberalismo. Lo racconta bene Tony Judt in un piccolo libro intitolato Guasto è il mondo. Negli anni Settanta le idee liberiste propugnate da Hayek nel dopoguerra si erano diffuse fino al punto di diventare senso comune: lasciate che gli interessi privati si dispieghino liberamente senza le interferenze della politica economica — dicevano i liberali — e otterrete più crescita e più benessere per tutti...
Il discorso liberista trae forza anche dal cattivo uso delle politiche pubbliche e dalla crescita del ruolo politico del ceto medio — in Italia lo descrive molto bene Sylos Labini. È questa l’ideologia che prepara la svolta politica di Reagan e della Thatcher, una visione del mondo elaborata da agguerriti think tank, diffusa da autorevoli media e sostenuta da aziende multinazionali interessate ad avere mano libera planetaria.
La forza di questa ideologia, paradossalmente, sta anche nel negare di esserlo. Lo scrive molto efficacemente Umberto Eco nel 1983 in Sette anni di desiderio: “Si parla di crisi delle ideologie. Errore. Casomai bisognerebbe parlare di modificazione delle ideologie. È caratteristico delle nuove ideologie non essere riconoscibili come tali, così che possano essere vissute come verità” … Una “verità” che sembra sostenere in maniera indiscutibile la marcia gloriosa della globalizzazione. Ma nel 2007 arriva la crisi finanziaria ed economica, che rivela la crescita di diseguaglianze e di insicurezza sociale che le politiche legate a questo modello ideologico hanno prodotto nel mondo. Il credo dell’ideologia neoliberista è rimesso in questione da autorevoli economisti e da grandi istituzioni economiche internazionali, e perfino da giornali mainstream come il Financial Times. Eppure, in questi dieci anni nel campo progressista non riesce ad affermarsi un paradigma alternativo. Non è un problema della sola politica ma di tutta la sinistra, anche quella che si occupa di diffondere le idee: i giornali, le riviste, le case editrici. E non è solo un problema italiano: la sinistra è divisa e in difficoltà in buona parte dell’Occidente.
E questo non perché manchi un pensiero nuovo, ad esempio sui temi dell’equità. Pensatori come Tony Atkinson e Amartya Sen (solo per citarne due molto noti anche in Italia) hanno scritto libri fondamentali su come nel XXI secolo si può ripensare una società insieme più giusta e più libera. E anche in Italia ci sono studiosi che da anni lavorano su un nuovo modello di welfare, che coniughi lotta alla povertà e alle disuguaglianze — anche di genere — con la sostenibilità economica ed ambientale.
Ciò che manca è il passaggio dalle idee alle opinioni: quelle che Leopardi (nel Discorso sui costumi degli italiani) ritiene decisive nel determinare i comportamenti. Un ambito in cui svolgono un ruolo essenziale i media, purché siano disposti ad assumere fino in fondo la loro responsabilità di orientamento intellettuale e formazione dell’opinione pubblica. Un esempio?
Nel suo ultimo libro La grande fuga il premio Nobel Angus Deaton scrive che la crescita non garantisce la creazione di più opportunità per tutti: anzi, è compatibile con maggiore diseguaglianza e povertà. Dunque, se la crescita è uno strumento e l’equità è il fine, almeno per chi è progressista non ha senso auspicare la crescita senza darle precise qualificazioni. Una idea che ancora non è diventata senso comune.
Di tutto ciò, i litigi tra Renzi, Bersani e D’Alema non sono che una modesta conseguenza. Date per morte tutte le ideologie, la maggioranza dei professionisti della politica ha smesso da tempo di citare i libri che ha letto mentre si dedica con passione ad inseguire i ritmi e le logiche della comunicazione televisiva. Siamo alla politica del giorno per giorno, la cui agenda è dettata dai sondaggi e in cui la personalità dei capi fa premio sulla qualità dei programmi. Eppure, mai come in questa fase di grande confusione, c’è spazio per idee nuove. E le idee nuove ci sono (e non solo nei libri). E c’è anche una nuova generazione che può dare “gambe” a queste idee, che forse più che nei partiti lavora nelle ong in giro per il mondo. Certo, bisogna fare una rivoluzione culturale. Compito molto difficile ma (la storia ci dice) non impossibile. E oggi quanto mai necessario.
L
doppiozero, 18 febbraio 2017 (c.m.c.)
Gli orientamenti politici e gli esiti delle decisioni collettive sfidano oggi le tradizionali categorie della psicologia del potere. L’opinione pubblica alla base delle scelte si forma per vie che sfuggono alle forme conosciute e le campagne elettorali sono costruite al di fuori del mondo dei fatti. Non solo, ma chi sceglie in un certo modo, concorrendo a esiti determinanti anche per il proprio presente e il proprio futuro, sembra cambiare idea un momento dopo, a fatti compiuti e, almeno per un certo tempo, irreversibili.
Viene sempre più spesso in mente Winston Churchill e la sua affermazione sulla difesa della democrazia «purché non voti mia suocera». Una provocazione alla sua maniera che comunque induce a interrogarsi sul presente della democrazia e delle forme di esercizio del potere. A fare affermazioni senza prove e senza logica; smentendole immediatamente dopo o cambiando versione continuamente, si ottiene seguito e consenso e viene da chiedersi come sia possibile.
Se consideriamo l’elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti d’America, la domanda da porsi è come abbia fatto una minoranza di americani a portarlo al potere. L’interrogazione è, perciò, su un deficit di democrazia e sulla perdita di democrazia partecipativa, come sostiene Judith Butler.
«Ci avviciniamo all’ipotesi che ci pare di poter sostenere: non siamo di fronte a un’epoca di post-verità, bensì all’affermazione di forme di potere sovralegale», come le aveva definite Carl Schmitt.
L’uso del sistema democratico per prendere il potere e appropriarsene da parte di chi democratico non è, né nello stile né nella sostanza, mentre è comunque in grado di ottenere il consenso soprattutto di chi è in tutt’altra condizione, consente un accentramento del potere che non sarebbe concepibile in situazioni di una almeno relativa democrazia partecipativa. È necessario considerare la dematerializzazione e la virtualizzazione dell’esperienza per cercare di comprendere alcune delle vie di creazione del consenso e di affermazione del potere oggi. Si tratta, ad esempio, di riprendere quello che Jean Baudrillard scriveva parecchi anni fa:
«L’astrazione oggi non è più quella della mappa, del doppio, dello specchio o del concetto. La simulazione non è più quella di un territorio, di un essere referenziale o una sostanza. È piuttosto la generazione di modelli di un reale senza origine o realtà: un iperreale. Il territorio non precede più la mappa, né vi sopravvive. […] È la mappa che precede il territorio – precessione dei simulacri – è la mappa che genera il territorio […]. L’età della simulazione comincia con l’eliminazione di tutti i referenti – peggio: con la loro resurrezione artificiale in un sistema di segni, che sono una materia più duttile dei significati perché si prestano a qualsiasi sistema di equivalenza, a ogni opposizione binaria, e a qualsiasi algebra combinatoria. Non è più una questione di imitazione, né di duplicazione o di parodia. È piuttosto una questione di sostituzione del reale con segni del reale; cioè un’operazione di cancellazione di ogni processo reale attraverso il suo doppio operazionale. […] sarà un iperreale, al riparo da ogni distinzione tra reale e immaginario, che lascia spazio solo per la ricorrenza di modelli e per la generazione simulata di differenze.» (Simulacres et simulation)
I fatti non contano e la loro rappresentazione narrata predomina e vince. Come sostiene Judith Butler in un’intervista a Christian Salmon, apparsa il 24 dicembre 2016 su Robinson, parlando delle elezioni di Donald Trump e dei contenuti delle sue affermazioni: «Al momento i fatti sembrano indicare che non è così. Ma lui non vive in un mondo di fatti. (…..) Ha poca importanza se si contraddice o se si capisce che rigetta esclusivamente le conclusioni che intaccano il suo potere o la sua popolarità. Questo narcisismo sfrontato e ferito e questo rifiuto di sottomettersi ai fatti e alla logica lo rendono ancora più popolare. Lui vive al di sopra della legge, ed è così che molti dei suoi sostenitori vorrebbero vivere».
Da tempo ci siamo resi conto di vivere in un’epoca in cui non disponiamo più di verità indiscutibili e la nostra condizione, come ampiamente segnalato da un profondo filosofo come Aldo Giorgio Gargani, è quella di chi è passato dalla verità al senso della verità. Secondo Giorgio Agamben: «La civiltà che noi conosciamo si fonda innanzitutto su una interpretazione dell’atto di parola, sullo ‘sviluppo’ di possibilità conoscitive che si considerano contenute e ‘implicate’ nella lingua» (Che cos’è la filosofia?, Quodlibet 2016). L’uso della lingua e soprattutto i suoi effetti non sono determinabili a priori. Vi è una dimensione performativa che piega i significati a seconda delle contingenze.
Accade per esempio oggi che la parola sicurezza sia usata efficacemente per ridurre e decimare i diritti democratici di libertà e, per molti aspetti, la democrazia stessa. E non accade senza consenso. Chi predica la sicurezza dà voce ad aspettative che sono poi alla base di ampi consensi. Sulla consapevolezza delle conseguenze di quel consenso si potrà discutere, ma intanto si produce una legittimazione di un sistema di potere. Sarà pure una minoranza della popolazione americana ad aver portato Trump al potere; rimane il fatto che c’è riuscita affermando le proprie aspettative profondamente antidemocratiche di vivere e agire al di sopra della legge.
Appare evidente che entrano in campo emozioni arcaiche e primordiali sollecitate e amplificate da mezzi virtuali contemporanei che non governiamo, ma ci dominano. Nel momento in cui, in modo confuso e contraddittorio, un leader libera l’odio, invita a usare la cosiddetta pancia per scegliere, legittima la possibilità di esprimere la collera senza limitazioni, rende dichiarabile e proponibile il razzismo, ognuno può sentirsi libero di tirar fuori le viscere. L’arcaismo emozionale e la pratica del voto con lo stile immediato e pratico del “mi piace”/ “non mi piace” di Facebook, producono una miscela sostenuta dalle vie mediatiche, in grado di mettere in discussione le forme della democrazia così come la conosciamo.
I processi di identificazione immediati generano dinamiche di “altercasting” e nel momento in cui le persone si riconoscono in un modo di essere e di fare volendo essere come il leader, non ci sono più disposizioni a verificare la verità delle affermazioni o la fattibilità delle proposte, ma solo adesione massiva e conformista, come abbiamo mostrato nella voce Conformismo.
Ma perché le persone aderiscono? Probabilmente ciò accade per emulazione e per paura. Un leader può guadagnarsi l’ammirazione per aver trovato il modo di non pagare le tasse o per il fatto di riuscire ad avere tante donne a disposizione, molestie sessuali incluse. Il leader va dove vuole, fa quello che vuole e prende quello che vuole. Chi vota vorrebbe essere come lui. Ciò però non basta. L’emulazione riguarda anche la corporeità, la gestualità, la teatralità delle espressioni e la corrispondenza a un modello mediatico stereotipato. Come ha mostrato Marco Belpoliti ne Il corpo del capo, il corpo si afferma come metafora e come forma di esercizio del potere, in particolare nelle modalità totalitarie. La forza attrattiva dei gesti e la loro capacità di coinvolgimento, soprattutto nelle performance comunicative, mostra di essere una componente non secondaria del potere sovralegale.
Accanto a questi fattori e impastandoli di un clima particolare, agisce la paura. Sia la paura suscitata ad hoc enfatizzando fenomeni del tempo come l’immigrazione, il pericolo derivante dagli emarginati o da forme di rivolta, le donne, i disoccupati, i diversi di ogni tipo; sia la paura indotta dai rischi del presente e dalla cosiddetta società del rischio.
Il rapporto tra il potere che non si basa sulla legittimazione, sulla dimostrazione dialogica dei fatti e sulla critica reciproca, ma si situa al di sopra della legge; il rapporto tra quel potere e la paura è stato molto ben descritto da Herta Müller, premio Nobel per la letteratura, a proposito delle continue visite che riceveva a casa dai servizi segreti: «Mia madre chiese: che cosa vogliono da te? Risposi: paura. Era vero. Questa breve parola si spiegava da sé. Perché l’intero Stato era un apparato della paura. C’erano i sovrani della paura e il popolo della paura. Ogni dittatura è formata da chi incute paura e dagli altri, che hanno paura. Da chi vuole farti paura e chi morde per paura. Ho sempre pensato che la paura sia lo strumento quotidiano di chi vuole metterti paura e il pane quotidiano di chi, per paura, morde».
La paura da centralizzata si è fatta diffusa e dà vita a forme di potere non semplicemente riconducibili né ai fascismi storici e neppure alla post-verità.
Abbiamo due volte paura di questi tempi: paura per sé e per gli altri e paura dell’altro. E la maggior parte delle persone contribuisce ad alimentare la paura portandosela con sé, oltre a cercare di ottenere dalla paura propria e altrui il massimo vantaggio. Gestire la paura non è altro che il preludio all’ubbidienza.
C’è un’epidemiologia del potere che si basa su un particolare tipo di collusione tra chi domina e chi è dominato; su un forte accentramento e su un monopolio della comunicazione: tutto è reso possibile dal fatto che la maggioranza delle persone usa subendoli i social network, il sistema mediatico e i molteplici canali di informazione e comunicazione. Più che una post-verità sembra affermarsi una surverità, un potere sovralegale che non è raggiungibile con gli strumenti della critica e del conflitto politico come finora li abbiamo conosciuti.
la Repubblica, 28 gennaio 2017 (c.m.c.)
LA “NUOVA” America di Donald Trump, per rispondere alla provocazione di Roberto Saviano, si presenta al mondo con i connotati del vecchio rinnovato a nuovo: un populismo nazionalista che non nasconde il desidero autoritario. Il menu offerto dalla Casa Bianca in questa prima settimana assomiglia all’indice di un libro di storia della prima metà del Novecento. E in questo senso l’America di Trump è insieme vecchia e insieme espressione rappresentativa di un capitalismo globale che vuole rivedere il suo rapporto con la democrazia e il cosmopolitismo dei diritti umani.
Di nuovo in questa America c’è la sepoltura senza esequie non solo dei Gloriosi Trenta ma anche dell’ideale che li aveva nutriti: politiche di eguali opportunità e ricerca di cooperazione internazionale. L’America di Trump è un rinnovato vecchio: protezionismo economico in età di globalizzazione finanziaria che, per irrobustire l’industria nazionale, farà prima di tutto gli interessi delle multinazionali imprenditrici, promettendo ai molti (che hanno votato Trump) che questo sarà positivo soprattutto per loro.
La stessa vetustà nel nuovo è rintracciabile nella propagandistica cancellazione per decreto di intenti della riforma sanitaria di Obama lasciando in sospeso il contenuto, ovvero come potrà rendere l’assicurazione altrettanto universale senza gravare sulla spesa pubblica. In questa cornice si inserisce l’obolo ai repubblicani: l’assalto rinnovato al diritto di interruzione di gravidanza. Vecchia e tradizionale è anche la politica antiambientalista che subito si afferma per decreto, dando via libera al passaggio dell’oleodotto anche nelle terre dove vivono gli Indiani d’America, e che rischiano l’inquinamento delle falde acquifere.
Vecchia politica di aggressione all’ambiente, dunque, cucinata insieme alla promessa di alleggerimento delle tasse agli imprenditori se promettono di investire in America. Una politica, faceva osservare un articolista del New York Times, che vende l’illusione ottocentesca di moralizzare il capitale, come se non sia realisticamente ovvio ( in primis a Trump, lui stesso un impresario che opera sul mercato globale) che esso segue la logica della convenienza, non della morale.
Ma il protezionismo rinnovato in grande stile si avvale dell’armamentario della filosofia liberista che Ronald Reagan portò alla Casa Bianca: anche Trump prova a giocare con la favola del trickle- down, vendendo l’illusione per cui abbassare le tasse ai ricchi equivarrà a indurli ad investire con un po’ di convenienza per tutti. E la guerra ideologica contro il Messico, al quale Trump vorrebbe imperialmente fare pagare il muro anti-immigrazione che lui vuole finire di costruire, rischia di diventare un boomerang perché molti dei beni abbordabili per i consumatori americani sono importati proprio dal Messico, mano d’opera compresa.
Ma di nuovo zecchino, qualche cosa c’è. Prima di tutto, la pratica in grande stile e alla luce del sole del conflitto di interessi, di fronte al quale la più vecchia democrazia del mondo non ha, proprio come l’Italia di Berlusconi, nemmeno uno straccio di impedimento normativo. In secondo luogo l’attacco, anche violento nel linguaggio, verso chi critica il presidente e, soprattutto, verso la stampa. Trump rovescia la tradizione jeffersoniana per cui un Paese può reggersi senza un governo ma non senza una stampa libera e rispettata.
La Casa Bianca inscena quotidianamente comunicati contro i giornalisti, e in aggiunta contro l’opinione democratica che gli ricorda che lui, il voto popolare non lo ha preso. Per questo, Trump sta facendo una crociata senza precedenti per contestare i “dati” veri nel nome di “dati alternativi” e quindi ricontare i voti. Il Presidente è in permanente campagna elettorale, come il populismo vuole.
Quale sarà l’effetto di questa vecchia-nuova politica populista e nazionalista fuori dagli Stati Uniti? Questa domanda mette in luce l’altra grande novità del governo Trump: la sua presidenza è un messaggio eloquente di sostegno ai populisti d’Europa, a partire dagli eredi della Brexit, ma soprattutto a quelli emergenti nel vecchio Continente che a Coblenza si sono riuniti in internazionale populista con un solo obiettivo: atterrare questa Unione per fare una nuova Europa, tanto populista, bianca e cristiana quanto l’America che Trump vuole.
La novità straordinaria che sta sotto i nostri occhi è che, oggi, il maggiore concorrente dell’Europa democratica viene proprio dall’America.La storia ha ricorsi mai identici perché avvengono in un nuovo contesto. Ritorna con l’elezione di Trump la reazione contro la democrazia tollerante e la voglia del nazionalismo geloso delle frontiere, e che però deve alzare muri fisici poiché mezzo secolo di libertà di movimento non si cancella per decreto.
Ritorna il senso di fallimento degli ordini liberali degli anni del primo dopoguerra, quando dalle disfunzioni dei partiti tradizionali emersero nuovi leader autoritari che si scagliarono contro l’umanitarismo democratico e la Lega delle Nazioni. Così Trump arringa contro l’Onu e dichiara che la tortura può essere buona strategia nella lotta contro l’Isis, ignorando che anche il suo Paese ha firmato una convenzione internazionale contro la tortura, che la pratica in silenzio e senza fanfara presumendone l’illegittimità.
La grande differenza è che nel Primo dopoguerra, in alternativa ai regimi totalitari che quei “nuovi” leader misero in scena, negli Stati Uniti si stava sperimentando una risposta democratica alla crisi economica, a guida Frank Delano Roosevelt. La nuova America è, al contrario, omologa alla voglia di populismo che c’è in Europa. E questa novità è una cattiva notizia per tutti.