

eddyburg, dedicati a ricordare una studiosa di problemi ambientali e una comunista, e a imparare ancora da lei. Il convegno, “Per un nuovo ecologismo. Laura Conti vent’anni dopo”, si svolgerà sabato 8 giugno a Mestre, in calce il link al programma
Ci sarà a Venezia sabato prossimo, un convegnodedicato a Laura Conti. Promosso dall’associazione“Gli asini” e la rivista “Lo straniero” con il sostegno e il patrociniodell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Venezia. Titolo del convegno è “Perun nuovo ecologismo. Laura Conti vent’anni dopo”, esso si svolgerà sabato 8giugno 2013 dalle 9:00 alle 19:00 presso la Plip Centrale dell’Altraeconomia diMestre. Il dibattito partirà da una serie di relazioni e interventi cheillumineranno vari aspetti dall’esperienza e dall’opera di Laura Conti, medico,partigiana e ambientalista, autrice, tra l’altro, di Checos’è l’ecologia (in ristampa per le Edizioni dell’Asino, con lerevisioni volute dall’autrice) scomparsa nel 1993. Vedendo tra i partecipantil’amico, e “opinionista" di eddyburg, Giorgio Nebbia l’ho pregato di inviare peri nostri frequentatori un suo ricordo di Laura Conti. Non l’ho conosciutapersonalmente ma ricordo con emozione i suoi libri (in particolare Una leprecon la faccia di bambina) e i suoi illuminanti articoli su l’Unità di queglianni. Anni in cui l'ambientalismo, quando c'era, era una cosa seria e non sconfinava nella "green economy" (e.s.)
Corriere della Sera, 11 aprile 2013 (f.b.)
Molti di coloro che l'hanno visitata, decidendo di svoltare la macchina da Phoenix sulla route 17 in direzione Sedona — perché lì c'è la città dell'architetto visionario, la Blade Runner hippy — sono rimasti un po' delusi di quanto fosse indietro la costruzione del luogo utopico di Arcosanti. «Ci manteniamo vendendo campane di ceramica», si giustificavano con i 50 mila visitatori all'anno i tanti studenti - stagisti o stanziali (7 mila in tutto) — che spiegavano cosa stesse nascendo lì, tra i cactus del deserto dell'Arizona. «La ricchezza di questo luogo — spiegavano — consiste non nell'avere di più, ma nell'aver bisogno di meno».
Beata gioventù, beat, spirituale, on the road! L'idea che la frontiera americana fosse anche la frontiera ideale per costruire una nuova «città del Sole» venne all'architetto torinese Paolo Soleri, scomparso novantatreenne il 9 aprile (come il suo maestro Frank Lloyd Wright), alla metà degli anni Sessanta. Di città utopiche l'architettura si è sempre nutrita: Tommaso Moro, Giovanni Botero, Tommaso Campanella… e, poi, i grandi architetti rivoluzionari francesi del Settecento come Boullée, Ledoux, Durand, padri ideali del Movimento Moderno secondo lo storico Emil Kaufmann. Solo che quasi tutte queste gigantesche città ideali sono rimaste sulla carta: disegni o parole. Soleri, invece, era partito dal Parco del Valentino (sede del Politecnico di Torino dove si era laureato nel '46) animato dallo spirito del socialismo utopistico ottocentesco di William Morris e di John Ruskin, per fondarne una. Era partito come i pioneri che avevano fondato l'America per declinare questo utopismo «Art and Craft» ai suoi giorni, facendolo incontrare con la beat generation e un po' di New Age, che aveva in Sedona la sua capitale. È vero: erano i tempi di Bob Dylan, Joan Baez, e Arcosanti, la città ispirata a una nuova disciplina ecologica chiamata «arcologia», poteva nascere persino non lontano dalla downtown di Los Angeles con vista sui vizi dello show-biz di Hollywood.
Arcologia, ovvero un misto di angelico, di romano (l'arco) e di utopistico che aveva in sé le stimmate del non-finito: non poteva concludersi quel luogo, solo rimanere un on the road dell'architettura, città nata in «rovina» e, pertanto, come diceva il filosofo Georg Simmel, essenza stessa dell'architettura in quanto rappresentazione dello sforzo spirituale dell'uomo d'innalzare e della Natura di distruggere.
Soleri, nato a Torino il 21 giugno 1919, iniziò a costruire Arcosanti nel 1970, prototipo di città per 5 mila persone i cui primi abitanti furono lui e sua moglie Colly, trasferitisi in Usa nel '47. Lui era andato a lavorare nello studio di Taliesin di Frank Lloyd Wright, il grande maestro di quell'architettura organica che gli servì come approccio per costruire luoghi che sfruttassero il meno possibile risorse e ambiente. Nel '65 annunciò su «L'Architecture d'Aujourd'hui» l'intenzione di realizzare una grande struttura per la Nuova Cosanti su un terreno a 60 miglia a nord di Phoenix. La fondazione messa su da lui riuscì ad acquistare 60 acri di terreno e a ottenere la concessione per lo sfruttamento di altri 800 acri confinanti. Il luogo scelto fu la parte terminale di una gola che si affaccia sulla valle del fiume Agua Fria. Iniziò un rito, una performance: arrivarono gli studenti peace-love-freedom dell'Arizona e si cominciò a costruire, con mattoni realizzati a mano, archi, case e stazioni di osservazione delle costellazione, quasi sul modello dell'osservatorio astronomico di Jaipur. L'idea urbanistica è quella dell'implosione, cioè dell'accorpamento delle varie finalità in un corpo organico collettivo (vedi anche il progetto per Mesa City del '59). Le aeree liberate dai mega accorpamenti dovevano servire per l'agricoltura o il godimento naturale. «Questo forma un ecosistema», diceva Soleri.
A parte i laboratori urbani di Cosanti e Arcosanti, in Arizona, Soleri progettò nel '96 un Hyper Building, una città-satellite autonoma da costruire in pieno deserto Mojavé composta da un edificio-torre alto un chilometro, che doveva ospitare 100 mila abitanti: un mammuth che ricorda Metropolis di Fritz Lang o lo scenario di Il condominio di James Ballard. Riuscì a costruire un ponte a Scottsdale e una fabbrica di Vietri sul Mare. Ascetico e visionario, non si stancò mai di sognare mentre l'architettura era diventava speculazione, esibizione... Venne premiato tardi: nel 2000 Leone d'oro alla Biennale (che ieri lo ha ricordato) e nel 2006 Cooper Hewitt Award. Nel 2005 il Maxxi gli dedicò una mostra, nel 2003 Jaca Book ha pubblicato un suo Itinerario di architettura. Lascia due figlie, Kristine e Daniela, che svolgono ricerche urbane presso la Cosanti Foundation. Il funerale sarà privato ad Arcosanti e il corpo tumulato a fianco di quello della moglie Colly, morta 31 anni fa. Un public memorial sarà celebrato ad Arcosanti.
Nel 1816, nel pieno della rivoluzione industriale inglese, Ugo Foscolo si trasferì in esilio volontario a Londra. Veniva da un agitato e povero soggiorno in Svizzera e non voleva ritornare nella Milano austriaca. E a Londra fu accolto con affetto e onore da politici e letterati cui era giunta la sua fama. Era fuggito dall´Italia lasciando incompiuto il poema Le Grazie dove avrebbe voluto raccontare in versi l´Armonia e «idoleggiare le idee metafisiche del Bello».
A Londra però l´attendevano altri impegni: la ricerca letteraria e critica, un´attività giornalistica come collaboratore di riviste inglesi e le inquietudini di osservatore della realtà sociale del paese che lo aveva accolto. Curioso delle macchine e dei progressi industriali in corso, visitò nel 1822 Manchester e Liverpool, fumanti di ciminiere, tra fragori di officine, soprattutto tessili, e rumorosi cantieri e fu una folgorazione: al poeta della bellezza si apriva lo scenario brutale dell´industrializzazione e del profitto capitalistico. Scrisse a una amica: «I vostri figli, o al più tardi i vostri nipoti si accorgeranno che la vera rivoluzione sarà qui tacitamente prodotta da un lato dalla disperata miseria della moltitudine, e dall´altro dalla potenza economica dei plebei arricchiti». E, alla fine, concludeva, si impianterà «la più terribile delle tirannidi, quella degli Oligarchi padroni delle manifatture che non hanno altra idea, altro sentimento che quello di fare fortuna».
Foscolo anticipava di vent´anni l´ansia di Leopardi per l´incalzare di «macchine al cielo emulatrici»; a cominciare dall´«Anglia tutta con le macchine sue» della Palinodia. I due poeti forse credevano di essere soli o tra pochissimi uomini di cultura a rimanere perplessi e sgomenti di fronte alle contraddizioni del progresso industriale, ma non era così perché proprio in quei vent´anni, anche in piena ideologia del libero mercato, stavano maturando, soprattutto in Inghilterra, riflessioni molto critiche sui limiti e i difetti di quella rivoluzione economica. E non era il lamento di aristocratici conservatori, di proprietari terrieri scalzati dal progresso (in un´inchiesta del 1811 risultava che i lavoratori dell´Inghilterra, della Scozia e del Galles occupati nell´industria e nel commercio superavano ormai di una volta e mezza quelli dell´agricoltura), ma di uomini d´affari e imprenditori intelligenti, non appartenenti ai «plebei arricchiti», e di studiosi attenti della società.
Saranno questi a gettare i primi semi di un mondo nuovo, diverso, progredito ma civile. In particolare uno di loro, Robert Owen, finito stranamente tra gli "utopisti" forse perché verrà accomunato nel Manifesto dei comunisti di Marx e Engels a quei singolari pensatori (ad esempio, Fourier e Saint-Simon) che «emergono nel primo periodo, non sviluppato, della lotta tra proletariato e borghesia». In verità, nella descrizione precisa e nella critica del capitalismo industriale, Marx ed Engels sono arrivati dopo di lui e comunque senza Owen non sarebbe nato il socialismo in Inghilterra e non sarebbero iniziate l´esplorazione e la diagnosi del modo di produzione industriale, delle condizioni di vita e di salute degli uomini, delle donne e dei bambini impegnati nelle officine e nelle miniere, né sarebbe apparsa, nella polemica politica di quegli anni, la possibilità che la società industriale potesse essere più vivibile di quella che si era venuta formando. Non risponde dunque a verità storica il fatto che l´avere Owen creduto in quella "possibilità" ne facesse l´esponente di un sogno utopistico, lontano dalla conoscenza dei rapporti effettivi di produzione e in assenza della lotta di classe dal cui esito vittorioso per il proletariato avrebbe potuto essere rovesciato quel mondo di povertà e di sfruttamento.
Anzi, pensando all´utopia "possibile" del tempo di Owen e del contemporaneo Henri de Saint-Simon (di cui è recente in Francia la riedizione degli scritti dove è limpidamente disegnato un futuro reale, non un sogno) si rimane sgomenti della contraddizione intellettuale e politica in cui si trova l´Europa attuale. Qui sembra perduta per sempre ogni ipotesi di riforma e di cambiamento che guardi oltre il presente, che osi immaginare, come fece Saint-Simon nel 1814 nel volume La riorganizzazione della società europea, un socialismo creativo in una «stretta eguaglianza di ordinamenti, di interessi e di istituzioni». Una Europa dunque senza riferimenti, attraversata e accomunata dalla paura, dal rifiuto per tutto ciò che non sia una razionalizzazione dell´esistente. Eppure nessun futuro sembra dispiegarsi davanti a noi se non riprendendo proprio l´intelligenza delle cose, quel filo che qualcuno aveva cominciato a svolgere proprio ai primi dell´Ottocento.
Infatti, duecento anni or sono, nel 1813, Owen aveva pubblicato un saggio che fece scalpore, Per una concezione nuova della società. Segnava l´inizio di una stagione di idee riformatrici che nel 1815, un anno prima della visita di Foscolo a Manchester, saranno più visibili nel saggio Osservazioni sugli effetti del sistema industriale. I titoli dicono molto perché Owen sapeva benissimo di cosa parlava. A vent´anni, nel 1791, aveva diretto una delle più grandi filande del Lancashire, dove lavoravano cinquecento operai e poco dopo, ormai ricco industriale e membro tra i più autorevoli della Società letteraria e filosofica di Manchester, era divenuto proprietario delle più moderne filande di New Lanarck, in Scozia. La sua azienda era fiorente e per venticinque anni Owen sperimentò un modello di società industriale dove il ruolo dell´imprenditore-capitalista fosse non solo quello di creare oggetti, ma di avere per collaboratori soggetti (i lavoratori e le loro famiglie) sani, ben retribuiti, felici del loro lavoro, partecipi delle sorti del tessuto civile e sociale della comunità. Insomma, l´industria come un servizio sociale e tramite di crescita culturale e morale senza bisogno della «lotta tra proletariato e borghesia» di cui parlerà il Manifesto.
Che il progetto, realizzato, fosse unico, inedito, sorprendente lo prova il fatto che a New Lanarck affluirono visitatori e osservatori da tutto il mondo per vedere come mai gli alti salari, le ore di lavoro ridotte, la protezione delle donne e dei minori impegnati nel lavoro, buone case, cibi e vestiti decenti, fabbriche areate e circondate dal verde, l´educazione scolastica dei bambini ispirata al laicismo, all´ateismo, alla conoscenza e alla solidarietà, producessero così grandi guadagni al proprietario. Tanto più che Owen aveva dato un limite al profitto del suo capitale e aveva deciso che i profitti eccedenti fossero tradotti in servizi sociali a favore dei lavoratori della fabbrica. Ebbene, il saggio Per una concezione nuova della società e lo scritto successivo destinato a correggere «le parti più dannose alla salute e alla morale» dei lavoratori del sistema industriale non erano altro che il risultato dei piani di Owen per le sue fabbriche "umanizzate". Se poteva apparire un´utopia essa era tale che, attuata nella vita sociale, avrebbe, come scrisse lo storico Maurice Dobb, «spazzato via in breve tempo il capitalismo e il sistema concorrenziale».
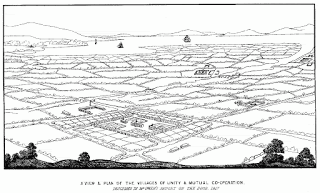 |
| il progetto di New Harmony |
Corriere della Sera, 14 febbraio 2013 (f.b.)
Si è spento ieri, dopo un'amara, lunga malattia, Gabriele Basilico, uno dei massimi protagonisti della fotografia europea. Le sue immagini propongono uno sguardo lungo sul mondo delle città, non quelle dei monumenti ma delle periferie, bordi slabbrati e consunti, spazi deserti di figure le cui tracce sono sempre presenti, fili, insegne, cartelli, arredi urbani. Un'invenzione senza confronto, ma che ha una storia.
Nato nel 1944, iscritto al Politecnico, architetto, sceglie subito la fotografia; non dialoga con Henry Cartier-Bresson ma semmai con Ugo Mulas che, fin dai primi anni 60, costruisce i tempi lunghi di uno sguardo sul mondo che tanto peserà sull'esperienza di molti. Basilico sceglie i propri modelli: prima di tutto Walker Evans che fotografa su lastra, condensando in un'immagine, il racconto dei luoghi dell'agricoltura statunitense rovinata dalla crisi del 1929.
Poi Eugène Atget che delle strade vuote, delle vetrine di Parigi, costruisce il mito e la storia. La prima grande ricerca "Milano ritratti di fabbriche" (1978-80) Basilico la racconta così: «Il vento, quasi assecondando una tradizione letteraria, sollevava la polvere, metteva in agitazione le strade, puliva gli spazi fermi, ridonando plasticità agli edifici, rendendo più profonde le prospettive delle strade... per la prima volta ho visto le strade e, con loro, le facciate delle fabbriche stagliarsi nitide, nette e isolate su un cielo inaspettatamente blu intenso... anche l'ombra diventava un elemento compositivo».
Una Milano delle fabbriche ai bordi del tessuto urbano, bloccate nello spazio come nelle foto di Bernd e Hilla Becher, ma con una dimensione di racconto diversa, quella di Mario Sironi e delle sue periferie, quella di Giorgio de Chirico e delle sue scene deserte, ma qui senza statue, solo prospettive taglienti, forme bloccate. È degli inizi degli anni '80 l'incontro con Luigi Ghirri e l'adesione a un altro progetto, quello della mostra «Viaggio in Italia» (1984). L'idea è di riprendere non l'Italia dei monumenti ma quella dei luoghi esclusi, ai margini, l'idea è di ritrovare la dimensione di un nuovo e diverso paesaggio, un paesaggio «altro», quello dei romanzi di Italo Calvino e quello, più vicino al gruppo di Ghirri, dei racconti di Gianni Celati che narra le umide mitologie dei pioppeti senza fine delle campagne del nord.
Ecco, in questa dimensione di racconto, sospesa fra pittura, letteratura e sguardo della memoria, si inserisce l'esperienza della «Mission Datar» (1984-1988) dove Basilico viene chiamato in Francia a riprendere le coste della Normandia, porti e strutture urbane, insieme a un gruppo fra i maggiori fotografi europei. Comincia con numerosi sopralluoghi, si devono pensare le foto prima di scattare: sei mesi di lavoro. Basilico riprende su lastra, col cavalletto, concentra l'immagine il più possibile, lascia, come Evans, come Atget, fuori del campo visivo le persone perché la città, il porto, sono esse stesse racconto, storia. «Sono diventato amico dei luoghi... i luoghi mi aspettavano, il porto di Dunkerque o di Le Havre erano pronti, come ad attendermi, a rilanciare il rito dello sguardo che si trasformava in fotografia».
Ma gli spazi dilatati delle immagini dei porti e delle marine hanno una storia, dei modelli che lo stesso Basilico riconosce: Bellotto con le grandi vedute di Dresda, toni bassi, forme taglienti, scandite, dove il racconto sembra dilatarsi oltre il limite del riquadro; oppure le vedute di Van Goyen o di Ruysdael, quelle del grande '600 olandese. Ecco, è questo il «senso dell'infinito come oggetto, come spazio osservato» che Basilico vuole creare.
L'altro grande momento della sua ricerca è Beirut, la città distrutta dalla guerra, un chilometro quadrato di edifici ripresi lentamente, con cavalletto e macchina a lastre, per fotografare lo spazio della memoria. «Il vuoto per me non significa mai vera assenza: si tratta piuttosto di una fase di silenzio che mi permette di instaurare un dialogo, spero autentico, con la realtà». Dopo vengono altre ricerche sulle periferie che si dilatano divorando le campagne, periferie senza centro, e sono quelle di «Appunti di un viaggio» (2006). E poi ancora le grandi ricerche su Istanbul, Shangai, Mosca, dove spesso «gli edifici svelano una forma antropomorfa: nelle architetture sono nascosti occhi, nasi, orecchie, labbra, volti che aspettano la parola».
In fondo, Basilico, come ogni grande artista, ha scattato sempre pensando a una stessa immagine, e lo scrive: (le mie sono) «le stesse fotografie... con gli stessi punti di vista... le stesse variazioni di luce» e questo per ritrovare, nel suo dialogo con l'enorme spazio degli orizzonti urbani, quella lunga durata che resta il segno più evidente del suo civile, umanissimo racconto.
«Più scuole e meno chiese, trasporti pubblici, illuminazione nelle periferie e consultazioni pubbliche. Cento anni dopo, l'insegnamento per Roma di un sindaco ebreo, laico, repubblicano è ancora valido» Il manifesto, 15 gennaio 2013
A mali capitali, antichi rimedi
Pareggio del bilancio sì, quindi. Con rigore. Ma anche, insieme, investimenti per le scuole, per l'istruzione. Più scuole e meno chiese, dice Nathan. «Nella Roma di un tempo non bastavano mai le chiese per pregare, mentre invano si chiedevano le scuole; oggi le chiese sovrabbondano, esuberano; le scuole non bastano mai!» chiarisce Nathan in un celebre discorso tenuto il 20 settembre 1910 alla breccia di Porta Pia, discorso che provocherà furiose polemiche. Roma usciva appena da secoli di dominio papale, era una città dove il lavoro produttivo era scarso e le condizioni sanitarie pessime: tutto intorno alla città, l'Agro romano era fonte di febbri malariche. L'analfabetismo dominante si accompagnava a povertà e a miseria. Sono dei primi del Novecento, nate per iniziativa di poeti e scrittori, di vari intellettuali, le Scuole per i contadini nell'Agro romano. Vengono aperte nelle aree più povere e degradate, sono scuole rivolte ad adulti analfabeti: incoraggiate e concretamente aiutate da Nathan. Che cerca altresì di dare spazio alle scuole professionali - scuole commerciali, per operai addetti al gas, elettricisti, oltre che per assistenti edilizi, magistrali per muratori e operai meccanici - che cerca di abbinare scuole e industrie private, di mettere in collegamento questi due ambiti: eppure la Gelmini nella sua cosiddetta riforma presentava questa esigenza come una grande novità.
Roma oggi è di nuovo una città fortemente degradata. Strade dissestate e sporche, macchine parcheggiate in doppia fila, che rendono difficile lo scorrimento del traffico, lavori annosi che non appena terminati devono essere ripresi perché mal fatti o perché si sono usati materiali non adatti o di scarto, alberi che avrebbero bisogno di cure, parchi abbandonati, servizi che lasciano a desiderare, come ben sa chiunque si sposti o cerchi di spostarsi con mezzi pubblici: i servizi invece erano stati una priorità, per il blocco Nathan. Che, con Montemartini, ha dato un forte impulso in merito: il comune si è occupato dell'igiene della città, dell'assistenza sanitaria. Sono state istituite guardie ostetriche per partorienti, profilassi di malattie infettive, presidi per medici in zone in difficoltà come Porta Metronia, Ferratella, in vari luoghi dell'Agro romano: e si richiede ai medici di risiedervi. Oggi il welfare è uno dei nodi problematici più rilevanti, un tema con cui si dovrà confrontare chiunque lavorerà in Campidoglio.
Hanno luogo in quegli anni le prime consultazioni popolari: per la mobilità, da cui poi l'Atac. Per l'illuminazione, da cui l'impianto idrotermoelettrico per la produzione e distribuzione dell'energia elettrica, sia per la forza motrice che per l'illuminazione; da cui l'Acea (si può ancora ammirare la centrale Montemartini al Testaccio, oggi un museo). Non senza critiche e irrisioni da parte di una stampa non abituata all'esercizio della democrazia nell'Urbe, in testa il noto «Il Travaso» che pubblica tredici derisorie quartine contro l'idea stessa del referendum («Ben è ver che se Dio non provvede/ a dar Egli la luce ... al cervello, / faccia il Blocco o non faccia l'appello,/ a che serve un miliardo di sì?»), laddove Nathan ha chiaro che l'illuminazione è una misura minima basilare, come ben sanno molte donne che negli ultimi tempi hanno subito aggressioni in zone periferiche, abbandonate e scarsamente illuminate di Roma. E non solo.
Ci si propone la moltiplicazione dei mercati, la guerra al bagarinaggio: e il fastidio per il mercato del pesce dal sindaco voluto e fatto aprire si riflette in una canzonetta di Giggi Pea, pubblicata da G. Micheli: «Er mercato der pesce è 'na risorsa,/questi so' fatti, mica so' parole,/de scuali, de merluzzi e de ciriole/ a Roma ce ne so' na quantità.// Poi sta' sicuro e si ne voi 'na prova/ar sinnico tu chiedi un baccalà/nemmeno volta l'occhi e te lo trova/ e nun lo paghi manco la metà...»
C'è bisogno di case, di case popolari: troppe le persone costrette a vivere in baracche, in alloggi impropri, con danno della salute. Si avrà un moderno piano regolatore, quello di Saint Just di Teulada, che prevedere diversi tipi edilizi, case popolari. Zone di Roma come Prati, S. Saba, Testaccio sono ancora lì a testimoniare l'importanza di quest'opera. E si cercherà di perseguire una rigida applicazione del sistema di tassazione sulle aree fabbricabili previsto su piano nazionale, basato sull'autodichiarazione del valore del terreno, che potrà però anche essere espropriato sulla base del prezzo dichiarato. Naturalmente la speculazione edilizia non gradisce. E sarà proprio sull'edilizia che la giunta incontrerà le maggiori difficoltà e resistenze, che cadrà.
Promettere poco e mantenere molto, diceva Ernesto Nathan. Proprio il contrario di quanto si fa oggi, quando eventuali candidati promettono mari e monti, da drastici sgravi fiscali a rosei, vicinissimi futuri. E si sa già che non manterranno nulla di quanto proclamato.
È stato, Ernesto Nathan, un riformista autentico. Ci sarebbe bisogno, oggi, di persone come lui, attente ai problemi degli strati sociali maggiormente in difficoltà, pronte a spendersi in prima persona.
IERI E OGGI
Le analogie tra la Roma del 1906 e la Roma di oggi sono notevoli: la situazione economica e sociale della città e quella finanziaria del Comune che Nathan ereditò dalla precedente amministrazione di Prospero Colonna non sono diverse da quella che Alemanno lascia in eredità al futuro sindaco di Roma-Capitale. Oltre al malgoverno del Comune - con un dissesto finanziario che richiese una svolta decisiva, c'è un'analogia significativa che riguarda l'invadenza del Vaticano e degli ambienti della destra cattolica nella vita della città. Non meno importanti sono le analogie che riguardano la situazione dei lavoratori, sia per quel che riguarda i livelli occupazionali e le condizioni di lavoro - con la disoccupazione strutturale, la precarietà occupazionale e i bassi salari - sia per quanto riguarda le condizioni di vita, in particolare le condizioni igienico-sanitarie degli alloggi e dei ricoveri dei lavoratori più precari. I bassi salari e la difficoltà di trovar casa a condizioni accessibili - nella Roma che in trent'anni dopo l'Unità aveva più che raddoppiato la sua popolazione - riguardavano tutti, non solo la classe operaia e gli strati più bassi dei lavoratori dei servizi ma anche vasti settori dell'impiego pubblico. Con la differenza che all'epoca, dopo il decennio della febbre edilizia e quello della crisi, le case semplicemente non bastavano; ora ci sono ma ne sono esclusi quelli che non possono pagare.
Chi stava peggio erano gli immigrati, dall'entroterra laziale e abruzzese. Erano i lavoratori agricoli, braccianti alla giornata, che con lo sviluppo dell'edilizia si trasformarono sempre di più in lavoratori edili talché al mercato delle braccia per la mietitura e le altre attività agricole stagionali si andò sempre più sostituendo il mercato delle braccia per l'attività edilizia. Ora vengono da più lontano: sono gli immigrati dal Terzo Mondo e dai paesi dell'Est. Il mercato delle braccia ora si svolge in prossimità degli "smorzi" (i magazzini-deposito di materiale edile) ed essi dormono dove possono. Prima i "cafoni" o i "burini", non potendo permettersi un alloggio, passavano le notti sotto i portici di piazza Vittorio.
Nei decenni precedenti l'esperienza di Nathan la struttura sociale della città era cambiata significativamente. Roma non aveva avuto lo sviluppo industriale delle altre capitali europee: non si può dire che si fosse consolidata una classe operaia industriale (come lamentavano studiosi, sindacalisti e settori del partito socialista) ma è altrettanto vero che gli addetti all'industria erano significativamente aumentati, anche se dominava l'occupazione nei servizi e la componente più evidente del proletariato era rappresentata dagli edili, spesso collocati all'esterno o al margine delle organizzazioni sindacali o aggregati in organizzazioni con posizione critica, come la Lega generale del lavoro, frutto di una scissione della Camera del lavoro, nella quale la componente anarchica era particolarmente significativa.
Dall'altra parte c'era una aristocrazia terriera collegata al Vaticano alla quale erano aggregati settori di borghesia reazionaria anch'essi interessati alla speculazione edilizia e alla rendita e coinvolti anch'essi negli scandali che a fine '800 avevano riguardato il paese e Roma in particolare. È a questo blocco che si opporrà Nathan. Ma già prima di lui l'indebolimento del fronte reazionario, e un primo blocco popolare che comprendeva anche rappresentanze del movimento operaio, aveva permesso la formazione di una giunta progressista (con sindaco Armellini), ancorché di breve durata, che mostrò l'esistenza di un'alternativa.
Questa si concretizzerà e lascerà un segno indelebile nella storia di Roma con l'elezione a sindaco di Ernesto Nathan. Dal punto di vista del lavoro, disoccupazione e bassi salari si presentavano in maniera drammatica. E su questo la possibilità di intervento dell'amministrazione comunale è molto modesta. Ma le condizioni dei lavoratori possono essere alleviate subito e migliorate in prospettiva con un intervento massiccio nel campo delle politiche sociali. Ad esempio con una politica abitativa per cui coloro che costruiscono le case per la gente non siano costretti a dormire all'addiaccio. Ma anche con lo sviluppo dei servizi e le municipalizzazioni operate da Nathan che ne resero più efficiente la gestione e meno onerosa la fruizione. La lotta contro l'analfabetismo e la politica scolastica i furono cardini fondamentali dell'impegno di Nathan. Le politiche sociali - si sa - costano. Ma fanno anche risparmiare consentendo sviluppo economico e sociale. E poi i costi sono resi affrontabili da un recupero delle risorse attraverso una tassazione giusta (come allora quella sui suoli o, come potrebbe essere ora, una patrimoniale) e attraverso la gestione di un bilancio pubblico e trasparente.
UN CONVEGNO E UN APPELLO
Una nuova rivoluzione nel segno di Nathan
Nel 1913 terminò la l'esperienza del sindaco più straordinario che Roma abbia avuto: Ernesto Nathan. Nel 2013 a Roma si vota per un nuovo sindaco. Nathan, tanto laico da proporre una legge sul divorzio nella città dei papi, mazziniano, ebreo, alleato dei socialisti, ha rappresentato una significativa frattura nella compatta storia della capitale: prima e dopo, e per un intero secolo, a dominare e plasmare la città sono stati - salvo brevi intervalli, in particolare l'esperienza di Petroselli - gli interessi della speculazione fondiaria ed edilizia. Quella di Nathan fu una rivoluzione interrotta. La sua amministrazione agì soprattutto su quattro ambiti, secondo la sintesi di Italo Insolera nel suo "Roma moderna": la tutela dell'igiene pubblica, l'incremento dell'istruzione elementare, una politica volta a limitare la speculazione fondiaria, la partecipazione della cittadinanza all'amministrazione. In quei pochi anni, non più di sette, fu varato il primo Piano regolatore di Roma, furono costruite decine di scuole elementari e rurali, fu costruita una rete tramviaria moderna che, grazie al solo referendum cittadino che si sia mai tenuto in città, divenne un'azienda municipale, così come Acea - acqua ed energia - azienda che Alemanno ha cercato di privatizzare del tutto: la pubblicizzazione dei servizi pubblici è un'indicazione più che mai attuale, dopo gli anni delle privatizzazioni forzate, che proseguono. (...) A noi pare che - se si vuole ridare un futuro a Roma - è da lì che si deve ricominciare. I quattro punti di quel programma sono, visti con gli occhi di oggi e guardando alle più innovative proposte sulla vita delle metropoli, i punti di partenza di una nuova rivoluzione romana. (...) Tutto questo noi vorremmo fosse l'oggetto di un convegno, da tenersi il 19 gennaio, presso la sala dell'Acquario (piazza Manfredo Fanti 47, a Roma), in cui intelligenze ed esperienze romane, docenti e giovani ricercatori, organizzazioni sociali e movimenti per la casa abbiano l'opportunità di studiare e dibattere quel che accadde un secolo fa per ricavarne l'ispirazione, l'energia necessaria ad avviare le grandi trasformazioni indispensabili per ridare a una città umiliata e impoverita, incollerita e frantumata, una speranza di futuro.
Maria Delfina Bonada, Maria Rosa Cutrufelli, Tommaso Di Francesco, Maria Immacolata Macioti, Riccardo Magi, Rossella Marchini, Angelo Mastrandrea, Sandro Medici, Sandro Morelli, Roberto Musacchio, Vincenzo Naso, Anna Pizzo, Valentino Parlato, Bianca Pomeranzi, Clotilde Pontecorvo, Alessandro Portelli, Enrico Pugliese, Patrizia Sentinelli, Antonello Sotgia, Pierluigi Sullo
L
The Nation, dicembre 2012, postilla (f.b.)
È quello di Jane Jacobs il nome che più spesso emerge nelle discussioni sulla qualità dell’abitare urbano contemporaneo. Ed è comprensibile, visto che il suo La Vita e la Morte delle Grandi Città ha avuto un’influenza sulle discussioni urbanistiche superiore a quella di qualunque altra opera. Però c’è anche un’altra Jane, Holtz Kay, il cui nome emerge forse un po’ più in sordina, ma di sicuro fra chi conta in questo campo. Una Jane che ha combattuto instancabilmente per decenni nelle trincee della critica di architettura e urbanistica, della conservazione storica, dell’attivismo politico e del giornalismo ambientale, e che fra gli altri prestigiosi ruoli ha ricoperto a lungo anche quello di critico di architettura per The Nation.
È stata probabilmente la sua ammirazione per Lewis Mumford, a partire dalla tesi specialistica del 1960 all’università Radcliffe con la prima intervista con lui, ad averla spinta a spaziare così tanto, senza però perdere il contatto coi più minuti particolari della vita quotidiana. A Mumford ha sempre fatto riferimento, direttamente e in quanto ha scritto, tante volte nei decenni. Nell’intervista pubblicata nel 1977 dalla rivista dell’American Institute of Architects, ci guida attraverso l’opera di Mumford, la sua eredità, la vita familiare di ogni giorno. Sa far rivivere il respiro della sua intelligenza, lo stile di lavoro, l’ambiente di cultura armena che lo circonda, e a dar voce anche a Sophia: “moglie, compagna intellettuale, amica per la vita, … sostegno materiale negli anni della gioventù, amanuense nella vecchiaia”.
Ma non si trattava certo di devozione cieca, come conferma questo splendido breve paragrafo della recensione all’autobiografia pubblicata nel 1982 sul Christian Science Monitor: “Nella sua autobiografia, così come nella vita, i lungimiranti obiettivi intellettuali di Mumford, il suo sguardo pessimista e morale, lo portano al tempo stesso verso il successo e il fallimento: fallimento perché sono i nostri Giosuè, non i Geremia, a far crollare le mura della società; successo perché le sue argomentazioni etiche lo proiettano nei secoli”. Jane Holtz Kay ha pubblicato una grande quantità di articoli; idee, revisioni, interviste, opinioni, critiche, dal campo dell’architettura, alle trasformazioni urbane, al “suburbio dell’auto”, a Olmsted, alla progettazione e pianificazione della città, a tante altre cose parallele e correlate.
Basta fare un elenco in ordine alfabetico delle pubblicazioni su cui ha scritto: da AIA, a Alternet, Appalachia, Sierra, Smithsonian, Technology and Urban Ecology; o contributi a The Chronicle of Higher Education, Columbia Journalism Review, Harvard Business Review, Ms., Orion, Preservation, The Progressive, Grist,e tante altre testate. L’elenco dei pezzi per il New York Times occupa quattro pagine web, e lo stesso vale per The Nation. Ha scritto Lost Boston (1980), notevole storia sociale e dell’architettura che attraversa secoli di patrimonio culturale distrutto, e pure con la speranza nell’impegno per la conservazione. Tra le centinaia di evocative illustrazioni un manifesto politico affisso alla fermata di Park Street della linea “T” della metropolitana, omaggio alla mancata elezione di suo padre, candidato liberal al Congresso negli anni ’50. C’è poi Preserving New England (del 1986 scritto insieme a Pauline Chase Harrell), percorso fra paesaggi urbani e rurali, e soprattutto il suo lavoro più importante Asphalt Nation(1997), che esplora la frontiera della mobilità, dalle distruzioni ambientali in nome della nostra dipendenza dalle automobili, ai tanti promettenti tentativi di riforme in corso negli anni ‘90.
Seguiva l’evoluzione dell’architettura per il Boston Globe, The Christian Science Monitor, e naturalmente per The Nation, dove ha recensito edifici, piani, mostre, e tanti libri a partire dal 1973. Era una voce nota ed esplicita nelle conferenze, nei circuiti culturali, a volte universitari. Il suo stile di scrittura era straordinariamente raffinato, paragrafi magistralmente costruiti, pagine che seguivano titoli intelligenti, articolate in termini anche gergali ma sempre coinvolgenti. Nel 1990 aveva collaborato con Dorothea Hass al varo di WalkBoston restando poi in stretto contatto col gruppo di lavoro, da sempre interessata alla causa dei pedoni. Pioniera dell’impegno urbano, fu un modello per la costituzione di associazioni del genere in tutti gli Stati Uniti per vent’anni.
Sono tante le cose indotte dall’automobile e dallo sprawl raccontate dalla Holtz Kay, che ancora oggi ci giocano contro; le emissioni dei motori in crescita, o una recente legge sui trasporti ad annullare i progressi fatti sinora, o una politica che in sostanza continua a non agire contro il cambiamento climatico. Però tante fra le iniziative più promettenti che aveva notato e poi sostenuto stanno maturando; c’è nuovo interesse per la smart growth, rinascono i trasporti pubblici, specie su rotaia, e poi il car-sharing, il ciclismo urbano, la pedonalità.
Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente entrambe le due Jane, a partire dai primi anni ’90, traendo grande giovamento dalla loro compagnia e dalle discussioni passeggiando nei loro amati quartieri. Le due Jane si sono anche incrociate fra loro almeno una volta, un buon incontro, quando la Jacobs ha scritto una brillante fascetta per l’edizione di Asphalt Nation. Condividevano una specie di solidarietà femminile, di sorellanza in un mondo dominato da maschi, che solo iniziava ad aprirsi a punti di vista e partecipazione femminile. Fisico sottile ma voce decisa, la Holtz Kay era tutt’altro che stridula, modello di tatto nelle relazioni intellettuali come nel conflitto politico. Se aveva qualche genere di propensione nel caso della nota polemica Mumford-Jacobs sui modi di affrontare l’urbanistica, di cui si fa allusione indiretta nell’intervista del 1977 a Mumford, è stata adeguatamente rintuzzata e messa in riga, impedendole di sbracare.
La Holtz Kay dava molta importanza ai particolari, specie umani, anche se qualche volta noi suoi amici “tossici dei trasporti” avremmo voluto vedere qualche suo paragrafo magari prima che andasse in stampa. Ma Martha Bianco, dopo aver criticato alcuni passaggi “scientificamente traballanti” di Asphalt Nation notava acutamente nella sua revisione del 1998 per H-Net :“Vuole spingere il lettore all’azione, contribuire ad accendere il fuoco di un attivismo anti-automobilistico .… bisogna ascoltare voci così, e non sedersi nell’accettazione che ci ha ridotto a questo stato di auto-dipendenza”. Viviamo in un grande universo costantemente, in cui come ci spiegano i fisici teorici tutto è possibile, e io mi immagino un bar in un angolo senza automobili, coi tavolini all’aperto, dove stanno seduti Mumford e le due Jane, la Holtz Kay in mezzo tra gli altri due per cercare di fargli far pace. I passanti rallentano per ascoltare quella accesa discussione, su come si dovrebbe riprogettare …. la sublime gated community dove abitano adesso.
Postilla
Al bellissimo ricordo personale di Preston Schiller vorrei brevemente aggiungere una nota che forse aiuta a capire il valore anche non specificamente “americano” della critica di Jane Holtz Kay. Per puro caso stavo leggendo Asphalt Nation proprio durante le periodiche trasferte lungo le grandi arterie interregionali ovest-est dal Piemonte al Veneto, a studiare i paesaggi suburbani per il saggio sulla dispersione a nastro produttiva e commerciale nella “megalopoli padana”, che sarebbe finito nei testi introduttivi della nota raccolta NO SPRAWL (a cura di M.C. Gibelli e E. Salzano). Sono state proprio le prospettive illuminanti di quel libro, la capacità di farci guardare oltre l’ovvio, a mostrare la strada, ad aprire la finestra su un panorama piuttosto inquietante, che un paio di generazioni di conformismo ci hanno costruito attorno. Uno dei lati positivi della globalizzazione è che, oltre ai flussi di capitali, anche le idee girano più vorticosamente, e magari aiutano un po’ a ristabilire equilibrio (f.b.)
Che cosa ci lascia in eredità? Di sicuro tutti i suoi lavori - La città difficile, Milano ore sette: come vivono i milanesi, Metropoli. La nuova morfologia sociale della città e La dimensione metropolitana sono solo alcuni esempi -, ma soprattutto la sua insaziabile curiosità per tutto ciò che di nuovo si va profilando sugli scenari internazionali, a partire dalle potenzialità delle nuove tecnologie nello studio dei comportamenti sociali in ambito urbano e metropolitano, e il suo sguardo ironico verso il mondo.
Senza retorica posso affermare che in Italia non si sarebbe potuta sviluppare la Sociologia urbana in modo originale rispetto alla tradizione americana e ad altre tradizioni europee, senza la presenza attivamente critica di Guido Martinotti, il quale già nella seconda metà degli anni ’60 aveva posto in evidenza quanto fosse importante una comprensione multifattoriale dei fenomeni urbani per non cadere in uno sterile iper-specialismo. In proposito, penso ad un suo articolo pubblicato nel 1985 su “Quaderni di Sociologia”, nel quale Martinotti utilizza il cubo come metafora di spazio scientifico dal punto di vista dell’analisi territoriale. Le facce del cubo sono i “confini mobili” con altrettante discipline: la geografia e la scienza dell’ambiente, l’economia, la politologia, la psicologia e le scienze del comportamento. Naturalmente egli era consapevole che questa apertura ad altri punti di vista disciplinari costituiva un rischio di indebolimento dello statuto epistemologico della sociologia urbana, rischio che recentemente in Italia ha prodotto i suoi effetti in sede di riforma dei raggruppamenti disciplinari non garantendo l’autonomia della sociologia urbana rispetto ad altri campi disciplinari. Questa è stata una delle ultime battaglie che Martinotti fece e che perdette insieme a tutti noi.
Oggi è un giorno non solo triste ma molto più povero per me e per tutti i colleghi che hanno avuto il privilegio di conoscere e di leggere Guido Martinotti.
La Repubblica, 13 novembre 2012
Famiglia della borghesia ebrea, il padre podestà fascista fino alle leggi razziali, poi la tragedia. Tutti i Ravenna muoiono ad Auschwitz: Margherita, Alba, Gino, Bianca si spegne nascosta a Roma sotto falso nome, i loro figli, tranne Eugenio, detto Gegio. Paolo e il padre Renzo si salvano, vengono internati in Svizzera. Tornato a Ferrara, Paolo porta con sé l’incarico di raccontare ogni cosa dei suoi. Senza commozione, con l’energia che un dolore sordo trasforma in vitalità. Raccoglie carte, lettere, fotografie e ogni tanto pubblica un piccolo libro. Gli fa compagnia, nel ricordo, Giorgio Bassani. Lo ha conosciuto nel ’38, quando lo scrittore dei Finzi-Contini fa lezione a casa sua per i ragazzini espulsi dal liceo Ariosto. Il cugino Gegio, sopravvissuto ad Auschwitz, è raffigurato da Bassani nel Geo Josz di Una lapide in via Mazzini.
Geo torna a Ferrara dove nessuno lo riconosce e dove incalza la fretta di dimenticare. Ravenna non ha mai fatto politica attiva, ma se Ferrara esprime una qualità urbana molto al di sopra della decenza, lo deve al suo culto per la memoria e all’esuberanza dei suoi progetti. Nel campo d’internamento conosce Antonio Cederna e, nel 1955, Ravenna è in Italia Nostra. Con Cederna mette a punto il restauro delle mura che Biagio Rossetti realizzò per la città. D’accordo con loro è Bruno Zevi. Ma il restauro è il primo passo di un programma più ambizioso: i 1200 ettari che dalle mura arrivano al Po, l’area che gli Estensi chiamavano il Barco e che è il luogo della naturale espansione di Ferrara. Ma un’espansione, un’addizione verde. Fino a quando le gambe glielo consentono, Ravenna gira con una macchina fotografica nel loden per beccare il minimo abuso.
Immagina solo proiezioni future. Il Museo della Shoah, un’idea alla quale lavora per anni, pensando persino a un edificio d’architettura contemporanea dentro il Barco. E poi una sistemazione fra arte e natura per la tomba di Bassani, nel cimitero ebraico. E poi i libri, l’ultimo sulla sinagoga di Ferrara. O quello, un’esilarante delizia, con le caricature vergate durante le riunioni di Italia Nostra – Cederna, burbero e sornione, Antonio Iannello, scamiciato e spettinato, e di nuovo Bassani. Negli ultimi anni gli occhi non lo assistono. Silvia, la segretaria, legge per lui, gl’insegna l’informatica. Ma quante idee gli brillino dentro è difficile conteggiare. Ogni tanto annuncia di volersi ritirare, ma è solo il preludio per ripartire. Era riuscito a sistemare l’archivio di casa. Aveva in calendario un libro sugli incontri di una vita. Troppo breve, la sua vita, per contenere tutta quella memoria.
Più volte Aldo Natoli ha ricordato la sua “scoperta dell’urbanistica”. Nel dialogo con Vittorio Foa del 1992 racconta che nel 1956 al comune di Roma aveva affrontato “per la prima volta i problemi dello sviluppo delle città e della loro organizzazione urbanistica come nessuno aveva mai fatto in Italia”.
Nella premessa alla ricerca di Luigi Coletta, Giuliana De Vito e Roberta Persieri sulla Proprietà fondiaria a Roma negli anni ’80 scrive che all’inizio del 1954 a lui, Luigi Gigliotti e Piero Delle Seta accadde di imbattersi “nei misteri dell’urbanistica”:
[…] giungemmo a scontrarci con il nocciolo duro della realtà; lo sviluppo, o meglio, la crescita della città non obbediva ad alcuna normativa generale, tanto meno alla razionalità di un disegno ideale; e, quanto alla funzione amministrativa e alle sue regolamentazioni, esse erano determinate, direttamente o indirettamente, dal vero motore del meccanismo della crescita e questo altro non era che l’interesse materiale dei proprietari del suolo urbano. Tutta la “scienza” urbanistica poggiava […] sulla concreta realtà del suolo urbano.
In verità è impropria la parola urbanistica. Aldo Natoli si occupò soprattutto del peso che giocava la grande proprietà fondiaria nelle decisioni riguardanti il futuro della città. Siamo nel vivo dello scontro sul piano regolatore di Roma, che si sviluppò nei primi anni Cinquanta quando Natoli era capogruppo Pci in consiglio comunale (lo fu fino al 1966, e fino al 1954 fu anche segretario della federazione). Sull’urgenza di una politica attiva delle aree fabbricabili le sue idee sono chiarissime.
Se non riusciremo a risolvere positivamente questo problema – scrive nel Sacco di Roma –, tutto il resto diventa illusorio. Noi potremo parlare quanto vorremo della conservazione del vecchio centro, della creazione di altri centri, della distinzione di centri culturali, artistici, politici, dello sviluppo della città a raggio, a stella, a nuclei satelliti, potremo parlare quanto vorremo di tutte queste belle cose; ma in realtà tutto questo non avrà nessun senso […].
Il sacco di Roma, com’è noto, raccoglie il lungo intervento di Natoli che, nel febbraio del 1954, occupò più sedute del consiglio comunale impegnato nel dibattito introdotto da Enzo Storoni, assessore all’urbanistica (sindaco Salvatore Rebecchini), che aveva concretamente messo mano alla formazione del nuovo piano regolatore generale con un’allarmata e coraggiosa relazione sull’“anarchia edilizia” imperante a Roma. Storoni era un galantuomo liberale, collaboratore del «Mondo» di Pannunzio, che cercava di ridurre lo strapotere della proprietà fondiaria attraverso strumenti fiscali e con la moralizzazione degli uffici comunali. Per Natoli, invece, che pure aveva rispetto e stima per Storoni, l’unico rimedio per bloccare la speculazione era l’esproprio delle aree destinate all’espansione e la formazione di un demanio comunale.
Aldo Natoli è stato il primo autorevole esponente politico italiano a porre così lucidamente la questione della rendita fondiaria. È bene chiarire subito che la proprietà pubblica dei suoli non era una novità: era noto il libro pubblicato in Italia nel 1951 La città e il suolo urbano, di Hans Bernoulli, importante studioso e amministratore svizzero, convinto sostenitore della proprietà pubblica delle aree urbane. Natoli aveva anche studiato le esperienze urbanistiche inglesi, svedesi, olandesi. Conosceva certamente l’art. 10 della legge di approvazione del Prg del 1931 e l’art.18 della legge urbanistica del 1942 che consentivano l’espropriazione dei suoli destinati all’espansione urbana. E soprattutto a Roma erano conosciute le realizzazioni del regime fascista (l’E42, le bonifiche e le nuove città) fondate sulla preventiva acquisizione dei suoli.
Ma allora (oggi è ancora peggio), i temi dell’urbanistica e dintorni erano considerati di natura tecnica, riservati alla competenza di specialisti, non meritevoli dell’impegno politico di vertice. Aldo Natoli fu un’eccezione. L’unico altro autorevole esponente politico italiano che si spese per la proprietà pubblica dei suoli urbani fu Fiorentino Sullo, – raro esempio di democristiano giacobino – che nel 1962, esattamente cinquant’anni fa (ma otto anni dopo Natoli), quando era ministro dei Lavori pubblici, presentò un disegno di legge di radicale riforma urbanistica. Era fondato sull’esproprio generalizzato delle aree urbane che i comuni, dopo averle urbanizzate, dovevano cedere in diritto di superficie ai costruttori privati. Com’è noto, Sullo finì male, accusato di voler togliere la casa agli italiani, fu sconfessato dal suo partito, lentamente ma ferocemente emarginato dalla politica. Ma non si spense il terrore della riforma urbanistica, tant’è che nell’estate del 1964, per paura che il primo governo organico di centro sinistra presieduto da Aldo Moro la riproponesse, fu addirittura tentato un colpo di Stato.
[Aggiungo, fra parentesi, che il terzo uomo politico di rango nazionale sicuramente attento all’urbanistica è stato Silvio Berlusconi. Beninteso su un versante opposto a quello di Natoli e di Sullo. La sua micidiale parola d’ordine è stata “padroni in casa propria”; ha firmato due condoni, e il “piano casa” che è peggio di un condono. Al paesaggio italiano Berlusconi ha fatto più danni dei bombardamenti della seconda guerra mondiale. Adesso sembra politicamente finito ma è più che mai diffuso il berlusconismo.]
L’interesse per l’urbanistica di Aldo Natoli non fu adeguatamente apprezzato dai vertici del Pci. Sempre nel dialogo con Vittorio Foa ricorda che quando nel 1954:
nel lasciare la segreteria della Federazione romana, feci un rapporto al Congresso della federazione tutto impostato sulle questioni dello sviluppo della città e quindi sulla prospettiva di una riforma urbanistica, c'era Togliatti presente e non disse niente. Poi parlando con degli altri disse che questi erano problemi da intellettuali. […]. Cosa che poi mi fu riferita. Ma del resto, lo ripeto, non ebbi mai l'appoggio. La cosa che bisognava fare allora, con la grande forza che il partito aveva nelle amministrazioni comunali, era la mobilitazione di queste amministrazioni comunali perché si impegnassero nella preparazione di Piani Regolatori moderni. Non è stato mai fatto questo. Io sono stato isolato sempre, cioè nessuno mi ha mai impedito di fare certe cose, però le facevo da solo e il tentativo di generalizzare il lavoro che si era fatto a Roma, che pure aveva avuto una grande risonanza nazionale, di generalizzare questo lavoro nei comuni, non si fece.
Edoardo Salzano, che nel 1966 successe a Carlo Melograni nel gruppo consiliare capitolino del Pci, nel suo libro di memorie conferma il disincanto di Aldo Natoli e scrive:
Il leader del ruppo consiliare non era più Aldo Natoli, che era su posizioni molto rigorose. […] Ma era l’insieme dell’atteggiamento del Pci che stava cambiando. L’urbanistica, almeno a Roma, non era più argomento centrale: le sue scelte potevano essere adoperate come merce di scambio per ottenere altri vantaggi […]. Così, in cambio d’un atteggiamento della Dc più vicino alle posizioni della sinistra sui grandi temi simbolici (come l’approvazione unanime da parte del consiglio di un ordine del giorno contro la guerra del Vietnam) assumemmo un atteggiamento più disponibile sulla politica urbanistica.
Intervistato da Peter Kammerer e Stefano Prosperi nel 2001 Aldo Natoli insiste sul colpevole silenzio del partito che “duole dirlo, neanche i dieci anni di amministrazione capitolina di sinistra sono valsi ad interrompere. In campo politico, civile, economico-sociale, culturale, una sconfitta che nulla vale ad attenuare”. Il riferimento di Natoli al decennio delle amministrazioni di sinistra (1976-1985, da Argan a Vetere) è in larga misura da condividere, ma a me dispiace di non sapere qual è stato il suo giudizio su Luigi Petroselli. Il quale, da giovane dirigente politico e amministratore di Viterbo, sensibilizzato proprio dall’azione capitolina di Natoli, aveva posto l’urbanistica al centro del suo impegno e, a Roma, nel progetto per Tor Bella Monaca realizzò un’inedita intesa con i costruttori romani disposti a operare su area pubblica, sottraendosi al canto delle sirene della speculazione fondiaria. Infine, devo aggiungere, mi dispiace non aver trovato nelle interviste citate alcun apprezzamento per il progetto Fori, la più bella idea per l’urbanistica di Roma moderna, sostenuta con entusiasmo da Petroselli.
Non dimentico di ricordare che Natoli fu sempre privo di indulgenza per l’abusivismo. A Kammerer e Prosperi dichiara: “tu sai quanto era sensibile a quel tempo la direzione del Partito alla alleanza con certi strati di piccoli borghesi. Il problema di avere una influenza sulla piccola borghesia era uno dei cardini della strategia di allora del partito, non della tattica, ma della strategia”. E a Roma la piccola borghesia è certamente quella degli abusivi. Nella citata prefazione alla ricerca sulla proprietà fondiaria scrive delle “fandonie sulla «metropoli sponanea» e di Roma soggetta “senza alcuna possibilità di riscatto ad una mala, sordida continuità. Speculazione fondiaria, abusivismo, crescita a macchia d’olio: questa la triade fenomenica”. La metropoli spontanea è il titolo di un famoso convegno del 1983 in Castel Sant’Angelo, voluto dal comune di Roma (allora amministrato dalle sinistre) proprio per celebrare l’abusivismo. L’unico comunista autorevole che prese le distanze fu Piero Della Seta.
L’impegno urbanistico di Aldo Natoli non fu adeguatamente riconosciuto neanche dagli studiosi dell’urbanistica romana, e mi riferisco in particolare a quelli pur critici con le amministrazioni democristiane. I prestigiosi fascicoli 27 e 28-29 della rivista «Urbanistica» integralmente dedicati alla formazione del piano regolatore di Roma negli anni Cinquanta, trattano pochissimo di Natoli. Carlo Melograni, che fu con Natoli nel gruppo capitolino del Pci dal 1960 al 1966, conferma che l’avversione al Pci era innegabile anche in alcuni dei migliori urbanisti di quella stagione, simpatizzanti democristiani (Leonardo Benevolo, Michele Valori) e olivettiani (Giovanni Astengo, Ludovico Quaroni). L’eccezione fu Italo Insolera. Sul n. 40 di «Urbanistica», trattando del dibattito relativo all’adozione del piano di Roma nel 1962, prende le distanze dalla “posizione preconcetta anticomunista, in una situazione in cui i comunisti si assumono l’impegno dell’estrema difesa del rigore urbanistico”.
Il voto contrario del Pci ha avuto un’importanza storica. Fu una decisione, coraggiosa, ben motivata, razionale e radicale, tuttavia molto sofferta e accolta dal partito non senza disagio. Una decisione la cui lungimiranza si è imposta con il passare degli anni ed ha accreditato a lungo la competenza e il rigore del Pci in materia di urbanistica.
L’isolamento dal mondo degli intellettuali non sfuggì certo a Natoli che, nella citata intervista di Kammerer e Prosperi, lamenta giustamente la distanza con la quale urbanisti e intellettuali progressisti trattavano la posizione comunista: “Ora leggo dei libri che vengono pubblicati in cui – scrive Natoli – quello che ho fatto io nei primi anni al consiglio comunale è completamente ignorato, completamente come se non fosse esistito”.
Torno alla biografia di Natoli. Nel 1954, quando lasciò la federazione di Roma per la direzione del partito si occupò della sezione Lavoro di massa con Luigi Longo, e lo fece con grande impegno. Il rapporto con gli operai lo travolse, finì con il dimenticare le precedenti esperienze. E nel 1956 (secondo Natoli, “l’anno in cui finisce la speranza”), dopo i fatti dell’Ungheria e il XX congresso del Pcus, fu spostato (retrocesso?) agli Enti locali, ma non ci pensò nemmeno a tornare all’urbanistica. Eppure, nel colloquio con Foa, riferendosi ai primi anni Sessanta, dichiara:
Pensa che cosa si poteva fare in Emilia, in quegli anni il partito controllava tutti i capoluoghi di provincia, se si fosse sistematicamente lavorato nei comuni per attuare e per, come dire, preannunciare la riforma urbanistica. Non si è fatto. Io ho chiesto più volte che si facesse, non l'ho mai ottenuto, non si è mai fatta una riunione. Mentre si sono fatte le riunioni del Comitato Centrale in cui si è parlato della nazionalizzazione dell'industria elettrica o addirittura della nazionalizzazione della Montecatini così si diceva allora, non è stato mai fatto nulla per la riforma urbanistica, sono stato sempre isolato. Infatti, qualche anno dopo, io ho deciso di non occuparmi più dell'urbanistica, perché mi ero reso conto che non potevo assolutamente modificare la posizione del partito.
La verità è che Natoli è preso da altre passioni. Dimentica o ignora che, proprio nel 1960 – lo ricorda Carlo Melograni –, si svolse un incontro con Mario Alicata, allora responsabile nazionale della cultura, con esponenti del Pci di Bologna che chiedevano la disponibilità di un compagno romano per l’incarico di assessore all’urbanistica del capoluogo emiliano (invito raccolto, com’è noto, da Giuseppe Campos Venuti): era evidentemente ancora indiscutibile il primato urbanistico del partito di Roma.
Ma Natoli l’urbanistica l’ha ormai lasciata spalle. Approfondisce la critica all’Unione Sovietica, comincia a seguire l’esperienza cinese.
Ed è lo stesso negli anni successivi, intorno al 1968, quando segue con attenzione la nascita della contestazione operaia e studentesca. Non possono essergli sfuggite le forti manifestazioni organizzate, in particolare a Torino nel 1969, proprio intorno all’insostenibilità della condizione urbana e dalla drammatica carenza di alloggi. La riforma urbanistica era fallita nel 1963 soprattutto perché Sullo – a causa dell’alterigia propria di un intellettuale giacobino –, non aveva capito l’importanza di un sostegno di massa. Anzi, contro Sullo si formò un fronte interclassista (“le fanterie” e “gli stati maggiori” della speculazione, secondo un’intramontabile definizione di Valentino Parlato).
Ma nel 1968 e negli anni successivi è cambiato tutto. Lo sciopero generale del 19 novembre 1969 per l’urbanistica e la casa fu una delle più possenti manifestazioni dell’Italia contemporanea e i risultati si videro, tant’è che nei mesi successivi, proprio grazie al sostegno operaio e sindacale, si ottennero importanti leggi di riforma del settore dell’edilizia abitativa e dei servizi collettivi.
Ma Aldo Natoli è ormai lontano.
E della sua azione in campo urbanistico non resta niente: questa è la mia amara riflessione conclusiva. Come non resta niente del tentativo di riforma urbanistica di Fiorentino Sullo, né della Roma di Luigi Petroselli. Non resta niente dello spirito autenticamente riformatore del centro sinistra. A me pare che in nessun campo come il quello delle politiche territoriali sia stato così rovinoso l’effetto delle filosofie neoliberiste che si sono affermate a partire dai primi anni Ottanta e hanno scompaginato anche la politica e la cultura di sinistra. Che negli anni più recenti ha accettato ambiguamente, ma più spesso esplicitamente, il primato della proprietà fondiaria, quella grande e quella minuta, quella legale e quella illegale.
Mi limito a tre esempi:
- nel 1986 la marcia, sostenuta dal Pci (Lucio Libertini), dei sindaci siciliani a favore dell’abusivismo
- nel 2005 la cosiddetta legge Lupi – dal nome del suo principale ispiratore, il deputato di Forza Italia Maurizio Lupi – con il complice silenzio della sinistra, che cancella il principio stesso del governo pubblico del territorio, non approvata per un pelo
- nel 2008 l’approvazione del nuovo piano regolatore di Roma (sindaci Francesco Rutelli e Walter Veltroni), rispetto al quale il piano regolatore del 1962 (quello che raccolse il voto contrario dei comunisti) è un capolavoro di cultura politica e urbanistica.
Com’è stata possibile, in pochi decenni, una così devastante regressione?
Di grande e raffinata cultura aveva collaborato a«Urbanistica informazioni» negli anni in cui la rivista bimestrale dell’Inu fudiretta da Eddy Salzano. Aveva curato in particolare la rubrica Anologia dove pagine di autori classicio comunque importanti per il nostro lavoro – da Hans Bernoulli a RanuccioBianchi, da Carlo Cattaneo a Manlio Rossi Doria – erano presentate da Francocon una nota densa di intelligenza e di curiosità. Aveva pubblicato saggi ericerche (Morfologia territoriale eurbana del 1983, Immaginazione di Roma, del 1994), nel 2008 Storia dell’Inu, Settant’anni di urbanistica italiana 1930-2000, con prefazione diAlessandro Montebugnoli. Negli ultimi anni aveva collaborato con il sindacatodei pensionati Cgil, proponendo anche nuove soluzioni urbanistiche etipologiche. Ciao Franco, non ti dimentichiamo.
Fra i tanti lavori che negli ambiti più diversi Italo Insolera ha progettato e realizzato, ve n'è uno rimasto di necessità in ombra nei numerosi articoli comparsi a suo ricordo: quello del restauro e del recupero dell'antico. Ricordo come mi illustrasse con affetto particolare il ripristino filologico dei giardini sopra Villa Giulia a Roma, quelli che connettono la residenza di papa Ciocchi Dal Monte alla contigua Villa Borromeo, e quanto tenesse a quella verde reintegrazione che costituiva un altro passo avanti nel completamento del restauro del sistema delle Ville romane, da Villa Borghese fino a Villa Giulia.
In quell'ambito ebbe poi l'incarico di restaurare Villa Poniatovski (nobili polacchi innamorati della musica e musicisti più che amatoriali essi stessi, grandi amici di Rossini), in origine Sinibaldi, rimaneggiata dal Valadier e più tardi degradata e manomessa a cereria industriale. Vi girammo con lui un servizio per "Bellitalia" (Raitre) all'epoca curata da Fernando Ferrigno. Restauro durato a lungo e al quale concorse Francesco Scoppola che molti anni prima aveva studiato con Italo a Ginevra. Anche di quel significativo ripristino completato poco tempo fa Insolera parlava con affetto intenso. A quel punto al sistema delle ville mancava - e putroppo manca - all'appello soltanto Villa Strohl Fern lasciata dal nobile alsaziano alla Francia e dai francesi maltrattata come poche.
In questi siti, come a San Paolo alla Regola, Italo, lo voglio sottolineare, portò la sua grande conoscenza di storico di Roma e una precisa consapevolezza filologica , senza pretendere di "lasciare il segno", a differenza di tanti architetti suoi contemporanei. Un grande merito pure questo.
I due volumi realizzati per ENI a metà degli anni Sessanta: quello sulle coste e quello sugli Appennini, furono per me il primo approccio con Italo Insolera. Quello in particolare sui paesaggi appenninici, ai quali pure iniziavo a dedicarmi, mi apparve quanto di più chiaro, sintetico e al tempo stesso profondo, si potesse realizzare per illustrare agli italiani la complessità sedimentata dei quadri visivi depositati dalla natura e dalla storia del lavoro umano. Uno spunto prezioso, per avviare poi un’analisi sistematica dei rapporti fra paesaggi ed aree culturali nell’ambito delle Campagne di rilevamento promosse da Andrea Emiliani, prima, e poi delle attività dell’Istituto per i Beni culturali dell’Emilia Romagna.
La collaborazione , nello scambio di opinioni e di esperienze, venne in seguito, con l’elaborazione del Piano Paesistico regionale negli spazi e con molti dei materiali raccolti dall’IBC. Le colonie sulla costa “riminizzata”, l’inventario e la perimetrazione dei centri storici, l’organizzazione degli insediamenti e del territorio rurali e i metodi di analisi ai fini di una tutela mirata, passarono sotto la sua visione e i suoi consigli grafici per essere trasferiti nelle norme e nella cartografia di Piano, con l’attenzione rivolta alla comprensione anche dei cittadini non addetti ai lavori.
L’ultimo incontro, preparato da Lucio Gambi, avvenne nella sua casa sul lago Maggiore, dove ci accolse , con Annina, con grande calore, per offrire all’IBC il prezioso archivio fotografico del fratello Delfino, al quale si doveva, fra l’altro, la collana audiovisiva “Conosci la tua regione” curata da Franca Cantelli.
È come se, d’improvviso, le solitudini delle nostre città si fossero fatte più acute, il loro degrado più irreversibile, la loro ingiustizia più radicale. Assieme agli occhi dell’architetto e urbanista Italo Insolera (nato a Torino nel 1929 e scomparso a Roma lunedì) si spegne, infatti, uno degli ultimi sguardi capaci di diagnosticare il male che sforma il nostro tessuto urbano e, con esso, il nostro modo di essere, anzi di non essere più, cittadini.
Una delle ultime, fulminanti diagnosi, Insolera l’aveva affidata a un’intervista a Francesco Erbani (Repubblica, 13 aprile 2010): “L’urbanistica? È ormai figlia dell’architettura. E l’architettura ridotta a pura forma assorbe tutto il dibattito culturale. Tutto lo spazio dell’informazione. Diventa il paradiso delle archistar. Si bada più al singolo progetto che non al disegno complessivo. Più al singolo manufatto che non alla città. Più all’individuo che non al collettivo. Occorre invece che l’urbanistica recuperi la sua linfa sociale”. Parole profetiche, una per una: proviamo a verificarle pescando a caso nella cronaca di questi giorni, anzi di queste ore.
Ieri il ministro Corrado Clini (che ormai porterà incollata per sempre la definizione geniale che ne ha dato Riccardo Mannelli su questo giornale: “Il ministro dell’Abbiente”), il governatore del Veneto, il presidente della Provincia e il sindaco di Venezia hanno inaugurato la mostra sul cosiddetto Palais Lumière di Pierre Cardin. Ancor prima che l’Enac dica se la torre di 250 metri che dovrebbe nascere a Marghera sia compatibile col traffico aereo, le istituzioni benedicono e consacrano un progetto – il dettaglio è grottesco – che scaturisce dalla tesi del nipote dello stilista, laureatosi con essa a Padova nel 2011. Le stesse istituzioni che non sono state capaci di aprire un vero confronto pubblico sul recupero della zona industriale di Marghera, di pianificare un risanamento urbano attraverso la partecipazione popolare, si prostrano all’istante di fronte a un singolo privato che presenta un progetto faraonico fatto in casa, che si basa sull’evidente desiderio di “oltraggiare Venezia” (così Salvatore Settis), modificandone per sempre lo skyline con una gigantesca torre luminosa degna del più cafone degli emiri.
Immancabilmente, il dibattito pubblico si è concentrato sulla forma della torre e sul suo valore estetico (“è bella o non è bella, mi piace o non mi piace”) sotterrando sotto il soggettivismo dell’archistar (in questo caso dell’apprendista archistar) ogni idea di città, di sviluppo sociale, di comunità. Naturalmente l’argomento più forte è che Cardin ci mette i soldi, e che siccome è molto anziano bisogna dire di sì all’istante: così, come in un nuovo medioevo, le torri dei feudatari più ricchi e potenti simboleggiano nel modo più violento e indelebile il trionfo degli individui sul collettivo, espellendo dalle vene esauste dell’urbanistica italiana le ultime gocce di linfa sociale (per usare le parole di Insolera).
In un bellissimo ricordo di quest’ultimo comparso ieri sul Corriere della Sera di Roma, Paolo Fallai ha citato un’intervista del 1993, quando qualcuno propose la candidatura dell’urbanista a sindaco di Roma. Insolera era forse il più profondo conoscitore della storia urbanistica recente della città, a cui nel 1962 aveva dedicato il fondamentale Roma moderna, ripubblicato da Einaudi nel 2011, con ampliamenti e contributi di Paolo Berdini (il quale è vicino a Insolera anche nell’impegno civile). Ma, nonostante questa indubbia competenza, Insolera declinò l’invito, e non già per pigrizia o codardia: “Non ho mai pensato di aver l’idea chiave in grado di capovolgere le cose – dichiarò in quell’intervista –. Un uomo, un’idea, un progetto non cambiano niente. Può riuscirci solo un lavoro faticoso, paziente, di tante persone. Solo la società può cambiare la società”. E al giornalista che gli chiedeva quando Roma sarebbe potuta rinascere, Insolera rispose: “Quando tornerà l’ideologia, una qualsiasi, si potrà fare. Per ricostruire, per risanare, occorre prima sapere quale tipo di città si vuole”.
Vent’anni dopo non solo questa analisi è ancora drammaticamente attuale, ma si può trasferire dall’urbanistica alla politica, da Roma all’Italia: con l’abdicazione della politica e il commissariamento dei tecnici tentiamo di risanare e ricostruire un Paese facendo a meno di un progetto comune. Ma, continua a martellarci la voce di Insolera, “solo la società può cambiare la società”.
So di dover resistere alla tentazione che la commozione e il dolore per la perdita di un amico prevalgano sul dolore e la commozione per la scomparsa del grande urbanista, intellettuale, storico, studioso di città. Sui giornali di oggi firme autorevoli – Paolo Berdini, Vittorio Emiliani, Francesco Erbani, Paolo Fallai, Grazia Pagnotta, Walter Tocci – e tanti altri sui blog e sui siti informatici – Ella Baffoni, Edoardo Salzano, Sauro Turroni – ricordano le cose fondamentali della sua vita di piemontese innamorato di Roma e che ha dedicato alla capitale le sue straordinarie attitudini. Aggiungo qualche disordinata riflessione. Ci saranno altre più meditate circostanze per ricordare compiutamente la sua figura e la sua opera.
Prima di ammalarsi Italo ha completato la nuova stesura di Roma moderna, il suo capolavoro, il più importante libro sulla storia urbana della capitale. Fu presentato nel novembre dell’anno scorso presso l’istituto francese di piazza Navona da Renato Nicolini, altro grande eretico, prestigioso esponente della cultura antiaccademica che ci ha lasciato da pochi giorni. La novità più rilevante dell’ultima edizione di Roma moderna, alla quale ha collaborato Paolo Berdini, riguarda l’inizio del racconto, spostato all’indietro, al 27 luglio 1811, data in cui Napoleone I firmò il decreto imperiale per “l’embellissement de Rome”. Insolera scrive nella premessa che la Rivoluzione francese “ha un carisma storico-culturale ben maggiore dei ministri e dei generali della modesta dinastia sabauda, incerta se allearsi con Garibaldi, sicura di avere in Mazzini un nemico”, e perciò è giusto attribuire ai francesi il merito di aver dato inizio a Roma moderna.
Il racconto di duecento anni di urbanistica romana – dal 1811 al 2011 – è la storia di un massacro, e dovrebbe indurre alla disperazione, la conclusione dovrebbe essere che hanno vinto i portatori degli interessi fondiari e speculativi.
Ma Italo Insolera non si arrende. Il suo amore per Roma lo induce all’ottimismo, proponendo per Roma moderna una prima conclusione riferita all’Appia Antica come “un auspicio per un futuro migliore”. L’Appia Antica – lo sappiamo – è una parte essenziale della vita di Insolera.
Ma a questa prima, forse scontata, aggiunge una seconda sorprendente conclusione: “Roma multietnica”. Si intitola così l’ultimo capitolo del libro che racconta della recente immigrazione. La capitale è sempre stata multietnica, da Adriano in poi gli imperatori provenivano dalle terre conquistate. Così anche le legioni che formarono nuovi nuclei familiari. E lo stesso è per la Chiesa cattolica con la presenza di religiosi provenienti da tutto il mondo.
Oggi a Roma vivono circa 600 mila immigrati ma continua a prevalere un atteggiamento di diffusa chiusura. Insolera racconta drammatici episodi generati dalla negazione dell’accoglienza e la tragica sorte dei Rom sui quali “si scaricano i pregiudizi e il latente razzismo della popolazione romana”.
Ma nonostante tutto l’integrazione va avanti e il quartiere di piazza Vittorio è diventato il simbolo della trasformazione. Proprio da piazza Vittorio prende nome l’orchestra formata da musicisti provenienti da ogni parte del mondo: Argentina, Brasile, Cuba, Ecuador, India, Mali, Senegal, Stati Uniti, Tunisia e Ungheria. Un insieme di sensibilità, strumenti e suoni che “getta alle ortiche la difesa di ormai inservibili identità culturali e religiose. Meno male che a Roma c’è l’Orchestra di Piazza Vittorio”: scrive Insolera. Non poteva esserci una più appropriata, convincente e conclusiva dichiarazione d’amore per Roma.
La prima edizione di Roma moderna del 1962 raccoglieva lunghi e documentati articoli scritti alla fine degli anni Cinquanta per la rivista «Urbanistica» che, allora, ai tempi di Adriano Olivetti e Giovanni Astengo, era la più importante rivista del mondo in materia di città e di territorio. A Torino, nella redazione di «Urbanistica» conobbe Annina, giovanissima, ma che già aveva alle spalle una bella storia, e poco nota, di staffetta partigiana, che da quel momento, schiva e silenziosa, ha seguito passo dopo passo con competenza e intelligenza il lavoro e la vita di Italo, la sua libertà intellettuale. E di questo, sapendo di interpretare il pensiero di quanti hanno conosciuto e stimato Italo, voglio ringraziarla, con tutto il cuore.
Torno a Roma, città che non ha ricambiato l’amore irriducibile di Italo. Mi riferisco alla Roma ufficiale, alle istituzioni rappresentative che hanno sempre accuratamente evitato di avvalersi della sua competenza. Talvolta chiamando in causa il suo brutto carattere. Prima o poi si dovrà scrivere la storia dei delitti commessi con il pretesto di scansare i portatori di temperamenti non accomodanti. Il brutto carattere di Insolera è una bugia, era solo rigoroso, e chi lo ha conosciuto, chi ha lavorato con lui sa quanto fosse illimitata la sua disponibilità all’ascolto e alle ragioni degli altri, al farsi carico dei problemi della pubblica amministrazione, quanto fosse trascinante la sua ironia, quanta insospettata dolcezza ci fosse anche nei rapporti professionali.
Il punto è che Italo aveva idee chiare e chiaramente le esponeva. Cito qui una sua intervista a l'Unità sull'esperienza delle giunte di sinistra in Campidoglio cominciata nel 1976 e stancamente finita nel 1985. “Non voglio dimenticare nulla, né la sparizione delle borgate, né le estati romane. Ricordo tutto e lo apprezzo (...). Dico che mancò una filosofia complessiva del cambiamento, non si cambia nel profondo se si insiste nell'abbandono di ogni ideologia come ispiratrice dei fini e dei mezzi. E se qualcuno sostiene che la pianificazione non occorre sono costretto a ricordargli che non occorre alle classi dirigenti, ma alle altre sì”.
E in un'altra intervista al Corriere della sera che gli chiede a quali condizioni Roma può rinascere, Insolera risponde: "Quando tornerà l'ideologia". E a una successiva domanda sull'utilità di un nuovo piano regolatore, risponde che sarebbe utile "solo se avesse un obiettivo ideologico, se puntasse a realizzare una grande idea. Se andasse oltre i metri cubi".
Era questa chiarezza d’idee, non il brutto carattere, era la sua concezione che l’urbanistica non può essere acriticamente asservita alle idee di chi esercita il potere che ha impedito ai mediocri esponenti della politica romana di passare alla storia lavorando con Insolera.
Insomma, Roma con Italo è stata matrigna. Ha studiato le vicende di Roma per oltre mezzo secolo (e non da erudito anodino ma da appassionato e fattivo elaboratore di idee ed i proposte): il mezzo secolo durante il quale sono stati formati due piani regolatori, un numero sconfinato di varianti, di studi, di progetti. Mentre Insolera continuava a essere inascoltato.
Vittoria Calzolari e Walter Tocci sono stati gli unici assessori del comune di Roma che hanno chiesto la sua collaborazione, Vittoria per il restauro degli alloggi di San Paolino alla Regola, Walter per la mobilità e soprattutto per il ritorno del tram. Quest’ultima esperienza, Insolera, Tocci e Domitilla Morandi l’hanno raccontata in un libro Avanti c’è posto, fra i più utili per comprendere le recenti vicende dell’urbanistica di Roma.
Diversa è la storia con la soprintendenza archeologica di Roma, e per essa intendo Adriano La Regina e Rita Paris, che hanno stabilito un duraturo e vitale rapporto di collaborazione con Insolera. Ripetuti e continui i contributi che in varia forma Italo ha dato all’Appia Antica. E posso appena ricordare la mirabile intesa che si stabilì fra La Regina, Antonio Cederna, Insolera, Leonardo Benevolo al tempo del sindaco Luigi Petroselli, quando sembrava che il progetto Fori fosse davvero fattibile, quando si credeva che la storia, anche quella più remota, potesse agire da protagonista della città moderna. E poi Tormarancia. Si deve allo studio condotto da Insolera se quella spettacolare porzione di campagna romana non è finita sotto il cemento e l’asfalto e oggi è integrata nell’Appia Antica.
Allora non è un caso se il luogo in cui siamo oggi, dove Roma saluta Insolera, è un’espressione della storia e dell’archeologia.
Insolera non si è occupato solo di Roma. Ha insegnato a Firenze, Venezia, Ginevra. Ha lavorato per tante città. Qui mi pare importante ricordare che fu progettista – insieme a Leonardo Benevolo, Carlo Melograni, Tommaso Giura Longo e altri – dei piani coordinati di Cecina, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Sassetta, Bibbona, comuni della Maremma livornese. Un’esperienza eccezionale dovuta ad amministratori illuminati che raccolsero le idee e le proposte di Italia Nostra contro “il mare in gabbia”. Si deve a quei piani se nella Maremma livornese – nonostante più recenti cedimenti – sopravvivono tratti di costa sottratti all’edificazione e spazi pinetati aperti a tutti.
Italo se n’è andato – lo hanno ricordato in molti – nello stesso giorno in cui sedici anni fa ci lasciò Antonio Cederna. Il sodalizio Cederna – Insolera è stato quello più detestato dai nemici del genere umano, come Cederna usava definire speculatori e associati. Fra le tante virtù che li affratellavano mi pare importante ricordare il saldo e indiscusso rapporto che entrambi ebbero sempre con le associazioni ambientaliste e culturali, e più in generale con il mondo della partecipazione popolare, dei comitati, della protesta.
È questa – di saper stabilire un rapporto fecondo fra l’alta cultura e i fermenti autentici e profondi della società – l’eredità più difficile che dobbiamo raccogliere.
Arrivederci Roma
Paolo Berdini – il manifesto
Italo Insolera È scomparso a 83 anni, l'intellettuale, urbanista e architetto che ha dedicato una vita di feconde riflessioni alle metropoli e alle trasformazioni del territorio italiano Italo Insolera È scomparso a 83 anni, l'intellettuale, urbanista e architetto che ha dedicato una vita di feconde riflessioni alle metropoli e alle trasformazioni del territorio italiano. Chiunque si sia occupato o si occuperà dell'evoluzione storica, urbanistica e sociale della città eterna si è formato su i suoi studi. Un
Italo Insolera ha dedicato una vita di feconde riflessioni alle città e alle trasformazioni del territorio italiano e la morte di un grande intellettuale lascia sempre un vuoto incolmabile. Mancheranno i suoi insostituibili libri, le sue intuizioni, il suo profondo impegno morale per rendere migliore la vita urbana. Mancherà il suo impegno formativo verso tante generazioni di urbanisti compiuto con i primi incarichi di insegnamento presso la facoltà di Architettura di Roma, continuato dal 1960 con la docenza presso l'Università di Venezia per poi concludersi all'università di Ginevra. Potremo rendere meno violenta la sua scomparsa soltanto se sapremo far iniziare in Italia e in tante sue città una profonda fase di trasformazioni urbane pensate in sintonia con il suo straordinario pensiero.
Italo Insolera nasce a Torino nel 1929, ma compie i suoi studi a Roma dove la famiglia si era trasferita poco dopo la sua nascita e si laurea in architettura presso l'Università La Sapienza nel 1953. Negli anni della formazione romana entra in contatto con il mondo di Italia Nostra e dell'Istituto nazionale di urbanistica. Con Antonio Cederna inizia un sodalizio che durerà tutta la vita e produrrà la straordinaria elaborazione sul parco archeologico dei Fori e dell'Appia Antica. Nell'Istituto nazionale di Urbanistica, allora profondamente ispirato dal pensiero di Adriano Olivetti, inizia a occuparsi sistematicamente di Roma e sul prestigioso periodico Urbanistica, allora diretta da Giovanni Astengo, scriverà due memorabili numeri sulla storia urbanistica di Roma moderna.
Roma diviene così il baricentro della sua vita. Grande intellettuale e uomo di vasta cultura, si è interessato dell'urbanistica italiana e dello sviluppo delle città. Questa attenzione è magistralmente esemplificato in una delle opere più straordinarie: la voce «urbanistica» nella Storia d'Italia edita da Einaudi (1973). In una meravigliosa sintesi traccia la storia delle evoluzioni delle maggiori città, ricercandone le attinenze dettate dalla congiuntura economica e culturale dei vari momenti e le specificità dovute alle generali origini storiche, alle condizioni morfologiche, alla storia locale come elemento connotativo dell'incessante evoluzione delle città e dei territori. Il suo ragionamento parte da una illuminante intuizione iniziale: «La città considerata come principio ideale delle istorie italiane: così Carlo Cattaneo alla fine del 1958 intitolava un saggio che muovendo da alcune considerazioni sulle città nella storia preunitaria, implicitamente poneva il problema del ruolo delle città italiane nell'imminente Stato unitario». La sua grande lezione è quella di saper partire dai concetti fondamentali che sono alla base delle trasformazioni del territorio, del paesaggio e delle singole città. Un percorso logico che nella sua vita ha dato frutti straordinari. Tra i tanti importanti saggi pubblicati, è almeno il caso di ricordare il bellissimo Saper vedere l'ambiente (De Luca, 2008), dove le trasformazioni dell'ambiente umano vengono rese intellegibili nel loro inscindibile rapporto con l'azione umana egli errori delle azioni delle classi dirigenti.
Oltre a questa insostituibile elaborazione di carattere generale, è a Roma che Insolera ha dedicato studi e approfondimenti, lasciando un patrimonio di conoscenze senza uguali. I due numeri monografici di Urbanistica diventeranno nel 1962 Roma moderna la prima e la più completa storia delle trasformazioni della città. Il volume edito da Einaudi verrà ristampato e ampliato ben 14 volte fino alla suo aggiornamento di pochi mesi fa, in occasione del cinquantenario dalla prima edizione. Chiunque si sia occupato o si occuperà dell'evoluzione storica, urbanistica e sociale della città eterna si è formato su quel fondamentale volume. Nella premessa di Roma moderna, Italo Insolera sottolineò i ringraziamenti ad Antonio Cederna «per il suo continuo insegnamento e per avermi proposto cinquant'anni fa di scrivere questo libro». Sono gli anni in cui Cederna inizia la sua strenua battaglia in difesa dell'Appia antica e Insolera con i suoi studi urbanistici fornisce prezioso materiale alla elaborazione del grande progetto di sistemazione dell'area centrale dei Fori e della creazione del parco dell'Appia Antica. Numerosi articoli, libri fondamentali, mostre documentarie e lavori condotti per conto della soprintendenza di Stato, in particolare quando essa è diretta da Adriano La Regina, costituiscono le basi scientifiche e culturali con cui questi due grandi intellettuali italiani hanno lasciato il loro più straordinario risultato. Questo legame tra i due grandi italiani è sottolineato anche da un fatto simbolico: Insolera muore il 27 agosto, sedici anni esatti di distanza dal suo grande amico Antonio Cederna.
Ma, come dicevamo per il suo atteggiamento sulla storia urbana italiana, lo sguardo di Insolera per la sua città elettiva era sempre rivolto al futuro. La immensa conoscenza della sua storia era lo strumento per pensare a una città migliore, umana, rispettosa dei diritti di tutti i cittadini, a iniziare dalle fasce socialmente più sfavorite. Questa sua tensione verso il futuro trova un parziale riconoscimento negli anni '90 durante i primi anni delle amministrazioni di centro sinistra nate sulla spinta morale del post Tangentopoli. È il vice sindaco Tocci ha chiamarlo in qualità di consulente sulla materia della mobilità e anche questa volta Insolera pensa alla città del futuro. Propone nuove linee tramviarie (memorabile quella di costruire una linea sui lungoteveri così da abbattere il traffico di attraversamento che li soffocano) e collabora alla realizzazione della linea tramviaria 8, la più grande realizzazione della recente vita della città. Un altro tassello della concezione unitaria dell'Appia antica, Insolera lo mette a segno proprio in quegli anni, collaborando all'interramento del Grande raccordo anulare che prima spezzava in due la «regina viarum» e, ancora, nella relazione di vincolo sul comprensorio di Tor Marancia, scritta su incarico della soprintendenza archeologica di Stato insieme a Vezio De Lucia e Carlo Blasi. E, ancora una volta, la sua attività professionale lascia lo spazio per una più generale riflessione sulla città in Avanti c'è posto, scritto con Walter Tocci e Domitilla Morandi (Donzelli, 2008).
E proprio concludendo la sua riflessione su Roma culminata con la nuova edizione (2011) di Roma moderna, Insolera ci lascia la grande eredità per il futuro. Dopo essersi infatti chiesto se non fosse il caso di mutare il titolo del libro apponendovi un punto interrogativo, giudicando dunque Roma una città non moderna al pari delle altri capitali europee, perché lasciata dai pubblici poteri in balia della più avida speculazione immobiliare, conclude il libro con una straordinaria idea. Roma potrà diventare moderna se saprà fare del grande vuoto del parco dell'Appia antica la «spina dorsale» di uno sviluppo che guarda al benessere dei cittadini e non all'affarismo di pochi speculatori immobiliari.
Oggi l'Italia della grande crisi economica è ad un bivio: siamo ancora in tempo per seguire la sua lezione abbandonando la speculazione e iniziando a pensare che le città sono il luogo della vita di milioni di cittadini. Farli vivere bene è un grande obiettivo etico e morale. Al raggiungimento di questo obiettivo ha dedicato la vita Italo Insolera.
La Roma di Insolera
Vittorio Emiliani– L’Unità
Si spegne con Italo Insolera una delle voci più alte, autorevoli coraggiose dell’urbanistica e della sua travagliata e entusiasmante storia. Scompare con lui uno degli intellettuali di sinistra che, con idee ben chiare e fermamente praticate, hanno segnato in positivo la vita democratica delle nostre città e, in particolare, di Roma. Alla quale Italo ha dedicato tanta parte delle ricerche, della elaborazioni progettuali, degli scritti di una incessante attività di architetto e urbanista, di esperto di restauri antichi e di mobilità urbana, di storiografo e saggista.
Nasce nel 1929 a Torino dove il padre Filadelfo, importante matematico originario di Lentini, in Sicilia, ha cattedra da tempo. Tre anni dopo la famiglia si trasferisce a Roma, dove Filadelfo ha studiato, e dove Italo si laureerà in architettura alla Sapienza nel 1953. Ben presto è in contatto con gli ambienti di Italia Nostra e dell’INU, all’epoca presieduto da Giovanni Astengo, si lega soprattutto ad Antonio Cederna, di otto anni più anziano, che dalle pagine del “Mondo” polemizza a tutto campo contro una speculazione selvaggia. Sodalizio durato una vita con al centro il tema, enorme e affascinante, del rapporto fra passato, presente e futuro.
Nel ’62 esce “Roma moderna” che, ampliato e aggiornato, avrà 14 ristampe e costituisce lo straordinario breviario laico per chiunque voglia occuparsi della più complessa delle capitali, fra Cesari, Papi e Terza Roma, in mezzo a ondate speculative che le forze democratiche hanno cercato di controllare con la pianificazione e col trasporto pubblico su ferro. Non però con l’energia severa che Italo aveva nel proprio Dna, morale e culturale.
Con Cederna collabora attivamente al progetto – fatto proprio da Luigi Petroselli – di un grande parco urbano dai Fori ai Castelli. Inoltre sovrintende al recupero di San Paolo alla Regola e, più tardi, all’interramento del raccordo anulare che trancia l’Appia Antica. Egli lavora in numerose città e regioni, come architetto e come pianificatore. Con una visione internazionale che gli viene dai molti anni di insegnamento a Ginevra e dalle consulenze, l’ultima – per il Consiglio d’Europa – finalizzata al recupero del centro storico di Antigua (Guatemala). Con Leonardo Benevolo e Pier Luigi Cervellati si occupa a lungo del centro storico di Palermo. L’esito finale non li soddisfa e però, sul piano teorico/pratico, essi dettano linee e metodi di intervento tuttora fondamentali.
L’ho avuto per sette anni collaboratore al “Messaggero” e ne ho apprezzato la capacità di lucido divulgatore. Come quando raccontava la stridente contraddizione di un’Italia che non progredisce nel trasporto su rotaia e invece esporta il know-how per tramvie e metrò. E dalla bocca gli uscivano lente e sarcastiche le battute per le quali andava noto. Se Roma è in parte tornata al tram, lo si deve in buona misura alla sua sagacia e al lavoro che, soprattutto con la Giunta Rutelli-Tocci poté mettere in cantiere, partendo da una straordinaria conoscenza storica di Roma che ai tempi del sindaco Nathan vantava primati in fatto di tramvie, purtroppo divelte da Mussolini (le giudicava “poco confacenti col carattere imperiale di Roma”) e anche dalle giunte post-belliche.
E’ stato in prima fila in tutte le buone battaglie per l’urbanistica, per la difesa del paesaggio, dall’Agro Romano, che conosceva come pochi, al nuovo Auditorium di Roma sul quale ci ha lasciato un libro esemplare. Battaglia che Cederna, lui, Vezio De Lucia, Giovanni Pieraccini ed altri condussero da posizioni culturali di minoranza. Per risultare poi vincenti.
Non ebbe, o forse non volle avere, a differenza di altri esponenti della cultura urbanistica e ambientale, una “chance” parlamentare (lo stesso Cederna fu candidato ed eletto una sola volta alla Camera). Troppo severo, autonomo, libero di mente, come Antonio del resto, scomparso anch’egli un 27 agosto di sedici anni fa. Ma è dal loro lavoro che si deve di nuovo passare, oggi e domani, se si vuole riprendere il filo rosso di una pianificazione democratica e incisiva che riporti in onore un valore da parecchi anni oscurato o dimenticato: l’interesse generale. Te ne siamo riconoscenti, Italo, la tua lezione resta con noi.
Addio a Insolera urbanista militante
Francesco Erbani – la Repubblica
Italo Insolera è morto ieri. Architetto, urbanista, storico, aveva ottantatré anni e appena un anno fa aveva dato alle stampe una nuova edizione del suo libro più importante, Roma moderna.
Molti malesseri lo tormentavano dolorosamente. Ma era contento, il velo di malinconia degli ultimi tempi svaniva mentre sfogliava quel volume che Einaudi aveva rilegato con una copertina grigia e tre foto aeree della città. Il libro l’aveva scritto nel 1962, più volte ristampato e infine aggiornato alle ultime vicende della capitale, con l’aggiunta di un capitolo iniziale sulla Roma napoleonica (in questa fatica era stato aiutato da Paolo Berdini). In chiusura aveva inserito un “glossario dell’urbanistica romana”. Quasi che il modo di crescere della città in due secoli avesse qualcosa di singolare e di esemplare al tempo stesso, fino a esprimersi in una lingua propria, poi diventata universale. Abusivismo, borgata, condono, palazzina, palazzinari, Società generale immobiliare...
Era nato a Torino nel 1929 e si era laureato a Roma nel 1953. Ha insegnato (a Venezia e a Ginevra). Ha realizzato piani territoriali (in Abruzzo, Sardegna, Puglia, Toscana, Emilia Romagna) e piani regolatori di città (a Livorno, a Lucca), si è occupato del centro storico di Palermo (con Leonardo Benevolo e Pierluigi Cervellati, sindaco Leoluca Orlando), di quartieri Ina-Casa (da Napoli a Siracusa) e di parchi (l’Appia Antica). Ha scritto tanti libri, in gran parte dedicati a Roma, agli sventramenti fascisti, all’Eur, all’Appia Antica, ai Fori imperiali. In un volume, scritto con Water Tocci e Domitilla Morandi, Avanti c’è posto (Donzelli), ha illustrato un piano di mobilità romana fondata sul ritorno del tram e in particolare su una linea che sarebbe dovuta correre sul Lungotevere ai bordi del centro storico, trasformato in un fantastico boulevard. Nessuna amministrazione comunale è stata però all’altezza delle sue idee.
Sui Fori imperiali è ritratto in una foto del 1981 (conservata nell’Archivio Cederna). Al collo ha una macchina fotografica e lo sguardo accigliato rivaleggia con quello, che si intravede, di Cederna. Eppure è passato appena qualche mese dalla distruzione, voluta dal sindaco Luigi Petroselli, di via della Consolazione, la strada che taglia i Fori sotto al Campidoglio. Il primo atto di un grande progetto che ha una valenza storico-culturale e urbanistica, l’eliminazione della via dei Fori imperiali e la riunificazione di tutta l’area archeologica. In quel progetto Insolera crede moltissimo (con Cederna, Benevolo, La Regina e altri). Ma non se ne farà nulla, nessuno dichiarerà decaduta l’idea, e silenziosamente anche questa, troppo alta per chi governava Roma, scomparirà dalla scena della città.
In esergo a Roma moderna aveva voluto una frase di Giulio Carlo Argan, sindaco di Roma fra il ‘76 e il ‘79: «La storia urbanistica di Roma è tutta e soltanto la storia della rendita fondiaria, dei suoi eccessi speculativi, delle sue convenienze e complicità colpevoli». Espressione lapidaria, che nel libro trovava una distesa articolazione, niente affatto costretta dentro un abito declamatorio e invece sostenuta da una documentazione impressionante. Storia urbanistica, ma tout court della città, dai decreti napoleonici che prefiguravano un parco archeologico fra Fori, Palatino e Colosseo, fino al “piano casa” e all’incubo proposto da Alemanno, e fortunatamente svanito, di trasformare l’Eur in una pista per la Formula 1. E fino al sogno che Roma possa diventare veramente moderna puntando sul suo essere multietnica.
«E l’urbanistica?», si domandava. L’urbanistica «è ormai figlia dell’architettura», rispondeva. «E l’architettura, ridotta a pura forma, assorbe tutto il dibattito culturale. Si bada al singolo progetto e non al disegno complessivo, al singolo manufatto e non alla città, all’individuo e non al collettivo». Occorre, aggiungeva, che l’urbanistica recuperi la linfa sociale smarrita, sovrastata com’è da un’attitudine analitica e descrittiva che oscura il resto, limitandosi a raccontare ciò che accade nelle città e fuori di esse e ritenendo inevitabili, irreversibili, al massimo mitigabili, la dispersione abitativa e il consumo del suolo. E invece lui insisteva su un’altra dimensione dell’urbanistica, a tratti militante, che attraverso la pianificazione può consentire alle persone un vero diritto alla città e una vita meno in affanno.
Non abbiamo dato il giusto ascolto alle idee di Italo
Walter Tocci – L’Unità
Scrivo questo ricordo di Insolera sulla sua scrivania. Ero venuto ad abbracciare Annina, l’amatissima compagna della sua vita, quando mi hanno telefonato da l’Unità. Qui ci sono le carte e i libri su cui stava lavorando, con difficoltà crescente a causa della malattia, ma con la curiosità mai sazia della sua pur sconfinata cultura, con il guizzo geniale e l’attenzione ai particolari, con lo scetticismo di tante delusioni ma con l’indomita fiducia nell’invenzione che talvolta sgorgava da un imprevedibile sorriso. In evidenza ci sono i materiali dell’ultimo libro che non è riuscito a concludere, un ripensamento del progetto di Quintino Sella per Roma, la grande idea di una capitale della cultura, come luogo dedicato al «cozzo delle idee», da realizzare tramite l’insediamento delle migliori università e centri di ricerca nelle stupende ville storiche che allora circondavano la città barocca, prima di essere distrutte dalla speculazione edilizia. Legare un primato moderno a quello antico era il solo modo per fare di Roma una vera capitale.
Quella intuizione era per Italo di straordinaria attualità e aveva mobilitato tutti i suoi amici per studiarne i dettagli. Quando si andava a trovarlo ognuno di noi doveva portare qualche nuovo contributo alla sua ricerca, ma era soprattutto un grande piacere ascoltarlo. Dopo averlo salutato, spesso, mi chiedevo le ragioni di quella passione. C’era forse un’inconsapevole identificazione con quel piemontese come lui che era rimasto ammaliato da Roma. Ancora di più, nell’insistenza su quella ricerca riaffiorava - stavolta quasi in forma di congedo - il suo vecchio assillo di comprendere come un progetto di città possa sposarsi con unaforte volontà politica.
Era lo stesso motivo che lo aveva portato a sostenere con sapienza ed entusiasmo il Progetto Fori di Luigi Petroselli, il sindaco che aveva saputo ascoltarlo. Ma ancora prima, c’era stata la speranza che le lotte popolari della periferia romana potessero costituire quell’energia riformatrice mancata alle perfide classi dirigenti della città nel secolo postunitario, come scrive nella prefazione all’edizione del 1971 di Roma Moderna: «se nei prossimi anni qualcuno dalle baracche, dalle borgate, dalla periferia riprenderà la lotta per un avvenire civile di questa città e troverà in essa ancora qualcosa da amare, qualcosa da vivere, sarà merito della loro tenace opposizione alla sistematica distruzione di Roma».
Sembrava allora possibile coniugare l’illuminismo del progetto con la concretezza della vita popolare. Una piccola conferma veniva anche dalla straordinaria diffusione di quel libro nei luoghi più diversi: nel seminario universitario, nell’ufficio di progettazione, nella redazione di un giornale, nella sede di un comitato di quartiere o di una sezione di partito. Poi nelle edizioni successive scomparve quell’inno alle lotte popolari e la speranza venne poggiata sull’impegno civile di Antonio Cederna. Se ne sono andati nello stesso giorno, il 27 agosto. E insieme spesso sono rimasti inascoltati.
Quando di questo saremo pienamente consapevoli ci mancheranno, non solo per i loro studi, per la passione civile, per l’esempio morale, ma per quella ricerca ancora da portare avanti di un legame tra il progetto di città e la vita quotidiana dei cittadini. La mia generazione ha avuto il privilegio di studiare sui suoi libri. Abbiamo imparato tante cose, ma non siamo riusciti a metterle in pratica compiutamente. Alle nuove generazioni non mancherà l’occasione di rileggerli con spirito nuovo, per fare meglio di noi. L’opera di Insolera merita di esser compresa in avvenire. Perfino Annina, dopo averlo amato per una vita, mi dice nel suo sobrio dolore che vorrebbe ancora chiedergli tante cose.
Anche Italo ci ha lasciato. Siamo sempre più soli a contrastare l’inesorabile avanzata del cemento e dell’asfalto sui paesaggi italiani, a difendere i nostri beni culturali dalla manomissione, a cercare di contrastare il mercimonio a cui si sono ridotti l’urbanistica e il governo del territorio.
Le sue idee, i suoi scritti, insieme con quelli di Antonio Cederna hanno indirizzato la vita di molti di noi. E’ stato così anche per me, sia per quel che riguarda l’attività professionale sia quella politica.
Di lui voglio ricordare due cose fra tante : l’appoggio forte e senza alcuna remora alla durissima ed estenuante battaglia che avevamo intrapreso per impedire la manomissione del San Domenico di Forlì, aiutandoci col suo sostegno e la sua autorevolezza a contrastare un progetto che avrebbe devastato una antica chiesa e i chiostri del convento, restituiti oggi alla città, finalmente restaurati ed adibiti a spazi culturali così come anch’egli suggeriva. Ricordo la fermezza con cui volle che il Piano Paesaggistico dell’Emilia Romagna a metà degli anno 80 venisse rappresentato interamente con tavole colorate, di immediata lettura e inequivocabile comprensione, anche e soprattutto per i cittadini che avrebbero così potuto meglio comprendere il sistema di tutele a cui veniva sottoposto il paesaggio della nostra regione di cui le carte ne rappresentavano anche gli elementi costitutivi.
Quando in Parlamento, talvolta anche in solitudine, cercavo di contrastare provvedimenti che avrebbero minacciato il nostro patrimonio storico artistico, i nostri beni archeologici, o quelli con cui si cercava di venderli o quando si varavano condoni edilizi, quando contestavo ciò che si voleva fare a Roma con sottopassi come a Castel Sant’Angelo o con piazze manomesse come quella di Montecitorio sapevo sempre che avrei ricevuto da Italo un sostegno sobrio e fermo che mi sarebbe stato di grande e insostituibile aiuto e conforto.
l’Unità
Chiarante, forza gentile del Pci
di Aldo Tortorella
Scrivere della scomparsa di un amico e compagno carissimo, con cui ho condiviso scelte e lotte politiche per un quarantennio, è cosa assai dolorosa e difficile. Incominciammo a lavorare insieme quando assunsi la responsabilità della sezione culturale ed egli si occupava della scuola. E la comune visione di quel che dovesse e potesse essere la sinistra ci ha portato, insieme, sino ad ieri. Ci separavano pochi anni, quello che bastava perché lui non potesse partecipare alla Resistenza e vivere quella esperienza che portò parecchi di noi, allora studenti, alla adesione al Pci. Chiarante seguì una strada completamente diversa, che diverrà esemplare di coraggio politico e di forza morale. Partecipe del mondo cattolico, iniziò il suo percorso nel movimento giovanile della Democrazia cristiana, di cui divenne rapidamente uno dei massimi dirigenti, schierato con la sinistra di Giuseppe Dossetti, uno dei principali estensori della Costituzione repubblicana. Protagonista nel 1953 della fondazione della corrente di Base, che raccolse l’eredità di Dossetti fattosi sacerdote, venne eletto, poco più che ventenne, nel consiglio nazionale della Dc al congresso del 54 che vide l’affermazione di Amintore Fanfani.
Erano, quelli, gli anni più aspri della guerra fredda. La contrapposizione tra i blocchi, e il monopolio statunitense dell’arma atomica, faceva temere la possibilità di una nuova catastrofica guerra. Chiarante, con altri esponenti di parte cattolica e molti intellettuali indipendenti di ogni parte d’Europa, decise di partecipare come osservatore al congresso costitutivo del movimento internazionale dei «partigiani della pace», subito bollato come filosovietico. Ne nacque una dura polemica con Fanfani, culminata con il rifiuto dell’autocritica e con l’espulsione. Da allora si fece più stretto l’incontro di Chiarante e del gruppo che faceva capo a lui e a Lucio Magri con le posizioni dei comunisti cattolici di Franco Rodano, con cui fondò la combattiva rivista Il dibattito politico. Quell’incontro sfociò, poi, nella adesione al Pci. Chiarante, come giornalista, era, intanto, divenuto vice direttore di Paese sera, quotidiano progressista indipendente di ampia diffusione.
Nella discussione interna al partito, egli portò le posizioni di chi, pur condividendo pienamente la scelta democratica e gradualista di Togliatti, sottolineava la necessità di marcare le esigenze riformatrici e trasformatrici, particolarmente dopo il superamento dell’arretratezza e l’avvenuta trasformazione dell’Italia in un Paese industriale avanzato. La discussione divenne più acuta dopo la scomparsa di Togliatti con cui Chiarante si era già misurato sulle colonne di Nuovi Argomenti quando si incominciò ad intravedere che venivano maturando tempi nuovi e temi fino a quel momento sconosciuti. Si era alla vigilia del 68, e dei mutamenti ma anche delle involuzioni di quel moto che fu, in Italia, giovanile e operaio. Chiarante fu allora con i compagni che sentivano il fascino delle posizioni di Ingrao, ma non parteciparono poi alla esperienza del Manifesto, pur rifiutandone la radiazione avvenuta sulla base di uno statuto che cambierà troppo tardi.
La differenza di opinioni non impediva però, allora, la assunzione di responsabilità rilevantissime. Chiarante fu responsabile della politica per la scuola, e poi delle politiche per la cultura, e direttore di Rinascita, la rivista settimanale edita dal partito: ovunque portando il peso della sua personalità pacata e ferma, come la sua scrittura. Il primato della scuola, della ricerca, della cultura per un Paese che voglia dirsi moderno e avanzato ebbero in Chiarante un interprete rigoroso e creativo. E la legislazione italiana per la difesa del nostro patrimonio culturale gli deve molto. Ma proprio perciò egli, come accadde a me e ad altri, temette, nel momento in cui fu proposto il mutamento del Pci in altro da sé, la dispersione di una comunità e di un grande patrimonio che non era solo di memorie e di sentimenti pur cari, ma di elaborazioni concrete e precise, perfettibili certamente, ma non così povere da dover rincominciare da zero. Non comprendevamo l’ansia di tagliare le proprie radici che non erano le medesime di quelle che avevano prodotto frutti avvelenati, anche se capivamo il bisogno di rinnovamento di una nuova generazione. Perciò non volemmo la scissione. E Chiarante assunse, anzi, quale esponente della minoranza congressuale, la responsabilità del gruppo senatoriale e della commissione di garanzia del nuovo partito reggendole entrambe con grande capacità e lealtà.
Parve a lui, e a me, che la nostra storia di partito dovesse concludersi con il bombardamento di Belgrado. Eravamo nel ‘98. Non ci convinceva la lacerazione tra le due sinistre, tema che oggi si ripropone, e perciò, assieme ad altri, partecipammo alla costruzione di una associazione per il rinnovamento e per l’unità della sinistra, di cui Chiarante è stato animatore determinante. Egli ha riassunto la sua storia, che è gran parte della storia del dibattito nel gruppo dirigente del Pci tra il ‘60 e il ‘90 in due densi volumi. Chi li legge può vedere non solo quante realtà egli avesse visto in anticipo. Ma quanta fermezza e coerenza vi sia stata nella sua volontà di una sinistra veramente nuova e aperta al futuro. Ciò che non si può leggere è che persona squisita fosse, quanta forza trasmetteva la sua serena coscienza, mai esibita. Anche per questo rimarrà non solo nei suoi scritti ma nell’animo di chiunque l’abbia conosciuto.
il manifesto
Addio a Giuseppe Chiarante Tutta la saggezza e le speranze degli anni '60
di Rossana Rossanda
Quel che è più triste dell'invecchiare è il perdere gli amici d'una vita. Quelli un poco più anziani di me se ne sono in gran parte andati, e anche diversi più giovani. Fra essi era Giuseppe Chiarante, Beppe, dal bel viso sereno e la voce tranquilla; lo conoscevo da non so quanto, più di mezzo secolo e abbiamo a lungo lavorato insieme, oltre che spartire le corse fuori porta, quando eravamo giovani e vispi settentrionali nella dorata Roma. Era l'amico e sodale di Lucio Magri, i due poco più che ragazzi della sinistra cattolica di Bergamo, negli anni '50 la città più inquieta della enorme Democrazia cristiana. Erano una fronda, facevano insieme il ribelle e il conformista, avevano finito con l'iscriversi al Pci, assieme ai grandi, i deputati Mario Melloni, Fortebraccio, e Ugo Bartesaghi. Non erano soli, altri ne condividevano molte idee senza però fare il salto. E non potevano essere più diversi nel carattere: quanto Lucio era prometeico, asseverativo, ostinato, tanto Beppe era prudente, pur nell'autonomia delle scelte, dialogante, aperto anche al dubbio. Lucio aveva le qualità del capo, Beppe quelle del saggio. Negli anni '60, quando fui chiamata a Roma per dirigere la sezione culturale in via Botteghe Oscure, Beppe ne fu incaricato come me e con me rimase finché fui allontanata, prezioso nel lavoro e nei rapporti, coltissimo, leale. Dei '60 condividemmo le speranze, cui il partito credeva di meno. Non so quanto contasse in lui l'essere cattolico, il suo riserbo non mi permetteva domande, ma la questione fra comunisti e cattolici gli stava molto a cuore, alimentata da quel Concilio Vaticano II che sembrò aprire tutte le strade e che i pontefici successivi a Giovanni XXIII chiusero, lentamente, forse senza una precisa intenzione Montini, con una accelerazione Karol Woytjla e non senza brutalità Ratzinger. L'incontro fra le due culture non doveva essere quello fra Dc e Pci, ma proprio fra una ispirazione di fondo che parve privilegiare i valori invece che i consumi, i "fondamentali" invece che le manovre. Ma anche una comune avversione a quello che il Pci chiamava, con la scusa di Gramsci, economicismo, in chiunque si occupava di più del capitale - la famosa struttura - che delle vicende politiche, l'altrettanto famosa sovrastruttura.
Su questo d'altronde Enrico Berlinguer avrebbe tentato negli anni '70 quel compromesso storico che non funzionò. Nei '70 il Pci era già meno comunista e la Dc meno cristiana di quanto fossero venti anni prima. Alla commissione culturale facemmo due convegni nei quali l'apporto di Chiarante fu decisivo: uno sulla famiglia, che contribuì alla fama di eterodossia che presto ci avvolse - eravamo antifamilisti e anticlericali - per cui Nilde Jotti e Emilio Sereni ci criticarono assai, e uno sulla scuola, sulla scia di quel Convegno sulle tendenze del capitalismo italiano che era stato organizzato dall'Istituto Gramsci nel 1962 e segna una prima linea, se non di rottura, di divisione nell'analisi che il partito faceva sulla situazione. Pur pensando in gran parte come noi, Chiarante non ci seguì nella vicenda del manifesto: e non per mancanza di coraggio ma per la persuasione che non sarebbe bastata una forza minoritaria a produrre in Italia un cambiamento. La sua posizione fu dunque non poco scomoda, perché restò nel Pci ma votando, assieme a pochi altri, contro la nostra radiazione. E del Pci seguì le sorti agitate, alleandosi con la mozione del "no" sulla svolta, negli anni turbolenti che seguirono l'89. Sperò anche lui in una presa di posizione fondamentale che si sarebbe dovuta prendere alla riunione di Arco e non fu presa. Da allora il Pci venne via via perdendo molti compagni, non occhettiani né dalemiani, ma neppure in consonanza con Rifondazione. Con Aldo Tortorella salvò dall'estinzione Critica marxista, che ha diretto assieme a lui assieme alla Associazione per il rinnovamento della sinistra, che opera tuttora cercando di riunificarne gli spezzoni non su proposte politiche estemporanee a breve, ma su un filone culturale ed etico, per la cui mancanza il Pci e poi il Pds avrebbero cessato di esistere. La confusione che seguiva nell'ex Pci ad ogni cambiamento di nome, impedì al partito di compiere ogni sforzo per trattenere loro, ma prima Ingrao, poi Bertinotti, e poi altri ancora, senza rendersi conto che stava perdendo l'essenziale del suo patrimonio politico ed umano.
Quando decidemmo come manifesto di riprendere una nuova serie del mensile sul quale eravamo nati, Chiarante lavorò con noi. E parallelamente scriveva, oltre che su Critica marxista, i tre volumi di storia del Pci ( La fine del Pci. Dall'alternativa democratica di Berlinguer all'ultimo Congresso 1979-1991, del 2009, Con Togliatti e con Berlinguer. Dal tramonto del centrismo al compromesso storico 1958-1975 del 2007 e Tra De Gasperi e Togliatti. Memorie degli anni Cinquanta del 2006), tutti pubblicati dall'editore Carocci, che sono una miniera di dati. Nel confronto con Il sarto di Ulm di Lucio Magri si vede la differenza dei caratteri: Magri è sempre sui limiti di quel che il Pci avrebbe potuto fare, Chiarante si attiene a una documentazione e testimonianza niente affatto asettica, appena un po' meno spietata. Oltre a questo, Beppe sperò a lungo come senatore che fosse perseguibile una difesa coerente del patrimonio culturale del paese, preceduto dalla compagna della sua esistenza, Sara Staccioli. Li vedevo assieme anche alle grandi esposizioni di Parigi, finché le condizioni di salute gli permisero di vedere: la perdita della vista fu, fra i mali che lo hanno assalito da anni, quello che lo tormentava di più. L'ho visto per l'ultima volta alcuni mesi fa, con l'indomita Sara che lo portava a un concerto all'Auditorium; era come sempre affettuoso ma stanco, molto.
Addio, caro Beppe, compagno ed amico. Il mio universo non è più lo stesso, ne guardo l'orizzonte e troppe sono le assenze.
il manifesto
Addio a Giuseppe Chiarante Passione, cultura, intelligenza. Ci mancherà molto
di Luciana Castellina
Ieri notte Beppe Chiarante ci ha lasciati. Era il giorno del suo ottantatreesimo compleanno, nove giorni più vecchio di me e infatti celebravamo spesso assieme l'anniversario: da circa sessant'anni, ché tanti sono quelli della nostra strettissima amicizia. Beppe aveva avuto fino alla nostra rottura del manifesto lo stesso percorso di Lucio Magri, di cui si può dire che sia stato fratello.
Nati e cresciuti nella stessa città, Bergamo, ambedue entrati nei Gruppi giovanili Dc, perché in quella provincia bianchissima (a meno di non vivere nella fabbrica ed essere uno straordinario, precoce e però isolatissimo operaio come il nostro Eliseo Milani) la politica lasciava solo la scelta fra le correnti di quel partito. Quella di Beppe e Lucio fu la scelta della sinistra dossettiana, la cosa più a sinistra che lì si potesse incontrare. Ma i Gruppi giovanili andarono parecchio oltre nella loro critica anticapitalista, tanto che Fanfani, alla vigilia del congresso di Napoli del '54, sciolse l'esecutivo dell'organizzazione e poi cacciò Beppe dal Consiglio nazionale del partito cui, molto precocemente, era stato nel frattempo promosso.
Ma una parte consistente di loro non abdicò e dette vita ad una serie di pubblicazioni di cui Beppe fu, con Lucio, uno dei principali animatori: Il ribelle e il conformista, diretto da un altro bergamasco (e in seguito colonna de il manifesto), Carlo Leidi, e Prospettive, in cui ritroviamo le firme dei tanti che poi approdarono alle fila comuniste: Baduel, Guerzoni, Asperti...
Ricordo questa vicenda non solo perché è fondante dell'itinerario politico di Chiarante, ma perché è un pezzo di storia italiana di cui poco si è scritto e che è stata invece di grande interesse. Lo stesso travaglio dei Gruppi giovanili della Dc fu infatti vissuto negli stessi anni dalla ben più corposa Giac, la Gioventù di Azione cattolica, i cui due presidenti, difronte al viscerale anticomunismo di Gedda e alla realtà democristiana, preferirono la via di un esule sacerdozio.
La Fgci - ma anche il Pci - capì poco e tardò ad offrire una sponda.
Da ponte, loro ormai fuori dalla Dc, funzionò il Dibattito politico di Franco Rodano, una rivista di cui Beppe fu per un periodo anche vicedirettore. Era nata per raccogliere i cattolici di sinistra e diventò invece - di fatto - una voce nuova e più di sinistra rispetto alla linea ufficiale del Pci. Poi ci fu l'ingresso nel partito, di cui Beppe sperimentò tutti i livelli: vicedirettore de Il Paese, dove lavorammo assieme all'inizio degli anni '60, poi con Rossana alla cultura, quindi con Tortorella, direttore di Critica marxista, di Rinascita, nella direzione e alla fine nella segreteria del Pci, nella seconda fase berlingueriana.
Non c'è stato mai, io credo, un vero dissidio politico fra noi che abbiamo scelto di dar vita al manifesto e Beppe, ma forse una differenza di carattere che ci ha portato a compiere scelte difformi: lui era prudente e paziente, noi no.
Giudicò allora il nostro un errore tattico. Ma non perché Beppe fosse un moderato: i suoi tantissimi scritti testimoniano la radicalità del suo pensiero. Quando nacque il Pds in quel nuovo partito resse poco: ne uscì con Aldo Tortorella in occasione della guerra alla Jugoslavia e con lui dette vita all'Ars, l'Associazione per il rinnovamento della Sinistra.
Ci ha lasciato la più lucida e completa analisi del dopoguerra in Tra De Gasperi e Togliatti; Da Togliatti a D'Alema; Con Togliatti e Berlinguer; Italia '95, la democrazia difficile; La fine del Pci.
Ai tanti di noi che l'hanno avuto per amico e compagno mancherà moltissimo la sua straordinaria intelligenza, il suo equilibrio, la sua cultura. Anche la sua passione, celata dietro il suo carattere schivo. Io non so più a chi potrò andare a chiedere consiglio. Sua moglie Sara è stata bravissima: sembrava fragile, è stata fortissima nell'aiutarlo a vivere in questi anni in cui la malattia l'ha attaccato. Le siamo vicini, come manifesto, il giornale cui aveva finito per collaborare spesso.
Il 12 giugno è morta Elinor Ostrom, insignita nel 2009 del premio Nobel per l'Economia. La ricordiamo pubblicando un estratto dell'introduzione al volume "La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica", a cura di E. Ostrom e di C. Hess, pubblicato da Bruno Mondadori nel 2009.
Con la parola “conoscenza” (knowledge() si intendono in questo libro tutte le idee, le informazioni e i dati comprensibili, in qualsiasi forma essi vengano espressi o ottenuti. Il nostro approccio è in linea con quello di Davenport e Prusak (1998, p. 6), i quali scrivono che «la conoscenza deriva dalle informazioni come le informazioni derivano dai dati». Machlup (1983, p. 641) ha introdotto questa distinzione fra dati, informazioni e conoscenza, in cui i primi sono frammenti di informazione allo stato grezzo, le informazioni sono costituite dall’organizzazione contestualizzata dei dati, e la conoscenza è l’assimilazione delle informazioni e la comprensione del modo in cui esse vanno utilizzate. In questo libro impieghiamo il termine “conoscenza” per riferirci a tutte le forme di sapere conseguito attraverso l’esperienza o lo studio, sia esso espresso in forma di cultura locale, scientifica, erudita o in qualsiasi altra. Il concetto include anche le opere creative come per esempio la musica, le arti visive e il teatro. Alcuni ritengono che la conoscenza sia “dialettica”, nel senso che possiede una doppia “faccia”: in quanto merce e in quanto elemento fondante della società (Reichman e Franklin 1999; Braman 1989). Questa doppia funzionalità – come esigenza umana e come bene economico – è indizio immediato della natura complessa di questa risorsa. Acquisire e scoprire conoscenza è al contempo un processo sociale e un processo profondamente personale (Polanyi 1958).
Ancora: la conoscenza è cumulativa. Nel caso delle idee l’effetto cumulativo genera vantaggi per tutti nella misura in cui l’accesso a tale patrimonio sia aperto a tutti, ma sia quello dell’accesso sia quello della conservazione erano problemi seri già molto prima dell’avvento delle tecnologie digitali. Una quantità infinita di conoscenza attende di essere disvelata. La scoperta delle conoscenze future è un tesoro collettivo di cui dobbiamo rispondere di fronte alle generazioni che ci seguiranno. Ecco perché la sfida di quella attuale è tenere aperti i sentieri della scoperta.
Assicurare l’accesso alla conoscenza diventa più facile se se ne analizza la natura e si mette bene a fuoco la sua peculiarità di bene comune. Questo approccio è in contrasto con la corrente letteratura economica, nella quale la conoscenza è stata spesso indicata come tipico esempio di bene pubblico “puro”: un bene disponibile per tutti e il cui uso da parte di una persona non limita le possibilità d’uso da parte degli altri. Nella trattazione classica dei beni pubblici, Paul A. Samuelson (1954, pp. 387- 389) ha classificato tutti i beni che possono essere utilizzati dagli esseri umani come puramente privati o puramente pubblici. Samuelson e altri, tra cui Musgrave (1959), hanno posto tutta l’enfasi sull’ esclusione: i beni dal cui uso gli individui potevano essere esclusi andavano considerati privati. Nell’affrontare questi problemi, gli economisti si concentrarono dapprima sull’impossibilità dell’esclusione, per poi orientarsi verso una classificazione basata sull’alto costo dell’esclusione. Da quel momento i beni sono stati trat-tati come se esistesse una sola dimensione. Solo quando gli studiosi hanno sviluppato una duplice classificazione dei beni (V. Ostrom ed E. Ostrom 1977), è stato pienamente riconosciuta l’esistenza di un loro secondo attributo. Il nuovo approccio ha introdotto infatti il concetto di sottraibilità (a volte definita anche rivalità) – per cui l’uso del bene da parte di una persona sottrae qualcosa dalla disponibilità dello stesso per gli altri – come fattore determinante di pari importanza per la natura di un bene. Ciò ha condotto a una classificazione bidimensionale dei beni. La conoscenza, nella sua forma intangibile, è rientrata allora nella categoria di bene pubblico, dal momento che, una volta compiuta una scoperta, è difficile impedire ad altre persone di venirne a conoscenza. L’utilizzo della conoscenza (come per esempio la teoria della relatività di Einstein) da parte di una persona non sottrae nulla alla capacità di fruizione da parte di un’altra persona. Questo esempio, naturalmente, si riferisce alle idee, ai pensieri e al sapere derivanti dalla lettura di un libro: non al libro in quanto oggetto, che sarebbe classificato come bene privato.
In questo volume impieghiamo le espressioni
beni comuni della conoscenza e
beni comuni dell’informazione in maniera intercambiabile. Alcuni capitoli si concentrano in particolare sulla comunicazione scientifica e accademica, ma le questioni discusse hanno un’importanza cruciale che si estende ben al di là della “torre d’avorio”. Ciascun
capitolo si dedica a un particolare aspetto della conoscenza in forma
digitale, principalmente perché le tecnologie che consentono una distribuzione globale e interattiva dell’informazione hanno trasformato
radicalmente la struttura della conoscenza come risorsa. Uno dei fattori critici relativi alla conoscenza digitale è la continua e radicale trasformazione (“ipercambiamento” o (hyperchange) ( delle tecnologie
e delle reti sociali che coinvolge ogni aspetto della gestione e del governo delle conoscenze, compresi i modi in cui esse sono generate, immagazzinate e conservate.
I sempre più numerosi studi sui vari approcci ai beni comuni della conoscenza mostrano la complessità e la natura interdisciplinare di queste risorse. Alcuni beni comuni della conoscenza risiedono al livello locale, altri al livello globale o in una posizione intermedia e tutti sono suscettibili di una molteplicità di utilizzi diversi e sono oggetto di interessi in competizione. Le aziende hanno premuto per misure più rigide a tutela di brevetti e copyright, mentre molti ricercatori, studiosi e professionisti si impegnano per assicurare il libero accesso alle informazioni. Le università si trovano su entrambi i fronti del dibattito sui beni comuni: da una parte, sono detentrici di un crescente numero di brevetti e fanno sempre più affidamento sulle sovvenzioni alla ricerca da parte delle aziende; dall’altra, incoraggiano il libero accesso alla conoscenza e la creazione di archivi digitali per i risultati delle ricerche svolte nei loro dipartimenti.
Gran parte dei problemi e dilemmi che affrontiamo in questo libro sono sorti in seguito all’invenzione delle nuove tecnologie digitali. L’introduzione di nuove tecnologie può rivelarsi decisiva per la robustezza o la vulnerabilità di un bene comune. Le nuove tecnologie possono consentire l’appropriazione di quelli che prima erano beni pubblici gratuiti e liberi: così è avvenuto, per esempio, nel caso di numerosi “beni comuni globali” come i fondali marini, l’atmosfera, lo spettro elettromagnetico e lo spazio. Questa capacità di appropriarsi di ciò che prima non consentiva appropriazione determina una meta-morfosi sostanziale nella natura stessa della risorsa: da bene pubblico non sottraibile e non esclusivo, essa è convertita in una risorsa comune che deve essere gestita, monitorata e protetta, per garantirne la sostenibilità e la preservazione.
Francesco Erbani, Antonio Cederna. Una vita per la città, il paesaggio, la bellezza, Roma, Legambiente-La biblioteca del cigno, 160 pp., 9,50 euro.
Il nuovo volume di Francesco Erbani è dedicato ad uno dei maestri del giornalismo italiano e, assieme, uno dei più importanti intellettuali italiani della seconda metà del ‘900, ben noto ai lettori di eddyburg: Antonio Cederna.
Il volume ripercorre la vita e il pensiero di Cederna sin dalle prime battaglie contro i monopoli e la rendita fondiaria, ancora oggi attualissime. E dall’insieme del volume emerge l’inalterata modernità del suo pensiero: dalle cronache sul Mondo che dal 1949 documentano il modo perverso in cui stanno crescendo le città italiane.
Indimenticabili le battaglie per la difesa dell’Appia e a favore di una pianificazione urbanistica pubblica.
Ma nel corso di oltre quarant’anni, Cederna sarà chiamato a denunciare le mille vicende che testimoniano l’assalto al territorio, il suo degrado e assieme quello del patrimonio culturale italiano.
Ora più che mai occorre rileggere Cederna!
Le prime presentazioni del volume:
5 giugno 2012 - Ferrara, Università di Ferrara, Facoltà di Architettura, via Quartieri, 8, h. 16:
Dialogano con l’autore: Francesca Leder, Arturo Lanzani e Elena Granata.
7 giugno 2012 – Roma, Villa di Capo di Bove, Appia Antica 222, h. 17:
Assieme all’autore intervengono Vezio De Lucia, Roberto Della Seta, Maria Pia Guermandi, modera Marco Fratoddi.
Portano una testimonianza: Desideria Pasolini dall’Onda, Adriano La Regina, Carlo Melograni, Edoardo Zanchini.
Titolo originale: A Passion For Urban Planning, And For Food – Scelto e tradotto da Fabrizio Bottini
La vita di Terry Tondro ha toccato cose diversissime. Professore di diritto lontanissimo dall’accademico nella sua torre d’avorio, adorava la buona tavola e il buon vino, preferendo cucinare da solo. E adorava le città: profondamente urbanista, ma che sapeva apprezzare l’oceano e l’aria frizzante del Maine rurale. Conoscitore della musica operistica, ascoltava anche con passione Ella Fitgerald. Ha lavorato per tutelare edifici storici, ma anche contribuito a realizzare case per e meno abbienti e la popolazione di colore. Uomo d’azione, Tondro, ma che faceva ogni cosa con stile e buon gusto. Affermato e riconosciuto esperto nel campo dell’urbanistica e del territorio, rimase sempre una persone umile.
"Era un egualitario nel profondo" ricorda il figlio Trevor. "Detestava apparire in qualche modo snob, pretenzioso, superiore rispetto agli altri. Era più un tipo dalle maniche rimboccate che uno con la camicia inamidata". Tondro è morto a Hartford, dove abitava, per un infarto in 26 aprile, due settimane prima del 74° compleanno. Era nato il 7 maggio 1938, cresciuto sulla sponda dell’oceano a Santa Monica, California, vicino a Los Angeles. Maggiore dei cinque figli di Lloyd e Italia Tondro (famiglia francese, il cognome originario si scrive Tondreau). Padre imbianchino, gran sostenitore di Franklin Delano Roosevelt e dell’idea di pari opportunità per tutti. Tondro inizia a lavorare in un caffè, poi in un elegante ristorante sul Wilshire Boulevard a Los Angeles durante le medie superiori. Il tutore scolastico gli consiglia ("un tipo senza troppa immaginazione" giudica oggi la moglie di Tondro) di iscriversi alla Scuola Superiore Alberghiera della Cornell University per diventare uno chef. Contemporaneamente Tondro ottiene anche una borsa per la Stanford University.
Desideroso di viaggiare sceglie la Cornell, ma dopo due anni a studiare “ospitalità” e raffinate tecniche di cucina, vuole passare ad un percorso di studi diverso. L’iscrizione al Reserve Officer Training Corps gli garantisce la copertura finanziaria. Dopo aver ottenuto il diploma nel 1961, Tondro entra nell’Esercito, e davanti alla scelta fra i carristi (servizio in Germania) e i paracadutisti (servizio nel territorio dello stato), opta ancora per la destinazione più lontana. Sfrutta le vacanze per viaggiare in Europa. L’idea originaria era di proseguire gli studi in Storia Americana, ma dopo il servizio militare ha imparato il valore dell’esperienza pratica, di “fare delle cose”. E così si iscrive a Legge. Per ingannare l’attesa dei corsi che cominciano solo nell’autunno 1964, Tondro torna in California dove lavora come istruttore di guida. Una delle allieve è Helle Stueland, giovane norvegese appena laureata all’Università di Berkeley. Si vedono regolarmente dietro il volante di una VolksWagen. Quando Helle si trasferisce a est l’inverno seguente sono ufficialmente fidanzati, si sposeranno nel giugno 1965.
Tondro ha ottimi voti alla Scuola di Diritto della New York University, e dopo aver ottenuto il titolo lavora per un anno all’Office of Economic Opportunity nel quadro del programma di Guerra alla Povertà del Presidente Lyndon B. Johnson: un’esperienza molto formativa. Per un breve periodo collabora anche con la fabbrica di calzature Paul Weiss di New York, salvo scoprire che detesta il diritto privato. Si iscrive allora alla Yale University per studiare urbanistica sino a ottenere una specializzazione in American Studies. Nel 1973 inizia a insegnare diritto all’Università del Connecticut, proprio nel momento in cui la città di Hartford sperimenta un percorso urbanistico chiamato Hartford Process. Progetto fallito, ma Tondro ha trovato la sua collocazione.
È coautore di una memoria presentata alla Cortre Suprema del Connecticut su un caso di variante all’ordinanza di zoning per East Hampton che impone una superficie minima degli alloggi di cento metri quadrati, considerata discriminante per i poveri (la corte stabilirà che si tratta di un provvedimento irrazionale e senza giustificazioni imposto dall’amministrazione, e lo boccia). Svolge approfondite ricerche su vari casi di destinazioni d’uso e zoning traendone un testo che diventerà per decenni una specie di bibbia per costruttori, urbanisti, amministratori e magistrati. "È stato in pratica un manuale per come prendere le decisioni in quell’area" commenta Dwight Merriam, esperto di diritto urbanistico di Hartford, che ne ha una copia tenuta insieme da strisce di nastro adesivo. Oltre a studiare casi, Tondro aveva inserito anche commenti propri di carattere più generale, sulle sentenze per le l’ambiente, le lottizzazioni, lo sviluppo urbano. Alle assemblee si portavano tutti il libro di Tondro, Connecticut Land Use Regulation: A Legal Guide for Lawyers, Commissioners, Consultants and Other Users of the Land tenendolo aperto sulle ginocchia.
“Facevamo a gara fra chi citava meglio quei passaggi scritti da Terry e che consideravamo più importanti per il nostro punto di vista" ha ricordato il magistrato Mark Dubois nella serata dedicata a Tondro. "Era diritto urbanistico reso accessibile a tantissimi" ricorda Tim Hollister, relatore di maggioranza per il caso East Hampton. "Aveva opinioni molto nette e non mancava mai di schierarsi chiaramente. Testimoniava anche cosa volesse dire esprimere un punto di vista disinteressato sulle scelte". Fu nominato dal Governatore William O'Neill presidente della Blue Ribbon Commission on Housing, e scrisse gran parte dei provvedimenti che oggi consentono di introdurre quote di case economiche in trasformazioni di abitazioni più costose, rendendo molto difficile per le amministrazioni escludere dal proprio territorio le case popolari. Secondo Tondro il sostegno alla casa per tutti non doveva arrivare solo dai comitati per i diritti, ma anche da chi come l’amministrazione vuole un alloggio per i ceti medi. A differenza di tanti professori che vivono in un mondo fatto di aule e biblioteche, Tondro apprezzava la militanza, vedere le proprie idee trasformarsi in realtà."Era uno di quei tipi di accademici, sempre più rari, davvero disponibili a partecipare e schierarsi sulle questioni urbane. Teneva un piede in entrambe le scarpe: gli studi, e la partecipazione urbanistica" ricorda Merriam.
Nella scuola legale, Tondro insegnava vari aspetti del diritto."Era abbastanza concentrato sugli aspetti economici delle trasformazioni, come la finanza influisca sulle capacità dei costruttori, sul rischio che una separazione per zone induca una divisione di classe” ricorda Michael Ziska, ex studente che ricorda Tondro come maestro. “Terry cercava sempre di unire pianificazione urbanistica e la possibilità di case per tutti. È grazie alle sue capacità che abbiamo fatto progressi". Da ragazzo Tondro aveva aiutato il padre nei lavori di manutenzione edilizia, e capiva essenzialmente il settore. Gli piacevano molto gli edifici storici, in particolare a Hartford quelli in stile vittoriano del XIX secolo. Nel 1973, quando sorse la protesta per la demolizione di un edificio storico sulla Prospect Avenue a Hartford, Tondro entrò nella Hartford Architecture Conservancy partecipando poi ad altre battaglie di tutela, con la Connecticut Trust for Historic Preservation, di cui fu presidente di sezione, e consigliere del Trust for Historic Preservation nazionale.
Fu approvata una legge sugli sgravi fiscali che rendeva più conveniente per le proprietà conservare gli edifici storici. “Terry vide la possibilità che in Connecticut si potesse fare tutela” ricorda Jared Edwards, architetto fra i fondatori della Hartford Conservacy. Tondro coinvolgeva ex studenti diventati deputati statali per sostenere il disegno di legge, che avrebbe protetto tanti edifici anche industriali. “Nel suo modo molto posato faceva notare quanto lo stato dovesse assumere un ruolo guida per gli investimenti privati nella tutela" ricorda Edwards. “Mise le basi per leggi che hanno ottenuto enormi risultati per decenni”. Svolse anche un ruolo essenziale per la destinazione a parco nazionale della tenuta agricola Wilton, del pittore impressionista ottocentesco J. Alden Weir. “Col suo talento arrivava a risultati che si ritenevano impossibili”.
Tra le grandi passioni di Tondro c’era anche la buona tavola. Dopo aver trascorso un mese in Italia con la famiglia nel 1978, era tornato portandosi ricette di cucina del tutto nuove: niente a che vedere con il solito sugo alla marinara, spaghetti e polpette. Le sue cene erano la leggenda di tutto il West End a Hartford. “L’invito era per le sette, si cominciava a mangiare alle nove, e ci si alzava all’una di notte” ricorda ancora Edwards. “Quando eravamo convinti di aver finite, ecco che spuntava un altro piatto ancora più elaborato. ... Quella sì che era vita. Certo con dieci chili in più”. Quando stava con la famiglia a New York andavano all’opera due volte la settimana, biglietti posti in piedi da uno a tre dollari. Lo facevano anche abitando in Connecticut. Dal 2000,dopo il pensionamento, passava ogni anno sei mesi con la moglie a Roma, studiando la lingua, sperimentando la la cucina, frequentando concerti e musei, soprattutto passeggiando per la città.
Tondro adorava le cravatte a papillon, che indossava con molto stile. Negli ultimi anni aveva avuto qualche piccolo attacco, ma anche quest’inverno era comunque andato qualche mese a Roma. Oltre alla moglie lascia due figli e tre nipoti. È sepoloto al Cimitero dei Veterani di Middletown. Molto adatto a lui, commenta la moglie: tutti con la medesima lapide, indipendentemente dal grado o dalla posizione sociale. Col rumore delle auto che ricorda a tutti quanto nonostante il prato verde si sia sempre in città. “Aveva un senso egualitario difficile da descrivere” ricorda Bill Breetz, vicino di casa ed ex collega di insegnamento. “Una cosa che ha attraversato tutta la sua opera: le case popolari, un’urbanistica inclusiva, la tutela per tutti della Weir Farm, e fare delle città posti migliori per viverci”.
Titolo originale: Jane Jacobs and the Power of Women Planners – Scelto e tradotto da Fabrizio Bottini
Fanno cinquant’anni a novembre, da quando l’uscita di La vita e la morte delle grandi città di Jane Jacobs cambiava in tutto il mondo il modo di considerarle. Eppure, nonostante da allora la si riconosca come un importantissimo contributo, c’è sempre invariabilmente quell’aggettivo di “casalinga”. Parlando di strategie per lo sviluppo urbano e socioeconomico, non c’è gran posto per le donne al tavolo delle decisioni. Certo lavorano nel settore, ma raramente in posizioni chiave dal punto di vista critico. Jane è stata un’eccezione. Ma la norma non è molto cambiata.
La Jacobs fece quella sua irruzione nel dibattito nazionale sulle città quasi per caso. Piuttosto riluttante a sostituire il suo direttore maschio dell’Architectural Forum al convegno del 1956. Aveva pubblicato alcuni articoli rivelatori sul metabolismo delle città, soprattutto su Vogue, a documentare il modo in cui a New York City crescevano armoniosamente i quartieri attorno a settori come pellicce o fiorai. Oggi quelle riflessioni sono considerate assolutamente innovative. Ma all’epoca si limitarono a metterla un po’ in luce.
E quella prima attenzione la Jacobs con gli articoli sia su Architectural Forum che su Fortune la trovò da parte di un prestigioso redattore maschio, William Holly Whyte. Lui era diventato famoso come autore del L’Uomo dell’Organizzazione, oltre che per sostenere idee simili alle sue. Ma anche lui fu costretto a superare i contrasti con un furioso e paonazzo editore di Fortune che gli chiedeva “Ma chi è quella pazza?”. Inaccettabile, quella casalinga senza una laurea. E anche la stessa caustica recensione di Lewis Mumford a La vita e la morte … era stata intitolata “Le ricette casalinghe di Mamma Jacobs”.
Riflettendo sul perché si consideravano in modo tanto diverso i contributi delle donne e degli uomini sul tema delle città, lei sottolineava quanto le donne tendessero a soffermarsi su cose prossime: la via, il quartiere, le relazioni. Coglievano così più facilmente quanta differenza si potesse fare, a partire da piccole cose. Gli uomini pensano in grande, nazionale, globale. Hanno un atteggiamento top-down. Un punto di vista proposto molto esplicitamente al pubblico quando il costruttore James Rouse e Jane Jacobs nel 1980 si presentarono insieme a Boston alla Conferenza sulle Grandi Città. L’argomento era se ci si dovesse orientare verso grandi prospettive e visioni ispirate, oppure procedere per più modeste trasformazioni progressive.
Parlò per primo Rouse, ricordando le parole di Daniel Burnham, “Non fate progetti modesti, sono senza magia, non rimescolano il sangue nelle vene degli uomini” citava. Venne il turno della Jacobs che esordì con, “Divertente, quei grossi progetti non rimescolano affatto il sangue delle donne. Loro hanno sempre preferito guardare ai progetti più piccoli”. Fu sommersa dagli applausi. Rouse sosteneva che coi grandi progetti si poteva consegnare al mondo città straordinarie. La Jacobs rispondeva che i grandi progetti portano a grandi errori, schiacciando creatività e possibilità alternative. Rouse affermava che con i grandi progetti si evita di sprecarsi in interventi sparsi e casuali. La Jacobs replicava che così ci si limita a standardizzare, a uniformare, a livellare.
Era il 1980. Molto tempo era passato da quando la Jacobs contribuiva sconfiggere Robert Moses su tre progetti che potevano cambiare radicalmente la città. E contribuiva anche ad accelerare il suo pensionamento. Era famosa in tutto il mondo per i suoi libri. Ma non pensò mai e poi mai che quanto sosteneva potesse avere lo stesso peso di qualcosa detto da uomini. Sono in tanti oggi ad affermare che i loro progetti si conformano ai precetti della Jacobs, mentre invece seguono l’idea della visione audace alla Robert Moses. Anche la Jacobs naturalmente sapeva pensare in grande, ma in modo diverso da Moses: non grossi progetti di demolizioni e superstrade, ma un complesso di infrastrutture e spazi sociali, dai trasporti alle biblioteche, o grandi reti urbane fatte di piccoli elementi, di interconnessioni fra quartieri.
Nell’introduzione all’edizione 1993 di La vita e la morte … per la Modern Library, Jane metteva in dubbio la diffusa convinzione che quel libro avesse tanto cambiato la cultura urbanistica. Cosa interessante, divideva il mondo in due, fra la gente che cammina e quella che va in macchina. A chi va a piedi, certo, quel libro forse aveva dato “legittimazione a quanto già sapevano, ma che gli esperti dell’epoca consideravano antiquato e contrario al progresso”. E proseguiva: Non è facile per chi non ha un ruolo formale opporsi a chi ce l’ha, anche quando i sedicenti esperti sono immersi fino al collo nell’ignoranza e nell’azzardo. Questo libro ha saputo dimostrarsi un’arma molto utile contro quel genere di esperti. Ma non è esatto chiamarlo qualcosa che ha avuto “influenza”, forse ha rafforzato, indotto a collaborare. Per contro, non ha mai voluto collaborare con quelli che ragionano in macchina, né li ha influenzati in alcun modo. Per quanto posso capire li lascia indifferenti anche oggi.
Il retropensiero, qui e in altri contributi della Jacobs, ricorda quello scambio di opinioni con Rouse, quel modo di verso di vedere le cose tra uomini e donne. Ne abbiamo discusso parecchio io e lei nel corso degli anni. Adorava ascoltare quanto le raccontavo delle mie ricerche in tutto il paese per i libri che stavo scrivendo, storie di riqualificazione urbana o di quartiere dove il catalizzatore erano sempre piccoli progetti, ancor più spesso sostenuti da donne. Oggi donne così ce ne sono un po’ dappertutto. A New York, Mindy Fullilove. Alexie Torres Flemming. Majora Carter. Kate Wood. Elizabeth Yampiere. Joan Byron. A New Orleans, Tanya Harris, Karen Gadbois, Carol Bebelle. Si tratta di attiviste, così come lo era la Jacobs. Un conto è stare nel mondo dei grandi principi, un altro partecipare attivamente alle trasformazioni di cui si avverte il bisogno. Qualunque osservatore attento delle città, nel XX o XXI secolo, non può negare che le donne siano sempre state all’avanguardia della loro salvezza e riqualificazione. Jane Jacobs era semplicemente una di loro.
Un’Italia che frana e si sbriciola non appena piove per due giorni di fila, ecco l’immagine che subito ci propone il 1973, quasi a imporre alla nostra attenzione il problema di fondo e il più trascurato della politica italiana: la difesa dell’ambiente, la sicurezza del suolo, la pianificazione urbanistica.
I disastri arrivano ormai a ritmo accelerato: e tutti dovremmo aver capito che ben poco essi hanno di “naturale” poiché la loro causa prima sta nell’incuria, nell’ignavia, nel disprezzo che i governi da decenni dimostrano per la stessa sopravvivenza fisica del fu giardino d’Europa e per l’incolumità dei suoi abitanti.
I “miracoli economici”, i boom edilizi, industriali e autostradali, sono avvenuti tutti al di fuori di qualsiasi programmazione di autentico e lungimirante interesse generale: abbiamo sistematicamente trascurato di realizzare tutta l’armatura dei servizi pubblici e delle attrezzature collettive (dalle scuole agli impianti di depurazione, dalle riserve naturali ai piani di bacino idrografico, dal verde pubblico ai trasporti collettivi, dal rimboschimento alla difesa dei litorali ecc.), indispensabili alle esigenze di vita della popolazione in un’epoca di sempre più veloci trasformazioni economiche e sociali. Gli eventi franosi sono due-tremila l’anno, con un morto ogni otto giorni: i geologi del Servizio di stato sono cinque, uno ogni dieci milioni di abitanti (mentre nel Ghana sono uno ogni settantamila). Sarebbe davvero strano che l’Italia non andasse periodicamente sott’acqua. Gli interventi pubblici sono saltuari, sono frammentari, non coordinati (nulla di decisivo è stato ancora fatto per il bacino dell’Arno, a sei anni di distanza dall’alluvione). Nel 1970 la commissione interministeriale De Marchi ha calcolato che per la difesa idraulica del suolo italiano occorrono 5300 miliardi nel prossimo trentennio. Ecco il costo dell’imprevidenza, i conti sbagliati della nostra economia, che ha puntato tutto sul tornaconto immediato e sul profitto.
Fino a che la difesa della natura e del suolo non diventerà la base della pianificazione del territorio, fino a che questo non sarà considerato patrimonio comune (anziché res nullius, come è stato finora), continueremo a contare le morti e le distruzioni. Ma intanto questa Italia, sempre pronta a invocare la propria “povertà” per non fare le cose indispensabili, ha stanziato la settimana scorsa altri cinquecento miliardi di lire per costruire nuove autostrade.
Gennaio 1973
Nell’87 il Sevizio geologico è passato alle dipendenze del Ministero dell’Ambiente e successivamente alle dipendenze del Consiglio dei Ministri. Trentatré miliardi sono stati finanziati dalla legge finanziaria ’88, l’organico è stato portato a 128 unità, un nuovo impulso è stato impresso alla redazione della carta geologica in scala al 50.000. E’ pronto il progetto per il consolidamento e la ristrutturazione della sede di Largo Susanna. Tra gli anni settanta e ottanta l’edificio rappresentò un autentico pericolo per l’incolumità di chi ci lavorava, a causa di gravi dissesti statici: minacciava di crollare la sede che ospitava il servizio preposto alla prevenzione del collasso idrogeologico nazionale. (A.C.1991)
Per gentile concessione dell'Archivio Cederna www.archiviocederna.it
Della sua bella e lunga vita mi piace ricordare un momento importante, che forse pochi conoscono, e che fa di Mario uno dei protagonisti dell’urbanistica moderna in Italia.
Mi riferisco al ruolo da lui svolto nella formazione di quelle misure – volute dal ministro Giacomo Mancini e dal direttore generale Michele Martuscelli, dopo la frana di Agrigento del luglio 1966 – che furono definite standard urbanistici, per migliorare le condizioni di vita nelle città, aumentare e qualificare le dotazioni di servizi e di spazi pubblici.
Mario Ghio dette il meglio di sé. Diventò di fatto il coordinatore del gruppo di lavoro, al quale collaboravano illustri urbanisti: Giovanni Astengo, Edoardo Detti, Luigi Piccinato, Fabrizio Giovenale, Marcello Vittorini, Vincenzo Di Gioia, Bubi Campos Venuti, Edoardo Salzano e altri. Il lavoro era molto seguito dalla stampa e da giornalisti, soprattutto da quelli, come Antonio Cederna e Vittorio Emiliani, più attenti alle sorti delle città e dei cittadini.
Chi vi parla era allora giovane funzionario del ministero incaricato di seguire il lavoro della commissione. Divenni subito il più diretto collaboratore di Mario. So che in circostanze come queste non è bello riferire in prima persona, mi permetto di farlo soprattutto per testimoniare una delle qualità di Mario: la sua straordinaria attitudine a lavorare con i giovani, a formare i giovani. Per me fu una prestigiosa scuola privata che ben pochi hanno potuto permettersi.
Alla base del nostro lavoro stava quel libro prezioso, scritto da Mario e da Vittoria, Verde per la città, che ha fatto conoscere in Italia la cultura degli spazi aperti e le migliori esperienze straniere. “Un libro che mi ha aperto la mente”: mi ha detto qui stamattina Giuliano Prasca.
Ho raccontato altre volte del “terrificante perfezionismo” di Mario, e della sua sconfinata capacità di lavoro. Finito l’orario d’ufficio continuavamo a casa Ghio. Elaborò tabelle e quadri sinottici complicatissimi. Poi drasticamente semplificati e sottoposti a discussioni anche aspre, in ogni sede, prima di essere tradotti nel decreto ben noto a chi si occupa di urbanistica. Ma la tenacia, la determinazione, anche il coraggio di Mario, non permisero che fossero sacrificate le quantità e la qualità dei servizi collettivi.
Voglio solo ripetere che se in molti paesi e città italiani, a cominciare da Roma, si dispone di verde e di aree per il gioco, lo svago, l’istruzione, la cultura, la contemplazione, lo si deve anche a Mario Ghio.
Nella sua bella e lunga vita Mario ha sempre lavorato intensamente, all’università, nella professione, nelle associazioni culturali, ha scritto testi e disegnato piani che restano fondamentali. Sempre con la stessa caparbia fermezza mostrata al tempo degli standard. Sempre insensibile al cambio delle stagioni politiche e culturali. Avendo sempre lo stesso indiscusso obiettivo della prevalenza dell’interesse generale.
Addio Mario, non ti dimenticheremo.
La morte di Mario Manieri Elia riporta alla memoria alcuni momenti cruciali del dibattito tra gli architetti italiani. Non posso lasciarli sotto silenzio senza favorire la tendenza (particolarmente diffusa oggi non solo tra gli architetti) a depurare di ogni elemento creativo e conflittuale il pensiero specialistico. Allora si concepiva il lavoro dell'architetto come indissolubilmente connesso all'urbanistica e alla storia. Il movimento moderno in architettura voleva far saltare l'agnosticismo morale della professione ottocentesca. Ricordo ancora il mio primo incontro con Manieri Elia, da studente iscritto, nel 1960-61, al primo anno alla Facoltà di Architettura. Dopo aver ascoltato una sua conferenza gli domandai (e l'Avanti! ci fece il titolo...) se non fosse vero che l'urbanista non potesse non essere socialista. Ne parlo perché dà il clima di quegli anni, in cui maturava il centrosinistra, e sembrava che il fulcro del progetto riformista dovesse essere una nuova legge per il governo del territorio, asse della programmazione (Sullo e Pieraccini ci hanno provato invano). E per confrontarlo col clima presente, dove (in Italia, non in tutta l'Europa) sembra acquisita la rinuncia a ogni rapporto dei poteri pubblici con i costruttori che non sia di dipendenza passiva
È significativo che nell'ultimo libro pubblicato in vita di Manieri Elia, I vissuti dell'architettura, cinque diadi di protagonisti a confronto - che comincia con la coppia mitica Dedalo-Prometeo - l'età contemporanea sia rappresentata dall'opposizione tra Rem Koolhaaas (il massimo del realismo, anche a prezzo della rinuncia preventiva ad ogni opposizione al potere) e Manfredo Tafuri. Tafuri sta pagando un oblio troppo rapido per non doversi concludere con la sua riscoperta, ma la commozione che mi prende per l'ultimo omaggio che Manieri Elia gli ha reso, riservandogli il posto della coscienza critica e dell'opposizione del nostro tempo (con uno schizzo del volto barbuto di Manfredo che campeggia in copertina), dipende dalla capacità che ha così dimostrato di passare sopra allo scontro che proprio con Tafuri aveva avuto a proposito di William Morris. Manieri Elia, oltre che della "città americana" e di Henry Sullivan, è stato sicuramente il massimo specialista di William Morris (Architettura e socialismo, William Morris e l'ideologia dell'architettura moderna, Opere di William Morris).
La polemica di Tafuri contro Manieri Elia colpiva senza indulgenza, come manifestazione di romanticismo acritico, ascientifico e sentimentale, l'idea stessa di una possibile derivazione della modernità dal socialismo utopico e dall'artigianato di qualità morrisiano. I recenti saggi di Richard Sennet, la moderna questione del "bene comune" pongono la questione forse in una luce diversa, dove sperimentalità e sapienza del fare appaiono estranei, più che all'Ottocento, agli idola fori del marxismo degli anni Settanta troppo legati alla società di massa.
Il secondo motivo per cui è necessario ricordare Mario Manieri Elia è il ruolo di protagonista che ha avuto negli sviluppi del progetto Fori, pilastro centrale dell'idea per Roma di Luigi Petroselli, successivi alla morte del Sindaco. Manieri Elia ha avuto la pazienza e la capacità di ascolto per mediare in quella colossale battaglia nel campo di Agramante scoppiata tra archeologi e architetti a proposito della cancellazione di via dei Fori Imperiali. Già nel 1981 aveva osservato, in un libretto per l'Electa, che la cancellazione fisica di via dei Fori non era la parte essenziale di un'idea che trovava il suo significato più profondo nell'affermazione della centralità per Roma non del traffico ma della cultura, su un'area che si estendeva dal Campidoglio all'Appia Antica allo stesso territorio dei Castelli. Negli ultimi tempi, in parallelo al Master Storia e Progetto che conduceva per l'Università di Roma Tre, Manieri Elia dedicava grande attenzione a raffinate questioni teoriche della mentalità progettuale, in una serie di volumi Topos e Progetto pubblicati da Gangemi, di cui sono usciti quelli intitolati Il vuoto e L'attesa, mentre è imminente la pubblicazione - ormai postuma - de L'ascolto.
Mario Manieri Elia faceva infine parte del gruppo capeggiato da Francesco Cellini (assieme al sottoscritto, Alessandra Macchioni, Vanessa Squadroni, Maria Margarita Segarra Lagunes, Giovanni Manieri Elia, Dieter Mertens, Carlo Gasparrini, Elisabeth Keven, José Tito Rojo, Giovanni Longobardi, Renzo Candidi, Andrea Mandara) vincitore del Concorso internazionale per la riqualificazione di Largo Augusto Imperatore - il cui inizio dei lavori si attende ormai da cinque anni, ed è stato recentemente nuovamente riannunciato.