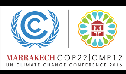Se vogliamo che le nuove generazioni (e noi stessi) si sopravviva dobbiamo reimparare che cos'è la natura nel pianeta in cui viviamo: occorre «la coltivazione di una coscienza di stagione e di luogo». il manifesto, 20 gennaio 2017
Si intitolava
Una coscienza di stagione e di luogo una preziosa conferenza che Fritjof Capra, nel 1997 tenne all’aperto nell’Edible Schoolyard, il “cortile commestibile” dell’Università di Berkeley. Si individuava come indispensabile per la sopravvivenza di tutti una ecoalfabetizzazione di massa, «la coltivazione di una coscienza di stagione e di luogo».
Della stagione noi non ci rendiamo conto, se non in occasione di catastrofi, quando ci ammaliamo, quando invecchiamo, quando la pioggia travolge gli argini dei torrenti, quando la neve abbatte effimere anche se sontuose costruzioni.
Ciò comporta, oltre tutto, un enorme problema pedagogico: negli spazi artificiali in cui li parcheggiamo, in quelli metropolitani, i bambini non sanno più riconoscere, ma soprattutto vivere, il ciclo vitale e temporale di un organismo, il ciclo di nascita, crescita, maturazione, declino, morte, e poi la nuova crescita della generazione successiva legato all’alternarsi del caldo e del freddo, dell’estate e dell’inverno.
Non hanno insomma più la struttura mentale della stagione, una struttura del ciclo e anche del limite. I sistemi metropolitani, modulati su quelli industriali, innaturali e contro Natura, hanno invece fatto acquisire, in base al pregiudizio che tutte le cose debbano crescere ed espandersi all’infinito, una struttura senza scansioni temporali, senza adattamenti temporali, senza incertezze e dissipazioni e perciò senza vere precauzioni .
È una struttura che ha influito sul senso del tempo ma anche dello spazio che non è più un luogo, ovvero uno spazio che è funzionale ma anche simbolico, e in cui l’uomo per abitare deve conseguire anche un senso di identità e di appartenenza, accumulare memoria e bellezza e armonia e relazioni di comunità e perfino un senso del sacro.
Il sacro è stato abolito nella struttura mentale moderna e certo nelle tante Facoltà per archistar si irridono (con ovvie eccezioni) quei riti magici fatti da antiche religioni e comunità non solo per propiziarsi lo spazio, ma per trasformarlo da spazio selvaggio a luogo civilizzato secondo una razionalità.
In quei riti c’era anche infatti una profonda essenza di scienza naturale finalizzata alla prevenzione e quindi rivolti ad indagare se erano adatti a quella specifica costruzione o città, quello specifico clima, quel movimento del sole, quelle specifiche condizioni del suolo, oltre alla vicinanza all’acqua e alla presenza di vegetazione.
Riti che davano un limite ed un principio di responsabilità all’abitare dell’uomo, al suo costruire, dicendogli continuamente, ossessivamente, che non era padrone, che ogni presa di possesso dello spazio non poteva essere avulsa del conoscere, curare, armonizzare.
Forte della coscienza di stagione e di luogo, la coscienza tragica dell’ecologia, invita perciò, sempre come Cassandra inascoltata, a verificare da dove venga la distruzione, a verificare se non è stato il caso ma proprio il desiderio di Paride a causare la sciagura.
A verificare cioè se le catastrofi naturali siano proprio naturali, o siano il frutto di un atto umano scellerato, la conseguenza del senso mancato della stagione e del luogo. Invitano a vedere (come del resto farà la magistratura) se in quell’albergo dove si promettevano tutte le stelle del benessere artificiale, non sia venuto meno proprio al primo patto, alla prima condizione vera del benessere che è la filiazione, il rispetto, la coscienza dei limiti che l’uomo figlio deve avere nei confronti della Natura.

«Nelle campagne italiane esistono persone che hanno scelto di radicarsi sul territorio per coltivarlo in maniera autonoma, efficiente, rispettosa dell’ambiente. Chi sono?» terranuova, 12 gennaio 2017 (c.m.c.)
Sembra una favola sbarazzarsi dei metodi agroindustriali, eppure oggi in Italia c’è chi vive questa favola tutti i giorni. Chi sono queste persone? Come fanno reddito? Quali tecniche adottano? E perché il loro lavoro è necessario?
«Nell'autunno 2015 iniziano le riprese del documentario indipendente "Con i piedi per terra", durante un viaggio per l’Italia intrapreso per intervistare contadini, ricercatori, medici e docenti universitari» spiega Valentina Gasperini, una delle voci e dei protagonisti del progetto.
«Compiuto con lo spirito della ricerca, è un'indagine realizzata riprendendo in presa diretta le attività quotidiane nei campi, nei boschi, nelle case e nei mercati. Con il ritmo sostenuto dell'avanscoperta, e valorizzato da musiche originali, il documentario racconta attraverso decine di storie personali come fare reddito in maniera sostenibile, onorando il senso di appartenenza al territorio e la cultura dei saperi millenari. Testimonianze che smascherando l'inganno ideologico operato dell'agro-industria lasciano affiorare un paesaggio finemente lavorato, come un pizzo fatto di attività agricole all'opera Con i piedi per terra».
"Con i piedi per terra" è una tappa del "Viaggio Tra Terra e Cielo": un percorso che procedendo dal web al video arriverà in teatro.
"Radici nel cielo" è un collettivo di artisti e tecnici attivo nel teatro civile e nel videomaking documentaristico. Elabora percorsi di ricerca e spettacolo sull’etica e il senso di appartenenza alla terra e alla comunità umana.
Nato nel 2015, Radici nel Cielo fa narrazione orale e comunicazione multimediale accogliendo i saperi e le abilità di professionisti diversi, con un metodo di lavoro aperto alle collaborazioni.
Il collettivo ha come base operativa la Tenuta San Cassiano ma, proprio come radici, i suoi membri vivono sparsi e lavorano uniti, disseminati tra monti
"Con i piedi per terra".
 «L’economia globale capitalistica prende le cose buone dai paesi poveri a cui restituisce la nocività. Il socialismo riconosce i bisogni essenziali alla vita». il manifesto, 30 dicembre 2016 (c.m.c.)
«L’economia globale capitalistica prende le cose buone dai paesi poveri a cui restituisce la nocività. Il socialismo riconosce i bisogni essenziali alla vita». il manifesto, 30 dicembre 2016 (c.m.c.)
La politica ha (dovrebbe avere) la funzione di soddisfare i bisogni delle persone: bisogni di cibo, di acqua, di abitazione, bisogno di respirare aria pulita, di salute, di informazione e istruzione, di mobilità, di dignità e libertà, eccetera. Per soddisfare questi bisogni, anche quelli apparentemente immateriali, occorrono cose materiali: frumento e mulini, acquedotti e gabinetti, cemento e vetro per le finestre, libri e banchi di scuola, letti di ospedale, veicoli e strade, eccetera.
Tali cose materiali possono essere ottenute soltanto trasformando, col lavoro, delle materie naturali: i raccolti dei campi diventano pasta alimentare o conserva di pomodoro e queste vengono trasportate nei negozi e poi arrivano alle famiglie; i minerali vengono trasformati in acciaio e questo diventa lattine per alimenti, o tondino per le costruzioni di edifici; gli alberi vengono trasformati in carta e questa in giornali o libri.
In ciascuna di queste trasformazioni delle materie naturali in oggetti utili, capaci di soddisfare, appunto, bisogni umani, i campi perdono una parte delle loro sostanze nutritive minerali, i mezzi di trasporto immettono nell’atmosfera gas nocivi, si formano scorie e rifiuti solidi, liquidi, gassosi che finiscono nel suolo o nei fiumi o nell’aria. Una circolazione natura-merci-natura alla fine della quale i campi risultano meno fertili, le acque e l’aria più inquinate.Il “peggioramento” della qualità dell’ambiente riguarda però molto diversamente le diverse classi sociali e i diversi paesi.
Alcuni godono i vantaggi del possesso di più merci, e sono maggiormente responsabili degli inquinamenti, altri non riescono a soddisfare neanche i loro bisogni essenziali e sono danneggiati dal peggioramento dell’ambiente.
Il caso più emblematico è rappresentato dai mutamenti climatici: i paesi ricchi, con i loro elevati consumi di combustibili fossili, immettono nell’atmosfera grandi quantità di gas serra; i paesi poveri, pur avendo bassi consumi energetici, subiscono gravi danni a causa delle piogge improvvise che allagano i campi o della siccità che asciuga le limitate riserve idriche.
I paesi ricchi possono disporre di grandi quantità di alimenti di buona qualità importandoli dai paesi poveri che li ottengono da monocolture che hanno sostituito la loro agricoltura di sussistenza. I paesi ricchi importano minerali e fonti energetiche per le loro industrie da paesi poveri a cui restano terre desolate e inquinate.
Molti rifiuti solidi e inquinanti dei paesi ricchi vengono smaltiti, con processi dannosi e pericolosi, nei paesi poveri. E’ la globalizzazione capitalistica: per denaro le cose buone vanno dai paesi poveri a quelli ricchi e le nocività vanno dai paesi ricchi a quelli poveri.
Il degrado dell’ambiente ha dato vita a movimenti di protesta, ma anche la protesta ambientalista può assumere diversi colori. Ad esempio davanti ad una acciaieria inquinante alcuni chiedono di chiuderla; altri riconoscono che l’acciaio è essenziale per tanti altri settori della vita umana, può essere fatto con processi alternativi, meno inquinanti, che consentono di salvare l’occupazione.
Alla contestazione ecologica ci sono due reazioni; il potere economico si sforza di minimizzare la portata umana dei danni ambientali esaltando i vantaggi per l’economia e la gioia che viene assicurata dal possesso di crescenti quantità di merci, del superfluo e del lusso.
D’altra parte talvolta le organizzazioni dei lavoratori, davanti al pericolo che più rigorose norme ambientali possano compromettere il loro posto di lavoro, sono disposti ad accettare i danni ambientali che compromettono la salute loro, dentro la fabbrica, e quella delle loro famiglie, fuori dal cancello della fabbrica.
Per superare gli atteggiamenti populistici ed egoistici di quelli che vogliono i benefici della tecnica purché i disturbi e le nocività danneggino qualcun altro, altrove, una sinistra ha (avrebbe) di fronte una sfida che richiede la collaborazione e la solidarietà dei popoli inquinati e dei lavoratori.
Una rivoluzione che parta dall’analisi dei bisogni umani, di quelli essenziali da soddisfare anche con un costo ambientale, e dei processi e materie e mezzi con cui soddisfarli tenendo conto dei vincoli fisici imposti dal carattere limitato delle risorse della natura e della limitata capacità dei corpi della natura di ricevere le scorie delle attività umane.
Un processo difficile perché il capitale finanziario, dopo aver saziato le domande delle classi e dei paesi più abbienti, per dilatarsi inventa sempre nuovi bisogni da far credere essenziali anche alle classi meno abbienti. Ha inventato macchine che invecchiano rapidamente, che devono essere sostituite con sempre “più perfetti” aggeggi, per la cui conquista le classi povere sono disposte a svendere il proprio lavoro e talvolta anche la propria dignità.
Una situazione che Marx aveva lucidamente descritto già un secolo e mezzo fa nel terzo dei manoscritti del 1844, spiegando che nell’ambito della proprietà privata ogni uomo s’ingegna di procurare all’altro uomo un nuovo bisogno; con la massa degli oggetti cresce la sfera degli esseri ostili, a cui l’uomo è soggiogato.
Ma spiegando anche che il socialismo è l’unico sistema capace di riconoscere quali bisogni sono essenziali per liberare “l’uomo” dalla miseria e dall’ignoranza, e i processi e le materie che sono in grado di soddisfarli.
La difesa dell’ambiente — un altro volto della lotta di classe — non passa quindi da un rifiuto della tecnica ma dal rifiuto della tecnica asservita al capitale per il quale le merci non servono a soddisfare bisogni umani ma solo a generare denaro per alcuni (pochi) e nocività per altri (tanti).
Alcune nocività ambientali generate in un paese danneggiano chi abita vicino, al di là degli oceani e addirittura chi abiterà il pianeta; si pensi all’eredità che l’avventura nucleare militare e commerciale di cui hanno “goduto” (si fa per dire) alcuni paesi nell’ultimo mezzo secolo, lascia alle generazioni che verranno nei prossimi decenni e secoli costringendoli a custodire sotto stretta sorveglianza i cumuli delle scorie radioattive.
 «Una prospettiva reale al nostro paese non può non includere l’obbligo etico di investire sempre di più nella sicurezza del nostro territorio. La stretta relazione tra dissesto geologico e dissesto sociale sottolinea una disattenzione collettiva verso il territorio». MicroMega online, 23 dicembre 2016 (c.m.c.)
«Una prospettiva reale al nostro paese non può non includere l’obbligo etico di investire sempre di più nella sicurezza del nostro territorio. La stretta relazione tra dissesto geologico e dissesto sociale sottolinea una disattenzione collettiva verso il territorio». MicroMega online, 23 dicembre 2016 (c.m.c.)
In Italia non esiste una strategia di riduzione dei rischi naturali, che parta dall’educazione nelle scuole e dall’informazione alla popolazione, che preveda sistematicamente esercitazioni di emergenza, la pianificazione di interventi di rinforzo delle abitazioni, l’applicazione rigorosa delle normative edilizie, la delocalizzazione di edifici strategici e di impianti industriali a rischio.
Al momento la prevenzione in Italia viene percepita soprattutto come declamazione di luoghi comuni e slogan, puntualmente rispolverati dopo ogni tragedia. Quali sono le ragioni profonde di una tale irrazionalità fatalistica che ignora la scienza? Il nuovo campo della geoetica può dare alcune risposte.
Il 24 agosto e il 30 ottobre 2016, due forti terremoti radono al suolo numerosi centri abitati nel territorio compreso tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. L’evento di ottobre provoca distruzione anche a Norcia, fino a quel momento considerata cittadina simbolo di un’accorta azione di ricostruzione e rinforzo strutturale eseguita dopo il terremoto della Valnerina del 1979. Crolla quasi completamente la Basilica di Norcia dedicata a San Benedetto, patrono d’Europa, uno dei simboli dell’identità culturale dell’Occidente.
Con Norcia probabilmente si sfalda anche una delle immagini positive attraverso cui mostrare necessità ed efficacia della sempre invocata e mai perseguita prevenzione dai rischi naturali. Del resto, un disastro naturale è contemporaneamente causa ed effetto di un disastro sociale, nel momento in cui la scienza resta inascoltata dalla politica, anche per sua intrinseca debolezza nel saper dialogare con la società.
Di nuovo siamo di fronte a un paese colto di sorpresa dall’ennesimo terremoto, un evento naturale decisamente ricorrente sul territorio nazionale, non prevedibile temporalmente, ma dalle conseguenze quantificabili. Se da un lato la Protezione Civile ancora una volta mostra tutta la sua efficienza e tempestività, dall’altro gli effetti disastrosi sul tessuto sociale, economico, storico e artistico di nuovo denunciano l’assoluta inadeguatezza delle attività di prevenzione.
In questo momento di sconforto e rabbia, parlare di rischi naturali e prevenzione è un compito delicato, che si dovrebbe saper affrontare da angolazioni diverse, nel tentativo di individuare nuove possibili soluzioni.
La scienza e la tecnica nel cassetto
Non esiste in Italia una robusta strategia di riduzione del rischio, articolata in azioni concertate, che parta dall’educazione nelle scuole e dall’informazione alla popolazione, che preveda sistematicamente esercitazioni di emergenza, la pianificazione di interventi di rinforzo delle abitazioni, l’applicazione rigorosa delle normative edilizie, la delocalizzazione di edifici strategici e di impianti industriali a rischio. Al momento la prevenzione in Italia viene percepita soprattutto come declamazione di luoghi comuni e slogan, puntualmente rispolverati dopo ogni tragedia.
Eppure non siamo certo all’anno zero e non mancano i punti forti sui quali fare leva per costruire un patto nazionale per la prevenzione dai rischi naturali, per aumentare la consapevolezza sociale e favorire un’azione politica responsabile. Uno di questi è la conoscenza scientifica. La comunità scientifica nazionale conosce da anni la sismicità delle zone interessate dai recenti terremoti, come del resto di tutta la dorsale appenninica, avendone analizzato le caratteristiche geologiche, le informazioni di sismologia storica e i dati strumentali, e avendo messo a punto banche dati online a disposizione di tutti [1] [2] [3].
Con le dovute cautele, i terremoti del centro Italia erano per la scienza “prevedibili”, se circoscriviamo la prevedibilità all’identificazione delle aree interessate dagli eventi e all’entità dell’energia potenzialmente sprigionabile. La scienza non è ancora in grado di dire in maniera deterministica quando potrà verificarsi un terremoto, ma certamente può quantificare probabilisticamente le occorrenze all’interno di determinati periodi temporali. Altrettanto nota era la vulnerabilità di quell’edificato antico o, se relativamente recente, costruito nell’incultura delle tecniche costruttive, quando non addirittura nella negligenza delle norme antisismiche.
In fondo scienza e tecnica hanno sempre umilmente imparato dai passati disastri e migliorato i modelli e le metodologie di intervento. Eppure, osservando le macerie di quei centri abitati, sembra che scienza e tecnica restino sempre strumenti spuntati, chiusi nel cassetto polveroso dei decisori politici, per i quali quegli strumenti possono solo rappresentare un pesante fardello amministrativo, quando non addirittura la fastidiosa evidenza della propria inadeguatezza e incapacità di lavorare per il bene della comunità.
La cultura del rischio
Pericolosità e rischio sono spesso usati come sinonimi, mentre hanno accezioni diverse. La pericolosità è una caratteristica intrinseca del territorio, funzione delle sue peculiarità geologiche, morfologiche, climatiche, su cui l’uomo non può intervenire, mentre il rischio implica la presenza sul territorio di “elementi” che possono essere danneggiati (popolazione, insediamenti abitativi, attività produttive, infrastrutture, beni culturali). Per valutare concretamente il rischio non è sufficiente conoscere la pericolosità, ma occorre anche stimare attentamente il valore e la vulnerabilità dei beni presenti sul territorio. Dunque, è dal rischio che possiamo difenderci, è agendo sul rischio che si fa prevenzione [4].
Ma il rischio è qualcosa di cui abbiamo un’adeguata percezione? Quanti di noi sono realmente consapevoli di rischiare la vita in determinate situazioni? Quanti cittadini hanno un’idea del grado di vulnerabilità della propria abitazione, o almeno sono a conoscenza dei luoghi più sicuri della propria casa e del proprio centro abitato?
Un dato di fatto è che la popolazione è ancora poco informata. Ad oggi il sapere sociale di cui siamo provvisti non comprende le opportune conoscenze di base sulla pericolosità dei fenomeni naturali e sul rischio ad essa associato, nonostante alcune significative iniziative a carattere nazionale [5]. Le conoscenze che possono venirci in aiuto in una situazione di emergenza o che possono supportare la programmazione della nostra difesa dai rischi sono ancora insufficienti.
La chimera della prevenzione
L’Italia, lo sappiamo, è una terra geologicamente giovane e per questo fragile. A questo ambiente fisico difficile e pericoloso spesso si sono aggiunti incuria, disattenzione, se non addirittura interventi scellerati dell’uomo che hanno ulteriormente incrementato l’esposizione al rischio. Purtroppo questo incremento del rischio non è stato accompagnato da un aumento della percezione del rischio stesso da parte della popolazione, che di conseguenza non è in grado di comprendere fino in fondo l’importanza di pretendere dai governanti lo sviluppo di politiche di difesa e di prevenzione.
Senza trascurare in alcun modo la dimensione economica della questione [6], o l’importanza di adottare strategie di riduzione del rischio che incrementino la resilienza delle comunità umane (ovvero la loro capacità di reagire al disastro in termini psicologici, sociali, economici e culturali) e riducano l’entità dell’intervento economico dello Stato per ripristinare nei limiti del possibile lo status quo, la prevenzione è soprattutto un dovere etico che dovremmo responsabilmente assumerci per rispetto della nostra stessa umanità.
Lo afferma già nel ‘500 l’architetto Pirro Ligorio nel suo Libro di diversi terremoti [7], quando ribadisce che i terremoti non sono accidenti oscuri e ineluttabili, ma fenomeni alla portata della ragione umana e che cercare di raggiungere la sicurezza abitativa è una necessità e un dovere dell’intelletto umano. È chiaro il suo riferimento alla responsabilità dell’uomo, che trasforma i terremoti in disastri quando in modo colpevolmente responsabile non fa nulla di ciò che è nelle sue possibilità razionali per difendere vite umane, beni e attività.
Ma se la scienza, nella sua dimensione evolutiva storica, ha sempre imparato da tutti i terremoti, le alluvioni, le eruzioni e da altri eventi del passato, mettendo in discussione i suoi modelli sulla base dell’osservazione diretta di quanto accaduto, la società moderna e la politica, sua emanazione organizzativa e operativa, sembrano dimenticare sempre troppo velocemente la lezione del presente, rimandando ad un futuro remoto l’adozione di strategie di intervento a lungo termine [8].
Un terremoto, un’eruzione, un’alluvione si ripresenteranno laddove permarranno le condizioni geologiche “favorevoli” al loro accadimento. E’ solo una questione di tempo. La scienza lo ripete con forza da decenni.
Ma anche alcune forme di saggezza popolare, nate da un rapporto più autentico e osservativo con la propria terra, facevano sì che nel passato, in un centro abitato, non si costruisse dove esistevano condizioni sfavorevoli all’insediamento. Al contrario, la società moderna sembra aver ridotto la sua temporale prospettiva di azione ad un periodo molto breve, determinato costantemente dalla rincorsa al problema contingente.
Pertanto, la “cultura dell’emergenza” che domina la nostra società, non appare più come causa, ma si rivela effetto di questa incapacità di pensare al futuro. E nella difesa dai rischi naturali l’incapacità di prefigurare razionalmente un futuro possibile ci determina in un costante atteggiamento passivo nei confronti di fenomeni che hanno tempi di ritorno anche di decenni. In questo quadro di riferimento culturale, la prevenzione resta una parola vuota, senza valore.
Recuperare la memoria del passato per progettare il futuro
Ad alimentare questo stato di cose c’è forse la facilità con cui siamo soliti perdere la memoria dei disastri del passato. In Italia eventi come i terremoti sono certamente frequenti, ma gli eventi più energetici possono avere tempi di ritorno molto lunghi, di parecchie decine se non centinaia di anni. Tempi di ritorno simili superano la durata della vita di un uomo, tant’è che dopo un terremoto bastano pochi anni per dimenticare. Il tempo diluisce la memoria dell’evento e allontana la paura. E mentre quel ricordo si cancella, svanisce dalla nostra memoria anche la necessità di porre l’opportuna attenzione nell’uso delle pratiche costruttive in quelle zone particolarmente rischiose del nostro territorio.
Pensare alla possibilità di un terremoto che ha tempi di ritorno di centinaia di anni è contro la nostra esperienza comune. Tuttavia, la memoria è elemento indispensabile per entrare nella dimensione temporale dei fenomeni naturali e comprenderla. Se non dimenticheremo cosa è avvenuto nel passato, lavoreremo con maggiore convinzione per prevenire ciò che può accadere nel futuro. E in ogni caso questo non basta.
Prevenzione: ruoli e responsabilità
La prevenzione, quell’insieme di azioni mirate a ridurre il rischio, è possibile solo se ruoli e responsabilità di scienziati, tecnici, amministratori locali, politici, mass media, cittadini sono chiaramente definiti [9].
Il compito degli scienziati è fare buona scienza, capire e modellare la realtà naturale, trasferire conoscenza alle diverse componenti della società e contribuire ad orientare chi deve prendere le decisioni sul territorio. I politici hanno il dovere di attivare responsabilmente nuove azioni di governo per la tutela dei cittadini e potenziare le iniziative già in atto [10], dotandosi di validi strumenti normativi che garantiscano il rispetto di adeguati livelli di sicurezza, tarati su conoscenze scientifiche affidabili e condivise.
Ai mass media è affidato il delicato lavoro di mediare tra scienziati e società, il che richiede massima attenzione alla qualità delle informazioni raccolte e diffuse, all’attendibilità e all’autorevolezza delle fonti da cui provengono dati, modelli, teorie e notizie. Se da un lato la denuncia mediatica di inefficienze politiche è una fondamentale missione civile, dall’altro i media dovrebbero dar maggiore risalto ai risultati positivi raggiunti nella difesa dai rischi, affinché la popolazione comprenda il valore della prevenzione e dei risultati che è possibile ottenere investendo oculatamente le risorse economiche collettive.
Gli stessi cittadini devono diventare più consapevoli della loro possibilità di incidere sulla sicurezza individuale e sociale. Informarsi sulle pericolosità del proprio territorio, accertarsi che gli edifici in cui si vive abbiano caratteristiche di sicurezza adeguate, conoscere i comportamenti che possono salvarci la vita durante un’emergenza, significa contribuire alla risoluzione o al contenimento dei problemi che possono affliggere l’intera comunità.
Da un lato i cittadini hanno il diritto di pretendere che lo Stato lavori per garantire la loro incolumità, dall’altro hanno il dovere di informarsi di più, per diventare più consapevoli del valore della prevenzione e dell’importanza di investire sulla propria sicurezza, e per essere in grado di valutare e sorvegliare l’operato di chi gestisce il territorio. L’ordinata società giapponese ci insegna che il rischio, anche se non del tutto eliminabile, può essere ridotto seguendo con responsabilità e disciplina semplici comportamenti virtuosi e pratiche corrette, in modo da non dover più correre almeno quei rischi che si possono evitare.
Le ragioni profonde di una cronica incapacità di prevenzione
Ma perché in Italia la prevenzione stenta a realizzarsi? Perché nel presente è così difficile pensare al futuro del territorio che abitiamo? In una prospettiva schiacciata sul presente, siamo portati a pensare, non senza ragione, che alla base del ritardo cronico nell’avviare estese politiche di prevenzione ci siano esclusivamente la difficoltà di reperimento di adeguate risorse economiche, l’inefficienza burocratica e la miopia delle classi dirigenti di questo paese. Ma forse queste “giustificazioni” non fanno che deviare l’attenzione dalla sostanza della questione, da quello che forse è principalmente un problema culturale, favorendo il perdurare di comportamenti attendisti e fatalisti nella società italiana.
Se come cittadini continueremo a pensare che per fare prevenzione i soldi siano sempre insufficienti, che la politica sia corrotta e la burocrazia incomba come un Moloch imbattibile, allora seguiteremo a sentirci quasi moralmente sollevati dalla responsabilità di dover prendere nelle mani il nostro futuro, aspettando che nella drammaticità dell’emergenza la nostra umana richiesta di aiuto venga accolta.
Ma come è possibile che una popolazione come quella italiana, capace di grandi slanci di solidarietà nei momenti di emergenza (dal cappotto, bene di lusso nel 1951, che il semplice cittadino donava allo sfortunato fratello del Polesine, fino al volontariato infaticabile del moderno sistema di Protezione Civile), non comprenda l’importanza di affiancare all’emergenza un’azione dagli effetti più sicuri e duraturi come la prevenzione?
Viene da pensare che il criterio guida del nostro agire sia condizionato dall’abitudine culturale a rimettere il nostro destino nelle mani del fato o di Dio, e nel contempo a considerare la solidarietà verso il prossimo in difficoltà come nostro unico, sufficiente adempimento morale: questo potrebbe giustificare la coesistenza della cronica trascuratezza nella prevenzione e del formidabile efficientismo in emergenza.
In un quadro simile, anche lo sviluppo di una società della conoscenza scientifica risulta azione gravosa per la collettività, mancando quel requisito di immediata utilità e semplicità necessario in una società sempre più confinata ed orientata da un flusso amorfo e inarrestabile di tweet, post e telegiornali fotocopia.
La prevenzione: una questione culturale
La prevenzione non è una cosa semplice: è un insieme di azioni che possono svilupparsi su periodi temporali anche lunghi, che richiedono una pianificazione oculata di risorse umane ed economiche. Il monitoraggio continuo dei fenomeni, l’identificazione delle aree a rischio, l’organizzazione di campagne educative alla popolazione, l'utilizzo di metodi di pre-allertamento, gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio edilizio, la messa a punto di strumenti normativi, il coordinamento efficace tra i molteplici soggetti preposti alla difesa dai rischi, rappresentano le modalità attuative di una strategia preventiva che deve essere alla base di ogni politica del territorio.
Ma queste azioni restano insufficienti se non vi è una contemporanea azione sul piano culturale. Nella società italiana sembra mancare il riconoscimento dei valori su cui fondare il nostro agire in tema di prevenzione. La prevenzione, infatti, non è solo un vantaggio economico. E’ una risposta moderna, razionale e responsabile a quel diritto alla sicurezza che ognuno deve eticamente perseguire per se stesso e per la comunità a cui appartiene, assumendosi una parte di responsabilità, dal politico al tecnico, dallo scienziato fino al singolo cittadino.
Per costruire una vera cultura della prevenzione, occorre recuperare l’idea del territorio come bene comune, risorsa e vantaggio collettivo, elemento nel quale confluiscono gli interessi individuali e quelli di tutta la comunità. Per riconoscere il valore di quel bene per sé e per gli altri, per rispettarlo, difenderlo, conservarlo e trasmetterlo integro alle generazioni future, bisogna prima aver ricostruito all’interno della nostra comunità relazioni sociali solide, fondate su principi etici condivisi ed attuati.
Il territorio: bene comune e sostrato di identità
Una prospettiva reale al nostro paese non può non includere l’obbligo etico di investire sempre di più nella sicurezza del nostro territorio. La stretta relazione tra dissesto geologico e dissesto sociale sottolinea una disattenzione collettiva verso il territorio.
Il territorio non è semplicemente il luogo dove casualmente siamo nati o viviamo, ma è il supporto fisico delle nostre attività, una preziosa risorsa in termini economici, ma anche e soprattutto uno dei valori fondanti della nostra identità, dunque un bene da salvaguardare. Solo attraverso la riscoperta del valore identitario dei territori è possibile avviare quel cambiamento culturale che ci porti tutti a comprendere il vantaggio di perseguire politiche di tutela della bio- e geodiversità, di sviluppo di nuovi modelli economici, di valorizzazione delle specificità storico-artistiche esistenti, di prevenzione dai rischi naturali.
La conoscenza del valore del territorio è il primo mattone su cui costruire una nuova consapevolezza sociale, capace di avviare nelle nostre scuole la formazione di cittadini responsabilmente orientati verso un futuro in cui possa affermarsi un nuovo modo di pensare e gestire il territorio. Educare è già prevenire.
Geoetica: un nuovo modo di pensare e gestire la Terra
La geoetica, seppur nata e sviluppata nell’ambito più strettamente scientifico per analizzare le implicazioni etiche, sociali e culturali che accompagnano l’attività geologica, sta ormai dispiegando tutto il suo potenziale educativo e operativo, andando a comprendere problemi che investono nel suo complesso l’intera società [11]. La necessità di sviluppare un robusto quadro di riferimento di valori etici, sociali e culturali all’interno della comunità delle geoscienze è ormai esigenza inderogabile [12] [13], proprio in virtù del vasto ambito di applicazione di questo gruppo di discipline, che investigano fenomeni tra i più impattanti del nostro tempo, dai cambiamenti climatici all’inquinamento ambientale, dallo sfruttamento delle risorse ai fenomeni naturali distruttivi.
È significativo che la comunità geologica comprenda l’importanza di sviluppare, dapprima al suo interno, una nuova consapevolezza del ruolo sociale e culturale che i geologi sono chiamati a svolgere, e che tenti poi di trasmettere all’intera società un nuovo paradigma culturale.
La geoetica si sta rapidamente affermando come nuova prospettiva e modalità di intendere e relazionarsi al pianeta. Il vivace dibattito internazionale, il crescente numero di pubblicazioni dedicate alla riflessione sugli aspetti etici e sociali della ricerca e della pratica scientifica [14] [15] [16], la creazione di una grande associazione scientifica [17], che promuove la geoetica a livello nazionale e internazionale, formalmente riconosciuta come partner strategico dalle più prestigiose organizzazione di geoscienze del mondo, testimonia che qualcosa sta cambiando.
Ma la portata innovativa della geoetica va al di là del dibattito scientifico, dal momento che può fornirci le categorie corrette per discutere di prevenzione e per accrescere la consapevolezza della sua necessità sia nelle classi politiche che nella cittadinanza. La geoetica mira a costruire un quadro di riferimento di conoscenza e azione basato su valori considerati indispensabili, tenuto conto dei bisogni della società e dell’ambiente e dell’urgenza di riconsiderare il rapporto tra uomo e territorio, uomo e pianeta, un pianeta sul quale vivono ormai 8 miliardi di abitanti, che necessitano di risorse e di protezione da fenomeni naturali pericolosi.
Aristotele definisce l’etica come l’indagine e la riflessione sui valori che sono alla base del comportamento operativo dell’uomo. Per analogia la geoetica è stata definita come l’indagine e la riflessione sui valori su cui basare comportamenti corretti nei confronti del Sistema Terra [18]. Pertanto, essa ha lo scopo di identificare quei valori che devono orientare gli uomini nella gestione della Terra, alla conoscenza e al rispetto delle dinamiche naturali, ponendo particolare attenzione alla corretta e responsabile comunicazione delle conoscenze alla popolazione, inclusa l’educazione al concetto di rischio [19].
La geoetica richiama scienziati e società alle proprie responsabilità. Nella sua applicazione ai rischi naturali, essa trova una felice corrispondenza nella frase di Giuseppe Grandori (1921-2011), grande figura dell’ingegneria sismica, dotato di indubbio buon senso, che ben 30 anni fa affermava: “Difendersi dai terremoti significa ridurre le conseguenze dei terremoti (vittime e danni materiali) al di sotto di un limite che la società ritiene accettabile, tenuto conto dei costi che un’ulteriore diminuzione di tale limite comporterebbe” [20]. L’apparente cinismo che può colpire il lettore a una prima lettura, scompare una volta riconosciute nella frase la propositiva intenzionalità scientifica e la grande valenza operativa e culturale. Difendersi dai terremoti non è azione dalle sfumature fideistiche o ideologiche, ma il risultato di un percorso di conoscenza che si concretizza in un patto sociale, dove la dignità della ragione umana è un insostituibile strumento al servizio del bene comune.
In questo consiste la geoetica e la geoetica ci riguarda tutti.
* Ricercatrice dell’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia, esperta di rischi geologici, è tra le fondatrici a livello internazionale della “geoetica”. Si batte per lo sviluppo di una cultura geologica e della prevenzione in Italia.
NOTE
1. Sito Internet dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: http://www.ingv.it
2. Database Macrosismico Italiano 2015 (DBMI15), di Locati M., Camassi R., Rovida A., Ercolani E., Bernardini F., Castelli V., Caracciolo C.H., Tertulliani A., Rossi A., Azzaro R., D’Amico S., Conte S., Rocchetti E. (2016). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Fornisce un set omogeneo di intensità macrosismiche provenienti da diverse fonti relativo ai terremoti con intensità massima ≥ 5 e d'interesse per l'Italia nella finestra temporale 1000-2014: http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/query_place/
3. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 (CPTI15), di Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Fornisce dati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con intensità massima ≥ 5 o magnitudo ≥ 4.0 d'interesse per l'Italia nella finestra temporale 1000-2014: http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/query_eq/
4. Silvia Peppoloni, Convivere con i rischi naturali, 2014, p. 148, ISBN 978-88-15-25078-0, Il Mulino, Bologna.
5. Campagna di comunicazione nazionale “Io non rischio”, a cura del Dipartimento della Protezione Civile: http://iononrischio.protezionecivile.it/
6.Antonio Scalari, Terremoto e prevenzione: perché l’Italia non è come il Giappone: http://www.valigiablu.it/terremoto-prevenzione/
7. Pirro Ligorio, Libro di Diversi Terremoti, a cura di Emanuela Guidoboni, De Luca Editori D’Arte, Roma 2005.
8. Silvia Peppoloni, La lezione della terra: tutto quello che ci hanno insegnato i terremoti: http://www.corriere.it/cultura/eventi/notizie/lezione-terra-tutto-quello-che-ci-hanno-insegnato-terremoti-bec37350-9b9a-11e6-92af-45665cb81731.shtml?refresh_ce-cp
9. Peppoloni S. & Di Capua G. (2014). Geoethical aspects in the natural hazards management. In: “Lollino, G., Arattano, M., Giardino, M., Oliveira, R., Peppoloni, S. (Eds.). Engineering Geology for Society and Territory - Volume 7, Education, Professional Ethics and Public Recognition of Engineering Geology. XVII, 274 p., Springer”. http://media.wix.com/ugd/5195a5_0440718081d340228edd071b5b20fa0a.pdf
10. Struttura di missione “#italiasicura”: http://italiasicura.governo.it/site/home/italiasicura.html
11. Carlo Doglioni e Silvia Peppoloni, Pianeta Terra: una storia non finita, 2016, p. 160, ISBN 978-88-15-26376-6, Il Mulino, Bologna.
12. Peppoloni S. (2012). Ethical and cultural value of the Earth sciences. Interview with Prof. Giulio Giorello. Annals of Geophysics, vol. 55, p. 343-346, ISSN: 2037-416X, DOI: 10.4401/ag-5755. http://www.annalsofgeophysics.eu/index.php/annals/article/download/5755/6025
13. Peppoloni S. (2012). Social aspects of the Earth sciences. Interview with Prof. Franco Ferrarotti. Annals of Geophysics, vol. 55, p. 347-348, ISSN: 2037-416X, doi: 10.4401/ag-5632. http://www.annalsofgeophysics.eu/index.php/annals/article/download/5632/6026
14. Peppoloni, S. & Di Capua, G. (Eds). Geoethics: the Role and Responsibility of Geoscientists. Geological Society, London, Special Publications, 2015, 419, ISBN 978-1-86239-726-2.
15. Wyss M. and Peppoloni S. (Eds). Geoethics, Ethical Challenges and Case Studies in Earth Sciences (2014), pp. 450, Elsevier.
16. Peppoloni S. & Di Capua G. (2012). Geoethics and geological culture: awareness, responsibility and challenges. Annals of Geophysics, vol. 55, p. 335-341, ISSN: 2037-416X, doi: 10.4401/ag-6099. http://www.annalsofgeophysics.eu/index.php/annals/issue/view/482
17. Sito Internet della IAPG – International Association for Promoting Geoethics: http://www.geoethics.org
18. Peppoloni S. & Di Capua G. (2014). The meaning of Geoethics. In: “Wyss M. and Peppoloni S. (Eds), Geoethics: ethical challenges and case studies in Earth Science, 450 p., Elsevier”. http://media.wix.com/ugd/5195a5_0156301931f9429da6db4bc4843eb605.pdf
19. Peppoloni S. & Di Capua G. (2016). Geoethics: Ethical, social, and cultural values in geosciences research, practice, and education. In: Wessel G. & Greenberg, J. (Eds.). Geoscience for the Public Good and Global Development: Toward a Sustainable Future. Geological Society of America, Special Paper 520, pp. 17-21, doi: 10.1130/2016.2520(03).
20. Giuseppe Grandori, Introduzione. In: Benedetti D., Castellani A., Gavarini C., Grandori G. (a cura di), Ingegneria Sismica, Quaderni de “La Ricerca Scientifica”, n. 114, Vol. 6, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, 1987, ISSN 0556-9664.
 «No Drill president. Reazioni indispettite dalla lobby dei petrolieri che sta per fare il suo ingresso sul tappeto rosso della Casa bianca. Mentre il Canada di Trudeau aderisce alla norma di salvaguardia». il manifesto, 22 dicembre 2016 (c.m.c.)
«No Drill president. Reazioni indispettite dalla lobby dei petrolieri che sta per fare il suo ingresso sul tappeto rosso della Casa bianca. Mentre il Canada di Trudeau aderisce alla norma di salvaguardia». il manifesto, 22 dicembre 2016 (c.m.c.)
Il presidente Obama ha annunciato il divieto permanente di operare trivellazioni per l’estrazione del petrolio e del gas in una vasta area della regione artica e della costa atlantica. Per fare ciò Obama ha fatto ricorso ad un’oscura legge risalente a 63 anni fa, compiendo una mossa che il presidente entrante Donald Trump non dovrebbe essere in grado di invertire e che sicuramente non sta gradendo. La norma imposta da Obama vieta tutti i futuri contratti di locazione di petrolio e gas nel Chukchi Sea, così come nella stragrande maggioranza del Mare di Beaufort.
L’annuncio di Obama è stato seguito, poco dopo, da quello del primo ministro canadese Justin Trudeau che a sua volta ha annunciato il divieto di nuove trivellazioni off-shore in acque artiche canadesi. Queste due risoluzioni combinate creano una cintura di protezione dell’Artico e mettono di fatto in salvo una zona delicatissima e vitale per l’ambiente e valgono, da sole, più di molti trattati e buone intenzioni messe nere su bianco ma che possono essere facilmente vanificate da un cambio di presidenza, mentre il destino di questa nuova norma voluta da Obama potrà essere cambiato solo con grande sforzo dei tribunali federali a cui Trump dovrà fare ricorso per rovesciarla, in un processo lungo e non completamente prevedibile.
La legge a cui ha fatto ricorso Obama – la Continental Shelf Outer Lands Act – che gli ha dato l’autorità di agire unilateralmente, era stata già usata in passato da alcuni presidenti per proteggere temporaneamente piccole porzioni di acque federali, ma la mossa di Obama, invece, è un divieto di perforazione permanente che riguarda una zona molto vasta, e coinvolge una porzione dell’oceano che va dalla Virginia al Maine e coinvolge gran parte della costa dell’Alaska.
«Non è mai stato fatto niente del genere prima – ha dichiarato Patrick Parenteau, professore di diritto ambientale alla Vermont Law School – Non esiste quindi alcuna giurisprudenza su questo tema che coinvolge acque ancora inesplorate».
Il divieto di perforazione Obama riguarda la circa il 98 per cento delle acque artiche di proprietà federale, una regione incontaminata dove vivono molte specie in pericolo tra cui orsi polari e balene. «Queste azioni, e le azioni parallele del Canada, sono volte a proteggere un ecosistema delicato e unico che è diverso da qualsiasi altra regione al mondo – ha detto Obama nel comunicato a seguito della legge – Le azioni che abbiamo intrapreso riflettono valutazioni scientifiche. Anche con gli standard di sicurezza elevati che entrambi i nostri Paesi hanno messo in atto, il rischio di una fuoriuscita di petrolio in questa regione resta significativo mentre la nostra capacità di ripulire l’ambiente da una fuoriuscita di petrolio, viste le condizioni difficili della regione, è molto limitata».
«Permanente? Non vediamo come questo divieto possa essere permanente», ha dichiarato immediatamente dopo la diffusione della notizia, Andrew Radford, consulente senior dell’American petroleum institute, che opera per le compagnie petrolifere. Certamente molti dei nuovi attori politici messi in campo da Trump faranno tutto il possibile per rovesciare questo provvedimento, primo tra tutti il nuovo Segretario di Stato Rex Tillerson, a capo della multinazionale del petrolio Exxon ma, fanno notare i docenti di legge, non è Obama il primo ad appellarsi al Continental Shelf Outer Lands Act: Eisenhower, Nixon, George Bush e Bill Clinton hanno utilizzato quella legge per proteggere porzioni di acque federali e nessuno di questi veti è stato annullato.
Non è insolito che i presidenti vengano colti da un’urgenza nelle loro ultime settimane in carica, in questo caso è però esasperata dalla incompatibilità di vedute dei due soggetti coinvolti nel passaggio di consegne: Trump ha la dichiarata intenzione di smantellare tutto il lavoro compiuto dal suo precedessore. La scorsa settimana, l’Amministrazione Obama ha promulgato una legge che protegge economicamente i centri di pianificazione familiare federali, i Planned Parenthood, e gli altri centri sanitari che procurano aborti: entrerà in vigore due giorni prima che Trump entri alla Casa Bianca.
Stiamo continuando a distruggere tutte le componenti del pianeta Terra: la terra, l'aria, gli oceani (per non parlar dei popoli) Non riusciamo neppure a impedire i pestiferi packaging, inutili a tutti salvo ai padroni del Mercato. La Repubblica, 17 dicembre 2016
Il Mediterraneo è diventato una zuppa di plastica. Un chilometro quadro, nei mari italiani, ne contiene in superficie fino a 10 chili. È questo il record del Tirreno settentrionale, fra Corsica e Toscana. Attorno a Sardegna, Sicilia e coste pugliesi, la media è invece di 2 chili. Sono valori superiori perfino alla famigerata “isola di plastica” nel vortice del Pacifico del nord: un’area di circa un milione di chilometri quadri in cui le correnti accumulano la spazzatura dell’oceano. Qui la densità delle microplastiche - i frammenti di pochi millimetri da cui è formata la “zuppa” - è di 335mila ogni chilometro quadro. Nel Mediterraneo arriva a 1,25 milioni. Per evitarlo, tutta la spazzatura dovrebbe andare nei cassonetti anziché nell’ambiente.
L’analisi che ha riguardato i mari della penisola arriva da un gruppo di biologi del Cnr ed è pubblicata su Scientific Reports. «A finire in mare sono soprattutto i rifiuti della nostra vita quotidiana » spiega uno dei coordinatori, Stefano Aliani, che con i colleghi nel 2013 ha raccolto i campioni di spazzatura a bordo della nave del Cnr Urania. «Sacchetti e bottiglie vengono degradati dalla luce. Nel giro di anni o perfino secoli, a seconda del tipo di plastica e dell’ambiente in cui finiscono, questi rifiuti si riducono in poltiglia». I frammenti microscopici sono stati raccolti con una rete speciale trainata dall’Urania in 74 punti di Adriatico e Tirreno. «Nel complesso - scrivono i biologi nello studio - la plastica è meno abbondante nell’Adriatico, con una media di 468 grammi per chilometro quadro, rispetto al Mediterraneo occidentale » con una media di 811 grammi.
«La gravità della situazione del Mediterraneo non ci stupisce » dice Aliani. «È un mare sostanzialmente chiuso, in cui una particella ha un tempo di permanenza di circa mille anni. Teoricamente, cioè, impiega tutto quel tempo per attraversare la stretta imboccatura di Gibilterra. Nelle sue acque sboccano anche fiumi importanti come Danubio, Don, Po e Rodano». Anche se i mari diventano sempre più torbidi (si calcola che dei 300 milioni di tonnellate all’anno di plastica prodotta nel mondo, una dozzina finiscano in mare), quale sia la sorte di buona parte della spazzatura resta un mistero. «Non sappiamo dove sia oggi tutta la plastica che abbiamo prodotto » spiega Aliani. «Quella che ritroviamo nelle nostre spedizioni non si avvicina neanche lontanamente all’ammontare che secondo i nostri calcoli dovrebbe essere finito in mare. Può darsi che molta si perda in fondo agli oceani, dove non abbiamo la possibilità di osservarla».
La responsabilità delle zuppe marine va in buona parte al packaging non riciclabile. In Europa scatole e involucri contribuiscono al 40% della produzione di questo materiale e a più del 10% dei rifiuti. Il 92% della plastica trovata in mare è composta da frammenti di meno di 5 millimetri. Tracce sono comparse in Artide e Antartide. Sono finite inglobate in alcune rocce (un campione dei cosiddetti “plastiglomerati” è stato osservato alle Hawaii nel 2014) e si sono infilate nei sedimenti dei fondali oceanici. Questo materiale è perfino stato proposto come uno dei segni distintivi dell’antropocene, l’era geologica caratterizzata dai segni della presenza umana sulla Terra.
«Per l’ecosistema marino, i danni sono molteplici» conferma Aliani. «Il pericolo più evidente per gli animali è il soffocamento ». Ma questi frammenti possono anche essere ingoiati dal plancton, le minuscole creature che si trovano alla base della catena alimentare del mare. In Spagna è nata un’azienda - la Ecoalf - che raccoglie sacchetti e bottiglie finiti nelle reti dei pescatori e li ricicla producendo vestiti. «Il problema non è solo la plastica in sé» prosegue il biologo del Cnr. «Mancano studi approfonditi, ma si pensa che questo materiale sia inerte per gli organismi ». Più pericolose sono le sostanze che alla plastica vengono combinate durante i processi industriali, per fornirle le caratteristiche volute. «Potrebbero agire come pseudo-ormoni, creando scompensi nel sistema endocrino. Abbiamo osservato il problema nelle balene».
 «E' quanto emerge dal 12° Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano di Ispra. Il report aggiorna per tutti i 116 capoluoghi di provincia italiani un insieme di indicatori fondamentali per valutare la qualità ambientale delle città e della vita nelle aree urbane italiane». Il Fatto Quotidiano online, 16 dicembre 2016 (c.m.c.)
«E' quanto emerge dal 12° Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano di Ispra. Il report aggiorna per tutti i 116 capoluoghi di provincia italiani un insieme di indicatori fondamentali per valutare la qualità ambientale delle città e della vita nelle aree urbane italiane». Il Fatto Quotidiano online, 16 dicembre 2016 (c.m.c.)
Dall’inquinamento da polveri sottili, migliorato nei primi mesi del 2016 rispetto al 2015 (un vero e proprio anno nero), allo stato del suolo e del territorio italiano con 2 milioni di persone a rischio alluvioni e oltre 22mila frane censite. Sono questi alcuni degli aspetti affrontati nel 12° Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano di Ispra, l’Istituto di ricerca del Ministero dell’Ambiente e del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente.
Dai fattori demografici, alla qualità dell’aria, dalla mobilità alle risorse idriche, fino al suolo e ai rifiuti: il report aggiorna per tutti i 116 capoluoghi di provincia italiani un insieme di indicatori fondamentali per valutare la qualità ambientale delle città e della vita nelle aree urbane italiane. Si tratta del primo rapporto a essere presentato dopo l’approvazione della legge 132 del 28 giugno 2016 (che entrerà in vigore il 14 gennaio 2017), che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), costituito da Ispra, Arpa e Appa.
Fattorisociali ed economici
In Italia, al 31 dicembre 2015, i residenti erano circa 60 milioni e 665mila, oltre 130mila in meno rispetto all’anno precedente. La diminuzione della popolazione residente ha interessato 87 dei 116 comuni presi in esame, più di tutti Roma (-7.290) e a Torino (-6.244). Al contrario i residenti sono aumentati maggiormente a Milano (8.696), Parma (2.552). L’incidenza dei cittadini stranieri è massima nei comuni capoluogo di provincia di Milano, Brescia, Prato e Piacenza dove più di 18 residenti su 100 sono stranieri. Anche nel 2015, la densità della popolazione è più alta a Napoli, seguita da Milano e Torino. Nel Comune di Roma, il più esteso dei comuni italiani, risiede circa il 5% della popolazione nazionale. Dal punto di vista economico di segno positivo, anche per il 2015, è il tasso di crescita delle imprese (0,2 punti percentuali in più rispetto al 2014) che, grazie al saldo positivo di 45mila nuove imprese, a livello nazionale ha raggiunto lo 0,7%. I nuovi imprenditori ‘under 35’ hanno contribuito con 66.202 nuove unità, 32mila sono quelle create dagli stranieri e 14.300 dalle donne.
Qualitàdell'aria
Un capitolo del dossier è dedicato al rapporto tra inquinamento atmosferico e salute, sulla base degli studi più recenti in materia e sottolinea che l’aria che respirano milioni di italiani nelle maggiori città della Penisola rappresenta ancora un grave problema di salute. Per quanto riguarda l’inquinamento da polveri sottili, al 13 dicembre 2016 almeno 18 capoluoghi di provincia hanno già superato il limite giornaliero per il pm10 (Frosinone, Venezia e le altre città della pianura padana le peggiori. Ma anche Napoli e Terni).
I dati sono migliori rispetto a quelli del 2015, quando 45 aree urbane su 95 non hanno rispettato il valore limite giornaliero del pm10. Sempre lo scorso anno, il 90% della popolazione nei comuni considerati è risultato esposto a livelli medi annuali superiori al valore guida dell’Organizzazione mondiale della Sanità per il pm10, l’82% a quello del pm 2,5, il 27% a quello del biossido di azoto. “Emerge chiaramente – rileva il rapporto – la notevole distanza dagli obiettivi dell’Oms” e, quindi “non sorprende il fatto che nelle stime recentemente elaborate dall’Agenzia Europea per l’Ambiente l’Italia figuri tra le nazioni con gli indici di rischio sanitario più elevati”.
Rischio alluvioni e frane
Uno dei principali elementi di pericolo per il territorio è costituito dai fenomeni di dissesto idraulico. Le conseguenze risultano in genere più pesanti in quelle aree dove l’intervento dell’uomo ha profondamente modificato il territorio e il paesaggio naturale, rendendoli più fragili e vulnerabili. La popolazione a rischio alluvioni è stimata in 1.950.954 abitanti, pari all’11,1% della popolazione residente totale nei 116 comuni.
Le città nelle quali è stato individuato un maggior rischio sono quelle lungo i grandi fiumi italiani (Po, Tevere, Arno) o in aree di pianura, oltre alla città di Genova. Dodici comuni capoluogo hanno più di 50mila abitanti a rischio. “Altro fenomeno di grande impatto – spiega il rapporto – sia per l’incolumità della vita umana che delle per i danni a infrastrutture ed edifici, è quello dei fenomeni franosi”. L’11,5% dell’area totale dei comuni censiti è compreso in aree a pericolosità da frana e in aree di attenzione dei Piani di Assetto Idrogeologico, il 3,3% se riduciamo l’analisi a quelle soggette a maggiori rischi e, quindi, a vincoli di utilizzo del territorio più restrittivi.
In questa pur ridotta percentuale di territorio vivono attualmente circa 170mila abitanti, pari all’1% della popolazione totale dei comuni capoluoghi di provincia. Nel 2015 sono 22.270 le frane censite nell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia che ricadono nel territorio dei 116 Comuni capoluoghi di provincia. I comuni con più abitanti a rischio frane sono: Napoli, Genova, Massa, Chieti, Palermo, Catanzaro, Salerno, Caserta, Siena, Lucca, Trento, Grosseto, Ancona, La Spezia e Campobasso. Ma il fenomeno rappresenta un rischio anche per i beni culturali: 1.117 sono a rischio, ovvero l’1,9% di quelli che si trovano nelle aree prese in esame.
Risorse idriche e balneabilità
Tra il 2012 e il 2015, nelle 116 città prese in esame si è registrata una riduzione dei consumi idrici dell’8,4%, ma nel 2015 è stata registrata una dispersione reale dell’acqua immessa nella rete di distribuzione del 35,4%. In 90 città si hanno valori di dispersione di rete reali superiori al 20%, di cui 18 superiori addirittura al 50%. Per la stagione balneare 2016, i monitoraggi confermano che la quasi totalità dei tratti costieri dei 9 capoluoghi costieri di Regione, monitorati da Snpa, è idonea alla balneazione. Diversi i dati sui pesticidi. Per il 2014 riguardano complessivamente 79 capoluoghi: su 160 punti di monitoraggio nelle acque superficiali, 26 (16,2%), relativi a 18 città, hanno livelli di concentrazione superiore ai limiti.
 «Sovranità alimentare. Una ventina di realtà disseminate dalla Lombardia alla Sicilia, un'organizzazione al tempo stesso di produzione e di lotta, sul modello dei Sem terra brasiliani». il manifesto, 15 dicembre 2016 (c.m.c.)
«Sovranità alimentare. Una ventina di realtà disseminate dalla Lombardia alla Sicilia, un'organizzazione al tempo stesso di produzione e di lotta, sul modello dei Sem terra brasiliani». il manifesto, 15 dicembre 2016 (c.m.c.)
C’è chi produce salsa di pomodoro e chi coltiva arance, chi fa il cioccolato e chi il caffè. Si tratta per il momento di una ventina di realtà disseminate dalla Lombardia alla Sicilia, dalla Puglia alla Toscana. Le ha unite la presa di coscienza del fatto che se vuoi tentare di produrre in maniera diversa, cioè rispettando la dignità delle persone e l’ambiente, e vuoi sottrarre migranti e non dal ricatto del caporalato e dello sfruttamento, devi unirti, ché da solo non ce la fai.
E ciò vale soprattutto in un settore come quello dell’agricoltura, in cui a dare le carte, cioè a stabilire prezzi e quindi, a cascata, condizioni di lavoro e retribuzioni, è la grande distribuzione, che punta a pagare il meno possibile i prodotti che finiranno negli scaffali dei supermercati. È nata così la rete Fuorimercato, che di recente ha tenuto a Milano la sua terza assemblea nazionale e che nel prossimo mese di febbraio vedrà il suo quarto incontro a Rosarno (Reggio Calabria), dove si trova una delle realtà aderenti alla rete, «Sos Rosarno».
Ma che cosa è fuorimercato? È da un lato un insieme di realtà che combattono, producendo, sfruttamento delle persone e dell’ambiente in campo agricolo. Dall’altro una serie di spacci, anche questi sparsi un po’ in tutta la penisola, che distribuiscono i beni prodotti che finiscono anche in mercati popolari e nelle liste dei Gruppi d’acquisto solidale di molte zone del nord Italia.
Detta così sembra facile, ma le difficoltà sono più d’una. Per questo Fuorimercato si sta tentando di strutturare come un’organizzazione al tempo stesso di produzione e di lotta. I modelli sono quelli del movimento dei Sem terra brasiliani e del Soc Sat andaluso, un sindacato che nella regione del sud della Spagna difende gli interessi dei braccianti. E qui si arriva a un altro pezzo del dna di Fuorimercato. Che oltre a essere una rete di produttori e di punti di distribuzione dei beni alimentari, è anche il tentativo di costruire un’alternativa.
«Siamo partiti dai bisogni», dice Gigi Malabarba di Rimaflow, una fabbrica lombarda che produceva per il settore automobilistico e che dopo essere stata rilevata dai lavoratori è stata riconvertita a «cittadella dell’altraeconomia» e oggi fa parte di Fuorimercato. I bisogni e i diritti cui tenta di fare fronte la rete sono tanti: quello dei migranti a un lavoro pagato dignitosamente e a un tetto decente sulla testa; quello dei braccianti e dei piccoli produttori italiani a non essere strangolati dai prezzi decisi da chi sta in alto. E quello dei consumatori di mangiare cibo decente e non avvelenato. Si tratta di cose diverse ma che si tengono insieme le une con le altre, e a Fuorimercato tentano di farlo. Come? «Con il mutuo soccorso», dice Gianni De Giglio di Sfrutta Zero, realtà pugliese attiva nel lavoro con i migranti.
Mutuo soccorso. Un salto all’indietro agli albori del movimento operaio per guardare al futuro: sorreggersi gli uni agli altri per evitare di farsi spazzare via dai giganti e garantire e garantirsi un’alternativa fatta di rispetto dei diritti, salubrità dell’ambiente e bontà del cibo. Ma se cerchi l’alternativa sei a tutti gli effetti una realtà anche politica.
Così, questo strano animale che è Fuorimercato, si sta attrezzando per fare del mutuo soccorso una leva per agire a 360 gradi: dal punto di vista della produzione per tentare di tenere sotto controllo tutta la filiera: «Per quanto riguarda coltivazione e trasformazione dei prodotti, ci siamo; la logistica e i trasporti invece sono le criticità, perché ad esempio per trasportare gli agrumi servono i tir, che noi non abbiamo; e sai, se riesci a dare continuità alle produzioni e alla filiera, crei anche lavoro e più in generale dai maggiore solidità a tutta l’organizzazione», dice Malabarba. «E affidarci ai corrieri non ci piace», aggiunge De Giglio. Perché? «Perché l’alternativa dev’essere completa, non ci possono essere coni d’ombra: non possiamo produrre e trasformare i nostri prodotti seguendo certi principi e poi affidarci per la loro spedizione a realtà che operano in modi che non condividiamo e che anzi combattiamo.
Così Rimaflow sta dando una mano fungendo da magazzino e consentendo così di fare meno spedizioni dal sud al nord e ottimizzando i periodi in cui si dispone di mezzi garantiti in mutuo soccorso da altri.
L’altro versante è quello delle vertenze: per l’accesso alle terre e per il diritto alla casa, innanzitutto, sia dei migranti che dei nativi. E anche qui si tenta di fare mutuo soccorso. Così, se una delle realtà della rete dispone di competenze al suo interno su un singolo settore, le mette a disposizione di tutti. Agronomi, avvocati, commercialisti, esperti di web e quant’altro, attivi in uno dei nodi, diventano patrimonio di tutti. Insomma, «tentiamo di costruire l’alternativa praticandola, facendone vedere i frutti – dice Malabarba – perché la teoria da sola non basta».
Ma non solo. Alla base di Fuorimercato c’è proprio la volontà di costruire un’altra economia. Che a partire dalle emergenze più stringenti, quella dei migranti sfruttati dal caporalato particolarmente virulenta al sud, si allarghi ad altri settori della produzione e della distribuzione di beni e servizi. Per questo, dopo tre incontri nazionali e in vista del quarto, si sta mettendo in piedi il coordinamento nazionale, nel quale un paio di rappresentanti di ognuno dei nodi dovranno tenere il filo dei rapporti tra la rete e le singole realtà. E, a proposito di mutuo soccorso, si sta apprestando una «cassa comune» che consenta di sopperire alle esigenze primarie di Fuorimercato.
Anche magari quelle derivanti dalle vertenze aperte. «Il tentativo è di coniugare l’aspetto mutualistico e quello del conflitto, perché per cambiare le cose sono necessari entrambi», dice De Giglio.
Ancora una volta: un passo indietro alle radici che resero saldo il movimento operaio, e sguardo avanti, «liberandosi dalle differenziazioni che spesso hanno minato le possibilità di alternativa per tuffarsi nel fare», chiosa Malabarba.
 «L'allarme. Sui tavoli della Cop22 irrompono gli ultimi dati diffusi dall’Organizzazione metereologica mondiale. Il 2016 ha tutte le carte in regola per divenire l'anno più caldo di sempre». il manifesto, 15 novembre 2016 (c.m.c.)
«L'allarme. Sui tavoli della Cop22 irrompono gli ultimi dati diffusi dall’Organizzazione metereologica mondiale. Il 2016 ha tutte le carte in regola per divenire l'anno più caldo di sempre». il manifesto, 15 novembre 2016 (c.m.c.)
Non vi è nulla di realmente nuovo o inatteso nell’allarme lanciato ieri sui tavoli della Cop22 dalla Wmo, l’Organizzazione metereologica mondiale. In un comunicato diffuso durante la giornata di apertura della 2a settimana di lavori a Marrakech, l’agenzia Onu ha confermato che il 2016 ha tutte le carte in regola per divenire l’anno più caldo di sempre. Si tratterebbe del terzo record di fila dopo i primati registrati dal 2014 e dal 2015.
Nello specifico l’aumento è di 0,88° in più rispetto al periodo 1961-90 e di ben 1,2 gradi in più rispetto all’epoca pre-industriale. Un aumento che rende sempre più vicina la soglia +1,5°, considerata da molti la soglia massima da non superare per garantire la sopravvivenza di ampie regioni del pianeta.
Il trend esponenziale delle temperature globali è confermato anche da un altro dato: 16 dei 17 anni più caldi sono stati registrati proprio nel XXI secolo. Aumentano inoltre gli eventi climatici estremi, inondazioni e ondate anomale di calore.
A ottobre la Wmo aveva diffuso altri dati riguardanti il raggiungimento delle 400 ppm (parti per milione) di Co2 in atmosfera. La novità rispetto al passato è che tale quantità non si registra più soltanto in alcune zone e per periodi particolari, ma a livello globale e lungo l’intero anno ed è destinata a non scendere per diverse generazioni.
Il segretario generale della Wmo Petteri Taalas ha aggiunto che in alcune regioni artiche della Russia si registrano temperature di 6-7 gradi superiori alla media, mentre sono salite di 3 gradi le temperature di altre regioni settentrionali, tra cui Alaska e Canada nordoccidentale. Il 21 luglio 2016 la società meteorologica Wunder Ground aveva diffuso il dato record registrato a Mitribah, in Kuwait: una temperatura di 54°. Se questi trend verranno confermati, il continente africano potrebbe letteralmente bruciare.
La desertificazione minaccia un quarto delle terre del pianeta e un miliardo di persone allocate in circa 110 paesi, ma è in Africa che si registra la situazione più drammatica. La siccità in Somalia ha portato a un +32% della popolazione malnutrita e a 431.000 rifugiati in Kenya, cui si uniscono i 300.000 profughi interni. Secondo la Banca Mondiale, con un aumento delle temperature medie globali tra +1,5° e +2° tra il 40% e l’80% delle terre agricole dell’Africa subsahariana non sarà più adatto alle coltivazioni di mais, miglio e sorgo già tra il 2030 e il 2040. A causa delle minori rese agricole stima un aumento tra i 35 e i 122 milioni di persone in condizioni di povertà estrema.
Una delle conseguenze sociali più drammatiche connesse ai dati sopra elencati riguarda il crescente fenomeno delle migrazioni climatiche: nel 2015, su 27,8 milioni di sfollati interni, 14,7 milioni sono stati determinati da eventi climatici estremi. Il rapporto The Human Cost of Weather Related Disaster afferma che, negli ultimi 20 anni, i disastri naturali sono stati determinati per il 90% da eventi climatici estremi. Tra i paesi più colpiti anche Cina, Filippine, Indonesia e Usa.
Oltre ai rischi interni, gli Stati Uniti rischiano di dover affrontare l’aumento dei migranti provenienti dal Messico: secondo le stime saranno 900.000 le persone in più spinte ogni anno verso la frontiera dal deserto che avanza sul 60% del territorio messicano. La domanda è d’obbligo: Trump è davvero convinto di poter affrontare queste emergenze investendo con una mano nell’energia fossile e con l’altra edificando attorno al paese migliaia di km di muro di cinta?
«A venticinque anni dalla sua approvazione, il Senato, snaturandone i presupposti, approva modiche inadeguate alla legge sulle aree protette che ha garantito la conservazione della natura e la salvezza di una parte cospicua del territorio italiano». Carteinregola online, 14 novembre 2016 (c.m.c.)
Il 10 novembre il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di modifica della legge 394/91 sulle aree protette (in calce in download), che adesso passerà alla Camera. 17 associazioni che si sono battute per apportare miglioramenti al testo hanno diramato un comunicato stampa che denuncia i numerosi e preoccupanti punti critici, dalla modifica della governance delle aree protette in cui viene prevista la presenza di portatori di interessi specifici, all’assenza di competenze specifiche in tema di conservazione della natura di Presidente e Direttore degli Enti Parco, alla mancata definizione di strumenti di partecipazione dei cittadini e la mancata previsione di comitati scientifici, a una norma che attraverso la “gestione faunistica”, con la governance prevista, acuirà le pressioni del mondo venatorio, al mancato divieto delle esercitazioni militari nei parchi e nei siti natura 2000…
COMUNICATO
«Né il Senato, né il Governo hanno accolto le osservazioni e le proposte di 17 Associazioni Ambientaliste e di centinaia di esperti e uomini di cultura, che hanno criticato in modo fermo e elaborato proposte migliorative. Risultato: una riforma sbagliata che chiediamo con forza venga modificata alla Camera».
Così le Associazioni subito dopo il voto con cui Palazzo Madama ha approvato, in prima lettura, il disegno di modifica della legge 394/91 sulle aree protette.
«Non volendo cogliere il senso costituzionale che vede la tutela della natura in capo allo Stato, la riforma non valorizza il ruolo delle aree protette come strumento efficace per la difesa della biodiversità e non chiarisce il ruolo che devono svolgere le Comunità del Parco.
Un testo che doveva rafforzare il ruolo e le competenze dello Stato centrale nella gestione delle aree marine protette, ma che in realtà continua a lasciare questo settore nell’incertezza e senza risorse adeguate.
Perché non possiamo non sottolineare che questa riforma viene fatta senza risorse, che la legge approvata non riesce a delineare un orizzonte nuovo per il sistema delle aree protette e senza migliorare una normativa che, dopo 25 anni di onorato servizio, non individua una prospettiva moderna per la conservazione della natura nel nostro Paese».
Numerosi e tutti molto preoccupanti sono i punti più critici del disegno di legge approvato al Senato:
Una modifica della governance delle aree protette che peggiora la qualità delle nomine e non razionalizza sufficientemente la composizione del Consiglio direttivo, in cui viene prevista la presenza di portatori di interessi specifici e non generali come deve essere. Non vengono definiti strumenti di partecipazione dei cittadini né la previsione di comitati scientifici;
Una governance delle Aree marine Protette che non prevede alcuna partecipazione delle competenze statali e individua Consorzi di gestione gli uni diversi dagli altri;
L’assenza di competenze specifiche in tema di conservazione della natura di Presidente e Direttore degli Enti Parco;
Un sistema di royalties che, pur legato ad infrastrutture ad alto impatto già esistenti, deve essere modificato per evitare di condizionare e mettere sotto ricatto i futuri pareri che gli enti parco su queste dovranno rilasciare;
Una norma che attraverso la “gestione faunistica”, con la governance prevista, acuirà le pressioni del mondo venatorio;
L’istituzione di un fantomatico Parco del Delta del Po senza che venga definito se si tratti o meno di un parco nazionale, quando peraltro la costituzione di questo, come Parco Nazionale, è già oggi obbligatoria ai sensi dalla legge vigente;
Non si vietano le esercitazioni militari nei parchi e nei siti natura 2000;
Non si garantisce il passaggio delle Riserve naturali dello Stato, del personale e delle risorse impegnato, ai parchi.
Sono alcuni dei motivi che fanno di questa riforma una riforma sbagliata, incapace di dare soluzioni ai problemi delle Aree Protette, ma addirittura tale da avvicinare troppo sino a sovrapporre pericolosamente i portatori d’interesse con i soggetti preposti alla tutela, svilendo la missione primaria delle aree protette e mettendole in ulteriore sofferenza.
Alla luce di ciò, gli elementi utili introdotti dalla riforma, soprattutto in termini di pianificazione, di classificazione e gestione dei siti della rete Natura 2000, di considerazione dei servizi ecosistemici, appaiono sostanzialmente depotenziati.
«Abbiamo dato la massima disponibilità al confronto, elaborando argomenti seri e proposte dettagliate. Con infinito rammarico siamo costretti a dover prendere atto di mancate risposte del relatore, della maggioranza e del Governo, con il risultato doppiamente negativo di perdere l’opportunità di miglioramenti costituzionalmente coerenti e di determinare un grave scollamento tra la politica italiana ed un approccio alla conservazione della natura coerente alle indicazioni ed agli obblighi internazionali», continuano le Associazioni ambientaliste che concludono:
«A venticinque anni dalla sua approvazione, il Senato, snaturandone i presupposti, approva modiche inadeguate alla legge sulle aree protette che ha garantito la conservazione della natura e la salvezza di una parte cospicua del territorio italiano. La questione ora si sposta alla Camera dei Deputati dove le Associazioni Ambientaliste faranno di tutto per far sentire una voce va ben oltre loro e coinvolge tutto il mondo della cultura e della scienza del nostro Paese».
Le associazioni che hanno chiesto modifiche al Senato
Ambiente e Lavoro
AIIG – Associazione Insegnanti di Geografia
Club Alpino Italiano
Centro Turistico Studentesco
Ente Nazionale Protezione Animali
FAI – Fondo Ambiente Italiano
Greenpeace Italia
Gruppo di Intervento Giuridico
Italia Nostra
LAV – Lega Antivivisezione
Legambiente
Lipu
Marevivo
Mountain Wilderness
Pro Natura
SIGEA
WWF Italia
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45868.htm
http://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2016/11/Modifiche-alla-legge-6-dicembre-1991-n.-394.pdf
«Mentre proseguono i lavori della conferenza sul clima di Marrakech (Cop22), “le politiche infrastrutturali, energetiche e di gestione dei rifiuti varate da Renzi sono in assoluta contraddizione con gli impegni di riduzione assunti nell’ambito dell’accordo di Parigi”». Il manifesto, 9 novembre 2016 (m.p.r.)
Il ragazzo si contraddice un giorno sì e l’altro pure. Non mantiene le promesse. Ma questa volta la questione è più seria del solito, perché stiamo parlando degli impegni presi dall’Italia per contrastare il riscaldamento globale. «Quella dei cambiamenti climatici - disse Matteo Renzi al Climate Summit di New York del settembre 2014 - è la sfida del nostro tempo, lo dice la scienza, non c’è tempo da perdere: la politica deve fare la sua parte. I nostri figli attendono che a Parigi l’accordo sia vincolante». Appunto. Sono trascorsi due anni, l’accordo di Parigi (COP21) è entrato in vigore cinque giorni fa e l’Italia è tra quei 60 paesi che formalmente si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 (l’obiettivo nostrano è stato fissato al 33%). Tutto bene? Non proprio.
L’inadeguatezza delle politiche energetiche messe in campo dal governo risulta evidente alla lettura del fitto dossier L’Italia vista da Parigi-Impegni internazionali e politiche nazionali per la lotta ai cambiamenti climatici preparato dall’associazione A Sud e dal Centro Documentazione Conflitti Ambientali (Cdca). La pubblicazione fa il punto della situazione proprio mentre a Marrakech stanno entrando nel vivo i lavori della COP22, la conferenza sul clima dove 170 paesi dovranno dotarsi di regole e strumenti per agire nell’immediato visto che gli anni tra il 2011 e il 2015 sono stati i più caldi mai registrati a livello globale, come documentato dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm). Un dato drammatico che dovrebbe spingere i paesi a fare di più per rispettare l’obiettivo minimo di mantenere l’aumento della temperatura entro 1,5 gradi.
Il dossier, spiega Marica di Pierri, presidente del Cdca e curatrice del rapporto, mette a fuoco alcuni provvedimenti del governo - tra cui il decreto Sblocca Italia, il decreto Spalma Incentivi e il decreto Inceneritori - e sottolinea perché “le politiche infrastrutturali, energetiche e di gestione dei rifiuti varate da Renzi sono in assoluta contraddizione con gli impegni di riduzione assunti nell’ambito dell’accordo di Parigi”. Un’evidenza che ancora ieri non ha impedito al ministro dell’Ambiente Galletti di affermare che l’Italia “farà di tutto per rendere ancora più ambizioso quell’accordo”. Nient’altro che dichiarazioni di rito a fronte di politiche che moltiplicano gli investimenti per lo sfruttamento delle energie fossili, per le infrastrutture per il trasporto su gomma e per l’incenerimento dei rifiuti.
Lo dice il “calendario” dei principali provvedimenti approvati in Italia nell’ambito della Strategia Energetica Nazionale (Sen) varata dal governo Monti nel 2013. Nel dicembre dello stesso anno il governo Letta autorizza l’erogazione di incentivi per 20 anni per la realizzazione di una centrale nel Sulcis, in Sardegna (secondo uno studio pubblicato a luglio, nel 2013 in Europa le emissioni delle centrali a carbone hanno causato più di 22.900 morti premature, decine di migliaia di casi di malattie e costi sanitari stimati in circa 62 miliardi di euro). Nel cosiddetto decreto “Spalma incentivi”, convertito in legge dal governo Renzi nell’agosto 2014, vengono ridotte le risorse per gli impianti fotovoltaici e i risultati sono evidenti: i nuovi impianti nel 2012 erano 150 mila, l’anno scorso 40 mila.
Non è tutto. Il decreto “Sblocca Italia” – convertito in legge nel settembre 2014 con un voto di fiducia e fortemente avversato da opposizioni e associazioni ambientaliste – di fatto si presenta come la negazione dell’accordo di Parigi. Gli articoli 36, 37 e 38 – si legge nel rapporto – incoraggiano l’attività estrattiva per mezzo della formula di rito che identifica le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come “operazioni di interesse strategico e di pubblica utilità, urgenti e indifferibili” (è la storia, triste, del referendum sulle trivellazioni dello scorso 17 aprile, con Matteo Renzi che ha tifato per l’astensione). Lo stesso decreto sblocca alcuni cantieri per un valore di 28 miliardi e 866 milioni, soprattutto per opere autostradali e aereoportuali. E ancora. L’articolo 35 sembra un inno alla CO2 e promuove la costruzione di nuovi inceneritori definiti come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell’ambiente” (un altro decreto, del 10 agosto 2016, poi individua otto aree in cui realizzare inceneritori).
L’elenco dei provvedimenti climalteranti del governo Renzi potrebbe continuare, ma ce n’è abbastanza per dire che l’Italia per essere credibile di fonte alla sfida del riscaldamento globale non può far altro che dotarsi di un nuovo piano energetico. Secondo gli autori del rapporto le soluzioni esistono e l’azione del governo dovrebbe rispettare una regola molto semplice: “Ogni legge o provvedimento che riguardi produzione di energia, infrastrutture, utilizzo dei suoli, trasporto o gestione dei rifiuti deve avere come punto di riferimento gli obiettivi dell’accordo di Parigi, ogni politica che anziché favorire la diminuzione ne produce incremento deve essere abbandonata”. E se la volontà politica manca, come è evidente, dovrebbero essere i cittadini a battersi e a vigilare, anche servendosi di azioni legali. Insomma è un problema di democrazia, e anche in questo caso manca come l’aria (per scaricare il dossier: asud.net e cdca.it).

Note sulla Laudato si' e sulla Dichiarazione islamica sul clima. Convergenze significative su questioni fondamentali in un mondo dominato troppo a lungo da un'ideologia dissipatrice del pianeta e devastatrice dell'umanità, e guidato da una politica asservita al mondo della finanza e al mito della crescita. Casa della cultura, Milano, online, 3 novembre 2016
Nell'enciclica Laudato si' Papa Francesco tratta le sfide più grandi che l'umanità si trova ad affrontare con sorprendente sintonia con la visione islamica del mondo e del ruolo che questa conferisce all'uomo che, secondo l'Islam, è quello di Vicario di Dio sulla terra, "khalifat-Allah fil-ard".
"E [ricorda] quando il tuo Signore disse agli angeli: 'Io porrò un vicario sulla terra'. Essi dissero: 'Metterai su di essa chi vi verserà la corruzione e spargerà il sangue, mentre noi Ti glorifichiamo lodandoTi e Ti santifichiamo?'. Egli disse: 'In verità, Io conosco quello che voi non conoscete'. E insegnò ad Adamo i nomi di tutte le cose e quindi le presentò agli angeli e disse: "Ditemi ora i loro nomi, se siete sinceri". [Sura Al Baqara, La Vacca, versetti 30-32]. In questi versetti è esemplificato il rapporto dell'uomo con la creazione nel pensiero islamico, dove il Vicario di Dio sulla terra deve preservare quanto affidatogli perché la terra è ciò che Dio ha creato ed affidato in custodia (amana). L'uomo dovrebbe quindi comprendere e meditare quanto la natura sia intimamente connessa a Dio poiché Sua creazione e la sua tutela diventa perciò un dovere religioso. Il richiamo all'intelletto umano, alla sua capacità di discernimento e di cogliere il divino è una costante nella narrazione coranica. "Non riflettono sui cammelli e su come sono stati creati, sul cielo e come è stato elevato, sulle montagne e come sono state infisse, sulla terra e come è stata distesa? Ammonisci dunque ché tu altro non sei che un ammonitore..." [Il Corano, Sura Al Ghashiah, L'Avvolgente, versetti 17-21].
Nel primo capitolo dell'enciclica il Pontefice ricorda che «un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale» e ingiunge ad ascoltare «tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri». Parole che trovano perfetta adesione con gli ideali islamici di giustizia sociale ed eguaglianza. Troviamo una profonda consonanza con quanto scritto nell'Enciclica sin dal primo capitolo - Quello che sta accadendo alla nostra casa - dove il Papa richiama a una profonda riflessione sulla condizione attuale del pianeta terra. Nella denuncia dei disastri ambientali provocati dall'uso scriteriato delle risorse in un mondo sempre più ingiusto e dalle disparità sociali devastanti che arrivano addirittura a privare una considerevole parte dell'umanità del diritto naturale all'acqua, il Papa tocca le corde più profonde del pensiero dei musulmani e temi su cui i più attenti si battono da tempo. Il Corano infatti conta infiniti passi sulla natura e sul creato, fino ad arrivare a una descrizione della storia della terra: «Non vedono dunque gli empi che i cieli e la terra erano un tempo una massa confusa e noi li abbiam separati, e dall'acqua abbiam fatto germinare ogni cosa vivente? E ancora non credono? E ponemmo sulla terra montagne immobili, che la terra non si scotesse sotto i piedi degli uomini, e ponemmo fra i monti dei passaggi, a guisa di strade, che gli uomini potessero dirigersi nel loro cammino, e ponemmo il cielo come un tetto saldamente tenuto. Eppure essi s'allontanano dai Nostri Segni sdegnosi! E pure è Lui che ha creato la notte e il giorno, e il sole e la luna, ciascuno navigante nella sua sfera" [Il Corano, Sura al Anbiya, i Profeti, versetti 30-33].
Nel secondo capitolo - Il Vangelo della creazione - Bergoglio riporta le parole dei vescovi del Paraguay molto significative: «Ogni contadino ha diritto naturale a possedere un appezzamento ragionevole di terra, dove possa stabilire la sua casa, lavorare per il sostentamento della propria famiglia e avere sicurezza per la propria esistenza». Questi diritti umani trovano un corrispettivo sharaitico alla base della giurisprudenza islamica: i maqasid al shari'ah, ovvero gli scopi ultimi dell'Islam, che sono la tutela della persona e della sua integrità (himayat al nafs wa himayat al 'ird), e qui ecco il contadino, la tutela della sua famiglia (himayat al nasl), della sua proprietà (himayat al mal).
Nel terzo capitolo - La radice umana della crisi ecologica - il Papa riporta il discorso sull'uomo e le sue responsabilità nella devastazione della terra a causa di un'ideologia relativista e "usa e getta" che mette il denaro al primo posto: un malinteso antropocentrismo che ha fatto credere agli uomini di potersi disconnettere dal Creatore e disporre a piacimento della Sua creazione senza porci alcun limite. Un monito che trova eco nel versetto coranico: «Ma non osservano il cielo sopra di loro come l'abbiam edificato e abbellito e senza fenditura alcuna? E la terra l'abbiamo distesa e vi infiggemmo le montagne vi facemmo crescere ogni specie di meravigliosa vegetazione: invito alla riflessione e monito per ogni servo penitente. Abbiam fatto scendere dal cielo un'acqua benedetta, per mezzo della quale abbiamo fatto germinare giardini e il grano delle messi e palme slanciate dalle spate sovrapposte" [Il Corano Sura Qaf, versetti 6-10].
Nel quarto capitolo Francesco ci richiama a quel fondamentale concetto che è il 'bene comune', base del nostro agire collettivo e pluralista, che richiede l'impegno di tutti per favorire la creazione di società più armoniche. Qui riporta le significative parole dei Vescovi del Portogallo - «L'ambiente si situa nella logica del ricevere. È un prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla generazione successiva» - per passare poi a interrogarsi su che tipo di mondo vogliamo per chi verrà dopo di noi. Nella denuncia del «principio della massimizzazione del profitto», il pensiero dell'enciclica incontra l'approccio islamico alla finanza, che proibisce gli interessi sul denaro ed è in radicale disaccordo con il terribile meccanismo del debito pubblico che schiaccia i paesi più poveri.
Rivolgendosi a un'ampia platea il Papa ha trovato larghi riscontri tra i credenti musulmani, specialmente nelle fasce più impegnate e colte. Per aderire all'appello lanciato da Papa Francesco nella Laudato si', al termine di un simposio internazionale che si è tenuto a Istanbul il 17 e il 18 agosto del 2015, è stata redatta la Dichiarazione islamica sul cambiamento climatico. La questione su cui è incentrata è quella del cambiamento climatico, altre questioni ecologiche sono citate in modo secondario. Si tratta probabilmente di una scelta strategica: il documento ha avuto forse lo scopo di esercitare una qualche influenza sui lavori della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si sarebbe poi tenuta a Parigi nel dicembre 2015. Il preambolo della Dichiarazione descrive i motivi che hanno determinato la stesura del documento che prende le mosse dall'affermazione dottrinale che Dio ha creato il mondo. Il paragrafo successivo fornisce un'interpretazione teologica del fenomeno del cambiamento climatico: esso - in sintesi - sarebbe il risultato del nostro fallimento esistenziale nell'assolvere al dovere dell'uomo di curare e tutelare il creato, cioè al nostro ruolo di khalifa di Dio sulla terra: «Egli è Colui Che vi ha costituiti vicari della terra» [Il Corano, Sura al-An'am, Il Bestiam, versetto 165].
La tesi di fondo della Dichiarazione è che invece di coltivare quella terra che Dio ci ha donato e affidato, l'abbiamo danneggiata abusandone. In termini analoghi alla Laudato si', il testo affronta il tema dell'"equilibrio delicato della terra" e del nostro essere "inseriti nel tessuto del mondo naturale". Seguono alcuni paragrafi in cui si mette in evidenza la gravità della situazione attuale e si esprime allarme rispetto a quanto poco è stato fatto in vista di una sua soluzione. Subito dopo una serie di affermazioni dottrinali - per la maggior parte semplici espressioni coraniche della signoria di Dio sulla creazione - viene tessuto un discorso complessivo volto ad affermare che la cura per l'ambiente è una preoccupazione intrinseca dell'Islam. «Le stelle e gli alberi prostrano» [Il Corano, Sura Al Rahman, Il Misericordioso, versetto 6], «a Dio si prostrano quanto è nei cieli e quanto è sulla terra, il sole, la luna, le stelle, le montagne, gli alberi, e le bestie» (Sura Yunus, Giona, versetto 18).
Tutti i musulmani vedono nei comportamenti del Profeta Mohammad la parola definitiva sulla giusta condotta. È inevitabile che il suo comportamento debba essere invocato a sostegno delle affermazioni della Dichiarazione. Alcuni suoi tratti vengono richiamati come una guida per portarci verso l'armonia. Il testo fa dunque riferimento anche alla semplicità dello stile di vita di Maometto (tra cui il suo parco uso di carne), alla sua raccomandazione di proteggere le scarse risorse del deserto come l'acqua, e di costruire santuari per la protezione della vita animale e vegetale.
La Dichiarazione islamica sul cambiamento climatico si conclude con una serie di appelli: ai negoziatori della Conferenza delle Nazioni Unite, cui chiede di condurre i colloqui per raggiungere dei risultati soddisfacenti; ai Paesi ricchi, che vengono esortati a farsi carico della parte preponderante dell'onere finanziario di una graduale eliminazione dei combustibili fossili; alle persone di tutte le nazioni, incoraggiate a rinunciare ai combustibili fossili e ad adottare le fonti di energia rinnovabile elaborando un nuovo modello di benessere che non danneggi il pianeta. L'appello del Papa trova perciò una eccezionale consonanza nel mondo islamico e stimola una riflessione che può e deve avvicinare gli uomini e le donne di buona volontà a qualsiasi religione appartengano. Il richiamo all'ecologia è un appello a una società più impegnata e meno materialista: ora è necessario agire tutti insieme per affermare il primato del pianeta terra e degli esseri umani su quelle logiche economiche che stanno distruggendo il mondo.
Nota del curatore. - Paolo Gonzaga è traduttore, giornalista freelance e analista politico. Laureato in Lingua e Letteratura Araba alla Facoltà di Lingue Orientali dell'Università di Ca' Foscari, ha vissuto in Egitto dal 1998 al 2004. Qui ha lavorato come Lettore di Lingua e Letteratura Italiana all'Università di El Minia e ha collaborato con il Consolato Italiano del Cairo come traduttore e mediatore culturale (fonte: Arab media Report). Nel 2011 ha pubblicato il libro: Islam e democrazia. I fratelli musulmani in Egitto (Torino: Ananke) e attualmente dirige il master dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: "Fonti, storia, istituzioni e norme dei tre monoteismi: ebraismo, cristianesimo e islam". (Renzo Riboldazzi)
«Che senso ha dunque interrogarsi sul futuro dell’agricoltura in un pianeta sempre più caldo se non ci si chiede anche e soprattutto come possiamo sfamare il mondo senza surriscaldarlo ulteriormente?» La Repubblica, 5 novembre 2016 (c.m.c.)
Il prossimo 7 novembre si aprirà a Marrakech la ventiduesima Conferenza delle Parti (Cop) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sinteticamente detta Cop22. La ventiduesima da quel 1994 in cui i governi si trovarono per ratificare gli Accordi di Rio. Obiettivo principale di quest’anno sarà dare seguito agli accordi siglati lo scorso dicembre a Parigi, che hanno rappresentato un passaggio storico, ancorché perfettibile, nella salvaguardia di un futuro per l’uomo su questo pianeta.
A distanza di quasi un quarto di secolo dal primo incontro, in Marocco farà finalmente il suo ingresso al tavolo dei negoziati anche l’agricoltura, buona ultima. Lasciando da parte l’amara constatazione che averci messo così tanto per comprendere la centralità della produzione alimentare nell’impatto sul cambio climatico non rende onore alla lungimiranza dei governanti del mondo, bisogna tuttavia anche segnalare un vulnus nell’impostazione della Cop22: se infatti finalmente all’ordine del giorno compare la produzione alimentare, questa è presente principalmente come comparto minacciato dalla crisi ambientale in atto.
Questo è senza dubbio vero, ma è un discorso monco se non si tengono presenti le responsabilità che questo settore ha nell’accelerare lo stesso cambiamento climatico. L’agricoltura (intesa nella sua accezione più ampia e dunque fatta anche di allevamento e pesca) incide sulle emissioni di gas serra per un terzo del loro valore complessivo, una cifra enorme che supera l’intero settore dei trasporti o della produzione di elettricità. Si può ignorare questo fattore? Volendo andare più nello specifico, poi, scopriamo come il 14,5% delle emissioni totali di gas serra sia dovuta alla sola produzione di carne. È evidente che questo modello di produzione non ha futuro, e che se vogliamo incidere oggi dobbiamo per forza di cose intervenire anche qui.
La Fao avverte che se il trend di consumo di carne proseguirà ai tassi attuali, entro il 2050 la quantità di carne prodotta e consumata raddoppierà dai livelli attuali, con le conseguenze che possiamo facilmente immaginare. Che senso ha dunque interrogarsi sul futuro dell’agricoltura in un pianeta sempre più caldo se non ci si chiede anche e soprattutto come possiamo sfamare il mondo senza surriscaldarlo ulteriormente? Di questo devono parlare i nostri governanti riuniti in Marocco. Altrimenti sarà l’ennesimo buco nell’acqua o poco più.
È necessario promuovere un modello alimentare differente, è necessario sensibilizzare a un minor consumo di proteine animali ma di migliore qualità, bisogna incentivare metodi di allevamento che siano a basso impatto ambientale, a ciclo chiuso e non intensivi, agroecologici e attenti al benessere animale. E attenzione, queste esperienze non sono da inventare, alcune esistono da migliaia di anni e ancora oggi rappresentano la grande maggioranza dell’intera produzione mondiale (l’agricoltura familiare produce ancora oggi il 70% del totale del cibo sul pianeta).
Fatte queste considerazioni sorge però spontanea un’altra riflessione: chi ha la responsabilità di fare il primo passo? Chi deve avviare per primo un percorso di contrazione? La risposta è una e una sola: i paesi dell’occidente industrializzato e ricco. Si sente da più parti affermare che Cina e India o altri paesi in via di sviluppo, vista la loro popolazione enorme e in crescita, dovrebbero rallentare e non imitare gli stili di consumo del nord ricco. Ma come si può essere credibili con un discorso di questo tipo? I paesi ricchi sono stati fino ad ora e sono ancora i principali responsabili delle emissioni e dunque del cambiamento climatico.
Questo è un fatto. E allora ci vuole un gesto di coraggio e di onestà, tocca a noi rivedere i nostri consumi e i nostri modelli di produzione, tocca a noi segnare la strada per un cambiamento effettivamente promettente per il futuro, tocca a noi tracciare una nuova traiettoria di sviluppo possibile per tutti, senza giocare al gioco dell’“iniziate voi e noi vi seguiamo”.
La ventiduesima Conferenza delle Parti è una nuova opportunità che va colta una volta per tutte, non possiamo certo permetterci di attendere altri ventidue anni nell’attesa che qualcuno si decida ad agire.
«“La crisi ecologica nasce dalla nostra separazione da ‘madre natura’. Ogni anello della catena della biodiversità è minacciato di privatizzazione e mercificazione”. Arriva in libreria “La Terra ha i suoi diritti”, l’ultimo libro-intervista di Vandana Shiva. Ne pubblichiamo un estratto dal capitolo “Pace, democrazia, attivismo”». Il Fatto Quotidiano, 3 novembre 2016 (p.d.)
Si parla di guerra per indicare campi di battaglia come la Siria, la Libia, l’Ucraina, l’Iraq o l’Afghanistan. Ma la più grande guerra che attualmente si combatte è quella contro il nostro pianeta. Poche multinazionali cercano di assicurarsi il controllo delle risorse della Terra in spregio dei più elementari limiti etici ed ecologici. La nostra acqua, i nostri geni, le nostre cellule, i nostri organi, le nostre conoscenze, la nostra cultura e il nostro futuro sono direttamente minacciati come su un campo di battaglia tradizionale. Non vede l’onnipresenza e la retorica guerriera dell’agroindustria? Che diventa palese quando si citano i nomi degli erbicidi di Monsanto: Roundup (“retata”, “razzia”), Machete, Lasso (“lazo”). Le industrie che producevano veleni ed esplosivi per uccidere durante le guerre sono le stesse che oggi fabbricano prodotti agrochimici. Negli anni Sessanta, Monsanto produceva in particolare l’Agente Arancio, scaricato dall’aviazione statunitense sulle foreste vietnamite durante la guerra per avvelenare gli alberi e gli uomini che essi proteggevano. Oltre ai numerosi tumori e malformazioni provocati all’epoca, molti altri casi fanno ancor oggi la loro comparsa.
I pesticidi hanno origine nelle armi chimiche: è utilizzando il cloro durante la Prima guerra mondiale (per esempio nell’iprite) che sono state messe in evidenza le proprietà insetticide dei composti a base di cloro, in seguito abbandonati, tra cui il Ddt, largamente diffuso prima di venire proibito. In seguito, l’ingegneria genetica ha preteso di offrire un’alternativa ai prodotti tossici. In realtà ha incrementato l’utilizzo di pesticidi ed erbicidi. Intanto gli Stati sostengono sempre di più i grandi gruppi nella loro marcia verso l’accaparramento delle risorse. È emerso un potere che coalizza Stato e industria per imporre le sue priorità al pianeta e ai popoli. Lo constatiamo senza timore di smentita in India, dove l’esercito è regolarmente chiamato a intervenire per espropriare le popolazioni che risiedono sui territori adocchiati dalle imprese. Ma il metodo è identico quando manifestanti greci o spagnoli subiscono gli assalti delle forze dell’ordine anche se non fanno che denunciare un’evidenza: le crisi economiche, alimentari, finanziarie sono lì a dimostrare che il sistema è agli sgoccioli e che una crescita senza limiti è impossibile su un pianeta dalle risorse limitate.
Gli scienziati hanno annunciato che siamo entrati in una nuova era: l’Antropocene. Ciò significa che le conseguenze chimiche, urbane, nucleari dei nostri stili di vita rimarranno incise negli archivi geologici del pianeta per migliaia di anni.
Eppure, anche tra quanti ammettono questa verità e il dato che l’umanità si trova in un’impasse esistono quelli che reagiscono ancora in maniera bellicosa, per esempio con la geoingegneria. Si rifiutano di abbassare le armi per lasciare che la natura si rigeneri e auspicano una lotta tecnologica contro i fenomeni naturali. Progettano interventi su grande scala per influenzare il sistema climatico e rallentare il riscaldamento: avvolgere la Terra di particelle di solfato per raffreddare il pianeta, inseminare di ferro gli oceani per stimolare il fitoplancton, o catturare il carbonio accumulato nell’atmosfera.
Manipolazioni che sono frutto di una totale mancanza di umiltà e di un’arroganza illimitata. Sono il sintomo di una perversione etica ed ecologica. Chi le promuove vede nell’uomo, una volta di più, il proprietario e padrone della natura, non un elemento che ne fa semplicemente parte. Di conseguenza, difendere i diritti della Terra Madre è la lotta più importante, tanto per l’ambiente come per i diritti umani e la giustizia sociale. Tenendo conto di tale contesto, è questa la lotta con le maggiori chance di portare a una pace duratura e a una situazione di stabilità.
«
L’elaborazione concettuale di un’indiscutibile emergenza non può cancellare la necessità di un lavoro in un tempo diverso, non deve diventare rimozione frettolosa e superficiale delle complessità che le macerie portano con sè». comune-info.net, 1 novembre 2016 (i.b.)
In pochi secondi una scossa di terremoto può sconvolgere la vita e l’aspetto di un paese. Un cambiamento drastico, brutale, istantaneo. Un terremoto può cancellare gran parte del nostro mondo e imporci di ripartire quasi da zero, per recuperare quanto perduto, al più presto. Vista così, alcune strade da percorrere possono sembrare obbligate, altre possono apparire logiche, rassicuranti. Ma forse in questo quadro manca qualcosa. Forse osservando meglio, potremmo eliminare alcune illusioni prospettiche. La prima distorsione nella nostra visione abituale riguarda il tempo del terremoto.
Una scossa dura pochi secondi: quel che accade spesso è così veloce da non darci modo di reagire opportunamente, di renderci conto chiaramente; in pochi secondi avviene qualcosa di assolutamente sconvolgente e totalmente “trasformante”. Però il tempo del terremoto non è quel che noi vediamo: sotto terra, il terremoto cresce e si prepara in moltissimi anni, in tempi geologici, con forze gigantesche e lentissime. Non possiamo pensare di rispondere a tempi così lunghi, forze così grandi, trasformazioni così profonde, con azioni rapide, soluzioni veloci, senza lunghe preparazioni. La prospettiva del nostro dialogo col terremoto non può che essere in tempi lunghi.
L’idea delle soluzioni in emergenza è in parte obbligata (non si possono lasciare persone che hanno perso tutto in condizioni di difficoltà e vuoto!), ma non deve cancellare la necessità di un lavoro nel tempo, non deve diventare rimozione e fretta.
Riguardo al tempo del terremoto c’è un’altra caratteristica che a volte sembra sfuggirci: i terremoti non “arrivano”, i terremoti ritornano. Il tempo del terremoto è circolare.
Dove un terremoto c’è già stato, lì ci sarà di nuovo. Il terremoto tornerà. Dopo il tempo necessario a riprepararsi, che non sappiamo quanto sarà e che per lo più sarà così lungo da far perdere memoria del terremoto precedente, il terremoto tornerà. Ma il fatto che i tempi lunghi ci facciano perdere memoria, non vuol dire che i terremoti del passato non siano esistiti. E se il tempo del terremoto è circolare, allora noi dovremmo provare a entrare nella sua ruota per dialogare con lui: dovremmo imparare a ricordare, a guardare le cicatrici che lascia e i segni che tramanda, a confrontarci giorno dopo giorno, a prepararci per il prossimo incontro.
Tempi lunghi, circolarità continua e “irregolare” (perché circolare non vuol dire che i terremoti hanno una “scadenza” esatta!): non siamo abituati a ragionare in questo modo sui terremoti, perché il dolore, il trauma, ci spingono a rispondere velocemente e poi rimuovere. Ma questa strada non può funzionare, perché il terremoto ha un suo carattere e dobbiamo farci i conti. Poi ci sono altre illusioni che sarebbe opportuno rimuovere. Prima fra tutte l’illusione della continuità: dopo uno sconvolgimento così doloroso e profondo com’è un terremoto, la tentazione di ricostruire tutto esattamente com’era, per dimenticare la sofferenza e la perdita, può essere forte. Ma è una tentazione che ci fa uscire dalla realtà (il cambiamento c’è stato, la perdita è irrimediabile) e ci rende difficile l’elaborazione e il ricordo. Inoltre il cambiamento, anche senza terremoto, è necessario e fisiologico: il terremoto ci costringe a un’evoluzione che dobbiamo provare a “governare”, facendoci tutte le domande che ci faremmo se il cambiamento l’avessimo indotto noi stessi.
Nel ricostruire dopo un terremoto dovrebbe essere normale chiedersi (come faremmo in qualsiasi altra ricostruzione): cosa c’era che non andava più bene(che non era più adatto, funzionale, “bello”) in quel che c’era prima? Cosa avrei voluto cambiare e cosa voglio cambiare? Come posso recuperare le cose che erano davvero importanti, costruire quelle che mancavano e tenere traccia della mia storia, incluso quest’ultimo evento?
Quel che per lo più succede ora, dopo un terremoto, è che nell’immediato si costruiscono strutture (che a volte permangono a lungo!) del tutto avulse dal corpo dell’abitato precedente, generando a volte un tessuto urbano frastagliato, sconvolto, confuso.
Poi si pretende di ricostruire “com’era prima”, immaginando di cancellare non solo il cambiamento e le perdite, ma anche l’adattamento mentale e psicologico cui i cittadini hanno dovuto ricorrere per gestire la confusione del dopo. Per non parlare dell’idea di ricostruire “dov’era”, che può essere ancora più folle, perché a volte gli edifici cadono proprio perché erano costruiti nel posto sbagliato!
Possiamo lavorare per una continuità che conservi memoria nella trasformazione, ma non possiamo puntare all’immutabilità, per il semplice fatto che l’immutabilità non esiste. C’è un’altra illusione, un’altra tentazione che rischia di farci perdere di vista la realtà e la complessità: l’illusione dell’azzeramento del rischio. Nei tempi lunghi di cui parlavamo è bene lavorare alla riduzione del rischio, agendo sul contesto e con le persone: lavorare per rendere i luoghi in cui viviamo più sicuri e soprattutto lavorare continuamente nelle comunità, per aumentare consapevolezza, responsabilità, collaborazione, capacità di leggere il territorio e di prevenire e reagire. Ma nei tempi tesi e veloci dell’emergenza l’idea di ricostruire un contesto che guardi solo alla sicurezza, mettendola avanti ad ogni altra cosa e immaginando di poter regalare alle comunità una situazione “a rischio zero”, è non solo un’illusione, ma una prospettiva destinata a produrre seri danni. Innanzitutto perché azzerare il rischio non è possibile: ci confrontiamo continuamente con rischi di ogni genere e continueremo a farlo, sempre.
Possiamo lavorare per ridurre il rischio “oggettivo”, concentrandoci su un rischio specifico (quello sismico, ad esempio), ma non possiamo prescindere dalla necessità di imparare a confrontarci col rischio, con tutti i rischi con cui siamo continuamente chiamati a misurarci. Immagiamo, per paradosso, una comunità convinta di vivere in un ambiente in cui il rischio è stato azzerato, convinta che sia la tecnologia a proteggere gli esseri umani dai rischi: che capacità svilupperanno i cittadini di osservare, di analizzare, di scegliere? E che faranno quando incontreranno, come inevitabilmente capiterà, un pericolo?
È ovvio che nella ricostruzione dopo un terremoto si punti alla massima sicurezza, ma per farlo non è necessario né accettabile dimenticare dimensioni altrettanto importanti (la vivibilità, la bellezza, la felicità). L’ultima illusione che vogliamo sottolineare è l’illusione dei salvatori e dei salvati. È l’illusione più pericolosa, perché (a volte) nasce da sentimenti nobilissimi e assolutamente da coltivare: empatia, solidarietà, collaborazione. E nasce anche da una necessità: nell’emergenza servono persone capaci, competenti, per agire rapidamente e bene, per salvare vite, per valutare i danni e predisporre soluzioni.L’emergenza in Italia viene gestita bene; il sistema di Protezione Civile è efficiente e fa quel che va fatto. Ma la nostra cultura impone anche ai terremoti le sue regole, che non è detto siano le regole adatte. La nostra cultura prevede che, soprattutto in casi estremi, siano solo gli “esperti” a dover decidere ed agire, il che sarebbe anche ragionevole, se fra gli esperti si includessero coloro che “hanno fatto esperienza” di quel che si deve affrontare. La nostra cultura non prevede più reazioni e soluzioni “spirituali” e comunitarie, ma solo soluzioni personali, pratiche e dall’alto.
Cosa succede dopo un terremoto? Sul territorio e fra le persone colpite calano esperti, decisori, curatori, volontari che risolvono la situazione, assistendo le vittime. Il territorio, già sottratto ai suoi dal terremoto, viene ulteriormente allontanato, nascosto; le persone colpite diventano definitivamente vittime, passive, mentre altri risolvono per loro (e spesso sono le stesse persone colpite ad aspettarsi che qualcuno da fuori risolva per loro la situazione). Tralasciamo l’ipotesi di scelte sbagliate (quando non truffaldine) e concentriamoci solo sui ruoli che i diversi soggetti si trovano ad interpretare: come si può uscire da uno sconvolgimento così grande se non ci si misura con esso? Se non si mettono in campo le proprie risorse, se non ci si connette con i nostri amici-vicini e se non si riconquista il proprio territorio?
Un tempo c’erano riti e momenti codificati per questa riconquista di relazioni e spazi: processioni, assemblee. Oggi la dimensione “spirituale” è sostituita da quella psicologica, che però lavora troppo spesso per risolvere i traumi dei singoli. Ma la dimensione del terremoto non è singola, è collettiva: il terremoto colpisce le comunità e solo dalle comunità può essere affrontato, nei suoi aspetti pratici, come in quelli emotivi, psicologici e spirituali. D’altra parte, perché una comunità che fa esperienza di un terremoto possa essere protagonista delle scelte e della ricostruzione, questa comunità deve esistere, riconoscersi, sapersi muovere come comunità prima del terremoto e prima dell’emergenza, ma da noi su questo aspetto (la famosa resilienza!) non si lavora, né come forma di prevenzione né come nient’altro.
Quindi, nonostante l’emergenza e le sue indiscutibili necessità, nonostante il desiderio di risolvere in fretta per superare il dolore, nonostante quel che apparentemente ci sembra normale e logico fare, ci converrebbe guardare anche oltre, per non trovarci di nuovo, al tempo del prossimo terremoto, impreparati.
Flaminia Brasini e Delia Modonesi, ConUnGioco onlus, da molti anni si occupano di educazione per la riduzione del rischio. Girano l’Italia in lungo e in largo, dal Friuli alla Sicilia, per incontrare bambini, ragazzi, insegnanti e cittadini che si confrontano col terremoto. “Proponiamo strumenti di scoperta e condivisione per capire, elaborare e decidere insieme. Abbiamo lavorato a lungo con ragazzi e insegnanti delle scuole di L’Aquila nel post emergenza e di svariate scuole dei comuni colpiti dal terremoto dell’Emilia. Esperienze e persone da cui abbiamo imparato molto”.

«Privatizzazioni. Nel disegno di legge sul servizio idrico, si assiste all’assoluta soppressione del modello dell’azienda speciale, l’unico modello di gestione dei servizi autenticamente pubblico, ancora vigente nel nostro ordinamento». il manifesto, 29 ottobre 2016 (c.m.c.)
La Camera dei deputati nell’aprile del 2016, in prima lettura, ha privatizzato il servizio idrico integrato. Tale voto si pone in assoluto contrasto con la legge di iniziativa popolare che voleva la gestione dell’acqua attraverso enti di diritto pubblico.
Proviamo adesso a fare una simulazione, immaginando già di stare in un modello costituzionale che attribuisce soltanto ad una camera il potere legislativo, con un Senato, composto da 95 personaggi in cerca di autore, impreziositi da 5 legionari del presidente della Repubblica.
Cosa succederebbe in ordine alla gestione dell’acqua? Non ci sarebbe più la possibilità di impedire che il referendum sull’acqua bene comune venga calpestato e con esso la volontà di 27 milioni di cittadini che nel giugno del 2011 votarono contro la svendita dei servizi pubblici essenziali.
Ecco, se malauguratamente dovesse vincere il Sì, quali sarebbero i primi ed immediati effetti nefasti della riforma costituzionale: annullare luoghi di rappresentanza, di discussione, di conflitto. Il bicameralismo perfetto, che in passato, proprio attraverso la tanto deprecata “navetta”, era riuscito a recuperare “sbandate” o “atti di forza” di una delle due camere, non potrà più svolgere quest’azione di ripensamento e di pressione contro indirizzi politici dominanti.
Riavvolgiamo il nastro e vediamo in che contesto si andrebbe ad inserire una non auspicabile riforma costituzionale. Come è noto, sono in corso di approvazione la legge per la gestione del servizio idrico integrato ed il decreto delegato Madia sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
In questo scenario, il 10 agosto u.s. è stato approvato dal Consiglio dei ministri il cd. decreto Madia 1, meglio conosciuto come Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, concepito con l’obiettivo dichiarato di privatizzare le società partecipate, anche quelle che erogano servizi essenziali (il c.d taglia partecipate).
Il fil rouge di tali normative è di calpestare gli esiti del referendum del 2011, di privatizzare e commercializzare i servizi pubblici locali; di sotterrare definitivamente il concetto di impresa pubblica, in evidente contrasto con la parte economica della nostra Costituzione.
Addirittura si indica il ricorso al mercato come criterio di preferenza per l’attribuzione di risorse pubbliche. Ad appena cinque anni dal referendum abrogativo, mentre alcune amministrazioni, quale Napoli, tra mille difficoltà, attuano la volontà referendaria (costituzione di Abc Napoli), Governo e Parlamento stanno costruendo un sistema normativo che ripropone in maniera ancora più virulenta il progetto Berlusconi-Ronchi del 2008.
Il progetto di riforma Madia 2 sui servizi di interesse economico generale esclude che i servizi a rete, quale è l’acqua, possano essere affidati a soggetti di diritto pubblico, come l’azienda speciale.
Siamo in presenza di un progetto normativo che si contrappone anche alla Corte costituzionale che nel 2012, evocando il rispetto della sovranità popolare e degli esiti referendari, aveva enunciato il vincolo referendario, stabilendo che il legislatore dovesse rispettare quanto espresso dai cittadini.
Nel disegno di legge sul servizio idrico, si assiste all’assoluta soppressione del modello dell’azienda speciale, l’unico modello di gestione dei servizi autenticamente pubblico, ancora vigente nel nostro ordinamento. Ovvero, si nega ai comuni, alle autorità d’ambito, anche in contrasto con il diritto europeo, la possibilità di poter scegliere un modello alternativo al mercato.
Il progetto è quello di privatizzare le grandi società pubbliche ex municipalizzate presenti nel nostro Paese (Iren, A2A, Acea, Hera) e porre il territorio italiano sotto il loro dominio e a loro volta della finanza, anche tossica , che le sostiene, da quando si ventilarono i falsi paradisi delle privatizzazioni.
Ma impedire che soggetti di diritto pubblico, quali le aziende speciali, possano gestire servizi pubblici essenziali, è un’operazione non conforme e non compatibile con la Costituzione. Rappresenta un tradimento della volontà popolare e dell’inequivoco risultato politico espresso, che aveva fortemente voluto, tra l’altro, l’abrogazione della clausola della remunerazione del capitale investito, proprio quella che spinge capitali e finanza a gestire l’acqua, a prescindere dalla qualità del servizio, della tutela delle risorse naturali, degli investimenti nelle infrastrutture.
Ma sono violati anche principi di diritto europeo, quali la sussidiarietà verticale e la libertà di definizione, impedendo ai comuni di scegliersi il modello di gestione più adeguato ed opportuno al proprio territorio ed alla propria realtà socio-economica, così come previsto, tra l’altro, dall’art. 106 del Trattato.
Un disegno politico talmente aggressivo da essere incoerente con il principio di neutralità del diritto dell’Unione europea rispetto al regime della proprietà ed ai modelli di gestione, che attribuisce ai comuni il potere fornire ed organizzare i propri servizi d’interesse economico generale e di attivare un “reale” regime pubblicistico in deroga alla regola della concorrenza.
Il ministro Madia ha detto che l’acqua non c’entra con il decreto e comunque il governo non intende privatizzarla. Bene, allora si suggerisce di procedere in tal senso:
1) presenti come emendamento del governo nel dibattito al Senato, relativo al disegno di legge sull’acqua, un emendamento all’art. 7 che preveda espressamente la modalità di gestione del servizio attraverso un ente di diritto pubblico;
2) stralci dallo schema di Decreto Madia 2 la gestione delle risorse idriche, come tra l’altro ha vivamente suggerito di fare la commissione affari costituzionali della Camera in sede consultiva.
Nel caso il quadro normativo rimanesse immutato, i comuni potrebbero scegliere l’acqua pubblica fondando la propria azione amministrativa direttamente sul diritto europeo il che non escluderebbe anche ricorsi dinanzi alla Corte costituzionale, che potrebbero attivare anche il comitato referendario per l’acqua bene comune del 2011, sollevando conflitto di attribuzioni contro gli atti posti in essere da parlamento e governo.
 «Il titolo della legge, attesa in aula al Senato, promette di tutelare le aree protette cambiando governance e regole. Insorgono 17 associazioni ambientaliste sostenendo che i partiti e gli interessi locali si spartiranno poltrone e non sapranno arginare le brame di industriali, petrolieri e cacciatori.». Il Fatto Quotidiano online, 24 ottobre 2016 (c.m.c.)
«Il titolo della legge, attesa in aula al Senato, promette di tutelare le aree protette cambiando governance e regole. Insorgono 17 associazioni ambientaliste sostenendo che i partiti e gli interessi locali si spartiranno poltrone e non sapranno arginare le brame di industriali, petrolieri e cacciatori.». Il Fatto Quotidiano online, 24 ottobre 2016 (c.m.c.)
Le mani della politica sui parchi, sempre più ostaggio di spartizioni e interessi locali, con un presidente e un direttore che possono non saperne niente di ambiente e si ritrovano esposti alle pressioni dei privati che pagano royalty per inquinare, costretti poi – al momento del rinnovo delle concessioni – a scegliere tra la conservazione della natura senza compromessi e la possibilità di intascare qualche euro per far fronte alle croniche ristrettezze economiche.
È questo, secondo gli ambientalisti, il destino dei parchi nazionali d’Italia se il testo della riforma della legge sulle aree protette, approvata lo scorso 20 ottobre dalla commissione Ambiente del Senato e atteso in aula, non verrà modificato. «Questa riforma non fa altro che accentuare il politicismo dei parchi indebolendo il loro ruolo principale che è la tutela della natura», denuncia il direttore del Wwf Gaetano Benedetto, sintetizzando la posizione di 17 associazioni ambientaliste che hanno diffuso un documento con tutte le modifiche necessarie perché la legge non tradisca nei fatti i buoni propositi enunciati dal relatore Massimo Caleo, vicepresidente Pd della commissione ambiente. «Il Parlamento ha saputo mettere a punto un provvedimento che finalmente aggiorna la legge sui parchi alle nuove esigenze degli enti, rafforzando le finalità di conservazione dell’ambiente e aprendo nuove opportunità di sviluppo sostenibile», ha annunciato il senatore in pompa magna subito dopo il voto, lasciando sconcertate le associazioni.
In balia degli interessi locali
A mettere in allarme gli ambientalisti è la modifica delle regole sulla composizione dei consigli direttivi dei parchi, uno degli organi principali nella gestione delle aree protette soprattutto per tutte le questioni economiche. Oggi la metà dei membri vengono dagli enti locali, portatori dunque degli interessi del territorio, mentre l’altra metà è designata a livello statale, e rappresenta gli interessi di conservazione della natura.
Con la riforma questo equilibrio rischia di rompersi, perché tra le nomine statali la legge prevede che accanto al rappresentante delle associazioni ambientaliste e a quelli di ministero dell’Ambiente e Ispra ce ne sia anche «delle associazioni agricole nazionali più rappresentative» (finora era scelto dal ministero dell’Agricoltura). Cioè un imprenditore agricolo del territorio, portatore di interessi economici legittimi, ma non proprio sovrapponibili a quelli di protezione dell’ambiente. Nei fatti, fa notare chi è d’accordo con il testo, è già così: i ministeri da sempre scelgono i loro referenti politici locali, ma per la presidente del Wwf Donatella Bianchi, «si rischia di sbilanciare i consigli verso gli interessi territoriali, diversi dalla conservazione della natura. Tra l’altro, ci sono categorie altrettanto importanti, come quella del turismo, che non vengono minimamente considerate».
Non fanno dormire tranquilli gli ambientalisti neanche i criteri per la scelta dei vertici dei parchi: «Il ddl non dice chiaramente che presidente e direttore devono avere specifiche competenze sulla conservazione della natura. Il rischio è che il presidente sia una figura più politica e che il direttore venga scelto sulla base delle sua capacità gestionali, che sono importanti ma non devono essere separate da specifiche competenze naturalistiche», continua la presidente del Wwf. In gioco c’è il lavoro stesso dei parchi, che da enti di tutela della natura rischiano di diventare ancora di più terreno di lottizzazione politica.
Per qualche euro in più
Anche la questione delle royalty si sta rivelando un vero e proprio cavallo di troia. Le legge prevede che i parchi ricevano direttamente le somme pagate da chi sfrutta il patrimonio naturale del parco o le aree contigue per attività economiche già autorizzate. Parliamo per esempio di concessioni di derivazione d’acqua per produrre energia idroelettrica, di permessi per la ricerca e l’estrazione di idrocarburi o ancora di concessioni per l’ormeggio di imbarcazioni. Un contentino per compensare le aree protette delle magre risorse messe a disposizione dal ministero dell’Ambiente? Il rischio, dice il presidente della Lipu Fulvio Mamone Capria, è che «le royalty diventino merce di scambio e che i parchi siano incentivati all’allargamento delle concessioni al momento del rinnovo».
Fuori le doppiette dai parchi
Gli ambientalisti vorrebbero anche che il testo escludesse definitivamente i cacciatori dai parchi nazionali, dove oggi sono ammessi per attività di controllo delle specie invasive o troppo numerose, come i cinghiali. «Chiediamo che per queste attività si scelgano sistemi ecologici e a ridotto impatto ambientale per gli ecosistemi del parco. Gli animali possono per esempio essere catturati e poi macellati altrove. L’ingresso con le armi nei parchi deve essere l’extrema ratio, e comunque deve poterlo fare solo il personale dell’area protetta, non cacciatori e guardie venatorie», denuncia ancora Mamone Capria.
La frattura
Mentre le 17 associazioni ambientaliste hanno ritrovato l’unità per combattere contro un testo che la Lipu definisce “pessimo”, e in cui, secondo il Wwf, «in nome della semplificazione si rischia di perdere di vista la tutela della natura», Federparchi, il “sindacato” delle aree protette, non esita a definire il provvedimento «un grande passo avanti per l’Italia dei parchi». E se il presidente di Federprachi Giampiero Sammuri minimizza le differenze, dicendo che «con gli ambientalisti siamo d’accordo quasi su tutto», il direttore del Wwf Gaetano Benedetto rilancia: «Federparchi ha dato il via libera in consiglio direttivo al ddl che poi è andato in votazione in commissione, le associazioni hanno presentato un testo di critica a quel provvedimento. La fotografia è questa, non ce n’è un’altra». Un particolare da non dimenticare è che il testo affiderebbe a Federparchi la piena ed esclusiva rappresentanza delle aree protette, anche se trattandosi di un’associazione volontaria aderirvi in teoria non è obbligatorio.
Le differenze di posizione sono evidenti. Alle critiche delle associazioni, Sammuri replica che «nei consigli direttivi con la riforma non si crea assolutamente uno sbilanciamento. Le royalty sono una buona cosa, anche perché una volta costruiti e autorizzati con le concessioni, gli impianti in questione non potrebbero comunque essere smontati e portati via». Sulle competenze dei vertici, spiega che «è giusto che il direttore abbia soprattutto competenze gestionali, perché deve far funzionare la macchina del parco. Il presidente deve essere una figura politica e non un esperto di temi naturalistici, così come il sindaco non deve essere esperto di viabilità o gestione dei rifiuti. Il provvedimento è molto positivo su alcuni aspetti pratici che chi milita nelle associazioni ambientaliste non ha chiari o non ritiene abbastanza importanti. Uno su tutti l’accorciamento dei tempi per la scelta del presidente, che è fondamentale».
Quale riforma?
Il testo andrà in aula al Senato a partire dal 25 ottobre. Poi dovrà passare alla Camera. Se tutto va bene, la riforma arriverà nel 2017. «Non so se ci sarà l’apertura che le associazioni ambientaliste stanno chiedendo, perché alcune questioni sono strettamente connotate secondo la moda politica del momento: scivolamento sull’ambito territoriale, federalismo improprio, concetto economico che viene sempre prima nonostante la Costituzione dica altre cose», dice un po’ abbattuto il direttore del Wwf Benedetto. E mentre il presidente della Lipu minaccia le barricate in mancanza di emendamenti migliorativi da parte del Parlamento o del governo, quello di Federparchi dice: «So già che non ci saranno tutte le cose che chiediamo, ma non per questo mi incatenerò davanti alla Camera o al Senato».

Direzione Cop 22. Sbarca oggi a Porto Torres la flotta per la giustizia sociale e climatica». Peccato che lo stesso giorno la Sardegna respingeva un gruppo di profughi, perché ne avevano già accolti il quantitativo stabilito.il manifesto, 23 ottobre 2016 (c.m.c.)
In vista della Conferenza dell’Onu sul cambiamento climatico (Cop 22), che si terrà dal 7 al 18 novembre a Marrakech, in Marocco, un gruppo di attori della società civile ha scelto di lanciare una campagna di mobilitazione euro-africana per la giustizia climatica e la giustizia sociale, l’Odissea delle Alternative Ibn Battûta, dal nome del cosiddetto «Marco Polo dell’Islam» che a metà del XIV secolo da Tangeri viaggiò per 28 anni, per terra e per mare, raggiungendo Timbuctù e Pechino.
«L’Odissea delle Alternative», partita il 19 ottobre e che proseguirà fino al 10 novembre, farà tappa in sei Paesi – Spagna, Francia, Italia, Tunisia, Algeria e Marocco – con l’obiettivo di rilanciare i temi della giustizia sociale, del clima e delle migrazioni, dando risalto alle pratiche virtuose ed alle soluzioni già riscontrabili in alcune delle comunità che si affacciano sul Mediterraneo.
Il Mediterraneo, afflitto dal crescere dell’intolleranza, da un brusco aggravamento delle tensioni, da guerre e conflitti, sarà una delle aree che maggiormente risentirà degli effetti dei cambiamenti climatici. Ed è per questo motivo che le comunità dell’area, ovvero le organizzazioni della società civile del Mediterraneo e del Sahel, si trovano – e ci troviamo – in prima linea per impedire o ridurre al minimo gli effetti, potenzialmente disastrosi, dei mutamenti climatici.
Da anni molti uomini, donne, bambini, attraversano il Mediterraneo, sperando in una vita migliore, ma spesso trovano la morte, anche per le gravi responsabilità delle istituzioni europee, che continuano a perseguire politiche di chiusura e di esternalizzazione delle frontiere.
Eppure questa drammatica situazione può essere modificata e sono tanti gli esempi che vanno in questa direzione, anche nei Paesi più poveri e in difficoltà: la rivalutazione dei saperi artigiani e industriali; il contrasto alla privatizzazione dei beni comuni; l’affermazione della gestione pubblica e partecipata del ciclo dei rifiuti e del ciclo delle acque; l’agricoltura familiare e di prossimità; i sistemi sociali ed economici locali che privilegiano la crescita auto sostenibile e lo scambio solidale e sussidiario, in opposizione al sistema competitivo neoliberista.
A MARRAKECH, finalmente, temi sino ad oggi trattati come singoli fenomeni saranno affrontati secondo una visione organica: la giustizia climatica, le migrazioni, la gestione delle risorse naturali, la sovranità alimentare, la riconversione ecologica, la sostenibilità energetica, la difesa del territorio, dei diritti umani e sociali, la pace, la cooperazione internazionale.
Senza dimenticare la necessità di lavorare a un grande piano di manutenzione della dimensione democratica, ricostruendo il concetto di partecipazione e ridando ruolo e potere ai «luoghi» reali della vita e della democrazia, rendendo riconoscibile il processo decisionale e di governo.
Il contrario di quello che prevede la riforma della Costituzione italiana promossa dal governo Renzi e sostenuta da tutte le più potenti lobbies economiche e finanziarie.Chi, come e dove si decide è argomento decisivo per il nostro futuro.
Per ridisegnare un nuovo assetto sociale ed economico occorre ricominciare ad «abitare» i luoghi, ripensare i processi decisionali, anche di governo del territorio, restituire la sovranità delle scelte alle comunità piccole e grandi. È necessario tracciare la strada verso un modello economico sostenibile e rispettoso dell’ambiente, dei territori, delle comunità che lo abitano; delineare un’organizzazione sociale basata sulla cooperazione, sul mutualismo e sull’autogestione.
Ed è di questo e di tanto altro che ci occuperemo anche nella tappa italiana dell’«Odissea delle Alternative» che l’Arci ha organizzato insieme alla Coalizione Clima, Rete della Pace, Rete della Conoscenza, Cgil, Legambiente, Unione degli Studenti, Rete degli Studenti Medi, Marevivo, Mani Tese, Fondazione Univerde, Earth Day Italia e con il patrocinio del Comune di Porto Torres. Le imbarcazioni attraccheranno oggi a Porto Torres e la manifestazione avrà inizio a partire dalle 16 nei locali del Museo del Porto.
Alla tavola rotonda sul Mediterraneo che affronterà il tema dei cambiamenti climatici e dei flussi migratori, seguirà un documentario, Mare Chiuso, sui respingimenti in mare; assisteremo ad alcune incursioni teatrali con una colorata Parata Migrante e concluderemo con un aperitivo multietnico e solidale a base di prodotti afro-sardi.
I catamarani, con il loro equipaggio, salperanno in direzione di Biserta, in Tunisia, dopo aver caricato le provviste e organizzato la cambusa. Simbolo di esperienze di resistenza e di resilienza e monito per chi ha in mano le leve del potere a rispettare prima e applicare poi, con serietà, gli impegni assunti nel documento firmato alla Cop21 di Parigi.
«Tra Olimpiadi, scandali e impeachment, l’aumento della deforestazione passa sotto silenzio». Il Fatto Quotidiano, 15 ottobre 2016 (p.d.)
Queimada, bruciato, non è solo l’emblematico titolo di un film di Gillo Pontecorvo, è anche un’infernale parola che ricorre spesso nelle pagine dell’ultima pubblicazione dell’Ipea, l’istituto di ricerche spaziali brasiliano, il quale anche quest’anno ha pubblicato il crudele resoconto sulla devastazione dell’Amazzonia in Brasile. Il dossier dell’Ipea – realizzato grazie al monitoraggio dei satelliti Landsat americani – sono inquietanti, giacché le Queimadas, nel 2015, sono aumentate del 309,6% e hanno contribuito, assieme al disboscamento, alla distruzione di 6.207 kmq di foresta tropicale. L’aumento è pari al 24% rispetto a quello registrato l’anno precedente. Assieme agli alberi della selva pluviale, vanno in fumo anche gli accordi sul riscaldamento globale di Parigi, ratificati a settembre, anche dal neo governo Temer, il quale si è impegnato a ridurre l’emissione dei gas serra del 37% entro il 2025 e del 43% nel 2030.
Tra le ambiziose misure che dovrebbero essere adottate, ci sarebbe il recupero di 12 milioni d’ettari d’aree silvestri devastate, oltre all’azzeramento del disboscamento entro il 2030. “Se esiste ancora la foresta, è grazie agli indios. Le dighe non sono certo costruite per portare energia alla gente, ma all’agro-business, come quello di Blairo Maggi, l’ex governatore del Mato Grosso do Sul, uno dei maggiori produttori di soia al mondo. Non ricordo il numero esatto, ma nei programmi di sviluppo del governo, ci sarebbe l’intento di costruire 150 impianti idroelettrici in Amazzonia”, spiega Bruna Franchetto, antropologa italiana all’Università Federale di Rio. Agrobusiness, allevamento del bestiame, ma anche industria mineraria e infrastrutture, tra cui l’edificazione di dighe e urbanizzazione, sono i grandi demolitori dell’Amazzonia che ingloba circa il 60% del bacino amazzonico sudamericano, pari a 4,2 milioni chilometri quadrati, il 49% del territorio brasiliano.
Nell’universo amazzonico vivono più di 342 mila indios, tra cui i Guarani Kaiowá, l’etnia che soffre con il più alto numero di assassinati e suicidi in Brasile. In tanti si chiedono se il governo neoliberale di Temer manterrà fede agli accordi, dato che a Brasilia circolano proposte di legge come la Pec 215, l’emendamento alla Costituzione giunto alla Camera, con cui le potenti lobby dell’agro-business ed evangeliche anelano a trasferire dall’esecutivo al Parlamento il potere di demarcare le terre destinate agli indios.
Nela Pec 215,il governo vorrebbe inserire anche la proposta di vendere terre pubbliche agli stranieri. I latifondisti vorrebbero aumentare la produzione delle commodity agricole e l’emendamento, secondo i ricchi fazendeiros, aprirebbe il cammino all’investimento straniero in un Paese in crisi profonda. Prima dell’attuazione dell’impeachment, la presidente Rousseff ha firmato numerosi decreti destinati al riconoscimento d’aree indigene, provvedimenti, però, in parte già annullati da Temer.
Secondo Franchetto, se la Pec 215 sarà approvata, si getterebbe la Costituzione nei rifiuti: nella Carta varata nell’88 venne riconosciuto agli indios il diritto originario d’esistere prima della formazione dello Stato brasiliano.
L'Oong internazionale Human Rights Watch denuncia «violazioni dei diritti delle comunità danneggiate dallo sfruttamento delle miniere di carbone e di uranio». Un altro caso di sfratto forzato di persone e comunità dell'Africa , causato dalla rincorsa del micidiale "sviluppo". asud.net, 10 ottobre 2016 (p.d.)
Secondo il rapporto “They Destroyed Everything: Mining and Human Rights in Malawi”, presentato da Human Rights Watch in occasione dell’ International right to know Day, «Il governo del Malawi non ha preso le misure necessarie per proteggere i diritti e i mezzi di sussistenza delle persone che vivono nelle comunità danneggiate dai progetti di sfruttamento minerario. Le famiglie che vivono vicino a delle aree di sfruttamento minerario di carbone e di uranio si confrontano con gravi problemi riguardanti l’acqua, il cibo e l’abitazione e non ricevono nessuna informazione riguardante i rischi per la salute ed altri prodotti da questo sfruttamento».
Il rapporto “Hanno distrutto tutto” esamina in 96 pagine l’impatto delle industrie estrattive sulle comunità di alcune delle prime aree minerarie del distretto di Karonga, sulla costa nord-occidentale del Lago Malawi. Il governo di Lilongwe ha favorito gli investimenti privati nell’estrazione di minerali e risorse per diversificare l’economia del Malawi, ma Human Rights Watch ricorda che «Ogni estrazione di risorse naturali va generalmente di pari con dei rischi ambientali e l’estrazione mineraria contribuisce in maniera importante al dannoso cambiamento climatico a alla capacità dei governi di garantire i diritti alla salute, all’acqua e al cibo».
Katharina Rall, ricercatrice della divisione salute e diritti umani di Human Rights Watch, avverte: «Il Malawi non dovrebbe commettere gli stessi errori riguardanti l’estrazione mineraria visti in altri Paesi dell’Africa australe. Non è sufficiente creare un ambiente favorevole agli investimenti da parte delle compagnie minerarie. Il governo dovrebbe proteggere urgentemente le comunità colpite». Il rapporto si basa su ricerche effettuate in Malawi tra il luglio 2015 e il luglio 2016 e su più di 150 interviste, comprese quelle a 78 persone che vivono nelle aree attualmente sfruttate dalle compagnie minerarie o dove sono iniziate le operazioni per aprire nuove miniere. Human Rights Watch ha anche incontrato i rappresentanti delle imprese e dei governi nazionale e locali, di Ong nazionali e internazionali e di organismi internazionali. E’ su queste basi che Human Rights Watch denuncia «Violazioni dei diritti delle comunità del distretto di Karonga, danneggiate dallo sfruttamento delle miniere di carbone e di uranio dell’Eland Coal Mining Company, della Malcoal, e di Paladin Africa Limited (Paladin)» e l’Ong internazionale ha concluso che «Il Malawi non dispone di protezioni appropriate per garantire l’equilibrio necessario tra gli interventi a favore dello sviluppo e la protezione dei diritti delle comunità locali; inoltre, tra il controllo insufficiente da parte del governo e la mancanza di informazioni, le comunità locali sono private di protezione».
Un’abitante di Mwabulambo ha detto a Human Rights Watch: «I nostri problemi sono cominciati con l’inizio delle attività minerarie. Il carbone è nei nostri orti e si spande nei nostri campi. A guardare i nostri campi, si direbbe che qualcuno li abbia innaffiati di petrolio».
A marzo una donna di 75 anni di Mwabulambo ha raccontato la sua storia ai ricercatori: «Avevo 6 acri (2,4 ha) di terra. Ma la miniera di carbone ha sparso del carbone sulla strada per renderla migliore per i camion, il carbone è percolato nel mio orto durante la stagione delle piogge e questo ha nuociuto al mio raccolto di frutti. Perché avete distrutto la nostra terra? Ci hanno lasciato con niente. Soffriamo la fame».
Human Rights Watch ha constatato che le attività minerarie hanno costretto diverse famiglie ad andarsene e queste persone sono state avvisate solo all’ultimo e non hanno avuto il tempo per trovare un altro posto dove stare, molte sono senza casa. In molti non sono stati informati delle procedure di indennizzo, che sono comunque poco chiare, e in diversi casi gli indennizzi sono stati inferiori a quelli necessari per ricostruire una casa o per conservare il già povero livello di vita precedente, anche perché in molti non possono più accedere alle terre che coltivavano. «La compagnia ha messo delle croci bianche su tutte le case delle famiglie da sgomberare. Hanno messo una croce bianca anche sulla nostra casa. Sono venuti una prma volta nl marzo 2012 per dirci che dovevamo sloggiare entro aprile. Ma hanno aspettato solo una settimana prima di ritornare per dirci che bisognava sloggiare subito. Non sapevamo dove andare. Abbiamo dovuto dormire all’aperto per qualche giorno. E’ stati difficile andarsene perché era la stagione delle piogge e abbiamo finite per installarci sotto la veranda di qualcuno o sotto un albero», raccontava Sinya M., di Mwabulambo, nel marzo 2016.
Gli abitanti del distretto di Karonga dicono di non aver ricevuto informazioni sufficienti sulle attività minerarie e sui rischi che comportano, in particolare le malattie respiratorie e altri problemi sanitari e ambientali. Chi vive nei villaggi ha scarso accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere e praticamente nessuno potrà curarsi dalle malattie legate all’estrazione di uranio e carbone. Il governo e le compagnie che operano a Karonga hanno assicurato che stanno sorvegliando gli impatti dello sfruttamento minerario, ma non hanno mai pubblicato I risultati.
Gli abitanti dei villaggi sono preoccupati per l’inquinamento delle fonti d’acqua dalle quali dipendono per bere e irrigare i campi. Secondo loro i camion delle miniere sollevano nuvole di polvere che soffocano i villaggi e le scuole con conseguenze per la salute, in particolare malattie respiratorie. Gli studi effettuati in altri Paesi sulle malattie legate all’esposizione all’inquinamento minerario danno loro ragione. Gli agricoltori hanno segnalato che la polvere di carbone e la cattiva qualità dell’acqua danneggiano i loro raccolti. La miniera di carbone dell’Eland, che ha chiuso nel 2015, ha lasciato dei livelli altissimi di polvere di carbone e pozzi pieni di acqua inquinata che possono essere pericolosi per i bambini e minacciano le risorse idriche locali.
La Rall constata: «A causa dell’insufficienza dell’infrastruttura sanitaria e del segreto mantenuto sui risultati delle indagini, è difficile dire cosa succede realmente. E’ uno degli aspetti del problema, il governo e le compagnie devono prendere sul serio l’indagine e gli interessati hanno diritto di conoscere i risultati».
Le più colpite sono le donne, sulle quali gravano i compiti domestici e agricoli. Sono state proprio le donne a segnalare la difficoltà di ottenere delle spiegazioni sui rischi che corrono da parte delle compagnie, anche perché la loro partecipazione agli incontri con le compagnie e il governo è stata ostacolata e limitata. Ma, dato che l’estrazione mineraria nuoce alla produttività agricola e minaccia le fonti d’acqua, le donne devono lavorare più a lungo per provvedere ai bisogni delle loro famiglie e fare più strada per trovare acqua pulita. Nagomba E., residente nel villaggio di Mwabulambo, spiega: «Le tubazioni passavano proprio davanti a casa mia e avevo l’acqua corrente in cucina e in bagno, poi loro hanno distrutto tutto. Alla mia età è difficile andare ancora al fiume».
«La compagnia ci aveva promesso un centro sanitario e nuovi rubinetti e dei ponti. Non avevano parlato di rischi», dice una donna di Kayelekera.
In generale, le compagnie che operano nel distretto di Karonga non hanno mantenuto le promesse di costruire centri sanitari o di trivellare altri pozzi d’acqua. Le Ong del Malawi sono molto preoccupate: «La corsa all’ industrializzazione e alla crescita deve essere accompagnata da un patto sociale e le compagnie devono mantenere le loro promesse», dice Reinford Mwangonde, direttore esecutivo di Citizens for Justice che fa parte del Natural Resources Justice Network, una rete malawiana di Ong che si battono per una estrazione sostenibile delle risorse.
Human Rights Watch ricorda che «Le industrie estrattive del Malawi sono ancora all’inizio, il che dà al governo e agli investitori l’occasione di rispettare i diritti delle comunità e di minimizzare i rischi con i quali si confrontano le comunità e gli ecosistemi naturali, mentre operano per lo sviluppo economico. Anche se il Malawi dispone di qualche legge e di politiche che proteggono i diritti delle comunità potenzialmente lese dall’estrazione mineraria, sono applicate male. Gli organi di vigilanza del governo sono inattivi durante il proseguimento delle attività di estrazione mineraria autorizzata, quali che siano i rischi che corrono le comunità locali o l’ambiente. La nuova proposta di legge, la Legge sulle miniere e i minerali, non rimedia alla mancanza di trasparenza riguardante I rischi legati allo sfruttamento minerario. Il governo ha iniziato a creare un quadro giuridico più ampio e ha promesso di migliorarne l’applicazione. Tuttavia, le comunità minerarie aspettano ancora i risultati delle ispezioni e i risarcimenti per i danni subiti. Il governo dovrebbe instaurare delle condizioni eque, informando e comunità sui rischi dell’estrazione mineraria, garantendo la loro partecipazione alla presa delle decisioni».
La Rall conclude: «Le miniere del distretto di Karonga saranno seguite da numerosi altri progetti di estrattivi in Malawi, il che conferisce una grande importanza agli insegnamenti che si possono trarre da questa esperienza. Il governo dovrebbe n mettere in atto delle protezioni efficaci in modo che le persone interessate dai nuovi progetti non subiscano gli stessi danni degli abitanti di Karonga».
«Burkina Fasu. Incontro con il pioniere della rigenerazione naturale, Yacouba Sawadogo». il manifesto, 7 ottobre 2016 (c.m.c.)
«Per ogni villaggio, una piccola foresta»: uno dei tanti sogni di quell’utopista concreto che si chiamava Thomas Sankara. Ma il 15 ottobre 1987 il presidente del Burkina Faso fu assassinato e finì una rivoluzione che parlava al mondo partendo dai contadini saheliani tormentati dalla miseria e dall’avanzare del deserto.
In soli 4 anni di governo – prima della restaurazione del golpista Blaise Compaoré -, i burkinabè non riuscirono a rinverdire il Sahel. Ma in tutti questi decenni, qualcuno ha portato avanti il lavoro sul campo. Seminare foreste tornerà ad essere una priorità nazionale dopo la sollevazione popolare dell’autunno 2014 che ha cacciato Compaoré e malgrado le tante contraddizioni del nuovo governo? Yacouba Sawadogo non lo sa. Ma continua a lavorare. Chi si reca al villaggio di Gourga, deve cercare Sawadogo nel grande bosco che si estende per ettari ed ettari, ricco di acacie, pruni, datteri del deserto, leiocarpus, gomma arabica, moringa; per gli uccelli e gli altri animali selvatici, piccoli punti di acqua sparsi qui e là. Una foresta dove decenni fa non c’era nemmeno un arbusto.
Niente piantumazioni monovarietali, costose e che spesso muoiono in quell’ambiente ingrato. Lui, Yacouba, gli alberi non li pianta: li semina. Pratica la strategia ecologica e sociale della Rigenerazione naturale assistita dagli agricoltori (Rna), nella quale gli alberi spontanei sono protetti perché trattengono l’umidità nel suolo e aiutano i raccolti. Tecniche simili di coltivazione e riforestazione naturale sono portate avanti, fra gli altri, dai Groupements Naam, un’associazione di gruppi di villaggio assai diffusa in Burkina Faso.
Sawadogo ha raccontato la sua storia giorni fa a Torino e Cumiana, partecipando all’incontro internazionale «Terra madre». Ci ha spiegato che negli anni 1970, durante anni di totale siccità, mentre i contadini fuggivano dalle campagne assetate, egli come un folle fece il cammino opposto. Da commerciante diventò pioniere della lotta contro il deserto, «per avere un’attività non fondata sul denaro». A Gourga allora si faceva la fame. Yacouba, da buon innovatore delle buone tradizioni, reintrodusse lo zai, un’antica tecnica tipica delle aree del nord, a più bassa pluviometria: nella stagione secca si scavano buchi regolari nei campi, per trattenere l’acqua nella successiva stagione delle piogge. La novità ideata da Sawadogo consisteva nello scavare buche più grandi, e nel deporvi compost e letame e anche le termiti, che aiutano a smuovere il terreno. Poi si seminano cereali e specie arboree.Così sotto le mani di Sawadogo e dei contadini affamati di Gourga ai quali offriva cibo in cambio di lavoro, migliorarono i raccolti (fino a 1,5 tonnellate di miglio per ettaro anziché 500 kg) e crebbe la foresta.
Dapprima lo credono folle, i capiclan cercano di boicottarlo perché sono abituati ad assegnare in tutta discrezionalità le terre – in Burkina sono dello Stato. A un certo punto la foresta è stata minacciata perfino da un progetto di espansione immobiliare della vicina Ouahigouya, poi per fortuna fermato. Ma lui ha resistito, fedele al principio che «il valore di una persona si misura con il tempo che ci mette a desistere». Tuttora distribuisce semi e dispensa consigli e corsi di formazione a chi glieli chiede. Migliaia di famiglie negli anni grami sono sopravvissute grazie alle sue tecniche: «Se riesce a produrre cibo a sufficienza, il paese si salverà», dice.
Per Chris Reji, esperto internazionale della Rna, «Yacouba, ricercatore analfabeta, ha avuto più impatto sulla preservazione del Sahel di tanti gruppi di ricerca internazionali e nazionali». Una ricerca della Fao stima che con l’equivalente di poche decine di euro si potrebbero rimborsare le ore di lavoro e le risorse necessarie ai contadini per rigenerare un ettaro di Sahel. Ma questo sostegno, una vera restituzione internazionale a chi è vittima anche dell’ingiustizia climatica, langue. Così la tecnica dello zai continua ad avere un risvolto duro: fatica nella polvere, con le pesanti zappe in mano e il sole che batte. In mezza giornata, otto persone valide possono scavare mille zai, ma piccoli. Poi agli zai vanno associate le dighette antierosive formate da cordoni di pietra – da trasportare a mano o con la carriola. Tanta fatica, tanto tempo significano anche una diffusione inferiore a quella che sarebbe necessaria. Gli stessi Naam non hanno quasi trattori e nemmeno zappe ergonomiche.
Lo zai può anche essere praticato con un attrezzo trainato dagli animali. E qui si apre un altro capitolo: gli asini burkinabè – da sempre compagni dello sforzo umano – sono stati decimati per anni, carne e pelli esportati verso l’Asia. Nello scorso agosto, anche grazie a una piccola campagna di repressione, il Burkina seguendo il Senegal ha introdotto una legge per la loro protezione. Ma questa è un’altra storia.
«Mentre il premier si autocelebra a Genova per i “passi avanti giganteschi”nella messa in sicurezza del territorio, dei 9 miliardi promessi sono stati spesi soltanto spiccioli (stanziati dal governo Letta). Quasi a zero anche i fondi per bonifiche e sistema idrico». Il Fatto Quotidiano, 6 ottobre 2016 (p.d.)
Ieri Matteo Renzi è andato a Genova: “Stasera presentiamo i lavori sul Bisagno (il fiume esondato nel 2014, ndr): la lotta al dissesto non si fa con le parole ma coi cantieri. E sono molto fiero dei passi in avanti giganteschi che sono stati fatti. Ma non basta”. I passi avanti giganteschi sono parte del Grande Piano contro il dissesto idrogeologico 2015-2020 da 9 miliardi: “Una rivoluzione copernicana – la definì il premier l’anno scorso –. Abbiamo già stanziato 1,2 miliardi. Ci rimbocchiamo le maniche e sistemiamo tutto”. Su Italiasicura.it si possono vedere i cantieri in una graziosa mappa multimediale. Poi, però, c’è la realtà. Il Tesoro, com’è obbligato a fare, ha appena pubblicato le Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali 2016 e lì c’è scritta una cosa un po’ diversa: finora sono stati spesi in tutto 74 milioni, molti dei quali proprio a Genova peraltro, stanziati da Enrico #staisereno Letta. Non solo: le critiche che il governo muove a se stesso in quel report sono pesanti tanto sul dissesto, quanto sulle bonifiche e il sistema idrico. Breve sintesi.
Dissesto idrogeologico
Ecco i 9 miliardi di Renzi nelle parole dei tecnici del ministero dell’Ambiente (Gian Luca Galletti fu uno dei più risoluti aedi del Grande Piano): “A causa dell’esiguità delle risorse disponibili si sta procedendo attraverso la realizzazione di Piani Stralcio”. Insomma, il Grande Piano nel settembre 2015 è diventato – in silenzio, con un decretino – “interventi di mitigazione del rischio alluvionale nelle aree metropolitane” (tutte nel Centro-Nord). Finanziamento teorico: 1,3 miliardi dal Fondo di sviluppo e coesione e dal ministero dell’Ambiente. Quei soldi, però, non esistono: “A causa dell’esiguità delle risorse disponibili si è deciso di finanziare 33 interventi per un importo di 654 milioni di risorse statali che hanno così costituito la sezione attuativa, rimandando la sezione programmatica” a quando avremo i soldi. Anche i 654 milioni, però, sono virtuali: a oggi infatti, ci dice il Tesoro, sono stati spesi 74,1 milioni. Poi ci sono altri 63 milioni da destinare “al piano di gestione del rischio alluvioni da completare entro l’anno”.
Quindi non spesi. Da qui al 2018 ci sono sulla carta 350 milioni in tutto, tutti stanziati da Letta nel 2013: 150 milioni quest’anno, 50 nel 2017 e 150 nel 2018. Il governo Renzi non ha messo un euro in più: “La scarsità delle risorse disponibili per il triennio 2016-18 non ha consentito a questa amministrazione di effettuare una programmazione strutturata per la mitigazione del dissesto idrogeologico”. In sostanza, il ministero dell’Ambiente chiede più soldi e li vorrebbe dal Fondo di sviluppo e coesione. Problema: quei soldi sono vincolati per l’80% a investimenti al Sud “con pregiudizio della grave situazione di dissesto nel Centro-Nord”. Dulcis in fundo: il decreto Sblocca Italia del 2015 ha stanziato 45 milioni per i programmi anti-dissesto “dei provveditorati regionali”: finora sono stati assegnati solo i 2 milioni del 2015.
Le fogne
Qui il ritardo è enorme. Da oltre 10 anni, una direttiva Ue impone a Roma la messa a norma dei sistemi fognari e depurativi: le acque reflue degli agglomerati urbani “devono essere sottoposte a trattamento adeguato”. Tradotto: vanno depurate. Per il 2016 sono stati stanziati 20 milioni. Cioè il 2% di quanto servirebbe. Recita infatti il documento del Tesoro: “La ricognizione effettuata ha evidenziato un fabbisogno finanziario di oltre 1 miliardo di euro per la realizzazione di interventiin 817 agglomerati oggetto di contenzioso comunitario”. A dicembre 2015, Bruxelles ha infatti annunciato che metterà in mora l’Italia alla Corte di Giustizia europea. Lì quantificherà la multa: rischiamo di dover pagare mezzo miliardo l’anno. Per mettere tutto a posto, invece di un miliardo, ci sono 20 milioni nel 2016, 14 nel 2017 e 7 nel 2018 in base a leggi di 10 anni fa.
Siti inquinati
Ce ne sono di vario genere, ma lo stato degli investimenti pubblici è terribile in ogni caso. Per l’amianto, ad esempio, Renzi ha promesso 45 milioni l’anno tra il 2015 e il 2017 per fare le bonifiche nei “sette Siti di interesse nazionale contaminati da amianto”. In teoria. Nella pratica dei 45 milioni del 2015 ne sono arrivati solo 25, cifra che scende a 19,7 milioni nel 2016. Ammette il governo nel suo report: “Si prevede che sarà erogata una percentuale di risorse superiore al 65% entro la fine del triennio”. Tradotto: 46 milioni sono già persi.
Poi c’è il piano straordinario di bonifica delle discariche abusive. Letta aveva stanziato 30 milioni per il 2016-2018: i soldi non sono mai arrivati perché - dicono i tecnici - “i soggetti attuatori non hanno mai consegnato i piani”. Le risorse, comunque, non bastano: mancano 66 milioni. Infine ci sono le bonifiche degli altri Sin: i siti di interesse nazionale – cioè posti super-inquinati tipo Taranto, Brindisi, i laghi di Mantova o il petrolchimico a Marghera – sono 40, istituiti per legge nel 1998 per procedere finalmente alle bonifiche. Come non si era fatto niente prima, così quasi niente dopo. Ora all’uopo sono destinati 75 milioni fino al 2018. Problema: solo i Piani di Stralcio per gli interventi “strategici e prioritari” – quelli, cioè, per evitare emergenze sanitarie – valgono 600 milioni e non ci sono. Se questo è l’andazzo, il piano “Casa Italia” lanciato dopo il terremoto andrà monitorato con attenzione.

«La concentrazione monopolistica che investe l’agricoltura industriale comporta una vertiginosa crescita nell’impatto sul mercato, a cominciare dai prezzi al consumo, nel potere delle lobby su leggi e regolamenti nazionali e internazionali, nella corruzione politica e nel controllo delle informazioni». Comune-info, 29 settembre 2016 (p.d.)
Anche se la notizia circolava dallo scorso anno, la conferma del 14 settembre sul fatto che Monsanto accettava infine di essere acquisita dalla Bayer ha provocato allarme. Sono due delle più antiche aziende che producono veleno, con una lunga storia di crimini contro la salute, l’ambiente, i diritti umani. Questo il profilo delle imprese, ma il retroscena è più complesso.
Monsanto è probabilmente la transnazionale con più denunce a livello planetario. Non solamente per le coltivazioni transgeniche, ma anche per molti altri attentati contro le persone e l’ambiente, come l’aver creato l’agente arancio, un’arma chimica che gli Stati Uniti hanno usato contro le contadine e i contadini nella guerra in Vietnam; l’ormone transgenico della crescita dei bovini, che si suppone sia collegato al cancro al seno e alla prostata e che si vende in Messico e in altri paesi dell’América Latina senza essere dichiarato; l’aver inventato il glifosato, un erbicida ad ampio spettro e l’agrotossico più usato nella storia dell’agricoltura, affermando che non era pericoloso. Al contrario, nel 2015, il glifosato è stato dichiarato cancerogeno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Bayer non è da meno. Fin dai suoi inizi, ha sviluppato l’eroina da vendere come medicina - con una storia di promozione della dipendenza per vendere di più -; ha avuto una collaborazione stretta e volontaria con i nazisti come parte del conglomerato IG Farben, che ha sviluppato il gas Zyklon B da usare nelle camere a gas di Auschwitz; diverse volte è stata portata a giudizio per danni causati dalle sue medicine e dagli agrotossici, come nel caso della morte di 24 bambini a Taucamarca, in Perù; per aver distribuito agrotossici altamente pericolosi senza avvertenze e in molti altri casi che le vittime hanno denunciato, spesso con il supporto della Coalición contra los peligros de Bayer [Coalizione contro i pericoli derivanti dalla Bayer, CBG], dove si può saperne di più sulla sua storia priva di scrupoli.
La storia di ciascuna di esse, prese separatamente, è terribile e tutto indica che unite saranno peggiori. Tuttavia, questa è solo una delle mega-fusioni che si stanno verificando nell’ultimo anno tra le maggiori imprese del settore agricolo e alimentare. Le sei transnazionali che controllano le coltivazioni transgeniche in tutto il mondo, Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer e Basf, sono tutte originariamente fabbricanti di veleni, prodotti chimici e agrotossici; ciascuna di esse ha un percorso storico simile e tutte cercano di fondersi l’una con le altre. Da tre decenni, l’industria chimica si è avventata sull’acquisto delle imprese sementiere commerciali – che fino ad allora erano migliaia e nessuna deteneva nemmeno l’uno per cento del mercato mondiale. Lo hanno fatto per costringere gli agricoltori a comprare il pacchetto di sementi e agrotossici. Già si stavano profilando le sementi transgeniche che, lontane dalla propaganda di un aumento della produzione e di altri imbrogli mai verificati, erano, fin dalle origini, sementi resistenti agli agrotossici delle stesse imprese, perché vendere veleno è il loro affare e questo era l’obiettivo principale.
Attualmente, queste sei imprese controllano il 62 per cento del mercato delle sementi commerciali – di ogni tipo – e il 75 per cento del mercato globale degli agrotossici. Nell’ultimo anno, si sono accordate per fondersi la DuPont con la Dow e la Syngenta con ChemChina (che è proprietaria di Adama, la settima impresa di agrotossici a livello globale); quindi, in pratica, se le autorità anti-monopolio avallano, saranno solo tre le imprese che controllano queste enormi quote di mercato.
È difficile immaginare che possano continuare a fondersi per diventare ancora più grandi. Tuttavia, il valore annuo del mercato mondiale delle sementi (secondo le vendite del 2013) è di 39 miliardi di dollari e quello degli agrotossici di 54, ma quello dei macchinari agricoli è di 116 e quello dei fertilizzanti di 175. I settori delle macchine e dei fertilizzanti si stanno consolidando ancora, così come i distributori di cereali, il passo successivo della catena. Non ci vorrà molto tempo, quindi, perché questi settori comprino i primi. (Per maggiori dettagli, si veda il rapporto Campo Jurásico, La guerra de los dinosaurios del agronegocio, del Gruppo ETC). Facciamo solo un esempio, prossimo, di queste altre fusioni: quasi contestualmente all’annuncio della fusione Monsanto-Bayer, due grandi imprese di fertilizzanti (Agrium e Potash Corp) hanno deciso di fondersi per costituire l’azienda più grande al mondo e Bunge, uno dei cinque maggiori distributori mondiali di cereali, ha concordato l’acquisto di Minsa, uno dei maggiori distributori di farina di mais del Messico.
Tutte queste fusioni non si verificano solamente per controllare maggiori quote di mercato, rappresentano anche una corsa per aumentare il loro controllo/monopolio sulle nuove tecnologie di manipolazione genomica – brevetti di biologia sintetica, CRISPR-Cas9 e altre nuove biotecnologie – e soprattutto, controllare banche-dati digitali relative ai suoli, all’acqua, al clima e ad altri aspetti chiave della produzione agricola. La prospettiva è che chi si dedica all’agricoltura industriale non potrà acquistare le sementi in un luogo e gli altri prodotti per l’agricoltura in altri, ma sempre più ci sarà un unico sportello imprenditoriale che vende un pacchetto che va dalle sementi all’assicurazione agricola, passando per gli agrotossici, i macchinari e i dati che sarà costretto a pagare e ad applicare per accedere al pacchetto.
Davanti a questo scenario che sembra di fantascienza e progettato solo per i grandi agricoltori industriali, molti si chiedono in che modo questo possa colpire i contadini e le famiglie agricole e che differenza c’è se le imprese sono 3 o 6 o 10? Un elemento certo è l’aumento del potere di pressione delle imprese a livello nazionale e internazionale, che non sarà determinato solo dalle loro dimensioni e dal potere di corruzione, ma anche dal controllo degli anelli della catena agroalimentare. Potranno ottenere, ancora di più, leggi e normative a loro favore, da quelle sulle sementi all’occupazione delle terre, permessi e sovvenzioni per l’uso dell’acqua, compreso il denaro pubblico per sostenerle in quanto “settori chiave della produzione”. Cosa già iniziata con le nuovi leggi sulle sementi finalizzate a rendere illegale la circolazione delle sementi contadine, in quanto non registrate, e poi con i crediti e i sostegni legati all’acquisto di determinate sementi, agrotossici e assicurazioni. Un altro aspetto è che l’uso di droni, sensori, GPS e satelliti che rientra nel pacchetto, non serve solo a fornire dati ed elementi in questa “agricoltura di precisione” ma anche a prelevare dati, non solo sui prodotti agricoli, ma anche sull’acqua, il suolo, il sottosuolo, la vegetazione, i boschi, la fauna, ecc. Il che, a sua volta, può combinarsi con altri progetti nocivi, come quelli sul mercati di carbonio, la biopirateria, l’esplorazione delle risorse e il monitoraggio/sorveglianza delle comunità e delle popolazioni.
Malgrado l’enormità delle minacce, tuttavia, continuano a essere i più piccoli, le contadine e i contadini, gli indigeni, i pescatori artigianali, gli orti urbani, la caccia e la raccolta artigianale a fornire il cibo a più del 70 per cento dell’umanità. Lo fanno malgrado la persecuzione e le costanti minacce ai loro territori, alle risorse e ai modi di vivere. Di conseguenza, opporci a questi colossi aziendali e al loro dominio sull’alimentazione e la salute di tutte e tutti, significa appoggiare quelle comunità e quelle forme del vivere e costruire/rafforzare reti e azioni concrete di sostegno reciproco.
Questo articolo è uscito su Desinformemonos. Traduzione per Comune-info: Daniela Cavallo
 «Intervista a Dorothee Häussermann."C’è un enorme lavoro da fare per riorganizzare radicalmente la nostra vita quotidiana e oggi abbiamo la tecnologia per farlo. Bisogna politicizzare il senso comune "». Il manifesto, 29 settembre 2016 (c.m.c.)
«Intervista a Dorothee Häussermann."C’è un enorme lavoro da fare per riorganizzare radicalmente la nostra vita quotidiana e oggi abbiamo la tecnologia per farlo. Bisogna politicizzare il senso comune "». Il manifesto, 29 settembre 2016 (c.m.c.)
Lo scorso luglio è stato il mese più caldo di sempre. Le temperature medie mondiali continuano a salire. Sono 360 ormai i mesi consecutivi con una temperatura più alta rispetto a quella media registrata durante tutto il secolo scorso. 360 mesi di fila, 30 anni. E il 2016 si preannuncia già come l’anno che batterà ogni record.
Se dai protocolli di Kyoto agli accordi di Parigi qualche passo in avanti è pure stato fatto, la velocità del riscaldamento climatico e soprattutto l’aumento della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera (dal 2014 siamo ben oltre la soglia dei 350 ppm, ritenuta da molti climatologi, fra cui James Hansen, come la soglia di concentrazione oltre cui la biosfera è a rischio) richiederebbero azioni istituzionali, drastiche e immediate.
I due settori chiavi su cui bisognerebbe agire subito sono l’Agrobusiness (in particolare gli allevamenti industriali) e il consumo di combustibili fossili. Ma gli interventi tardano anche perché smontare una macchina in piena accelerazione richiederebbe un atto di forza che nessuna istituzione internazionale sembra voler esercitare realmente.
Non stupisce che dal 3 al 15 maggio 2016, a poche settimane dunque dalla prima ratifica degli accordi di Parigi (il 26 aprile 2016 a New York) una rete di organizzazioni ambientaliste coordinate da 350.org abbia dato vita alla più grande azione di disobbedienza civile mai organizzata contro l’estrazione e il consumo di combustibili fossili.
La campagna Break free from Fossil Fuel ha coinvolto più 30 mila attivisti in tutto il mondo, coordinando globalmente occupazioni, manifestazioni e azioni di sabotaggio in 12 Paesi su cinque continenti: dalle Filippine agli Stati Uniti, dalla Nigeria al Brasile, dall’Australia all’Indonesia, dai Paesi Bassi all’Inghilterra alla Turchia. Ma è in Germania che è stata organizzata l’azione di disobbedienza civile più imponente: per quattro giorni, dal 13 al 16 maggio, l’associazione tedesca Ende Gelände («Fino a qui e non oltre») ha mobilitato più di 3500 persone in Lusazia, nella regione tedesca di Brandeburgo. Abbiamo raggiunto Dorothee Häussermann, attivista di Ende Gelände che sarà in Italia all’inizio di ottobre per partecipare ai Colloqui di Dobbiaco (30 settembre – 2 ottobre) organizzati da Wolfgang Sachs.
Dorothee puoi raccontarci cosa è successo in Brandeburgo lo scorso maggio?
Abbiamo bloccato un’enorme miniera di carbone in Lusazia. La Vattenfal, che è una delle quattro società tedesche per la produzione di energia, è proprietaria dell’intero bacino carbonifero. All’inizio del 2016 ha deciso di vendere questa enorme miniera di carbone lignite al miglior offerente. Si parla tanto in Europa di politiche ambientali. Questa sarebbe un’occasione perfetta per chiudere un bacino carbonifero, bonificarlo e investire in nuove tecnologie verdi.
Invece che si fa? Non solo si permette la vendita di questa miniera, ma si dà perfino la possibilità al nuovo investitore di costruire nuovi impianti, aumentare la quantità di carbone estratto e quindi di peggiorare le condizioni ambientali già drammatiche di questa regione. Il nostro messaggio è molto chiaro ed è diretto al futuro investitore. Dovrà sapere che gli impediremo con ogni mezzo di continuare l’estrazione del carbone. Saremo un costo altissimo per il suo investimento. Il carbone deve restare dove è. La miniera va chiusa. Investa in energie rinnovabili.
Come è stata accolta la vostra protesta dal governo del Brandeburgo?
Non abbiamo alcuna sponda istituzionale. In Brandeburgo è al governo un’alleanza rosso/verde (Spd e Verdi dal 2009) ma il paradosso è che perfino i verdi sono a favore delle miniere. La politica tradizionale è totalmente cieca e sorda. Per questa ragione la nostra unica possibilità è quella di organizzarci e di forzare questa insensata condizione di blocco attraverso azioni di disobbedienza civile di massa. La situazione ambientale è gravissima. Ma nessuna forma di potere istituzionale vuole prendersi la responsabilità di intervenire, soprattutto contro la grande finanza e le sue politiche ambientali distruttive.
Ende Gelände fa parte di una rete internazionale di associazioni e attivisti. Come siete organizzati?
La nostra organizzazione è fatta quasi completamente di volontari. Alcune persone lavorano a tempo pieno per coordinare la comunicazione mediatica, i siti web e le relazioni internazionali con le altre associazioni. Per il resto siamo tutti attivisti. Crediamo che la politica debba recuperare il suo lato alto, nobile. Del resto, lottiamo per interessi comuni e quindi anche per noi stessi.
Scopo principale della vostra lotta politica è quello di fermare il riscaldamento globale. Da anni ormai esistono studi Onu e Fao che mostrano come il ciclo agricoltura intensiva/deforestazione e allevamenti industriali sia corresponsabile del riscaldamento globale in una percentuale addirittura maggiore rispetto a quello dell’uso dei combustibili fossili.
La situazione generale è grave e complessa. Noi lottiamo per una giustizia climatica. Facciamo parte di una rete internazionale: solo mettendo insieme la somma delle azioni di tutte le organizzazioni ambientaliste possiamo avere un’immagine della totalità dell’azione politica dei movimenti di contestazione. Ogni gruppo lavora su obiettivi specifici. Noi vogliamo impedire che le miniere della Vattenfal vengano vendute. Ma accanto a noi altri gruppi lavorano per convertire l’agricoltura industriale in agricoltura biologica, per chiudere gli allevamenti intensivi, per sperimentare forme di energie sostenibili e così via. C’è un enorme lavoro politico da fare. Dobbiamo riorganizzare radicalmente la nostra vita quotidiana. Oggi abbiamo la tecnologia per farlo. Ormai è solo lotta politica. Dobbiamo riuscire a politicizzare il senso comune.
Di cosa parlerai ai colloqui di Dobbiaco?
La politica deve tornare ad essere una parola nobile. Per farlo deve però necessariamente implicare altri due concetti: il concetto di empatia e quello di giustizia.