


Osservatorio del Sud, 24 marzo 2018.
Dal mercato al progetto
Il flusso di immigrati provenienti da vari Paesi del Sud e dell’Est del mondo si iscrive in un vasto processo di destrutturazione demografica, ma anche di mobilità sociale, che ha dimensioni grandiose e di lunga data. Solo di recente è esploso in forme caotiche e drammatiche a causa delle guerre recenti in Oriente e in Africa. L’Human Development Report 2009, dedicato dalle Nazioni Unite a Human mobility and development, ricordava che «Ogni anno, più di 5 milioni di persone attraversano i confini internazionali per andare a vivere in un paese sviluppato». E i maggiori centri di attrazione erano e sono gli USA, l’Europa e l’Australia. Una migrazione immane che dalla metà del secolo scorso ha spostato circa 1 miliardo di persone fuori dai luoghi in cui erano nate.
In questo quadro europeo confuso e generatore di sentimenti xenofobi, la sinistra ha, in Italia, la possibilità di indicare una soluzione non contingente e transitoria al problema. Una via difficile, ma affatto utopica, che potrebbe addirittura fare da modello anche per altri paesi del continente. Noi possiamo indicare agli italiani e agli europei, contro la politica della paura e dell’odio, una prospettiva che non è solo di solidarietà e di umano e temporaneo soccorso a chi fugge da guerre e miseria. Con le donne, gli uomini e i bambini che arrivano sulle nostre terre noi abbiamo l’opportunità di costruire un inserimento stabile e cooperativo, relazioni umane durevoli, fondate su nuove economie che gioverebbero all’intero Paese.
Un grave squilibrio territoriale.
Occorre partire da una considerazione d’insieme relativa alle condizioni dell’Italia dei nostri giorni.
Il nostro paese soffre di un grave squilibrio nella distribuzione territoriale della sua popolazione. Poco meno del 70% di essa vive insediata lungo le fasce costiere e le colline litoranee della Penisola, mentre le aree interne e l’osso dell’Appennino, soprattutto al Sud, sono in abbandono. Secondo indagini del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione dell’omonimo Ministero, le aree interne rappresentano circa i 3/5 del territorio nazionale e accolgono poco meno di ¼ della popolazione.
Ebbene, queste aree non hanno bisogno che di popolazione, di nuove energie, di voglia di vivere, di lavoro umano.Queste terre possono rinascere, ricreare le economie scomparse o in declino con nuove forme di agricoltura che valorizzino l’incomparabile ricchezza di biodiversità dell’agricoltura italiana.
Un’agricoltura della ricchezza bioagricola
A che cosa ci riferiamo allorché parliamo di agricoltura per ridare vita e nuovi presidi territoriali alle aree interne? Si tratta di uno dei tanti slogan di propaganda politica “movimentista” ? Oppure di un’utopia che non ha alcun fondamento economico, né dunque alcuna possibilità di riuscita? All’obiezione si deve innanzi tutto rispondere con una considerazione storica. Non si tratta, infatti, di una progettazione o addirittura di una aspirazione a vuoto di volenterosi militanti. Per secoli l’agricoltura italiana è stata una pratica economica delle “aree interne”, vale a dire dei territori collinari e montuosi, gli ambiti orografici dominanti nella Penisola.
La seconda obiezione, relativa all’economicità di una agricoltura in queste aree è che occorre intendersi su che cosa si intende per economicità. Per far questo occorre liberarsi di una idea riduzionistica di agricoltura che ha dominato per tutto il secolo passato. In queste aree non si può pensare alla pratica agricola come una impresa industriale che deve strappare margini crescenti di profitto, generare accumulazione di capitale, con sovrana indifferenza per ciò che accade alla fertilità del suolo, alla distruzione della biodiversità, all’inquinamento delle acque, alla salute degli animali, dei lavoratori e più in generale dei cittadini.
Ma che tipo di agricoltura si può oggi praticare su terre lontane (ma non lontanissime, l’Appennino dista sempre relativamente poco dal mare) dai grandi snodi viari e commerciali? La dove non è possibile, né utile, né consigliabile organizzare produzioni di larga scala? Qui si può praticare soprattutto frutticultura e orticoltura di qualità. E sottolineo questo aspetto di novità storica della agricoltura di collina rispetto al passato. Si tratta di una agricoltura di qualità perché essa utilizza con nuova consapevolezza culturale un’attività produttiva fondata sulla valorizzazione di un dato storico eminente della nostra millenaria tradizione produttiva: l’incomparabile ricchezza della nostra biodiversità agricola.
Tale straordinaria biodiversità agricola - frutto dell’originalità della nostra storia e della varietà dei climi e degli habitat che, dalle Alpi alla Sicilia, si ritrovano nella Penisola, - ha espresso la sua vitalità nell’agricoltura promiscua preindustriale. Campi nei quali coesistevano alberi da frutto di diverse varietà, ulivi, viti insieme spesso ai cereali, agli orti. Oggi questa agricoltura ritrova ragioni economiche per rifiorire, innanzi tutto perché è in grado di offrire prodotti che hanno qualità intrinseche superiori, sia di carattere organolettico che nutrizionale, rispetto a quelli industriali di massa. In tanti vivai, Istituti di ricerca - e nelle coltivazioni degli amatori - si conservano ancora in Italia centinaia di varietà di meli, peri, susini, mandorli, peschi, viti a doppia attitudine, insieme a un vasto patrimonio di germoplasma, ecc.
E invece l’organizzazione di una distribuzione alternativa (tramite i gas, i gruppi del commercio eco-solidale, a km 0, ecc) può cambiare la natura stessa del prodotto finale. La diversità e varietà dei sapori, la salubrità e ricchezza vitaminica e minerale del frutto, la sua freschezza e assenza di conservanti e residui chimici, ne fanno un bene che acquista anche sotto il profilo culturale un nuovo valore. E naturalmente il rapporto diretto fra produttore e consumatore tende a rendere bassi e accessibili i prezzi. Dunque, non si propone il ripristino dell’ ”agricoltura della nonna”, ma una nuova economia rispondente a una elaborazione culturale più avanzata e ricca del nostro rapporto col cibo, che incorpora anche una superiore visione della pratica agricola come parte di un ecosistema da conservare.
Questa agricoltura può far ricorso a molti elementi di economicità e di riduzione dei costi, di norma esclusi nelle pratiche industriali. Intanto la varietà delle colture - anche nelle coltivazioni orticole, grazie alla sapienza consolidata della pratica degli avvicendamenti e delle alternanze, ma anche alle nove tecniche come l’agricoltura sinergica - costituisce un antidoto importante contro l’infestazione dei parassiti. E’ nelle monoculture, infatti, che questi possono produrre grandi danni, e debbono essere controllati - anche se con decrescente efficacia - tramite costosi e ripetuti trattamenti chimici.
Altre economie
Nei frutteti si può molto utilmente praticare l’allevamento dei volatili ( polli, oche, faraone,ecc).Tale pratica già nota ai primi del ‘900 in alcuni paesi europei ( ad esempio nei meleti della Normandia)8 e oggi sperimentata da alcune aziende ad agricoltura biologica, combina un insieme sorprendente di vantaggi. I volatili, infatti, ripuliscono il terreno dalle erbe infestanti e lo concimano costantemente con i loro escrementi, facendo risparmiare all’azienda il lavoro e i costi del taglio delle erbe e quello della fertilizzazione del suolo. Ma aggiungono all’economia aziendale uno straordinario apporto produttivo: le uova, i pulcini e la carne di pregio commerciabili tutto l’anno.
Sempre sul piano del contenimento dei costi è utile rammentare che qualunque azienda agricola produce una quantità significativa di biomassa. Sia sotto forma di rifiuti organici domestici, che quale residuo dei tagli, potature, controllo delle siepi, ecc. Ebbene, questo materiale - tramite il metodo del cumulo - si può trasformare in utilissimo compost per fertilizzare il suolo, senza ricorrere ai fertilizzanti chimici, e risparmiando su tale voce di spesa che grava invece in maniera crescente sull’agricoltura industriale. Il costo dei concimi, è noto, dipende dal prezzo del petrolio. Un grande agronomo biodinamico, Eherfried Pfeiffer, sosteneva che un buon terriccio di cumulo può avere una capacità fertilizzante due volte superiore a quella del letame bovino: il più completo fra i fertilizzanti organici. Di questo terriccio si potrebbe fare commercio, come si fa commercio del fertilizzante ottenuto dalla decomposizione di sostanza organica da parte dei lombrichi. Nel Lazio, ad es., esiste qualche azienda che vende humus, un terriccio ricavato dalla “digestione” di letame bovino ad opera dei lombrichi.
Sempre sul piano del risparmio dei costi - senza qui considerare la buona pratica di impiantare pannelli solari sugli edifici, case, stalle, uffici, ecc, per rendere l’azienda autonoma sotto il profilo energetico - una riflessione a parte meriterebbe l’uso dell’acqua. La presenza di questo elemento è ovviamente preziosa e spesso indispensabile nelle agricolture delle aree interne. Ad essa si attinge normalmente con i pozzi azionati da motori elettrici. Se l’elettricità è generata da pannelli fotovoltaici il costo è ovviamente contenuto. Ma spesso non è così. E ad ogni modo, in tante aree interne, l’acqua potrebbe essere attinta in estate senza costi se durante l’inverno venissero utilizzati sistemi di raccolta delle acque piovane.
Infine due questioni rilevanti: il reperimento dei suoli dove esercitare le nuove economie e i protagonisti primi del progetto, vale a dire gli imprenditori, gli uomini e le donne che accettano la sfida. Per quanto riguarda la terra, la sua disponibilità e i suoi prezzi variano molto nelle stesse aree interne. In Toscana il valore fondiario può essere proibitivo, ma in tante aree appenniniche esso ha scarso valore. Senza dire che esiste un po’ in tutte le regioni d’Italia una superficie non trascurabile di terreni demaniali, soggetti a usi civici, o appartenenti ai comuni. Ma sia per questi ultimi che per quelli di proprietà privata si rendono oggi necessarie forme di regolazione e di facilitazione - laddove non esistono già - di accesso alla terra a costi contenuti.
Altro rilevante problema è quello degli imprenditori. E’ evidente che non si può lasciare l’iniziativa imprenditiva alla spontaneità e alla capacità attrattiva di un progetto. Sarà necessaria un’azione concordata con le varie forze territoriali in campo (amministrazioni, Coldiretti, sindacati, comitati locali, associazioni, cooperative, ecc.) che devono svolgere una funzione iniziale di promozione e coordinamento, oltre che di conoscenza e informazione: disponibilità della terra, presenza di boschi e macchie, ecc. Ma è evidente che la ricostruzione di un nuovo ceto di agricoltori per le aree interne passa oggi attraverso una nuova politica dell’immigrazione. Ebbene in che modo, con che mezzi, con quali forze si può perseguire un così ambizioso progetto?
Risulta necessario, in via preliminare, cancellare la legge Bossi-Fini e cambiare atteggiamento di legalità di fronte a chi arriva. Occorre dare agli immigrati che vogliono restare la possibilità di trovare un lavoro in agricoltura, nell’edilizia, nella selvicoltura, nei servizi connessi a tali settori, nel piccolo artigianato. Non si capisce perché i giovani del Senegal o dell’Eritrea debbano finire schiavi come raccoglitori stagionali di arance o di pomodori e non possano diventare coltivatori o allevatori in cooperative, costruttori e restauratori delle case che abiteranno, dei laboratori artigiani in cui si insedieranno altri loro compagni. Ricordiamo che gli indiani hanno salvato di fatto l’allevamento bovino nel Nord d’Italia. Ricordo che tra gli immigrati sono presenti attitudini e saperi agricoli che potrebbero avere ben altra destinazione.
Certo, il motore politico-istituzionale per avviare l’operazione dovrebbe essere un vasto movimento di sindaci. Su tale fronte, la strada è già stata aperta alcuni anni fa non senza risultati. Mimmo Lucano e Ilario Ammendola, sindaci di Riace e Caulonia, in Calabria, hanno mostrato come possano rinascere i paesi con il concorso degli immigrati, se ben organizzati e aiutati con un minimo di soccorso pubblico. I sindaci dovrebbero fare una rapida ricognizione dei terreni disponibili nel territorio comunale: patrimoniali, demaniali, privati in abbandono e fittabili, ecc. E analoga operazione dovrebbero condurre per il patrimonio edilizio e abitativo. A queste stesse figure spetterebbe il compito di istituire dei tavoli di progettazione insieme alle forze sindacali, alla Coldiretti, alle associazioni e ai volontari presenti sul luogo. Se i dirigenti delle Cooperative si ricordassero delle loro origini solidaristiche potrebbero dare un contributo rilevantissimo a tutto il progetto. Sappiamo che a questo punto si leva subito la domanda: con quali soldi? E’ la risposta più facile da dare. Soldi ce ne vogliono pochi, soprattutto rispetto alle grandi opere o alle altre attività in cui tanti imprenditori italiani e gruppi politici sono campioni di spreco. I fondi strutturali europei 2016-2020 costituiscono un patrimonio finanziario rilevante a cui attingere. E per le Regioni del Sud costituirebbero un’occasione per mettere a frutto tante risorse spesso inutilizzate.
E qui le forze della sinistra dovrebbero fare le prove di un modo antico e nuovo di fare politica, mettendo a disposizione del movimento i loro saperi e sforzi organizzativi, le relazioni nazionali di cui dispongono, il contatto coi media. Esse possono smontare pezzo a pezzo l’edificio fasullo della paura su cui una destra inetta e senza idee cerca di lucrare le proprie fortune elettorali. L’immigrazione può essere trasformata da minaccia in speranza, da disagio temporaneo in progetto per il futuro. Così cessa la propaganda e rinasce la politica in tutta la sua ricchezza progettuale. In questo disegno la sinistra potrebbe gettare le fondamenta di un consenso ideale ampio e duraturo.

L'Espresso,
Non ci sono più le utopie di una volta, decisamente. E quando si affacciano, magari un po' timidamente, lo fanno con i connotati cambiati.In questa nostra epoca, infatti, ad andare alla grande sono le distopie. O la Realpolitik che vola piuttosto basso, e si giustifica spesso a colpi di "Tina" ("There Is No Alternative", come soleva ripetere compiaciuta la signora Thatcher), ma che pressoché nulla ha a che spartire con il realismo alto di personaggi come Thomas Hobbes o Voltaire. E d'altronde, in effetti, ce n'è ben donde, sull'onda di una crisi finanziaria ed economica – o meglio, come palese, un autentico cambio di paradigma del capitalismo – che non molla la presa ormai da un decennio.
E il nostro immaginario, nel corso del secondo Novecento, si è così via via popolato di distopie proiettate dalla letteratura e dalla cinematografia di fantascienza, in particolare per effetto del successo della narrativa di Philip K. Dick (a cui naturalmente si rifà anche il nuovo Blade Runner 2049). E sempre fantascienza distopica è quella al centro del serial televisivo The Handmaid's Tale (Il racconto dell'ancella, ricavato dall'omonimo romanzo di Margaret Atwood del 1985), che ha furoreggiato nelle premiazioni degli ultimi Emmy Awards.
Ma se l'ansia distopica pervade l'età neoliberista – e, a volte, si ha effettivamente l'alquanto spiacevole sensazione di vivere dentro un racconto di James Ballard –, esiste anche chi si dà da fare per mettere in campo delle ricette alternative (magari discutibili, ma comunque utili per cercare di sottrarsi all'onnipresente pensiero unico).
Al proposito, c'è un piccolo Paese che mostra una spiccata vocazione a sfornare visioni utopiche. Si tratta dell'Olanda, nazione libertaria per antonomasia, patria di Erasmo da Rotterdam, di Baruch Spinoza e del comunismo consiliare di Anton Pannekoek (che fu anche il fondatore dell'Istituto di astronomia dell'Università di Amsterdam, a lui intitolato insieme a un asteroide). E, più recentemente, culla dei movimenti per il reddito universale e quello di cittadinanza. Dalle terre basse arriva l'ultima novità in materia – e chissà che non siano proprio la loro collocazione geografica e la natura orografica di piatto fazzoletto di terra, che ha quale unico orizzonte l'infinita visuale del mare e dell'oceano, ad agevolare il plusvalore del pensare oltre certe compatibilità rigide dell'esistente.
A fare dibattito oltre i confini dei Paesi Bassi (dove si è convertito in un best seller) è un libro di Rutger Bregman, classe 1988, storico ed editorialista del trendissimo giornale online nato col crowfunding De Correspondent, che ha ottenuto un paio di nomination per lo European Press Prize.
Si tratta di Utopia per realisti (Feltrinelli), dove lo studioso, dalla scrittura brillante, corre su e giù per la storia (dalla Rivoluzione francese alla robotica contemporanea, dal luddismo all'economia dello sviluppo) perorando la causa di un'utopia «da non prendere troppo sul serio», pena la caduta nel girone infernale dell'utopismo pernicioso e delittuoso di fascismo e comunismo. Dunque, per cominciare, niente fanatismo o settarismo utopistico, da cui uomini e donne di buona volontà si devono premurare di sgombrare il campo. E poi, pur avendo individuato lì l'avversario e la fonte della gran parte dei problemi e delle ingiustizie, un riconoscimento (con una punta di ammirazione) – un po' come fece Karl Marx nei confronti della borghesia e del capitalismo – alla forza trasformatrice del neoliberismo e alla sua capacità di riplasmare il Villaggio globale a propria immagine e somiglianza.
A partire dalla persuasione, espressa da Friedrich von Hayek, che «le idee e le credenze umane siano i motori principali della storia» (una visione, solo in questo, sorprendentemente similare alle convinzioni del suo antagonista per antonomasia, il grande John Maynard Keynes). Per continuare con la reinvenzione semantica e ideologica – dagli effetti devastanti – della categoria di "liberismo", la quale, nel senso comune e nell'immaginario-ideologia collettivo, ha smesso da tempo di identificare l'originaria dottrina economica per trasformarsi nella facoltà – dichiarata alla stregua di un "diritto" – di «essere solo se stessi», e di «fare quel che si desidera», come dire dalle macchine desideranti di Gilles Deleuze al "capitalismo libidinale" trionfante descritto da Bernard Stiegler.
Il punto è che indietro (dalla condizione postmoderna), in tutta evidenza, non si torna. E, quindi, bisogna immettere al suo interno un progetto – concetto caro alla modernità di derivazione illuministica – differente, e alternativo. Et voilà l'utopia per realisti, che magari rischia di provocare qualche delusione nei romantici inguaribili e negli antisistema accaniti, così come nei nostalgici della restaurazione di un (impossibile) mondo fordista. E il catalogo dell'intellettuale olandese prevede il decremento dei consumi e la riduzione dell'orario di lavoro (un cavallo di battaglia di Keynes nel suo utopistico Prospettive economiche per i nostri nipoti del 1930), una società aperta che superi i confini statali e una drastica lotta contro la povertà combattuta con un reddito universale di base. Nei cui riguardi, forzando un poco (ma senza esagerare), si può dire che Marx e Karl Polanyi erano duramente contrari, mentre Richard Nixon e Milton Friedman favorevoli (o almeno possibilisti).
Perché una destra e una sinistra classicamente intese esistono ancora, sostiene Bregman, ma faticano sempre più a dare risposte adeguate a fronteggiare i complicatissimi tempi che viviamo. E sembrano intrise di "Retrotopia", per dirla col titolo dell'ultimo testo (edito da Laterza) dello scomparso Zygmunt Bauman. E un'utopia per realisti potrebbe anche essere quella tratteggiata dallo studioso di geopolitica Parag Khanna nel suo La rinascita della città-Stato (Fazi), dove teorizza il modello degli "info-Stati", la cui governance si basa su tecnocrazia "illuminata" e Big data per dare risposte efficienti ai cittadini (e il cui simbolo è Singapore, che per qualcuno potrebbe invece identificare una distopia).
In ogni caso, qui non siamo precisamente dalle parti di Tommaso Moro, di Tommaso Campanella o di Étienne-Gabriel Morelly. Quanto, piuttosto, in presenza di utopie a congruo tasso di realismo. Visioni, per certi versi, più domestiche e praticabili, con ricadute circostanziate e determinate, e quindi contestualizzate in un quadro che si caratterizza per la resilienza e la longevità quasi inscalfibile del pensiero unico. La nozione di un'"utopia realistica" può allora suonare come un autentico paradosso. Ma, appunto, di paradossi (postmoderni) è disseminata e costellata la nostra problematica contemporaneità.
 «Esperti e tecnici che si dedicano solo a contare e ottimizzare sono pericolosi».
«Esperti e tecnici che si dedicano solo a contare e ottimizzare sono pericolosi».
L'Espresso, 11 giugno 2017 (c.m.c)
Se è vero che siamo nell'epoca della post-politica, certo non siamo nella post-economia. Ma chi sono gli economisti di cui ascoltiamo le proposte? Bisognerebbe distinguere fra "numeristi" e umanisti. I primi corrispondono a una fantasia che il profano ha dell'economia: una specie di super-ragioneria, che amministra i conti nazionali. Visione falsa. La vera economia, come dice l'etimo della parola, ha per oggetto la vita quotidiana, il governo dei suoi affanni: le misurazioni quantitative ne sono solo uno strumento.
Václav Havel ha chiarito il pericolo della economia "numerista" nella prefazione al testo di T. Sedlácek L'economia del bene e del male (Garzanti). Gli economisti dediti solo a contare e ottimizzare sono pericolosi. Se affidassimo loro l'amministrazione delle orchestre, eliminerebbero le pause dalle sinfonie di Beethoven. Perché pagare i musicisti quando non lavorano? Forse perché, eliminandole, la sinfonia sparirebbe. La mente umana cerca l'armonia: che include l'eccitazione ma anche la pausa.
Il dilemma numerismo-umanismo tocca le grandi questioni economiche, rivelando la loro profonda natura psicologica. Il fisco sta al centro di ogni politica: particolarmente per il cittadino italiano, consapevole dei compiti sociali, eppure – per secolare mancanza di identificazione con lo stato – spesso suo evasore. Immaginiamo un paese A dove le spese pubbliche corrispondano al 40% del prodotto nazionale (PIL). Se A è un paese virtuoso, lo stato imporrà tasse per il 40% del PIL: i cittadini le pagheranno e il bilancio pubblico resterà in pareggio. Immaginiamo ora un paese B. Anche qui le necessità della spesa pubblica corrispondono al 40% del PIL: ma i cittadini in media nascondono metà dei loro redditi. Cosa farà lo stato? Se li tassasse al 40% andrebbe in bancarotta. Sceglierà una tassazione nominale dell'80%. Presumibilmente ne incasserà metà, cioè 40%. Così, anche il paese B manterrà i conti in ordine.
Per il numerista i due sistemi sono equivalenti: sia A che B riescono a pareggiare il bilancio e a fornire prestazioni pubbliche pari al 40% del PIL. Non per quello umanista. I costi numerici sono apparentemente uguali, quelli psicologici ben diversi. In B il cittadino medio dovrà tenere una contabilità doppia per i suoi redditi, ufficiali e nascosti; avrà costantemente paura di confonderli e di essere scoperto; nasconderà i guadagni evasi "sotto il materasso", rischiando di dimenticarli o farseli rubare; spesso rinuncerà a mezzi di pagamento moderni come la carta di credito o il bonifico per internet.
Ma soprattutto, anche se negherà di avere veri sensi di colpa, proverà un disagio indefinibile: qualcosa in lui "sa" che non dovrebbe andare così. Insomma, se risparmierà sulle tasse sosterrà un "costo psicologico" che non è misurabile numericamente, ma è molto alto. Avrà un reddito pari al cittadino di A, ma una qualità della vita decisamente peggiore. Non è finita: anche la sua controparte, il rappresentante dello stato, pagherà costi psicologici seri. Incontrando il cittadino, darà per scontato che questi ha la coscienza sporca. Non potendolo dimostrare, e non potendo nascondere soldi a sua volta, sentirà di essere il babbeo, sacrificato a una maggioranza di furbi; reagirà trattando il cittadino in modo freddo, o altezzoso, o ostile: quando non si farà addirittura tentare dal "ognuno deve pensare a se stesso", chiedendo pagamenti sottobanco. Anche lui sarà spesso di malumore e stressato. Perderà la fede nel suo lavoro e nella società cui esso è destinato. Come un disperato abbandonato dal suo Dio, tanto l'uomo dello stato che il cittadino non "crederanno" più in un ordine sociale, ma nel circolo vizioso della diffidenza.
Se il calcolo della evasione sarà stato corretto, a fine anno i numeri torneranno: ma durante tutto l'anno ognuno avrà vissuto nello stress, perché si basava su una stima indiretta della frode, non su dati certi. E, proprio come la cattiva coscienza, anche l'insicurezza costante ha un alto costo psicologico.
Prendiamo ora un altro esempio. Una valuta stabile è da sempre apprezzata perché evita l'incertezza dei prezzi. È il motivo per cui in tutto il mondo si convertono i risparmi in Dollari o Franchi Svizzeri. Purtroppo, i politici sono eletti per un periodo limitato di tempo. Se l'economia è stagnante, per saziare gli elettori qualcuno propone la svalutazione. Per riavviarla oggi in Italia bisognerebbe innanzitutto tornare alla lira, abbandonata a costo di lacrime e sangue proprio per la sua instabilità. Il politico che la suggerisce si affida però a un numerista, che dimostra con cifre il suo argomento. Se svalutiamo del 20%, sul mercato internazionale le nostre merci costeranno 20% di meno.
Aumenterà l'esportazione: non per maggior fiducia nella produzione del nostro paese (che al contrario si riprenderà la reputazione di esser poco stabile) ma per immediata convenienza (in altre parole: gli stranieri saranno incoraggiati a comprare, ma scoraggiati dall'investire in Italia). Naturalmente molti prezzi internazionali – come quello del petrolio, quotato in Dollari – resteranno invariati: cioè costeranno il 20% in più per noi che abbiamo svalutato. Questo aumenterà sia le spese di chi usa l'auto sia quelle dei produttori: che però ora esportano di più. Logicamente anche i dipendenti vorranno qualche beneficio: il loro costo della vita (che include petrolio e altri beni importati) sta crescendo. Sommando tutti questi aumenti, dopo un po' le nostre merci costeranno un 20% in più. Il vantaggio è svanito. Il numerista interverrà: Svalutiamo ancora, magari del 30%! E, quando avremo esaurito lo slancio, un'altra volta. Insomma, se abbiamo creato un vantaggio esportativo, e poi lo abbiamo perso, abbiamo trovato un equilibrio: la produzione funziona, anche se a singhiozzo.
Non con nuove tecniche, ma con quella del criceto, che crede di viaggiare quando corre nella ruota. Una trappola che ha torturato l'Argentina: che però, non essendo popolata da criceti, è scivolata nella esasperazione. Mentre l'inferno circolare ruota, produttori e dipendenti vivono nell'insicurezza: senza vedere un orizzonte in cui terminerà, perché la via della svalutazione è un viaggio di cui si conosce l'inizio, ma difficilmente la fine. Non potendosi stimare le spese per gli anni futuri, si faranno sempre meno contratti a lungo termine e si programmerà sempre più alla giornata. Questo lascerà cicatrici perfino nel rapporto tra le generazioni, un cui asse portante è lo sguardo dei genitori lanciato verso il futuro dei figli.
Impariamo anche questo dal Sud America, dove continue inflazioni hanno disabituato a pensare se stessi nel futuro lontano: in qualche caso contribuendo addirittura alla diffusione dell'Aids, perché la malattia si manifesta solo nei decenni. Alla lunga, qualunque costo psicologico viene presentato all'incasso: quelli della manipolazione numerica sono silenziosi veleni. Governare gli uomini come se fossero numeri e non psicologia è l'errore più grave che i politici possano commettere.
 «"Attualità del paradosso: si cancellano le differenze e crescono le disuguaglianze; il mondo è ogni giorno più uniforme e più disuguale". Un estratto del testo che l'antropologo francese ha dedicato al festival
«"Attualità del paradosso: si cancellano le differenze e crescono le disuguaglianze; il mondo è ogni giorno più uniforme e più disuguale". Un estratto del testo che l'antropologo francese ha dedicato al festival
Vicino/lontano di Udine, che verrà letto domenica 14 maggio». il manifesto 13 maggio 2017 (c.m.c.)
Da dove viene il malessere che caratterizza tutti i dibattiti sulla cultura e l’identità? Un paradosso è evidente: il mondo globalizzato è anche il mondo della più grande differenza, dove crescono la circolazione, la comunicazione e il consumo. Eppure coloro che circolano non consumano e non comunicano nelle stesse proporzioni e condizioni. Di qui l’attualità del paradosso: si cancellano le differenze e crescono le disuguaglianze; il mondo è ogni giorno più uniforme e più disuguale. Le conseguenze sono almeno due.
Da un lato, su scala mondiale, l’esterno, anche quello di cui si nutre l’interno, è in via di sparizione e la distinzione interno-esterno perde la sua pertinenza. Si delineano tre tendenze che costituiscono, a diverso titolo, una minaccia o una costrizione per la vita culturale: la globalizzazione imperiale, quella «scoppiata» e la globalizzazione mediatica.
La globalizzazione imperiale è quella che tentano di immaginare gli Stati Uniti, la potenza dominante, o almeno certi suoi rappresentanti. Tutto avviene come se, in assenza di un esterno e di un’alterità radicale le diverse culture nazionali trovassero nuova linfa all’interno, riscoprendo le tradizioni che le ideologie nazionali del secolo scorso avevano cancellato: si riscoprono le regioni, le minoranze, i piccoli paesi.
Gli antropologi americani «postmoderni» hanno sviluppato da questo punto di vista una teoria sottile che chiamerei «globalizzazione scoppiata», attirando l’attenzione sulla diversità rivendicata del mondo. Ma sarebbe senza dubbio un’illusione vedere in queste rivendicazioni il principio, l’espressione e la promessa di uno scambio futuro e di un rinnovamento prossimo delle culture. È necessario infatti né sottostimare il carattere stereotipato delle rivendicazioni particolari, né la loro integrazione nel sistema di comunicazione mondiale.
La globalizzazione scoppiata corrisponde a un momento della storia del pianeta dominato dal mondialismo economico e tecnologico: quest’ultimo si adatta bene ai particolarismi culturali, specialmente se non si occupano del campo del consumo e delle regole del mercato.
Il lavoro tipico di quella mediatica è, invece, la spettacolarizzazione delle differenze e, al limite, il loro consumo. Prima di tutto il consumo turistico: il candomblé brasiliano, gli accampamenti yanomami, i guerrieri masaï fanno parte dei programmi turistici europei e del consumo televisivo, cinematografico e fotografico. Tutto rende problematico lo statuto dell’avvenimento, fino a concepirlo e a metterlo in scena solo per la televisione.
Prendere coscienza delle gravi disuguaglianze che pesano sul destino del mondo che verrà, denunciare le illusioni di una vita che si arrende alle tecnologie della comunicazione, inquietarsi per le condizioni con le quali il riferimento planetario si impone a tutte le società e a tutte le culture del mondo, non è voler ignorare il carattere ineluttabile della mondializzazione, e ancora meno rifiutare le chances offerte, in molti campi, dallo sviluppo delle tecnologie. Aprirsi al futuro oggi significa aggiungere al patrimonio culturale e alla cultura di ogni essere umano l’esperienza delle tecnologie della comunicazione e un massimo di conoscenze scientifiche: una conoscenza generale dei problemi.
Ogni riflessione sulla cultura di domani dovrà tener conto di due ostacoli fondamentali: il fossato, l’abisso, che si allargano sempre più tra i più ricchi e i più poveri, tra coloro che avranno accesso alla cultura e coloro che non l’avranno. Il secondo ostacolo potrebbe contribuire allo sviluppo del primo: l’invenzione delle immagini e il rischio che essa comporta di farci prendere lucciole per lanterne, dei simulacri per realtà.
Marx diceva che dietro i rapporti tra le cose ci sono i rapporti tra gli uomini: questo è ancora più vero per le immagini. L’individuo da un lato, il pianeta dall’altro: e dall’uno all’altro una molteplicità di relazioni non riducibili allo scambio di informazioni permesso o imposto dalle tecnologie della comunicazione. Su scala globale la diversità necessaria al dinamismo culturale si confonderà forse un giorno con quella di miliardi di individui che, ciascuno per la propria parte, sono e saranno ancora di più nel futuro un mondo e una cultura. Così, a differenza delle altre, l’utopia di oggi ha trovato il suo luogo: il pianeta.
il manifesto 12 maggio 2017 (c.m.c.)
«O ci liberiamo dall’idea occidentale di umano o non sopravviveremo a lungo». Sono piuttosto netti Deborah Danowski ed Eduardo Viveiros De Castro, entrambi ricercatori presso il Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico, in Brasile. L’intenzione non è quella di fare dell’allarmismo o di alimentare un orizzonte squisitamente teorico postumano, già tanto frequentato. Hanno un’aria pacifica e la voce di entrambi si fonde in un’articolazione filosofico-antropologica che precisano da diversi anni.
Hanno scritto Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine (Nottetempo, pp. 320, euro 17, traduzione di Alessandro Lucera e Alessandro Palmieri). Le formazioni sono diverse (Danowski insegna filosofia alla Pontificia Universidade Catolica di Rio de Janeiro, mentre Eduardo Viveiros De Castro antropologia sociale presso il Museo Nacional dell’Universidad Federale) eppure, nella strana alchimia della relazione, in questi anni si sono esercitati a pensare insieme in un confronto serrato proprio con quella domanda che dà il titolo al libro, pubblicato in Brasile tre anni fa e che, nell’edizione italiana, ha una introduzione aggiornata.
Il titolo che avete scelto per il vostro denso volume è una domanda che preferite mantenere «radicalmente aperta». A parte quello a venire, viviamo o no nel migliore dei mondi possibili?
Questo è l’unico mondo che abbiamo, non ne esistono di infiniti. Detto questo, è impossibile essere ottimisti al modo in cui lo era Leibniz, del resto lui aveva come garante Dio e non poteva certo immaginare ci saremo trovati in questo stato di cose: la crisi climatica e più in generale ecologica, per esempio. A Leibniz dedichiamo una nota del libro ma la prospettiva non può più essere orientata verso un perfezionamento storico, quel migliore dei mondi possibili ipotizzato dal filosofo è come se fosse all’apice di un’immagine piramidale, non sappiamo quale sia il peggiore ma esiste un collasso che non possiamo più ignorare.
«Ci troviamo in un momento descritto con maggiore efficacia dalla visione termodinamica, o forse – ancora più precisamente – dall’entropia, a livello sociale, politico, economico e della stessa condizione del pianeta».
Vi concentrate sull’idea di «fine». Conclusione singolare, biologica, e al contempo di tutte le cose. In che modo l’avete declinata?
«Esistono molti tipi di «fine» e una costellazione di autori che ne danno interpretazioni diverse. Per esempio c’è la fine assoluta di cui abbiamo rappresentazione visiva nel film Melancholia di Lars Von Trier. Poi c’è quella metafisica alla Nihil Unbound di Ray Brassier (che viene collocato insieme a Iain H. Grant, Graham Harman, Levy Bryan sotto l’etichetta di «realismo speculativo»); quindi dal momento che tra circa tre miliardi di anni il nostro mondo finirà, tanto vale considerarci già morti da un punto di vista metafisico. In questa tesi la morte è considerata una verità ontologica. La posizione tanatologica prevede una forma di nichilismo attivo perché la consapevolezza della ineluttabilità della morte come destino universale è una acquisizione della intellegibilità delle cose. Non c’è un Dio. Nulla di esterno ci salverà e dobbiamo accettarlo.
«Non siamo profeti dell’Apocalisse, ci sono molti modi diversi di intendere la parola «mondo» e la parola «fine». Fine della specie, fine del cosmo, della civiltà, del capitalismo. Ci sono molti mondi che possono finire e alcuni di essi sarebbe bene che finissero. A un certo punto sarà importante che anche la nostra specie scompaia, i tempi medi di sopravvivenza di ogni specie sono di 2 milioni di anni, la nostra esiste da 200mila anni ma niente ci garantisce l’ulteriore tempo che potremmo avere a disposizione».
Il problema risiede nel dispositivo escludente di una specie che vorrebbe dettare le regole anche per le altre?
«Ciò che ci preoccupa è la fine di questo mondo, forse la nostra specie continuerà ma non i nostri modi di vita. Non dimentichiamo che i nostri corpi, per il 90%, sono costituiti da altre specie. Dobbiamo imparare a stare al mondo in una modalità non essenzialista, abbandonando l’eccezionalismo. Siamo aperti al flusso della materia e della vita, in questo senso siamo integrati all’esistente restando una configurazione momentanea di questo flusso.
Anche l’arroganza antropocentrica ha un suo posto nel ragionamento che avanzate…
La domanda infatti non è se esista o meno un mondo a venire ma se esista vivibile per tutti i viventi, umani e non umani, compresa la parte migliore dell’umanità che certo non siamo noi considerato quel che abbiamo fatto al pianeta».
L’umano che arriverà verosimilmente non sarà maschio, né bianco, forse sarà una donna o chissà. Convocate anche l’impegnativa categoria di «popolo a venire». Da chi si compone?
«Per noi non è un insieme di individui e non è neppure un concetto che riguarda solo gli esseri umani, l’espressione è più complessa ed estesa. È qualcosa di collettivo che non esclude le altre specie. Come ci sono diversi tipi di popolo ci sono numerose pluralità di popolazioni. Spesso c’è un popolo indicato sommariamente come specie umana oppure come categoria politica, pensiamo alla classe operaia, intesa – nella sua universalità – come tratto caratteristico dell’immaginario di sinistra. Per noi invece il popolo non può che nominarsi al plurale, come molteplicità di umani e non umani.
Ogni popolo è connotato da orientamenti che rispondono alle parzialità di ciascuno di essi, pensiamo alle comunità lgbqt, ma anche alle battaglie come per esempio quelle delle donne, alle comunità nere, ma gli esempi sono molti».
«Il nostro presente – scrivete – è l’Antropocene; questo è il nostro tempo. Ma tale tempo presente si rivela essere un presente senza avvenire, un presente passivo». Un tempo fuori sesto che è oltre la distopia e che ha superato la fantascienza. Oltre a descrivere uno scenario di profonda angoscia, quale è il dato di esperienza quotidiana che può aiutarci a non rimanere schiacciati dalle gabbie teoriche?
«Ci sono molti popoli che ci restituiscono esperienze dirette di modi di vivere diversi; cioè non c’è qualcosa da inventare ma qualcosa da osservare, questi popoli vivono fuori della società industrializzata e portano da anni esperienze importanti. Per esempio nelle zone semi-aride nella parte nord-est del Brasile ci sono popolazioni che vivendo in un clima ostile si sono ingegnate con tecnologie. La loro esistenza è già una forma di resistenza all’invasione che prevedrebbe la cosiddetta civilizzazione. I popoli sono molti e le forme di vita escogitate sono altrettante. Non possiamo aspettarci soluzioni istituzionali anche se la grandezza dei problemi è tale che in certi casi dobbiamo di necessità fare riferimento a questo genere di mediazioni. Non è però questo il punto di leva: le forme istituzionali, i grandi organismi internazionali hanno dei limiti che non possiamo ignorare. Dobbiamo osservare meglio e volgerci verso chi ha già sperimentato quella che sarà l’esperienza universale del «mondo diminuito» in cui sopravvivere sarà un compito difficile.»
officinadeisaperi, 22 aprile 2017 (c.m.c.)
«I mendicanti vecchi e incapaci di lavorare ricevono una licenza di mendicità. Ma per i vagabondi sani e robusti frusta invece e prigione. Debbono esser legati dietro a un carro e frustati finché il sangue scorra dal loro corpo». Così uno statuto di Enrico VIII del 1530.
Nel 1547 lo statuto di un altro sovrano inglese, Edoardo VI, «ordina che se qualcuno rifiuta di lavorare dev’essere aggiudicato come schiavo alla persona che l’ha denunciato come fannullone». E più avanti stabilisce che «I giudici di pace hanno il compito di far cercare e di perseguire i bricconi, su denuncia. Se si trova che un vagabondo ha oziato per tre giorni, sarà portato sul luogo di nascita, bollato a fuoco con ferro rovente con il segno V sul petto e adoperato quivi, in catene, a pulire la strada o ad altri servizi». Sono alcuni dei frammenti di quella che Marx, in un celebre capitolo del Capitale, definiva la «legislazione sanguinaria» messa in atto dalla corona inglese a partire dal ‘500, per punire chi si sottraeva al lavoro e dava spettacolo di povertà o creava insicurezza nelle città con i propri furti.
Siamo alle origini dell’ “accumulazione originaria” del capitale e tali feroci disposizioni contro i proletari dell’epoca vengono in mente a leggere le cronache su quanto accade alla frontiera tra Messico e USA, tra la Spagna e il Nord Africa, presso i fortilizi di Ceuta e Melilla, ai fili spinati e ai muri alla frontiera tra la Serbia e la Slovenia, alle barriere di cui si è circondata l’Ungheria, il cui parlamento ha votato l’arresto cautelare per chiunque entri nel territorio magiaro, al muro politico innalzato dal Regno Unito nei confronti di chi arriva dal Continente, alla nostra frontiera con la Francia a Ventimiglia.
Certo, non siamo ancora al marchio di fuoco della lettera C sul petto dei “clandestini”, ma quanto a crudeltà nei confronti dei disperati che scappano da guerre e miseria è solo una questione di grado. I gruppi dominanti dei paesi ricchi e il loro ceto politico sono feroci al punto giusto, quanto è consentito loro da secoli di habeas corpus e dalle conquiste dello stato di diritto dell’età contemporanea.
Ciò che tuttavia rende comparabile la situazione descritta da Marx con quella dei nostri giorni è la causa della formazione dell’esercito degli uomini e delle donne “eslege”, vagabondi e clandestini nel linguaggio dei persecutori. I questuanti che a partire dal XVI secolo vagavano per le città inglesi erano infatti contadini inurbati, cui erano state sottratte e recintate le terre da parte della nobiltà cadetta, che vi allevava pecore merinos. Avevano perso la casa, il cottage, erano rimasti privi dei “mezzi di produzione”, come dice Marx, e perciò migravano in città cercando lavoro e fonti di sostentamento. E qui trovavano il lavoro coatto o la persecuzione: la nuova forma di detenzione della fabbrica industriale arriverà più tardi.
Quanto somiglia la causa sociale dell’inurbamento proletario inglese alle guerre scatenate, o segretamente fomentate dall’Occidente nel Sud del mondo, alla miseria generata dalle sue politiche neocoloniali, ai disastri climatici provocati dal suo consumismo forsennato, da padroni del Pianeta? Gli stati ricchi saccheggiano le economie dei paesi poveri, devastano i loro territori e quando i fuggiaschi si affacciano ai loro confini sono marchiati come potenziali criminali. Nella marcia all’indietro che la storia ha intrapreso negli ultimi anni stiamo precipitando alle origini dell’accumulazione capitalistica…
Ebbene, credo che sia diventato pericoloso ormai per la nostra civiltà il grado di assuefazione con cui le nostre coscienze e il nostro stesso immaginario pubblico si sta adagiando all’orrore. Non possiamo più aspettare reazioni da Bruxelles, né iniziative dal nostro ceto politico. Fanno parte dell’apparato di potere che lavora, insieme ai media, per renderci tutto tollerabile, ordinario, normale, accettabile. Ma i semplici cittadini, ridotti ormai a puri consumatori di merci e di sogni pubblicitari, privi di voce per mancanza di rappresentanza, devono rassegnarsi, convivere impotenti con la barbarie quotidiana?
Io credo che noi colpevolmente continuiamo a trascurare un’arma politica ben nota che potrebbe avere un’efficacia non comune se utilizzata con sistematicità e su scala almeno europea.
Mi riferisco al boicottaggio delle merci. Diversi anni fa persino Umberto Eco la raccomandava come strumento legale di lotta. Ebbene, qual è il paniere delle merci dell’import-export tra l’Ungheria e l’UE? Dal momento che l’Unione che non espelle l’Ungheria, come sarebbe giusto, non potremmo condurre una campagna di boicottaggio dei prodotti ungheresi mostrando al governo di Orban che esiste un’opposizione alla sua politica criminale contro i migranti? Ma deve trattarsi di una battaglia articolata, che deve creare una rete nella rete, nutrita di buona informazione, che duri dei mesi, in grado di uscire, dove possibile, fuori dalla rete, con volantinaggi esplicativi davanti ai supermercati sui prodotti da boicottare, in grado di sostenere una campagna di massa che arrivi sui grandi media, generando allarme tra le imprese e l’opinione pubblica ungherese.
È quanto dovremmo fare anche nei confronti di singole imprese, per esempio contro Benetton, che intende sottrarre le terre dei contadini in Patagonia (A.P. Esquivel su “il manifesto” del 30 marzo) perché i latifondi che già possiede non gli sono sufficienti. Si tratta di una via potenzialmente dirompente. Il capitale ci ha ridotto a indifesi consumatori. Facciamo dell’uso mirato dei nostri consumi un’arma per colpire interessi potenti, trasformiamo la pubblicità nel suo contrario, una campagna di discredito in grado di far comprendere ai signori del capitale che possono essere danneggiati dai loro sudditi e che c’è un limite al loro dominio.
 «I greci avevano “paidéia”, i romani “pietas”, gli illuministi “diritti”: è sempre il linguaggio la culla del cambiamento. Nel linguaggio resiste la culla del cambiamento e l’antidoto a Babele. Da “armonia” a “silenzio” così guariremo da Babele».
«I greci avevano “paidéia”, i romani “pietas”, gli illuministi “diritti”: è sempre il linguaggio la culla del cambiamento. Nel linguaggio resiste la culla del cambiamento e l’antidoto a Babele. Da “armonia” a “silenzio” così guariremo da Babele».
la Repubblica, 29 marzo 2017 (c.m.c.)
Le parole possono essere tante cose: parole di verità o di menzogna; parole che accendono o che spengono; di assoluzione e di condanna; parole che vivificano o che uccidono; che aprono o che chiudono; lievi come carezze o pesanti come pietre. Mai come in questo tempo l’umanità ha parlato: chiacchiere, giornali, radio e televisione, cellulari, web. La parola è il mezzo non unico ma certamente principale della comunicazione. Che cosa dobbiamo intendere per comunicazione? Non voglio fare dell’etimologia, se non per sottolineare che essa ha significato il passaggio da uno a un altro non di parole, ma di cose, per farle diventare “comuni”. Comunicazione significa fare comunanza di oggetti, proprietà, pensieri, informazioni, esperienze, sentimenti, conoscenze del più vario genere.
Con le parole non solo si comunica, ma anche ci si scomunica; non solo si passano verità, ma anche inganni; non solo ci si gratifica l’uno con l’altro, ma ci si denigra anche. Munifico è colui che è prodigo di doni, doni che possono essere buoni e cattivi, come i doni avvelenati. Ma il munus che sta nella comunicazione è anche compito, responsabilità. La società è un insieme di munera reciproci. A tutto questo servono le parole, quando non sono vuote parole. Teniamo dunque ben fermo questo concetto: le parole della comunicazione sono parole di reciprocità, reciprocità di doni e di responsabilità.
Ogni società in ogni sua epoca ha le sue parole-chiave. Nella Grecia classica era paidéia, l’educazione dell’uomo bello e buono a cui si collegavano il coraggio, l’abilità ginnica, la formazione filosofica e musicale, ecc. Nella Roma repubblicana la parola era, per l’appunto, res publica, cosa di tutti sostenuta dal consenso di tutti e finalizzata al bene di tutti. Nella Roma imperiale, era invece la secondo l’ideale che Virgilio associò alla virtù del “pio Enea” per alludere, adulandolo, a Ottaviano Augusto.
Nel Medio Evo, la vita si svolgeva intorno alla salus animarum, alla caccia agli eretici e alla crociata contro gli infedeli. Nella società feudale, le parole erano fedeltà e onore: fedeltà nei confronti del principe cui si doveva riconoscenza per i benefici ricevuti e onore nei confronti del ceto cui si apparteneva. Il Rinascimento scoprì la humanitas.
Gli uomini delle rivoluzioni promosse dai lumi della ragione, alla fine del ’700, scaldavano i propri cuori quando nominavano la umanità, con i suoi diritti imprescrittibili. L’epoca dei “risorgimenti” dell’Ottocento (tra cui il nostro Risorgimento) si è nutrita a sazietà della parola Nazione e della sua potenza. Poi, a missione compiuta, furono il progresso e la modernità, le parole mitiche su cui tutte le altre si orientavano, come aghi magnetici attratti da quest’unico polo.
Veniamo alle parole che usiamo oggi. Si può dire che siano “comunicative”? Se teniamo presente quanto detto sopra circa la doppia valenza della comunicazione: il dono scambievole e la responsabilità reciproca, altrettanto certamente dobbiamo riconoscere che le nostre parole non sono “comunicative”. Al contrario: sono dissociative.
Sono parole circondate da un ideologico alone positivo. Chi direbbe male di innovazione, riforme, sviluppo, crescita, competitività, eccellenza, meritocrazia, successo, e, sopra ogni cosa, business? Ma, ognuna di queste parole ha il suo contrario che condanna all’emarginazione, all’irrilevanza, al rifiuto, all’umiliazione, all’oblio. Per non soccombere tu, deve soccombere qualcun altro. È la legge della concorrenza elevata alla massima potenza. Si vince o si perde la partita della vita rispetto a che cosa? Nelle società competitive si vince o si perde per desiderio di ricchezza, di potere e di fama: tre beni distinti ma collegati che, anzi, si alimentano l’uno con l’altro come una trinità.
La ricchezza, il potere e la fama non sono affatto mali in sé. Ma essi si danno spinte reciproche e contribuiscono, ciascuno per la sua parte, alla smodatezza, all’eccesso, alla sregolatezza. Sulla ricchezza e sul potere così tante teorie, dottrine, ideologie politiche sono state prodotte che non se ne può nemmeno fare cenno. La fama, invece, è rimasta piuttosto in ombra... La si relega tra le innocenti, magari ridicole, aspirazioni degli animi vanesi.
Eppure, anch’essa è oggetto d’impetuosi desideri e pulsioni e, come la proprietà e il potere, modella potentemente le relazioni sociali. Essa, infatti, distribuisce biasimo e lode, alza e abbassa nella considerazione sociale. Vale per la fama la stessa cosa che vale per la ricchezza e per il potere: appropriazione dalla parte degli uni comporta privazioni dalla parte degli altri.
Il veleno non sono in sé i beni materiali, il potere e la fama. Il veleno è l’ingordigia. L’ingordigia è mossa dalla legge dell’auto-accrescimento progressivo. Non può arrestarsi da sé perché contraddirebbe la sua natura. Più si ha, più si arraffa. Denaro, potere e fama sono forze travolgenti che crescono crescendo e, alla fine, non lasciano scampo. All’inizio, si opera per possederli. Alla fine, se ne è posseduti.
Eppure, di una parola da fuori, di una parola eccentrica, c’è bisogno; c’è straordinariamente bisogno nel tempo in cui il darsi da fare stando dentro accresce il disagio. Quella che non c’è non è la parola che mette ogni cosa a posto, rincuorante e incoraggiante; la parola pacificatrice e illuminante; la parola sulla quale si possano raccogliere le forze con unità d’intenti; la parola che sia segno d’orientamento per uscire dal labirinto in cui ci troviamo che, eufemisticamente, possiamo chiamare il malessere della nostra civiltà. Il silenzio.
Nel tempo del frastuono, le energie interiori necessarie contro imbonitori e inquisitori le troviamo facendo silenzio. Solo in silenzio possiamo pensare noi stessi per noi stessi, condizione per poterci poi pensare consapevolmente in relazione agli altri. Il conosci te stesso che campeggiava sul frontone del tempio di Apollo è la formula pregnante della scomposizione-ricomposizione del sé. È il leopardiano «infinito silenzio», dove dolce è «il naufragar». Tutto questo, al di là delle fumisterie filosofiche e degli incantamenti mistici, può esistere. Basta saperlo cogliere.
La solitudine. Solitudine e silenzio si richiamano reciprocamente. L’isolarsi, anche stando in mezzo alla compagnia di altri, è un’esperienza che tutti abbiamo fatto, quando siamo presi da un pensiero. Sembra talora indifferenza o aristocratica sufficienza, onde il richiamo “democratico”: ritorna tra noi. La solitudine è una ricerca d’equilibrio tra questi due opposti richiami, ugualmente vitali: essere tra sé e sé ed “essere tra noi”. Essere solo tra noi, significa perdere se stessi; essere solo se stessi è paranoia, presunzione e narcisismo, i disturbi della psiche che Dostoevskij, più di centocinquanta anni fa, ha descritto ne Il sosia: un racconto che, se letto, con gli occhi dei frequentatori odierni dei social network, ha il carattere della profezia.
Anche per la solitudine, si deve ripetere ciò che s’è detto per il silenzio. Non è l’obiettivo finale. Se tale fosse, sarebbe desolazione mortifera. È il punto iniziale da cui può scaturire una vita sociale feconda.
Il buio. Se è condizione d’arrivo, il buio evoca l’idea del vuoto, della sventura, delle tenebre. Ma, la luce riluce soltanto a partire dal buio. Lux lucet in tenebris. Se dunque la luce è bene, lo è anche allo stesso modo il buio che rende possibile la luce. Che si possa vedere solo nel rapporto tra luce e non luce, tra luce e ombre, lo dice splendidamente il mito platonico della caverna.
Che sia qui la parola che non c’è ma che cerchiamo, nel silenzio, nella solitudine e nell’ombra delle promesse di libertà? Che si nasconda qui la parola con la quale possiamo vedere i guasti del mondo, resistere alle parole di Babele, aprirci alle incognite della libertà, cercare uscite d’emergenza?
Che la parola che racchiude un tale programma di affrancamento possa essere “armonia”? L’armonia è la giusta collocazione reciproca tra parti diverse. In che cosa consista questa giustezza non sapremmo dire facilmente in positivo. Certamente, però, sappiamo che non ha nulla a che fare con la babele che dovremmo avere davanti agli occhi.
*Il testo di Gustavo Zagrebelsky che qui pubblichiamo è una sintesi della sua lectio alla Biennale Democrazia, la manifestazione culturale da lui presieduta e intitolata in questa edizione “Uscite di emergenza”, in programma da oggi a domenica 2 aprile.
: Miseria dello sviluppo di Piero Bevilacqua. Officinadeisaperi, 27 febbraio 2017 (c.m.c.)
Con inappuntabile coerenza i partiti che ormai possiamo chiamare indistintamente liberali, cercano da tempo di adattare le istituzioni formative ai bisogni delle imprese. Più precisamente cercano di piegare la formazione delle nuove generazioni a questa stagione ideologica del capitalismo contemporaneo e ai suoi progetti di dominio. E lo fanno con i più vari strumenti.
Nell’agosto del 2004, l’allora primo ministro britannico Tony Blair, sedicente laburista, conquistò le prime pagine dei giornali con una clamorosa trovata. Fece stanziare dal suo governo mezzo miliardo di sterline per incentivare la competitività nelle scuole inglesi. La logica del disfrenamento competitivo che attraversa l’economia internazionale portata dentro le scuole. Come se già la società non fosse impregnata di violenza agonistica, di individualismo, di lotta. Anche le istituzioni formative devono incorporare principi artificiali, di gara, supremazia, vittoria, sconfitta. Una mimesi della guerra che deve rifondare i valori, rimodellare la formazione culturale, plasmare il comportamento delle nuove generazioni.
Eppure, per secoli il merito culturale, anche dentro scuole e Università, non ha avuto certo bisogno di incentivi alla competizione per emergere. E a cosa porta un arricchimento culturale incentivato dal fine di prevalere sul prossimo?
Perché il medesimo agonismo debba essere replicato più tardi all’interno dell’azienda, dove operai, tecnici, dirigenti, dovrebbero guerreggiare reciprocamente per il bene dell’impresa?
Anche sotto il profilo di questo fine ultimo, noi crediamo che si tratti di un delirio. È sulla cooperazione dei suoi membri che si regge qualunque impresa. Senza dire che oggi nel campo del sapere è la cooperazione e il dialogo fra discipline diverse a far premio alla conoscenza. Così è nel campo della medicina, negli studi ambientali o nelle scienze della terra, per non dire delle migliaia di scienziati dell’Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) che oggi concertano le loro disparate competenze per studiare il clima che cambia.
Ma oggetto dell’aggressione da parte dei partiti – in questo caso soprattutto della destra – è stata negli ultimi decenni la scuola pubblica. In Europa colpi d’ariete le sono stati lanciati contro, con varia fortuna. In Italia, soprattutto nei primi anni del governo di centro-destra, sono state intraprese vere campagne di diffamazione. Non solo i fogli della destra, ma anche Il «Sole 24 Ore», il giornale della Confindustria, ha ospitato articoli in cui la scuola italiana, accusata di statalismo, veniva trattata alla stregua del Monopolio dei Tabacchi.
Eppure, quella scuola, laica, pluralista e universale nei suoi programmi – i cui insegnanti vengono scelti non per appetenze confessionali o ideologiche, ma in base al merito e con pubblici concorsi – costituisce una delle grandi conquiste della democrazia repubblicana. Quel tanto di mobilità sociale che ha attraversato l’Italia nella seconda metà del Novecento – che ha permesso a figli di contadini e operai di diventare professionisti – lo si deve alla scuola pubblica. Difficilmente un Paese uscito da una guerra rovinosa, povera di materie prime e di fonti energetiche, con danni ingenti all’apparato produttivo, sarebbe diventato un grande Stato industriale senza un scuola capace di produrre tecnici, quadri dirigenti, professionisti dai molteplici saperi.
Ma certo la pressione maggiore è stata esercitata sugli indirizzi della formazione. E qui l’unanimità di posizioni del ceto politico è venuta crescendo di anno in anno. L’imperativo, ormai da tutti invocato, è uno solo: modellare la scuola «secondo le esigenze della società». Una perorazione eterna, com’è noto, che perde il suo antico significato positivo se nel frattempo la società si identifica con l’impresa con il cosiddetto libero mercato. In realtà l’esigenza continua di rimodellare le strutture formative non è che il frustrante tentativo di piegare scuola e Università a un mercato del lavoro sempre più mutevole. L’immaginifica parola d’ordine lanciata dalla destra italiana negli ultimi anni è stata la scuola «delle tre I»: Impresa, Inglese, Internet. Vale a dire la proposta di costruire precocemente soldatini manageriali, cui spalmare addosso qualche approssimativa verniciatura formativa.
Ma non è solo miopia italiana.
A molti, in Europa e nel mondo, questa appare la linea più avanzata dell’innovazione e dunque della modernità. Eppure pochi sanno, o ricordano, che il problema del nesso tra scuola e industria, tra formazione culturale e innovazione tecnologica, è stato affrontato e risolto quasi cinquant’anni fa. È stato Friederich Pollack – uno degli ultimi esponenti della Scuola di Francoforte – nel libro l’Automazione a ricordare i dibattiti dei primi anni ’60 del Novecento. Nel 1962, egli ricorda, a Cachan, in Francia, si svolse un congresso internazionale al quale parteciparono 500 esperti di consulenza professionale di tutti i continenti, con al centro il tema: L’inserimento del giovane in un mondo che sul piano tecnico ed economico si sviluppa ad un ritmo accelerato.
Di fronte alla obsolescenza rapida e continua dei mestieri e delle competenze tecniche, ricorda Pollack, la conclusione del congresso fu che gli esperti di consulenza professionale dovevano consigliare ai giovani «di non specializzarsi». Solo una formazione ricca e universale è il percorso che può salvare un giovane da uno specialismo precoce, che precocemente verrà travolto dall’innovazione tecnologica. Un’acquisizione, dunque, di mezzo secolo fa, completamente rimossa per la rozza furia di «stare dietro allo sviluppo». Una strategia formativa – c’è bisogno di dirlo? – che ha maggior valore strategico oggi, quando un ingegnere meccanico, in una qualunque fabbrica automobilistica, è condannato all’obsolescenza delle sue competenze nel giro di 5-6 anni. Dunque, gli attuali novatori, i riformatori progressisti di tutte le fedi, non fanno in realtà che inseguire un treno partito da un pezzo. Solo che essi continuano a inseguirlo correndo nella direzione opposta.
Tuttavia, non ci sono stati solo questi tentativi e campagne sparse. In realtà una più vasta regìa era già all’opera. Come ormai comincia ad emergere con sempre maggiore consapevolezza e visibilità generale, le riforme (o i loro tentativi) dell’ultimo decennio rientrano nel più ampio disegno di costruzione di nuove e più omogenee istituzioni formative all’interno dell’Unione Europea.
È almeno dalla Dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999 dai ministri dell’Istruzione dei vari Paesi dell’Unione – seguita dalle Dichiarazioni di Lisbona e Parigi e da varie altre iniziative recenti –, che è emersa in maniera lineare l’intelaiatura progettuale di trasformazione e rimodellamento dell’istruzione superiore proposta per il Vecchio Continente. Secondo tali nuove linee – ricorda C. Lorenz in un saggio apparso su “Passato e presente” nel 2006 – tanto la Scuola che l’Università devono ricadere nella logica del New Public Management (NPM), esse cioè devono abbracciare le finalità di servizi organizzati secondo regole di mercato, obbligati ad accettare e conformarsi alle sfide della competizione, secondo gli imperativi di una visione neoliberista dello sviluppo. Dopo la dichiarazione di Bologna – che pur perseguiva giuste finalità di omologazione europea degli studi e dei criteri valutativi – è apparso sempre più evidente che agli iniziali obiettivi formativi sono subentrati criteri di addestramento culturale all’agone competitivo.
Sempre più – ha ricordato Christophe Charle, docente della Sorbona – «le università sono assimilate a imprese o marche che si dividono un mercato di diplomi, il cui valore sociale è misurato in funzione degli sbocchi lavorativi e degli stipendi ottenuti dai laureati di questo “investimento educativo”». È il mercato che preme sempre più direttamente sugli stessi contenuti formativi delle Università. Tutto questo mentre aumentano ovunque le rette per l’iscrizione, che tengono sempre più ai margini i ragazzi socialmente non abbienti e creano un nuovo «darwinismo educativo». Le conquiste egalitarie realizzate su tale terreno, sia in USA che in Europa, a partire dal dopoguerra, si stanno rapidamente perdendo. L’uguaglianza dei punti di partenza, con scuole e Università alla portata di tutti, oggi si va trasformando in una chimera, che rende completo e definitivo il circolo dell’iniquità in cui le società liberali stanno rinchiudendo il mondo.
Ho avuto la ventura di seguire direttamente, in qualità di docente alla Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza di Roma, l’applicazione della riforma universitaria introdotta dall’ex comunista Luigi Berlinguer, nel 1998 e proseguita, senza apprezzabili modifiche, nel 2005 da Letizia Moratti, ministro del governo di centro-destra. Mi è stata dunque concessa la possibilità di osservare molto da vicino la grande trasformazione che si è venuta verificando in poco tempo all’interno di una grande e antica Facoltà umanistica europea. Occorre dire che i mutamenti sono stati rapidi: nel linguaggio di docenti e studenti, nel loro comportamento, nell’organizzazione dello studio e degli esami, nel rapporto con i libri di testo, nei criteri di valutazione culturale. Questi ultimi hanno costituito il vero cuneo con cui la logica accumulativa del profitto, l’utilitarismo carrieristico si è fatta strada nel mondo degli studi.
Com’è noto, per poter plasmare la mente dei giovani allievi secondo procedure di economia aziendale è stata introdotta la misurazione del profitto universitario con il sistema dei crediti. Gli studenti possono accumulare crediti, anche fuori dalle Università, da poter spendere nel futuro come moneta sonante. Il linguaggio bancario non è solo una goffa simulazione e una umiliazione storica per le Università d’Europa, nate nel Medioevo, che hanno fatto grande per secoli questo Continente non solo di economie, ma anche e soprattutto di conoscenze e saperi. Quasi che i nostri Atenei venissero ora rivalutati, sottratti alla loro cadente vetustà, grazie all’efficiente linguaggio delle imprese. Non è solo questo.
Sotto tale aspetto la rimodulazione del linguaggio universitario in ossequio ai dettami dell’economicismo corrente non sembra voler arrestarsi di fronte a nulla. Rivelo qui un particolare poco noto. Affinché la svalutazione di tutto ciò che è pubblico, anche nelle Università, potesse spingersi sino al grottesco, al fine di non lasciare inesplorato nessun angolo del regno del ridicolo, nella nuova normativa è previsto che l’iscrizione dei ragazzi al biennio specialistico si configuri sotto forma di un contratto, siglato tra lo studente e un rappresentante della Facoltà, di norma un docente. Basterebbe questo straordinario segnale per avere un’idea della meschinità senza fondo che deve oscurare la mente del riformatore a cui dobbiamo tali trovate.
Anche l’iscrizione universitaria – che di fatto avviene attraverso un regolare pagamento delle tasse allo Stato – deve fingersi come un atto privatistico, deve schiacciarsi su un modello di subordinazione personale, per apparire economicamente efficiente. Quasi che lo studente fosse un prestatore d’opera – un bracciante agricolo o un fornitore di merci – il quale sottoscrive un impegno di lavoro con una controparte privata da onorare secondo uno standard di efficienza.
Naturalmente non sottovalutiamo il potere del linguaggio. Il riformatore delle università lo sa bene, perciò non si cura del ridicolo. Esso deve addestrare a una nuova visione economica della vita universitaria e degli studi le nuove generazioni. Il linguaggio diventa poi obbligante, perché incarna regolamenti. Così i crediti hanno trasformato i ragazzi in procacciatori di punteggi, come i clienti dei supermercati, che li collezionano per poter riscuotere i premi finali.
Eppure non è questo il cuore del problema.
Non è qui che la riforma neoliberista ha ficcato il suo cuneo devastatore. Non è qui che anche il sapere in generale subisce un colpo micidiale e forse irreparabile. La vera e radicale trasformazione, la rottura programmata di un paradigma culturale secolare – talmente grave e profonda da non essere stata neppure avvertita, probabilmente, dagli stessi programmatori – è che nelle Università, soprattutto nel Facoltà umanistiche, è cambiato il modello storico dello studio, il processo di apprendimento e di formazione, il meccanismo della trasmissione del sapere. Con la moltiplicazione degli esami, ridotti ad esamini, non solo si immeschinisce il quadro della formazione complessiva dello studente, costretto ad imparare poco di tutto, ma si realizza qualcosa di assolutamente nuovo.
La preparazione dell’esame cessa di essere ciò che è stato per tanti secoli fino ai nostri giorni: l’occasione per studiare e approfondire un determinato campo del sapere.
Un campo che diventa nostro e che interiormente ci arricchisce e ci plasma. Con la riforma essa è diventata qualcos’altro. Ciò che prima era studio, lettura di tanti libri su una singola disciplina, riflessione, approfondimento, meditazione, rielaborazione critica, ora, con la moltiplicazione degli esami, si trasforma in una prestazione continua e frammentata, nella rendicontazione di alcune rapide letture a quella specie di verificatore fiscale che è diventato il docente. Gli esami e la loro preparazione così come i crediti vengono misurati secondo un impiego di quantità temporali, contate in ore necessarie richieste, così che il percorso dello studente sia soggetto a un determinata velocità di prestazione come in una qualunque fabbrica tayloristica. La formazione delle nuove generazioni si trasforma così in un percorso a cottimo, piegata a una logica di rendimento temporal-quantitativo, che mette in secondo piano la qualità culturale e spirituale della formazione. Soprattutto abolisce la dimensione stessa della formazione così come l’abbiamo finora conosciuta: intreccio inscindibile di valori spirituali e saperi.
Gli studenti apprendono a concepire lo studio come un lavoro scandito da tempi determinati, soggetto a standard oggettivi di misurazione e si abituano ad essere continuamente monitorati da un’autorità organizzativa posta al di sopra di loro. È la plasmazione aziendale dell’uomo nuovo, così come lo vuole questa recente incarnazione dello sviluppo, un progetto camuffato da via libertaria che rivela un tendenziale volto totalitario, portatore della «tetra visione di una esistenza controllata e aritmetizzata in ogni suo gesto», come dice Claudio Magris.
Il tentativo, dunque, è di creare velocemente nuovi quadri disciplinati da inserire nei vari settori del mercato del lavoro, una sorta di uomo nuovo seriale, con caratteristiche omogenee, flessibile e veloce, adattabile a varie circostanze, interamente modellato dal suo finale scopo produttivo. A essere direttamente minacciata è dunque la figura umana che ci è più familiare, che ha attraversato sinora indenne tutte le civiltà, che è fondamento di ogni civiltà: l’uomo che pensa. Avanziamo, così, a piccoli passi verso quell’avvenire, come dice Emil Cioran, «in cui il rimpicciolimento dell’uomo raggiungerà la perfezione di un’utopia capovolta». Dovrebbe essere evidente, ma non lo è: nella nostra epoca non è il sonno della ragione, ma la ragione, questa ragione calcolante, che genera mostri.
Ancora più stupefacente è oggi il fatto che – a dispetto dello sforzo di piegare il mondo degli studi superiori alle necessità dell’economia al suo vortice distruttivo – esso non sortisce alcun esito concreto sul piano della creazione di nuovo lavoro. Oggi in Europa, e soprattutto in Italia, la disoccupazione intellettuale ha assunto dimensioni forse mai prima conosciute. Un’intera generazione rischia di essere privata del lavoro per il quale si è formata. Non sempre il fenomeno è visibile in tutta la sua ampiezza, statisticamente rilevabile. Spesso è occultato dal fatto che tanti laureati si rassegnano a lavori precari e dequalificati. Ma migliaia di giovani che si sono laureati spesso con il massimo dei voti, che hanno conseguito il Dottorato, che sempre più di frequente hanno nel loro curriculum Master e PhD acquisiti in Italia e all’estero, frequentato stages e simili sono senza lavoro.
In genere si tratta dei ragazzi che hanno utilizzato le borse Erasmus e Socrates nelle Università europee, che conoscono più lingue, che a 25 anni hanno girato buona parte del mondo. Ci chiediamo come sia possibile, in questa fase incerta di costruzione dell’Europa, dare nuovo impulso all’Unione lasciando nell’insicurezza e nella precarietà il fiore della nostra gioventù studiosa. È uno spreco intollerabile – sia per quello che esso è costato alle famiglie e alle finanze pubbliche – sia per il suo potenziale inutilizzato. Da dove può trovare consenso il progetto europeo se lascia nella precarietà la futura élite intellettuale che esso stesso ha allevato?
In realtà, il modello verso cui tendono tanto l’Europa che gli USA – questi ultimi, per lo meno, con incomparabile generosità di mezzi – è di creare nuove figure di ricercatori che rispecchino, coerentemente, tanto il modello formativo avanzante che le tendenze del mercato del lavoro Ricercatori a tempo determinato, sulla base di contratti a scadenza escogitati al fine di incalzarli a prestazioni sempre più efficienti: è questa la nuova frontiera per le nuove generazioni studiose. In Italia il governo di centro-destra, raccogliendo anche idee che sono di tutto il ceto politico, ci ha provato con un disegno di legge delega sul “Riordino dello stato giuridico e del reclutamento dei professori universitari”. Ma è stato sconfitto. La tendenza generale, comunque, è evidente. Si vogliono, per il futuro, ricercatori e docenti che stanno sempre sulla corda, non sicuri del domani, e perciò pronti a piegare la schiena a compiti sempre più severi. Naturalmente, nella dominante logica del “breve termine” tale modello dovrebbe essere altamente produttivo, privo di sprechi e di parassitismi.
Eppure in pochi riescono a immaginare gli effetti di lungo periodo che una simile condizione degli studiosi verrebbe a produrre. Nei giovani sarebbe mortificato lo spirito critico e di innovazione, vista la subalternità ai molteplici poteri, accademici, politici, aziendali cui sarebbe sottoposta la riconferma del loro lavoro. Ma ciò che appare clamorosamente dimenticato è il valore della ricerca non finalizzata a scopi immediati, che lascia libero lo studioso di perseguire le proprie strategie di indagine, senza vincolarlo a scadenze strette di produttività. Tutto ciò che di grande e straordinario hanno prodotto sinora la cultura e la scienza in tutta la storia passata si deve alla possibilità dell’investimento intellettuale di lungo periodo.
Nessuno si è accorto che la stessa nostra civiltà si fonda su tale modello?
Gli storici della mia generazione, in Italia, agli inizi dei loro studi, hanno sempre guardato con invidia ai loro colleghi e coetanei francesi. Questi ultimi agli inizi della loro carriera, godevano della possibilità di lavorare, anche per 5-6 anni e oltre, e con buon sostegno finanziario, all’elaborazione della Tesi di Dottorato. Dopo la laurea, i giovani più dotati potevano impegnare le proprie energie, senza altre cure, in ricerche di vasto respiro e impegno. Da quelle Tesi nascevano i loro primi grandi studi. Ma proprio quella generosa istituzione ha consentito alla Francia di generare la più affascinante e prestigiosa storiografia del Novecento. Una avventura intellettuale come quella delle “Annales”, non ha confronti con gli altri Paesi e ha dato vita alla fioritura di una galleria interminabile di grandi storici, da Marc Bloch a Lucien Fevbre, da Ferndand Braudel a Jacques Le Goff, solo per citare i nomi più noti. E considerazioni analoghe potremmo svolgere per campi del sapere lontani dai nostri.
Quali scopi produttivi perseguiva Einstein nell’indagare i problemi della relatività? Quale contratto a scadenza doveva onorare?
E non è forse noto che uno dei gioielli della tecnologia contemporanea, il computer, è in fondo il frutto ultimo di lunghi studi astratti e disinteressati di matematica?
Le grandi imprese del pensiero non si realizzano con la frusta di qualche aguzzino. Ma fioriscono nelle società nelle quali la ricerca libera e disinteressata è un valore, fa parte di un progetto che non scade l’anno successivo. L’ossessione della resa economica di tutto il nostro agire è il tarlo che oggi immeschinisce ogni impresa.
». il manifesto, 24 dicembre 2016 (c.m.c.)
«Il 2016 è stato un anno storico e turbolento», sostiene con marcato senso eufemistico Mark Zuckerberg in un messaggio video di fine anno registrato dal fondatore di Facebook assieme all’amministratrice Sheryl Sandberg, parte di una serie occasionale di one-on-ones in cui i due dirigenti discutono di temi «social». Questo particolare tête-à-tête ha avuto una eco negli Stati Uniti e in Europa per la valutazione con la quale Zuckerberg ha definito Facebook un nuovo tipo di mass media.
«Facebook non è un tecnologia tradizionale», ha detto il 31enne fondatore del social network che raggiunge di gran lunga più utenti di qualunque radio, televisione o giornale della storia. «Non si tratta di una tradizionale media company. Noi progettiamo una piattaforma tecnologica e ci sentiamo responsabili per come viene utilizzata».
Si tratta di una sostanziale modifica della linea ufficiale dell’azienda di Menlo Park che ad oggi ha tenuto a definirsi piattaforma tecnologica «neutrale» senza partecipazione attiva nel contenuto immesso dagli utenti. «Non scriviamo le notizie che la gente legge sulla piattaforma – ha sostenuto Zuckerberg -, ma allo stesso tempo sappiamo di essere molto più che semplici distributori. Siamo parte integrante del discorso pubblico».
L’acquisizione di una improvvisa consapevolezza editoriale segna una netta svolta per il social network. Facebook utilizzato da 1,8 miliardi di utenti, recentemente è stato ripetutamente chiamato in causa per il ruolo nella diffusione di notizie inattendibili, la marea montante di voci ed illazioni che ha contribuito sensibilmente ad alcuni dei fenomeni «storici» evocati a Zuckerberg, a partire dal voto inglese sulla Brexit per arrivare all’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti.
Per far fronte al proliferare di notizie imprecise o strumentali nella sezione trending l’azienda ha di recente sostituito lo staff editoriale con un algoritmo . Ma «l’automazione» della verità da parte dei programmatori è risultata altrettanto insoddisfacente. La scorsa settimana Zuckerberg ha annunciato l’accordo con una serie di partner giornalistici, fra cui la Abc News e la Associated Press alle quali appalterà le analisi di attendibilità.
I tentativi di mediazione «editoriale», oltre che l’inadeguatezza al ruolo dei programmatori di Silicon Valley, sottolineano la problematica attualmente legata ai social network. Mai come quest’anno è infatti stata esplicitata l’infuenza delle piattaforme come fonti di informazione.
L’elezione di Donald Trump (lui stesso inveterato twittatore), resa possibile in gran parte proprio da una campagna imbastita sul sistematico offuscamento demagogico tramite internet, ha messo al centro dell’attenzione il flagello delle fake news e le devastanti ripercussioni delle bufale virali emerse come più insidiose eredi della propaganda e fondamentali strumenti di persuasione populista.
Paradigmatiche sono ad esempio le attuali diatribe in Rete sull’assedio di Aleppo. Una tragedia efficacemente offuscata dalle infinite polemiche fra post virali che perorano, in termini propagandistici, le cause delle parti in guerra. Il popolo di Facebook è stato così sommerso dalle mille sterili polemiche a base di «like» e controlike, mentre i belliggeranti hanno potuto perseguire indisturbati (e rigorosamente al riparo da occhi giornalistici) i propri sanguinari fini.
Il turbine di «notizie» virali senza possibilità di verifica costituiscono l’orwelliano ecosistema post-giornalistico: una utile cortina fumogena per gli interessi economici, finanziari, geopolitici in campo. Il «turbolento» 2016 di Zuckerberg ha insomma esplicitato come non mai gli effetti potenzialmente devastatanti della «postinformazione» veicolata proprio dai social network.
La rappresentazione forse più agghiacciante a questo riguardo si è avuta il mese scorso con l’episodio pizzagate, quando un uomo armato ha fatto irruzione in una pizzeria di Washington minacciando personale e avventori. Il negozio era stato oggetto di una campagna social che aveva insinuato che fosse la centrale clandestina di un giro di pedofili gestito nientemeno che da Hillary Clinton e dal direttore della sua campagna elettorale, John Podesta. La bufala diffusa ad arte era stata potenziata da migliaia di «ri-post» fin quando un complottista lievemente più squlibrato aveva imbracciato un fucile minacciando la strage. Simili campagne calunniose stanno diventando una norma in Usa dove una costellazione di siti legati alla «Alt Right» usano simili arbitrarie accuse per aizzare l’odio complottista.
Di questa settinmana è invece la notizia di una famiglia ebrea in fuga dalla propria casa in Pennsylvania dopo che una campagna virale l’aveva tacciata di aver ottenuto la cancellazione della rappresentazione natalizia alla locale scuola media del «Cantico di Natale» di Dickens (la guerra contro il Natale è meme favorito di Donald Trump). La bufala paranoica, ormai è evidente, è sempre più precorritrice di una diffuso «anafabetismo dell’informazione» che rende plausibile ogni stravagante accusa proviente da un post scritto da un mitomane online. O da qualcuno vicino a un neoeletto presidente degli Stati Uniti.
Lo pseudogiornalismo viene cioè impiegato sempre più come arma contundente di un dilagante neomaccartismo per invalidare fondamentali meccanismi democratici e rimanda necessariamente alle responsabilità ora riconosciute anche da Zuckerberg. Ma permane un fondamentale equivoco: i social network ambiscono ad essere nuove agorà ma si tratta pur sempre di monopoli privati a scopo di lucro che commercializzano un unico prodotto: gli utenti.
Malgrado la narrazione ormai anacronistica di internet cone inarrestabile democratizzatore «orizzontale» della comunicazione, le piattaforme in rete rappresentano dunque un mastodontico trasferimento di strumenti di dialogo e «informazione» dalla sfera pubblica e politica a quella commerciale, al riparo da molta regolamentazione pubblica e quindi tantopiù suscettibili di strumentale manipolazione.
Nessuno con la possibile eccezione di Wladimir Putin (o Beppe Grillo), ha dimostrato di afferrare il concetto meglio di Trump, che ha come prima cosa nominanto Steve Bannon, operatore del massimo portale di bufale complottiste («Breitbart News»), a super-ministro della disinformazione e braccio destro nella Casa Bianca. E il «summit digitale» al quale Trump ha recentemente convocato i massimi dirigenti dei social network, subito accorsi al tavolo del nuovo inquilino della Casa Bianca, ha esposto la natura essenzialmente mercenaria del complesso tecno-info-industriale.
Il video dei due amabili impresari digitali che discettano disinvoltamente del futuro dell’informazione come di una strategia di new economy, ha trasmesso un affascinante – ed inquietante – scorcio dei nuovi poteri decisionali delle nostre vite.
Il 14-15 ottobre al monastero di Sezano si terrà la prima Conferenza nazionale sull’Utopia, con laboratori, proclamazione di dottori honoris causa in utopia, cena utopica oltre ad esperienze di impossibili resi possibili. Una iniziativa stimolante che ci facciamo raccontare da padre Silvano Nicoletto, stimmatino.
In una società pragmatica e competitiva stupisce sentire parlare di utopia….
«Stupisce, ma in realtà ce n’è un estremo bisogno. Viviamo in una società dove un imperante cinismo riduce tutto a denaro e successo, con una visione di politiche dall’esito immediato: prendi e porta via; una monocultura basata sulla predazione dei diritti, della vita, dei beni comuni e dell’ambiente. Rompere con questi mondi chiusi non è uno scherzo, ma occorre rendere possibili altri scenari dove l’umanità e gli esseri possano semplicemente vivere gli uni assieme agli altri e gli uni per gli altri».
Qual è l’utopia di cui si parlerà nella conferenza?
«C’è bisogno innanzitutto di prendere congedo da una concezione sprezzante dell’utopia, quasi si trattasse di sogni irrealizzabili. L’utopia di cui si parlerà nella conferenza invece è concreta ed ha a che fare con progetti di vita e di società che attendono di essere realizzati come superamento delle attuali prospettive a corta veduta».
Da quale visione parte il sogno utopico di questo progetto?
«Il punto di partenza coincide con una visione che considera come bene comune la possibilità per tutti di vivere insieme. Il sogno (che non va inteso come una chimera) è la realizzazione di una umanità che non toglie a nessuno i beni necessari alla vita per destinarli alle logiche del mercato. Si tratta di un altro modo di vivere più rispettoso di tutto e di tutti, in armonia con tutto ciò che abita e si muove nella “casa comune”». Il Monastero di Sezano (Verona)
Il monastero di Sezano capitale nazionale dell’utopia ? Non sarà troppo ambiziosa questa iniziativa?
«Oltre che ambiziosa, se così fosse, sarebbe anche presuntuosa e per questo il monastero di Sezano non sarà mai capitale nazionale dell’utopia. Tuttavia questo è un luogo (topos) in cui le utopie che già anticipano futuro si danno appuntamento, si confrontano e si sviluppano attraverso una feconda relazione».
Come è nata questa iniziativa, e cosa intende valorizzare?
«La causa remota è il quinto centenario dello scritto di Thomas More sull’utopia. Ma oggi intendiamo dare voce ai molti percorsi che in questi anni i diversi movimenti della terra, della conoscenza, della resistenza al predominio finanziario, dei beni comuni come l’acqua, il suolo, l’energia, l’aria e l’ambiente, hanno realizzato con esperienze di nuove narrazioni del mondo e della vita».
Utopia e realismo contrapposti quindi?
«Non contrapposti ma proposta di nuovi e altri progetti rispetto alla narrazione stantia e scontata che i maestri del realismo continuano a ripetere senza apportare una virgola di miglioramento ai problemi del mondo, ed anzi provocando processi di impoverimento, di squilibri e di guerre».
Sabato pomeriggio ci sarà la proclamazione di alcuni dottori honoris causa in utopia per il 2016…
«Sì, è ormai nella prassi del Monastero del Bene comune, in collaborazione con l’Università del Bene Comune assegnare il dottorato honoris causa in utopia a quelle persone o a quei gruppi che in concreto hanno realizzato azioni ed esperienze in diversi ambiti (economico, lavorativo, educativo, sociale, …) capaci di testimoniare che l’utopia (non luogo) può diventare eutopia (buon luogo)».
Chi sono i nuovi dottori in utopia?
«Quest’anno è stato deciso di premiare la cooperativa sociale New Hope, che sta dando dignità e speranza a tante giovani immigrate; Jürgen Grässlin, pacifista tedesco indomito oppositore dell’industria delle armi e Bernard Tirtiaux, maestro vetraio, scultore, artista, musicista, poeta e scrittore belga». Bernard Tirtiaux
Con che criterio sono stati scelti ?
«Il primo criterio è senz’altro la qualità delle esperienze che rappresentano, vale a dire esperienze capaci di infrangere i dogmi del pensare e del vivere attuali. Un altro criterio individua in persone e in gruppi non necessariamente appartenenti al mondo accademico i candidati per questo riconoscimento. Esiste un mondo complesso di esperienze innovative che necessitano di venire alla luce ed essere riconosciute».
Nel programma dei lavori si legge “Incontro con l’audacia mondiale” …
«In effetti questa sollecitazione dell’incontro con l’audacia mondiale viene proposta nell’ultimo libro, non ancora pubblicato in Italia, di Riccardo Petrella, Au nom de l’humanité. L’autore parla di tre audace: la prima “Dichiarare illegale la povertà” (ovvero i processi che generano impoverimento), la seconda “Disarmare la guerra” e la terza “Mettere fine alla finanza attuale”».
Sembra una scommessa impossibile…
«L’impressione è quella di un’impresa titanica, ma è altrettanto vero che molte micro e macro realtà si stanno muovendo in disobbedienza a questi codici e non è detto che il gigante così possente e terribile alla fine non abbia i piedi d’argilla».
Nel programma della conferenza è prevista anche una cena utopica, di cosa si tratta?
«La conferenza inizierà con una cena curata dallo chef Fulvio De Santa, il cui menù è talmente “utopico” da scartare i prodotti artificiali per gustare i prodotti naturali tramandati dalla saggezza di chi ha lavorato la terra con rispetto e amore, e dei giovani “contadini resistenti”che continuano questa tradizione».
Non solo conferenza quindi, ma festa…
«Certo, non solo conferenza, ma soprattutto festa perché la festa non è un accidente dell’utopia ma fa parte della sua sostanza».
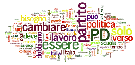 Estratto dell’intervento dell’autore al "Festival del diritto" a Piacenza; quest’anno il tema su cui studiosi di varie discipline si stanno confrontando è quello della dignità. La Repubblica, 24 settembre 2016 (c.m.c.)
Estratto dell’intervento dell’autore al "Festival del diritto" a Piacenza; quest’anno il tema su cui studiosi di varie discipline si stanno confrontando è quello della dignità. La Repubblica, 24 settembre 2016 (c.m.c.)
Eppure, viviamo in un mondo nel quale non è nemmeno possibile stabilire con precisione quanti sono gli esseri umani che non conoscono questo elementare diritto che possiamo chiamare “diritto al segno” o, leopardianamente, “diritto all’orma”.
italiachecambia online, 22 settembre 2016 (c.m.c.)
Il 2 ottobre, nella Giornata internazionale della nonviolenza e nell’anniversario della nascita di Gandhi, Firenze ospiterà un convegno internazionale interamente dedicato a quella che Helena Norberg-Hodge, analista economica vincitrice del Right Livelihood Award (il “Premio Nobel alternativo”) e del Goi Peace Award, definisce l’“economia della felicità”. Insieme a lei saranno protagonisti di questo evento relatori del calibro di Serge Latouche, Jeremy Irons e Vandana Shiva.
Italia che Cambia è mediapartner dell’VIII Conferenza Internazionale dell’Economia della Felicità promossa dall’organizzazione non profit Local Futures e dall’associazione Mani Tese, con la collaborazione ed il sostegno di Terra Nuova e Gruppo Macro.
L’evento consiste in una sessione plenaria di conferenze aperta al pubblico la domenica 2 Ottobre sul tema Economia della Felicità. La conferenza fiorentina segue una serie di fortunate edizioni precedenti, svoltesi in Australia, USA, India e Korea, di enorme successo.
Lo scopo principe dell’evento è quello di ri-pensare l’economia, allontanandosi dal modello di crescita globale condotto dalle multinazionali, a favore di un nuovo modello economico in cui siano centrali la persona e l’ambiente. La struttura stessa dell’attuale economia globale causa instabilità, scarsità (artificiale) e competizione, squarciando il tessuto di comunità e producendo distruzione ecologica su scala massiccia. Collasso finanziario, scandali bancari, debiti enormi, surriscaldamento globale, crisi del petrolio, livelli di disoccupazione in aumento, crescita dei livelli di alienazione personale: tutti questi sono segni della disfunzionalità dell’attuale modello basato sulla egemonia dell’economico e sul mito della crescita globale.
Tuttavia un crescente numero di persone, tra cui ecologisti, filosofi, economisti, attivisti, stanno guardando verso un nuovo modello: quello basato su un’economia localizzata.
La conferenza di Firenze si prefigge in particolare di:
- Dare il via ad un dibattito informato sui temi della economia della crescita globale, in primo luogo i cosiddetti trattati di libero scambio che hanno determinato e determinano il passaggio di potere dai governi nazionali alle multinazionali o Big Corporation.
- Raccogliere esempi concreti di progetti di localizzazione per esplorare un nuovo paradigma economico che beneficia le persone, le loro comunità e l’ecologia – piuttosto che le banche e le grandi aziende.
- Avviare uno studio sistemico e un dibattito sulle idee e le mode culturali che hanno portato nell’epoca moderna all’egemonia dell’economico e del monetario su gli altri aspetti della vita. Solo un analisi accurata delle radici culturali del mito della crescita globale, può portarci ad invertire radicalmente la tendenza perché in realtà un altro mondo è possibile, anzi necessario.
- Esplorare i programmi di gruppi e organizzazioni locali rispetto al passaggio da globale a locale e rivitalizzare le economie e comunità
- Condividere strategie efficaci per un cambiamento sistemico. Questo deve passare per cambiamenti di politica attraverso leggi, tasse e sussidi che penalizzino il commercio e l’economia globale per favorire il locale, l’ecologico, le comunità di territorio.
- Contribuire alla costruzione di un movimento internazionale forte a favore del cambiamento da globale a locale, attraverso il International Alliance for Localization (IAL) ed altre piattaforme condivise.
Repubblica, 9 settembre 2016 (c.m.c.)
Giobbe ha dovuto tenere a mente una grande verità, imparandola in maniera dura: «So questo per la verità, che nessun uomo può vincere la sua causa contro Dio. Se un uomo sceglie di discutere con lui, Dio non risponde a una domanda su mille» (Gb 9; 2-3). Da qui in avanti si capirà cosa vuol dire questa verità di Giobbe.
Molti anni fa Italo Calvino, proprio sui giornali, aveva parlato di una specie di centro “strano”, affermando che: «La società moderna tende verso un complicato set-up, che gravita verso un centro vuoto, ed è in questo spazio, che si rivela vuoto, che tutti i poteri e valori si riuniscono».
Questo processo potrebbe aver dato il via, per ricordare ancora Calvino, a una potente teoria di forza centripeta del vortice di contemporaneità, ad un centro schizzato dai “cadaveri” dei tanti che aspiravano in passato a stabilirsi in un presunto centro che in realtà si è scoperto poi vuoto. Mi sono già confrontato sul tema religioso in molte occasioni e tornerò a farlo ad Assisi nel dialogo con Papa Francesco il 20 settembre prossimo. Ora però l’aspetto più interessante, in questo scritto, è quello che riguarda una figura tradizionalmente vincente e, da qualche tempo, tragicamente perdente: il Dio Padre, il Padre, la Patria. Una precisazione.
Da quanto visto in Polonia, nei luoghi dello sterminio, ma non solo, questo discorso del “centro vuoto” non tocca neanche in parte il pontefice attuale, che esercita un ruolo di Padre sui giovani in cerca di un centro che non trovano. Tralascio al momento quest’aspetto. Non ho intenzione di affiancare il “cadavere” del Padre o di Dio Padre a quello di chi sta esercitando un grande ruolo, anche politico, come Papa Francesco.
 «Emergency è un luogo in cui cura e attenzione alle persone si legano alla «bellitudine», anche in zone di guerra».
«Emergency è un luogo in cui cura e attenzione alle persone si legano alla «bellitudine», anche in zone di guerra».
Il manifesto, 27 agosto 2016 (p.d.)
La «bellitudine» è qualcosa di diverso dalla bellezza, è una parola «sporca», imperfetta, che accoglie le asperità della vita, non ha l’eterea distanza della bellezza. La «bellitudine» sintetizza quello che per noi significa coniugare etica ed estetica.
Ci si stupisce sempre quando si parla di bellezza in progetti d’emergenza come quelli realizzati da Emergency, in realtà ci si dovrebbe stupire del contrario, del perché un ospedale in Africa, in un luogo di guerra, o in una tendopoli post terremoto non dovrebbe essere bello? Non vi è alcun motivo razionale alcuna giustificazione pratica. È semplicemente una questione di cultura e attenzione.
Per questo ci piace parlare di «bellitudine» perché la parola bellezza è troppo «scivolosa», chi decide cos’è bello o meno, in base a quale criterio?
«Bellitudine», invece, si toglie da questa secolare disquisizione, è qualcosa d’altro, più sottotono, modesto: è semplicemente cura delle cose, dei dettagli, delle proporzioni, amore delle persone, in sintesi rispetto. Dal rispetto non può che nascere qualcosa di bello, non può essere altrimenti.
Si è discusso per secoli di bellezza. Alla fine se ne è parlato talmente tanto che ci siamo dimenticati di cosa sia veramente la bellezza. Allora, inventare una nuova parola ci toglie d’impaccio e ci permette di tornare a parlare di bello senza tanti patemi.
In questa prospettiva i progetti «belli» partono da un principio di giustizia. Partono dal presupposto che stare in un luogo, pulito, curato armonioso, anche creativo sia una sorta di diritto.
Non è una questione di costi ma di cultura. La progettazione in zone di crisi ha a che fare con il futuro e non si può che immaginarlo migliore del presente, non avrebbe senso pensarlo altrimenti.
Il futuro ha il respiro ampio dell’utopia non ha nulla a che fare con l’emergenza, deve superarla e basta.
Sono utopie molto concrete: tre alberi in un campo profughi in mezzo al deserto, una parete colorata nel mezzo del grigio di una periferia, un edificio pulito nel mezzo del degrado che sia il post terremoto o il campo profughi, aiuterà le persone ad uscire dalla crisi, dalla disperazione, l’architettura aiuta ad immaginare un futuro (possibilmente migliore).
La «bellitudine» diventa così pratica concreta nei progetti di Emergency, parte dal rispetto delle persone, dei loro diritti di vivere in un luogo accogliente che sia nell’ultima delle periferie, in un campo profughi, o in mezzo alla nuova povertà.
debito». Comune-info, 17 luglio 2016 (c.m.c.)
No, la violenza a Genova 2001 non è riuscita a reprimere le ragioni e la forza del “movimento altermondialista”. Quella ragioni e quella forza sono riemerse in altre forme, come dimostrano ad esempio le lotte di molti territori contro grandi opere e l’estrattivismo, oppure le straordinarie mobilitazioni per l’acqua bene comune e campagne come Stop T-Ttip.
Anche le battaglie per la liberazione dai debiti illegittimi e odiosi, che tante energie avevano raccolto in quella stagione, oggi sembrano riaffiorare, con le diverse esperienze di resistenza alle ricette di austerity applicate ad alcuni paesi del Nord del mondo.
Per questo c’è chi ha scelto Genova per alimentare vecchie e nuove speranze, per mettere in relazioni temi ma soprattutto persone e gruppi, per continuare a «promuovere ad ogni livello la liberazione dai debiti illegittimi, verificare se siamo capaci di attivare percorsi di Audit del debito pubblico a partire da quello degli enti locali… Vogliamo dire con forza che la vita viene prima del debito…»
Genova non è casuale. Questa città, così come il tema del debito, è un crocevia di storie, di sofferenze, di visioni. Chiunque lotta prima o poi si imbatte in questa questione ormai globale. Genova, così come il tema del debito, cerca di essere un telaio che mette insieme più fili affinché possano trasformarsi in un tessuto in cui si colgono, sì le differenze che però non dovrebbero essere mai squarci. Ma Genova è anche stato il luogo di scontri in cui sangue innocente è stato versato: per me sorgente di una nuova umanità.
A tutti coloro che prepararono e vissero quei giorni intensi e drammatici del G8 2001 e che da quei giorni trassero la forza per continuare a saldare culture differenti, ma non indifferenti, a questi penso sia dedicata: «Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia». Ci unisce oggi l’attenzione ai problemi delle persone e dei popoli schiavi del debito e la propensione a privilegiare le esistenze rispetto alle teorie ovvero i volti rispetto alle dottrine. Dopo quindici anni dal G8 di Genova e nell’anno del Giubileo, come cittadini diversamente credenti, ci siamo dati appuntamento per condividere una delle questioni globali più urgenti: il progressivo indebitamento dei popoli dell’intero pianeta.
Indagheremo come, anche in Europa, sembra prevalere l’ideologia della finanza e dei vincoli di bilancio che hanno creato debito, diseguaglianze, risvegliato egoismi, nazionalismi e spinte isolazionistiche che ampliano il solco di un’Europa senza anima, riportando indietro l’orologio della storia a periodi caratterizzati da drammatici conflitti.
Sotto i nostri occhi si consuma l’orrore di esclusioni e della pericolosissima costruzione di muri materiali e mentali, conseguenza di un malinteso senso del limite che colpisce bersagli umani invece di quelli che animano la finanza senza regole, rafforzatasi dopo la crisi a danno di un economia umana.
Sembra infatti prevalere un’economia estrattiva che porta con se privatizzazioni di beni comuni, distruzione, miseria, violenze, guerre, migrazioni epocali e irreversibili cambiamenti climatici che colpiscono aree del pianeta vulnerabili, creando un debito ecologico pagato soprattutto da paesi non responsabili, ma gravati da un debito pubblico in gran parte illegittimo. Verrebbe da dire che ci stiamo allontanando dal terreno dell’umano!
Vogliamo confrontarci in maniera responsabile per verificare se e quali impegni assumere per scongiurare gli effetti di una invisibile dittatura finanziaria e di una economia dei più forti, provando a scegliere di stare dalla parte di chi, come noi, paga il prezzo più elevato di queste ingiustizie. In particolare vorremmo verificare se è possibile promuovere ad ogni livello la liberazione dai debiti illegittimi, verificare se siamo capaci di attivare percorsi di Audit del debito pubblico a partire da quello degli enti locali, smascherando la geografia dei poteri che dietro di esso si nasconde.
La domanda è: vogliamo impegnarci in prima persona cercando di coinvolgere tutte le organizzazioni disponibili affinché siano adottate misure di contrasto al debito privato e pubblico che impediscono la piena partecipazione dei cittadini alla vita sociale, economica e democratica?
Vogliamo dire con forza che la vita viene prima del debito?
Vogliamo e in che misura promuovere e vivere un diverso modello sociale ed economico che rimetta al centro la piena dignità di ogni persona nel rispetto della vita del nostro pianeta? Quindici anni fa i movimenti dicevano che un altro mondo è possibile e da allora molta strada è stata fatta anche attraverso la grande stagione referendaria per l’acqua bene comune, del forum per una nuova finanza pubblica e sociale, dello stop al T-Ttip, delle piccole e grandi battaglie per il territorio, solo per citarne alcune, ma oggi a che punto è la costruzione di quel mondo?
Comune-info, 10 luglio 2016 (c.m.c.)
Dell’ “erba voglio” si dice proverbialmente che non cresce neppure nel giardino de re. Eppure c’è stato un tempo, una stagione «breve, intensa ed esclusiva», in cui è comparsa nei luoghi più impensati: dalla scuola alle fabbriche, agli interni di famiglia.
Tra gli anni Sessanta e Settanta, nella fase di massima espansione della società dei consumi, che prometteva cibo in cambio di una dipendenza incondizionata, due “soggetti” tenuti per secoli ai margini della storia – i giovani e le donne – hanno dato prova di una straordinaria «creatività generativa», destinata a cambiare il volto della politica e dell’idea stessa di rivoluzione.
Con loro hanno fatto ingresso nella polis le categorie del “desiderio” e della “felicità”, guardate con sospetto dalla sinistra parlamentare ed extraparlamentare perché ritenute meno materialistiche di quella del bisogno, e hanno aperto prospettive inedite al “tragico” dualismo che ha diviso e contrapposto privato e pubblico, individuo e società, natura e cultura, destino del maschio e della femmina.
Elvio Fachinelli, originale interprete del ’68, in un articolo uscito sui Quaderni piacentini nel febbraio dello stesso anno, così definiva il «desiderio dissidente»: una «diversa logica di comportamento rispetto al reale e al possibile, contrapposta alla logica del soddisfacimento dei bisogni fino allora dominante».
Il desiderio e la dissidenza oggi sembrano essersi inabissati nella bocca vorace di una civiltà che, pur dando segni di visibile decadenza, macina ogni segnale di cambiamento, ogni forma nuova di socializzazione, ogni sapere che non sia funzionale alla sua conservazione.
Il venir meno dei confini tra vita e politica, anziché portare all’evidenza i nessi, che ci sono sempre stati, tra due poli astrattamente divisi dell’esperienza umana, sembra aver prodotto un amalgama difficile da districare, ma proprio per questo destinato a muovere resistenze, prese di distanza individuali e collettive.
A lasciare aperta la speranza è ancora una volta la lettura che Fachinelli fece dell’“utopia” di Walter Benjamin: «esigenze radicali», di cui si può dire che rappresentino in un particolare momento storico il «possibile attualmente impossibile», e che per questa stessa ragione si ripropongono nel tempo a venire, chiedendo risposte e soluzioni.
Che la crisi economica sia anche la crisi di un modello di sviluppo e di una civiltà che ha avuto come protagonista unico il sesso maschile, che la sessualità sia parte essenziale non riconosciuta della vita pubblica, dei suoi poteri, della sue istituzioni, dei suoi linguaggi, sono acquisizioni oggi presenti nelle coscienze di uomini e donne, più di quanto la generazione del ’68 potesse immaginare. Il «primum vivere», che viene dalle teorie e pratiche originali del femminismo, trova paradossalmente nell’orizzonte chiuso di chi dice di non avere futuro, la sua spinta più forte e più convincente.
Chi ha seguito un’altra logica, un altro ritmo, non può fallire e scomparire per sempre. Attualità e inattualità, presente e passato, continuità e imprevisto, intelligenza personale ed elaborazione collettiva, non ubbidiscono a «passaggi meccanici». Il rimando reciproco non è quello di causa-effetto e del discorso lineare, ma dei movimenti improvvisi, della frattura.
A tenerli insieme è la possibilità della “ripresa” aperta a nuove, impensate soluzioni. Non resta che sperare che la logica del desiderio, come la “passione” di Marx, la spinta ad autorealizzarsi da parte dell’uomo, lavori sotterraneamente, da vecchia talpa, e torni a sorprenderci, quando meno ce lo aspettiamo.
». Il manifesto, 9 luglio 2016 (c.m.c.)
Il rapporto tra poteri e resistenze è anche una partita tra luce e ombra. E non si tratta di stabilire una volta per tutte un primato tra i due ambienti, piuttosto di tracciare la loro reversibilità tattica. Ma se è vero che il controllo oggi si gioca sulla necessità di prevedere il comportamento di soggetti liberi e mobili, ciò significa che la luce su cui si fonda dovrà partire dai soggetti stessi. Da qui, forse, la necessità di un elogio dell’ombra, a quarant’anni da Sorvegliare e punire di Michel Foucault e a più di sessanta da L’uomo invisibile, unico romanzo compiuto di Ralph Ellison.
Sessant’anni potrebbero essere un tempo congruo per disperdere l’eco delle prime parole di quel libro. Eppure erano potenti, le note di un manifesto a venire, una new thing: «sono un uomo invisibile. No, non sono uno spettro, come quelli che ossessionavano Edgar Allan Poe; e non sono neppure uno di quegli ectoplasmi dei film di Hollywood. Sono un uomo che ha consistenza, di carne ed ossa, fibre e umori, e si può persino dire che posseggo un cervello. Sono invisibile semplicemente perché la gente si rifiuta di vedermi: capito?»
Poche frasi e la voce si localizza, facendo di un seminterrato l’indirizzo da cui recapitare un’autobiografia a ritroso destinata a insinuarsi di piatto nelle pieghe di un secolo tagliato a metà dalla linea del colore: «vivo abusivamente in un edificio affittato solo ai bianchi, in una sezione del seminterrato che fu interrotta e dimenticata durante il XIX secolo». Dove può abitare uno squatter nero, in un condominio per soli bianchi, se non nell’ombra? A ripensarci, Ellison è stato davvero lo scrittore dell’ombra.
Shadow and Act è il titolo della raccolta di saggi che seguirà, anni dopo, il primo lavoro – quando ormai il jazz era diventato il suo nuovo condominio, un condominio black, anche se sotto costante minaccia di sfratto, e prima che le 2000 pagine del secondo infinito romanzo bruciassero insieme al tentativo disperato di riscriverle. La questione però era sempre la stessa: la condanna a vivere nell’ombra che diventa possibilità di agire nell’ombra, magari indossando maschere ad hoc, come suggerirà in Black Mask of Humanity. Forse Ellison conosceva l’etimo latino di persona, che rimanda a phaersu, la maschera funebre etrusca, e probabilmente a per-sonare, il suono che passa attraverso una maschera comica, o l’ancia di un sax.
Anonimato mainstream
Due mesi fa un gruppo di ricercatori del Queen Mary ha annunciato di aver smascherato Banksy, membro non anonimo del popolo degli invisibili – schiera eterogenea che dal passamontagna del subcomandante Marcos arriva all’ombra accecante del famigerato Jihadi John, l’aguzzino di Daesh. Le modalità di cattura aggiornano un’«arte» antica, la caccia all’uomo: geo-localizzazione, incrocio di dati, macchie di calore, hot-spot che tracciano percorsi, frequenze, profili. E poco importa che finiscano per confermare vecchie ipotesi, un’inchiesta tradizionale di un tabloid inglese pervenuta allo stesso nome e indirizzo.
Piuttosto vale la pena chiedersi perché proprio Banksy. Lo spiega un articolo sull’Independent: «the academics made the unflattering comparison between Banksy’s street artwork and acts of criminal vandalism». Certo, Banksy è un tagger, mainstream ma pur sempre vandalo. Si è trattato dunque della prova generale di una app da lanciare altrove, nel mare magno del mercato della sicurezza.
Da oggi, si annuncia, vandali, tagger ma anche molestatori oltre ovviamente a criminali e potenziali terroristi non avranno più ombra: nessuno bacerà o ucciderà nell’ombra. La stagione degli uomini invisibili sembra alle nostre spalle. Va detto però che «invisibili», in origine, nel diritto internazionale, erano gli undocumented, soggetti divenuti tali per aver perduto ogni nazionalità: in Grecia e Turchia all’inizio del Novecento, dappertutto nell’Europa a cavallo tra le due guerre, a milioni sotto il Reich e poi ancora nel dopoguerra, per esempio tra gli «sciavi» in Friuli.
La lista si potrebbe aggiornare, se non fosse che gli undocumented di oggi, una volta varcata una linea di fuga, finiscono per lo più sotto i fari di una motovedetta, un molo, una frontiera spinata. E qui diventano visibilissimi, pressoché trasparenti, attraverso hot spot (ancora), bodyscanner, rilevamenti biometrici e schedature che confluiscono in database sigillati in acronimi à la Russolo, come Sis-Eurodac. Per inciso, l’ultimo intervento di Banksy, quando ancora era invisibile (una Marianne avvolta da lacrimogeni con alle spalle un tricolore lacerato), puntava contro lo sgombero della invisible jungle di Calais e la schedatura e la deportazione degli invisibili in centri panottici.
Vite in fuga
Vale la pena chiedersi che fine abbia fatto oggi l’uomo invisibile, se si può ancora scrivere, oltre che leggere, un libro così. I suoi discendenti li ritroviamo per esempio a Philadelphia, accompagnati giorno e notte da Alice Goffman nelle pagine di On the run. Fugitive lifes in an American City per riscoprire, nelle evoluzioni statiche della linea del colore, cosa significhi avere sempre e ovunque i fari puntati addosso: animali in una riserva, prede braccate senza possibilità di ombra o di fuga e con una probabilità su 4 di finire in galera. E allora occorrerebbe chiedersi anche cosa significhi fuggire nell’epoca dei Gps, di segnali agganciati a celle satellitari, nei giorni di una caccia all’uomo che dalle tracce analogiche (un’impronta, una piuma) passa alle scie digitali che ognuno si lascia alle spalle. E magari rendersi conto che road movies come Thelma e Louise o Blues Brothers oggi non durerebbero più di un quarto d’ora, forse anche a Molenbeeck.
In queste pieghe l’invisibilità sembra svanire e lo smascheramento, consapevole o meno, volontario o meno, è all’ordine del giorno. Se la psicoanalisi, quella più easy, segnala che l’individuo «ipermoderno» (narciso/cinico/desiderante) è mosso da un’irrefrenabile pulsione scopica e narrativa (e non serve fare i nomi dei dispositivi social che la innervano), questo soggetto traslucido non lo troviamo solo seduto davanti al rumore bianco di uno schermo ma dappertutto, nelle maglie larghe di un controllo giocato sulla luce e la prevedibilità. In gioco sembra essere la possibilità di abitare i due millimetri che separano una maschera dalla pelle: una parte nascosta, sotto la superficie, che si potrebbe chiamare diritto all’invisibilità ma che è soprattutto ombra, spazio sottratto alla luce.
Chi ha letto Il cerchio di Dave Eggers (un «castello» poco kafkiano e di vetro che vale per google e in cui si dettano gli imperativi morali di una società trasparente), anche a costo di una letteralità lontana dalla scrittura di Ellison si sarà fatto un’idea delle scarse possibilità di recuperare quei due millimetri, la distanza rispetto a soi meme, espressione forse di un’altra verità, mai adiacente e identica, che diventa occasione per de-soggettivarsi, «strappare il soggetto a se stesso». Resterebbero i meandri del deep-web, ma anche lì finiremmo per scoprire che molti hacktivisti, sbandierando la trasparenza come obiettivo e la rivelazione come strategia, adottano strumenti (malware, trojan) e procedure di data-mining analoghi ai cookies di Google e del mercato estrattivo dei big-data o alle logiche di controllo di programmi governativi come Prism.
Invisibilità tattica
Certo, in questi casi un intero regime di visibilità appare ribaltato, e tra le fila di Anonymous è possibile scorgere un’invisibilità tattica che riconduce a Ellison ricordandoci come il conflitto sia sempre mimetico. Resta però un isomorfismo di fondo: il fatto che in tutti i casi (per rivelare o per controllare) le maschere saltano, l’ombra si ritrae e la luce trionfa. Si tratta di una luce che scaturisce per lo più dai soggetti stessi, che induce e soprattutto seduce. E anche qui vale la pena non farsi abbagliare: il prefisso «se-», più che a un immediato gesto riflessivo (se-ducere sta per condurre fuori) rimanda a un movente che origina dal soggetto e lo spinge a competere in primo luogo con se stesso. Del resto l’auto-imprenditorialità, cardine della sharing economy, la ritroviamo ovunque, da airbnb ai makers, e ci restituisce le traiettorie di una soggettività «dividuale», all’incrocio di profili, punti accumulati, in costante competizione e soprattutto trasparente.
«La piena luce e lo sguardo captano più di quanto facesse l’ombra, che alla fine proteggeva.» Sono quaranta gli anni che ci separano da Sorvegliare e punire, percorso che riannoda i fili di tecnologie immanenti che producono corpi docili, imprigionati in anime indotte a credere di essere sempre sotto i fari di uno sguardo disciplinante. Reclusi e osservati in una stanza: la famiglia, la scuola, l’ospedale, la prigione, la fabbrica. Gilles Deleuze ha detto che non siamo più (solo) così. E mentre videocamere e guinzagli elettronici avvicinano l’idea di un individuo portatore del proprio assoggettamento, diverse pareti saltano: l’impresa ha sostituito la fabbrica, il self-care l’ospedale, l’(auto)valutazione l’esame. Lo sguardo incorporato dello schema di Jeremy Bentham (quello del Panopticon) si fondava sull’inverificabilità, ma proveniva da una torre visibile, oggettiva, altra da sé.
Lo spazio del buio
Oggi quello sguardo sembra partire dai soggetti stessi, da dati, tracce e profili autocostruiti prima ancora di venire aggregati e messi a valore dagli algoritmi del capitale. Se governare attraverso la libertà è la bussola neoliberale, una simile libertà è fatta di luce, irretita nelle trappole della visibilità. Ed è sempre il soggetto la posta in palio: che cosa stiamo diventando?
Sulla scia di Kant e dell’Aufklarung Foucault si chiedeva soprattutto questo. In tempi di anime al lavoro, farsi carico del peso dei lumi significa vedere cosa può succedere dalle parti del buio: contro la piena luce di un’esibizione di sé, coatta o meno, sondare lo spazio di agibilità consentito dall’ombra. Edouard Glissant rivendicava il diritto all’opacità come principio di non identità rispetto a ogni sguardo o modello trasparente. Si dovrebbe partire da qui per trovare un antidoto ai fasci di luce che presidiano le professioni di sé e i confini del presente.
». Il manifesto, 8 luglio 2016 (c.m.c.)
Chissà se in uno dei prossimi concerti Bruce Springsteen canterà “Devils and Dust”: «ho il dito sul grilletto, non so di chi fidarmi, ho Dio dalla mia parte e sto solo cercando di sopravvivere – la paura è una cosa potente, prende la tua anima piena di Dio e la riempie di diavoli e polvere….»E’ la metafora di un’America che da un quarto di secolo sta collocata alle crossoads fra onnipotenza e paura, con Dio dalla sua parte ma un mondo ostile e sconosciuto tutto intorno… E’ l’America che fra onnipotenza e terrore ha ucciso Calipari, e che fra onnipotenza e terrore continua gli omicidi quotidiani di polizia (580 nel 2016 finora, cui almeno 100 afroamericani disarmati).
Era “visibilmente nervoso” e spaventato il poliziotto del Minnesota che ha sparato a Philando Castile: gli hanno insegnato che i neri sono tutti pericolosi, criminali e drogati, e che i criminali drogati sono tutti armati. Perciò quando Castile ha ripetuto il gesto che costò la vita ad Amadou Diallo (allungare la mano per prendere il documento che gli aveva chiesto), ha dato per scontato che stesse invece per prendere un’arma: come si può immaginare che un negro abbia un portafoglio? Il poliziotto aveva paura; ma era anche armato e quindi onnipotente: non capisco, ho paura, ma posso uccidere quello di cui ho paura, e lo faccio. Per un portafoglio scambiato per una pistola, Amadou Diallo fu crivellato da 41 colpi, per Philando Castile ne sono bastati quattro.
Del senso di onnipotenza fa parte anche la quasi certezza dell’immunità. Finora nessuno dei poliziotti responsabili di uccisioni nel 2016 è stato punito. Dietro questa impunità c’è il senso – condonato, se non sotterraneamente condiviso, nella cultura delle istituzioni – che le persone di colore sono meno umane degli altri, ucciderle è meno grave. Questo è il gesto che ha sancito la morte di Allen Sterling in a Baton Rouge in Louisiana: un essere pensato come subumano per la sua identità è reso ancora più degno di essere schiacciato proprio dalla sua impotenza, lì a terra indifeso come un insetto che ti invita a schiacciarlo (abbiamo visto una scena identica, e finora identica impunità, anche a Hebron lo scorso marzo).
E infine. Noi siamo governati da un parlamento che ha votato allegramente (Partito “democratico” compreso) che chiamare “orango” una donna nera (l’ex ministro Cécile Kyenge) “fa parte del discorso politico” e non è un insulto. Anche qui, insomma, sono le istituzioni le prime a designare i bersagli di violenza etichettandoli come subumani, meno meritevoli di esistere.
Perciò se un fascista di Fermo chiama scimmia una donna africana sopravvissuta a Boko Haram, si tratta tutt’altro che di un pazzo e di un isolato, di uno che fa parte di una deviante e minoritaria cultura ultrà, ma del portatore estremo di un senso comune che non sfigurerebbe nel parlamento della Repubblica.
E se il marito della donna offesa reagisce, allora l’aggressore è lui: i neri devono stare al loro posto, prendersi ingiurie e insulti e stare zitti. Anche qui, quando la vittima è a terra, l’assassino non si ferma, non è soddisfatto, deve andare fino in fondo, deve schiacciare questo insetto che da un lato ha la sfrontatezza di protestare e ti fa sentire minacciato (ma senti come minaccia la sua mera presenza), e dall’altro non ha la possibilità di colpire e ti fa sentire onnipotente.
Il governatore del Minnesota scappa, i governanti dell’Italia accorrono a Fermo a far vedere quanto sono solidali. Chissà dov’erano quando quattro bombe sono scoppiate, nella stessa città di Fermo, davanti a chiese colpevoli di ospitare migranti e rifugiati. Da noi è meno marcato il senso dell’onnipotenza, ma coltiviamo accuratamente la pianta della paura e siamo maestri nella pietà parolaia intrisa di indifferenza.
In Louisiana e in Minnesota, gli afroamericani scendono in strada, gridano, protestano, cercano di ricordarci che “Black lives matter”, le vita nere contano negli Stati Uniti come nelle Marche. Ma fino a quando continueremo a pensare che le vite dei neri contano solo per i neri, che la Shoah sia un’offesa che riguarda solo gli ebrei, che la strage di Orlando è una questione dei gay, che gli assassini di polizia e gli assassini razzisti siano offese a una “razza” e non offese all’umanità – fin quando la sollevazione contro queste schifezze non sarà universale, anche la nostra rabbia non sarà che parole e polvere.
«». Il manifesto, 7 luglio 2016 (c.m.c.)
Si è concluso a Roma il convegno internazionale su Globalizzazione e diritti fondamentali, organizzato dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco a 40 anni dalla Dichiarazione dei diritti dei popoli, sottoscritta ad Algeri. Giustizia ambientale, finanziarizzazione dell’economia, ruolo dei media e delle reti sociali sono stati i temi in discussione nella giornata conclusiva, moderata da Nicoletta Dentico. Problemi, convergenze, sguardi antichi e nuovi saperi condivisi per ricostruire la cittadinanza del Terzo millennio e prospettive di cammino su questioni di rilevanza globale e nazionale.
La Dichiarazione di Algeri è tutt’ora attuale anche se l’imperante retorica sui diritti umani serve a nascondere iniquità e asimmetrie, imposte anche attraverso le istituzioni internazionali che quei diritti dovrebbero tutelare. «L’imperialismo – scriveva Lelio Basso nel preambolo alla Dichiarazione di Algeri – può sopravvivere solo imponendo un regime di schiavitù a paesi che gli offrono possibilità di realizzare i profitti che gli sono essenziali per un continuo sviluppo». E perciò: «Solo combattendo il sistema, lottiamo di fatto contro la causa delle violazioni».
Parole capovolte e contraffatte nell’ingombro di informazioni interessate che producono «un basso livello di verità» e portano – ha sottolineato l’economista indiana Mary E. John – a non vedere che «l’80% dell’abbigliamento mondiale si produce nei paesi del sud, dove lo sfruttamento della manodopera è più feroce». Una situazione in cui «partiti xenofobi possono presentarsi come falsi paladini della sovranità dei popoli».
Proprio in un contesto simile, «colpisce la capacità di anticipazione della Dichiarazione di Algeri nell’aver colto il carattere dell’oppressione neocoloniale: forse persino più brutale di quella, diretta ed esplicita, coloniale», ha detto Luciana Castellina. E cioè di aver colto e denunciato «la nuova violazione contro l’autonomia dei popoli, esercitata attraverso il capitale finanziario, multinazionale, gli accordi commerciali funzionali all’imposizione di un modello sociale, economico, politico devastante sul piano ecologico, ma gradito all’Occidente».
La Dichiarazione di Algeri – ha ricordato Gianni Tognoni – rifiutava di accettare l’«espulsione» dei soggetti portatori di diritti inalienabili (popoli e individui) dal loro ruolo di protagonisti, «e la loro trasformazione in spettatori-vittime di nuove forme di dittatura, che rivendicavano una impunità completa in nome dell’autonoma normatività dei trattati economici».
Fra le ragioni dei massacri e delle tensioni che scuotono diverse regioni del mondo, vi è anche la creazione di «false nazioni e stati, imposti dalle grandi potenze», ha detto ancora Castellina, portando il discorso sul «popolo più grande e più oppresso, quello nomade dei migranti. Non parlo solo dei disperati che affogano nei barconi – ha aggiunto – parlo del fatto che migrare è diventato un fenomeno generalizato che richiede un nuovo tipo di cittadinanza universale e chiama in causa l’umanità intera».
Il manifesto, 3 luglio 2016 (c.m.c.)
Nessun tempo della storia umana, prima del XX secolo, ha avuto il privilegio di registrare tante dichiarazioni e normative in materia di diritti umani. Salvo poche e brevi eccezioni, mai prima della Dichiarazione universale del 1948 l’umanità era riuscita a distillare e fissare una lingua dei diritti in grado di sostituire tutte le altre parole etiche.
Giustamente l’allora Segretario Generale delle Nazioni Unite Boutros Ghali, aprendo a Vienna il summit sui diritti umani nel 1993, affermò che essi sono «il linguaggio comune di tutta l’umanità» e persino oggi, sfaldate tutte le grandi ideologie, la narrazione dei diritti è la sola ideologia che resiste.
Le norme internazionali sui diritti umani ancora non riescono ad alleviare in misura sensibile la sofferenza dell’umanità, ma su di esse poggia la legittimazione costituzionale di molti Stati, e grazie a esse i movimenti popolari e i decisori responsabili nel mondo hanno il potere di sfidare le pratiche politiche che producono sofferenza e frantumano la dignità delle persone.
Questo potenziale inestimabile non riesce ancora a umanizzare la politica mondiale, spiega lo studioso indiano Upendra Baxi, ma resta l’unica strategia a nostra disposizione per sfidare quelli che John Berger chiama i gesticolanti nuovi tiranni.
Contro questa genia di inafferrabili profittatori, i protagonisti assoluti della storia globale negli ultimi decenni del secolo scorso, il visionario socialista Lelio Basso orchestrò una straordinaria demarche internazionale con un gruppo di militanti giuristi, politici e intellettuali del nord e del sud del mondo, che il 4 luglio 1976 lanciarono ad Algeri la Dichiarazione universale per i diritti dei popoli.
Bisognava denunciare apertamente la contraddizione violenta tra gli assunti teorici di libertà e la pratica storica degli Stati Uniti, e il discorso di Lelio Basso ad Algeri non cede ad ambiguità: «L’espressione centrale della propaganda americana mondo libero equivale a quella di un modo in cui la libera impresa può agire liberamente senza l’ostacolo delle nazionalizzazioni o di qualsiasi altra restrizione un mondo al servizio di quella alleanza tra multinazionali e intervento statale nell’economia che costituisce il perno dell’attuale politica imperialista».
Riproporre la Dichiarazione universale dei diritti dei popoli oggi, a quaranta anni dalla sua proclamazione, può sembrare nostalgica memoria di un’idea oramai sconfitta e datata. Viviamo i deliranti effetti di un mondo in cui il diritto retrocede – con l’eccezione del diritto alla guerra (ius ad bellum) – e il potere elitario avanza.
Le Nazioni Unite hanno definitivamente abdicato alla loro funzione, istituzionalizzando al proprio interno la presenza di un settore privato senza briglie, oggi acclamato come partner essenziale per lo sviluppo sostenibile. Gli accordi del commercio internazionale, costruiti per ispirazione di un mercato sempre più organizzato in cartelli, sono l’unica declinazione della diplomazia internazionale di paesi privi di autonomia decisionale.
Le ingerenze esterne sono esercitate su scala globale da sovrani inconoscibili alla guida della speculazione finanziaria, e questa è la sola novità rispetto a 40 anni fa. I 30 articoli della Dichiarazione di Algeri, così asciutti eppure trasudanti buonsenso di civiltà, hanno mantenuto intatta la loro rilevanza. Semmai hanno acquisito nuove pieghe di attualità nel disegnare l’orizzonte di un ordine internazionale oggi più che mai necessario, incardinato sui diritti di popoli protagonisti, e non più vittime marginalizzate dal diritto formale e dalla storia.
Non è affatto commemorativa dunque la conferenza internazionale che la Fondazione Basso e il Tribunale Permanente dei Popoliorganizzano per l’occasione il 4 e 5 luglio a Roma (http://www.fondazionebasso.it/2015/the-universal-declaration-of-peoples-rights/) con un’agenda ambiziosa e un parterre di esperti da tutto il mondo chiamati a una diagnosi severa, ma anche a proposte di ripensamento, per un diritto dal basso.
Attraverso i temi dell’immigrazione, dell’ambiente, dei popoli indigeni, dei diritti salariali delle donne, la conferenza riprenderà concetti come “democrazia”, “autodeterminazione”, “sovranità” per illuminare i limiti del diritto internazionale nel momento in cui le democrazie costituzionali non sono più in grado, ovvero non sono più autorizzate, ad affermare e garantire i diritti fondamentali dei popoli. Un nodo che noi europei abbiamo imparato a conoscere molto bene.
Altraeconomia, 1 luglio 2016 (c.m.c)
Un uomo dai tratti duri, completamente glabro a eccezione per i baffetti hitleriani, Julius Streicher apparve quasi irriconoscibile -emaciato, spettinato- sul banco degli imputati del processo di Norimberga, che esattamente 70 anni fa si celebrava per punire i “principali criminali di guerra” del Terzo Reich.
Fu condannato a morte per “crimini contro l’umanità” benché non fosse un militare (ma fu un dirigente del regime nazista). Sin dal 1923 - dieci anni prima dunque dell’ascesa di Hitler - Streicher era infatti soprattutto l’editore di una pubblicazione violentemente antisemita, Der Stürmer (“L’attaccante”), settimanale illustrato che raggiunse la tiratura di quasi 500.000 copie. Finì a Norimberga con l’accusa di essere uno dei principali istigatori dell’odio razziale nei confronti della popolazione ebraica e non solo. Il Tribunale internazionale (una realtà fino ad allora inedita nella storia) riconobbe per la prima volta in maniera lampante la responsabilità dell’utilizzo di talune parole -della parola in generale- in caso di crimini efferati.
Più recentemente, nel 1994, durante i cento giorni delle violenze in Rwanda dove morirono un milione di tutsi e hutu moderati, l’emittente radiofonica “Radio Mille Colline” -nota anche come “radio machete”- fu uno dei più «sinistri esempi di come i media possono favorire lo sterminio di massa» (Fulvio Beltrami).
Mandiamo in stampa questo numero della rivista pochi giorno dopo l’assassinio della deputata laburista Jo Cox -uccisa per le sue posizioni di integrazione e accoglienza- e della strage omofoba di Orlando. Nell’uno e nell’altro caso sono emerse evidenti le responsabilità dei media, dei social network e di tutte quelle persone che, attraverso di essi, hanno alimentato odio e acrimonia: la verità è che a furia di inneggiare ai fucili, qualcuno finisce per imbracciarli davvero (soprattutto se si comprano anche al supermercato).
A partire dal 1936, la casa editrice Stürmer-Verlag di proprietà di Streicher intraprese anche la pubblicazione di libri per bambini. Illustrati, contenevano filastrocche inneggianti la supremazia della razza ariana e i pericoli di “contaminazione”.
È nelle scuole che inizia il lavoro di responsabilizzazione della parola -insieme, o a volte in contrasto, con le famiglie-. Ecco perché forse non diamo mai abbastanza riconoscimento al ruolo indispensabile di maestri e insegnanti, categoria perlopiù bistrattata: il ruolo di chi contribuisce alla formazione della coscienza critica degli individui.
In un Paese di furbi «che cercano sempre di approfittare degli altri» come l’Italia, scriveva Bruno Munari sulla rivista Azione non violenta nel 1998, “se non cambiamo la mentalità dei bambini, se non insegniamo loro che essere furbi è una scelta arida, non riusciremo ad aprire una via verso la civiltà”. Le scuole sono chiuse e riapriranno a settembre.
I bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze che vi studiano oggi sono le donne e gli uomini che presto affronteranno le grandi sfide della nostra epoca: il cambiamento climatico, i conflitti, le migrazioni, la disuguaglianza. Emergenze alle quali noi “adulti” ci siamo addirittura assuefatti, e che non fanno quasi più notizia (ma non vale per tutti). Non cambiare mai, non rassegnarci, non abituarci all’orrore.
«Se succedesse a me, l’anestesia del cuore, preferirei morire. Tutta la mia energia è nel fare, nell’agire, perché ho dovere e responsabilità, ma una dose è per difendere la mia capacità di piangere, di urlare e quindi di ridere, se arrivano vivi» ha scritto il sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini). Le affronteranno meglio di quanto forse abbiamo saputo fare noi.
 «Bisogna cominciare da subito a mettersi insieme per attivare un progetto di inclusione culturale a sinistra, per superare confini che prima di noi sono stati abbattuti dal nostro avversario». Il manifesto, 28 giugno 2016 (c.m.c.)
«Bisogna cominciare da subito a mettersi insieme per attivare un progetto di inclusione culturale a sinistra, per superare confini che prima di noi sono stati abbattuti dal nostro avversario». Il manifesto, 28 giugno 2016 (c.m.c.)
Con il risultato del referendum inglese il capitalismo finanziario che governa gran parte delle dinamiche mondiali ha ottenuto un’altra importante vittoria. Solo ad una lettura superficiale e di corto periodo dell’avvenimento si potrebbe credere il contrario, cioè che le forze antisistema, perlopiù di destra, ma anche qualche sprovveduto altermondialista, siano i veri trionfatori della Brexit.
Se l’economia finanziarizzata è senza territorio, senza nazione, senza spazio, se ha progressivamente superato tutte le differenze di cultura e di clima tra le varie parti del globo rendendolo realmente ciò che è, un luogo senza inizio e senza fine in cui i confini sono retaggi del passato, ebbene l’ulteriore scomposizione europea risulta un tassello fondamentale nella sua strategia di globo-colonizzazione. Che senso ha oggi, infatti, pensare le Nazioni come spazio di governo reale delle dinamiche economiche? Quale modello è realmente e stabilmente sovrano nel mainstream dei flussi di capitale?
Noi sappiamo, ma non riusciamo a pensare questo dato in termini politici, che ogni microsecondo miliardi vengono spostati da una parte all’altra del globo senza nessuna regolazione, mossi da algoritmi atti solo a guadagnare plusvalenze da qualunque cosa, dalle vite migranti alle armi, passando per consumi di lusso o cultura di massa.
Su tutto questo, che influenza nella quotidianità la nostra vita spirituale, imaginale e materiale, che ci condizione nel profondo archetipico della nostra relazione con mondo dentro e fuori di noi, che potere hanno oggi gli Stati, le Nazioni? Estremamente residuale purtroppo, o per fortuna, se solo riuscissimo a pensare il globo per come lo ha reso uniforme questo flusso.
Tutto scorre, diceva Eraclito di Efeso, riferendosi al fluire del tempo. Ma oggi che tempo e spazio sono la stessa cosa, o meglio che lo spazio non esiste più perché annullato, sussunto nel tempo degli scambi «in tempo reale», che senso ha questa verità? Evidentemente abbiamo bisogno di rivedere le nostre categorie e di adattare la nostra episteme a condizioni già da tempo mutate ma che non riusciamo a cogliere nelle loro implicazioni politiche.
Gli «utili idioti» delle destre xenofobe, con la bava alla bocca per la Brexit sono dunque solo le teste di ariete per un ulteriore processo di sminuzzamento mucillaginoso delle società europee ridotte a meno dei loro individui, come proponeva la Thatcher quando fece entrare la Gran Bretagna nella CEE, e lo fece proprio perché in quel momento il significato della scelta non era affatto «europeista» ma strumentale alla decostruzione di una Europa che doveva così essere frenata e sottoposta ai diktat liberali che allora stavano divenendo liberisti: la reganomics.
Infatti, l’effetto domino che probabilmente si attiverà, dato che i politici europei non hanno le circonvoluzioni celebrali per pensare se non in termini territoriali e di breve periodo, porterà ad un azzeramento radicale dell’ideale europeo come venne concepito da Spinelli, cioè uno spazio macroculturale, aperto e poroso, prima ancora che politico ed economico, nel quale i popoli mettevano da parte le diseguaglianze per costruire, attraverso le loro diversità, uno spazio comune.
È evidente ad ogni ragazzino collegato al mondo attraverso il suo smartphone che lo spazio minimo per riacquistare diritti, partecipazione, governo dei territori, podestà sulla propria esistenza, è almeno continentale. E dunque da oggi il dibattito sulla costruzione di una sinistra all’altezza delle sfide deve decisamente prendere una piega di questa portata, mettere subito da parte i livelli nazionali, ricomporsi su scala europea, ripensarsi nell’internazionalismo che ci impongono le mutate condizioni.
Questi mesi vedranno momenti difficili per le istituzioni democratiche nazionali ed internazionali: le ricette del rigorismo cercheranno di dare la spallata finale al progetto europeo, lasciando poi le destre amministrare la povertà e le diseguaglianze.
È possibile che molti governi cadranno, incluso quello italiano, incapaci di ripensare l’Europa come rinascita culturale di una idea di eguaglianza, welfare, libertà di circolazione e solidarietà euro mediterranea. Bisogna cominciare da subito a mettersi insieme per attivare un progetto di inclusione culturale a sinistra, avendo come obiettivo una Carta Costituzionale Europea come programma fondamentale per superare confini che prima di noi sono stai abbattuti dal nostro avversario.
». Il manifesto, 6 giugno 2016 (c.m.c.)
A ottantasette anni, Ágnes Heller incarna sempre la vitalità della filosofia ben oltre l’etichetta di «allieva di Lukács». È stata una delle protagoniste al Festival Biblico di Vicenza del dialogo con Riccardo Mazzeo, ispirato dal saggio a quattro mani Il vento e il vortice.
Utopie, distopie, storia e limiti dell’immaginazione (Erickson pagine 152 euro 14,50). «È un libro nato a Pordenonelegge nel settembre 2015 dopo il confronto con Riccardo Mazzeo sul tema ’bellezza e utopia’. Allora mi stavo occupando di filosofia medioevale e rinascimentale. Ma scattò l’interrogativo: ’Perché oggi non ci sono più utopie?’. Così sono giunta alla conclusione che questa assenza potrebbe perfino trasformarsi in un vantaggio…» spiega, mentre sorseggia felice un espresso e conta di concludere il suo soggiorno italiano con la visita alla Biennale di architettura.
Sopravvissuta alla Shoah, espulsa nel 1959 dall’Università di Budapest, emigra con il marito Ferenc Fehér in Australia nel 1977. Dopo aver insegnato sociologia a Melbourne, approderà a New York sulla prestigiosa cattedra di Hannah Arendt.Da tempo è tornata a vivere nella capitale ungherese, anche nel ruolo di spina nel fianco del premier ultranazionalista Viktor Orban. E di nuovo, nell’ultimo libro, Ágnes Heller insiste nell’illuminare speranze e paure alla luce di uno sguardo filosofico mai disattento nei confronti delle trame visionarie quanto dell’attualità.
«Dal mio punto di vista, occorre distinguere due forme di utopia – spiega la filosofa -. Quella del desiderio, cioè un mondo in cui tutti i bisogni sono soddisfatti: non si deve lavorare, niente Stato né leggi o guerre. È come l’età dell’oro che è alle nostre spalle, come per la Grecia antica. O come nella Bibbia (Genesi, 2) con Adamo e Eva nel Giardino dell’Eden, che hanno tutto a disposizione senza dover lavorare e non sono minacciati dal dolore e dalla morte.
Marx immagina lo stesso tipo di utopia, solo che diventa quella del futuro dell’umanità: niente mercato, Stato, leggi, istituzioni, matrimonio, eccetera; tutti i bisogni soddisfatti nella società dell’abbondanza. Ma come già evidenziava Freud in Disagio della civiltà, utopia senza cultura e con una libertà totalmente negativa».
E l’altra forma di utopia qual sarebbe?
L’utopia filosofica. In buona sostanza, non ci permettono la soddisfazione dei nostri desideri, però da qualche parte e in qualche modo possiamo immaginare la società giusta. Comincia Platone con la sua Repubblica ideale, perché i filosofi sono in grado di trasformare l’idea in realtà e quindi anche di creare lo Stato perfetto.
Nel 1516 Thomas More scrive Utopia nell’età delle grandi scoperte: è l’isola esattamente opposta all’Inghilterra; ma è anche, di fatto, uno Stato totalitario. Con Charles Fourier si approda all’utopia socialista del falansterio. Costruita «scientificamente», perché nel XIX secolo si aveva fede nella scienza capace di risolvere ogni problema. Di qui l’idea che sarebbe stato sufficiente mettere gli individui insieme per ottenere lo stato d’armonia e la felicità di tutti. Dopo il 1789 la narrazione è ispirata, invece, dall’idea di progresso universale. Dallo stato primitivo si tende verso quello civilizzato. Progresso all’orizzonte dell’umanità per evoluzione, grazie alla rivoluzione o attraverso riforme progressive.
Il «secolo delle ideologie» tuttavia non produce felicità, ma guerre mondiali. Né realizza sogni: se mai, disillude…
Si giunge così all’idea della fine dell’utopia. Nel XX secolo collassa il concetto di progresso: dopo Auschwitz e i gulag come si può ancora parlare di società che tende naturalmente al meglio, al futuro luminoso, alla progressiva felicità? È il primo momento di critica culturale che apre alla prospettiva della distopia. Si sviluppa il concetto di decadenza, che Oswald Spengler sintetizza nel Tramonto dell’Occidente. Ma con l’incubo della guerra nucleare anche la scienza non è più l’angelo della redenzione: le bombe atomiche sono l’emblema della dannazione.
Si imbocca così l’immaginazione critica, la «contro-narrazione», il pensiero non più edificante?
Le distopie sono gli scenari dell’autodistruzione per la nostra ecosfera, che da almeno vent’anni sono previsti nella letteratura scientifica. Altri vettori di distopie sono le opere di letteratura fiction che già Jonathan Swift aveva offerto con le sue satire. Penso in particolare al Mondo nuovo di Aldous Huxley, a 1984 di George Orwell e a La strada di Cormac McCarthy. Senza dimenticare i numerosi film con le medesime caratteristiche.
E cosa hanno in comune?
Le distopie sono avvertimenti. Ci mostrano le alternative alla disillusione, alla disperazione, alla catastrofe. Un po’ come i profeti biblici che, nella società dominata dal peccato, indicano all’umanità che soltanto con la correzione dei suoi comportamenti, può evitare un’esistenza dannata. Oggi sappiamo che l’uso delle armi nucleari equivale alla fine del mondo. O che abbiamo una scelta fra essere soggiogati da un leader totalitario e difendere le libertà.
Dunque, in questo vortice, esiste qualcosa che si possa fare?
Coltivare il «giardino» in cui viviamo. Con responsabilità, attenzione e cura. Era il suggerimento di Voltaire, nel Candido. Del resto, questo è il mondo dove siamo nati e moriremo. Ognuno deve mantenerlo e insieme renderlo un po’ migliore. Non è una prospettiva brutta: senz’altro migliore rispetto alla disillusione che nasce dalle utopie mancate.
Tornando ai temi dell’ultimo saggio, dove si annida la contraddizione fondamentale dell’individuo nella società?
Occorre ritornare alla Costituzione della Rivoluzione francese che sancisce i droits de l’homme e du citoyen come se i diritti umani e quelli di cittadinanza fossero equivalenti e perfino sinonimi. Non è certo così, soprattutto dal punto di vista etico nell’Europa moderna. Ci viene, infatti, chiesto di essere brave persone e buoni cittadini. Due sfere differenti: la moralità individuale e il rispetto delle leggi. Eppure, sono anche pilastri che si sorreggono a vicenda nel nostro mondo. La cooperazione tra valori privati e virtù pubbliche è oggi più necessaria che mai se vogliamo evitare che il futuro assomigli agli incubi della distopia.
E la crisi che attanaglia l’Europa, è risolvibile?
Va sempre ricordato che, al contrario del mondo anglosassone, in Europa la democrazia non è certo una tradizione. Anzi, per Grecia, Spagna, Portogallo e per la stessa Italia vale solo negli ultimi decenni. E nella storia dei Paesi dell’Est la democrazia è ancora più recente. Piuttosto, bisogna prestare attenzione al bonapartismo sempre presente in Europa: lo inaugura Napoleone e arriva ben oltre Mussolini. L’uomo forte, che tutto risolve, perché finisce con l’incarnare la verità, lo Stato, la società. Il «condottiero» che non si fa scrupoli e ricorre al populismo, anche se rappresenta interessi oligarchici.
A volte mi vien da pensare che il Vecchio Continente sia stato ri-paganizzato: la nazione come autorità suprema e il nazionalismo come religione. Eppure, l’Unione Europea è nata, al contrario, come «universalistica» all’insegna della solidarietà fra gli stati membri.
Purtroppo, la costruzione dell’Ue non è stata accompagnata dall’emergere di una coscienza europea comune. Così l’Europa rischia di restare un progetto burocratico senz’anima. Paradossalmente, l’opportunità di cambiamento e di apertura ci arriva dall’emergenza dei rifugiati e dalla minaccia terroristica.
». Il Sole 24 ore, 8 maggio 2016 (c.m.c.)
L’articolo 9 della Costituzione afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, dove il paesaggio e la storia rimandano a quegli esiti significativi e olistici dell’esistenza carichi più di significato che di qualità estetica. La cultura non si limita al bello.
Diffusa è l’idea che la cultura equivalga al bello e di qui il pensiero, ormai troppo fatto, della bellezza che salverà il mondo. Ma l’uomo si salva solo coltivando varie aiuole dell’orto, non una sola. Se ritorniamo ai Greci, troviamo una idea di cultura ampia che dovremmo fare nostra, quella del kalokagathos, cioè del bello unito al buono. Essa comprende corpi e spiriti eccellenti, istituzioni, costumi e leggi da preferire, le cose che rifulgono, insomma tutto ciò che s’impone nel continuum tra “significato” storico e “rappresentazione” estetica. Quanto lontano da questa idea di cultura è l’uomo d’oggi, unilateralmente disciplinare e maniacalmente economico, la cui umanità a brandelli invoca una rilegatura.
Da un punto di vista filosofico, il bene è il campo in cui fioriscono le idee morali e politiche che servono a governare la vita individuale, di gruppo e di comunità. I valori primi possono essere considerati singolarmente – pace, libertà, felicità, giustizia, amore, creatività – e nel loro confluire in quei paesaggi e sistemi d’idee che sono le civiltà. Riguardano temi sui quali i pensatori s’interrogano da millenni e che portano ogni giorno ciascuno di noi, anche se non ce ne accorgiamo, alla fortuna o alla rovina. Ecco perché è importante imparare, fin sui banchi di scuola, come essere curiosi di sé ma anche di amici, rivali e nemici, perché frammenti di verità si trovano anche nelle tasche altrui e i frammenti nella nostra tasca non bastano.
Esagerare un fine primo come la libertà oppure l’uguaglianza porta a trasformare un bene in un male, perché nell’uomo sempre fermentano più valori primi, tutti ugualmente necessari, che solo il buon senso consente in una qualche misura di combinare, anche quando contrastano fra loro. I disastri del ’900 provengono da esagerazioni sia dell’Illuminismo che del Romanticismo, entrambi in origine movimenti liberatori. Esiste un terreno comune umano di fini primi che riguarda alcuni valori morali accettati da gran parte degli uomini, non sempre e ovunque ma in grande parte dei tempi e dei luoghi. Si tratta di valori condivisi senza i quali le società non comunicherebbero, non si comprenderebbero e non si riprodurrebbero.
Terreno comune è distinguere il bene dal male, il vero dal falso e il giusto dall’ingiusto; perseguire bisogni basilari come cibo, riparo, sicurezza e appartenenza a un gruppo; raggiungere un minimo di libertà, felicità e sviluppo delle proprie potenzialità; concepire gli individui in relazione al loro ambiente maturale e culturale, etc. Si tratta dei limitati valori primi che sono dati, accettati, validi in sé e parte del mondo oggettivo; distinti da usanze e inclinazioni inventate e adottate che la storia mostra come numerosissime e diversissime.
Secondo una durevole e prevalente tradizione di pensiero gli uomini disporrebbero della conoscenza naturale innata di un certo numero di verità universali ed eterne quali l’esistenza di Dio, la conoscenza del bene e del male e del giusto e dell’ingiusto, l’obbligo di dire il vero, di restituire i prestiti, di mantenere le promesse e di seguire alcuni o tutti i comandamenti della Bibbia. Al contrario, secondo pensatori come Epicuro, Lucrezio, Vico, Herder, Hume e Marx, le suddette verità si sarebbero formate tramite evoluzione e sviluppo culturale, sarebbero cioè il risultato di effetti cumulativi, privi tuttavia di struttura e di scopo. Per questi pensatori la “natura umana” sarebbe si comune ma non fissa. È un atteggiamento che porta al pluralismo dei valori, ma non al relativismo, per il quale i fini primi sono soggettivi, arbitrari e infiniti, idea che i pluralisti rifiutano.
È comune pensare che i beni contrastino con i mali e si armonizzino invece tra loro; ma è una idea sbagliata. È doloroso prendere coscienza che i beni possano contrastare anche fra di loro. Ciò spiega perché sia così difficile agire moralmente e politicamente per il bene delle persone e comune. Quando si tratta di beni che configgono, la scelta si fa drammatica. Infatti è impossibile essere perfettamente liberi e perfettamente uguali, perfettamente giusti e perfettamente compassionevoli, perfettamente pianificati e perfettamente spontanei, perfettamente consapevoli e perfettamente felici; altrettanto impossibile è essere a un tempo lucidi e stupefatti, calmi e furiosi, leali e neutrali. Risulta pertanto incoerente qualsiasi idea di una armonia perfetta tra tutti i fini primi.
Ne consegue che l’attuazione totale e contemporanea di valori può rivelarsi impossibile quando sono tra loro incompatibili. Necessità e bisogni antinomici possono essere bilanciati ricorrendo, più che a una magica sintesi dialettica, a imperfette e provvisorie composizioni: ad esempio concedendo una dose di libertà e una dose di uguaglianza, in modo che nessuno dei due fini giunga a schiacciare l’altro. Altre volte un tale compromesso si rivela impossibile, come quando una comunità si propone di massimizzare un valore ritenuto preminente, per cui non dà spazio agli altri valori.
Ogni scelta comporta la perdita delle alternative scartate e nel caso di valori incompatibili, il sacrificio di un fine a favore di un altro, così che la commedia umana si converte sovente in un doloroso dilemma. Neppure è possibile gerarchizzare i valori primi, distinguere i più importanti dai meno importanti, perché manca un criterio valido per misurarli. Ne consegue che i valori primi sono incommensurabili e quindi tutti ugualmente necessari.
Sono da ritenere validi non solamente i fini che prediligiamo ma anche quelli che scartiamo o addirittura detestiamo. Se ci dotiamo dell’empatia che Vico e Herder insegnano, capiamo come, in condizioni storiche particolari, sia stato possibile scegliere e perseguire in maniera coerente e comprensibile scopi che non sentiamo più come nostri. Grazie all’immaginazione è dato intravedere cosa abbia significato essere un servo greco, un soldato romano, un martire cristiano, un giacobino, un ayatollah o un hippy americano: tutti modi di vivere che hanno avuto senso in altri tempi e luoghi. Penetriamo e comprendiamo gli eroi di Omero e Wagner, ma non condividiamo più i valori di Achille e Sigfrido, pur rientrando Iliade e Tetralogia nel nostro canone culturale. I missionari hanno potuto convertire gli Isolani delle Trobriand e i Pigmei dell’Africa, perché si appellavano a valori che anche gli altri intendevano.
Il fatto che tutto il mondo desideri visitare l’Italia rivela anch’esso l’esistenza di un terreno comune umano, cioè la possibilità di apprezzare una serie di civiltà anche se si appartiene a un diversissimo paesaggio di idee.I valori di una civiltà possono confliggere con i nostri eppure rientrare in quel genere di fini che immaginiamo perseguibili senza che smettano di apparirci umani. Sono fioriture che appartengono ad aiuole diverse e comprendere le aiuole lontane è diventato compito affrontabile solo a partire dello storicismo, che la cultura europea ha inventato nel XVIII secolo; una conquista che ancora non ha raggiunto numerose parti del globo, come ogni giorno è dato di constatare.
Capire quanto non condividiamo è divenuta una necessità imprescindibile anche nel nostro Paese. Dobbiamo preservare il nostro centro di gravità culturale e farlo conoscere e rispettare a chi viene da fuori, ma possiamo al tempo stesso esercitarci in idee e gusti di altri continenti. Capire falsi miti, fanatismi e estremismi non esclude che si possa combattere per difendere la forma di vita che preferiamo dal nemico che si proponesse di distruggerla. Valori comuni ed empatie fungono da ponte tra le culture nell’andirivieni ininterrotto tra limitati valori primi che uniscono e innumerevoli usanze che dividono.
Chi crede in un sistema unico e finalizzato di valori inalterabili, universali ed eterni, più che nel terreno comune umano che empiricamente è dato riscontrare, tende all’intolleranza verso quanto ritiene falso, perverso e deviato. È così accaduto che perfino l’illuminista Voltaire abbia dato del barbaro a Shakespeare. Lo storicismo, figlio del Romanticismo, impedisce ormai a noi simili pregiudizi, per cui possiamo essere legati al nostro paese e al tempo stesso sentirci parti di un unico Pianeta.