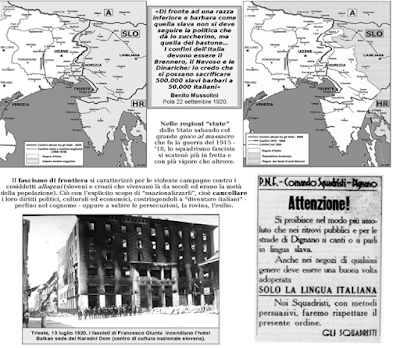Negli anni del secondo governo Berlusconi il Parlamento italiano approvò la legge 30 marzo 2004, n.92,
«Istituzione del Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti
degli infoibati». Iniziò molto presto - come controcanto alle manifestazioni della destra neofascista e nazionalista - la civile e necessaria protesta delle voci più riflessive.
Il primo intervento critico fu forse quello di Corrado Staiano con un articolo sull'Unità, dal titolo emblematico: La memoria e gli avvoltoi. L'indignazione per la pesante mistificazione dei fatti ci spinse a raccogliere su eddyburg documenti che rivelassero ai frequentatori del sito la verità. Qui alcuni dei più rilevanti, raccolti nella cartella Italiani brava gente:
Si legga Foibe, la dignità di un dolore corale di Predrag Matvejevic (il Manifesto, 2014) sulla strumentale deformazione storica delle "foibe", La storia intorno alle foibe del collettivo Nicoletta Bourbaki, che ha chiesto a sette storici di rispondere alla domanda: In cosa consiste la “più complessa vicenda del confine orientale”? (Internazionale, 2017), e il mio articolo A proposito di un discorso monco del presidente Mattarella (eddyburg, 2018).

Nigrizia.it,
Non basta perseguitare chi fugge da condizioni disumane; nel cosiddetto ‘mondo civile’ ci si accanisce persino contro i bambini: qui in Italia si vuole agire nei confronti dei rom, minacciando la perdita della potestà genitoriale se i loro figli non frequentano le scuole; nell’America di Trump e della ‘tolleranza zero’ si agisce con crudeltà nei confronti dei migranti dal Centro America, separando e mettendo letteralmente in prigione i bambini di famiglie che sono riuscite a varcare il confine. Neanche il pianto disperato degli innocenti commuove questi novelli Erode!
Che fare? Non solo la società civile e le comunità cristiane, come invita a fare Zanotelli, ma anche le amministrazioni locali 'progressiste' dovrebbero prendere esempio dal movimento USA dei Sanctuary States (sono già 7) e delle Sanctuary Cities (sono decine le contee e le grandi città che vi aderiscono...): un movimento che si oppone alle politiche razziste e xenofobe contro gli immigrati 'illegali' attuate da Trump e che si sta impegnando in iniziative di contrasto alle leggi federali e in azioni penali, rischiando severi tagli di fondi da parte del governo federale. Per ora, di iniziative analoghe nel nostro paese non se ne vedono... (m.c.g.)
L’onda nera del razzismo e della xenofobia che sta dilagando in Europa – dall’Ungheria all’Austria, dalla Polonia alla Slovenia – travolge oggi anche il nostro paese. Il volto più noto di questo razzismo nostrano è certamente Matteo Salvini, segretario della Lega e ora ministro degli interni nel nuovo governo giallo-verde (non dimentichiamoci che Salvini è apprezzato da Bannon, ex consigliere di Trump e portabandiera dell’ultra destra sovranista mondiale!).
In queste prime settimane di governo giallo-verde, Salvini ha subito rivelato la sua strategia politica con degli slogan che fanno paura. «È finita la pacchia dei migranti», «i clandestini devono fare le valigie, se ne devono andare», «nessun vice-scafista deve attraccare nei porti italiani», «siamo sotto attacco e chiediamo alla Nato di difenderci dai migranti e terroristi», «l’Italia non può essere il campo profughi d’Europa».
Pesante l’attacco contro la Tunisia, definito come paese «esportatore di galeotti». La politica leghista vuole creare “più centri di espulsione” per sbarazzarsi di 500.000 irregolari rimandandoli ai loro paesi. Pesanti le parole del ministro degli interni contro il sindaco Mimmo Lucano che ha fatto rifiorire il paese di Riace (Calabria) accogliendo migranti: «È lo zero!». Altrettanto dura la politica del ministro degli interni contro i rom: vuole smantellare i loro campi con le ruspe e attuare quanto concordato nel “contratto di governo”: l’obbligo della frequenza scolastica, pena la perdita della responsabilità e potestà genitoriale. Siamo alle leggi speciali per i rom? Inoltre egli promette il pugno duro per la sicurezza e il decoro urbano, a spese dei senza fissa dimora, dei poveri, degli ultimi.
E il segretario della Lega è passato subito dalle parole ai fatti, negando alla nave “Acquarius”, che portava oltre 600 migranti, di potere attraccare ai porti italiani. Un atto vergognoso giocato sulla pelle dei poveri, ma anche illegale perché viola la nostra Costituzione e i trattati internazionali firmati dall’Italia sulla ricerca e salvataggio marittimo.
È ormai un Salvini che impazza a tutto campo, mentre i Cinque Stelle sono già prigionieri del campo di forza della Lega che ha sempre più consensi e riceve gli elogi di Bannon e di Marine Le Pen e del gruppo di Visegrad. Dobbiamo riconoscerlo: siamo davanti a un “razzismo di Stato” preparato in questo ventennio da leggi come la Turco-Napolitano, la Bossi-Fini, i decreti Maroni, la realpolitik di Minniti e da un crescente razzismo degli italiani.
E i conventi cosa fanno?
È un fenomeno questo che ci interpella tutti: società civile, cittadinanza attiva, movimenti popolari, Chiese, comunità cristiane. Come missionario mi appello per primo alla Chiesa italiana perché faccia un serio esame di coscienza cercando di capire quanto i cristiani abbiano contribuito a questo disastro. È mai possibile che le nostre comunità abbiano dimenticato quelle parole così chiare di Gesù: “Ero affamato…, ero assetato…, ero forestiero… e non mi avete accolto?”. Non è forse questo il momento più opportuno per aprire le nostre comunità ed accogliere coloro che sono minacciati di espulsione? A che cosa servono i conventi o le case religiose se non ad accogliere coloro che la società opulenta non vuole?
Dovrebbe farci riflettere che negli Usa tante chiese e comunità cristiane si siano dichiarate “sanctuary”, luoghi di rifugio per coloro che Trump (altro razzista!) ha deciso di deportare ai loro paesi dove rischiano la vita! Non è forse il momento in cui lanciare il “Sanctuary movement” anche in Italia per salvare tanti migranti da morte sicura? È mai possibile che negli USA lo stato della California si sia dichiarato “santuario” per gli irregolari che Trump vuole espellere e in Italia nessuna comunità cristiana ancora abbia fatto un tale passo?
Creare anticorpi
Mi appello alla cittadinanza attiva di questo paese perché in fretta crei gli anticorpi per reagire al fascio-leghismo nostrano. È fondamentale imboccare seriamente la strada della disobbedienza civile per tutte quelle leggi che disumanizzano i nostri fratelli e disumanizzano anche noi. «Una legge che degrada la personalità umana è ingiusta», così scriveva dal carcere di Birmingham, Martin Luther King. E aggiungeva: «I primi cristiani si rallegravano per essere considerati degni di soffrire per quello in cui credevano. Allora la Chiesa non era un semplice termometro che misurava le idee e i principi dell’opinione pubblica: era un termostato che trasformava il costume della società. Quando i primi cristiani entravano in una città, le autorità si allarmavano e subito cercavano di imprigionare i cristiani perché “disturbavano l’ordine pubblico” ed erano “agitatori venuti da fuori”. Ma i cristiani non cedettero, chiamati ad obbedire a Dio e non agli uomini».
È questo lo spirito che deve ritornare ad animare le comunità cristiane per poter sconfiggere, insieme a tanti uomini di buona volontà, l’onda nera del razzismo e xenofobia che ci sta travolgendo. Dobbiamo farlo insieme, credenti e laici, memori di quanto afferma il danese Kaj Munk, pastore luterano antinazista, ucciso come un cane nel 1944: «Quello che a noi manca è una santa collera!».
Tratto dalla pagina qui raggiungibile.
 Ho ascoltato un'intervista rilasciata dal leader del M5S, Luigi Di Maio, a proposito dei porti da chiudere e dei migranti da respingere. Orribile: ecco perché Di Maio e Salvini sono due facce della stessa medaglia
Ho ascoltato un'intervista rilasciata dal leader del M5S, Luigi Di Maio, a proposito dei porti da chiudere e dei migranti da respingere. Orribile: ecco perché Di Maio e Salvini sono due facce della stessa medaglia
Mi vergogno d’essere italiano. Ho ascoltato ieri l’intervista rilasciata da Luigi Di Maio a proposito della chiusura dei porti, e mi sono vergognato anche di essere, come lui, napoletano. Ma l’orrore di quella intervista mi è stato utile perché mi ha fatto capire una cosa: Di Maio e Salvini non sono due facce distinte e diverse della destra: sono le due facce della stessa medaglia, non so quale delle due sia la più disgustosa.
Non ha senso, quindi, guardare con occhio diverso il Movimento 5 stelle e la Lega, sostenendo che il primo è un aggregato di persone diversamente orientate, riunite solo dalla volontà di “superare” la Prima Repubblica.
Ciò che mi ha particolarmente colpito non è che i due energumeni avessero una visione simile della questione dei migranti. Sono tanti, ancora, quelli che non hanno compreso che l’esodo dalle regioni, che l’Europa ha sfruttato fino allo sfinimento, è inarrestabile. E ci sono tantissime altre persone, nell’Italia e nell’Europa di oggi, che covano nelle loro viscere profondi rigurgiti di razzismo sciovinista e nazista: Hitler ha seminato largo, e il terreno fertilizzato dal capitalismo era pronto a trasformare i semi in randelli da usare contro i diversi. Ha ragione Bertold Brecht, è cominciato con gli zingari[1] e prosegue senza tregua.

Mi ha indignato particolarmente la proposta, supinamente accettata da troppi, che sia possibile rovesciare il segno che distingue quelle singolarissime strutture della nostra civiltà che sono i porti. Ho imparato che la vera, profonda ricchezza della civiltà umana è nella concreta possibilità di incontrare, conoscere, esplorare le mille diversità che caratterizzano le diverse storie, costumi, credenze, saperi che contrassegnano le numerose etnie, patrie, città, lingue, culture che rendono ogni luogo e ogni persona diversi tra loro. E se separare gli uni dagli altri dignifica renderli sterili, la loro colloquiale diversità diventa invece un patrimonio di tutti.
Soprattutto nell’area geografica alla quale apparteniamo i porti sono sempre stati, al tempo stesso, il simbolo e la struttura dedicata all’incontro e allo scambio, quindi lo strumento per la crescita comune della comune civiltà. E chiudere i porti è una decisione molto vicina a quella di imporre una vasectomia generalizzata a tutti i maschi della razza umana.
[1] «Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c'era rimasto nessuno a protestare».
 Lettera da Parigi. Anche dall'estero qualcuno segue gli scandali peggiori che avvengono nel Belpaese. L'assassinio di Peppino Impastato da parte della mafia 40 anni fa, è ricordato da un Memoriale a Cinisi, Che cosa ricorderà gli scandali compiuti da signori in giacca e cravatte e senza sacrifici umani evidenti? (e.s.)
Lettera da Parigi. Anche dall'estero qualcuno segue gli scandali peggiori che avvengono nel Belpaese. L'assassinio di Peppino Impastato da parte della mafia 40 anni fa, è ricordato da un Memoriale a Cinisi, Che cosa ricorderà gli scandali compiuti da signori in giacca e cravatte e senza sacrifici umani evidenti? (e.s.)
Don Ciotti, il creatore di Libera, ha osservato, qualche giorno fa, a proposito della mafia, che «nessuno in campagna elettorale ne aveva parlato perché disturba» [1]. Nella rivista MicroMega del 30 aprile, due giornalisti minacciati personalmente dai criminali, Amalia De Simone e Sandro Ruotolo, hanno intitolato un loro articolo: «La mafia è scomparsa dalla televisione e dai giornali».
Anche quando Sergio Mattarella fu eletto, pochissimi giornalisti osarono ricordare che il nuovo Presidente della Repubblica aveva tenuto tra le suoe braccia suo fratello morente, Piersanti, ucciso nel 1980 da Cosa Nostra, con la probabile complicità di Andreotti. Roberto Scarpinato, procuratore nel processo del 2003 contro Andreotti, ricorda che contrariamente a quel che si dice e scrive, la Corte ha stabilito che l’Inossidabile ha collaborato con Cosa Nostra, era informato della sua decisione di uccidere Piersanti Mattarella, non ha impedito il crimine e non ha denunciato i criminali.
Ma, a causa della sopravvenuta prescrizione, la corte non ha potuto condannare Andreotti, che eriuscito a fare tacere giornali e TV su tutto questo[2].
E quando pure la stampa osa menzionare i crimini della mafia, talvolta commette gravi omissioni. Il 29 aprile l'Espresso ha dedicato nove pagine e la copertina a Peppino Impastato, massacrato 40 anni fa da Cosa Nostra[3]. Ma solo quattro righe menzionano, limitandosi a ricordare l'evento e senza nemmeno citare ll lavoro paziente a accurato che Umberto Santino e sua moglie Anna Puglisi, stanno compiendo volontariamente da anni, creando, coltivando e animando il centro Centro Siciliano di Documentazione "Giuseppe Impastato".
Il giovane Peppino Impastato, nato a Cinisi in una famiglia mafiosa, aveva rotto con la parentela, svolgendo una serie di attività, tra cui la radio: aveva creato "Radio Aut", e denunciava i potenti mafiosi del paese e i loro complici. Il 9 maggio 1978, il corpo di Peppino è stato trovato sui binari della ferrovia, fatto a pezzi da quattro chili di tritolo.
Gli investigatori hanno immediatamente concluso che Peppino era un terrorista maldestro, vittima della carica che stava portando per preparare un attentato. Subito dopo il delitto, Umberto Santino e Anna Puglisi, coraggiosi combattenti contro la mafia, hanno avviato un lavoro per salvare la memoria di Peppino e ottenere giustizia;. Tra l'altro hanno organizzato una manifestazione nazionale nel 1979, riunendo a Cinisi 2000 persone. E' stata la prima manifestazione antimafia della storia d'Italia.
Ma sono stati necessari vent'anni di azione congiunta del Centro siciliano di documentazione Peppino Impastato, del fratello di Peppino e della sua madre, perché la giustizia sia giunta a riconoscere l'omicidio e a denunciare i colpevoli. Il boss che ha ordinato la strage, Tano Badalamenti, è stato condannato solo nell'aprile 2002. Il Centro Impastato ha dovuto lanciare una petizione per chiedere la riapertura del caso, che era stato prudentemente chiuso dalla giustizia nel 1992.
Oggi Anna Puglisi e Umberto Santino
[6] stanno lavorando alla realizzazione di un Memoriale-laboratorio della lotta alla mafia. La loro azione costante dimostra che cittadini coraggiosi e ostinati possono, a rischio della loro vita, costringere l'apparato statale a riconoscere verità che disturbano troppe persone sul ruolo delle mafie. Ciò è particolarmente utile in questi anni,, allorché sono arrivati al governo dell’Italia, fascisti nostalgici
[7] e figure inquietanti anche per altre ragioni.
Abbiamo letto che si è ampiamente discusso sull'inserimanto nel nuovo governo del professor Paolo Savona. Questo nome ci ha ricordato un altro scandalo italiano: l'intervento sulla Laguna di di Venezia denominato MOSE: un intervento scandaloso per ragioni diverse della mafia ma paragonabile a essa per l'effetto di corruzione su vasti corpi sociali. Ma di questo scriveremo in una prossima occasione, Perchè lo scandalo sembra prosegiore e aggravarsi con nuove devastanti iniaiative
Ci siamo ricordati che Savona è stato [8] presidente del Consorzio Venezia Nuova, il potente blocco d'intessi finanziari, immobiliari, industriali privati cui lo Stato ha affidato la gestione di una straordinari . Il nuovo ministro aveva affermato: “Le critiche sono prive di fondamento, il progetto delle opere mobili è tra i più studiati e più moderni del mondo”. Il Mose, diga galleggiante che avrebbe dovuto salvare Venezia dalle acque, non funziona ancora, deve essere già restaurata e causa gravi danni alla Laguna di Venezia che non proteggerà mai. Secondo il procuratore Scarpinato,[9] “uno dei più famosi casi di corruzione è il Mose di Venezia, 2 miliardi il costo iniziale previsto e costo finale, invece, di 6 miliardi, di cui 4 di spesa di corruzione. » E questi 4 miliardi « sono tagli agli ospedali, alle scuole, alle pensioni… »
9 giugno 2018, Parigi
Riteniamo che questo sia non solo è ingiusto nei confronti dei creatori a Palermo del primo centro italiano di documentazione sulle mafie, il Centro Peppino Impastato
[4], ma è anche antipedagogico. In effetti, questa storia illustra la penetrazione della criminalità organizzata nello Stato italiano, fino nei servizi d’ordine e giudiziari, per non parlare della classe politica
 Il Fatto quotidiano, 19 maggio 2018. Un asciutto resoconto di un'ammirevole manifestazione di uomini e donne dalla pelle nera che si è svolta a Napoli per rivendicare i diritti della democrazia. Con commento (e.s.)
Il Fatto quotidiano, 19 maggio 2018. Un asciutto resoconto di un'ammirevole manifestazione di uomini e donne dalla pelle nera che si è svolta a Napoli per rivendicare i diritti della democrazia. Con commento (e.s.)
La prima cosa che colpisce nei resoconti sulla manifestazione che si è svolta a Napoli è la compostezza dei partecipanti, mille miglia distanti dallo sguaiato vocìo che si sollevava dalle torbide platee (dai bar alle piazze) e dai prosceni del teatrino della “politica” italiana. Poi ci ha colpito il contrasto Bianco/Nero che contrassegna, nel linguaggio corrente come su quello “formativo” dei media, il conflitto in essere. Il conflitto non è tra persone dalla pelle chiara e persone dalla pelle scura, ma tra sfruttatori e sfruttati, tra il mondo che ha soffocato la sua umanità nel benessere (i “satolli e disperati” diceva il cardinal Lercaro), e quello che patisce e muore nei luoghi dove è stato confinato e condannato alla miseria e alla morte dalla rapacità degli altri: dai padroni e dai beneficiari del capitalismo. Tuttavia, è significativo che il conflitto si manifesti alla fine nel contrasto tra quei due colori, dove il “nero” si riferisce sempre all’uomo da cui fuggire, oppure da bruciare o impiccare. Alla fine gli stereotipi che prevalgono sono quelli del razzismo. Segue l'articolo di Stefano Feltri (e.s.)
i, 19 maggio 2018
La piazza nera che sfida i giallo verdi
di Stefano Feltri
Per capire i dilemmi anche morali che dovrà affrontare il nuovo governo Lega-Cinque Stelle bisognava essere in piazza Plebiscito a Napoli ieri mattina: migliaia di persone – pare 10.000 – sedute in silenzio sulle scalinate ad ascoltare chi parla dal microfono al centro, un po’ in italiano, un po’ in inglese, un po’ in francese. Tutti neri, tutti immigrati, quasi tutti senza permesso di soggiorno. Una manifestazione di rara compostezza, inedita per dimensione e per la quasi totale assenza di italiani, con tre richieste: tempi più rapidi per concedere i permessi di soggiorno, regolarizzazione di chi è in Italia da anni, lavora e non ha alcun Paese dove tornare o in cui essere rimpatriato a forza, e l’estensione del reddito di inclusione anche ai migranti.
Una folla muta di persone arrivate da tutta Italia, dagli inferni di Castel Volturno, dalle campagne di Caserta (dove oggi si replica), da Roma, dai campi di pomodori di Foggia. Coraggiosi fantasmi senza documenti che sfilano in corteo in mezzo a quei poliziotti che – stando alla legge – dovrebbero fermarli e contestare loro di essere arrivati su un barcone, di lavorare in nero, di non avere diritto a rimanere in Italia. I pochi che prendono il microfono per parlare chiedono di poter contribuire a una società che sentono la loro: finché restano nell’ombra dell’irregolarità sono costretti a usare i loro miseri compensi per remunerare qualche caporale o a pagare affitti in nero.
Le associazioni come il centro sociale “ex Canapificio” di Caserta che hanno promosso l’evento di ieri e l’appello “Reddito e diritti per tutte e tutti – Nessuno escluso” hanno un obiettivo molto concreto: permettere agli immigrati di accedere al reddito di inclusione (Rei), il sussidio anti-povertà introdotto dal governo Gentiloni che è quasi identico al reddito di cittadinanza dei Cinque Stelle, anche se di importo più basso. Queste associazioni hanno scoperto che la legge è abbastanza ambigua da lasciar intravedere anche ai migranti in Italia per ragioni umanitarie da almeno due anni la possibilità di accedere al Rei (che oggi arriva quasi a 900.000 persone per un importo medio di 297 euro al mese) e le Regioni hanno alcuni margini di flessibilità per aggiungere risorse a quelle nazionali ed estendere la platea dei beneficiari. Stanno quindi trattando con la Campania di Vincenzo De Luca e pare ci sia qualche spiraglio, visto che la Regione già ha sperimentato il coinvolgimento di migranti in lavori di pubblica utilità. Secondo l’Istat, l’incidenza della povertà assoluta tra le famiglie del Mezzogiorno di soli italiani era nel 2016 il 7,5 per cento, tra quelle di soli stranieri del 29,7 per cento.
La piazza napoletana di africani di ieri dimostra che molti degli argomenti avanzati dai Cinque Stelle sono fondati: soltanto un sussidio universale e non più legato alle categorie di appartenenza può garantire davvero di uscire dalla trappola dell’indigenza e di avere abbastanza libertà da opporsi al reclutamento dei caporali e partecipare da cittadini alla vita democratica. Peccato che, proprio ieri, mentre quei ragazzi africani attraversavano Napoli, i Cinque Stelle firmassero un contratto di governo con la Lega che si è impegnata a rimpatriare quasi tutti i presenti al corteo. E se non riuscirà a rimpatriarli, complicherà loro la vita in ogni modo possibile (si prevede l’espulsione per i richiedenti asilo che commettono reati, a prescindere dal loro diritto a rimanere) per compiacere le richieste securitarie di un elettorato spaventato più dai talk show che dal contatto diretto con i migranti.
Non sarà facile tenere insieme la maggioranza gialloverde che sarà presto attraversata da dilemmi laceranti. I manifestanti di Napoli farebbero bene a non farsi troppe illusioni.
 Avvenire, 4 maggio 2018. Chiacchierano per fare un governo. Ma quanto tempo sarà ancora necessario per averne uno che elimini lo schiavismo dei "datori di lavoro" italiani che imperversano in ogni angolo della Penisola?
Avvenire, 4 maggio 2018. Chiacchierano per fare un governo. Ma quanto tempo sarà ancora necessario per averne uno che elimini lo schiavismo dei "datori di lavoro" italiani che imperversano in ogni angolo della Penisola?
«Denuncia di Medici per i diritti umani: nella Piana di Gioia Tauro braccianti sfruttati e abbandonati alla miseria»
I negrieri della porta accanto non hanno il cuore tenero. La fatica è da bestie. La paga è da fame. Chi si ribella può anche andarsene. Ma se resta tra i filari degli aranceti a reclamare un euro in più, potrebbe finirgli male. Tanto c’è sempre qualcuno più affamato di lui pronto a prenderne la misera paga.
Gli schiavi con permesso di soggiorno sono almeno 3.500: braccianti stagionali che forniscono manodopera a basso costo ai produttori locali di arance, clementine e kiwi vivono in insediamenti informali, tendopoli o capannoni abbandonati. A otto anni dalla rivolta di Rosarno, nella piana di Gioia Tauro è cambiato poco e niente. «I grandi ghetti di lavoratori migranti rappresentano uno scandalo italiano rimosso dalle forze politiche», denuncia Medici per i diritti Umani (Medu) che da cinque anni con una clinica mobile segue le loro condizioni di salute.
Il 'ghetto' più grande è quello della zona industriale di San Ferdinandoche, in un capannone e nella vecchia fabbrica a ridosso, accoglie il 60% degli stagionali. Rovistano tra cumuli e roghi di rifiuti. Medu, che ha pubblicato il dossier dal titolo «I dannati della Terra», ha operato nella zona da dicembre ad aprile curando 484 persone: giovani lavoratori con un’età media di 29 anni, provenienti dall’Africa subsahariana, tra cui un centinaio di donne dalla Nigeria, il 90% dei quali regolarmente soggiornanti.
«È stato un periodo funestato da incendi, uno dei quali tragico, in cui è morta una giovane donna nigeriana, Becky Moses – spiega Alberto Barbieri, di Medu –. Una dignità negata per tanti migranti ma anche per noi cittadini italiani ed europei. In una palude di mancanza di cambiamento ci sono anche esperienze che dimostrano che è possibile fare integrazione con pochi mezzi, come a Drosi, dove gli alloggi sfitti sono stati inseriti in un progetto di affitti a basso costo». Un’esperienza che Medu chiede di replicare, con programmi pluriennali di housing sociale.
Le precarie condizioni di vita, oltre che quelle di lavoro, minacciano la salute fisica e mentale: le patologie più frequenti riguardano l’apparato respiratorio e digerente, in alcuni casi i medici quest’inverno hanno riscontrato principi di congelamento degli arti.
Solo 3 persone su 10 lavorano con un contratto, le altre vengono pagate a cottimo o a giornata, tramite caporali. «In otto anni – sottolinea Riccardo Noury, portavoce di Amnesty – nulla è cambiato ma è cambiato il clima che c’è intorno all’immigrazione: la campagna elettorale è stata intrisa di xenofobia e di messaggi d’odio. Dopo le elezioni il tema è sparito».

Gli interventi istituzionali restano «frammentari, parziali e inefficaci – scrive Medu –. Nel mese di agosto dell’anno scorso è stata allestita un’ennesima tendopoli, la terza in ordine di tempo, che non ha tuttavia fornito una risposta adeguata (dal punto di vista numerico, logistico e dei servizi offerti) ai bisogni alloggiativi dei lavoratori migranti: con 500 posti disponibili a fronte delle oltre 3.000 persone presenti, in assenza di assistenza medica, sanitaria e socio-legale e di mediatori culturali, si tratta ancora una volta di una soluzione di carattere puramente emergenziale, che confina le persone in una zona isolata e lontana da qualsiasi possibilità di integrazione ed inserimento sociale».
La ’ndrangheta non sta a guardare. In passato non sono mancate minacce e raid contro i raccoglitori. Anche per questo molti non se la sentono di protestare. Il pagamento a cottimo è il più diffuso: 0,50 centesimi per ogni cassetta di arance, 1 euro per i mandarini. Chi viene pagato a giornata percepisce tra i 25 ed i 30 euro. Il 34% delle persone lavora 7 giorni la settimana. Perché agli schiavi non è permesso riposare.

il manifesto,
«Anticipazioni sulle licenze di vendita di armi 2017 del ministro Azzarello ma senza relazione alle Camere. Vendite per oltre 10 miliardi incluso il Golfo. Riarmo in vista e solo 150 mila addetti, compreso l'indotto»
Appena entrato in carica il nuovo Parlamento è già stato scavalcato, ignorato quale organo sovrano su un settore che dire strategico è dire poco: il controllo sull’export delle armi e dei sistemi militari.
Se ne sono accorte le organizzazioni che da quasi tre decenni sorvegliano l’attuazione della legge 185 sul rilascio delle licenze di esportazioni di armamenti: Amnesty international, Oxfam, Rete della Pace, Rete per il Disarmo, Movimento dei focolari e Fondazione Finanza Etica.
Hanno scoperto che il ministro plenipotenziario Francesco Azzarello, direttore dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (Uama) soltanto tre giorni fa, come una sorpresa da uovo di Pasqua, ha rilasciato una intervista all’agenzia Ansa fornendo anticipazioni “pesanti” sulle vendite di armi all’estero nell’anno appena trascorso.
Anticipazioni ancorate a «una serie di considerazioni anche di tipo politico prima dell’invio al Parlamento della relazione prevista dalla legge 185», denunciano le associazioni pacifiste, che parlano di «grave sgarbo istituzionale».
I dati diffusi con questa curiosa anteprima parlano chiaro: le autorizzazioni all’export armiero per il 2017 ammontano a 10, 3 miliardi di euro, quindi si attestano per il secondo anno di fila sopra la soglia dei 10 miliardi, anche se il dato complessivo, pari a 14,9 miliardi di commesse autorizzate è in calo del 31% sul 2016. E il bilancio dell’anno scorso resta, per esplicita e soddisfatta sottolineatura del ministro Azzarello “il secondo valore più alto di sempre”. Ciò che ha fatto la differenza due anni fa è stata la grossa partita dei 28 Eurofighter venduti al Kuwait per 7,3 miliardi ma la componente di export direzionata verso i Paesi del Golfo, e quindi verso i sanguinosi conflitti mediorientali, continuano a costituire la fetta più grossa della torta. Nel 2017 c’è infatti da considerare la partita del valore di 3,8 miliardi per navi e missili venduti al Qatar.
Quanto alle bombe sfornate dagli stabilimenti sardi della Rwm Italia , per essere utilizzate – come ha denunciato anche l’Onu – dall’Arabia saudita nella strage di civili in Yemen, nell’anno appena trascorso e probabilmente proprio per merito delle denunce delle associazioni pacifiste e delle organizzazioni internazionali, le licenze sono passate da 486 milioni del 2016 a 68 milioni del 2017.
Nel frattempo il tradizionale mercato di sbocco delle industrie armiere italiane, in primis Leonardo-Finmeccanica e Fincantierima anche tutta una serie di aziende medio-piccole, cresciute di numero da 124 a 136 in un solo anno, che spesso producono in joint venture con imprese straniere in modo da aggirare leggi e limitazioni – cioè il mercato costituito dagli altri paesi della Ue e Nato – ha recentemente subito una contrazione. Ma a ben vedere si tratta di una impasse temporanea, destinata a essere soppiantata da un trend d’incremento.
L’avvisaglia viene proprio in queste ore dal Cile, dove – al salone International Air & Space Fair ancora in corso Leonardo ha appena siglato un contratto con il ministero della Difesa britannico per la fornitura di una suite di protezione elettronica per ammodernare la flotta di elicotteri da combattimento, una cinquantina in tutto, Apache della Raf.
L0orizzonte della Brexit non frena affatto la compartecipazione tecnologica tra Leonardo, Thales, Bae Systems e la statunitense Boing per quanto riguarda radar, sensori e apparecchiatura da guerra. Al contrario l’Europa, che già oggi è la seconda potenza al mondo per spesa in armamenti, nel prossimo futuro si riarmerà sempre di più.
Come denuncia un report del sito Sbilanciamoci.info con il nuovo strumento di cooperazione rafforzata per la creazione di una difesa comune europea – Permanent structure cooperation, in sigla PeSCo – è lecito prevedere, invece che un risparmio per la razionalizzazione dei costi degli eserciti nazionali, in realtà una esplosione delle spese per sistemi d’arma iper tecnologici.
Da quanto il PeSco è stato varato da 25 paesi Ue, in sordina, nel dicembre 2017 la spesa dei paesi europei per le armi è già aumentata e a partire dal 2020 si prevede uno stanziamento di 5,5 miliardi tra fondi europei e nazionali destinati all’acquisto di sistemi di difesa e per la ricerca, con la possibilità che questi soldi vengano anche svincolati dal conteggio dei deficit di spesa pubblica.
In Italia il business bellicoo a detta dello stesso Azzarello, rappresenta lo 0,9% del Pil e dà lavoro, incluso l’indotto, ad appena 150 mila persone.
Ed è bene ricordare che, a fronte di tutti questi miliardi spesi, il moltiplicatore della spesa militare – come ricorda il centro studi Rosa Luxemburg , è assai più basso di quello di servizi pubblici e manutenzione del territorio e beni comuni.

Internazionale, 6 giugno 2018. La storia della strage tentata dal nazifascista di Macerata (Ancona, Italy) Luca Traini, furioso per la presenza di persone dalla pelle più scura della sua. Profili delle vittime innocenti
Macerata, una tranquilla cittadina delle Marche, non trova pace da quando è finita sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. “Macerata come l’Alabama, Macerata come il Bronx”. In città fino a pochi giorni prima si discuteva al massimo della pedonalizzazione del centro cittadino, poi è arrivato il fantasma di Pamela Mastropietro a turbare le notti della provincia.
Il corpo della ragazza di 18 anni, tossicodipendente, è stato ritrovato nelle campagne di Pollenza, era stato fatto a pezzi e nascosto in due valige. Per la morte di Mastropietro è stato arrestato lo spacciatore Innocent Oseghale. Ma gli investigatori non sono riusciti a chiarire le circostanze dell’omicidio, nella prima fase non riuscivano a stabilire se la ragazza era morta di overdose o era stata uccisa. Hanno fermato tre nigeriani. Dopo due mesi un’indagine della scientifica ne ha scagionati due. Secondo la polizia, non erano presenti nella casa di via Spalato dove è avvenuto l’omicidio.
Nonostante la confusione delle informazioni sulla morte di Mastropietro, Luca Traini, un neonazista di Tolentino, candidato della Lega alle amministrative del giugno del 2017 a Corridonia, ha deciso che i responsabili della morte di Mastopietro erano i nigeriani di Macerata e che i neri in generale sono un problema per la città. Per questo, a quattro giorni dal ritrovamento del corpo, ha preso la sua pistola Glock e la sua Alfa nera e si è messo a girare per Macerata sparando ai neri. Ha aperto il fuoco in dieci punti della città, esplodendo in tutto trenta proiettili e colpendo almeno sei persone. I feriti non avevano mai incontrato l’aggressore prima che alzasse la pistola contro di loro.
Sogni ricorrenti
Festus Omagbon ha 33 anni ed è originario di Benin City, in Nigeria. Il 3 febbraio camminava da solo con il cappuccio della giacca a vento sulla testa, perché aveva freddo. Traini, che arrivava alle sue spalle, ha fatto inversione e ha fermato la macchina. Voleva controllare che fosse un nero. Omagbon ha visto abbassarsi il finestrino. Un uomo calvo con un pizzetto sul mento lo ha guardato con gli occhi sbarrati. Ha alzato la pistola e ha sparato.
Ha un sorriso aperto Omagbon, mentre è seduto davanti a una scrivania nell’ufficio del Gruppo umana solidarietà (Gus), l’organizzazione che gestisce l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati a Macerata. Vive in un appartamento con otto persone a Servigliano, un paesino di mattoni rosa nella valle del fiume Tenna, con le colline che disegnano un paesaggio dolce sullo sfondo. Il foro del proiettile sull’avambraccio destro non si è ancora rimarginato e un tutore nero sostiene l’arto ancora debilitato. Omagbon non sa per quanto tempo dovrà tenerlo.
Le ferite si stanno rimarginando, ma nella sua mente rimane un interrogativo: non riesce a capire perché Traini gli abbia sparato. Prima di questa aggressione, non ha mai avvertito ostilità nei suoi confronti. “A volte al supermercato se mi mancano i soldi per comprare qualcosa, capita che qualcuno mi aiuti. Ho sempre incontrato persone gentili. Mai un insulto o una parola fuori posto”, racconta.
Alla sua famiglia in Nigeria non ha il coraggio di raccontare cosa è successo
Omagbon ha ottenuto la protezione umanitaria e ha tutti i documenti in regola. Sarebbe dovuto uscire dall’accoglienza a marzo, ma dopo l’attentato gli operatori hanno chiesto di prolungare la permanenza per aiutarlo anche dal punto di vista sanitario. Vorrebbe fare l’autista di taxi o di autobus, ma sta facendo fatica a imparare l’italiano e a prendere la patente di guida. Si applica molto, dicono gli operatori. Di notte sogna ancora il volto fermo di Traini mentre alza la Glock e spara.
Non si aspettava un’aggressione del genere e ora ha paura di camminare per le vie del paese, a ogni rumore sobbalza. La mattina del 3 febbraio era uscito di casa alle sei, a Servigliano, e aveva preso un autobus per Macerata: voleva comprare un po’ di ingredienti speciali in un supermercato gestito da un pachistano, per cucinare piatti tipici nigeriani.
Aveva sonnecchiato sull’autobus fino all’arrivo in città poi al capolinea era sceso e a piedi stava raggiungendo il centro cittadino, quando da un’auto nera è stato esploso il proiettile che l’ha gettato a terra. Va spesso in chiesa, pregare lo fa sentire bene, lo tranquillizza. È convinto di essere ancora vivo per una grazia ricevuta dal cielo. Alla sua famiglia in Nigeria non ha il coraggio di raccontare cosa è successo.
Morirò giovane
Anche Wilson Kofi, un altro dei sei feriti, all’inizio non ha raccontato ai suoi genitori in Ghana che ha rischiato di morire. “Nel mio paese se qualcuno ti spara significa che fai parte della malavita, hai commesso qualche reato. Non è possibile che ti sparino per strada se non sei un criminale”, afferma. Così ancora cerca di spiegare ai genitori che a tentare di ucciderlo è stato un neonazista che leggeva il Mein Kampf di Adolf Hitler, uno che ce l’ha con i neri perché li ritiene inferiori.
Kofi ha ventun anni, non ha studiato oltre le elementari. Vorrebbe fare il muratore o il manovale, mestieri che ha già fatto in Ghana e in Libia, ma il proiettile che l’ha colpito alla spalla ha danneggiato l’articolazione. “È difficile ora pensare a un futuro per me”, afferma, mentre osserva le persone che passano davanti alla finestra dell’appartamento al piano terra in cui abita con altri ragazzi. Indossa un giubbotto di pelle verde e sembra spaesato. “Mi dovrò inventare un nuovo lavoro, magari riparare gli elettrodomestici”.
Da nove mesi abita a Macerata e il 3 febbraio era uscito di casa con il suo amico Eric per andare in centro. Mentre camminava ha sentito degli spari, Eric ha cominciato a gridare e a correre. Kofi invece è rimasto come bloccato. Non riusciva più a muovere le gambe. Ha sentito gli spari, poi un colpo, ha sentito il suo amico gridare e lo ha visto allontanarsi. Il proiettile gli è entrato nella spalla, ha visto il sangue sgorgare: “C’era sangue ovunque, ma io non ho sentito dolore”.
È caduto a terra e ha perso i sensi: “Sentivo le voci intorno a me, sentivo i passi, la confusione”. In particolare ricorda la voce di una ragazza che gli ha preso la mano e gli è stata vicino. Qualcuno ha fotografato questa ragazza bionda, che lo ha rassicurato fino a quando sono arrivati i medici: “Non ti preoccupare, sta arrivando l’ambulanza”, diceva. Ora Wilson vorrebbe trovarla per dirle grazie e a tutti i giornalisti che incontra chiede di diffondere la foto per far sapere alla ragazza che le è molto grato e vorrebbe dirglielo di persona.
“Ho pensato che la mia vita sarebbe finita così, su quel marciapiede, quella mattina. Riuscivo solo a pregare, perché se stai per morire è inutile pensare ad altro, meglio parlare direttamente con dio”, racconta. Anche Wilson Kofi è molto religioso e ha capito quello che gli era successo solo una volta arrivato in ospedale. Nel pronto soccorso c’erano solo neri e qualcuno gli ha detto che un uomo si era messo a sparare contro i neri.
Il processo contro Luca Traini comincerà il 9 maggio: il ventottenne di Tolentino è accusato di strage, tentato omicidio e danneggiamento per odio razziale. Nel primo interrogatorio non si è pentito e al processo, secondo la stampa locale, la difesa potrebbe chiedere una perizia per dimostrare l’incapacità di intendere e di volere dell’aggressore.
Wilson Kofi non vuole assistere alle udienze, ha affidato la sua difesa a un avvocato. Non lo convince la storia raccontata da Traini, quella della vendetta per la morte di Pamela Mastropietro . “Se avesse voluto vendicarla avrebbe dovuto uccidere chi l’ha uccisa, non mettersi a sparare per strada. Siamo tutti neri, ma non siamo la stessa persona. Siamo tutti neri, ma veniamo da paesi diversi, siamo persone diverse”, afferma. Non vuole vederlo in faccia Traini, non vuole parlarci. Ora ha paura anche a uscire di casa, ha paura di morire giovane. “Nel mio paese se vieni attraversato da un proiettile come è successo a me, anche se sembri guarito, poi muori lo stesso”, dice con uno sguardo ancora atterrito.
Tutti spacciatori?
A venti giorni dall’attacco razzista di Luca Traini, la sede del Gus di Macerata è stata presa di mira: il 26 febbraio in pieno giorno un uomo incappucciato ha lanciato pietre contro il portone di vetro dell’organizzazione, rompendolo. Qualche settimana dopo l’uomo è stato identificato dalla Digos e fermato: ha detto di aver agito per esasperazione, perché disoccupato. “La campagna di ostilità contro il Gus è cominciata ben prima dell’attacco di Traini contro i neri. È stato un crescendo negli ultimi due anni e in particolare negli ultimi mesi”, spiega Paolo Bernabucci, presidente nazionale del Gus.
“Tutto è cominciato con l’inchiesta Mafia capitale che ha scoperchiato interessi mafiosi legati alla gestione dei migranti. Da quel momento tutte le organizzazioni che si occupano di richiedenti asilo in Italia sono state accusate di voler fare profitto coi profughi”, aggiunge Bernabucci. Ma questa è “diventata una giustificazione per molti razzisti”. Si sente spesso dire “non sono razzista, ma sono contro il business degli immigrati”. Il Gus opera a Macerata dal 2004 e oggi ospita 110 rifugiati nel servizio Sprar e 80 richiedenti asilo nei Cas.
“Sempre più spesso i maceratesi gridano all’invasione, anche se i richiedenti asilo in città sono meno dell’un per cento della popolazione”, aggiunge Bernabucci che difende il modello diffuso di accoglienza scelto dal Gus, quello che rifiuta la logica dei grandi centri di accoglienza e preferisce la sistemazione in appartamento. “A Macerata abbiamo sempre avuto tassi di inserimento lavorativo dei richiedenti asilo (33 per cento nel 2017) superiori alla media nazionale, molti trovano un impiego nelle aziende della provincia, ma la percezione del fenomeno migratorio sta cambiando radicalmente e i sentimenti di ostilità sono sempre più forti”.
Nel capoluogo marchigiano sono ospitati 360 richiedenti asilo, i due terzi di loro sono accolti da un Cas
Il Gus, come molte altre associazioni che si occupano di rifugiati e richiedenti asilo in Italia, è accusata di “fare business” con l’accoglienza, perché è una delle principali organizzazioni di questo tipo a Macerata e in Italia. “Quello che non viene mai detto però è che diamo lavoro a quattracento persone del posto e che i soldi che prendiamo dallo stato sono spesi per pagare i professionisti che lavorano per noi”, continua.
Il 28 febbraio la guardia di finanza ha aperto un fascicolo sull’organizzazione accusata di non aver versato l’iva per le prestazioni pagate. Bernabucci si difende dicendo di “aver seguito le regole fiscali a cui è soggetto il settore. Non versiamo l’iva perché a nostra volta non la incassiamo. Non siamo un ente commerciale. Se dovessimo pagarla noi, tutti gli altri che lavorano nel nostro ambito dovrebbero farlo”.
Nel capoluogo marchigiano sono ospitati 360 richiedenti asilo, per due terzi accolti da un Centro di accoglienza straordinaria (Cas). Il loro arrivo in città è stabilito dal prefetto e dal ministero dell’interno, perché i comuni della zona non assicurano abbastanza posti nei centri di accoglienza ordinaria (Sprar). Secondo l’ultimo rapporto Sprar, solo il 46 per cento dei comuni marchigiani partecipa all’accoglienza di richiedenti asilo.
Dopo l’attacco di Traini, il sindaco di Macerata Romano Carancini ha chiesto al ministero dell’interno di chiudere i progetti Cas e di lasciare aperti solo gli Sprar, rispettando la cosiddetta clausola di salvaguardia che stabilisce che i comuni che aderiscono allo Sprar ospitino due richiedenti asilo ogni mille abitanti. Il Gus è stato criticato anche perché Innocent Oseghale è stato ospitato da uno dei suoi progetti, prima di essere mandato via per cattiva condotta. “Ci siamo dovuti difendere dall’accusa di ospitare degli spacciatori, come se tutti i richiedenti asilo fossero spacciatori”, afferma un operatore. “Il livello di ostilità è davvero allarmante”.
Macerata come l’Alabama
A piazza della Libertà gruppi di universitari si ritrovano la sera sotto ai portici del palazzo municipale di mattoncini, qualcuno è appena uscito dal teatro Rossi. Sulla facciata neoclassica del comune una targa di marmo ricorda i caduti maceratesi della battaglia di Dogali: una delle pagine più dolorose del colonialismo italiano nel Corno d’Africa. Per Stefania Animento, una giovane sociologa maceratese che da qualche anno si è trasferita a Berlino, Macerata è diventata come Marte: si sente un’aliena a parlare con i suoi concittadini. Le capita spesso di sentire qualcuno che dice: “Luca Traini ha sbagliato ma…”, oppure: “Poteva andare peggio, qualcuno avrebbe potuto farsi male”.
È stata propria una frase come questa, pronunciata da un maceratese in tv durante un’intervista, a farla saltare sulla sedia e a spingerla a prendere il primo aereo per tornare a casa all’indomani dell’attentato. “Di solito quando dico ai miei amici stranieri che sono di Macerata, tutti mi guardano con sconcerto, nessuno sa nemmeno dove si trovi. Mi chiedono se è in Toscana”, racconta. Ma in poche ore a febbraio tutto il mondo ha scoperto le coordinate geografiche di casa sua.
“Macerata sul Guardian, Macerata sui siti di mezzo mondo: Macerata era la città di Traini, Macerata casa mia, sembrava diventata improvvisamente l’Alabama”, racconta Animento. Appena arrivata a casa, ha trovato che a piazza della Libertà si erano radunati i militanti di CasaPound, arrivati per partecipare a una manifestazione di solidarietà con Luca Traini. “Una presenza nuova e inaspettata”, dice la sociologa, che ora fa parte del gruppo Macerata antifascista.
Subito dopo l’attacco si è parlato molto di emergenza fascismo nelle Marche, in realtà in città da dicembre si era formato il gruppo Macerata antifascista per contrastare il ritorno di atteggiamenti xenofobi alimentati soprattutto dal gruppo Macerata ai maceratesi, legato a Forza Nuova e attivo in città dal 2015.
Nel 2013 davanti alla sede del Partito democratico di via Spalato (la stessa presa di mira da Traini il 3 febbraio) era apparsa una scritta: “Kyenge torna in Congo”. L’ex ministra dell’integrazione Cécile Kyenge, dopo la tentata strage, partecipando alla manifestazione antirazzista, aveva commentato: “Il gesto di Luca Traini non è venuto fuori dal nulla”. Infatti dal 2015 proprio nella città marchigiana Kyenge si è costituita parte civile in un processo contro un dirigente locale di Forza nuova, Tommaso Golini, fondatore di Macerata ai maceratesi e accusato di propaganda razzista per la scritta contro l’ex ministra.
“Ci siamo resi conto che stavano aumentando i segnali d’insofferenza verso i migranti, tra l’altro il comune aveva assegnato una sala a Macerata ai maceratesi. Allora abbiamo deciso di organizzarci, ben prima dell’attacco di Traini”, spiegano Giulia Sacchetti della Palestra popolare e Cecilia Trisciani di Macerata antifascista. “In passato Macerata ai maceratesi aveva organizzato qualche picchetto, ma sembravano veramente poche persone. Per questo prima del dicembre 2017 non ci eravamo preoccupati”, afferma Trisciani. “Poi abbiamo capito che il loro discorso stava facendo presa tra la gente, stava entrando nei discorsi al bar”.
Per Trisciani la cosa più allarmante è la cosiddetta zona grigia: “C’era sgomento e vergogna per il gesto di Traini, un ragazzo incontrato mille volte per strada o al bar, che aveva cominciato ad andare in palestra e a frequentare l’estrema destra. Ma anche un senso d’indignazione e spavento per le molte affermazioni di solidarietà dei maceratesi verso Traini che venivano condivise soprattuto sulla pagina Facebook Sei di Macerata se…”.
Stefania Animento ha provato a esaminare la situazione da sociologa: “Osservando i dati sulla disoccupazione, sulla partecipazione al mercato del lavoro, sul benessere economico, sull’istruzione e soprattutto concentrandosi sulle serie storiche e sul rapporto dei dati regionali rispetto a quelli nazionali, emerge che le Marche sono nella media italiana”, afferma. Lo stesso discorso vale per l’immigrazione: “Con circa il 9 per cento di popolazione immigrata, le Marche e la città di Macerata coincidono quasi perfettamente con i dati nazionali”. Questa “medietà” della città, rappresentata come tranquilla, benestante e operosa, non ha aiutato però a percepire i cambiamenti traumatici avvenuti negli ultimi anni, che hanno continuato a ribollire sotto traccia.
I ragazzi e le ragazze che chiedono qualche spicciolo davanti al supermercato danno fastidio
Il crac della Banca delle Marche avvenuto nel marzo 2016 ha volatilizzato 1,2 miliardi di euro trascinando sul lastrico molti risparmiatori, i terremoti dell’estate e dell’autunno del 2016 hanno portato un senso di terrore e precarietà nella vita di molte famiglie della zona, la ricostruzione si è fatta attendere e i danni per le attività produttive sono state ingenti. L’onda lunga della crisi economica del 2008, infine, ha avuto come conseguenza la chiusura di decine di fabbriche, la delocalizzazione delle imprese locali e la precarizzazione dei contratti di molti lavoratori.
Questi cambiamenti sono tornati a galla con il trauma dell’omicidio di Pamela Mastropietro e poi con l’attentato di Traini. “Nessuno è sceso in piazza per il crac della Banca delle Marche, ma tutti si sono sentiti minacciati dalla morte di Mastropietro”, spiega Animento. I neri, gli immigrati rappresentano in questo momento le paure profonde dei maceratesi: “I ragazzi e le ragazze che chiedono qualche spicciolo davanti al supermercato danno fastidio. La piccola e media borghesia, il ceto medio marchigiano, quello con tassi di propensione al risparmio più alti della media italiana, nonostante il benessere ha paura di perdere tutto, perché non ha più la prospettiva di una crescita”.
“Chi è di estrazione sociale più bassa, chi non ha studiato e ha fatto l’operaio per una vita intera e ha faticato e risparmiato, secondo il costume locale, per mettere da parte i soldi per comprare il suv o l’appartamento ai figli non sopporta quelle mani tese e quei ‘ciao capo’ davanti al supermercato. Suonano come una presa in giro, la scoperta che anni e anni di lavoro, in fondo, non hanno fatto sparire la paura di non arrivare a fine mese e non hanno regalato il privilegio di fregarsene di come va il mondo”, conclude Animento. In questo modo prova a spiegare, almeno in parte, il successo della Lega, che il 5 marzo a Macerata ha preso il 20 per cento dei consensi, passando dai 153 voti nel 2013 ai 4.575 voti nel 2018.
Il corpo spezzato di una donna
“Per molto tempo non sono riuscita a dormire dopo l’omicidio di Pamela Mastropietro”, racconta Federica Nardi, una giornalista che scrive per il giornale online Cronache maceratesi ed è dottoranda di ricerca all’università di Macerata. Per Nardi finché non si farà chiarezza sulla morte atroce di Mastropietro, ma anche sulle notizie false e sui pregiudizi seguiti all’omicidio, Macerata non troverà pace.
“Molti hanno creduto ai riti vudù, ai nigeriani che hanno mangiato il cuore della ragazza, anche se questa notizia è stata molte volte smentita dalla procura”, racconta Nardi. Qualcuno, come Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia e altri politici locali, ha addirittura fatto campagna elettorale sulla storia del cuore sparito, un particolare agghiacciante che è stato sempre negato dagli investigatori, ma che ha avuto più diffusione delle notizie verificate sull’omicidio di Mastropietro. “Siamo stati sciacallati dai politici in campagna elettorale”, continua Nardi.
I giornali locali sono stati accusati di aver soffiato sul fuoco del razzismo, ma per la giornalista sono soprattutto i social network e i siti di notizie false ad aver approfittato dell’omicidio della ragazza per dare messaggi di un certo tipo. “In particolare la pagina Facebook Sei di Macerata se… ha cavalcato l’odio e la tensione, veicolando messaggi fortemente razzisti”, spiega.
Qualche anno fa Baleani è stata picchiata e gettata nel cassonetto sotto casa da suo marito
La provincia è soprattutto vicinanza. Vicinanza con le vittime, ma anche con i carnefici. “Luca Traini lo conoscevamo tutti, era uno di noi. E per questo alcuni si sono vergognati per quello che ha fatto, altri lo hanno giustificato”, spiega Nardi. La provincia è riconoscersi, conoscersi tutti fin da bambini: “Pensare che una ragazza è stata fatta a pezzi a poche strade da casa mia, in un quartiere della Macerata bene, non ci fa dormire sonni tranquilli”. Quando l’8 marzo le donne e le ragazze sono scese in piazza aderendo alla marcia di Non una di meno “Pamela Mastropietro è stata nei pensieri di molte di noi”, dice Nardi. “È chiaro che il suo corpo fatto a pezzi è stato usato per dire altro, come avviene spesso con il corpo delle donne”.
Non è stato certo il primo caso di violenza sulle donne avvenuto nella zona: al centro antiviolenza della città nel 2017 sono state registrate 41 denunce. E poi c’è il caso di Francesca Baleani, la moglie dell’ex direttore del teatro Rossi di Macerata, che nel 2006 sconvolse la cittadina: “Qualche anno fa Baleani è stata picchiata e gettata nel cassonetto sotto casa da suo marito, poi è stata soccorsa da un passante che ha sentito gli strepiti della donna ancora viva”, racconta Nardi.
Lo scorso anno Baleani, che in seguito alla sua esperienza si è impegnata contro la violenza sulle donne, ha ricevuto un premio a Parma per il suo operato e in quell’occasione non ha avuto parole tenere per Macerata e per i maceratesi, accusando la città in cui vive di non essere “capace di abbracciarla e di pronunciare il suo nome e la sua storia senza provare imbarazzo”.
Dopo la morte di Pamela Mastropietro e la tentata strage razzista di Luca Traini, la violenza è tornata al centro della discussione in una città che in tutti i modi prova a rimuoverla. Macerata deve fare i conti con almeno quattro fantasmi: la violenza sul corpo di una donna, il razzismo cieco contro i neri, l’indulgenza verso i carnefici e infine la grande diffusione di sostanze stupefacenti in un territorio che ha tassi di morte per overdose superiori alla media nazionale.
Il fatto che a uccidere Mastropietro siano stati presumibilmente degli immigrati ha permesso di usare due capri espiatori perfetti per deresponsabilizzare la comunità: i neri e la droga. Con le studenti del corso in cui insegna, Nardi ha deciso di smontare i pregiudizi di questa vicenda e nella prima lezione le ha portate a fare interviste ai Giardini Diaz, diventati il simbolo dello spaccio e del presunto degrado della città.
Ai Giardini Diaz Pamela Mastropietro ha incontrato Innocent Oseghale, ai Giardini Diaz si sono dati appuntamento gli attivisti che qualche giorno dopo l’attentato di Luca Traini hanno manifestato solidarietà alle vittime. “Ho chiesto alle ragazze di stare sedute per qualche ora a guardare quello che succedeva, perché non tutti gli immigrati sono spacciatori e non tutti i maceratesi sono razzisti. E forse è venuto il momento di capire, di ritrovare la complessità, invece di dividerci in tifoserie. Solo condividendo gli spazi e guardando la realtà senza mediazioni sarà possibile ricostruire una verità condivisa su tutta questa faccenda”.
Sull’argomento leggi anche:
A Macerata rinasce un movimento antirazzista
Da Fermo a Macerata, la vera emergenza è il fascismo
Da sapere: la costa adriatica è l’hub dell’eroina in Italia
Nella costa adriatica sembrano concentrarsi i traffici di eroina in una maniera non paragonabile a nessun altra regione italiana. Secondo Salvatore Giancane – autore del libro Il mercato globale dell’eroina – nell’Adriatico convergono due delle tre grandi rotte dell’eroina dall’Afghanistan all’Italia: la rotta balcanica e la rotta meridionale africana. In questo territorio si sovrappongono diversi gruppi di importatori che si servono anche di una diffusa rete di venditori al dettaglio.
Anche i dati sul consumo dicono cose simili. Recentemente la Società italiana tossicodipendenze ha lanciato un progetto GeOverdose per monitorare, a partire dalle notizie di cronaca, le morti per overdose in Italia. Dalla mappa emerge che dal gennaio del 2018 ci sono stati 48 decessi su tutto il territorio nazionale e tra le zone con più diffusione ci sono proprio le Marche con almeno cinque casi di morti sospette per overdose. Per Stefano Trovato del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) di Macerata uno dei problemi delle Marche è che non c’è un osservatorio sulla diffusione delle droghe nella regione e anche le politiche di riduzione del danno sono poco praticate.
“L’uso dell’eroina – anche a causa dei prezzi sempre più bassi – è molto diffuso, anche in fasce di età giovanili, ma c’è pochissima consapevolezza del fenomeno e questo determina la mancanza di politiche pubbliche in grado di rispondere al problema. I ragazzi non possono parlare con nessuno, non hanno informazioni su questa questione se non da chi già fa uso di sostanze stupefacenti o dagli spacciatori”. Per Trovato dopo la morte di Pamela Mastropietro la risposta delle autorità è stata di tipo securitario, con blitz antidroga nei parchi cittadini e volanti della polizia nelle strade: “Ma questo tipo di misure non sono sufficienti se non si mettono in atto una serie di politiche serie sul tema”.
Articolo ripreso dalla pagina qui raggiungibile

Internazionale giornale,
Negli anni trenta mio padre ha perso due zii in una battaglia contro i fascisti ad Al Jawsh, un paesino nella Libia occidentale a ventisette chilometri circa da Shakshuk, la città d’origine di mio padre e della nostra tribù. Quel giorno per i tre fratelli era cominciato proprio come nella canzone Bella ciao: “Una mattina mi son svegliato e ho trovato l’invasor”. Mio nonno è stato l’unico a sopravvivere. Si chiamava Khalifa.
Non ho conosciuto mio nonno, tutto quello che so di lui viene dai racconti che me ne faceva mio padre quand’ero bambino. Quelle storie sono una delle poche cose che condividevamo. Io preferivo i racconti di mia madre, non solo perché mi è più vicina ma anche perché mi descriveva le persone e il loro modo di vestire, di camminare e di parlare, e poi i luoghi e gli odori, i colori e le sensazioni che lei provava.
Ricordo un cartone animato che io e mio fratello adoravamo guardare da piccoli. In uno degli episodi c’era la storia di due fratelli che litigano in continuazione e che per questo finiscono trasformati in cani (credo c’entrasse la magia, ma non lo ricordo con precisione). Mio padre, in silenzio fino a quel punto, sorrideva e diceva: “Visto cosa è successo? Se continuate a litigare capiterà lo stesso anche a voi”.
Gli ultimi testimoni
Ci sono alcune persone, come mio padre, che danno continuamente lezioni di vita, e altre, come mia madre, che ti raccontano una storia e poi lasciano che sia tu a trarre le conclusioni. Da quando sono diventato adulto, forse il periodo più lungo che ho trascorso da solo con mio padre è stato l’anno scorso, quando per qualche settimana è stato ricoverato in ospedale mentre Tripoli era sull’orlo di un’altra lotta tra milizie. Io e mio fratello avevamo deciso di fare turni di ventiquattr’ore per stare con lui, così da essere sicuri che non sarebbe rimasto da solo in caso gli scontri avessero bloccato le strade in direzione dell’ospedale.
Le ore in ospedale erano lunghe, perciò abbiamo cominciato a parlare davvero, tanto. Mi ha raccontato di nuovo tanti episodi che avevo ascoltato da bambino, ma stavolta mi ha dato la versione integrale e ha risposto alle mie domande.
Le ore in ospedale erano lunghe, perciò abbiamo cominciato a parlare davvero, tanto. Mi ha raccontato di nuovo tanti episodi che avevo ascoltato da bambino, ma stavolta mi ha dato la versione integrale e ha risposto alle mie domande.
Ho capito allora che i testimoni dell’epoca dell’occupazione italiana e della seconda guerra mondiale sono anziani, e che i ricordi di queste generazioni spariranno con loro. Senza le loro voci, nessuno potrà più parlare di quell’epoca a partire da un’esperienza personale e l’unica fonte a nostra disposizione resterà il sapere che ci ha trasmesso il regime, con una notevole “sintesi” storica. Questo ha determinato un divario tra le generazioni, e tutte le volte che si crea un divario si crea anche la necessità di riempirlo. Oggi il dibattito su quell’epoca è complicato, e nessuno è interessato a comprendere le complessità.
Per esempio, agli studenti a scuola non s’insegna che molti libici collaborarono con i fascisti, che intere brigate e molti capi tribù lavorarono e combatterono per loro e si divisero al proprio interno per questo. Non leggiamo delle reclute che marciarono al fianco dei soldati italiani per conquistare l’Etiopia. Per non parlare del dibattito sui crimini commessi contro gli ebrei libici: era ed è ancora un tabù. In realtà alcune delle famiglie più ricche nella Libia di oggi devono la loro prosperità a quel periodo, ai soldi e alle proprietà che rubarono agli ebrei costretti a lasciare il loro paese.
Alle generazioni postbelliche sono stati insegnati solo alcuni fatti, che non potevano in nessun modo essere contestati. Per più di quarant’anni il governo libico ha scelto di ignorarne alcuni e amplificarne altri. Lo strumento principale è stato il Centro nazionale per gli archivi e gli studi storici. Fondato nel 1977 con il nome di Centro per le ricerche e gli studi sul jihad libico, nel 1980 era diventato il Centro del jihad libico per gli studi storici. Questo centro è stato istituito soprattutto con l’obiettivo di “condurre ricerche di tipo documentario, raccogliere manoscritti, documenti e opere legate al suo scopo, e documentare tutte le fasi del jihad libico contro la colonizzazione italiana”. Il 24 marzo 2009 lo hanno unito al Centro nazionale per i manoscritti e gli archivi trasformandolo appunto in Centro nazionale per gli archivi e gli studi storici.
All’inizio del 2009 era stato diffuso un “annuncio importante”: “Il Centro del jihad libico sta registrando i nomi dei fratelli che hanno combattuto con l’Italia in Abissinia, Eritrea, Somalia e nella seconda guerra mondiale, e gli impiegati e gli operai libici che hanno collaborato con l’amministrazione coloniale italiana dal 1911 al 1942. I fratelli in questione, i loro nipoti o parenti devono affrettarsi per andare al centro del jihad di Tripoli o alle sue filiali in tutta la Jamahiriya (Libia) per riempire il modulo di registrazione”.
Perché questo improvviso interesse per un argomento fino ad allora trascurato? Il motivo per cui il Centro era stato incaricato di preparare quelle liste è che il governo italiano aveva accordato “il ripristino del pagamento delle pensioni ai titolari libici e ai loro eredi che, sulla base della vigente nominativa italiana, ne abbiano diritto”, secondo quanto si leggeva nel Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Libia e la repubblica italiana firmato a Bengasi nel 2008.
È come se annunciaste la possibilità di pagare i collaboratori del regime nazista nei paesi europei occupati dalla Germania durante la seconda guerra mondiale, compresi quelli che hanno lavorato nei campi di concentramento nazisti e quelli che hanno contribuito a reprimere la resistenza. Quante persone o familiari sarebbero orgogliosi di fare un passo avanti e annunciare che il loro padre o nonno hanno collaborato con i fascisti e ritirare la loro pensione? Non molti, immagino, ed era proprio questo lo scopo di quell’articolo: per quanto umiliante possa essere, non sarà mai davvero applicato, non è altro che un trucco dell’accordo.
L’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi ha dichiarato a proposito dell’accordo: “C’è un riconoscimento completo e morale dei danni inflitti alla Libia da parte dell’Italia durante il periodo coloniale”. Nonostante le dichiarazioni, esaminando gli articoli del trattato e prestando attenzione non solo a quello che è scritto ma anche a quello che non è scritto, si nota qualcos’altro.
“L’Italia, sulla base delle proposte avanzate dalla Grande Jamahiriya e delle successive discussioni intervenute, si impegna a reperire i fondi finanziari necessari per la realizzazione di progetti infrastrutturali di base che vengono concordati tra i due Paesi nei limiti della somma di cinque miliardi di dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per 20 anni”. Il pacchetto di risarcimento comprende progetti di costruzione, borse di studio per studenti (cento) e pensioni per i soldati libici che hanno prestato servizio nell’esercito italiano durante il periodo coloniale.
Se avessero davvero voluto risarcire le vittime dei fascisti, avrebbero dovuto offrirsi di pagare le vittime dei campi di concentramento e dei tribunali militari, che hanno condannato a morte tanti libici dopo processi sommari. Quello che è stato vagamente annunciato come un “risarcimento completo e morale” non è andato oltre quella frase.
Di fatto l’accordo non solo ha ignorato i crimini dei fascisti, ma ha cercato di premiare i libici che hanno contribuito a commetterli. In quei campi di concentramento è stato ucciso un terzo della popolazione della Cirenaica: quelli che non sono stati giustiziati o non sono morti a causa di epidemie, sono morti di fame o uccisi dalle lunghe marce forzate”. Tutto ebbe inizio quando Mussolini – “il più grande bluff d’Europa”, come lo definì Hemingway – assunse il controllo dell’Italia.
Il genocidio libico
Dopo la marcia su Roma, Mussolini dichiarò dal suo balcone che avrebbe reso di nuovo grande l’Italia. Forse offrì alla folla eccitata una delle sue pose da supereroe; per lui quel balcone era l’equivalente di un account Twitter. La Libia era il primo articolo da spuntare nella sua lista di cose da fare per rendere di nuovo grande l’Italia, e così iniziò la “pacificazione della Libia”, o meglio il “genocidio libico”.
La campagna partì nel 1923, quando soldati armati fino ai denti e sostenuti da aeroplani e mercenari marciarono contro i libici, che possedevano solo vecchi fucili ottomani, cavalli e cammelli. Alla fine del 1924 la Tripolitania era interamente sottomessa. Le tribù erano troppo impegnate a combattere le une contro le altre, e la resistenza disorganizzata ne rese più facile la sconfitta. Nel 1929 le due regioni e il Fezzan del nord furono unificate. La resistenza era ridotta a piccoli gruppi in Cirenaica, sotto la guida di Omar al Mukhtar. Continuarono a condurre una guerra di guerriglia sfruttando la loro conoscenza del territorio e la loro facilità di spostamento.
Distruggere ciò che restava della resistenza divenne la missione del generale Graziani. Per riuscirci era disposto a tutto, anche all’uso di bombe all’iprite, nonostante l’Italia avesse firmato nel 1925 la convenzione di Ginevra sulla messa al bando delle armi chimiche in battaglia. Pensava che il modo migliore per affrontare la resistenza fosse isolarla. Poi diede il via alle deportazioni di massa dei libici rinchiudendoli nei campi di concentramento.
Per descrivere uno di questi campi prenderò in prestito alcuni paragrafi scritti da un sopravvissuto al campo di concentramento di El Aghelia, Ibrahim al Arabi al Ghamari:
«La terra era desolata. Circondati da sabbia e acquitrini, priva di popolazione. C’era un piccolo forte per le ispezioni, circondato da torri, a loro volta circondate da filo spinato per poter contenere il maggior numero possibile di detenuti. C’era un cancello presidiato da agenti di polizia. Fuori a farmi la guardia c’erano contingenti di mercenari somali ed eritrei. Avevano costruito loro le torri con gli uffici del forte per il personale, era compito loro registrare i detenuti e ispezionarli, ogni mattina.
Ogni mattina tutti i detenuti dovevano presentarsi negli uffici del personale per registrare la loro presenza. Se qualcuno non si presentava, voleva dire che era he era morto. Malati e disabili invece dovevano essere portati sulle spalle senza discussione.
Ogni mattina dopo l’appello sceglievano i più giovani e quelli in grado di lavorare e li dividevano in quattro squadre: una era addetta alla pulizia degli uffici, delle latrine e delle stalle, e chi ne faceva parte doveva trasportare sulla schiena i rifiuti fuori dal campo. Un’altra squadra doveva pulire il campo e svolgere altri lavori. I membri di una terza squadra dovevano trasportare sulla schiena le merci dal porto ai negozi, destinati a rifornire soltanto i militari. A una quarta squadra spettava il compito di trasportare fino ai negozi la legna da ardere. Io appartenevo a quest’ultima squadra.
Agli anziani spettava il compito di trasportare i cadaveri e seppellirli.
Ogni giorno c’erano almeno centocinquanta morti. Venivano seppelliti in fosse poco profonde. Non avevano la forza di scavare buche profonde, perciò i cadaveri erano vulnerabili agli attacchi delle iene, dei lupi, delle volpi e dei cani. I corpi andavano in putrefazione e questo ha contaminato tutto il sito, costringendo i responsabili a trasferirlo a un chilometro di distanza.
Tra i detenuti era pericolosamente diffusa la carestia, e molti hanno iniziato a morire di fame. Dopo la morte di un gran numero di detenuti per la fame, la maggior parte dei quali anziani e bambini, le guardie hanno iniziato a distribuire grano importato dalla Tunisia. A ogni persona spettavano due chili di grano ogni due settimane. I detenuti lo cuocevano sul fuoco per migliorarne il sapore e bevevano l’acqua per riempirsi le pance. Molti avevano ulcere in bocca e gengive sanguinanti.
La diffusione di terribili malattie tra i detenuti ha eliminato quasi tutti gli altri. I pazienti venivano ricoverati in tende situate in una angolo lontano del campo, accanto al filo spinato. Se una persona mostrava i sintomi della malattia, la sua famiglia era obbligata a trasferirlo immediatamente in una di queste tende e lasciarlo lì a morire. Nessuno poteva stargli accanto, era proibito. Ogni mattina un parente andava a trovarlo. Se lo trovava morto doveva informare l’ufficio per la registrazione dei detenuti. Questa era l’unica cura consentita. Se una persona ammalata moriva a casa prima di essere stata trasferita nella tenda per i pazienti, venivano inflitte dalle 300 alle 500 frustate ai familiari, che venivano inoltre privati della razione settimanale di grano.
Abbiamo patito molto in queste condizioni disumane: fame, sete e umiliazione erano parte della nostra quotidianità. Non importava se davanti avevano un giovane o un anziano, un uomo o una donna, erano indifferenti a tutto. Le donne venivano frustate sulle gambe e gli uomini sul petto e sulla schiena, dopo averli legati a un palo conficcato per terra.
In occasione di una conferenza stampa durante la sua visita a Roma, Gheddafi ha detto “il mio amico Berlusconi, un amico che oggi tutti i libici conoscono, dopo che con le sue tante utilissime visite in Libia ha aperto la via a questo trattato”. Beh, tutti i libici conoscono Berlusconi solo per la squadra del Milan, e lo ricorderanno per sempre, dopo la sua visita in Libia per firmare il trattato, come il leader italiano che ha baciato la mano di Gheddafi. L’unico e solo canale televisivo nella Libia dell’epoca ha continuato a mandare in onda quel bacio all’infinito. Nel caso non lo aveste visto, ecco a voi un link.
Gheddafi voleva solo questo, apparire. Dal suo punto di vista, voleva dimostrare al mondo e ai suoi cittadini che era ancora “l’uomo di ferro”, come lo definiva Berlusconi. Ha sempre dichiarato di voler rendere di nuovo grande la Libia, addirittura ha rinominato il paese “Grande Jamahiriya araba”. Questa grandezza si manifestava soprattutto nell’ostilità contro le altre nazioni, nei discorsi di odio, nell’eliminazione di ogni opposizione e nell’acquisto di miliardi di dollari di armi con le ingenti riserve petrolifere della Libia.
L’accordo ha inoltre offerto a Gheddafi l’opportunità di ricompensare il suo amico per “’importante contributo dell’Italia al fine del superamento del periodo dell’embargo nei confronti della Grande Jamahiriya”, come sottolineato nell’introduzione all’accordo. Berlusconi non è solo un politico e uomo d’affari, è anche un uomo di spettacolo, come lo stesso Gheddafi, e ha così sintetizzato il vero scopo dell’accordo: “Grazie al trattato siglato oggi, l’Italia potrà vedere ridotto il numero dei clandestini che giungono sulle nostre coste e disporre anche di maggiori quantità di gas e di petrolio libico, che è della migliore qualità”. In poche parole, finché farete scorrere il vostro petrolio e terrete i migranti nella vostra parte di Mediterraneo saremo amici e potremo far finta che nel vostro paese non succeda niente di male.
I nuovi campi
È paradossale che, oltre a ignorare i campi di concentramento e premiare i collaboratori che ci lavoravano, l’accordo abbia gettato le basi per una nuova epoca di campi di concentramento finanziati dall’Italia con l’aiuto di collaborazionisti libici che vengono pagati generosamente. L’unica differenza oggi è che eritrei e somali sono dentro quei campi e non fuori a fare la guardia.
Nel 2011, durante i suoi ultimi mesi al potere, Gheddafi ha spalancato la strada alle barche: chiunque avesse un’imbarcazione veniva pagato per riempirla di migranti e mandarli in mare. Quando il diavolo che conoscevano è andato via, la Libia si è divisa tra molti nuovi diavoli sconosciuti. Il nuovo accordo firmato con Al Sarraj ha revocato e cancellato molti articoli contenuti nella precedente versione. L’ultimo aggiornamento dell’accordo è andato ancora più dritto al punto: ridurre i migranti e tenerli in Libia in cambio di denaro. Stavolta però niente baciamano.
Però c’era un tranello: i nuovi diavoli non sono stati in grado di offrire quello che aveva offerto Gheddafi, ossia il silenzio più assoluto. Per quarant’anni di dittatura Gheddafi ha avuto il totale controllo dei mezzi d’informazione e ha represso tutte le voci, mentre i nuovi signori della guerra non possono controllare del tutto ciò che succede nel mondo. E non si può dire certo che non ci provino.
Tuttavia la parte di questo accordo che preferisco è questa: “A partire dal corrente anno, il giorno del 30 agosto viene considerato, in Italia e nella Grande Jamahiriya, Giornata dell’amicizia italo-libica”. Questa data segna e rappresenta esattamente il contrario, è un promemoria di questo accordo vergognoso e disonorevole. Niente al mondo mi farebbe più piacere oggi di un vero giorno per festeggiare l’amicizia tra Italia e Libia, per avviare una vera cooperazione, uno scambio culturale e un dialogo sincero, distante da loschi accordi disumani.
Libici e italiani non sono responsabili delle azioni dei peggiori tra i loro concittadini. Credo che le persone siano responsabili solo delle loro azioni, di ciò che hanno fatto e anche di ciò che non hanno fatto. Chi approva in silenzio è colpevole tanto quanto chi commette un crimine. Dopo aver letto un libro o guardato un film sulla seconda guerra mondiale e sui crimini orribili commessi da nazisti e fascisti, chiunque a un certo punto si sarà chiesto cosa avrebbe fatto se fosse stato lì, se fosse vissuto in quel periodo. Adesso abbiamo la possibilità di conoscere la risposta. Viviamo in tempi interessanti, oggi sta succedendo di nuovo. Cambiano i nomi e le giustificazioni, ma oggi di nuovo ci sono persone gettate nei campi di concentramento finanziati dai soldi dei contribuenti italiani (adesso mi sembro proprio mio padre).
(Traduzione di Giusy Muzzopappa)

Avvenire
«Nella richiesta di ampliamento la consociata italiana della multinazionale tedesca prevede un'area per «prove di scoppio»
«Realizzazione del nuovo campo prove R140». È questa una delle istanze presentate da Rwm per testare e produrre ordigni da guerra in Sardegna. La consociata italiana della multinazionale tedesca intende cioè realizzare un nuovo poligono di tiro per perfezionare gli esplosivi da provare sul campo prima della messa in commercio. La procedura per l’ampliamento dell’area produttiva è in piedi da mesi. La compagnia, spinta dai ricchi affari per le forniture di bombe aeree alla coalizione saudita che sta combattendo nelle Yemen, deve fronteggiare la crescente richiesta di armi.
Se per un verso è stato avviato uno stabilimento proprio in Arabia Saudita, per l’altro Rwm si appresta a fare della Sardegna il poligono per perfezionare le micidiali bombe e studiare nuovi 'prodotti'. «Per soddisfare le esigenze si prevede di inglobare all’interno dell’area dello stabilimento una zona di proprietà della Rwm Italia SpA, sul lato nord – si legge nelle relazioni consegnate alla Regione Sardegna – attualmente esterna alla porzione recintata ed utilizzata direttamente per le attività dell’opificio».
Dai documenti della società tedesca, rivelati dalla redazione di Youtg.net, si evince che l’azienda intende recintare un’area di sua proprietà, attualmente esterna al muro perimetrale della fabbrica di Domusnovas, per realizzare un campo prove che consisterà in un cratere circondato da «robusti terrapieni» alti 4 metri, e realizzati in cemento e terra.
Stando alle carte su cui dovranno esprimersi le autorità per la concessione dei permessi di ampliamento, «il reparto R140, destinato ad area per prove di scoppio, è costituito da uno spazio piano circondato da robusti terrapieni dell’altezza minima di 4 m». Inoltre, «il piano d’appoggio per i campioni di esplosivo destinati alle prove di scoppio sarà costituito da un letto in sabbia fine che avrà spessore di 1,5 m. Tutta la zona terrapienata verrà recintata con rete metallica alta 2,5 m con un unico cancello di accesso». A distanza di sicurezza dovrà essere realizzato un bunker che servirà come riparo per i lavoratori durante le esplosioni. La relazione contiene anche precisazioni per rassicurare sulla eventuale dispersione di sostanze tossiche.
Nelle settimane scorse Fabio Sgarzi, amministratore delegato della società che produce armamenti a Domusnovas, aveva dichiarato che «non c’è alcuna possibilità di riconvertire la Rwm Italia. Nessun cambio di attività è possibile, la prospettiva sarebbe solo la chiusura della fabbrica e il licenziamento dei dipendenti». Se Regione e Comune di Iglesias respingessero il piano di ampliamento, dunque, Rwm potrebbe ipotizzare «la chiusura della fabbrica e il licenziamento dei dipendenti ». Un ricatto, secondo attivisti e operatori del volontariato, oltre che per gli esponenti del Comitato per la riconversione. Nel marzo del 2016 la multinazionale tedesca, appoggiandosi alla controllata sudafricana Rheinmetall Denel Munition (Rdm) e d’intesa con la Saudi Military Industries Corporation (Samic), ha inaugurato a sud di Riad uno stabilimento nel quale vengono prodotte e assemblate bombe da artiglieria e ordigni aerei del tipo attualmente commissionato allo stabilimento sardo.
Un investimento con un suo specifico peso politico: all’inaugurazione erano presenti il principe ereditario Mohammed bin Salman bin Abdelaziz e l’allora presidente sudafricano Jacob Zuma. La fabbrica saudita, dove attualmente lavorano 130 addetti, ha però necessità di un periodo di rodaggio, perciò Domusnovas resterà ancora per qualche tempo il principale sito di approviggionamento.

la Repubblica
«Quando penso alle province del Lazio e ai suoi borghi, penso ad accogliere più turismo, che rilanci l’economia locale, e meno migranti, che invece pesano sull’economia locale. Non è questione di destra o di sinistra, ma di #buonsenso». Questa terribile dichiarazione di Roberta Lombardi, candidata 5 Stelle alla presidenza del Lazio, è un sintomo da non trascurare.
Di quale ‘buon senso’ si parla? Di quel senso comune, per nulla buono, per cui dei migranti non si ragiona come di esseri umani, ma come di numeri (peraltro del tutto inverosimili: fino a vagheggiare inesistenti invasioni), o come di minacce (la ‘bomba sociale’). Lo stesso ‘buon senso’ per cui bisognerebbe «aiutarli a casa loro» (e questo l’ha scritto Matteo Renzi, dimenticando l’articolo 10 della Costituzione, che dice che l’Italia è casa di tutti coloro che non hanno i nostri stessi diritti), o sostenere mamme e famiglie italiane, «se uno vuole continuare la nostra razza» (Patrizia Prestipino, Pd).

Non cito le innumerevoli frasi di esponenti della Lega, Fratelli d’Italia, e organizzazioni fasciste perché ciò che mi interessa stigmatizzare è la penetrazione di idee di fatto razziste in quello che appunto si presenta come il senso comune. È lo slittamento generale a destra, addirittura l’egemonia di questo non-pensiero, il principale avversario di ogni prospettiva democratica. Luigi Manconi e Federica Resta hanno recentemente argomentato (nel libro
Non sono razzista, ma…, Feltrinelli 2017) circa i nessi tra questa indifferenza morale verso i migranti e quella verso gli ebrei, al tempo dell’Olocausto: «l’indifferenza della vita di ogni singolo in un mondo la cui legge era disinteresse per l’altro e vantaggio individuale universale» (T. Adorno).
Nel caso della Lombardi la dichiarazione ha anche un’altra chiave di lettura. Sarebbe di ‘buon senso’ immaginare i borghi spopolati delle aree interne come grandi alberghi diffusi per turisti, possibilmente per turisti di lusso. Questa idea rischia di dare la mazzata finale a una parte del Paese in cui, tra mille difficoltà, è ancora possibile coltivare uno stile di vita non è del tutto appiattito sull’alienazione morale e sulla solitudine esistenziale delle metropoli. Come spiega Vito Teti in Quel che resta. L’Italia dei Paesi tra abbandoni e ritorni (Donzelli 2017) è proprio questa Italia minore e sofferente che può ridare senso e sapore all’Italia apparentemente vincente. A patto che non la trasformiamo in un gigantesco parco a tema per turisti, ma la aiutiamo a rifarsi tessuto civile: anche con l’integrazione di nuovi italiani, qualunque sia il colore della loro pelle. «Ripopoliamo le aree spopolate dell’Appennino con immigrati e rifugiati», ha proposto il ‘paesologo’ Franco Arminio. «Nella città vecchia il popolo nuovo», ha detto l’urbanista Ilaria Agostini, chiedendo che i centri storici spopolati delle città d’arte siano luoghi di integrazione. E i concreti esempi positivi non mancano, a partire da quello notissimo di Riace.
Investire in questa direzione significa, sul medio e lungo periodo, favorire il «progresso materiale e spirituale della società» (art. 4 Cost). Con quali soldi? È stato calcolato che con i sei miliardi di euro che l’Ue ha dato alla Turchia di Erdogan per bloccare i rifugiati, si sarebbero potuti accogliere e integrare tre milioni di migranti. Questo è buon senso. Così come è buon senso trovare intollerabile che i migranti affoghino nel mare in cui facciamo il bagno d’estate, o che siano chiusi in campi di concentramento pagati dai nostri governi. E questa orrenda campagna elettorale ha un terribile bisogno di trovare un senso. Possibilmente buono.
 Parliamo di foibe e di popolazioni ma, a differenza di Sergio Mattarella, presidente della nostra Repubblica, ne parliamo in un'ottica libera da ogni traccia di ipertrofia nazionalistica
Parliamo di foibe e di popolazioni ma, a differenza di Sergio Mattarella, presidente della nostra Repubblica, ne parliamo in un'ottica libera da ogni traccia di ipertrofia nazionalistica
Fu negli anni del secondo governo Berlusconi che il Parlamento italiano approvò la legge 30 marzo 2004, n.92,
«Istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti
degli infoibati». Le foibe, l’esodo giuliano-dalmata: due espressioni su cui giova riflettere, ancora una volta.
Il 9 febbraio scorso il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, intervenendo solennemente sul ricordo tragico delle foibe, ha parlato anche lui (l’aveva già fatto anni fa il suo predecessore Giorgio Napolitano) degli eventi accaduti a oriente delle frontiere dell’Italia negli anni 1943-1945. Mattarella ha detto: «Capitolo tragico, violenza ingiustificabile. Alla durissima occupazione nazi-fascista di queste terre, nelle quali un tempo convivevano popoli, culture, religioni diverse, seguì la violenza del comunismo titino, che scatenò su italiani inermi la rappresaglia, per un tempo molto lungo: dal 1943 al 1945»
E ha proseguito: «Le stragi, le violenze, le sofferenze patite dagli esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati non possono essere dimenticate, sminuite o rimosse. Esse fanno parte, a pieno titolo, della storia nazionale e ne rappresentano un capitolo incancellabile, che ci ammonisce sui gravissimi rischi del nazionalismo estremo, dell'odio etnico, della violenza ideologica eretta a sistema».
Le Foibe
Domandiamoci intanto che cosa sono le “foibe”, una parola che ha assunto un significato truce, una parola adoperata come un manganello chiodato per colpire slavi e comunisti.
Le foibe sono, geomorfologicamente, voragini di varia ampiezza e profondità caratteristiche dei territori carsici, come in parte dell’Italia nordorientale e della Slovenia. Sono state usate, nell’Europa contadina e silvo-pastorale, come qualunqua altro fosso o dirupo nascosto nella boscaglia e nella campagna: un luogo nel quale nascondere i rifiuti domestici o del lavoro, le carogne degli animali, e occasionalmente i cadaveri dei briganti sorpresi e vinti e dei nemici ammazzati in duelli o un agguati. È evidente che sono state largamente utilizzate nei momenti delle più cruente guerre civili.
Le foibe sono divenute negli ultimi decenni il simbolo di un tragico capitolo della nostra storia. Un capitolo che non si comprende (e anzi se ne rovescia il senso) se lo si guarda e valuta con l’occhio di una sola delle vittime. Chi vuole comprendere che cosa furono davvero le foibe, come e da chi vi gettarono persone vive o cadaveri, legga la documentatissima e rigorosa narrazione della storica Claiudia Cernigoi, una volta disponibile su eddyburg, ora raggiungibile in un volume cartaceo oppure online: Clara Cernigoi, Operazione foibe a Trieste.
Le popolazioni
Il presidente della Repubblica italiana, quando oggi ricorda «la grande sofferenza delle popolazioni istriane, fiumane, dalmate e giuliane» dovrebbe ricordare anche le ancor più grandi sofferenze patite, prima del 1943, dalle popolazioni della Slovenia, della Croazia, del Montenegro e inflitte con indicibile crudeltà da chi portava quella stessa bandiera tricolore che oggi distingue la nostra Repubblica.
Dovrebbe ricordare le stragi di popolazioni inerme, di interi paesi e villaggi rei di ospitare popolazioni slave. La bandiera tricolore la impugnavano gli sgherri italiani agli ordini del generale Mario Roatta, il quale, posto a capo delle truppe italiane dal governo italiano emanò, l’ordine: «non “dente per dente”, ma “testa per dente”»: per ogni colpo sparato da un partigiano slavo contro un italiano, ammazzate lo slavo, anche se l’italiano appartiene all’esercito invasore che sta trucidando la sua famiglia, saccheggiando il suo patrimonio, bruciando le sua case e i suoi villaggi.
Dovrebbe sapere, e ricordare, che tra il 1941 e il 1943 nella provincia di Trieste furono bruciati per rappresaglia contro i partigiani sloveni e italiani i paesi di Mavhinje-Malchina, Čerovlje-Ceroglie, Vižovlje-Visogliano, Medjevaš-Medeazza, Mačkovlje-Caresana, Gročana-Grozzana. Dovrebbe sapere che in quegli anni decine di partigiani sloveni (la Slovenia era stata inghiottita dall’Italia fascista come provincia di Lubiana) furono impiccati o fucilati o avviati nelle camere a gas.
L’occupazione manu militari dei territori e dei popoli slavi era stata accompagnata da una massiccia e penetrante campagna propagandistica. Si vedano in proposito i materiali esposti nella mostra “Testa per dente”. La prima cosa che balza agli occhi, è una frase di Benito Mussolini pronunciata a Pola nel 1922: «Di fronte a una razza inferiore e barbara come quella slava non si deve seguire la politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone. I confini dell’Italia devono essere il Brennero, il Nevoso e le Dinariche: io credo che si possono sacrificare 500.000 slavi barbari per 50.000 italiani»
Un annuncio, quello di Mussolini, cui più tardi seguirono i fatti. L’Italia savoiarda e fascista si è impegnata, a partire dagli anni Venti del secolo scorso (quindi ben prima della Germania di Hitler) in una penetrante operazione di cancellazione di ogni elemento della cultura e dell’identità slovena, croata, montenegrina (in una parola, slava). A partire dalla toponomastica, dalla lingua insegnata e parlata negli asili e nelle scuole (50 scuole slovene erano state chiuse), dai nomi e cognomi degli impiegati pubblici e privati (un volume di 350 pagine conteneva l’elenco di 3mila cognomi da cambiare Un migliaio di circoli culturali, assistenziali, sportivi e ricreativi sloveni e croati furono chiusi, e i patrimoni assegnati a destinatari italiani.
Il primo episodio vistoso riguardò ovviamente la cultura: nel luglio 1920 fu bruciato dai fascisti il Centro sloveno di cultura di Trieste
Mistificazione continua.
I rapporti tra l'Italia e le popolazioni slave sono stati spesso occasioni di mistificazioni. Attribuire agli sloveni o ai croati delitti o stragi o altre forme di annullamento delle persone o delle cose fu prassi consolidata. Qualche volta fu clamorosamente smentita nel momento stesso in cui avveniva. La disavventura capitò una volta a Bruno Vespa.
Nel corso di un dibattito a più voci nella trasmissione "Porta a porta" Vespa mostrò un'immagine fotografica che rappresentava la fucilazione alla schiena di un gruppo di persone, presentandola come un'esecuzione, compiuta dai comunisti jugoslavi, di un gruppo di partigiani italiani. Uno storico presente all'incontro ebbe buon gioco nel dimostrare che si trattava, all'opposto, di civili sloveni fucilati da ben riconoscibili (in altre foto) militari italiani. Come spiegò più tardi il giornalista Michele Smargiassi sul sito "Fotocrazia, nel quale si riportano anche i nomi delle vittime, tutte slovene.
Per concludere, tutto quello che abbiamo sommariamente ricordato lo abbiano tratto dalla lettura del libro di Claudia Cernigai, dell'archivio di
eddyburg o dal sito web
10 febbraio. Consigliamo caldamente la lettura di quest'ultimo per chi non vuol essere accusato come (per adoperare le parole di Sergio Mattarella), di «nazionalismo estremo, dell'odio etnico, della violenza ideologica eretta a sistema», vizi dai quali lui stesso non ci sembra essere del tutto esente.
piccolo campionario delle nefandezze dell'Italia in Slovenia e Croazia
la Stampa
«Dai social solidarietà al naziskin accusato di strage»
Lo hanno applaudito al passaggio per i corridoi del carcere, Luca Traini. I detenuti italiani, ovviamente, non tutti. E lui s’è impettito. Orgoglioso di quello che ha fatto. Altro che «gesto folle di un fascista che ha infangato il tricolore», come sosteneva ieri il ministro Andrea Orlando, in visita ai feriti di Macerata. No, Traini per tanti è ormai un eroe.
Sembra davvero aver scoperchiato i sentimenti più segreti di una parte d’Italia, questo naziskin dall’aria truce. In tanti solidarizzano. Non soltanto sui social, ma anche nelle strade. E il suo avvocato Giancarlo Giulianielli è il primo a esserne sbalordito. Due giorni fa l’ha chiamato un normale cittadino da una cittadina della civile Toscana, e ha chiesto come fare a collaborare alle spese della sua difesa. Anche diversi gruppi dell’estrema destra dichiarano di essere pronti a pagarne le spese legali. Giulianielli, correttamente, ha informato il suo assistito di queste iniziative. Gli ha chiesto: che vuoi fare? E Traini, che si è detto onorato di riscuotere tanto consenso, ha risposto: «Che diano tutto alle famiglie bisognose. Ma che siano famiglie italiane».
Si sentono i suoi dieci anni di militanza nei gruppi più estremi, quelli che già da tempo fanno raccolte di cibo a favore dei poveri, alla maniera dei neonazisti greci di Alba Dorata. Al sostituto procuratore Stefania Ciccioli, Traini ha raccontato la sua vita di adolescente emarginato e triste, con una difficile storia familiare, che a 17 anni trovò finalmente un gruppo dove sentirsi spalleggiato. La sua prima manifestazione, un raduno di Forza Nuova ad Ascoli. Ma poi di queste iniziative ce ne sono state tante. L’innamoramento per la Lega e per Matteo Salvini è storia recente.
Brutti sporchi e cattivi, in genere i naziskin si vantano di essere diversi dalla brava gente borghese. Traini non fa eccezione. Sulle nocche delle mani si era fatto tatuare la parola inglese «Outcast». Significa: emarginato. Così come farsi tatuare sulla tempia la runa celtica: a un certo punto ha intrapreso un percorso di non ritorno. E se ora in tanti a Macerata s’interrogano su come sia stato possibile, Luca Traini evidentemente aveva varcato la sua linea d’ombra. Non per caso, se fino a un anno fa in palestra lo chiamavano «Big John» e lui ci stava a questo ruolo abbastanza inoffensivo, e con gli amici il massimo dell’esagerazione era mangiare 10 hamburger al fast food, ora aveva preso a farsi chiamare «Lupo». Un percorso verso il precipizio che in palestra era stato ben percepito. La storia era davvero diventata un’altra. E ora? «Siccome si sente orgogliosamente un emarginato tra gli emarginati - racconta il suo legale - dice che il carcere non gli sta stretto. Anzi, lo sente come se fosse casa sua». Un successo.

l'Avvenire,
Ma in ospedale, a visitare e portare solidarietà ai feriti di Macerata, a tre giorni dagli spari del filonazista Luca Traini non c’è andato nessuno. Nessun rappresentante del governo, solo un paio di deputati. Unici, e gliene va riconosciuto il merito, l’esponente di Leu Beatrice Brignone e (non ricandidato) il cattolico e demo-solidale Mario Marazziti. Come mai, viene da domandarsi? È usanza normale da parte delle autorità andare a stringere la mano ai feriti innocenti, dopo un episodio di violenza. Stavolta no.
Forse perché di questi tempi farsi riprendere mentre si stringe la mano a un migrante, a un nero di pelle, sia pure in ospedale, non giova. In questi tempi di elezioni, in un’Italia esacerbata da propagande odiose. Si sa, poi su media e social la foto gira, la vedono in milioni. E al 4 marzo, manca meno di un mese.
Segni inquietanti da Macerata. La solidarietà allo sparatore espressa da alcuni cittadini all’avvocato di Traini, che ne è rimasto stupefatto. Solidarietà, a dire il vero, con una sola remora: «Ecchè, se va a spara’ così? Poteva piglia’ qualcuno», è il commento di un salumiere del centro della città, riferito dalle cronache del "Corriere". «Poteva piglia’ qualcuno, qualcuno di noi; per fortuna ha colpito solo quei là».
Quei là, ecco. Di cui quasi nessuno di noi sa il nome, perché i media per lo più non ci si sono molto soffermati. Quei sei ragazzi: Wilson Koff, 20 anni, ghanese; Omar Fadera, 23 anni, dal Gambia; Jennifer Otiotio, 25 anni, Gideon Azeke, 25 anni, e Festus Omagbon, 32 anni, tutti nigeriani; Mahamadou Toure, 28 anni, dal Mali.
All’età in cui i nostri figli sono ancora in casa, hanno già traversato il deserto, i campi profughi, il Mediterraneo. Alcuni di loro hanno regolari documenti. Altri no, come uno dei nigeriani, che appena medicate le ferite al pronto soccorso se la è filata alla svelta, temendo altri guai. Perché anche tra le lenzuola candide e le attenzioni dei medici non si sentiva al sicuro. Lo sanno, le giovani ombre che lavorano in nero e dormono negli scantinati, che non sono "come noi". Che ci sono gli uomini, e poi ci sono loro, gli invisibili. «Non si spara così, poteva colpire qualcuno...». Invece quel neonazista ha colpito soltanto dei migranti, cioè nessuno.
Hannah Arendt nei tempi della persecuzione antiebraica parlava di "non uomini"; di masse di persone cui venivano tolti i diritti civili, il passaporto, le proprietà, e che venivano respinti da Paesi fino a allora democratici. Finché, ovunque cacciati, diventavano appunto, nei lager, «non uomini». Displaced people, sfollati, senza terra: ieri su "Avvenire" la filosofa Laura Boella osservava come oggi si usi la stessa espressione per profughi e migranti.
C’è da riflettere, su questo processo di "anonimizzazione" che coinvolge anche italiani per niente razzisti. È quello sguardo che non si posa nemmeno un istante, per strada o in metrò, sul nero che ci affianca; quasi avendolo meccanicamente già infilato in una categoria, "vù’ cumprà", "clandestino". Insomma, altri da noi. Tacitamente, senza pensarlo apertamente,«non uomini».
Non possiamo certo accogliere, e nemmeno dare l’elemosina, a tutti i poveri che incrociamo.
Emagari non siamo noi che possiamo dar loro un lavoro non in nero. Guardarli in faccia, quello sì però possiamo, fare un cenno di saluto, chiedere magari a quello che è sempre al solito angolo come si chiama, e da dove viene. È poco, è quasi niente: ma è almeno un cominciare a riconoscere, nella massa indistinta che spaventa tanti, dei volti, degli esseri umani. Come noi.
Intanto, da Macerata arriva la notizia che il gip dubita dell’accusa di omicidio per il nigeriano arrestato per la morte di Pamela Mastropietro, tanto che non ha convalidato il fermo per questo reato, ma "solo" per vilipendio e occultamento di cadavere. Si sospetta che la povera ragazza potrebbe essere morta di overdose (e per una dose comprata coi soldi ottenuti vendendo il proprio corpo a un italianissimo "cliente").
Anche se poi Innocent Oseghale, forse con un complice, ne avrebbe fatto a pezzi e occultato il corpo. Oseghale potrebbe non essere un assassino, come ha invece rapidamente giudicato il vendicatore nero di gesti e di parole, con trascorsi in Casa Pound e Lega. Che ha preso un tricolore e una pistola, e dall’auto ha cominciato a sparare. Mirando solo ai neri di pelle, solo a quei là, nel mucchio. Un mucchio in cui indistinguibili erano i nomi, le facce, le storie.
A terra, sanguinanti, solo «non uomini». Che non è bene andare a trovare in ospedale. Poi ti fotografano mentre gli stringi la mano. E non conviene, meglio di no – al 4 marzo, manca meno di un mese.

Huffpost 3 febbraio 2018. Dalla violenza delle parole degli energumeni a quella stragista dei fatti criminali il passo non è tanto lungo. Ma porta all'abisso. A Macerata è avvenuto.
Era solo questione di tempo e il tempo è arrivato. Un crimine all'americana, dell'America di oggi, un raid razzista fatto sparando in giro per le strade della città, una tentata strage nutrita di odio razziale e di rabbia, una generica vendetta diretta non a questo o a quel colpevole ma a una razza, a un colore, a tutto ciò che non siamo noi. Stavolta però non d'America si è trattato ma della provincia italiana, la provincia tranquilla, una volta luogo di certezze e solidità contrapposte alle nevrosi e violenze della città. Provincia oggi raggiunta e travolta, anch'essa, dall'onda lunga dell'ansia italiana. Inatteso ed estremo risveglio del Paese tutto davanti a quelle molteplici firme identitarie: saluto fascista, bandiera tricolore sulle spalle, e quel "Viva l'Italia". L'Italia, sì, è stata chiamata in causa tutta – e davvero siamo arrivati a questo, siamo diventati questo?
A Macerata un limite è stato attraversato, una barriera è stata rotta. Dagli slogan violenti è stata generata vera violenza. Una affermazione banale, eppure sempre negata, dalla leggerezza e dalla irresponsabilità di un dibattito politico che detesta e disprezza come buonismo gli inviti al rispetto, che boccia come evirato ogni tentativo di ragionare invece che inveire, una cultura tornata in voga perché usa le parole come sostituto delle pallottole – per ferire l'anima, per sminuire la dignità altrui, e per soddisfare ego sminuiti gonfiandoli di finta superiorità.
E se pensate che sto pensando a Salvini e alla estrema destra, ebbene sì: è proprio a loro che sto pensando. Penso a tutte le colonne di stampa che grondano parolacce, volgarità, battute e tanti, tanti incitamenti a reagire, colpire. Fino a divenire l'inno – e abbiamo visto anche questo – alla reazione individuale contro il mondo, armi in mano e resistenza al "nemico" nel cuore. Diritto alla difesa, viene chiamato, anche se dovrebbe più spesso definirsi diritto all'offesa.
Macerata è oggi al centro di una orribile storia: una ragazza diciottenne, scappata da una comunità di recupero dalla droga, uccisa e fatta a pezzi in due valigie da un nigeriano spacciatore di droga. La polizia pare sicura della colpevolezza. La storia dolorosa, la morte efferata che è stata inflitta a Pamela Mastropietro merita ogni indagine, ogni severità, ogni condanna.
Una storia così crudele invoca anche ogni domanda di sicurezza e deve indicare anche la responsabilità dello Stato nel non saper gestire, o anche solo capire, le conseguenze di una politica dell'immigrazione mai davvero pensata e organizzata. La politica tutta ha l'obbligo di pensare alla sicurezza del paese. E certamente è colpevole di inadeguatezza. Ma la risposta a tutto questo, ai tanti errori non possono portare certo all'odio, allo scontro, alla giustizia individuale, alla strage pianificata.
E quando vi si arriva, siamo molto vicini, come si diceva, a entrare in un territorio tutto nuovo, da cui sarà molto difficile tornare.
Peccato che Salvini, così ambizioso, così dinamico, così voglioso di fare qualcosa per il Paese non abbia colto che anche per lui, soprattutto per lui, oggi era arrivato il momento di non attraversare il limite, di porre un argine alla follia attraverso una netta presa di distanza. Di dire parole di cautela e avviare un dialogo e una riflessione con il suo popolo. Non l'ha fatto. E non è stato un errore, il suo. È evidentemente una convinzione: perché questa è l'Italia che Salvini vuole, evidentemente.
Per la politica italiana questo è stato un giorno in cui la verità sui rischi che corre il Paese ha fatto irruzione nei riti sempre finti della campagna elettorale. Le conseguenze di questo scossone si possono avvertire fin da ora: l'episodio crea scompiglio nella coalizione della destra, obbliga la sinistra a ripensare un po' alle proprie divisioni interne, e mette sotto pressione il Movimento 5 Stelle che come sempre preferisce rimanere nel vago, come già è successo, quando avvengono storie scomode. Sempre che la verità la si voglia ascoltare.

il manifesto, 4 febbraio 2018.
Di colpo, il buio. A Macerata, ieri, siamo caduti in uno dei punti più oscuri della nostra storia recente. Di quelli in cui sembrano materializzarsi i peggiori incubi, da «scene di caccia in Bassa Baviera». Il folle tiro al bersaglio su base etnica, i corpi che cadono uno dopo l’altro, la corsa dell’auto alla ricerca di nuove vittime di colore, la città paralizzata, rinchiusa in casa, tutto questo ci dice che un nuovo gradino dell’orrore è stato sceso.
Non è il primo caso di violenza sanguinosa di tipo razzista: il 13 dicembre del 2011, in Piazza Dalmazia a Firenze, due giovani senegalesi, Samb Modou e Diop Mor, caddero sotto i colpi della 357 Magnum di Gianluca Casseri, un fascista di Casa Pound che poco dopo, braccato dalla polizia, si suicidò. Ed è di appena un anno e mezzo fa l’omicidio di Emmanuel Chidi Namdi, nigeriano, massacrato a botte da un energumeno di estrema destra mentre cercava di difendere la fidanzata a Fermo, non molto lontano da Macerata.
Ma questo di Macerata sta ancora un passo oltre. Per la modalità e il movente del fatto: l’intento di vendicare l’atroce morte di Pamela Mastripietro, secondo le cadenze tipiche del linciaggio nell’America dell’apartheid, colpendo indiscriminatamente i presunti compatrioti del presunto assassinio (e dimenticando, fra l’altro, che la rapidissima cattura di questo si deve alla preziosa testimonianza non di un italiano ma di un africano).
Per le caratteristiche del protagonista, ancora un fascista, candidato senza fortuna nella Lega, ma prima già vicino a Forza nuova e Casa Pound come Casseri, che però a differenza di quello non si è suicidato ma ha inscenato una teatrale rappresentazione, salendo sulla base del monumento ai caduti avvolto nel tricolore, quasi a lanciare un proclama alla nazione. Prontamente accolto, d’altra parte, da un impressionante seguito sui social, ed è questo il terzo fattore che colloca Macerata «oltre»: energumeni della tastiera che invocano «Luca Traini Santo Subito», invitano a fare altrettanto e proclamano che «questo non è che l’inizio» scaricando su «chi apre le porte all’invasione» degli africani la colpa sia dell’uccisione di Pamela che della reazione del «giustiziere» di Corridonia. Un argomento quest’ultimo, sostanzialmente in linea con le prime esternazioni di Matteo Salvini, che nel segno di una feroce campagna d’odio sta conducendo il proprio giro elettorale.
Non possiamo più ignorarlo. Macerata non è un fatto isolato. Né semplicemente opera di un disadattato. Macerata si inserisce in un quadro spaventosamente degradato. Ci parla di un vero sfondamento antropologico del nostro Paese. Viene dopo le oscene esternazioni della sindaca di Gazzada sul giorno della memoria nella terra del leghismo. Dopo la pubblicazione in rete di un aberrante fotomontaggio in cui la testa mozzata della Presidente della Camera Boldrini appare sotto la scritta «Sgozzata da un nigeriano inferocito, questa è la fine che deve fare così per apprezzare le usanze dei suoi amici», e dopo il rogo del manichino che la rappresentava, da parte dei «giovani padani» di Busto Arsizio. Dopo un lungo rosario di dichiarazioni, atti, ordinanze di sindaci leghisti, sfregi da parte di squadristi fascisti di cui si va perdendo il conto.
Macerata ci dice che l’azione dei tanti «imprenditori dell’odio» in felpa o in camicia bianca, sta tracimando oltre il terreno delle propaganda, e generando vere e proprio azioni terroristiche. Perché quello che si è visto a Macerata è in senso proprio un episodio di terrorismo, non diverso da quelli organizzati dall’Isis o dai suoi cani sciolti a Barcellona, Londra o Bruxelles, con le persone inermi fatte bersaglio e le città chiuse nel terrore. Come tale va trattato l’attentatore di Macerata. E come tale il mondo democratico dovrebbe trattare l’evento, organizzando subito una risposta di massa, lì dove il fatto è avvenuto, mobilitando chi ancora crede che quella deriva possa essere arrestata. E che la notte della memoria non è del tutto caduta su di noi. Se non ora, quando?

il manifesto, 27 settembre 2018. non si può proprio dire che l'Italia fascista (e nemmeno quella prefascista) abbiano dovuto attendere Hitler e il nazismo per dimostrare queste virtù Le avventure in Abissinia, Somalia e Libia lo testimoniano, oltre le leggi antisemite del 1938.
Quest’anno il Giorno della Memoria coincide con la ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi contro gli ebrei dell’Italia fascista. Promulgazione ad opera di quel sovrano Vittorio Emanuele III al quale, se non altro per questa ragione, devono essere precluse le porte del Pantheon.
Come giustamente ricorda una importante pubblicazione edita l’anno scorso in Germania per gli ottanta anni dalle leggi di Norimberga, fu una iniziativa tutta italiana senza che vi fosse alcuna pressione da parte del Reich nazista, come si ostina a ripetere qualche tardo estimatore di Benito Mussolini.
Tutto quello che si può dire in proposito è che nell’Europa invasa dall’antisemitismo, l’Italia fascista non volle essere seconda a nessuno, ossessionata come era, fra l’altro, dallo spettro della contaminazione razziale. Frutto avvelenato dell’appena conquistato impero coloniale e della forzata coabitazione con i nuovi sudditi africani.
Come tutti i neofiti, anche il razzismo fascista ebbe il suo volto truce. La «Difesa della razza», l’organo ufficiale del regime che ebbe come segretario di redazione Giorgio Almirante, ne forniva la prova in ogni numero contraffacendo le fattezze fisiche degli ebrei o rendendo orripilanti quelle delle popolazioni nere.
Il tentativo di fare accreditare l’esistenza di una razza italiana pura nei secoli aveva il contrappasso di dare una immagine inguardabile delle popolazioni considerate razzialmente impure. L’arroganza della propaganda non impedì che essa facesse breccia in una parte almeno della società italiana e ancora oggi non è detto che essa si sia liberata dall’infezione inoculata dal fascismo, come stanno a dimostrare piccoli, ma numerosi episodi che si manifestano, e non solo negli stadi.
Non bisogna fra l’altro dimenticare che non solo tra il 1938 e l’8 settembre del 1943 l’odio razziale ebbe libero corso, ma che dopo l’armistizio e l’occupazione tedesca la caccia agli ebrei divenne uno dei principali motivi dell’esistenza della Repubblica Sociale neofascista.
In nome della purezza della razza il regime costrinse a fuggire o mise in campo di concentramento ebrei che in altre parti d’Europa si erano illusi di trovare un rifugio non precario entro i confini italiani; ma costrinse all’emigrazione scienziati e intellettuali italiani, privando il Paese di una componente culturale che, nella più parte dei casi, non avrebbe fatto ritorno in Italia neppure dopo la liberazione anche a causa degli ostacoli non solo burocratici alla reintegrazione di quanti erano stati costretti a espatriare e che per tornare a esercitare il proprio ruolo in patria non avrebbero potuto contare su nessun automatismo.
Le leggi contro gli ebrei costituirono un’ulteriore penetrazione del regime nel privato dei cittadini: il divieto dei matrimoni con cittadini ebrei; l’espulsione degli ebrei come studenti ed insegnanti dalle scuole e dalle università; l’espulsione degli ebrei dalla pubblica amministrazione.
Di fatto, ma anche di diritto, si venne a creare una doppia cittadinanza con cittadini di serie A e cittadini di serie B, preludio dell’ostracismo generalizzato sancito dalla Repubblica Sociale che proclamò semplicemente gli ebrei cittadini di stati nemici, quasi a dare la motivazione non solo ideologica per la parteicpazione italiana alla Shoah.
Ancora oggi è difficile dare una valutazione sicura delle reazioni della popolazione italiana alle leggi razziali. Le azioni di salvataggio compiute dopo l’8 settembre non devono ingannare a proposito dei comportamenti che si manifestarono prima dell’armistizio.
Gli stessi ebrei non si resero esattamente conto della portata delle leggi razziali. Il fanatismo della stampa, in particolare nella congiuntura bellica in cui gli ebrei vennero imputati di tutti i disastri del Paese, andava probabilmente oltre il tenore dello spirito pubblico che oscillava tra indifferenza e cauto plauso, aldilà del solito stuolo dei profittatori.
Le autorità periferiche non ebbero affatto i comportamenti blandi che qualche interprete vuole tuttora addebitare loro. Il conformismo imperante coinvolse la più parte della popolazione. Il comportamento timido, più che cauto, della Chiesa cattolica non incoraggiò in alcun modo atteggiamenti critici che rompessero la sostanziale omogeneità dell’assuefazione al regime.
A ottanta anni di distanza la riflessione su questi trascorsi è ancora aperta e si intreccia con alcuni dei nodi essenziali della storiografia sul fascismo (per esempio la questione del consenso).
È una storia che deve indurci ad approfondire un esame di coscienza collettivo alle radici della nostra democrazia e a dare una risposta a fatti che sembrano insegnarci come la lezione della storia non sia servita a nulla se è potuto accadere che il presidente del tribunale fascista della razza diventasse anche presidente della Corte Costituzionale della Repubblica.

Sono stati dichiarati tutti ammissibili i ricorsi presentati dai cittadini sudanesi contro il Governo italiano per il respingimento collettivo che, il 24 agosto 2016, ha dato esecuzione all'accordo tra il Capo della Polizia italiana ed il suo omologo sudanese. Ne danno notizia in una nota l'Arci e l'Asgi, l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione. La Corte europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali (Cedu) ha comunicato formalmente i ricorsi al Governo italiano e ha posto precisi quesiti volti a conoscere le modalità dell'espulsione e se siano stati rispettati i diritti e le garanzie previste dalla Convenzione europea.
I ricorsi, ricorda la nota, sono stati tutti depositati da avvocati dell'Asgi: i cittadini sudanesi furono oggetto di una vera e propria "retata" a Ventimiglia, alcuni furono trasportati in condizioni disumane e poi rinchiusi illegittimamente nell'hotspot di Taranto. Quindi vi fu il tentativo di rimpatriarli tutti. Alcuni furono effettivamente riportati in Sudan e 5 di loro incontrarono rappresentanti di Asgi ed Arci che, tra il 19 e il 22 dicembre 2016, si recarono a Khartoum grazie al supporto di una delegazione di parlamentari europei del gruppo della Sinistra europea. Tutti coloro che non furono rimpatriati hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale in Italia, in quanto soggetti a persecuzioni e discriminazioni nel Paese da cui provenivano. I ricorsi hanno denunciato la violazione di diverse norme della Convenzione Edu e della Convenzione di Ginevra. Il Governo italiano, entro il 30 marzo 2018, dovrà fornire una risposta al proprio operato dinanzi alla Cedu.
Articolo tratto da "Avvenire!, qui raggiungibile in originale
 «
«
Iniziato a Milano il processo civile contro l’azienda italiana da parte di una comunità del Delta del Niger che nel 2010 ha visto il suo territorio inondato di petrolio dopo un’esplosione di un oleodotto. L’Eni avrebbe violato la sua d
ue diligence».
I fatti risalgono al 5 aprile 2010 quando un oleodotto gestito dalla Nigerian Agip Oil Company (Naoc), sussidiaria nigeriana di Eni, è esploso inondando una superficie di 17,6 ettari nei pressi del villaggio di ikebiri. «Il guasto tecnico che ha provocato la fuoriuscita del petrolio, ammesso dalla stessa Naoc, risale al 5 aprile, ma l’ammissione del guasto e l’intervento dei tecnici non è arrivato prima dell’11 aprile, quasi una settimana dopo», racconta Godwin Ojo, ambientalista nigeriano direttore dell’associazione Friends of the Earth Nigeria che sta sostenendo la comunità del Delta in questa battaglia. «Terreni agricoli, stagni e fiumi dove la popolazione pesca, sono stati contaminati e l’intera comunità (circa 5 mila persone) è stata privata dei propri mezzi di sostentamento. Per questo chiediamo all’Eni di prendersi le sue responsabilità, di pagare una giusta compensazione e di bonificare il terreno perché questo non è stato fatto».
Da parte sua Eni ha sempre sostenuto che la sua sussidiaria ha già effettuato la bonifica dei terreni, mentre una compensazione di 20 mila dollari è stata rifiutata dalla stessa comunità che chiede invece 2 milioni di euro. «Speriamo di ottenere giustizia più velocemente e che questo possa portare al ripristino dei nostri mezzi di sostentamento. Insieme possiamo vincere», prosegue l’ambientalista nigeriano per cui questo è solo uno dei tanti casi di inquinamento provocato dalle compagni petrolifere che agiscono nel Delta del Niger, una delle zone più ricche di petrolio dell’intera Africa. «Il problema non è solo di Agip – continua Godwin Ojo –, ma di tutte le compagnie impegnate nel Delta: Shell, Mobil, Chevron ed Elf. Dal 1956, anno in cui è stata avviata la produzione petrolifera, sono avvenuti più di 10 mila sversamenti e molto spesso le compagnie, invece di bonificare le zone, preferiscono dare fuoco al petrolio per eliminare le prove». «E anche quando si ricorre ai tribunali locali – prosegue – è difficile avere giustizia, perché le compagnie sono troppo potenti, la pressione dei governi europei, assetati di risorse, è forte, e le rendite dal petrolio sono una voce chiave nel bilancio del governo. Per questo ci siamo rivolti all’Italia sperando di avere giustizia».
Il precedente
Petrolio e gas rappresentano la principale voce dell’export nigeriano, pari al 90% del valore delle esportazioni e al 30% del Prodotto interno lordo del paese. Un sistema segnato anche da una profonda corruzione politica e dal malaffare come dimostra il caso della
maxitangente Eni-Shell per cui la società di San Donato Milanese è stata recentemente rinviata a giudizio sempre al tribunale di Milano.
Nel caso si dovesse arrivare a sentenza sarebbe la prima volta che in Italia una compagnia viene chiamata a rispondere per i danni ambientali provocati da una propria sussidiaria in un altro paese. Anche se non è da escludere che vi possa essere un accordo extragiudiziale tra la compagnia e la comunità così da evitare il pronunciamento del giudice. Un precedente importante in questo senso risale al 2015 quando la comunità Bodo, che si era appellata alla corte di Londra, ha ottenuto dalla Royal Dutch Shell un risarcimento di 83,5 milioni di dollari per i danni provocati da un analogo incidente (anche se di portata molto più grande).
«In questo caso – conclude l’avvocato Saltalamacchia – la pressione dei media era stata fondamentale perché la stampa si era quasi interamente schierata al fianco della comunità e Shell aveva deciso di pagare pur di distogliere l’attenzione dal caso. Purtroppo in Italia la situazione è molto diversa e il sistema mediatico tende a tutelare queste grandi compagnie, ma speriamo che qualcosa possa cambiare».
Anche per questo Amnesty International Italia, Mani Tese e Survival International hanno deciso di promuovere una campagna per mantenere alta l’attenzione sul caso e sulle devastazioni ambientali in corso nel Delta del Niger.

Cronache di ordinario razzismo
La “tutela del decoro” viene prima della garanzia dei diritti delle persone. Anche a Natale. Sembra pensarla così il sindaco di Como Mario Landriscina (sostenuto da una coalizione di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia), che il 15 dicembre ha firmato un’ordinanza per “la tutela della vivibilità e il decoro del centro urbano”.
Si legge nell’ordinanza (
il cui testo è disponibile qui
):
«Con decorrenza immediata e fino al superamento delle situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana in premessa richiamate, con termine ultimo di 45 giorni dalla data odierna, all’interno della città murata (zona a traffico limitato) e nelle immediate vicinanze, in particolare nelle aree di mercato attigue alle mura e in viale Varese, è fatto divieto di:
- Mendicare in forma dinamica ponendo in essere forme di accattonaggio molesto ed invasivo, tali da coartare l’autodeterminazione delle persone a compiere atti di liberalità;
- Mendicare in forma statica occupando spazi pubblici anche con l’utilizzo di cartoni, cartelli ed accessori vari che arrecano disagio al passaggio dei pedoni;
E’ altresì fatto divieto di bivaccare sotto i portici dell’ex chiesa di San Francesco in largo Spallino, presso la basilica del “Crocefisso” in viale Varese, nonché in piazza San Fedele e in via Boldoni e più ampiamente sotto tutti i portici della città murata».
Il linguaggio utilizzato nell’ordinanza meriterebbe da solo un commento, ma diamo priorità ai fatti. Perchè gli effetti di tale misura si sono visti immediatamente: domenica 17 dicembre, un gruppo di persone senza fissa dimora non ha potuto ricevere la colazione. E’ la prima volta che accade, dopo “più di sette anni”, come sottolineano i volontari che ogni mattina si recano presso l’ex chiesa di San Francesco a Como a distribuire la colazione “ma soprattutto un’occasione di relazione” alle persone – più di 150 – che dormono li fuori, perchè senza casa. “Questa mattina ci è stato proibito di farlo perché i nostri semplici gesti sarebbero contrari alla nuova ordinanza. Ci è stato detto che fino al 10 gennaio non ci è possibile portare un piccolo simbolo d’amore a queste persone, perché in vista del Natale non è decoroso”.
Certo, sentire associare al periodo natalizio la parola decoro, piuttosto che solidarietà, risulta piuttosto paradossale. Ma questo è quello che è andato in scena nel capoluogo lombardo, suscitando la rabbia dei volontari. “Una rabbia scatenata dall’ipocrisia di chi sputa sui valori più importanti. Così si aggiunge solo odio in animi già troppo feriti dalla vita. Con che scopo?”, scrivono i membri del gruppo, chiedendo “in quale specchio si guardino e cosa vedano le persone che continuano ad insultare così i poveri, non comprendendo che il problema non sono i poveri ma la povertà”. Una povertà che con misure del genere “si amplifica. Se provassimo a guardare in faccia la povertà con il desiderio di sconfiggere lei, e non i poveri, allora forse si potrebbero trovare soluzioni e pensieri che possano essere dalla parte dell’essere umano. Questo ci sembra allora il Natale: la ricerca di una possibilità, di un’umanità più dignitosa. Dignità non decoro ci aspettiamo dal nostro sindaco soprattutto a Natale, altrimenti non chiamiamolo Natale!”.
All’appello lanciato dai volontari si è unito il direttore della Caritas diocesana Roberto Bernasconi, con un duro monito: “La nostra città ha trasformato il Natale in un fatto meramente commerciale. Ha ridotto il capoluogo ad una città dei balocchi, dimenticandosi che dentro di essa esistono drammi enormi. E non mi riferisco soltanto ai profughi, che esprimono solo una parte delle povertà della nostra comunità, ma anche alle famiglie che non riescono ad arrivare ai fine mese; ai nostri anziani, sempre più soli ed emarginati nelle loro case; ai tanti giovani, insicuri e fragili nel progettare la loro vita; ad un carcere che abbiamo quasi dimenticato, che “ospita” più di cinquecento persone che lì sopravvivono, ogni giorno. Ed ecco che dentro questo quadro, ciliegina sulla torta, è arrivata un’ordinanza che, a mio avviso, mette fuori legge anche il Gesù Cristo che deve arrivare, perché è arrivato proprio in queste condizioni”, ha affermato Bernasconi, ricordando che “il Natale si fonda sull’accoglienza di Cristo, che nasce in una condizione di profugo, di emarginato”. Rivolgendosi al sindaco, il direttore della Caritas ha chiesto “un passo indietro”.
Anche Como Senza Frontiere ha chiesto al sindaco la revoca dell’ordinanza, organizzando per sabato 23 dicembre alle 10 una “bivacco solidale” proprio davanti all’ex chiesa San Francesco.
Le polemiche contro l’ordinanza travalicano i confini regionali: “L’ordinanza emanata dal sindaco di Como è deplorevole – dichiarano i membri di Cild -Coalizione Italiana Libertà e Diritti – ma consentita dalla legge. Una legge, il decreto Minniti Orlando, che è stata approvata lo scorso aprile e che abbiamo molto contestato. Una legge che prevede, tra le altre cose, proprio la possibilità di emanare ordinanze sindacali contro ‘grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana’. Questo a patto che non si ledano diritti costituzionali, quale è il diritto alla solidarietà. Nell’ordinanza non c’è alcun divieto di portare latte caldo e altri beni ai senza fissa dimora, niente che possa fermare chi intenda farlo”. Proprio per questo, la Cild “offre assistenza gratuita ai volontari ai quali sarà impedito di prestare solidarietà in forza di un’ordinanza che nulla dice al riguardo”.
Dal canto suo, il sindaco non sembra avere alcuna intenzione di tornare indietro: “Non ritirerò l’ordinanza. Sono un uomo libero, anche di sbagliare. Se la città me lo chiede, mi dimetto”.
Articolo tratto da "cronache di ordinario razzismo" qui reperibile in originale

RAI news,
In un rapporto pubblicato oggi, all’indomani dello scandalo suscitato dalle immagini relative alla compravendita dei migranti in Libia, Amnesty International ha accusato i governi europei di essere consapevolmente complici nelle torture e nelle violenze ai danni di decine di migliaia di rifugiati e migranti, detenuti in condizioni agghiaccianti nel paese nordafricano. Il rapporto, intitolato Libia: un oscuro intreccio di collusione, descrive come i governi europei, per impedire le partenze dal paese, stiano attivamente sostenendo un sofisticato sistema di violenza e sfruttamento dei rifugiati e dei migranti da parte della Guardia costiera libica, delle autorità addette ai detenuti e dei trafficanti. "Centinaia di migliaia di rifugiati e migranti intrappolati in Libia sono in balia delle autorità locali, delle milizie, dei gruppi armati e dei trafficanti spesso in combutta per ottenere vantaggi economici. Decine di migliaia di persone sono imprigionate a tempo indeterminato in centri di detenzione sovraffollati e sottoposte a violenze ed abusi sistematici", ha dichiarato John Dalhuisen, direttore di Amnesty International per l`Europa.
I governi europei non solo sono pienamente a conoscenza di questi abusi, ma sostengono attivamente le autorità libiche nell`impedire le partenze e trattenere le persone in Libia. Dunque, sono complici di tali crimini", ha aggiunto Dalhuisen. Dalla fine del 2016 gli stati membri dell’Unione europea e soprattutto l’Italia hanno attuato una serie di misure destinate a sigillare la rotta migratoria attraverso la Libia e da qui nel Mediterraneo centrale, con scarsa attenzione alle conseguenze per le persone intrappolate all’interno dei confini della Libia, dove regna l’anarchia. -
a cooperazione coi vari attori libici si è sviluppata lungo tre assi:
- la fornitura di supporto e assistenza tecnica al Dipartimento per il contrasto all’immigrazione illegale (Dcim), l`autorità libica che gestisce i centri di detenzione al cui interno rifugiati e migranti sono trattenuti arbitrariamente e a tempo indeterminato e regolarmente sottoposti a gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura;
- la fornitura di addestramento, equipaggiamento (navi incluse) e altre forme di assistenza alla Guardia costiera libica per metterla in grado di intercettare le persone in mare;
- la stipula di accordi con autorità locali, leader tribali e gruppi armati per incoraggiarli a fermare il traffico di esseri umani e a incrementare i controlli alla frontiera meridionale della Libia.
La presenza, nella legislazione libica, del reato d’ingresso irregolare, unita all’assenza di norme o centri per la protezione dei richiedenti asilo e delle vittime del traffico di esseri umani, fa sì che la detenzione di massa, arbitraria e a tempo indeterminato sia il principale mezzo di controllo dell`immigrazione in Libia.
Rifugiati e migranti intervistati da Amnesty International hanno riferito dei trattamenti subiti o di cui sono stati testimoni: detenzione arbitraria, tortura, lavori forzati, estorsione, uccisioni illegali che chiamano in causa autorità, trafficanti, gruppi armati e milizie. Decine di rifugiati e migranti hanno descritto il devastante ciclo di sfruttamento in cui colludono le guardie carcerarie, i trafficanti e la Guardia costiera. Le guardie torturano per estorcere danaro e, quando lo ricevono, lasciano andare le vittime o le passano ai trafficanti. Costoro organizzano la partenza, col consenso della Guardia costiera libica.
Se non è dato sapere quanti funzionari della Guardia costiera libica collaborino coi trafficanti, è evidente che nel corso del 2016 e del 2017 questo organismo ha incrementato la sua operatività grazie al sostegno ricevuto dagli stati dell’Unione europea. Di conseguenza, è aumentato il numero delle operazioni in cui rifugiati e migranti sono stati intercettati in mare e riportati sulla terraferma libica. -
Questo articolo è stato pubblicato sul sito di RAI news, in questa pagina dalla quale lo abbiamo ripreso
See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/rapporto-amnesty-migranti-torture-abusi-libia-65807273-1c38-40c9-94f1-054d39ef5792.html
See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/rapporto-amnesty-migranti-torture-abusi-libia-65807273-1c38-40c9-94f1-054d39ef5792.html

il manifesto,Ma nessuno scende in piazza in questo paese?
VERGOGNA ITALIA,
L’ACCORDO SUI MIGRANTI CON LA LIBIA
«È DISUMANO»
di Adriana Pollice
«L
'Onu accusa l'Europa. L’Alto commissario delle Nazioni Unite attacca la politica Ue e il piano Minniti: La sofferenza nei campi di detenzione è un oltraggio alla coscienza»
La collaborazione tra Ue e Libia per fermare il flusso di migranti è «disumana». Così l’ha bollata ieri in una nota l’Alto commissario Onu per i diritti umani, il principe giordano Zeid Raad al-Hussein, che ha poi aggiunto: «La politica dell’Unione europea di sostegno alla Guardia costiera libica perché intercetti i migranti e li consegni alle terrificanti prigioni in Libia è un oltraggio alla coscienza dell’umanità. Il sistema di detenzione per migranti è irrecuperabile: una situazione già disperata è diventata catastrofica». L’accusa si fa più esplicita quando Zeid Raad al-Hussein spiega: «La comunità internazionale non può pretendere di risolvere migliorando le condizioni di reclusione. I prigionieri non hanno alcuna possibilità di contestare la legalità della loro detenzione e non hanno accesso a un aiuto legale». L’Alto commissario ha chiesto la depenalizzazione dell’immigrazione irregolare perché «solo le alternative alla detenzione possono salvare le vite dei migranti».
Secondo il dipartimento libico per il contrasto all’«immigrazione illegale» (che dipende dal ministero dell’Interno libico), 19.900 persone sono trattenute in strutture sotto il suo controllo, contro le 7mila di metà settembre. «L’Ue non ha prodotto nulla per ridurre gli abusi subiti dai migranti» ha proseguito l’Alto commissario. Una donna sub-sahariana ha raccontato allo staff Onu, che a novembre ha visitato quattro strutture: «Sono stata portata via dal centro di detenzione e stuprata in una casa da tre uomini, compresa una guardia del centro». Donne, uomini e bambini raccontano: «Ci picchiano solo perché chiediamo cibo o cure mediche o informazioni». Un uomo rinchiuso nel centro di Tarik al-Matar, dove in 2mila vivono ammassati in un hangar senza bagni funzionanti, ha spiegato: «Non dormiamo, abbiamo malattie, ci manca il cibo, non ci laviamo per mesi. Moriremo tutti, è troppo difficile sopravvivere all’odore di feci e urine».
Stupri e violenze accompagnano i migranti fin dall’inizio del loro viaggio, ricorda l’Onu: «Sono già stati esposti a rapimenti, torture, lavori forzati, sfruttamento, gravi violenze fisiche, fame e altre atrocità nel corso dei loro viaggio attraverso la Libia nelle mani dei trafficanti». Una donna della Costa d’Avorio ha raccontato: «Durante il viaggio uomini armati hanno scelto sei donne, quando mi sono rifiutata sono stata schiaffeggiata e mi hanno puntato una pistola alla testa. Quattro uomini mi hanno stuprata. Ero all’inizio di una gravidanza, ho sanguinato molto, penso di aver perso il bambino».

Ue e Italia, ricorda l’Onu, stanno fornendo assistenza alla Guardia costiera libica per intercettare le imbarcazioni, anche in acque internazionali, «nonostante i timori che questo condanni più migranti a una detenzione arbitraria, illimitata, atroce. Non possiamo essere testimoni silenziosi di questa schiavitù – ha concluso l’Alto commissario – in nome della prevenzione dell’arrivo sulle coste europee di gente disperata e traumatizzata». L’Onu chiede poi alle autorità libiche di porre fine alle violazioni dei diritti umani.
Dall’Ue ieri si è cercato di ridimensionare la portata delle accuse: «L’Unione europea lavora in Libia in cooperazione con l’Onu, la priorità è salvare vite e combattere i trafficanti – spiega una portavoce – per creare canali legali verso l’Europa per chi necessita protezione internazionale. La Ue finanzia Oim, Unhcr e Unicef per migliorare le condizioni in Libia. I campi di detenzione devono essere chiusi, la Ue chiede che i migranti vengano portati in centri di accoglienza con standard umanitari internazionali. Solleviamo regolarmente questo argomento con le controparti libiche». Nessuna marcia indietro neppure sulla marina libica: «Abbiamo addestrato 142 membri della Guardia Costiera. Fa parte dell’Operazione Sophia». Proprio ieri la Guardia costiera libica è tornata ad attaccare le Ong chiedendo più fondi all’Ue. Si è fatto sentire anche il presidente del parlamento europeo, il forzista Antonio Tajani: «Oggi sarà presa la decisione ufficiale, una delegazione del Parlamento europeo si recherà in Libia per verificare la situazione. L’azione contro l’immigrazione illegale non può essere confusa con la violazione dei diritti umani».
ASTE DI SCHIAVI A TRIPOLI,
LE PROVE IN UN VIDEO-SCOOP DELLA CNN
«Vendiamo umani. La giornalista afro-americana commenta: "Mancano solo le catene"»
«Mancano solo le catene», commenta la giornalista afro-americana della Cnn che ha messo a segno uno scoop internazionale sul ritorno del mercato degli schiavi in Libia secondo metodi che sembrano ricalcati dal film Django Unchained senza però la fine catartica di Tarantino.
Il video, evidentemente girato con un cellulare e acquistato dalla giornalista, mostra i volti sgomenti dei due ragazzi nigeriani venduti all’asta e reclamizzati come esemplari forti, adatti a lavori pesanti come quelli agricoli. Immagini riprese in una notte dell’agosto scorso, sulla base delle quali la giornalista della Cnn ha poi cercato conferme e girato interviste nel centro per migranti Treeq Alsika di Tripoli gestito dalle autorità ufficiali di Tripoli.
È riuscita anche a filmare da lontano un’altra asta di carne umana viva, sempre alla periferia della capitale libica. Un mercanteggiamento veloce, sempre di notte, dentro un compound illuminato e presidiato da un guardiano in tuta mimetica di cui non è stata inquadrata la faccia.
La reporter ha anche intervistato un supervisore del centro di detenzione, il quale conferma di aver sentito dire dell’esistenza di queste aste di schiavi ma di non averne mai vista nessuna. «I contrabbandieri di esseri umani – racconta lei – dopo la chiusura della rotta marittima ad opera della Guardia costiera libica sono rimasti in arretrato rispetto ai passaggi e così diventano i padroni dei migranti, che vendono come schiavi». Lei e i suoi collaboratori hanno quindi consegnato alle autorità di Tripoli tutta la documentazione raccolta, prima di pubblicarla con il titolo «People for sale», ricevendo in cambio la promessa di avviare un’indagine.
In base alle testimonianze raccolte nel centro di detenzione di Tripoli, dove si vedono centinaia di giovani africani accatastati gli uni sugli altri in uno stanzone o in specie di gabbie «senza cibo né acqua», le compravendite di uomini non sono una novità, vanno avanti da tempo. Così come le torture e le richieste di riscatto alle famiglie d’origine. Alle Ong dei soccorsi i migranti dicono che avvengono anche dentro i centri.